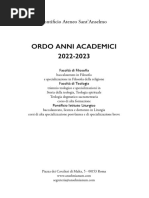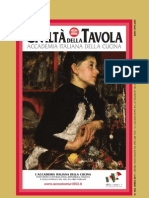1
Didattica curricolare C3 Consorzio FINO
J. Leclercq, Umanesimo e cultura monastica
1. L’opera di Jean Leclercq Umanesimo e cultura monastica, è una raccolta di saggi scritti dal
monaco benedettino tra il 1959 e il 1984 ed editi da Jaca Book nel 1989 grazie al lavoro di Inos Biffi;
questi coprono, dunque, un arco di tempo non da poco, quasi un trentennio. Gli stimoli, le suggestioni
e le questioni che gli scritti affrontano sono molti e fanno riferimento a diverse fasi degli studi di
Leclercq; tuttavia possiamo riscontrare come denominatore comune di questo sforzo di
approfondimento intenso, il tentativo di fornire, al pubblico che ne è interessato non per forza di
esperti, un quadro della formazione della cultura monastica, delle sue fonti e dei suoi frutti. In questo
senso l’opera si ricollega e conferma quanto l’autore aveva affrontato nello studio che, probabilmente,
ha avuto più fortuna: L’amour des lettres et le désir de Dieu, libro nato da una serie di lezioni tenute
da Leclercq all’Istituto di studi monastici Sant’Anselmo di Roma nell’inverno 1955-56. Proprio il
titolo di quest’opera ci permette di stabilire l’oggetto materiale indagato dallo studioso: l’amour des
lettres, che è l’aspetto maggiormente speculativo, da intendersi non solo e non tanto come l’amore
per le belle lettere ma come l’arte, la cura per lo scrivere bene che equivale non alla proprietà dello
scrivere, ma soprattutto ad uno stile, ad un umanesimo (vedremo più avanti quale senso assume il
termine); e il désir de Dieu ovvero la ricerca di Dio, l’unificazione in Lui, che, invece, costituisce
l’aspetto esperienziale ed è il fondamento della teologia mistica, come è stata definita da Leonardi, la
quale costituisce uno dei due versanti teologici (l’altro è la teologia scolastica elaborata nelle prime
Università) necessari per comprendere la filosofia medievale.
2. Innanzi tutto, per comprendere cosa si intende per umanesimo monastico occorre indagare
quale scopo avesse lo studio delle lettere. Ne troviamo notizia in uno dei più grandi rappresentanti,
Bernardo di Clairvaiux, che nel Sermone 37 sul Cantico dei Cantici sottolinea: «non si deve
disprezzare la conoscenza delle lettere (scientiam litterarum): essa adorna la mente (ornat animam),
la ammaestra (erudit eam) e la rende capace di insegnare agli altri (facit ut possit etiam alios
erudire)»1. La scienza delle lettere ha, dunque, tre obiettivi: innanzi tutto la propria istruzione, la
litteratura fa uscire l’uomo dalla rudezza (e-rudire); inoltre questa scientia litterarum affina la mente,
la orna, la abbellisce. L’ornatus è tutto ciò che si aggiunge, per renderla piacevole, ad una realtà che
già esiste. Nella mente dell’uomo questa realtà è la capacità di cogliere la bellezza, la poesia, ciò che
è degno di essere approfondito in vista del terzo scopo: fare partecipi gli altri di questa capacità di
gustare la verità rivestita dalla bellezza.
1
Bernardo di Chiaravalle, Sermoni sul Cantico dei Cantici, 37, 2.
� 2
Chiarito lo scopo, occorre definire meglio quale sia la materia dello studio delle litterae da cui
potremmo comprendere quale sia il significato di umanesimo. Come è noto sono essenzialmente due
i campi della formazione monastica: le Sacre Scritture, Antico e Nuovo Testamento, e lettere profane
degli autori pagani, i gentiles. Il senso profondo dello studio delle prime è nel concetto stesso di
Rivelazione: il Verbo di Dio si è incarnato, il suo messaggio è stato affidato ai testi, la Parola è
divenuta Scrittura. In questo processo la profondità della Rivelazione è stata resa attraverso diverse
lingue, tre fondamentali: l’ebraico, il greco e il latino. Così, per comprendere il messaggio rivelato
occorreva essere iniziati ad almeno una di esse, il latino; si andava a scuola da una grammatistès, che
insegnava le prime nozioni, poi da un grammaticos o litteratus, che insegnava la letteratura la quale,
a sua volta, preparava all’arte oratoria e quella del pensiero. Il latino permetteva di conoscere il
pensiero antico e le Scritture e dunque permetteva di esprimere, almeno attraverso l’esercizio scritto,
concetti ed esperienze di carattere spirituale. Ecco allora un dato fondamentale per comprendere
l’umanesimo monastico: non si tratta, semplicemente, di padroneggiare abilmente una lingua o di
assimilare una cultura, ma attraverso questi strumenti c’è la ricerca di un’esperienza, quella dell’unità
con Dio in Gesù Cristo, che è avvertita come essenziale per l’accrescimento del valore integrale della
persona. La formazione e l’istruzione sono in vista di un’esperienza. Commenta Leclercq:
«l’istruzione e la cultura permettono [attraverso lo studio dei gentiles] un affinamento della
personalità: rendendo un individui capace di esprimere esperienze spirituali, esse producono per lui,
in lui, esperienze che lo arricchiscono. Non si ha dunque il diritto di scindere in lui, per poi analizzarli
separatamente, la conoscenza che possiede riguardo agli autori profani e i valori di umanità che ha
acquisito a loro contatto. […] Comprendere l’umanesimo di questi monaci significherebbe
individuare, attraverso ciò che essi esprimono in un linguaggio imparato alla scuola dei pagani, la
loro esperienza cristiana; significherebbe cogliere, in ciascuno di loro, quel che essi provano, una
volta formati alle lettere, quando scoprono il proprio intimo davanti a Dio»2. In questo senso si
dispiega il significato del termine umanesimo riferito alla cultura monastica, la cui definizione
impegna Leclercq a muoversi tra i tanti sensi che al termine sono stati assegnati: un profondo senso
dell’uomo, una sua valorizzazione, di cui l’esperienza cristiana fa in modo che si prenda coscienza e
di cui provoca la riscoperta. L’umanesimo di questi monaci si riferisce al fatto che essi si sentano a
proprio agio nell’antichità e vi scoprono elementi che servono come norma per la vita spirituale. Un
esempio illuminante di questa impostazione, come vedremo tutt’altro che priva di tensioni, è Gregorio
Magno il quale assicura che lo studio delle arti liberali aiuta nell’approfondimento della Parola di
Dio: «Sebbene questa cultura contenuta nei libri profani non serva di per se stessa al combattimento
spirituale dei santi, se viene unita alla divina Scrittura, ci permette di conseguire una conoscenza più
2
J. Leclercq, Umanesimo e cultura monastica, Jaca Book, Milano 1989, p. 23.
� 3
acuta della Scrittura stessa. […] Ecco in verità l’unico scopo del nostro studio delle arti liberali:
comprendere più profondamente la Parola di Dio, grazie alla formazione che esse ci procurano. Gli
spiriti maligni tolgono dal cuore di alcuni il desiderio di imparare, perché, ignorando le scienze
profane, non giungano alla finezza delle cose spirituali»3
3. Questa convivenza tra formazione alle litterae e vita cristiana, tuttavia, non fu priva di
tensioni. Secondo Leclercq la storia dell’umanesimo monastico è segnata, in particolare, dal ripetersi
di due fondamentali conflitti che segnavano la vita interiore e la riflessione dei monaci: il primo è
quello tra la vita spirituale cristiana e le realtà profane, il secondo quello tra miseria e grandezza
dell’uomo. Per quanto riguarda il primo aspetto, il problema si pone nei seguenti termini: come è
possibile rimanere cristiano essendo a contatto con i valori pagani che si esprimono nella letteratura
antica? Le regole monastiche dal V al VII secolo prese in esame da Leclercq, che di fatto attuano il
passaggio dal monachesimo antico a quello medievale, stabiliscono una pratica che si basa su due
presupposti: da un lato il monaco deve sviluppare la sua natura umana nel campo della conoscenza,
dall’altra deve farlo con lo scopo di far crescere in sé la vita di Cristo. L’antinomia tra le due realtà,
cristiana e pagana, si riconduce non sul piano delle idee, ma al livello delle esperienza spirituale.
Testo fondamentale è, in questo senso, la Regola di San Benedetto che prescrive alcune norme
che guideranno in grande misura le successive evoluzioni. Qui vi sono espresse le due componenti
fondamentali del monachesimo: la conoscenza delle lettere e la ricerca di Dio. Una delle principali
occupazioni del monaco è la lectio divina che include, oltre alla lettura, la meditazione. Nel monastero
è necessario, pertanto, possedere dei libri, saperne scrivere e saperli leggere. Chi non lo sa fare, deve
impararlo. Come nota approfonditamente Leclercq nell’opera Cultura umanistica e desiderio di Dio4,
per comprendere l’esercizio della lectio divina occorre conoscere i significati di legere e meditari:
«nel medio evo, come nell’antichità, a differenza di oggi, si legge abitualmente non tanto con gli
occhi, ma con le labbra e con le orecchie, pronunciando cioè la parola, esprimendola e ascoltando
quel che si pronuncia. In questo modo la lettura è una vera audizione: legere significa nello stesso
tempo audire»5. Il verbo legere nel Medioevo ha un preciso significato, in parte differente da quello
di oggi. Legere è un esercizio che impegna tutta la persona, in particolare la voce e la mente. È
importante sottolineare questo aspetto perché mostra il carattere «pratico», Hadot parlerebbe di
esercizio spirituale, che i monaci attribuivano a questo esercizio. Stesso discorso vale per la
meditatio: essa indica il pensare ad una cosa al fine di poterla attuare, ovvero prepararvisi, prefigurarla
nello spirito, desiderarla e compierla, in qualche modo, anticipatamente, esercitarsi in essa ovvero
3
Gregorio Magno, La regola pastorale, Città Nuova, Roma 2000.
4
Cfr. J. Leclercq, Cultura umanistica e desiderio di Dio, Sansoni, Firenze 1965, pp. 11 – 27.
5
Ivi, pp. 16 -17.
� 4
fissarla nella memoria e apprenderla. Altra fonte significativa per quanto riguarda il rapporto tra la
vita spirituale cristiana e la conoscenza della letteratura profana è Gregorio Magno; in questo maestro
spirituale del Medioevo, come lo definisce Leclercq, è evidente come la Sacra Scrittura sia la fonte
imprescindibile di ogni itinerario per raggiungere Dio. In confronto ad essa, tutto il resto è secondario,
perfino inutile o addirittura nocivo. Questo perché, sottolinea Leclercq, non si tratta «per Gregorio di
sapere ciò che è l’uomo, di acquisirne un concetto astratto, di farne una teoria: si tratta, per l’uomo,
di vivere in rapporto con Dio o, più esattamente, di vivere il suo rapporto con Dio, di realizzarlo
sempre più, di renderlo continuamente più reale in sé e per sé»6. Si comprende come, dunque, la
conoscenza non sia affatto qualcosa di disinteressato e che la Scrittura non è assolutamente
considerata prima di tutto come fonte di conoscenze; essa è l’occasione di una esperienza che ha il
suo compimento solo nell’amore. Per questi monaci era chiaro come occorresse incarnare ciò che si
leggeva, metterlo in pratica interiorizzandolo perché si comprende solo ciò che si ama. Il vertice della
conoscenza risiede nella sapienza, frutto dell’amore di Dio; allo stesso tempo questa conoscenza non
è da intendersi come una forma di gnosticismo erudito, ma come un atto di amore intellettuale in cui
più ci si unisce a Dio nella carità più aumenta la conoscenza che si ha di Lui. È significativo un passo
del Commento al Cantico dei Cantici in cui Guglielmo, esaminando la frase del libro biblico «I tuoi
occhi di colomba»7, così scrive: «Gli occhi della contemplazione sono due, la ragione e l’amore. […]
Ora, quando <questi occhi> vengono illuminati dalla grazia si aiutano molto l’un l’altro nel senso che
l’amore vivifica la ragione e la ragione rischiara l’amore. […] E questi due occhi spesso diventano
un occhio solo quando collaborano lealmente fra loro, quando mentre contemplano Dio, cosa in cui
soprattutto agisce l’amore, la ragione si trasforma in amore (ratio transit in amorem) e diventa una
specie di intelligenza spirituale e divina che supera e assorbe (superat et absorbet) tutta la ragione»8.
Ora, i testi profani sono utili solo nella misura in cui favoriscono questa esperienza, accendono
questo desiderio di unione con Dio. Senza un rapporto con Dio che sostiene il monaco nello studio,
le litterae sono inutili o dannose. Invece, l’esperienza a contatto con la Bibbia fa della erudizione
secolare un mezzo per arrivare a Dio e per comprendere meglio la Sua Parola. In Gregorio, come in
tanti grandi maestri del monachesimo medievale, vi è una fusione tra il fervore cristiano e la tradizione
culturale dell’antichità; in loro l’umanesimo non si traduce in una pura veste letteraria, ma in un
accordo tra vita culturale ed esperienza spirituale tale per cui più ci si eleva nella cultura, anche
profana, più si guadagna in umanità nel rapporto con Dio.
6
Leclercq, Umanesimo e cultura monastica, op. cit., p. 30.
7
Ct 1, 14.
8
Guglielmo di Saint – Thierry, Commento al Cantico dei cantici, 76, a cura di M. Spinelli, Città Nuova, Roma 2002,
pp. 104 - 105.
� 5
Il secondo aspetto del conflitto è quello della dialettica tra la grandezza e la miseria dell’uomo;
egli, quando rientra in se stesso, si scopre fragile, povero, dolente e, allo stesso tempo, rivestito di una
dignità tale da potersi considerare il vertice della creazione. Ora, questa tensione è stata presente da
subito all’interno dell’interpretazione filosofica del detto delfico, anche nella tradizione socratico –
platonica: «risultano ben evidenti le due linee secondo le quali è stato inteso filosoficamente il
“conosci te stesso”: 1) quella squisitamente socratica che tende soprattutto a sottolineare la finitezza
dell’uomo rispetto a Dio e al divino, e che quindi intende imporsi come esortazione per l’uomo a
tener conto, in tutto ciò che pensa e che fa, di questa sua “finitezza”, e di conseguenza a superare il
più possibile la propria hybris; 2) quella iniziata da Platone e sviluppata dai Neoplatonici, che nel
“conosci te stesso” cerca di fare emergere il più possibile la tangenza della parte più elevata dell’uomo
(l’intelligenza della sua anima) con il divino, che lo stesso Socrate ammette espressamente, ma che
non sviluppa»9. Tuttavia, all’interno della visione biblico – cristiana questa tensione si arricchisce;
l’uomo è fatto a immagine e somiglianza del creatore di tutte le cose, di lui si è fatto prezzo Dio stesso
morendo sulla croce ma, allo stesso tempo, è il responsabile della caduta di tutto il creato, in lui abita
il peccato ed è smarrito nella «regione della dissomiglianza», espressione tratta dal Politico di Platone
(273d), la quale indica quel luogo in cui l’anima si è perduta dopo aver smarrito la conoscenza di sé.
Origene, nel suo Commento al Cantico dei Cantici, sottolinea come conoscersi, per l’anima, sia
rendersi conto della propria bellezza: «se non avrai conosciuto te stessa ed avrai vissuto senza
conoscere chi sei e non ti sarai dedicata affatto alla conoscenza, senz’alcun dubbio non avrai una
tenda tua, ma vagherai di qua e di là “tra le tende dei pastori”, e “tra le tende ora di questo ora di quel
pastore” farai pascolare i capretti, animali inquieti e vagabondi e consacrati al peccato. Ebbene, dovrai
sopportare queste cose finché, grazie alle cose stesse e all’esperienza, non comprenderai quanto male
sia per l’anima il non conoscere né se stessa né la propria bellezza, per la quale costei supera tutte le
altre, non vergini, ma donne, ossia quelle che hanno fatto esperienza della corruzione e non sono
rimaste allo stato verginale»10. Tra gli autori che hanno riflettuto a lungo sul tema della miseria e
grandezza dell’uomo c’è sicuramente Bernardo. La prima cosa che rivela la conoscenza di sé è la
condizione di miseria in cui l’uomo è immerso; questa esperienza, tuttavia, non fa cadere nella
disperazione, ma apre alla misericordia verso il prossimo e ai gradi dell’umiltà necessari all’accesso
della verità: «Per coloro che la verità rivela a se stessi, e che così avvilisce ai loro propri occhi, tutto
diviene necessariamente amaro ciò che prima amavano, perfino la propria persona. Perché,
guardandosi con sincerità, si costringono a vedersi quali si vergognerebbero di essere veduti anche
da loro stessi. Mentre provano dispiacere per quello che sono, anelano a ciò che non sono e che non
9
G. Reale, Presentazione, in P. Courcelle, Conosci te stesso, op. cit., p. 9.
10
Origene, Commento al Cantico dei Cantici, 2, V, 4 - 5, op. cit., pp. 234 – 235.
� 6
sperano certamente di raggiungere con le loro forze. […] Ma riconoscendo chiaramente di non esservi
capaci […] si rifugiano dalla giustizia alla misericordia» 11 . Dove, invece, risplende la grandezza
dell’uomo? Nella dignità, nella scienza e nella virtù. La dignità è il libero arbitrio, immagine di Dio
nell’uomo che anche dopo il peccato originale continua ad essere presente; la scienza consiste nel
riconoscere in se stessi questa somma dignità e, allo stesso tempo, colui grazie al quale ne siamo
rivestiti; virtù è ricercare colui che dona la vita e tenerlo stretto dopo averlo trovato. L’uomo, a
immagine di Dio, assume così una profondità abissale. Nella tradizione monastica e cristiana questa
profondità non è destinata a rimanere un enigma, un mistero chiuso in se stesso, ma è interrogata e
rischiarata dalla relazione con Dio. Sottolinea Leclercq: «egli [l’uomo] fa esperienza della
concupiscenza, constata che può commettere peccati e che ne commette; nello stesso tempo sa che vi
è in lui una “reale” capacità di Dio: egli crede che può riceverlo in sé e che veramente lo possiede.
Come può trovare la sua unità? […] un Sant’Anselmo esprimerà acutamente l’antinomia, risolvendola
al tempo stesso come teologo: la soluzione si trova nell’incontro tra Dio e l’uomo in Gesù Cristo»12.
4. Un ultimo aspetto che mi sembra interessante presentare dello studio di Leclercq è il suo
tentativo di ricostruire una pedagogia e il percorso formativo spirituale nell’esperienza monastica, in
particolare tra il VI e il IX secolo. Anche in questo caso Leclercq mette in evidenza come trattare del
rapporto tra pedagogia e formazione spirituale abbia dato luogo ad un conflitto, poiché la formazione
alla cultura pagana poteva essere avvertita come un ostacolo per la vita spirituale del cristiano. Questo
conflitto di fondo veniva affrontato nella pratica della vita monastica le cui linee erano dettate dalle
Regole; Leclercq ha preso in esame alcune Regole, come quella di Paolo e Stefano, del VI e VII
secolo, successivamente l’opera di Gregorio Magno, e infine l’organizzazione della pedagogia
all’epoca di Carlo Magno. Leclercq ravvisa due caratteristiche comuni per quanto riguarda
l’organizzazione pedagogica: il superiore era il responsabile della preparazione dei giovani alla vita
monastica e ne affidava la cura a educatori che si incaricavano sia dell’istruzione sia della formazione
spirituale; la prima si conseguiva soprattutto attraverso la meditazione dei Salmi, l’altra attraverso i
consigli del maestro e gli esempi offerti da tutta la comunità. Quest’ultimo punto, in particolare, è
molto importante: è la comunità dei monaci a educare alla vita spirituale. Non esistono scuole
monastiche propriamente dette, soprattutto nei primi secoli del monachesimo benedettino, ma nei
momenti in cui i monaci lavorano o leggono, i futuri monaci imparano a leggere. In altri termini,
sottolinea Leclercq, la scuola è tutto il monastero. Soprattutto il monastero era una scuola di carità,
una scuola in cui tutto quello che si faceva portava al servizio di Dio; pertanto essi mantennero sempre
una certa riserva verso una ricerca intellettuale condotta al di fuori di questo quadro e senza le
11
Bernardo di Chiaravalle, I gradi dell’umiltà e della superbia. L’amore di Dio, a cura di G. Mura, Città Nuova, Roma
2002, pp. 94 – 95.
12
Leclercq, Umanesimo e cultura monastica, op. cit., p. 24.
� 7
garanzie di sincerità e di umiltà che esso offre. Senza questo obiettivo della carità, lo studio diventa
mera curiositas che i monaci sempre rifiuteranno. La scienza deve andare di pari passo con la
semplicità, altrimenti essa si tramuta in gonfiore, secondo le parole di Paolo. In cosa consiste questo
gonfiore? Si può dire che esso sia la complessità propria dello spirito quando si applica ad oggetti
molteplici e diversi. Questo rischia di generare una specie di agitazione poco favorevole alla pace
interiore e, dunque, alla ricerca di Dio e di disperdere l’attenzione verso numerosi e superflui
problemi. Per rimediare a questi inconvenienti, bisogna ricondurre lo spirito a una sola occupazione
e preoccupazione, sostituire a tutti i problemi una sola ricerca e una sola esigenza: cercare Dio, fuggire
il rumore esterno delle controversie ed eliminare i problemi inutili: questo è il primo compito della
semplicità. Un brano tratto dal sermone 8 di Bernardo al Cantico dei Cantici è molto significativo in
questo senso: «Anche tu cammina con prudenza tra le realtà nascoste. Ricordati del sapiente che dà
questo avvertimento: “non indagare cose troppo alte per te, e non scrutare cose più forti di te”. […]
La dottrina dello Spirito non eccita la curiosità: infiamma la carità. Così la sposa, quando cerca colui
che ama, non si affida al sentimento carnale, non consente ai vani ragionamenti dell’umana curiosità.
Essa domanda il bacio, cioè invoca lo Spirito Santo, da cui riceverà nello stesso tempo il gusto della
scienza e il condimento della grazia. La scienza donata sotto forma di bacio, è ricevuta con amore: il
bacio è segno di amore. La scienza che gonfia, essendo priva di carità, non sgorga dal bacio. […] Il
bacio conferisce dunque a un tempo un duplice dono: una conoscenza illuminata, una devozione
feconda. […] Non possiede né l’una né l’altra colui che comprende la verità senza amarla, colui che
ama e non comprende»13.
Il quadro organico offerto da Leclercq ci restituisce un mondo, quello monastico, tutto teso,
nello studio, nel lavoro, nella meditazione, alla ricerca di unità tra l’uomo e Dio. Tale ricerca ha
condotto le menti più illuminate del monachesimo a riflettere sul valore e il significato dello studio;
nonostante le grandi differenze di spazio e di tempo, Leclercq ravvisa nello sforzo di mettere lo studio
al servizio della vita, della dimensione pratica, il denominatore comune. Viva lectio est vita honorum
(la vita dei buoni è una viva lezione): in questo sintagma può essere raccolto uno dei più autentici
contributi della tradizione dell’umanesimo monastico.
13
Bernardo di Chiaravalle, Sermoni sul Cantico dei Cantici, 8, 5-6.