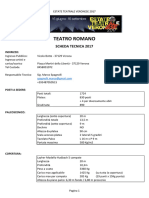Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
187 visualizzazioni3 pagineLa Locandiera Word
La locandiera di Goldoni è una delle sue commedie più importanti. Ambientata in una locanda fiorentina, la vicenda ruota attorno alla locandiera Mirandolina e al suo tentativo di sedurre il Cavaliere di Ripafratta. La commedia mette in scena in chiave ironica i vizi dell'aristocrazia attraverso i personaggi del Marchese e del Conte, che cercano invano di conquistare Mirandolina.
Caricato da
nensi zorbaCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
187 visualizzazioni3 pagineLa Locandiera Word
La locandiera di Goldoni è una delle sue commedie più importanti. Ambientata in una locanda fiorentina, la vicenda ruota attorno alla locandiera Mirandolina e al suo tentativo di sedurre il Cavaliere di Ripafratta. La commedia mette in scena in chiave ironica i vizi dell'aristocrazia attraverso i personaggi del Marchese e del Conte, che cercano invano di conquistare Mirandolina.
Caricato da
nensi zorbaCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd