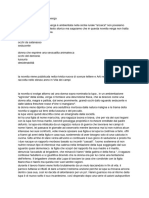Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
296 visualizzazioni5 pagineGiovanni Verga
Il documento riassume la vita e le opere di Giovanni Verga, uno dei principali esponenti del verismo italiano. Verga nacque in Sicilia nel 1840 e visse a Firenze e Milano, dove entrò in contatto con il verismo. Le sue opere più importanti includono Vita dei campi e I Malavoglia, che utilizzano tecniche narrative veriste come lo straniamento e il discorso indiretto libero.
Caricato da
AliceCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
296 visualizzazioni5 pagineGiovanni Verga
Il documento riassume la vita e le opere di Giovanni Verga, uno dei principali esponenti del verismo italiano. Verga nacque in Sicilia nel 1840 e visse a Firenze e Milano, dove entrò in contatto con il verismo. Le sue opere più importanti includono Vita dei campi e I Malavoglia, che utilizzano tecniche narrative veriste come lo straniamento e il discorso indiretto libero.
Caricato da
AliceCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd