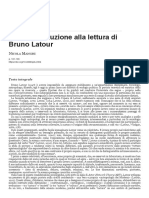Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Angelo Turco - Geografie Disuguali
Caricato da
Tommaso CaprarelliTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Angelo Turco - Geografie Disuguali
Caricato da
Tommaso CaprarelliCopyright:
Formati disponibili
Verso la costruzione di territorialità
inclusive
1 - Genealogia del pensiero inclusivo in geografia
La geografia ha tentato di dar conto, nei secoli, del progetto umano di abitare la terra, aperto e mai concluso.
Come si pone di fronte alle “geografie disuguali”? Cosa ha prodotto e produce la ricerca su queste problematiche,
e come si trasferisce tutto ciò nell’educazione? Se ci soffermiamo sulla ricerca, a un primo sguardo l’interrogazione
sulle “geografie disuguali” non appare tra le preoccupazioni maggiori della disciplina. Ma questa sarebbe una
risposta troppo leggera: esiste una filiera significativa molto sensibile alle problematiche della diseguaglianza dei
territori; una filiera minoritaria, ma neppure tanto sotterranea, che marca la disciplina fin dal suo consolidamento
istituzionale a cavallo del ‘900 e, dopo l’eclisse dell’età dei nazionalismi e totalitarismi novecenteschi nel Vecchio
Continente, trova sviluppi plurimi dopo il secondo dopoguerra, per un impulso congiunto dalle Americhe e
l’Europa.
Proviamo a tracciare una mappa di questa tradizione di ricerca, evocando come “antefatto” l’importante battaglia
epistemologica giocatasi al tempo dell’“istituzionalizzazione disciplinare” e facendo qualche cenno essenziale alle
ramificazioni che si richiamano a tale “antefatto”. Recupereremo la traccia di due “fabbriche” del pensiero
geografico che hanno sviluppato punti di vista originali e forti sulle identità inclusive, con l’avvertenza che si tratta di
un primo tentativo di ricognizione di una tradizione di ricerca troppo spesso considerata più per il suo contenuto
ideologico‐politico che per la sua portata scientifico‐analitica. Non che le fabbriche del pensiero inclusivo rifiutino il
proprio patrimonio etico e le proprie fonti d’ispirazione ideologica; esse ne rivendicano, anzi, il valore politico e
ideale, e questa rivendicazione costituisce il ferro di lancia per consolidare il processo di legittimazione sociale
della disciplina, ritenuto peraltro troppo debole da questa tradizione di ricerca. Resta tuttavia il fatto che la critica
stenta a riconoscere un genuino valore epistemico alle ricerche in parola, impoverendo il processo di legittimazione
scientifica della Geografia.
È una questione importante che vedremo riemergere più volte. Investe centralmente il tema della problematica
quale matrice autentica di innovazione conoscitiva (Raffestin, 1976), immaginazione scientifica e costruzione
sociale della realtà. Non è un caso che nella vicenda qui esaminata i due tipi di processo -uno di legittimazione
scientifica e l’altro di legittimazione sociale- s’intreccino in più modi nell’esperienza di diversi protagonisti
dell’edificazione di una geografia dell’inclusione.
A cominciare da W. Bunge, il più radicale innovatore nell’esplorazione territoriale delle disuguaglianze, ritenuto da
autorevoli studiosi il fondatore della geografia quantitativa. Alla luce di un’analisi per lungo tempo dominante, che
oggi appare uno stereotipo avente più un valore storicocritico che di solidità interpretativa, ciò può apparire
sorprendente, ma solo in parte e se si resta in superficie. Bunge ha coltivato un’esigenza di legittimazione sociale
tramite il processo di legittimazione scientifica della disciplina. Per alcuni quest’ultima si è rivelata inadeguata, per
lui si è rivelata insufficiente e addirittura controproducente dal punto di vista dell’impegno in direzione di una
territorialità inclusiva; a qualcuno, infine, è apparsa perfino congrua. In ogni caso la legittimazione scientifica è
stata un potente fattore di coscientizzazione. Per quella via, infatti, si è costruita la consapevolezza che la partita si
giocava sul piano della legittimazione sociale, e quindi della problematizzazione, e non su quello di una credibilità
scientifica, per altro affidata a metodi quantitativi che, guidati da informazioni raccolte in funzione di interessi
egemonici, finiscono per rafforzarne le ragioni. Sul modello di Bunge, seppure perlopiù indipendentemente da lui,
questa è stata l’esperienza di studiosi come D. Harvey o G. Dematteis.
2 - L’antefatto: una battaglia epistemologica al tempo dell’istituzionalizzazione
Tra l’ultimo quarto del XIX secolo e il primo del XX, nel corso del processo d’istituzionalizzazione si affrontano due
posizioni paradigmatiche principali in seno alla disciplina, una “positivista” e l’altra “essenzialista”.
L’istituzionalizzazione disciplinare: uomini e posizioni
Il paradigma positivista, d’impronta comtiana, assume la “realtà” (l’universo empirico da indagare) come “data”
nelle istituzioni operanti, specie politiche, ma anche economiche e più ampiamente culturali e sociali. Dal punto di
vista epistemologico questo significa porre l’interrogazione scientifica -ciò di cui ci occupiamo- su un piano che
assume le configurazioni strutturali dei processi sociali senza metterne in discussione i fondamenti. Ciò porta ad
affrontare i problemi in un quadro interpretativo funzionale all’assetto esistente.
Le grandi figure del paradigma positivista sono F. Ratzel (1844‐1904), P. Vidal de la Blache (1845‐1918) e H.
Mackinder (1861‐1947). Ciascuna di queste personalità mostra un aspetto del panorama positivista, che appare
così come una posizione paradigmatica non compatta e omogenea, ma assai complessa.
● Il positivismo ratzeliano è detto “ambientalista” a causa del ruolo che attribuisce ai fattori naturali nel
condizionare i comportamenti umani. La geografia umana consisterebbe nella spazializzazione dei
comportamenti umani, che sarebbero perciò determinati dall’ambiente fisico, nella sua accezione più ampia.
Per questo il positivismo ratzeliano è detto anche “determinismo”. Il suo povero fondamento teorico affonda
le sue radici in una tradizione multisecolare del pensiero occidentale.
● Il positivismo vidaliano è detto “storico”: ciò spinge a evidenziare il ruolo della “contingenza” nell’analisi
dei fatti sociali e quindi la funzione della storia nell’organizzazione di risposte “puntuali” a eventi
(un’innovazione tecnologica, una rivoluzione politica, un cambiamento istituzionale...) e circostanze (un
mosaico pedologico, un tipo di clima...) che sono quindi sempre in qualche modo “locali” e temporalmente
definite. La geografia di Vidal è detta in genere “regionale”, perché offre la spiegazione dell’agire umano
come insieme di fatti di localizzazione: combinazioni locali di eventi e circostanze transcalari. L’insieme di
tali fatti di localizzazione offrirà poi allo studioso i materiali empirici per procedere a delle generalizzazioni
che consistono da un lato nell’organizzare delle descrizioni coerenti del mosaico regionale, opportunamente
perimetrato; dall’altro lato -eventualmente- nel ricavare, per induzione, da una collezione più o meno ampia
di “casi” locali descritti e spiegati delle “leggi” universali.
Quindi, oltre a qualche differenza di sfumature e linguaggio, la comune appartenenza paradigmatica non comporta
sostanziali divergenze sulla “natura” del prodotto scientifico in Ratzel e Vidal: la spazializzazione (localizzazione,
regionalizzazione) è l’esito primo e fondamentale nell’ottica di entrambi. La loro è sostanzialmente una “geografia
regionale” a vocazione idiografica, suscettibile di nutrire una “geografia generale” a vocazione nomotetica: ciò che,
in definitiva, sistematizzerà Hartshorne qualche decennio più tardi sancendo il trionfo del paradigma positivista. La
perfetta compatibilità epistemologica delle posizioni di Ratzel e Vidal, spesso presentate come antitetiche, è
mostrata dall’opera di Mackinder, che nei suoi studi usa moduli descrittivi e supporti argomentativi ispirati sia alla
declinazione “ambientalista” che “storicista” del paradigma positivista. Definisce l’Heartland sia in termini di
“posizione” che di “contingenza”, quest’ultima emblematizzata dall’ascesa della Germania sullo scacchiere
europeo.
Il paradigma essenzialista assume la realtà come uno “stato di cose” che si determina per l’effetto di forze, che
agendo si combinano localmente in un modo o in un altro. La geografia essenzialista è autoconsistente, priva di
fondamenti e dunque tanto aleatoria nella sua costituzione quanto trasformabile nella sua evoluzione, in
dipendenza dalle forze che agiscono, le ideologie che le animano, gli interessi che le guidano. Costituzione ed
evoluzione degli spazi come campi di forze sono le preoccupazioni che orientano la ricerca, con una forte
propensione a “capire per cambiare”, nella prospettiva di un fortissimo impegno verso il mutamento sociale in
senso egualitario.
Quindi ciò che differenzia il paradigma essenzialista da quello positivista non sono tanto le teorie o i metodi di
indagine, quanto le problematiche. Queste non sono solo l’esito di una propensione esistenziale, di una “metafisica
influente”, di una scelta ideologica: sono anche il punto di partenza della catena logica che porta alla scoperta
scientifica, come ammonisce Popper (Turco, 1987). La loro formulazione, come ha puntualizzato Raffestin (1976),
non solo dichiara la posizione del ricercatore rendendone espliciti i presupposti, ma orienta i suoi percorsi di
ricerca, disegnando le traiettorie secondo cui -foucaultianamente- è “il punto di vista” che finisce per “fare la
cosa”.
Una costellazione di personalità eterogenee conferisce, se non una forma definita, certo una robusta sostanza al
paradigma essenzialista in Geografia. Si tratta di studiosi di diversificata formazione culturale, poco organici al
mondo accademico dove si va affermando con decisione il paradigma positivista, anche se spesso intrattengono
rapporti personali con esponenti universitari. Si tratta di personaggi fortemente proiettati non solo nell’analisi dello
“stato di cose”, ma anche nel suo cambiamento tramite l’impegno politico. Questo disegna un perimetro vasto, tra
anarchismo e socialismo, con una forte contestazione dei poteri costituiti e delle forme autoritarie del suo esercizio.
In questa stessa scia si sviluppa una critica del capitalismo (inteso in modo più o meno esplicito come fonte e
beneficiario dei modi di produzione e distribuzione della ricchezza) nelle sue proiezioni territoriali. Ricordiamo E.
Reclus (1830‐1905), P.A. Kropotkin (1842‐1821), A. Ghisleri (1855‐1938) e R. Luxemburg (1871‐1919), a riprova
della diffusione assolutamente paneuropea del paradigma essenzialista. Il problema della “spazializzazione” dei
fatti sociali è visto in modo diverso: prevale certamente il senso di una spazialità modellata dalla società, ma in
alcuni è evidente il possesso del concetto di territorialità, ossia di una forma spazializzata dell’azione sociale che,
divenuta territorio e in quanto tale -quindi oltre i fatti di natura-, non solo si riflette sulla società ma produce società.
È l’idea di territorio come esito e, insieme, condizione dell’azione sociale, giunta a formulazione esplicita nella
seconda metà del secolo scorso (Turco, 1988).
Fu R. Luxemburg a spingersi più avanti in questo campo. La sua teoria dell’accumulazione evidenzia la centralità
del territorio nella genesi e nello svolgimento dei processi sociali. La produzione capitalistica, che ha per finalità
ultima l’accumulazione, produce squilibri territoriali e quindi diseguaglianze sociali, e il processo accumulativo, per
sua natura perpetuo e mai concluso, rischia proprio per questo di andare in crisi. A causa di sovraccumulazione o
stagnazione il capitale tradisce la sua funzione e perde la sua natura: riprodursi, vale a dire produrre capitale
tramite se stesso. È così che, in assenza di nuove opportunità d’investimento, di nuove risorse (materiali e
simboliche) da sfruttare, il capitale evita la crisi tramite una strategia geografica: rendendo lo squilibrio territoriale
che esso stesso crea e alimenta una risorsa. E ciò perché nei territori squilibrati (sottosviluppati, arretrati) si creano
sacche consistenti di economia non capitalistica da sfruttare, in un continuum che la saturazione delle aree
sviluppate e la loro omologazione capitalistica renderebbe altrimenti impossibile.
3 - Digitazioni vidaliane in Francia
Il cerchio si salda con la “geografia della guerra”, apparsa negli anni ‘10 del ‘900. In preparazione del conflitto e in
previsione della sua fine, infatti, il paradigma positivista -che aveva già vinto la lotta dell’istituzionalizzazione nella
disciplina- afferma una sua legittimità a far valere le sue competenze nella gestione delle ipotesi e dei tavoli di
pace. Il sapere geografico, come hanno messo in luce gli studi di Ginsburger (2010), è dunque posto al servizio
della politica, seppure con risultati deludenti, e oltretutto in un’età di nazionalismi imperanti che prepara da subito le
condizioni per lo scoppio del secondo conflitto mondiale. Ciò rappresenta un salto di qualità nell’affermazione
dell’identità professionale del geografo, in precedenza considerato un “maestro”, cioè un tecnico della formazione
geografica degli allievi a scuola, e un esperto di esplorazioni geografiche. Queste ultime, associate alle cartografie
prodotte prima e dopo il loro svolgimento, hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo del colonialismo. Non è
un caso che proprio per una questione di identità scientifica e professionale si dispiega la “battaglia delle Annales”,
tutta interna al paradigma positivista a dominante storicista (Soubeyran, 1995).
Dopo una lunga pausa il dibattito riprende nel secondo dopoguerra, grazie a sensibilità maturate in vari luoghi e
forme differenziate soprattutto durante il conflitto. Nella Francia degli anni ‘40, con una geografia saldamente
vidaliana, affidata al prestigio della monografia regionale, si affaccia la figura di uno studioso militante, che diventa
centrale nel mondo accademico: Jean Dresch (1905‐1994). Impegnato politicamente nel Partito Comunista più
forte dell’Europa occidentale dell’epoca, Dresch è allievo di E. De Martonne (1873‐1955), figura maggiore della
geografia francese e genero di Vidal de la Blache: ha perciò una formazione eminentemente geografico‐fisica. È
però allievo anche di A. Demangeon (1872‐1940); non stupisce quindi che sia un fautore dell’unità della disciplina,
impersonando quella che per decenni sarà la dottrina disciplinare prevalente in Francia e, per sua influenza, nel
mondo.
Dresch è un agguerrito critico del colonialismo, tema che -specie con la questione algerina- rende particolarmente
acuta la coscienza dei geografi. Decostruisce l’imperialismo francese tramite l’analisi del capitalismo coloniale: un
tema alquanto inedito nelle preoccupazioni disciplinari. Allievi suoi e di P. George sono i giovani geografi che si
distinguono nell’impegno anticolonialista (Bataillon, 2006; Semmoud, 2014; Deprest, 2009). Anche altri “geografi
comunisti” esercitano importanti ruoli istituzionali nella geografia francese: ad esempio Jean Tricart (1920‐2003),
anch’egli geografo fisico, e Pierre George (1909-2006).
In un clima fortemente attestato sull’ideologia disciplinare vidaliana, alquanto conservatrice sul piano metodologico,
si profilano orizzonti di apertura verso nuove problematizzazioni della disciplina, che costituiscono l’essenziale della
spinta innovatrice della Geografia in Francia: si pensi a J. Suret‐Canale, coi suoi immensi e profondissimi studi
sull’Africa subsahariana, o a Y. Lacoste.
Autore di un libro fondamentale sulla geografia del sottosviluppo, Lacoste ottiene fama mondiale negli anni ‘70 con
la pubblicazione di un libro che getta una nuova luce sulla guerra del Vietnam e le strategie territoriali americane.
La geografia e la guerra: una storia antica, ma rivisitata in un contesto internazionale fortemente critico verso le
dottrine che affermano il diritto (e, secondo le retoriche del tempo, il dovere) degli USA di farsi “gendarme del
mondo”. Quelle esperienze di studio, riflessione e militanza “civile” prima che politica spiegano la genesi
dell’impresa scientifica più articolata e ricca di questo autore: la rivista Hérodote, fondata nel 1976 e ancora attiva.
La seconda via verso la legittimazione sociale procede dalla legittimazione scientifica. È la strada intrapresa da R.
Brunet, una personalità eminente della geografia francese che interpreta la sensibilità critica come impegno
politico, che un ricercatore deve affermare soprattutto con le sue pratiche di studio. Queste devono essere coerenti
con la tradizione disciplinare: non a caso Brunet chiamerà “Reclus” il grande centro di ricerca creato a Montpellier
nel 1982. La ricerca, inoltre, dev’essere rigorosa, e in ciò aiutano molto i metodi quantitativi, anche se la loro
funzione è sempre e comunque strumentale rispetto al disegno conoscitivo: è la filosofia di fondo che ispira
L’Espace Géographique, la rivista fondata da Brunet che ha acquisito subito fama internazionale. Infine la ricerca
dev’essere “attiva”, ossia deve sforzarsi di assumere su di sé la responsabilità del cambiamento, dando indicazioni
analitiche applicabili alle interpretazioni alla base delle politiche territoriali e alle azioni che le sostanziano: è uno
dei sensi più profondi della corematica.
Fondamentale per l’esperienza quantitativistica in Francia fu l’influenza dirompente dei franco‐canadesi, studiosi
francesi che hanno insegnato e fatto ricerche in Canada, dove hanno potuto assorbire con più facilità l’esperienza
statunitense, particolarmente di Brian Berry. Figure di spicco sono J.B. Racine ed H. Raymond, che hanno provato
a coniugare le “buone ragioni” del quantitativismo con la tradizione disciplinare, senza tradirne le radici. A rinforzo
di tale posizione, pensano successivamente un libro composto col loro maestro, Hisnard, uno dei testi più lucidi
sulla “rivoluzione quantitativa”. I franco‐canadesi svilupparono mescolanze fermentanti in Svizzera (la sede
universitaria di Racine era Losanna), con studiosi come C. Raffestin, A. Bailly, G. Nicolas‐Obadia, non meno che in
Francia, dove andavano sorgendo reti di riflessione, la più nota e influente delle quali è il Groupe Dupont.
4 - Esperienze italiane, echi di Spagna
In Italia il movimento critico si è sviluppato a partire da una presa di coscienza delle pratiche legittimizzatrici sul
piano scientifico e su quello sociale. Fondamentali sono stati A. Vallega (1934-2006) e G. Dematteis. Il primo ha
favorito, con le sue ricerche e le sue pratiche di coinvolgimento e incoraggiamento, la crescita di una coscienza
critica di giovani geografi, che negli anni ‘70 erano fortemente insoddisfatti delle impostazioni disciplinari, dei temi e
degli esiti delle ricerche. Ritenevano i limiti da essi stigmatizzati dovuti a una scarsa capacità di spingere l’analisi in
profondità, a carenze metodologiche, ad ambiguità diffuse dell’ideologia disciplinare. Tra quest’ultime si segnala la
mitologia intorno all’unità della disciplina, in un periodo in cui forse solo il Dipartimento di Geografia dell’Università
di Padova era fedele a questa impostazione. Ma si segnala anche la pretesa di valutare la bravura dei ricercatori,
la loro dignità scientifica, dalla varietà dei temi trattati piuttosto che dallo spessore dei risultati ottenuti. Senza
dimenticare un maestro come E. Bonetti (1910-2005), che ha diffuso in Italia i modelli di localizzazione di von
Thünen, Weber, Christaller, Lösch, o studiosi come Gabriele Zanetto, Fabio Lando, Attilio Celant, Nedim Vlora,
Paola Pagnini, Piero Landini. Questi perlopiù non erano affatto innamorati delle metodologie quantitative, che
considerano strumentali rispetto a una teoresi forte, e che hanno praticato solo per una parte limitata del loro
impegno di studio: seguendo in ciò un modello proposto da personalità come C. Raffestin o H. Capel.
Vario fu il destino scientifico di questi studiosi, che allora furono chiamati “neopositivisti” (con una tonalità polemica)
dai loro coetanei, a loro volta chiamati(si) “storicisti”, pur desiderosi di cambiamento ma attestati su altre posizioni.
Ispiratore e padre di questo movimento fu Lucio Gambi (1920‐2006), un grande studioso che ha rotto molti argini
della tradizione disciplinare italiana, in avvitamento su se stessa nel secondo dopoguerra e giunta ormai esangue
di fronte a fenomeni epocali come il movimento studentesco del ’68, del tutto incapace di capire la voglia di
cambiamento che attraversava il paese. Questo gruppo, sotto l’ala sapiente e discreta di Dematteis (sensibile alle
istanze della legittimazione scientifica del quantitativismo) ha riunito grandi personalità come Massimo Quaini,
Pasquale Coppola (1943‐2008) e Franco Farinelli, riuscendo, in poco tempo, a dare corso a una produzione
importante e di ragguardevole impatto, esaltando i temi altrove ignorati o appena accennati dell’inclusione sociale,
della giustizia spaziale, degli equilibri regionali. A ciò si affiancano iniziative come la costituzione di un gruppo di
“Geografia Democratica” (Cavallo, 2007) e la fondazione di una rivista, che per la sua vita breve ebbe nome
“Herodote Italia”, dal nome della consorella francese fondata da Lacoste.
La geografia critica spagnola è intimamente legata alla fine del franchismo e all’avvento della democrazia. È un
panorama complesso, tra ramificazioni, sensibilità e inclinazioni metodologiche plurime, la cui personalità più
influente è quella di H. Capel, autore di una produzione scientifica e divulgativa sterminata. Capel sperimenta in
una forma esemplare l’esperienza della doppia legittimazione, scientifica e sociale. Da una parte c’è il suo sforzo di
illuminare gli aspetti salienti della storia ed epistemologia del pensiero geografico moderno. Questa tensione verso
l’enucleazione di elementi forti della disciplina si esprime sul versante dell’analisi quantitativa, specie nell’ambito
della geografia urbana, uno dei campi d’elezione di Capel. Come nota N. Benach, Capel fu “tra i primi a mostrare
una sensibilità nei confronti della geografia quantitativa”, ma allo stesso tempo era cosciente di un “contenuto
ideologico occulto di quelle investigazioni, che ignoravano le relazioni sociali di produzione”. Ciò accadrà in diverse
esperienze anglosassoni. Un secondo, altrettanto importante aspetto, marca la vicenda di Capel, che si svolge
nell’ambito dell’organizzazione culturale: fu organizzatore infaticabile di piccoli seminari tematici, grandi convegni
internazionali, collane e riviste. Ancora oggi la piattaforma Geocritica, da lui creata, è il portale geografico più vasto
e articolato del mondo; vi vengono pubblicati articoli in tutte le lingue neolatine, il che testimonia la volontà di non
dare per scontata né l’egemonia culturale della geografia anglosassone né la sua definitiva vittoria. Una tematica,
questa, molto sentita in Spagna.
5 - W. Bunge: un precursore con un ampio seguito nel mondo anglosassone
Nel 1962 apparve, nella collezione dei Lund Studies in Geography, il libro Theoretical Geography, scritto da William
Bunge. A qualcuno parve eccentrico, ma per altri era un testo fondatore, difficile ma appassionante: “forse il testo
seminale della rivoluzione quantitativa” (Cox, 2001). Fui impressionato dalla sua illustrazione di cosa diventava il
“k” di Christaller (un parametro, una grandezza fissa) nella teoria di Lösch (una variabile, una grandezza mobile).
Un passaggio essenziale per comprendere il salto dalla geometria, che con le sue relazioni di quantità non spiega
nulla del fatti sociali, alla topologia, che con le sue relazioni di qualità “spiega” -o perlomeno prova a spiegare-
quella che nella “teoria della localizzazione”, puntando all’individuazione di “regioni”, diventò l’assunto
fondamentale della “nuova geografia” (o “geografia quantitativa”). Questo assunto recita più o meno così: “regione”
è un’area (un perimetro, un’estensione) in cui sono minimizzate le disomogeneità, le quali, viceversa, sono
massimizzate nei confronti dell’esterno. Un punto di partenza per un campo sterminato di ricerche per la “nuova
geografia”, ma anche un punto di arrivo nella riflessione del nostro autore.
W. Bunge (1928‐2013) incontra abbastanza tardi e solo casualmente la geografia, diventando un brillante allievo di
R. Hartshorne (1899‐1992), forse il geografo più conosciuto al tempo del loro incontro, negli anni ‘50. Ma questa
“strana coppia” non dura molto: alla fine del decennio la rottura è consumata. Hartshorne è il massimo assertore
della geografia come scienza idiografica, una “scienza descrittiva interessata alla descrizione e interpretazione di
casi unici” (Hartshorne, 1939). Bunge, che nel frattempo ha meditato la serrata requisitoria di Schaefer (1953)
contro l’uniqueness, dunque la scienza idiografica, segue ormai la sua strada e approda ai risultati più avanzati cui
la geografia sia pervenuta in quanto scienza nomotetica, impegnata nella ricerca di leggi generali. Pur operando in
un’Università (allora) piuttosto periferica, quella di Washington, Seattle, diventa un elemento di spicco del gruppo
“Michigan Interuniversity Community of Mathematical Geographers”, estendendo i suoi interessi alla cartografia,
campo che andavano allora sondando in profondità studiosi come W. Tobler e T. Hagerstrand.
La maturazione di Bunge è dettata da un genuino amore per la scienza e dalla convinzione che essa non si dà
senza elaborazione teorica. Ci troviamo di fronte, dunque, a un processo di legittimazione scientifica di una
disciplina geografica percepita come molto decaduta. Ma è alla legittimazione sociale che Bunge si volge, dopo i
suoi fondamentali apporti alla “rivoluzione quantitativa”, diventando un attivista di spicco per i diritti civili e contro la
guerra in Vietnam. A causa del suo burrascoso rapporto con le istituzioni accademiche, Bunge è alla fine costretto
a lasciare l’Università. Tuttavia non rigetta l’esperienza passata, ma sviluppa un punto di vista conciliativo tra i due
ordini di legittimazione, esattamente come proveranno a fare in Francia R. Brunet e in Italia G. Dematteis.
L’originalità della posizione di Bunge nasce dalla consapevolezza che le metodologie quantitative possono
scardinare i vecchi ordini, costruendone di nuovi e rendendoli visibili tramite una cartografia appropriata: scientifica
e, al tempo stesso, immaginativa. Per quanto tutto questo non sia automatico, il potere delle metodologie
matematiche resta incredibile nelle mani di chi sa usarlo. Perché dunque non servirsene nella lotta contro le
diseguaglianze, le discriminazioni, la guerra, la miseria, l’infanzia tradita? Il suo “periodo astratto”, come dichiara in
un testo lucido e appassionato, non è dissociato dal suo presente, ma è messo al servizio della “logica della vita”
(Bunge, 1979). È a questo punto che lo studioso intraprende, come gli esploratori che hanno fatto la geografia del
passato, le “spedizioni” che mettono insieme le informazioni, le interpretazioni idonee a riconfigurare la realtà,
integrando nella cognizione geografica ciò che i discorsi dominanti non dicono e, cartograficamente, gli sguardi
egemonici non vedono. E di cui, conseguentemente, non solo la politica (politics), ma le politiche (policies) non si
curano.
È in questo complesso quadro epistemologico e intimamente personale che trova la sua genesi Fitzgerald (Bunge,
1971), uno dei grandi libri che mantengono la Geografia contemporanea in un solco degno della sua plurimillenaria
tradizione. Ed è da qui, da un attivismo anti‐militarista accorato e documentalmente severo che trae motivazione e
significato quel Nuclear War Atlas (1988) che nullifica, tramite la mappatura degli sfregi territoriali provocati in
ipotesi dalla bomba, ogni ragione “atomica”.
La figura e l’opera di Bunge hanno avuto un’influenza senza pari sulla Geografia contemporanea. Soprattutto nel
mondo anglosassone, dove si profilano e consolidano posizioni articolate e fermentanti di una Geografia “radicale”,
sempre più decisamente disposte a mescolare impegno intellettuale e attivismo politico contro l’ingiustizia e la
diseguaglianza spaziali. Queste posizioni sono animate da figure di spicco come E. Soja, M. Watts e R. Peet; si
esprimono tramite pubblicazioni sterminate, riviste scientifiche, prese di posizioni “civili”, interventi sui media,
iniziative editoriali. Tutte le elaborazioni teoriche degli ultimi 70 anni si sono misurate con lui; ciò vale anche per la
cartografia, che Bunge influenza sul piano della duplice legittimazione, sia scientifica (risalente al “periodo
astratto”) che sociale.
6 - Fabbriche del pensiero geografico inclusivo: due esempi
La geografia dell’inclusione, detta critica o radicale, si può declinare tramite esperienze molteplici per singoli
paesi (Francia, Spagna, Italia), ovvero per grandi aree culturali, come esemplifica Bunge per il mondo
anglosassone. Ma la geografia della legittimazione sociale sviluppa anche una forte vocazione
internazionalistica, attraverso network relazionalmente laschi ma dai potenti e convergenti effetti comunicativi.
Delle “fabbriche del pensiero” imperniate su alcuni temi portanti e alimentate da personalità di disparata origine e
formazione, talora anche assai differente, non sempre collegati tra loro da relazioni istituzionali o comunque
sistematiche, che tuttavia coniugano attività di studio, militanza civile e comunicazione pubblica. Osserviamo due
esempi di queste “fabbriche del pensiero”, incernierate sui temi della “giustizia spaziale” e del “lavoro come
contropotere”.
6.1. L’ingiustizia spaziale e le sue radici/implicazioni storiche, sociali e filosofiche
Il tema della giustizia spaziale, e della necessità di restaurarla ove violata, mobilita lungo sentieri disparati alcune
delle intelligenze più acute e percussive della scena disciplinare mondiale. La Geografia di questi studiosi è la
Geografia tout court.
D. Harvey inaugura questo filone di preoccupazioni con un libro divenuto presto celebre. Egli muove dall’esigenza
di rileggittimare la disciplina sul piano scientifico, approdando a un’opera che per molti divenne fondamentale. Già
nel titolo, Explanation in Geography, dichiara la sua posizione epistemica, distanziandosi da Hartshorne non tanto
sul piano dei “temi” (la geografia regionale non è messa in discussione) quanto su quello degli “scopi” della
disciplina, che, secondo Hartshorne, pur descrivendo e interpretando, non avrebbe nulla da “spiegare”. Il picco
tecnico e razionalistico della riflessione di Harvey (1969) marca anche lo slittamento verso la legittimazione sociale;
egli diventa così un leader intellettuale riconosciuto non solo nell’ambito della geografia critica, ma anche in quello
delle scienze sociali, al punto da essere noto più come filosofo, urbanista e sociologo che come geografo.
Lo studioso anglo‐americano accentua progressivamente le sue posizioni in senso marxista, ma resta fedele a
un’impostazione di fondo che vede la giustizia sociale (la lotta alle disuguaglianze, l’accesso a beni e servizi, la
pratica dei diritti oltre il loro riconoscimento formale) realizzarsi tramite lo spazio geografico e, per converso,
l’ingiustizia sociale alimentarsi nello spazio geografico. È dunque nel territorio che si radicano le strategie del
capitalismo, lo spatial fix diventa un elemento fondamentale dei processi accumulativi ed è eminentemente per via
geografica che l’“enigma del capitale” si fa storia sulla carne viva delle società sistematicamente commodificate.
Da tutt’altre prospettive converge sulla giustizia territoriale M. Santos (1926‐2001), geografo brasiliano che
rivendica orgogliosamente la sua appartenenza disciplinare. Figlio della piccola borghesia afrodiscendente
bahiana, Milton sperimenta le contraddizioni di una delle società più inegualitarie del mondo in uno dei Paesi più
territorialmente squilibrati del pianeta. Giornalista, politico e professore universitario, è costretto all’esilio dal regime
militare, preoccupato dai suoi orientamenti sempre più marxisti. Durante il suo lungo soggiorno in Francia conosce
J. Tricart, P. George e B. Kayser, consolidando il suo orientamento per una geografia critica, capace di interrogarsi,
in via preliminare, sulla natura della territorialità. La sua posizione concettuale è originale e forte, un pensiero che
riflette tre caratteristiche icasticamente indicate da J. Lévy: osservatore militante, teorico nomade, intellettuale
impegnato. Milton, così, concettualizza lo spazio come “un insieme indissociabile, solidale e allo stesso tempo
contraddittorio di sistemi di oggetti e di sistemi d’azione, nei quali si edifica la storia”. Se dunque non si dà storia
(non si comprendono i fatti umani) senza geografia, questa è strettamente collegata alle “tecniche”, ovvero “un
insieme di mezzi strumentali e sociali, per mezzo dei quali l’uomo realizza la sua vita, producendo e creando lo
spazio geografico” (Santos, 2006). Ogni spazio, continua, è una “forma‐contenuto”, e l’una non esiste senza l’altro,
laddove si fondono processo e risultato, funzione e forma, passato e futuro, oggetto e soggetto, naturale e sociale.
Su queste basi si edifica una “teoria sociale critica” che prende in carico un mondo di luoghi, il luogo essendo
oggetto di una “ragione globale” e di una “ragione locale”, in convivenza dialettica. Ma è proprio questa convivenza
che rischia di disintegrarsi con la trasformazione della globalizzazione in globalitarismo. La visione di Santos su
quest’ultimo grande tema può essere sintetizzata dicendo che la globalizzazione è un fatto in sé positivo, di
apertura al mondo, ma se acquista -come fa con la regia neoliberista- il profilo di un progetto globaritario cambia
natura, poiché si regge sulla dominazione, sull’esclusione o sull’accesso condizionale ai benefici.
Affascinante e molto complessa, l’opera di A. Berque sembra avere poco a che fare con la giustizia territoriale. Si
tratta però di illusione ottica, dovuta alle modalità di problematizzazione di Berque e al suo specifico linguaggio.
Questo studioso conosce Marx, ma le sue fonti d’ispirazione sono altre: filosofi, cartografi, poeti, moralisti, geografi‐
viaggiatori d’estremo oriente (Cina, Giappone, Corea), Heidegger, la filosofia greca antica e la cultura araba. Non si
pone il problema delle legittimazioni, assumendo una concezione dichiaratamente filosofica della geografia, una
disciplina che s’interessa ontologicamente alla costruzione del mondo umano, al luogo dell’abitare e alle condizioni
dell’abitante. Prima di altre questioni sulla costruzione “oggettuale” e “metodologica” del sapere geografico viene il
rispetto di questa missione della disciplina.
“Abitare la terra” è molto diverso dallo “stare al mondo”: implica non solo un’azione (a conferma che la geografia
incorpora sempre, in qualche modo, una teoria dell’azione), ma, soprattutto una responsabilità verso l’ecumene.
Berque ha sviluppato riflessioni fondamentali sulla complessità dello spazio geografico, in particolare sulle
configurazioni della territorialità, come il luogo, il paesaggio, l’ambiente. Ma è forse nella critica della modernità che
si condensa il suo contributo alla ricerca delle condizioni d’ingiustizia territoriale. La tragedia della modernità
consiste nella perdita del senso cosmico dell’esistenza umana, in una “acosmia” che scinde l’uomo dalla biosfera di
cui è indissolubilmente parte, frammenta l’agire territoriale in una serie di azioni disconnesse e prive di coerenza,
che creano contesti geografici dove valgono la legge del più forte e l’incapacità di vedere oltre gli effetti immediati.
6.2. La politica come contro potere e il lavoro come dignità
Lavoro e potere: un binomio inscindibile nel pensiero geografico critico. Ma come si articola questa relazione, quali
ne sono i fondamenti logici, le declinazioni storiche, le scale di dispiegamento? Richiamiamo la riflessione di due
grandi studiosi su questi temi: Doreen Massey (1944‐2016) e Claude Raffestin.
“Geografa radicale, femminista, teorica e attivista politica, ammirata in tutto il mondo per i suoi lavori su spazio,
luogo e potere”: così apriva il Guardian (22/3/2016) il suo ricordo di Doereen Massey. Studiosa di Marx, Doreen
innesta sulle sue sensibilità culturali e politiche le letture marxiane di Gramsci e Althusser, ma di fatto il suo
approccio è profondamente geografico. Negli anni ‘70-‘80 Massey si distingue nel campo del lavoro nelle sue
determinanti geografiche, e vi culmina nella sua teoria della “divisione spaziale del lavoro” (1984). Questa diventa
lo strumento (apparentemente rozzo, ma estremamente performante) attraverso il quale il capitalismo mantiene la
sua stabilità, creando e alimentando continuamente squilibri: con ciò elaborando su altro piano una teoria dello
sviluppo capitalistico sulla scia di Rosa Luxembourg.
In seguito Doreen coglie il senso profondamente problematico dell’asserzione di Marx sul “tempo” che, nello
sviluppo capitalistico, prende il sopravvento sullo spazio. È ciò che la porta a elaborare il concetto di “senso globale
del luogo”, come recita il titolo di un suo celebre articolo (1991), dove il problema non è solo quello della
coesistenza dialettica di locale e globale, come postulato da Santos, ma è quello dell’“estroversione” bidirezionale
del luogo, in cui il luogo per un verso si definisce attraverso la compattazione di frammenti eterogenei di mondo,
per un altro “esplode” nel mondo con la sua topìa, come nell’esempio di Londra, capace d’imprimere al mondo i
suoi ritmi, regole, interessi, logiche.
Nell’itinerario di D. Massey spicca l’analisi della produzione e riproduzione delle disuguaglianze sul e attraverso il
territorio. La divisione spaziale del lavoro e la costruzione di un “senso del luogo estroverso” sono i due campi
d’impegno più rappresentativi. Ricordiamo altri due significativi scandagli di questa studiosa: il primo concerne le
discriminazioni di genere, più o meno esplicite ed evidenti, ma sempre potenzialmente esplosive (1994); il secondo
riguarda il linguaggio, l’attenzione per i modi d’espressione che rendono possibile instaurare e perpetuare la
dominazione attraverso la parola manipolata (2015).
“Geografo italiano di lingua francese”, C. Raffestin è lo studioso più noto, in Italia, tra gli stranieri citati in questo
saggio. La sua notorietà è dovuta soprattutto al suo “Per una geografia del potere”: è perciò che Claude è ritenuto
eminentemente un geografo politico, autore oltretutto di un saggio sulla geopolitica tra i più originali e noti in tema
(1995). Per capire il pensiero di questo autore bisogna partire dall’assunto che “fondamento del potere è il lavoro”.
Questo assunto è riproposto con nettezza sin dalle prime pagine dell’opera di Raffestin, anche se spesso è solo
registrato e non messo nel circolo del ragionamento dall’autore, per dare sostanza geografica a due punti
qualificanti della teoria del potere di Foucault, a cui s’ispira. La prima afferma che il potere non si possiede ma si
esercita, dunque il lavoro non è “una cosa” ma un “atto”, che acquista il suo senso in una “relazione”, che può
essere simmetrica o asimmetrica. La seconda afferma che ogni potere genera un contropotere, che non solo è
resistenza, ma ben più profondamente è strategia per sanare o almeno attenuare le dissimmetrie relazionali per
portarle nell’alveo della simmetria.
La concettualizzazione di Raffestin contiene nuclei di sviluppo di vasta portata. Claude ha riflettuto sulle
matematiche geografiche, incidendo sugli approcci quantitativi (1974); ha espresso il più lucido richiamo alla nostra
disciplina sulla centralità della problematica nel processo di elaborazione scientifica (1976). La sua concezione del
lavoro fornisce non solo il quadro ontologico all’abitare umano, che diventa processo di territorializzazione, ma
anche il significato costitutivamente etico della territorialità, una costruzione irrevocabilmente umana: il prodotto è
la condizione del lavoro umano, di cui nessun potere può appropriarsi senza affrontare le conseguenze di
un’operazione illegittima, benchè spesso formalmente legale.
7 - Tra didattica e ricerca
In Italia il tema delle geografie diseguali è stato presente finora nell’insegnamento secondario, ma non abbastanza.
Anche all’Università questi temi sono poco trattati, nonostante nel discorso pubblico la geografia entri attraverso i
suoi rappresentanti “critici”, piuttosto che per altri argomenti e circostanze. Il tema del Convegno annuale dell’AIIG,
dunque, non è solo un argomento ben scelto: è una svolta, destinata ad avviare un più deciso orientamento della
sensibilità collettiva verso le tematiche che occupano la scena informativa. Pone con forza l’idea che la territorialità
è un elemento cruciale del nostro pianeta e che il territorio è il frutto più prezioso del lavoro umano: l’uomo non
potrebbe essere quello che è, e quindi fare quello che fa, senza il suo impegno nel creare sue proprie geografie,
interpretando creativamente i dati di natura e agendo intelligentemente su di essi.
L’approccio critico a questi temi recupera alla tradizione disciplinare una filiera di pensiero a lungo trascurata che
pone, accanto ai grandi geografi riconosciuti della memoria accademica, personaggi di enorme spessore politico e
intellettuale. Ma soprattutto solleva questioni cruciali come la giustizia spaziale, la crisi ambientale, la dignità
territoriale, il lavoro, il potere, le dinamiche del capitalismo, dalle cui proiezioni territoriali dipende il benessere e il
destino di tutti.
Non serve insistere sulle benefiche ricadute didattiche di questo impegno formativo della “geografia nelle scuole”.
Vediamone rapidamente tre:
1) Una rinnovata possibilità di dialogo coi ragazzi. I banchi di scuola, con la geografia critica, non sono altro
dalla discussione familiare, dall’esperienza quotidiana, dalla preoccupazione costante di “comprendere” per
non farsi espropriare del proprio futuro;
2) Ciò che possono raccontare ai ragazzi le nuove tecnologie visuali: “il passato non è un tempo, è una
posizione”, e nulla può raccontarcelo più delle geografie disuguali. Magari in Sudafrica, magari con un
drone;
3) Restaurare il nesso tra formazione e impegno civile nella nostra disciplina, che serve a fare la guerra ma è
fondamentalmente per la pace. Stabilendo condizioni durevoli di convivenza. È qui che appare con tutta la
sua forza il tema della cittadinanza come accesso alla territorialità, del territorio come welfare, secondo la
riflessione di L. Mazza (2015), e delle configurazioni geografiche come “beni comuni”: paesaggio, luogo,
ambiente, disposizioni non appropriative aperte alla fruizione di tutti, preziose, libere, universali.
Potrebbero piacerti anche
- Moloch e i bambini del re. Il sacrificio dei figli nella BibbiaDa EverandMoloch e i bambini del re. Il sacrificio dei figli nella BibbiaNessuna valutazione finora
- La nascita dell'approccio quantitativo alla conoscenzaDa EverandLa nascita dell'approccio quantitativo alla conoscenzaNessuna valutazione finora
- Comprendere Il MondoDocumento23 pagineComprendere Il Mondolascalalaura01Nessuna valutazione finora
- Fare Antropologia PavanelloDocumento8 pagineFare Antropologia PavanelloClara DuchampNessuna valutazione finora
- Dispense Corso Fabio LandoDocumento147 pagineDispense Corso Fabio LandopompeoborromeoNessuna valutazione finora
- 1.paradigmi Antropologici e Concetto Di CulturaDocumento16 pagine1.paradigmi Antropologici e Concetto Di CulturaHumberto Luis RiccomiNessuna valutazione finora
- Laudisa - CausalitàDocumento25 pagineLaudisa - CausalitàEster VigilantiNessuna valutazione finora
- Comparazione FabiodeiDocumento38 pagineComparazione FabiodeiDomenico BrancaNessuna valutazione finora
- Introduzione Alla GeografiaDocumento58 pagineIntroduzione Alla GeografiaTuttle ButtleNessuna valutazione finora
- Capitolo 2 - Geografia CulturaleDocumento9 pagineCapitolo 2 - Geografia CulturaleAngela MazzocchiNessuna valutazione finora
- Sacrificio Umano Pref Di MassenzioDocumento12 pagineSacrificio Umano Pref Di MassenzioMondo ComuneNessuna valutazione finora
- Capitolo 1 - Geografia CulturaleDocumento6 pagineCapitolo 1 - Geografia CulturaleAngela MazzocchiNessuna valutazione finora
- Aspetti Della Filosofia ModernaDocumento18 pagineAspetti Della Filosofia ModernaAnonimoNessuna valutazione finora
- Nuova Storia CulturaleDocumento7 pagineNuova Storia CulturalePietro ProsperiNessuna valutazione finora
- L'antropologo e Il Mondo GlobaleDocumento21 pagineL'antropologo e Il Mondo GlobaleIris FrrokuNessuna valutazione finora
- Riassunto Storia Del Pensiero AntropologicoDocumento26 pagineRiassunto Storia Del Pensiero AntropologicoSalvo Cini100% (1)
- Renato de Fusco - Storia e StrutturaDocumento6 pagineRenato de Fusco - Storia e Strutturacamilla.priviteraNessuna valutazione finora
- La filosofia sociale del pragmatismo: Un’introduzioneDa EverandLa filosofia sociale del pragmatismo: Un’introduzioneNessuna valutazione finora
- Geografia CulturaleDocumento48 pagineGeografia Culturalegufo69100% (2)
- La Malattia Morale LIBRODocumento321 pagineLa Malattia Morale LIBROBela HethelyiNessuna valutazione finora
- Lezione 1Documento31 pagineLezione 1PaolaBibiana CiaravellaNessuna valutazione finora
- Che cos’è la vita?: Indagini epistemologiche e implicazioni eticheDa EverandChe cos’è la vita?: Indagini epistemologiche e implicazioni eticheNessuna valutazione finora
- Breve Introduzione Alla Lettura Di Bruno LatourDocumento4 pagineBreve Introduzione Alla Lettura Di Bruno Latourluca.valzanoNessuna valutazione finora
- Capitolo Primo Introduzione Psicologia PDFDocumento97 pagineCapitolo Primo Introduzione Psicologia PDFraffaella1968Nessuna valutazione finora
- Geografia StoricaDocumento35 pagineGeografia StoricaFernanda MartinsNessuna valutazione finora
- Life of A Galilean ShamanDocumento6 pagineLife of A Galilean Shamanangelo_scribd100% (1)
- Demarcazione Della ScienzaDocumento55 pagineDemarcazione Della ScienzaAlberto ValentiNessuna valutazione finora
- Sintesi Domande Esame Di Geografia (6cfu) - Prof. Matteo ProtoDocumento30 pagineSintesi Domande Esame Di Geografia (6cfu) - Prof. Matteo ProtoValentina Di SimoneNessuna valutazione finora
- Dal Pra - Sommario Di Storia Della Filosofia - 1 La Filosofia Antica e Medievale - 1990Documento385 pagineDal Pra - Sommario Di Storia Della Filosofia - 1 La Filosofia Antica e Medievale - 1990auloagerioNessuna valutazione finora
- I SofistiDocumento6 pagineI SofistiCrocetti SimonaNessuna valutazione finora
- Un Introduzione Critica Alle Teorie Contemporanee Sugli Affective StudiesDocumento18 pagineUn Introduzione Critica Alle Teorie Contemporanee Sugli Affective StudiesDaria FisenkoNessuna valutazione finora
- Storia Sociale e Contemporanea Del 900Documento11 pagineStoria Sociale e Contemporanea Del 900Fabio VoglioloNessuna valutazione finora
- Dalla Biosfera Alla Noosfera. Pensieri Filosofici Di Un Naturalista (Valdimir Ivanovic Vernadskij) (Z-Library) - 204-EndDocumento202 pagineDalla Biosfera Alla Noosfera. Pensieri Filosofici Di Un Naturalista (Valdimir Ivanovic Vernadskij) (Z-Library) - 204-EndVictor HugoNessuna valutazione finora
- Riassunto Capitolo 7 Punti 1.2.4Documento3 pagineRiassunto Capitolo 7 Punti 1.2.4Valeria Mahoxy CrestiniNessuna valutazione finora
- Riassunto Dispensa MarhabaDocumento27 pagineRiassunto Dispensa Marhabaspinalex100% (1)
- Antropologia e etnografia: Scienza, metodo, scritturaDa EverandAntropologia e etnografia: Scienza, metodo, scritturaNessuna valutazione finora
- Bourdieu, Pierre Passeron, J-C. - La Riproduzione. Elementi Per Una Teoria Del Sistema ScolasticoDocumento303 pagineBourdieu, Pierre Passeron, J-C. - La Riproduzione. Elementi Per Una Teoria Del Sistema ScolasticoMarko Bons100% (2)
- Atti BuiattiDocumento12 pagineAtti Buiattiantonio_forgioneNessuna valutazione finora
- Filosofia VarricchioDocumento388 pagineFilosofia VarricchioRickyNessuna valutazione finora
- Dispense Antrop Sist Conosc 2011-2012Documento135 pagineDispense Antrop Sist Conosc 2011-2012mangiacarrubeNessuna valutazione finora
- Riassunto Antropologia Contemporanea MateraDocumento22 pagineRiassunto Antropologia Contemporanea MateraSabrina BarcaNessuna valutazione finora
- Bobbio Max SchelerDocumento23 pagineBobbio Max SchelerAnonymous 4L7zuPcaLNessuna valutazione finora
- Riassunto Il Gioco Della Cultura Di S. Piccone Stella e L. SalmieriDocumento55 pagineRiassunto Il Gioco Della Cultura Di S. Piccone Stella e L. SalmieriPaolaNessuna valutazione finora
- 978880621899PCADocumento13 pagine978880621899PCAGabriele AlgardiNessuna valutazione finora
- Marco Tarchi - Il Populismo e La Scienza Politica Come Liberarsi Del Complesso Di Cenerentola PDFDocumento19 pagineMarco Tarchi - Il Populismo e La Scienza Politica Come Liberarsi Del Complesso Di Cenerentola PDFcarlo.scognamiglio76Nessuna valutazione finora
- Spengler - FaustismoDocumento17 pagineSpengler - FaustismoMichele CalcagnoNessuna valutazione finora
- Insegnare Storia Nella Scuola Primaria e Dell'InfanziaDocumento21 pagineInsegnare Storia Nella Scuola Primaria e Dell'InfanziaAnna SchisanoNessuna valutazione finora
- SociologiaDocumento131 pagineSociologiaLAURA GALDININessuna valutazione finora
- Teorie Sociali e GlobalizzazioneDocumento73 pagineTeorie Sociali e Globalizzazioneelena.dacchioliNessuna valutazione finora
- Sistemica, Voci Nella Complessità, U.Telfener e L.CasadioDocumento64 pagineSistemica, Voci Nella Complessità, U.Telfener e L.Casadioumberta telfener100% (1)
- Indagine BiograficaDocumento23 pagineIndagine BiograficapicalmNessuna valutazione finora
- Filosofia SviluppoDocumento12 pagineFilosofia Sviluppogabriel magoNessuna valutazione finora
- Michel Foucault La Verità e Le Forme GiuridicheDocumento20 pagineMichel Foucault La Verità e Le Forme GiuridichesaraNessuna valutazione finora
- Cultura Egemone e Culture SubalterneDocumento22 pagineCultura Egemone e Culture SubalterneAlessio OliverioNessuna valutazione finora
- Appunti Storia Della FilosofiaDocumento3 pagineAppunti Storia Della FilosofiaMattia StrdNessuna valutazione finora
- Il destino dell'umanità: Il metodo scientifico applicato alla condizione umanaDa EverandIl destino dell'umanità: Il metodo scientifico applicato alla condizione umanaNessuna valutazione finora
- Sociologia GeneraleDocumento87 pagineSociologia GeneraleMarikaCastellanetaNessuna valutazione finora
- Sintesi Spazio e PoliticaDocumento14 pagineSintesi Spazio e PoliticaVero CastellucciNessuna valutazione finora
- Tiburtino IIIDocumento17 pagineTiburtino IIITommaso CaprarelliNessuna valutazione finora
- Riccardo Morri - Da Alvito Alla Campagna RomanaDocumento20 pagineRiccardo Morri - Da Alvito Alla Campagna RomanaTommaso CaprarelliNessuna valutazione finora
- Ordine GeografiaDocumento1 paginaOrdine GeografiaTommaso CaprarelliNessuna valutazione finora
- Lucio Gambi - Critica Ai Concetti Geografici Di Paesaggio UmanoDocumento8 pagineLucio Gambi - Critica Ai Concetti Geografici Di Paesaggio UmanoTommaso CaprarelliNessuna valutazione finora