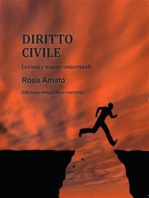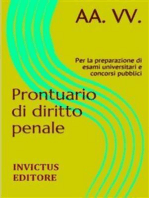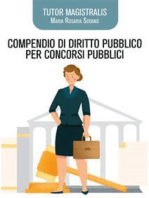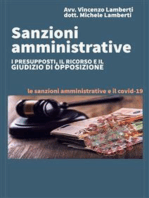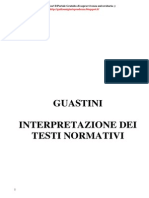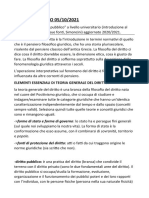Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Diritto Soggettivo Ed Interesse Legittimo
Diritto Soggettivo Ed Interesse Legittimo
Caricato da
uniroma130 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
2K visualizzazioni8 pagineCopyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
DOC, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
2K visualizzazioni8 pagineDiritto Soggettivo Ed Interesse Legittimo
Diritto Soggettivo Ed Interesse Legittimo
Caricato da
uniroma13Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 8
Diritto soggettivo ed interesse legittimo
Superate le vecchie teorie che facevano consistere il diritto soggettivo in un potere
o in una signoria della volontà o in un interesse protetto o le successive teorie
combinatorie, il moderno pensiero giuridico sembra concordare, pur con varie sfumature,
nel mettere in rilievo alcuni elementi che entrano a costituire il concetto di diritto
soggettivo: l'esistenza di un interesse che l'ordinamento riconosce meritevole di tutela, la
tutela accordata dall'ordinamento e cioè il complesso di strumenti giuridici da questo
predisposti per la tutela dell'interesse, l'idoneità di questa tutela alla piena realizzazione
dell'interesse.
Cumulando questi elementi si può dire che il diritto soggettivo è la fondamentale
posizione di vantaggio fatta ad un soggetto dall'ordinamento in ordine ad un bene e
consistente nell'attribuzione al medesimo soggetto di una forza concretantesi nella
disponibilità di strumenti vari (facoltà, pretese, poteri) atti a realizzare in modo pieno
l'interesse al bene.
A seconda del tipo di interesse protetto il soggetto può realizzare l'interesse con il
solo suo comportamento, e cioè senza la cooperazione attiva di altri soggetti (diritti
assoluti) o con la cooperazione necessaria di un altro soggetto (cooperazione che, a sua
volta, può consistere in una collaborazione attiva: diritti di credito; o in una mera
soggezione al comportamento del titolare: diritti potestativi).
Talvolta quando si definisce il diritto soggettivo si aggiunge che la tutela giuridica
è accordata all'interesse in modo diretto ed attuale: e ciò si dice proprio per distinguere il
diritto soggettivo dall'interesse legittimo la cui tutela sarebbe indiretta e occasionale, ma
l'introduzione di questo connotato è inutile perché, come vedremo subito, non è su tale
terreno che si distinguono le due situazioni giuridiche.
Veniamo ora all'interesse legittimo. La definizione tradizionale dell'interesse
legittimo, dettata evidentemente con attenzione al modello del diritto soggettivo ed al
profilo della distinzione dell'interesse legittimo dal diritto soggettivo nel senso or ora
accennato, vedeva nella nostra situazione un interesse individuale strettamente connesso
(per taluni, addirittura coincidente) con l'interesse pubblico e protetto dall'ordinamento
attraverso la tutela giuridica di quest'ultimo, protetto cioè non in via diretta e specifica
(come invece sarebbe protetto il diritto soggettivo), ma in via occasionale e indiretta (si è
anche detto, con riferimento all'atto amministrativo che non viola, che l'interesse
legittimo e un interesse occasionalmente violato). In questa definizione, che ha radici in
tutta la problematica tedesca dei diritti soggettivi pubblici del secolo scorso e del
principio di legalità inteso in senso oggettivo, c'è molto di vero ma il vero è
incompletamente espresso e commesso con tali inesattezze da uscirne travisato.
In questa definizione c'è la consapevolezza, alla quale resta fondamentale per il
nostro argomento, del collegamento fra la posizione fatta al privato (per la tutela del suo
interesse) e la funzione della pubblica amministrazione (per la realizzazione dell'interesse
pubblico) e c'è ancora l'intuizione che l'interesse legittimo si muove sul piano sostanziale,
è cioè un modo di protezione dell'interesse individuale da parte dell'ordinamento che si
distingue dal modo di protezione in cui consiste il diritto soggettivo ma è della stessa
qualità di questo. Il difetto della teoria sta in ciò: che essa, da una parte, non analizza
compiutamente il profilo del modo come avviene la tutela dell'interesse individuale,
dall'altro concepisce il collegamento tra interesse pubblico (potestà pubblica) e interesse
privato o (interesse legittimo) come riduzione del secondo ad un mero accidente del
primo, tutelato solo o in occasione (si è parlato perciò di interesse occasionalmente
protetto) o per tramite (si è parlato perciò di interesse in diritti indirettamente protetti: ma
questa è già un'impostazione più corretta) della protezione dell'interesse pubblico. Così
ragionando, la teoria in discorso finisce anche per svilupparsi in una contraddizione
insolubile, rilevata da più parti, laddove essa attribuisce rilevanza all'interesse legittimo
sulla base di una norma esclusivamente rivolta alla disciplina del potere pubblico e alla
soddisfazione dell'interesse pubblico e, solo in via di riflessione, protettiva dell'interesse
privato (c'è chi ha affermato icasticamente che gli interessi legittimi sorgono in relazione
a norme che per definizione non si occupano di essi [Guarino]).
Era quindi logico che l'attenzione della scienza si concentraasse, a superamento
dell'impasse in cui veniva per trovarsi la teoria tradizionale, nello sforzo di conferire
all'interesse legittimo una effettiva specifica rilevanza approfondendo nel tempo stesso il
profilo del modo di protezione di tale interesse. Troviamo qui varie risposte della dottrina
a tali problemi, e risposte che costituiscono per così dire il tempo intermedio della storia
dell'argomento e che, pur attraverso molte sfumature e combinazioni, possono ricondursi
a due orientamenti:
a) una parte della dottrina si è volta a cogliere il momento e il modo giuridico di
esazione dell'interesse e ha identificato l'interesse legittimo con un interesse strumentale
ad un comportamento da parte dell'amministrazione e cioè in definitiva con un interesse
alla legittimità degli atti amministrativi. Così si è definito l'interesse legittimo come
l'interesse di fatto che ogni soggetto fa valere contro l'amministrazione in regime di
legalità oppure come l'interesse dell'amministrato acché il potere amministrativo, nel
quale si imbatte la posizione soggettiva sostanziale, venga esercitato nel rispetto delle
regole imposte dall'ordinamento all'azione amministrativa.
Questo orientamento ha avuto il merito di cominciare ad elaborare il profilo della
relazione tra interesse individuale e norma protettiva dell'interesse pubblico. Ma per il
resto è certo insoddisfacente. Un simile interesse, anzi tutto, postula l'esistenza di un
inammissibile dovere dell'amministrazione di osservare le leggi, al quale, comunque, se
esistesse, dovrebbe corrispondere una situazione giuridica favorevole in capo a tutti i
soggetti e non ad alcuni soltanto. Né vale molto precisare che l'interesse alla legittimità è
fissato in particolare in capo ad alcuni soggetti e soltanto in questi casi che si ha
l'interesse legittimo. In questa versione resta sempre oscuro un punto essenziale: e cioè in
che cosa propriamente consista l'interesse legittimo, questo particolare modo di
protezione di un interesse materiale.
La fissazione può spiegare a chi spetta l'interesse, non cosa esso sia. La più
elegante esposizione di questa dottrina è stata offerta da chi ha congiunto l'interesse
legittimo al diritto soggettivo, vedendo in quest'ultimo un presupposto necessario
dell'interesse legittimo; ora, se queste formule vanno intese in senso restrittivo, non è
vero che a monte dell'interesse legittimo vi sia sempre un diritto soggettivo: ciò è vero
solo per una categoria di interessi legittimi quelli collegati ad una attività amministrativa
espropriativa di beni o diritti del privato o in generale gli interessi di tipo positivo, non è
vero sempre, non è vero ad esempio per la grossa categoria degli interessi collegati a una
attività concessoria, e per molti altri interessi pretensivi. Se, invece, con la formula del
diritto soggettivo quale presupposto dell'interesse legittimo si intende, come è stato più di
recente spiegato, ricollegare l'interesse al rapporto giuridico, a qualità, status inerenti ad
un dato soggetto, non ad un'occasione e a significare nei limiti del diritto positivo il
carattere sostanziale, la formula è accettabile ma rimane sempre da stabilire non solo
come si produca questo collegamento ma che cosa ne risulti giuridicamente: è invece
toccato un problema ulteriore, quello della individuazione dell'interesse legittimo. Ed
infatti chi più ha arricchito questo punto di vista dei presupposti di fissazione ha finito per
dare una complessa esposizione delle situazioni legittimanti.
B) l'orientamento più importante e che ha avuto maggior peso negli sviluppi
ulteriori della dottrina è quello, nella definizione dell'interesse legittimo, che ha messo
l'accento sul potere di reazione processuale attribuito al soggetto per la tutela del suo
interesse leso dall'attività amministrativa. Tale orientamento, che ha preso l'avvio
dall'insegnamento del Chiovenda, il quale ravvisava nell’interesse legittimo un puro
potere di azione (praticamente il potere o diritto del privato, leso da un atto
amministrativo illegittimo, di provocarne l'annullamento da parte del giudice
amministrativo) presenta molte sfumature, andando dall'opinione di chi ha compiuto la
totale dissoluzione dell'interesse legittimo nella posizione processuale, attribuendo
all'interesse sostanziale singolo valore di interesse di mero fatto, a chi ha doppiato la
posizione processuale con una posizione sostanziale (il diritto all'annullamento dell'atto
amministrativo illegittimo). Questo orientamento ha avuto il merito di richiamare
l'attenzione su di un profilo fondamentale della nozione di interesse legittimo, e cioè sul
modo di protezione dell'interesse singolo, o, per meglio dire, sull'elemento della
situazione di interesse legittimo costituito dagli strumenti di tutela accordati
dall'ordinamento. Ma, a parte che esso considera restrittivamente tali strumenti,
riducendone alla sola reazione processuale per l'eliminazione dell'atto illegittimo
(arrivandosi da taluno a ritenere l'interesse legittimo come null'altro che l'espressione
anticipata, dal punto di vista soggettivo, dell'esistenza di una giurisdizione
d'annullamento), veniva trascurato l'altro fondamentalismo profilo dell'interesse
legittimo, con il primo peraltro strettamente congiunto, e cioè l'interesse materiale del
singolo (l'interesse protetto) nella sua connessione con il potere amministrativo, con la
conseguenza, più o meno dichiarata, più o meno accettata, ma in un certo senso fatale, di
conservare all'interesse singolo la sua condizione subordinata ed eventuale.
La fase più recente degli studi sull'interesse legittimo è caratterizzata
dall'elaborazione di due temi.
Da una parte si studiano i problemi di collegamento fra l’interesse materiale del
singolo e la posizione e l'esercizio del potere amministrativo; superata la grezza visione
dell'accidentalità dell'interesse singolo rispetto all'interesse pubblico e dell'occasionalità
della tutela del primo, si mettono in rilievo i nessi di relazione, con il potere,
dell'interesse visto non soltanto come limite del potere medesimo, ma come elemento che
contribuisce alla determinazione in concreto dell'interesse pubblico e quindi del potere.
Dall'altra, e coerentemente, si amplia la visuale per quanto attiene al modo di tutela
dell'interesse, portandosi l'attenzione, oltre che sullo strumento processuale, sugli altri
poteri che l'ordinamento sembra mettere a disposizione del titolare dell'interesse a
protezione di questo.
La ricerca di una nozione dell'interesse legittimo più ricca di contenuto ed insieme
più specificamente caratterizzata in relazione al modo di essere e di operare della
pubblica amministrazione è oggi agevolata da varie cose. Anzi tutto, ovviamente, dalla
larghissima elaborazione che, in circa un secolo, la giurisprudenza (particolarmente
amministrativa) ha fatto della figura analizzando sotto vari profili centinaia e centinaia di
fattispecie. In secondo luogo (qui non si detta un ordine di priorità, tanto più che i vari
contributi sono combinati ed interagenti) dall'approfondimento che la dottrina va
compiendo del procedimento, della discrezionalità, della legalità dell'attività
amministrativa, i quali sono temi che tutti si riportano al problema essenziale del diritto
amministrativo, il problema dell'interesse pubblico visto nella dinamica della sua
determinazione e quindi nella confluenza dei vari interessi che in tale dinamica sono
coinvolti, compresi gli interessi degli amministrati. In terzo luogo, dall'emersione sempre
più ampia, a livello della considerazione normativa, degli interessi degli amministrati alla
determinazione dell'interesse pubblico: il centro di questa considerazione normativa si
ritrova, è inutile dire, nei principi costituzionali, che valorizzano, nella formula politica
generale delle direttive di struttura della pubblica amministrazione, la posizione ed il
contributo dell'amministrato, ai quali direttamente si collegano le normative (in
particolare, come è ovvio, la legge 2241 del 1990) che hanno aperto l'organizzazione
amministrativa alla partecipazione dei cittadini al procedimento e teorizzato l'attività
dell'amministrazione.
Tenendo presente questo ambiente culturale e le più valide esperienze dottrinali in
argomento, si può delineare quella che allo stato sembrava più soddisfacente concezione
dell'interesse legittimo.
Dobbiamo avvertire che le considerazioni che seguono riguardano l'interesse
legittimo così come si manifesta nel campo del diritto amministrativo e cioè come
fenomeno collegato all'esistenza e l'esercizio di una potestà amministrativa. Non ci
proponiamo il problema se di interesse legittimo si possa parlare anche in altri settori
particolarmente nel campo del diritto privato; si veda anche l'ormai notissima sentenza
della cassazione, sezioni unite civili, 22.11.1979, numero 5688, che, in materia di
rapporto di impiego con gli enti pubblici economici, ha ricostruito in questa chiave le
posizioni soggettive dei lavoratori nei cosiddetti " concorsi privati " per assunzione o
promozione, aprendo la strada su cui per molti anni la giurisprudenza ha continuato a
muoversi, ma che più di recente sembra essere stata abbandonata dalla stessa cassazione:
vedi per esempio sentenza 10.8.1987, numero 6864. Probabilmente se ne può parlare -
non sono state fatte questo riguardo molte confusioni - riconducendo alla categoria
dell'interesse legittimo e cumulando alla figura propria del diritto amministrativo figure
che hanno ben diversa natura e, di interesse legittimo, qualora si dia questa situazione il
valore e la funzione che lessare il diritto amministrativo, si può parlare per il diritto
privato probabilmente solo laddove v'è esercizio di vere e proprie potestà attribuite per la
soddisfazione di interessi collettivi, nell'ambito di un'organizzazione nella quale
acquistino rilevanza, per i loro rapporti con gli interessi collettivi, gli interessi dei membri
dell'organizzazione stessa.
Per cogliere il concetto di interesse legittimo, partiamo dalla considerazione della
norma giuridica che prevede un potere della pubblica amministrazione e ne disciplina
l’esercizio. Questa norma sicuramente tutela uno specifico interesse pubblico e
l'attribuzione e la disciplina del potere sono disposte a soddisfazione di tale interesse.
Ora, qual è, rispetto la norma, la posizione degli interessi privati coinvolti nel
meccanismo d'esplicazione del potere ?
La dottrina tradizionale rispondeva a questa domanda negando che la norma
attributiva del potere si occupasse direttamente degli interessi privati e ammettendo
soltanto un effetto " di rimbalzo " del precetto normativo su tali interessi. La risposta è
però sicuramente inesatta: inesatta in generale, inesatta soprattutto con riferimento alla
posizione della pubblica amministrazione nello stato democratico contemporaneo.
In generale, c’è da dire che l'interesse pubblico (più precisamente l'interesse
collettivo istituzionalmente tutelato dalla pubblica amministrazione) non è un interesse
che incorpora degli interessi privati, ma che convive con essi, di volta in volta
sacrificando e soddisfacendoli. L'organizzazione amministrativa è, appunto, il luogo
istituzionale in cui è delineato il quadro degli interessi (pubblici e privati) presi in
considerazione, né sono stabiliti gli ordini di priorità e risolti i conflitti. La norma
attributiva del potere amministrativo la quale è norma di organizzazione, che, non solo
quindi non prescinde dalla considerazione degli interessi privati, ma consiste proprio
della presa in considerazione di essi insieme con uno più interessi pubblici e della loro
sottoposizione, da parte della norma, all'incidenza del potere.
Si deve aggiungere che la norma definisce solo astrattamente l'interesse pubblico,
in quanto solo astrattamente determina il territorio che lo riguarda e indica gli interessi
che sono coinvolti nella dinamica della sua soddisfazione. E’ soltanto con il
procedimento amministrativo che il quadro prende vita effettiva: è col procedimento
amministrativo che l'interesse pubblico viene determinato puntualmente ed in concreta
relazione con tutti gli altri interessi. Attraverso il procedimento amministrativo si
definisce pure il modo concreto di sottoposizione dell'interesse privato all'incidenza del
potere, ma il privato entra nel procedimento non già per sentirsi dettare le condizioni
della sua soggezione e nemmeno soltanto per porre dei limiti al potere, ma per contribuire
alla stessa determinazione dell'interesse pubblico: ciò vale a dire che il potere
amministrativo si esercita, e si precisa, attraverso una sorta di confronto e cooperazione
dinamici con gli interessi privati, che ha la sua sede procedimento.
Questa situazione è accentuata negli stati democratici contemporanei e, in
particolare, in quello italiano. In varie direzioni oggi si valorizza, per i fini della giustizia
amministrativa, il principio di imparzialità posto dall'articolo 97 primo comma della
costituzione. Secondo l'opinione prevalente, che i pubblici uffici debbano essere
organizzati in modo da assicurare l'imparzialità dell'amministrazione, come dispone
questa norma, significa innanzitutto proprio che la norma di organizzazione deve tener
presenti gli interessi privati, in primo luogo, sul piano sostanziale, " commisurando " il
potere alla loro puntualità e consistenza e in secondo luogo, sul piano strumentale,
predisponendo i mezzi per che nell'esercizio del potere amministrativo sia assicurata " la
presenza " di tutti gli interessi coinvolti nella disciplina dettata dalla norma stessa, il che
esclude ovviamente una mera e pregiudiziale soggezione degli interessi privati e una loro
solo occasionale protezione. Dietro a ciò, c'è ancora il fatto veramente basilare che, nello
stato costituito dalla costituzione repubblicana, l’amministrazione continua ad essere
un'entità, o complesso di entità, agente per un proprio interesse (interesse collettivo), ma,
poiché essa appare ormai decisamente strumento immediato della comunità popolare e
dell'ordinamento che di questa è espressione (articolo 1) e poiché ancora questa comunità
popolare è essenzialmente luogo d'esplicazione della personalità dell'uomo (articolo 2), e
cioè di soddisfazione degli interessi del medesimo, ne risulta un nuovo rapporto fra
interesse dei singoli, interesse dell'amministrazione, finalità dell'ordinamento, rapporto
difficilissimo accogliersi ma circa il quale si può sicuramente dire che tendenzialmente,
nella realizzazione delle finalità dell'ordinamento, l'interesse dell'amministrazione appare
sempre congiunto con l'interesse dei singoli quanto meno nel senso che il completamento
della soddisfazione del primo esigono la più accurata costante considerazione degli
interessi dei singoli.
Se è vero, e da concludere che la norma attributiva del potere, norma agevolativa,
è direttamente e volutamente agevolativa, sia dell'interesse pubblico, sia degli interessi
dei singoli. L'attribuzione del potere della sua concreta configurazione (e cioè la
determinazione della consistenza concreta di esso) si compiono tutte le soddisfazioni
insieme dell'interesse pubblico e degli interessi privati. Nel senso che l'imposizione di
limiti al potere (il potere è, per sua natura, limitato) è operata anche a salvaguardia degli
interessi privati. L'affermazione della dottrina tradizionale che l'interesse legittimo è un
interesse protetto, di riflesso e occasionalmente, è completamente inesatta ed è precipitato
giuridico di una ideologia che assegnava all'interesse del singolo una posizione
assolutamente subordinata rispetto all’amministrazione e all'interesse di essa. Certo non è
facile stabilire quali interessi privati siano protetti dalla norma regolatrice del potere
pubblico, ma quando ciò accade è certo che gli interessi privati sono protetti
immediatamente e non solo di riflesso dalla norma organizzativa.
Fino a questo punto diritto soggettivo e interesse legittimo non si differenziano in
nulla: entrambe le situazioni sono costituite da interessi intenzionalmente protetti
dall'ordinamento. È a proposito del modo di protezione dell'interesse materiale di cui
consiste il diritto soggettivo e di quello di cui consiste l'interesse legittimo che si apre la
principale divergenza (ma non la sola: differenze ci sono e si vedranno dopo, anche nel
modo di individuazione della posizione giuridica soggettiva). Modo di protezione
significa grado (consistenza) e forme della protezione.
Ora, per quanto riguarda il primo, sappiamo che diritto soggettivo costa di poteri
atti a soddisfare pienamente (a soddisfare sempre, sia che il titolare del diritto vi possa
pervenire con il solo comportamento, e sia che egli abbisogni della collaborazione di di
altri) interesse del singolo. Per l'interesse legittimo questa soddisfazione piena e sicura
non si ha, perché se è vero che la norma, con l'attribuzione la delimitazione del potere,
tutela insieme l'interesse pubblico e gli interessi privati, da questo stesso meccanismo
discende che l'interesse pubblico, essendo tutelato attraverso l'esercizio del potere, è
tutelato immediatamente e pienamente, mentre l'interesse privato essendo tutelato
anch'esso attraverso l'esercizio del potere, risulta tutelato mediatamente ed
eventualmente: non sempre, infatti, l'esercizio del potere soddisfa l'interesse privato
essendo vero solo che alla soddisfazione dell'interesse il privato non può venire che in
seguito ed in relazione alla soddisfazione dell'interesse pubblico. Questo per il grado di
protezione. Bisogna però avvertire che sono molti i casi in cui esercizio corretto del
potere porta con sé necessariamente la soddisfazione dell'interesse privato: sono i casi in
cui, o per i caratteri della situazione di fatto (fra più aspiranti ad una concessione
amministrativa, uno solo possiede i requisiti stabiliti dalla legge) o per come è regolato
l'esercizio del potere (dovere per l'autorità amministrativa di provvedere, e di provvedere
in un certo tempo o in un certo modo), a tale esercizio non può che indirizzarsi nel senso
della soddisfazione dell'interesse privato. Bisogna anche avvertire che l'aumento di
efficacia del processo amministrativo, ottenuto soprattutto attraverso il progressivo
rafforzamento del giudizio di ottemperanza, opera anche nel senso di valorizzare sempre
più lo scopo di soddisfazione dell'interesse materiale di tale processo e quindi
contribuisce ad ampliare il contenuto e la forza incisiva dell'interesse legittimo. In questi
casi e sotto questo aspetto, l'aspettativa del privato finisce quindi per atteggiarsi quasi
come la pretesa nascente da un diritto soggettivo, ma i caratteri giuridici e i limiti della
situazione sono, in via di principio, quelli. Quanto alle forme della protezione (questo è
l'aspetto più interessante), risulta, da ciò che fin qui si è detto, che la protezione non può
consistere che nella possibilità attribuita al titolare dell'interesse di influire sull'esercizio
del potere, operando la corretta esplicazione del medesimo e intervenendo a correggere le
deviazioni. La forma principale in cui si esprime tale protezione è il potere di reagire
all'emanazione di un atto amministrativo illegittimo provocandone, in via principale e
incidentale, l’annullamento da parte del giudice amministrativo o anche il potere di
opporsi sempre in sede giurisdizionale, all'annullamento dell'atto amministrativo chiesto
dal ricorrente; ma la protezione accordata all'interesse non si manifesta solo in ciò.
Procedendo a ritroso, essa si manifesta attraverso il potere di provocare l'eliminazione di
un atto amministrativo in via amministrativa e, più indietro, attraverso il potere di
partecipazione allo stesso procedimento amministrativo e, ancora più indietro, nello
stesso potere di provocare l'esercizio del potere amministrativo e cioè di dare inizio al
procedimento amministrativo quando l'apertura di esso è di iniziativa del privato. Si tratta
quindi di possibilità tutte strumentali, ma di una gamma amplissima di possibilità
strumentali, che hanno il loro culmine nel potere di provocare l'annullamento in giudizio
dell'atto amministrativo (o di resistere a tale richiesta), e che si spiegano lungo tutto l'arco
dell'esercizio della potestà amministrativa che contribuiscono a concretare secondo le
prescrizioni della norma. Si può quindi dire che l'interesse legittimo finisce per consistere
nella possibilità di partecipazione del privato la funzione amministrativa di carattere
attivo, alla quale di qualunque formula si rivesta, in sostanza si esprime sempre nel
prospettare all'autorità amministrativa, e nel giustificare dal punto di vista delle
condizioni di fatto o del profilo del diritto, dei progetti di atto amministrativo che
l'interessato vorrebbe vedere adottati dall'autorità amministrativa; si può anche dire che
l'interesse legittimo finisce veramente per essere sotto tale profilo una pura azione (potere
o diritto di azione) purché sia chiaro che tale azione non consiste solo nel potere di agire
nel giudizio amministrativo ma un complesso di possibilità di agire sia nel giudizio sia
nel procedimento amministrativo al fine di influire sull'attività amministrativa.
Viene chiarito così quale è la funzione dell'interesse materiale del fenomeno
dell'interesse legittimo, e in che senso ed entro quali limiti il predetto fenomeno
appartenga all'ambito sostanziale e non a quello processuale. E l'interesse legittimo
appartiene all'ambito sostanziale, vuoi perché l'interesse protetto è un interesse materiale,
vuoi perché la protezione del medesimo non deriva principalmente e originariamente
dell'articolo 26 del testo unico della legge sul Consiglio di stato, il quale concede la
possibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo che stato leso in un suo interesse,
ma è avanti tutto ordita dalla norma regolatrice del potere, ed è ordita con il fatto stesso
che tale norma include anche l'interesse materiale della sua trama, al limite e
completamento del potere, ma è un ambito sostanziale dinamico, strumentale, non statico
di godimento. In tal senso è lecito accostare l'interesse legittimo a diritti soggettivi aventi
natura strumentale e (il diritto di credito anzi tutto), e in termini attuali equiparare i
rapporti amministrativi che si instaurano con una amministrazione che ha assunto
prevalentemente strutture e funzioni di uno stato di servizi, ai rapporti paritari d'ordine
interpretato. Possediamo ora gli strumenti per tentare una definizione dell'interesse
legittimo.
L'interesse legittimo è la posizione di vantaggio fatta ad un soggetto
dell'ordinamento in ordine ad una utilità oggetto di potere amministrativo e consistente
nell'attribuzione al medesimo soggetto di poteri atti ad influire sul corretto esercizio del
potere, in modo da rendere possibile la realizzazione della pretesa all'utilità.
Potrebbero piacerti anche
- Riassunti Mandrioli Primo Libro e Secondo LibroDocumento55 pagineRiassunti Mandrioli Primo Libro e Secondo LibroErion Eri CikoNessuna valutazione finora
- Filosofia Del Diritto - VernaglioneDocumento50 pagineFilosofia Del Diritto - Vernaglioneberilo1975Nessuna valutazione finora
- Dispensa Diritto PrivatoDocumento180 pagineDispensa Diritto PrivatoGaia Poggi100% (3)
- Manuale Di Scrittura AmministrativaDocumento218 pagineManuale Di Scrittura Amministrativapopozuda100% (3)
- Codificazione Diritto RomanoDocumento9 pagineCodificazione Diritto RomanocindyNessuna valutazione finora
- Tutor Magistralis. Compendio di diritto pubblico per concorsi pubblici: Per concorsi pubblici nel settore GiustiziaDa EverandTutor Magistralis. Compendio di diritto pubblico per concorsi pubblici: Per concorsi pubblici nel settore GiustiziaNessuna valutazione finora
- Docsity Appunti Lezioni Di Storia Del Diritto Italiano I Prof Ssa Sigismondi Universita La Sapienza Di Roma Canale M ZDocumento70 pagineDocsity Appunti Lezioni Di Storia Del Diritto Italiano I Prof Ssa Sigismondi Universita La Sapienza Di Roma Canale M ZmikhaelspertiNessuna valutazione finora
- GiurisprudenzaItaliana04 2010Documento256 pagineGiurisprudenzaItaliana04 2010Lawrence BoschettiNessuna valutazione finora
- Riassunti Diritto Processuale CivileDocumento126 pagineRiassunti Diritto Processuale CivileDjamilaNessuna valutazione finora
- Patti Parasociali RescioDocumento42 paginePatti Parasociali RescioCésar E. Moreno MoreNessuna valutazione finora
- Diritto Processuale Civile 1°libroDocumento84 pagineDiritto Processuale Civile 1°libroMartina De bellisNessuna valutazione finora
- Lezioni Di Filosofia Del Diritto Libro RiassuntoDocumento44 pagineLezioni Di Filosofia Del Diritto Libro RiassuntoAliceNessuna valutazione finora
- Introduzione Al Diritto Amministrativo Canonico (J)Documento25 pagineIntroduzione Al Diritto Amministrativo Canonico (J)Jhon Correa100% (1)
- Diritto PrivatoDocumento14 pagineDiritto PrivatoAlessia Cogliati100% (1)
- Appunti Di Diritto RomanoDocumento24 pagineAppunti Di Diritto Romanocandu890% (1)
- Appunti Filosofia Del Diritto-Norme, Concetti, ArgomentiDocumento91 pagineAppunti Filosofia Del Diritto-Norme, Concetti, Argomentimadririca97100% (3)
- Diritto CostituzionaleDocumento18 pagineDiritto Costituzionalealteriuris100% (2)
- Atto AmministrativoDocumento13 pagineAtto Amministrativouniroma13100% (1)
- Le Fonti Del DirittoDocumento8 pagineLe Fonti Del DirittoRenèe Antonia GilibertiNessuna valutazione finora
- Successioni - Matteo MarroneDocumento13 pagineSuccessioni - Matteo MarroneFabio G. MetisiNessuna valutazione finora
- Trabucchi Capo 1 (44 Pag.)Documento44 pagineTrabucchi Capo 1 (44 Pag.)Angela Valentino100% (1)
- Dalla Torre Lezioni Di Diritto Ecclesiastico 4 EdDocumento62 pagineDalla Torre Lezioni Di Diritto Ecclesiastico 4 EdAlberto NannettiNessuna valutazione finora
- Riassunto Pagliaro GeneraleDocumento232 pagineRiassunto Pagliaro GeneraleSilvia DchNessuna valutazione finora
- SANZIONI AMMINISTRATIVE I presupposti, il ricorso e il giudizio di opposizione: Le sanzioni amministrative e il covid 19Da EverandSANZIONI AMMINISTRATIVE I presupposti, il ricorso e il giudizio di opposizione: Le sanzioni amministrative e il covid 19Nessuna valutazione finora
- Filosofia Del DirittoDocumento43 pagineFilosofia Del DirittoMariyaNessuna valutazione finora
- Diritto Privato: La FamigliaDocumento27 pagineDiritto Privato: La FamigliaGiurisprudenzaPisaNessuna valutazione finora
- Riassunto Libro Gli Ortodossi Di Enrico MoriniDocumento29 pagineRiassunto Libro Gli Ortodossi Di Enrico MoriniDomenico De SimoneNessuna valutazione finora
- Il Positivismo GiuridicoDocumento31 pagineIl Positivismo GiuridicoPaolo Sarandi100% (1)
- Filosofia Del DirittoDocumento65 pagineFilosofia Del Dirittouncle_sam94Nessuna valutazione finora
- Riassunto Di Filosofia Del Diritto RossDocumento19 pagineRiassunto Di Filosofia Del Diritto RossMassimo BelibaniNessuna valutazione finora
- Romano - Marrone 2Documento56 pagineRomano - Marrone 2acidfrehmour100% (1)
- Dispensa Diritto Ecclesiastico Finocchiaro Ottima Recente 2013Documento83 pagineDispensa Diritto Ecclesiastico Finocchiaro Ottima Recente 2013Massimo Belibani0% (1)
- 7.nozioni Di Diritto CivileDocumento12 pagine7.nozioni Di Diritto CivileJosephmetalNessuna valutazione finora
- Appunti - Istituzioni Di Diritto Privato (Galgano)Documento63 pagineAppunti - Istituzioni Di Diritto Privato (Galgano)Beniamino AmitranoNessuna valutazione finora
- Sintesi FinocchiaroDocumento127 pagineSintesi Finocchiaroceccone23Nessuna valutazione finora
- Appunti Di Diritto Privato PDFDocumento91 pagineAppunti Di Diritto Privato PDFFrancescoNessuna valutazione finora
- RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA. Le novità in vigore dal 22.6.2022 introdotte dalla l. 26.11.2021, n. 206Da EverandRIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA. Le novità in vigore dal 22.6.2022 introdotte dalla l. 26.11.2021, n. 206Nessuna valutazione finora
- Diritto RomanoDocumento24 pagineDiritto RomanoAlexandra ValtellinaNessuna valutazione finora
- Il Negozio GiuridicoDocumento7 pagineIl Negozio GiuridicoMariaCristinaZuppelliNessuna valutazione finora
- Fondam Diritto Europeo MaruottiDocumento58 pagineFondam Diritto Europeo MaruottiPierpaolo GaudioNessuna valutazione finora
- Sistemi Giuridici Comparati CSX PDFDocumento129 pagineSistemi Giuridici Comparati CSX PDFMiłosz A. LipowieckiNessuna valutazione finora
- Appunti Sociologia Del DirittoDocumento28 pagineAppunti Sociologia Del Dirittojeanne9494Nessuna valutazione finora
- Guida Alla Redazione Della Tesi Di LaureaDocumento14 pagineGuida Alla Redazione Della Tesi Di LaureaAntea AssociazioneNessuna valutazione finora
- Sociologia Del DirittoDocumento42 pagineSociologia Del DirittoStefano ArnaldiNessuna valutazione finora
- Appunti Diritto Processuale Civile MandrioliDocumento157 pagineAppunti Diritto Processuale Civile MandriolikinkyersNessuna valutazione finora
- Diritto Romano e CristianesimoDocumento5 pagineDiritto Romano e CristianesimodonpedrodetoledoNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto Del LavoroDocumento113 pagineRiassunto Diritto Del LavoroAlessandra PignataroNessuna valutazione finora
- Diritto Privato 1 F Ruscello - SintesiDocumento127 pagineDiritto Privato 1 F Ruscello - SintesiRiccardo RosaNessuna valutazione finora
- Lineamenti Di Diritto Processuale PenaleDocumento220 pagineLineamenti Di Diritto Processuale PenaleMichela CarrieroNessuna valutazione finora
- L'interpretazione Dei Documenti Normativi-GuastiniDocumento61 pagineL'interpretazione Dei Documenti Normativi-GuastiniFrancesca Iervolino100% (2)
- Diritto InternazionaleDocumento63 pagineDiritto Internazionalecristina laeraNessuna valutazione finora
- Diritto TributarioDocumento84 pagineDiritto Tributariopietro marraNessuna valutazione finora
- Diritto Pubblico Appunti LezioniDocumento92 pagineDiritto Pubblico Appunti LezioniMiko ArzoNessuna valutazione finora
- Filosofia Del Diritto, Barberis HartDocumento88 pagineFilosofia Del Diritto, Barberis HartArdita BitiNessuna valutazione finora
- Compendio Diritto CostituzionaleDocumento75 pagineCompendio Diritto CostituzionaleFederica Lorenza PerpignanoNessuna valutazione finora
- Diritto e Giustizia Di Alf RossDocumento13 pagineDiritto e Giustizia Di Alf RossSilvio Giovannini100% (1)
- Delitti Contro La Persona - Diritto PenaleDocumento63 pagineDelitti Contro La Persona - Diritto PenaleChiara Gammaitoni100% (1)
- RisarcimentiDocumento4 pagineRisarcimentiuniroma13Nessuna valutazione finora
- Legge Abolitrice Contenzioso AmministrativoDocumento1 paginaLegge Abolitrice Contenzioso Amministrativouniroma13Nessuna valutazione finora
- Diritto Soggettivo Ed Interesse LegittimoDocumento8 pagineDiritto Soggettivo Ed Interesse Legittimouniroma13Nessuna valutazione finora
- CostituzDocumento87 pagineCostituzuniroma13Nessuna valutazione finora
- Luiss Libera Università Internazionale Degli Studi SocialiDocumento2 pagineLuiss Libera Università Internazionale Degli Studi Socialiuniroma13Nessuna valutazione finora
- Ricorso Tar 2Documento3 pagineRicorso Tar 2uniroma13Nessuna valutazione finora
- Luiss Libera Università Internazionale Degli Studi SocialiDocumento2 pagineLuiss Libera Università Internazionale Degli Studi Socialiuniroma13Nessuna valutazione finora
- Ricorso TARDocumento3 pagineRicorso TARuniroma13Nessuna valutazione finora
- CostituzDocumento87 pagineCostituzuniroma13Nessuna valutazione finora