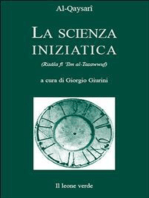Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Ismail Considerazioniteorichee 2020
Ismail Considerazioniteorichee 2020
Caricato da
Ulisse SantusTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Ismail Considerazioniteorichee 2020
Ismail Considerazioniteorichee 2020
Caricato da
Ulisse SantusCopyright:
Formati disponibili
Considerazioni teoriche e critiche sull’imitazione parodica (al-Muʿāraḍa al-hazliyya) in epoca
mamelucca
Author(s): Nasser Ismail
Source: Quaderni di Studi Arabi , 2020, Vol. 15, No. 1/2, Arab(ic) Linguistics and Beyond
(2020), pp. 313-337
Published by: Istituto per l'Oriente C. A. Nallino
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/10.2307/27268522
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
Istituto per l'Oriente C. A. Nallino is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend
access to Quaderni di Studi Arabi
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
QSA
brill.com/qsa
Considerazioni teoriche e critiche sull’imitazione
parodica (al-Muʿāraḍa al-hazliyya) in epoca
mamelucca
Nasser Ismail
Professore associato, Dipartimento di Lingue e Culture Moderne,
Università degli Studi di Genova, Genova, Italia
nasser.ismail@ymail.com
Abstract
Classical and modern studies of Arabic literature have paid only modest attention to
the parodic imitations of poems (al-muʿāraḍa al-hazliyya). These were often ascribed
to the rhetorical technique of taḍmīn without taking into due consideration, as was the
case for “serious” reproductions, the semantic, historical and dialectical interaction
between the two texts, their authors and readers. The present article will attempt to
trace the theoretical and critical notions of this literary practice in the Arab tradition,
particularly focusing our interest on the Mamlūk one which tended to acknowledge
and confer upon it the dignity of a literary genre.
Keywords
Muʿāraḍa – parody – Mamluk literature – al-Ǧazzār – Ibn Makānis
Afffrontando il tema dell’imitazione parodica (al-muʿāraḍa al-hazliyya) non
si può non notare la pressoché completa corrispondenza semantico-lessicale
tra i due termini enantiosemici greco e arabo indicanti questa modalità1 e che
1 Dalle prime traduzioni in lingua araba della Poetica di Aristotele in epoca abbaside si può
desumere l’assenza di un’eventuale influenza o un legame tra i due termini succitati. Mattà
b. Yūnus (m. 328/940), autore della più antica traduzione sopravvissuta, tradusse erronea-
mente il termine “parodia”, citato da Aristotele, con “madīḥ” (encomio), mentre i successivi
commentatori ed epitomatori lo ignorarono. Cfr. Badawī, Fann al-šiʿr, p. 89.
© Koninklijke Brill NV, Leiden, 2020 | doi:10.1163/2667016X-15010217
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
314 Ismail
veicolano allo stesso momento due signifijicati opposti, ossia la similitudine e
la contrapposizione (para-odè: accanto/contro-poesia = muʿāraḍa: muḥāḏāh/
muqābala – afffijiancamento/confronto/contrasto/competizione/emulazione).2
Tuttavia, diversamente dalla tradizione occidentale, che ha sovente adoperato
il termine “parodia” per defijinire le imitazioni befffarde e ingannevoli,3 quella
araba classica e medievale fu più tassativa nel riconoscere come muʿāraḍa4
solo poesie completamente conformi alle originali non solo sul piano della
struttura, del motivo, del contenuto ma anche del registro.5 Le riproduzioni
poetiche che proponevano un travestimento o una rivisitazione incongruente
di un ipotesto venivano spesso, soprattutto nel periodo abbaside, snobbate o
ascritte semplicemente alla categoria retorica del procedimento citazionale
taḍmīn,6 senza tenere in gran conto l’interazione semantica, storica e dialettica
tra le due opere e i rispettivi autori e lettori. Analogamente, gli studi moderni di
letteratura araba hanno riservato una modesta attenzione alle contrafffazioni
capovolte, relegandole alla sfera del riso (taḥāmuq)7 o a un mero desiderio
artistico di “challenge of parodying”8 o di “mocking the poetic convention-
s”.9 Il presente articolo si prefijigge di rintracciare le nozioni teoriche e critiche
riguardo a questa prassi poetica nella tradizione classica e medievale araba,10
rivolgendo maggior interesse a quella mamelucca che, come cercheremo di
provare, tese a rivalorizzarla e a conferirle la dignità del genere letterario.
2 Cfr. Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿarab, vol. VII, p. 167-168; Hutcheon, “Ironie, satire, parodie”,
p. 143; Hutcheon, A Theory of Parody, p. 32.
3 Sangsue, La parodia, p. 14.
4 Per una più ampia defijinizione lessicale del termine muʿāraḍāt cfr. Sallūm, al-Muʿāraḍāt fī
l-šiʿr al-andalusī, p. 41-48; Van Gelder, “Muʿāraḍa”, EAL, vol. II, p. 534; Schippers, “Muʿāraḍa”,
EI2, vol. VII, p. 261.
5 Cfr. Von Grunebaumm, “The Concept of Plagiarism”, p. 242; al-Šāyib, Tārīḫ al-naqāʾiḍ, p. 7;
ʿAwaḍayn, al-Muʿāraḍa fī l-adab al-ʿarabī, p. 24; Haxen, “The Muʿāraḍa concept”, p. 113-115;
Van Gelder, “Muʿāraḍa”, EAL, vol. II, p. 534.
6 È interessante sottolineare che nell’antica Grecia il termine parodia si riferiva tra l’altro
anche alla tecnica di citazione di un brano epico o tragico all’interno di un poema satirico
o eroicomico. Cfr. Householder, “Π APΩ IΔ IA”, p. 3; Sangsue, La parodia, p. 21-22.
7 al-Ǧammāl, al-Adab al-ʿāmmī fī Miṣr, p. 194-195.
8 Antoon, The Poetics of the Obscene, p. 45.
9 Larkin, “Popular Poetry”, p. 224.
10 In questo studio ci limiteremo alla trattazione del concetto e della modalità di muʿāraḍa
hazliyya così come è conosciuta nella letteratura araba nella sua accezione tradizionale,
ossia il travestimento burlesco di una data poesia. Non afffronteremo invece contrafffazioni
nel senso più lato che comprenderebbero parodie di generi, convenzioni e stili letterari o
di modi di parlare e di agire di una persona o di un certo gruppo sociale. Sulla parodia nel
periodo abbaside nel suo senso più estensivo cfr. Szombathy, Mujūn, p. 150-154.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Considerazioni teoriche e critiche sull ’ imitazione parodica 315
Col volgere al termine del IV/X sec., tra i critici arabi si era ormai consoli-
data la vecchia convinzione che la poesia avesse raggiunto il suo apice e che i
margini di un eventuale rinnovamento contenutistico ed espressivo si fossero
talmente assottigliati da rendere sempre più arduo, o perfijino vano, l’impegno
dei poeti coevi e posteriori. Tale rassegnazione dinanzi all’insuperabile perfe-
zione del retaggio letterario è testimoniata a più riprese nei testi dei teorici più
signifijicativi, in modo particolare quando si doveva trattare l’annosa disputa del
plagio (al-sariqa).11 In un’ottica sempre più permissiva e tollerante verso que-
sta pratica difffusa, al-Qāḍī al-Ǧurǧānī (m. 392/1001), in un passaggio emblema-
tico del suo studio critico su al-Mutanabbī (m. 354/965), giustifijicò la presenza
di frequenti influenze, ispirazioni e prestiti nei testi poetici:
Se devo essere sincero, i nostri contemporanei e quelli successivi dovreb-
bero essere più compresi e meno biasimati a questo riguardo. Coloro
che sono stati prima di noi si sono appropriati delle idee, in quanto a
noi antecedenti, e ne hanno esaurito la maggior parte. Non ne è rimasto
che qualche rimasuglio, poco ambito perché di scarso valore o di difffijicile
trattazione […]. Ogniqualvolta uno di noi si sforza e impegna il proprio
pensiero nel trovare un’idea (maʿnà) nuova e originale per comporre un
verso innovato, va poi a sfogliare i vari canzonieri e ne trova di certo uno
identico o simile […]. Per questa ragione vieto a me stesso e agli altri di
accusare qualsiasi poeta di plagio.12
Una posizione sostanzialmente simile fu proposta da al-Āmidī (m. 370/980),13
da Abū Hilāl al-ʿAskarī (m. 395/1005)14 e da Ibn Rašīq (m. 456 o 463/1064 o
1071).15 Al-ʿAskarī, come anche al-Qāḍī al-Ǧurǧānī, arrivò a suggerire ai poeti
avveduti (ḥāḏiq) e scaltri di camufffare o di occultare i loro “plagi”, in modo
da renderli meno identifijicabili e potersi perfijino guadagnare il merito dell’idea
contrafffatta.16
Orbene, la diatriba si chiuse con “its recognition of the best poet as a good
plagiarist of meanings and an original creator of techniques and styles”.17
L’afffermazione del diritto dei poeti di poter razziare a piacimento “every other
11 Cfr. Von Grunebaum, “The Concept of Plagiarism”, p. 234-253.
12 ʿAbd al-ʿAzīz al-Ǧurǧānī, al-Waṣāṭa, p. 214-215.
13 al-Āmidī, al-Muwāzana, p. 55-56.
14 al-ʿAskarī, Kitāb al-ṣināʿatayn, p. 196; Kanazi, Studies in the Kitāb Aṣ-Ṣinā‘atayn, p. 112-114.
15 al-Qayrawānī, al-ʿUmda, vol. II, p. 280-294.
16 Cfr. anche Ibn Ṭabāṭabā, ʿĪyār al-šiʿr, p. 80-81.
17 al-Musawi, Arabic Poetry, p. 46.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
316 Ismail
poetic territory”,18 l’eccessivo culto della poesia del passato nonché il ripetuto
richiamo a quel senso di impossibilità di rigenerazione contenutistica anda-
vano di pari passo con il riconoscimento e il consolidamento di vecchie pra-
tiche letterarie imitative. Nella faticosa ricerca dell’autoafffermazione, ogni
poeta poteva mostrare la propria piena assimilazione del patrimonio poetico,
prendendo in prestito spunti intertestuali impliciti ed espliciti.19 Qualunque
poesia precedente o coeva di un certo valore e fama si trasformava in un ipote-
sto a cui altri autori potevano ispirarsi legittimamente, citando, a piene mani
e senza tecniche dissimulative, emistichi o interi versi nell’ipertesto (taḍmīn,
īdāʿ, tašṭīr),20 oppure potevano esporre lo stesso argomento adoperando una
struttura identica di metro e rima (muʿāraḍa).
In questo contesto si potrebbero comprendere le raccomandazioni del can-
celliere e teorico di tarda epoca abbaside, Ḍiyāʾ al-Dīn b. al-Aṯīr (m. 637/1239),
che citò esplicitamente il procedimento muʿāraḍa con la sua accezione più
ristretta, ovvero come esercizio imitativo fijinalizzato all’acquisizione di compe-
tenze poetiche e prosastiche. Rivolgendosi agli aspiranti scrittori (mutadarrib,
mubtadiʾ, mutraššiḥ)21 che muovevano i primi passi nel mondo delle lettere,
Ibn al-Aṯīr li esortava a cimentarsi nelle muʿāraḍāt poiché costituivano un
modo efffijiciente e profijicuo per imparare e allenarsi a scrivere:
Il novizio in quest’arte […] deve procurarsi un’epistola o una poesia,
osservare i suoi signifijicati, capirla da cima a fondo e fijissare tutto nella
propria memoria (qalb). Dopodiché, che si impegni a comporre un pezzo
di contenuto simile, sostituendo ogni parola [del testo originale] con
un’altra equivalente e di un signifijicato afffijine di propria invenzione e pro-
segua in questo modo per tutto il testo. […] una volta che il lavoro è com-
pletato, passi a un altro testo e attui nuovamente lo stesso procedimento.
Egli continui a dedicarsi costantemente all’emulazione [muʿāraḍa] delle
epistole, se è segretario, o delle poesie, se è poeta, fijinché arriverà a matu-
rare cotanta esperienza, la sua indole familiarizzerà con il genere e la sua
mente avrà assoluta dimestichezza con esso.22
Sorprendentemente, sembra che agli studiosi arabi classici, molto attenti
a delineare i plurimi aspetti storici, tecnici, fijilologici, critici ed estetici della
18 Ibid.
19 Cfr. al-Taṭāwī, al-Muʿāraḍāt al-šiʿriyya, p. 21.
20 Cfr. Van Gelder, “Taḍmīn”, EI2, vol. X, p.78-79; Bosworth, “Tak̲h̲mīs”, EI2, vol. X, p. 123-125.
21 Ibn al-Aṯīr, al-Ǧāmiʿ al-kabīr, p. 26.
22 Ivi, p. 26-27.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Considerazioni teoriche e critiche sull ’ imitazione parodica 317
poesia, fosse del tutto sfuggito di addurre precisazioni terminologiche e teori-
che su questa importante tipologia. I primi riferimenti a nostra disposizione
evidenziano la tendenza in ambito letterario ad adoperare il termine muʿāraḍa
con il signifijicato tecnico di imitazione seria come nel caso preciso dell’opera
andata perduta Ṯaʿla wa-ʿAfra (o Ṯuʿla wa-ʿUfra), composta da Sahl b. Hārūn
(m. 215/830) sulla falsariga di ( fī muʿāraḍat) Kalīla wa-Dimna.23 Gli accenni
più signifijicativi in merito si trovano in manuali di retorica e di esegesi (tafsīr)
e si limitano a spiegarne sbrigativamente la modalità di “non-realizzazione”,
principalmente in contesto coranico: “fa-ammā muʿāraḍat al-kitāb fa-ʿarḍ
wāḥid ʿalà l-āḫar ḥattà yastawiyā (la muʿāraḍa tra due testi consiste nell’ac-
costare l’uno all’altro fijinché diventano simili).24 Tra i teorici che cercarono
di focalizzare il concetto di muʿāraḍa e distinguerlo dal plagio, indagando
sullo spinoso argomento della riproduzione del Corano, vi fu ʿAbd al-Qāhir
al-Ǧurǧānī (m. 471/1078).25 In due singolari passaggi sul tema, il retorico abba-
side afffermò che l’imitazione dovesse riguardare i concetti e le idee e non limi-
tarsi a una sostituzione sinonimica della forma lessicale (muʿāraḍa min ǧiha
tarǧiʿ ilà maʿānī l-kalām al-maʿqūla dūna alfāẓi-hi al-masmūʿa), altrimenti il
nuovo testo sarebbe fijinito per diventare una semplice traduzione (tarǧama)
o una spiegazione (tafsīr) dell’altro.26 Tuttavia, precisò al-Ǧurǧānī, una ripro-
duzione che proponeva degli enunciati (kalām)27 sintatticamente e gramma-
ticalmente composti in modo diverso (naẓm wa-tartīb), pur adoperando dei
sinonimi lessicali, non sarebbe mai potuta essere identica al proprio ipotesto.28
In sintesi, quando si voleva imitare un testo, l’anelito di creatività dell’autore
poteva ancora esprimersi, se non tramite immagini e artifijici nuovi, con una
composizione diversa che implicava inevitabilmente sfumature di signifijicato
diffferenti.29 Uno dei riferimenti più rilevanti, e per altre ragioni discussi dagli
studiosi moderni,30 che mette in risalto la pratica di muʿāraḍa è quello di Abū
Isḥāq al-Ḥuṣrī al-Qayrawānī (m. 413/1022). In un breve cenno nella sua rac-
colta di adab, il letterato nordafricano attribuì la nascita del genere maqāmāt
al desiderio di Badīʿ al-Zamān al-Hamaḏānī (m. 398/1008) di imitare alcuni
23 al-Ǧāḥiẓ, al-Bayān wa-l-tabyīn, vol. I, p. 52.
24 al-Ṣūlī, Adab al-kuttāb, p. 129.
25 Cfr. Peled, “On the Concept of Literary Influence”, p. 45-46.
26 ʿAbd al-Qāhir al-Ǧurǧānī, Dalāʾil al-iʿǧāz, p. 259.
27 Sul concetto di Kalām nel pensiero di ʿAbd al-Qāhir al-Ǧurǧānī cfr. Ghersetti, “Word in the
linguistic thinking of ʿAbd al-Qāhir al-Jurjānī”, p. 85-108.
28 ʿAbd al-Qāhir al-Ǧurǧānī, Dalāʾil al-iʿǧāz, p. 260-261.
29 Ivi, p. 265.
30 Cfr. questo passaggio in Hämeen-Anttila, Maqama, p. 67.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
318 Ismail
aneddoti scritti da Ibn Durayd al-Azdī (m. 321/933): “ʿāraḍa-hā bi-arbaʿimiʾat
maqāma fī l-kudya”.31
Data la generale indiffferenza teorica dei classici verso questo genere,32 la
maggior parte degli studiosi moderni deducono che, in linea di massima, per
essere considerato muʿāraḍa, un componimento doveva necessariamente con-
dividere con l’ipotesto gli elementi strutturali, ossia metro e rima, nonché l’ar-
gomento e il registro che di norma era serio.33 Il che può essere dimostrato
dalla frequente presenza di questo termine nei testi critici e antologici per
introdurre dei versi emulativi che rispettavano tali criteri.34 In realtà, fijin dall’i-
nizio, la prospettiva critica di muʿāraḍāt sembrava voler riconoscere soltanto
le riproduzioni “positive” che, in segno di assoluta ammirazione, intendevano
esaltare il modello ispiratore conformandosi ai suoi canoni formali e alla sua
tematica (ġaraḍ). Tali composizioni venivano tuttavia spesso riportate e ana-
lizzate come copie subordinate quasi servili, interessanti in gran parte dei casi
in un quadro di confronto (tafāḍul-mufāḍala) tra l’originale e il contrafffatto.35
Pare che questa posizione categorica interpretasse in parte il rifijiuto ideolo-
gico da parte di teorici e retorici di qualsiasi confronto tra il Corano e un altro
testo parodico a esso ispirato (muʿāraḍat al-Qurʾān). A conferma di tale suppo-
sizione sta il fatto che, come è stato detto, gran parte della già limitata specu-
lazione teorica su questo procedimento si concentrava sulla defijinizione della
natura testuale e letteraria di versi scritti in imitazione del Corano da qualche
autore abbaside, come al-Mutanabbī e al-Maʿarrī (m. 449/1058).
A questo riguardo appare molto esplicativa la descrizione del retorico Yaḥyà
b. Ḥamza al-ʿAlawī (m. 749/1348) della caratteristica essenziale che ci conduce
a ritenere muʿāraḍa un certo testo. La sua riflessione puntava in primo luogo
a escludere che una riproduzione – nel caso specifijico di alcuni versi simili al
Corano – potesse essere iscritta alla muʿāraḍa qualora non fosse stata simile
o confondibile con il suo originale: “al-muʿāraḍa bayna l-kalāmayn innamā
takūn muʿāraḍa iḏā kāna bayna-humā muqāraba wa-mudānāh bi-ḥayṯ yaltabis
aḥadu-humā bi-l-āḫar aw yakūn aḥadu-humā muqāriban li-l-āḫar (la muʿāraḍa
tra due discorsi si verifijica quando essi sono simili o afffijini al punto che l’uno si
31 al-Ḥuṣrī, Zahr al-ādāb, vol. I, p. 315.
32 Meisami, Structure and Meaning, p. 273.
33 al-Šāyib, Tārīḫ al-naqāʾiḍ, p. 7; ʿAwaḍayn, al-Muʿāraḍa fī l-adab al-ʿarabī, p. 24; Von
Grunebaumm, “The Concept of Plagiarism”, p. 242.
34 Cfr. al-Ḥuṣrī, Zahr al-ādāb, vol. II, p. 44; Ibn Diḥya, al-Muṭrib, p. 113; al-Mustaʿṣimī, al-Durr
al-farīd, vol. V, p. 442; vol. VII, p. 84; vol. IX, p. 99; al-Nuwayrī, Nihāyat al-arab, vol. II,
p. 249.
35 ʿAbd al-Qāhir al-Ǧurǧānī, Dalāʾil al-iʿǧāz, p. 260.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Considerazioni teoriche e critiche sull ’ imitazione parodica 319
può confondere con l’altro o gli diventa somigliante).36 I versi apocrifiji, secondo
al-ʿAlawī, erano certamente di qualità inferiore (nuzūl al-qadr) e caratterizzati
da “ḫalāʿa” (indecenza) e “ḥamāqa” (stupidaggine) e pertanto non si pote-
vano in alcun modo ascrivere al genere muʿāraḍa del testo sacro “fa-iḏā kāna
l-kalāmān fī ġāyat al-buʿd wa-l-inqiṭāʿ fa-lā yuʿaddu aḥadu-humā muʿāriḍan
li-l-āḫar”.37 Partendo dalla convinzione condivisa in ambito ortodosso dell’ini-
mitabilità stilistica e contenutistica del Corano (iʿǧāz)38 e dal presupposto che
nessun autore avrebbe osato imitarlo in maniera seria per sfijida o per emula-
zione, ogni altra riproduzione con un registro “non serio” non sarebbe stata in
alcun modo giudicata né accostabile né rafffrontabile.
Le imitazioni poetiche che miravano al capovolgimento del messaggio,
facendo leva sull’ironia e sul sarcasmo, come quelle dei famosi parodisti abba-
sidi, Abū Ḥukayma (m. 239-240/854), Ibn Sukkara al-Hāšimī (m. 385/995),
Ibn al-Ḥaǧǧāǧ (m. 391/1001) e Abū al-Ḥasan ʿAlī b. ʿAbd al-Wāḥid Ṣarīʿ al-Dilāʾ
(m. 412/1021), seppur note e accattivanti per il loro contenuto umoristico e
befffardo, non conobbero tanta fortuna nelle antologie e nei manuali di reto-
rica classici, forse per il loro contenuto eccessivamente insolente e osceno
o perché considerate superfijiciali e poco autentiche. Anche i componimenti
segnalati in alcune raccolte di epoca abbaside, a causa del rovesciamento del
tema e del registro usato, non venivano comunque etichettati come muʿāraḍa
e quindi non rientravano in detta categoria, né potevano essere riportati in
sede di comparazione critica o artistica.39 Per esempio la parodia scritta da
Abū Bakr al-Ṣūlī (m. 335/946) della Muʿallaqa di Imruʾ al-Qays (m. c. 550), rite-
nuta probabilmente la poesia più imitata nella letteratura araba,40 fu classifiji-
cata da Ibn Rašīq e da altri critici successivi sotto la categoria intertestuale di
taḍmīn,41 perché il letterato abbaside aveva citato ad verbum l’emistichio inau-
gurale qifā nabki nell’ipertesto.42 Ibn Rašīq mostrò il proprio apprezzamento
per la deviazione del tema (wa-aǧwad min-hu an yaṣrif al-šāʿir al-muḍammin
waǧh al-bayt al-muḍamman ʿan maʿnà qāʾili-hi ilà maʿnā-h) dall’ubi sunt al
lamento scherzoso per la lunga attesa davanti alla porta dell’emiro, ma non
36 al-ʿAlawī, al-Ṭirāz li-asrār al-balāġa, vol. III, p. 214.
37 Ibid.
38 Cfr. Campanini, Il Corano e la sua interpretazione, p. 33-36.
39 Cfr. Szombathy, Mujūn, p. 124-128.
40 Stetkevych, The Mute Immortals Speak, p. 241; Meisami, “Imruʾ al-Qays Praises the
Prophet”, p. 223.
41 Su questo procedimento intertestuale cfr. Gully, “Taḍmīn, ‘Implication of Meaning’”,
p. 466-480; Sanni, “Again on Taḍmīn”, p. 7-13; Meisami, Structure and Meaning, p. 271-273.
42 al-Qayrawānī, al-ʿUmda, vol. II, p. 86. Cfr. i versi di Abū Bakr al-Ṣūlī in Meisami, Structure
and Meaning, p. 272; cfr. la Muʿallaqa di Imruʾ al-Qays in Stetkevych, The Mute Immortals
Speak, p. 249-257; Amaldi, Le Muʿallaqàt, p. 33 ss.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
320 Ismail
riconobbe la nuova poesia, identica all’originale per rima e metro, come una
muʿāraḍa.43 Parimenti, Ibn al-Muʿtazz (m. 296/908) preferì defijinire la parodia
del poeta abbaside al-Faḍl al-Raqāšī (m. c. 200/815) scritta in risposta a una
poesia autoelogiativa dell’emiro Abū Dulaf al-ʿIǧlī (m. c. 226/841) come una
“controproposta” (iǧāba) molto simile alle naqā’iḍ.44 Data l’anomalia tipolo-
gica di queste riproduzioni, una loro attribuzione alternativa al genere hazlī
(comico-scherzoso) o a quello di muǧūn/suḫf (sciocchezze),45 oltre che alla
sezione destinata al taḍmīn e ad altri procedimenti citazionali analoghi, diven-
terebbe naturalmente comprensibile.
Nei XIII-XVI secoli si può percepire una visione critica relativamente
diversa delle imitazioni serie o parodiche. Come si è già visto, Ibn al-Aṯīr fu fra
i primi teorici a promuovere in modo articolato la muʿāraḍa come strumento
necessario per “innestare” la predisposizione poetica ed esercizio fondamen-
tale sulle regole compositive per gli aspiranti poeti e scrittori. L’emulazione dei
capolavori del patrimonio poetico costituiva invero uno stimolo rilevante per i
poeti del periodo mamelucco, più di quanto lo fosse stato per quelli omayyadi
o abbasidi. Il ricordo dell’epoca d’oro e dei suoi personaggi religiosi, dei poeti
leggendari, degli eroi politici e militari condusse gli autori successivi a richia-
marli in composizioni letterarie contrafffatte, destinate a diventare un campo
di tensione e di confronto tra passato e presente.46 La mimesi seria doveva
servire a questo punto “as a means to determine one’s relation with the past,
to enter into a dialogue with its central texts, to introduce their message into
contemporary discourse and to adapt it to the then prevailing tastes”.47 Questo
fu il caso di al-Burda, “probably the most celebrated poem ever composed in
Arabic”,48 oltre che tra le più imitate, del poeta e mistico egiziano al-Būṣīrī
(m. 694-6/1294-7).49 Essa fu a sua volta una muʿāraḍa tradizionale di un noto
componimento di Ibn al-Fāriḍ (m. 632/1235) e un’evocazione dell’episodio in
cui il Profeta, sei secoli prima, aveva dato in dono il proprio manto a Kaʿb b.
Zuhayr (m. 24/644?). Un’ulteriore dimostrazione dell’importanza speciale
rivestita dalle muʿāraḍāt in epoca mamelucca è data dal grande successo di
pubblico e critica delle diverse imitazioni di maqāmāt50 e di badīʿiyyāt (il
43 al-Qayrawānī, al-ʿUmda, vol. II, p. 85.
44 Cfr. Ibn al-Muʿtazz, Ṭabaqāt, p. 227; Szombathy, Mujūn, p. 119.
45 Così hanno fatto anche alcuni studiosi moderni tra cui Zoltan Szombathy nel suo saggio
sul muǧūn nella società e letteratura arabo-islamica medievale.
46 al-Baldāwī, “al-Muʿāraḍāt al-šiʿriyya”, p. 342.
47 Bauer, “Mamlūk Literature: Misunderstandings”, p. 114.
48 Homerin, “Arabic religious poetry”, p. 86.
49 Cfr. Stetkevych, “From Jāhiliyyah to Badīʿiyyah”, p. 225; Abū Zayd, al-Badīʿiyyāt, p. 223.
50 Ḍayf, al-Maqāma, p. 76-78; Hämeen-Anttila, Maqama, p. 185, 344.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Considerazioni teoriche e critiche sull ’ imitazione parodica 321
componimento poetico di madīḥ nabawī) testimoniato dalla molteplicità di
poeti e autori che ci si cimentarono, nonché dalla persistenza di questi due
generi fijino all’epoca moderna.51
Allo stesso modo, a quel tempo i testi di riproduzione grottesca incontra-
rono un certo favore tra la critica in conformità con un’inclinazione crescente
pressoché generalizzata, e iniziata già alcuni secoli prima, verso la valoriz-
zazione della comicità52 (e altri termini e accezioni convenzionali adoperati
spesso indiffferentemente, come suḫf, hazl, mazḥ, duʿāba, fukāha, suḫriya,
tahakkum, muǧūn)53 quale aspetto fondamentale della vita reale degli autori
e della società.54 In assenza dei mecenati tradizionali, si assistette a una sensi-
bile degenerazione socio-economica della classe dei letterati. Grazie all’alfabe-
tizzazione, tale fenomeno coincise paradossalmente con la crescita tra le fasce
medio basse della quota dei produttori e dei consumatori delle arti letterarie
e con il naturale modifijicarsi delle loro preferenze in relazione ai generi e ai
topoi.55 Il poeta, in molti casi, non era più il rappresentante di una comunità
o un importante letterato cortigiano come nelle epoche precedenti, bensì un
personaggio della classe media o bassa e “an actor whose best role was some
form of institutionalized disorder”.56 Il genere parodico non poteva certamente
non partecipare a tutti questi cambiamenti profondi. All’ammirazione incon-
dizionata del mito del passato riverberata nell’imitazione seria si sottrassero
numerosi poeti coevi che da un lato manifestavano la propria disperazione di
non poterne fare parte e dall’altro ne rievocavano esperienze poetiche al fijine
però di confutare la pretesa di universalità in circostanze e coordinate socio
storiche diffferenti.
D’altro canto, in diversi manuali di retorica di questo periodo si ravvisa il
consolidarsi della percezione del hazl come procedimento espressivo, lettera-
rio e retorico dalla natura semantica e pragmatica contraddittoria,57 in modo
molto simile alla parodia così come è intesa oggi: “usually makes its point by
employing a serious style to express an incongruous subject thus disturbing
the balance of form and matter”58 e “riferire parole conosciute assegnando
51 Abū Zayd, al-Badīʿiyyāt, p. 223.
52 Cfr. Pellat, “Seriousness and Humour in Early Islam”, p. 356.
53 Per un’ampia trattazione del concetto di muǧūn cfr. Szombathy, Mujūn, p. 35-41. Per una
defijinizione degli altri termini e forme espressive cfr. Antoon, The Poetics of the Obscene,
p. 7-19.
54 Ḍayf, Fī l-šiʿr wa-l-fukāha, p.71-72; Bauer, “Mamlūk Literature: Misunderstandings”, p. 111.
55 Cfr. Bauer, “Mamlūk Literature: Misunderstandings”, p. 109-111; Bauer, “Ayna hādhā min
al-Mutanabbī”, p. 7.
56 Hamori, On the Art of Medieval Arabic Literature, p. 38.
57 Cfr. Van Gelder, “Arabic Debates of Jest and Earnest”, p. 200-201.
58 Falk; Beare, “Parody”, p. 183.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
322 Ismail
loro un senso diverso da quello che avevano in origine”.59 In questo contesto,
vale la pena ricordare due modalità espressive identifijicate da alcuni retorici
classici ed esposte con maggior enfasi dai loro successori di epoca mamelucca
(Ibn Abī al-Iṣbaʿ m. 654/1256, Yaḥyà b. Ḥamza al-ʿAlawī e Ibn Ḥiǧǧa al-Ḥamawī
m. 837/1433) in termini riconducibili all’incongruenza e all’inconsistenza tra
i signifijicati letterali trasmessi dalla superfijicie dell’enunciato e l’intenzione
metatestuale dell’autore.60 Fu probabilmente al-Ǧāḥiẓ (m. 255/868-9), in
Risālat al-tarbīʿ wa-l-tadwīr,61 (poi seguito da Ibn al-Muʿtazz)62 il primo a sot-
tolineare l’esistenza di due “espedienti” che consistevano nel comporre un
discorso dal registro comico o serio ma con un messaggio recondito profon-
damente opposto di critica (ḏamm) o di elogio (madḥ), fornendo le defijini-
zioni adoperate più tardi nei trattati di retorica hazl yurād bi-hi ǧidd (burla
dall’obbiettivo serio) e ǧidd yurād bi-hi hazl (serietà dall’obiettivo burlesco).63
A quest’ultimo procedimento, costituito da un registro apparentemente serio
ma a un livello soggiacente principalmente intenzionato a deridere una persona
o un certo comportamento, Ibn Abī al-Iṣbaʿ e i retorici successivi attribuirono
la nota denominazione “tahakkum”, che nei manuali veniva sovente associata
ad altre accezioni reputate sinonimiche quali “hazʾ-istihzāʾ e suḫriya”.64 Tra le
varie e relative denominazioni della tassonomia retorica araba, forse per la sua
economicità lessicale, al-tahakkum65 incontrò in seguito una larga difffusione
per descrivere ogni caso in cui si diceva a fijini derisori l’opposto di ciò che si
pensava “iḫrāǧ al-kalām ʿalà ḍidd muqtaḍà l-ḥāl istihzāʾan bi-l-muḫāṭab”.66 Le
due modalità sopracitate da al-Ǧāḥiẓ si incrociano ulteriormente con un’al-
tra simile, basata sulla contraddizione e con un esplicito intento sarcastico,
al-hiǧāʾ wa-l-istihzāʾ fī maʿriḍ al-madḥ (la satira e la burla in veste di encomio)
come nel pungente verso elogio-sarcastico di Muḫallad b. Bakkār al-Mawṣilī
(m. 232/846) sulla balbuzie del poeta Abū Tammām (m. 231/846):67
59 Sangsue, La parodia, p. 23.
60 al-Ḥamawī, Ḫizānat al-adab, vol. I, p. 126-128.
61 al-Ǧāḥiẓ, Risālat al-tarbīʿ, p. 53; al-Ǧāḥiẓ, al-Bayān wa-l-tabyīn, vol. I, p. 93.
62 Ibn al-Muʿtazz, Kitāb al-badīʿ, p. 63; al-Tawḥīdī, Maṯālib al-wazīrayn, p. 447-448.
63 Cfr. Van Gelder, “Mixtures of Jest and Earnest in Classical Arabic Literature: Part I.”, p. 174;
Montgomery, “Al-Jāḥiẓ on jest and earnest”, p. 209-240.
64 Ibn Abī al-Iṣbaʿ, Taḥrīr al-taḥbīr, p. 568-570; al-ʿAlawī, al-Ṭirāz, vol. III, p. 91; al-Ḥamawī,
Ḫizānat al-adab, vol. I, p. 126-128, 215-217.
65 Sul concetto di tahakkum cfr. anche Farrell, “Comic Authority”, p. 87-88.
66 al-ʿAlawī, al-Ṭirāz, p. 476.
67 Ibn Abī al-Iṣbaʿ, Taḥrīr al-taḥbīr, p. 550; al-Ḥamawī, Ḫizānat al-adab, vol. I, p. 215.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Considerazioni teoriche e critiche sull ’ imitazione parodica 323
Oh tu, che sei il profeta di Dio per l’arte poetica! Oh tu, che sei [simile a]
Gesù, fijiglio di Maria!
Se non parlassi, saresti sicuramente fra gli esseri umani più valenti in
poesia.
Furono diversi i retorici e gli autori mamelucchi che si interessarono alle
imitazioni parodiche e si mostrarono inclini alla loro inclusione nel corpus
della letteratura “canonica”. Sebbene si trattasse di una tipologia non ricono-
sciuta come muʿāraḍa, tre importanti biografiji mamelucchi usarono il termine
“ʿāraḍa” (imitare) nel riportare dei versi parodici fra i più famosi della tradi-
zione abbaside. Nell’esporre il profijilo del poeta Muḥammad b. ʿAbd al-Wāḥid
Ṣarīʿ al-Dilāʾ, Muḥammad b. Šākir al-Kutubī (m. 764/1363), Ṣalāḥ al-Dīn
al-Ṣafadī (m. 764/1363) e Ibn Kaṯīr (m. 774/1373) presentarono il suo compo-
nimento parodico ispirato alla celebre poesia encomiastica “Maqṣūra” di Ibn
Durayd precisando: “ʿāraḍa Maqṣūrat Ibn Durayd bi-maqṣūrat muǧn/hazl”
(imitò la poesia di Ibn Durayd con un’altra grottesca).68
Ibn Durayd:
Oh mia bella gazzella, simile a un’antilope che pasce giacinti tra alberi e
dune!
Non vedi la mia chioma? È come il chiarore del mattino tra le ultime scie
dell’oscurità! [incanutita per il mal d’amore].69
Ṣarīʿ al-Dilāʾ:
Il mal d’amore il mio cuore ha turbato, manifesta è la mia pazienza da
quando compagno il dolore mi è diventato!
Oh, signori! È partita e con lei il mio cuore è rimasto! Da quando è andata
via, anche il sonno mi ha abbandonato.
Nel fare sciocchezze che stupiscono chi se ne intende, consolazione troverò.70
[…]
Chi le proprie scarpe bucate non vuole avere, che se le porti pure in mano
camminando.
Per chi i piedi vuole proteggersi, meglio indossare le scarpe che camminare
scalzo.
68 al-Kutubī, Fawāt al-wafayāt, vol. III, p. 423-424; al-Ṣafadī, al-Wāfī, vol. IV, p. 46; Ibn Kaṯīr,
al-Bidāya, vol. XIII, p. 41-42.
69 Cfr. Muḥammad, Šarḥ maqṣūrat Ibn Durayd, p. 43.
70 al-Ṯaʿālibī, Yatīmat al-dahr, vol. V, p. 23.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
324 Ismail
Chi un ago nei propri occhi si infijila, cieco all’istante diviene.
[…]
Chi dalla conoscenza è abbandonato e dalla ricchezza privato è al pari del
cane nel suo stato.71
I tre biografiji si rifecero a una fonte comune, quella di Ibn al-Naǧǧār al-Baġdādī
(m. 643/1245), che a sua volta avrebbe attinto da al-Ṯaʿālibī (m. 429/1038).72 Pare
comunque che quest’ultimo, nell’impiego del verbo “ʿāraḍa”, si riferisse solo al
preludio amoroso nella poesia di Ṣarīʿ al-Dilāʾ apparentemente serio e ingan-
nevole, incalzato però da versi contenenti dichiarazioni assiomatiche ridicole.
Il bufffo paradosso (mufāraqa) insito nelle afffermazioni di Ṣarīʿ al-Dilāʾ è accen-
tuato grazie alla commistione tra la serietà del registro e l’assurda saggezza del
contenuto messa a confronto con l’aulica solennità dell’ipotesto di Ibn Durayd.
Rimane molto indicativo, tuttavia, l’utilizzo del verbo “ʿāraḍa” da parte di Ṣalāḥ
al-Dīn al-Ṣafadī, uno dei letterati e critici più rilevanti di quel tempo, poiché
la sua citazione della poesia prende inizio dalla parte veramente parodica del
componimento.73
L’ammirazione per la parodia di Ṣarīʿ al-Dilāʾ, nonostante il suo contenuto
derisorio e dissacrante del poema originale, fu pressoché unanime tra i let-
terati e gli intellettuali mamelucchi se paragonata all’indiffferenza snobistica
mostratale da molti antologisti del passato con la sola eccezione, probabil-
mente, di al-Ṯaʿālibī. Ibn Ḫallikān (m. 681/1282) sottolineò che l’ultimo verso del
poema (Man fāta-hu l-ʿilmu wa-aḫṭā-hu l-ġinà – fa-ḏāka wa-l-kalbu ʿalà ḥaddin
sawā) era tanto pregno di grottesca saggezza (muǧūn-ǧidd) da non lasciare
alcun dubbio sull’ineguagliabile maestria e creatività poetica dell’autore.74
Numerosi versi di questa parodia furono riportati da Šams al-Dīn al-Ḏahabī
(m. 748/1348), molto conosciuto per la sua serietà e compostezza, nelle sue
opere biografijiche.75 L’esegeta e giurista tradizionalista Ibn Kaṯīr fece notare
che il poeta fu assai invidiato per l’ingegnosità dell’ultimo verso del compo-
nimento.76 Kamāl al-Dīn al-Damīrī (m. 808/1405) non poté nascondere il suo
profondo gradimento dello stesso bayt sul cane e di tutta la poesia in generale:
71 al-Kutubī, Fawāt al-wafayāt, vol. III, p. 424; al-Ṣafadī, al-Wāfī, vol. IV, p. 46.
72 al-Ṯaʿālibī, Yatīmat al-dahr, vol. V, p. 22. A diffferenza degli altri, al-Ṯaʿālibī riportò che
questa poesia intendeva invece parodiare un’altra del poeta abbaside Abū al-ʿAnbas
al-Ṣaymarī (m. 275/888).
73 al-Ṣafadī, al-Wāfī, vol. IV, p. 46.
74 Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān, vol. III, p. 384.
75 al-Ḏahabī, Tārīḫ al-Islām, vol. XXVIII, p. 324-325; al-Ḏahabī, Siyar aʿlām al-nubalāʾ,
vol. XVII, p. 308-309.
76 Ibn Kaṯīr, al-Bidāya, vol. XIII, p. 42.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Considerazioni teoriche e critiche sull ’ imitazione parodica 325
“wa-hāḏā l-bayt āḫir qaṣīda la-hu fī l-muǧūn, ḏakara fī-hā min ṣanʿat al-ġazal
funūnan, wa-law lam yakun la-hu siwā-hu la-kafā-h. Wa-hiya ṭawīla ṭannāna
ʿaǧaza fuḥūl al-šuʿrā’ an yazīdū fī-hā baytan wāḥidan” (Questo è l’ultimo verso
di una sua poesia sul muǧūn nella quale il poeta esibì alcune arti relative al
tema ġazal. Se egli non avesse scritto altro che questo verso, esso sarebbe stato
sufffijiciente [a provare la sua maestria]. La poesia è lunga e solenne e i poeti
più afffermati “fuḥūl” non sono riusciti ad aggiungerci neanche un solo verso).77
La Maqṣūra di Ṣarīʿ al-Dilā’ seppe suscitare altrettanto l’interesse di al-Maqrīzī
(m. 845/1442) che nel Muqafffà ne riportò ben trenta versi.78 La consolidata
fama di questa parodia nel periodo mamelucco fu il motivo per cui l’insigne
giurista Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī (m. 852/1449) tenne a precisare di averla impa-
rata a memoria e di aver perfijino ottenuto una iǧāza per poterla trasmettere
e insegnare.79
Fra i poeti passati che in epoca mamelucca ebbero una popolarità prover-
biale vi fu Ibn Ḥaǧǧāǧ,80 vissuto in pieno secolo X e defijinito da alcuni studiosi
come “a master parodist”.81 La straordinaria stima da egli goduta può essere
confermata dalle varie raccolte dedicate alla sua fijigura e alla sua poetica e
composte da protagonisti di spicco del panorama letterario di allora, quali
al-Asʿad b. Mammātī (m. 606/1209) (Qarqarat al-daǧāǧ fī alfāẓ b. Ḥaǧǧāǧ),82
Ǧamāl al-Dīn b. Nubāta (m. 768/1366) (Talṭīf al-mazāǧ min šiʿr b. Ḥaǧǧāǧ) e
Ibn Ḥiǧǧa al-Ḥamawī (Laṭā’if al-talṭīf).83 Per questo motivo, la parodia di Ibn
Ḥaǧǧāǧ della Muʿallaqa di Imru’ al-Qays84 costituì molto probabilmente un
modello ispiratore per altre contrafffazioni grottesche scritte da alcuni fra i più
celebri poeti mamelucchi: Abū al-Ḥusayn al-Ǧazzār (m. 679/1281), Ṣalāḥ al-Dīn
al-Ṣafadī, Ǧamāl al-Dīn b. Nubāta e Faḫr al-Dīn b. Makānis (m. 794/1392).
Tuttavia, a diffferenza del testo precursore pervaso di una virulenza quasi inau-
dita e basato su allusioni sessuali e scatologiche, le riproduzioni mamelucche
erano di impronta sociale e caricaturale. I due componimenti di Ibn Nubāta
e Ṣalāḥ al-Dīn al-Ṣafadī appartengono, come quello di Abū Bakr al-Ṣūlī, al
genere iḫwāniyyāt e si servono della struttura e di alcuni versi della Muʿallaqa
in un gioco epistolare di botta e risposta a fijini ludici, deviandone l’argomento
77 al-Damīrī, Ḥayāt al-ḥayawān, vol. III, p. 596-597.
78 al-Maqrīzī, Kitāb al-muqafffà, vol. VI, p. 153-155.
79 al-ʿAsqalānī, al-Maǧmaʿ al-muʾassis, vol. II, p. 347.
80 Bauer, “Mujūn epigrams by Ibn Nubāta”, p. 161.
81 Antoon, The Poetics of the Obscene, p. 45.
82 al-Ḥamawī, Muʿǧam al-udabāʾ, vol. II, p. 640-641.
83 Antoon, The Poetics of the Obscene, p. 10.
84 Su questa parodia cfr. Antoon, The Poetics of the Obscene, p. 49-56.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
326 Ismail
da descrittivo-amoroso a scusatorio-scherzoso.85 Le poesie di Abū al-Ḥusayn
al-Ǧazzār e di Ibn Makānis sembrerebbero ancora più interessanti per il
discorso parodico poiché stimolarono, oltre agli apprezzamenti dei loro con-
temporanei, alcune riflessioni critiche e retoriche.
Abū al-Ḥusayn al-Ǧazzār:
Fermatevi e piangiamo al ricordo di una camicia, di un paio di pantaloni e
di un mantello [darrāʿa] logoro e sbiadito!
Non sono uno che piange se Asmā’ va via, gemo piuttosto per la perdita dei
miei vestiti consunti!
Se Imru’ al-Qays b. Ḥuǧr avesse visto quello che sofffro per la mia tanta
inquietudine e confusione,
non si sarebbe infijilato nella lettiga di ʿUnayza e non sarebbe passata la
notte prima che lui si dimenticasse del suo amore.
È una mia passione ora trovare rifugio nei mercati cittadini; pensare a
Tawḍiḥ e al-Miqrāt non mi desta grande interesse! […]
Chissà se un giorno la gente mi vedrà vestito di un caftano di feltro, con cui
orgoglioso camminerò, trascinando l’orlo.
I miei nemici rimarranno sconfortati perché non ne hanno uno simile.
Se avessi voluto farmi cucire un semplice mantello di cotone, non avrei
avuto bisogno di chiedere neanche pochi denari.
Ma io vorrei conseguire la gloria in feltro e a questa alta gloria perfijino per-
sone come me potrebbero giungere.86
Ibn Makānis:
La mia poesia s’è disinteressata della descrizione delle gazzelle per elogiare
invece un ciufffo folto come una barba, pendente da un naso.
È gremito di cimici che brillano come perle in una collana.
Che brutto ciufffo, così fijitto e ingarbugliato, che spunta da quel naso come un
grappolo di datteri ricadente da una palma!
Dicono che è il naso a essere immerso nei peli e a sporgere così prominente
come un uomo nobile avvolto in un manto bianco e nero di lana.
85 Cfr. queste due parodie e il loro contesto epistolare in al-Ṣafadī, Alḥān al-sawāǧiʿ, vol. II,
p. 245-249.
86 Cfr. la poesia in al-Ǧazzār, Šiʿr Abī l-Ḥusayn al-Ǧazzār, p. 241-242; al-Yūnīnī, Ḏayl mirʾāt
al-zamān, vol. IV, p. 70-71; al-Kutubī, ʿUyūn al-tawārīḫ, vol. XXI, p. 259-260; al-ʿAbbāsī,
Maʿāhid al-tanṣīṣ, vol. IV, p. 160-161; al-Ǧammāl, al-Adab al-ʿāmmī, p. 195.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Considerazioni teoriche e critiche sull ’ imitazione parodica 327
Negli spiazzi e nei sentieri presenti all’interno si vedono ora pidocchi e len-
dini simili a grani di pepe.87
La poesia di Abū al-Ḥusayn al-Ǧazzār si propone come una contrafffazione
breve ma identica per metro e rima alla Muʿallaqa. A raffforzare il legame di
intertestualità tra i due componimenti, vi è l’inclusione integrale nell’iperte-
sto del famoso emistichio di apertura dell’ipotesto “Fermatevi e piangiamo al
ricordo”, nonché di alcuni rimandi espliciti a idee e a nomi propri della poesia
originale: “Asmā’, Imru’ al-Qays b. Ḥuǧr, ʿUnayza, lettiga, Tawḍiḥ e al-Miqrāt”.
Trarre ispirazione dalla Muʿallaqa preislamica sembra in questo caso rappre-
sentare per il poeta mamelucco un modo per marcare sia la continuità che la
rottura con il passato. Da una parte, egli manifestava il desiderio di dichiarare
la sua aderenza alla tradizione poetica araba, consacrandola come una fonte
inesauribile e indispensabile per interagire con il tempo. In quest’ottica, i due
testi diventavano “a space for a dynamic dialogue, and the modern poem in
the hands of its masterly producers universalizes the moment through active
engagement with the local and the traditional”.88 Dall’altra, anziché esaltare
il testo ispiratore analogamente a molti altri, egli lo usava per attirare l’atten-
zione del suo pubblico, sicuramente memore dell’ipotesto, al fijine di suscitare
nostalgia e rimpianto per il contrasto tra presente e passato. Il rovesciamento
quindi intendeva proporre una lettura contemporanea del testo di partenza
e riplasmarlo in spazi e dimensioni nuove, in modo da rivelare un altro rove-
sciamento, ancora più concreto, ovvero quello socio culturale dei ruoli. La
parodia di al-Ǧazzār non mirava a dissacrare o a demolire il suo ipotesto, né
fu concepita, similmente al caso di Ṣarīʿ al-Dilā’, come “sheer fun of making
parodies”.89 Il poeta, nella veste di un eroe comico, si servì dell’ironia per sot-
tolineare maggiormente la sua frustrazione e il rifijiuto di essere paragonato,
con la sua umiliante povertà, al grandioso modello cavalleresco e poetico di
Imru’ al-Qays, ricordando al pubblico che non era il talento a fare la difffe-
renza, ma le coordinate temporali e spaziali e il conseguente capovolgimento
dei valori.90 Al-Ǧazzār non aveva dubbi che il poeta pre-islamico si sarebbe
comportato alla sua stessa maniera se avesse vissuto circondato dalle sue ansie
e preoccupazioni socio-economiche, pertanto, ahimè, non era più tempo di
stare a rimpiangere gli accampamenti o le avventure amorose tra le dune del
87 Cfr. questa poesia in al-Ḥamawī, Ḫizānat al-adab, vol. II, p. 326; al-ʿAbbāsī, Maʿāhid
al-tanṣīṣ, vol. IV, p. 159-160.
88 al-Musawi, Arabic Poetry, p. 45.
89 Van Gelder, Of Dishes and Discourse, p. 95.
90 Cfr. Larkin, “Popular Poetry”, p. 223-224.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
328 Ismail
deserto. Un invito simile fu lanciato tre secoli prima dal pioniere Abū Nuwās
(m. 199/813), che alluse alla stessa poesia in un suo componimento per deri-
dere i valori e i canoni letterari antichi. Parimenti, il poeta abbaside suggerì
di non osservare l’invocazione di Imruʾ al-Qays a piangere sui ruderi del pas-
sato e invitò invece dispettosamente i suoi ascoltatori ad andare a bersi un bel
bicchiere di vino di buon mattino.91 La realtà mamelucca di al-Ǧazzār appare
comunque assai lontana da quella preislamica e abbaside e la posta in gioco
allora era la lotta per la sopravvivenza contro le precarie condizioni di vita dei
letterati. Era fondamentale a quel punto per il poeta del XIII secolo mettere in
discussione gli anacronistici cliché etici e socio-letterari ereditati dalle epoche
precedenti92 che condannavano gli intellettuali coevi, messi continuamente a
confronto con i fuḥūl della tradizione, a un’auto-rappresentazione spesso sof-
ferente e tormentata. Fu presumibilmente questa contemporaneità della paro-
dia di al-Ǧazzār e il suo solido legame con la realtà del suo tempo a convincere
alcuni critici del periodo a proporla come un tentativo arguto e ben riuscito
di rovesciamento parodico (hazlī) della Muʿallaqa. ʿAbd al-Raḥīm b. Aḥmad
al-ʿAbbāsī (m. 963/1556) la collocò tra i miglior esempi di citazione (min ẓarīf
al-taḍmīn)93 poiché il poeta seppe trasporre la vecchia struttura e alcune idee
della poesia originale in un contesto e con un argomento totalmente diversi
(ṣarafa-hu ʿan maʿnā-hu al-awwal).94 Seppur implicitamente, al-ʿAbbāsī rico-
nobbe la poesia nella sua totalità come un testo contenente un messaggio
deviato in veste vecchia.
Il carattere prettamente caricaturale della parodia di Ibn Makānis ricorda
invece un fijilone specifijico della cultura letteraria araba classica e medievale
che per motivi storiografijici, letterari, linguistici e pratici si interessò dei difetti
fijisici.95 La derisione di alcune imperfezioni fijisiche (al-hiǧā’ al-ḫalqī) costituì
spesso un motivo di satira e un’arma denigratoria praticata da numerosi poeti
arabi.96 Ne sono prova evidente la rinomata poesia di al-Mutanabbī contro il
governatore d’Egitto Kāfūr (m. 357/968) e, ancora prima, le virulente invet-
tive scambiate tra al-Farazdaq (m. 110/728) e Ǧarīr (m. 111/729) e tra Ḥammād
ʿAǧrad (m. 161/778) e Baššār b. Burd (m. 167-168/783-784).97 Quest’ultimo,
secondo alcuni, gemette dopo aver ascoltato un’invettiva detta sul suo conto
da parte di Ḥammād, perché, essendo cieco, non avrebbe potuto vedere il
91 Cfr. Meisami, Structure and Meaning, p. 33-34.
92 Szombathy, Mujūn, p. 115.
93 al-ʿAbbāsī, Maʿāhid al-tanṣīṣ, vol. IV, p. 160.
94 Ivi, p. 157.
95 Sadān, al-Adab al-ʿarabī al-hāzil, p. 12-19.
96 Cfr. Sadān, “Risāla fī l-damāma”, p. 11, 28.
97 Ḍayf, Tārīḫ al-adab al-ʿarabī. al-ʿAṣr al-ʿabbāsī al-awwal, p. 168.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Considerazioni teoriche e critiche sull ’ imitazione parodica 329
proprio avversario per disprezzare e sbefffeggiare il suo aspetto fijisico in un’e-
ventuale risposta.98 L’articolato componimento di Ibn Makānis si inserisce in
questa lunga tradizione che cercava di farsi befffa delle persone, sofffermandosi
sulle loro stranezze fijisiche. La vittima dello scherzo (mudāʿaba)99 era un amico
dell’autore e l’oggetto di dileggio questa volta non era il colore della pelle, ma
un naso imponente dalla peluria particolarmente folta. La strategia adottata
dal poeta mamelucco per accentuare l’impatto caricaturale fu quella di servirsi
della Muʿallaqa come struttura ispiratrice e di assemblarne i secondi emistichi
(ʿaǧuz) nell’ipertesto (brillano come perle in una collana; come un grappolo di
datteri ricadente da una palma; come un uomo nobile avvolto in un manto bianco
e nero di lana; Negli spiazzi e nei sentieri presenti all’interno; simili a grani di
pepe). Ci troviamo di conseguenza davanti a un componimento doppio, ma
strutturalmente e tecnicamente omogeneo, in cui il primo emistichio di ogni
verso è di invenzione del parodista e il secondo è un prestito integrale dall’i-
potesto. La sfijida maggiore del poeta consistette nel reimpiego capovolto delle
immagini memorabili e auliche inventate otto secoli prima dall’ingegno poe-
tico di Imru’ al-Qays per ricordare gli estesi deserti, i cieli stellati, le morbide
dune, le graziose fanciulle e le avventure amorose, per esporre invece befffar-
damente i dettagliati particolari anatomici di quell’orribile naso peloso. Ibn
Makānis introdusse nel componimento del poeta preislamico un’intenzione
del tutto inversa. La voce del parodista entrava così in “conflitto con l’antico
padrone e lo obbligava a seguire scopi direttamente opposti. La parola dive-
niva arena di lotta di due intenzioni”.100A diffferenza di al-Ǧazzār che aveva
elaborato un testo parallelo completo con un linguaggio proprio, Ibn Makānis
scelse di adoperare un registro lessicale arcaico al fijine di mimetizzare i nuovi
versi con quelli vecchi e intensifijicare in questo modo il paradosso tra l’ambien-
tazione e la narrazione originali e quelle intruse.
Nel suo commento su questo componimento, Ibn Ḥiǧǧa al-Ḥamawī espresse
più volte la propria ammirazione per la fantasia poetica di Ibn Makānis,
mettendo in evidenza la sua maestria nel deviare le immagini da un conte-
sto tragico-romantico a un altro vivamente comico e caricaturale: “wa-l-laḏī
aqūlu-hu: al-mahyaʿ al-laḏī iḫtaraʿa-hu Ibn Makānis, wa-mašà ʿalay-hi fī taḍmīn
hāḏihi l-muʿallaqa yuʿaddu min al-muʿallaqāt fī bābi-hi […], fa-inna-hu atà
bi-mā lā ’ḫtalaǧa fī ṣadr muta’addib” (dico: «il modo inventato e seguito da Ibn
Makānis di servirsi di questa muʿallaqa citandola è da considerarsi un modello
magistrale per questo genere […]. Egli ha creato ciò che nessun altro letterato
98 al-Iṣfahānī, Kitāb al-aġānī, vol. XIV, p. 210.
99 al-Ḥamawī, Ḫizānat al-adab, vol. II, p. 326.
100 Bakhtin, “Problemi dell’opera di Dostoevskij”, p. 1231.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
330 Ismail
ha mai pensato di fare prima»).101 Fu in particolare la ripresa (īdāʿ) dell’emisti-
chio (come un grappolo di datteri ricadente da una palma) a colpire maggior-
mente il critico e poeta Ibn Ḥiǧǧa. Al posto della musa di Imru’ al-Qays con la
sua capigliatura folta, nera e spiovente sulla schiena, molto simile ai grappoli
di datteri penzolanti dalle palme, nella parodia di Ibn Makānis spicca il naso
dell’amico coperto e pieno di peli non meno folti: “wa-la-ʿamrī inna hāḏā l-īdāʿ
min al-siḥr fī naqli-hi ilà hāḏihi l-ṣifa l-ġarība” (Giuro che questa citazione [del
verso] è incantevole per il modo curioso in cui è stata riadattata).102 Il gioco
parodico anche nei versi successivi, per Ibn Ḥiǧǧa, non era per nulla meno
efffijicace e geniale: il naso sporge orgoglioso al posto della montagna e le cavità
nasali sostituiscono le piazze e i sentieri del vecchio accampamento: “hāḏā
l-laḏī waqaʿ ʿalay-hi l-iḫtiyār min iḫtirāʿ Faḫr al-Dīn […], wa-la-ʿamrī inna-hu min
al-iḫtirāʿ al-laḏī lam yusbaq ilay-hi wa-lā ḥām fijikr min qabli-hi ʿalay-h” (è que-
sta creazione di Faḫr al-Dīn b. Makānis che abbiamo scelto […], e giuro che
si tratta di un’invenzione mai ideata né pensata da nessun altro prima).103 La
stessa imitazione attirò successivamente l’attenzione altresì di ʿAbd al-Raḥīm
b. Aḥmad al-ʿAbbāsī che nel riportarne alcuni versi la defijinì un esempio di
“taḍmīn ġarīb” (curiosa citazione).104
La parodia di Ibn Makānis rappresentava una sfijida scaturita evidentemente
dalla consapevolezza del valore letterario del testo parodiato, ritenuto una
manifestazione di perfezione poetica. Tuttavia, dalle parole di Ibn Ḥiǧǧa si può
comprendere che capovolgere questa ode in una prospettiva così caricaturale
rivelava, per la critica di allora, una creatività singolare tipica di un grande
poeta. L’uso del secondo emistichio nella parodia enfatizzava infatti il para-
dosso e dissacrava altrettanto il contenuto della Muʿallaqa che ogni letterato e
gran parte del pubblico delle arti letterarie sapeva a memoria. L’esagerazione
delle imperfezioni somatiche della vittima del dileggio andava di pari passo
con la deformazione dell’ipotesto e il tutto si svolgeva in un’atmosfera ludica
che consentiva al poeta di giocare con il passato e dare sfogo ai suoi impulsi di
estro letterario.
Conclusioni
Il genere muʿāraḍa trovò senza dubbio una grande difffusione nella tradizione
letteraria araba poiché spesso costituiva una dichiarazione di proprietà del
101 al-Ḥamawī, Ḫizānat al-adab, vol. II, p. 326.
102 Ivi, p. 327.
103 Ivi, p. 328.
104 al-ʿAbbāsī, Maʿāhid al-tanṣīṣ, vol. IV, p. 159.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Considerazioni teoriche e critiche sull ’ imitazione parodica 331
patrimonio precedente da parte di ogni autore arabo successivo,105 autoriz-
zato ad attingervi per afffermare l’orgoglio delle proprie radici, il proprio senso
di appartenenza e la propria capacità compositiva.106 Le molteplici contrafffa-
zioni delle Muʿallaqāt, di altri poemi di autori di spicco del periodo abbaside
(Abū Tammām, al-Mutanabbī, Abū Nuwās), di testi di prosa come le maqāmāt,
di antologie e perfijino di trattati che continuano a proporsi fijino all’epoca
moderna sono molto indicative di un desidero rinnovato da parte di quasi di
tutti i protagonisti della letteratura araba di tutti i tempi di interagire con i
capisaldi di questo patrimonio.
L’attenzione dei teorici e dei critici classici si era concentrata per lo più
su come distinguere tra i vari generi di trasformazione testuale, per poter
fijissare meglio i malleabili confijini tra il plagio e l’ispirazione intertestuale
e ipertestuale.107 Furono quelli di epoca mamelucca, insieme ad autori e ad
antologisti, a riconoscere la dignità letteraria e il valore creativo di al-muʿāraḍa
al-hazliyya oppure al-muḥākāh al-sāḫira. La riproduzione parodica non veniva
più disprezzata o inquadrata come manifestazione di aridità inventiva o
di parassitismo letterario, caratteristico di scrittori mediocri e fannulloni, ai
danni di opere e di autori di grande levatura. Ne è testimone la partecipazione
massiccia da parte degli autori mamelucchi nell’esercizio di questa pratica.108
Perfijino il limite di evitare i testi sacri e non coinvolgerli in una pratica così bef-
farda e derisoria fu spesso e volentieri valicato al fijine di accentuare i paradossi
e raffforzare i capovolgimenti.109 Fra i motivi che possono giustifijicare il consoli-
damento di questo genere nei “secoli mamelucchi” vi è la percezione della poe-
sia e della letteratura in generale come “participational mode”,110 ovvero come
modalità associativa e mezzo di comunicazione tra i membri della società dei
letterati e con il pubblico dei consumatori delle arti letterarie. La riscrittura
105 Anche se esula dal nostro argomento, è interessante accennare che tale funzione è facil-
mente riscontrabile nel caso dell’Andalusia dove la nostalgia e la distanza geografijica della
Penisola Iberica dall’epicentro spaziale della civiltà araba classica conferirono alla pratica
delle muʿāraḍāt un ruolo rilevante nel ravvivare i legami con la cultura madre. Cfr. Sallūm,
al-Muʿāraḍāt fī l-šiʿr al-andalusī, p. 55; Haxen, “The Muʿāraḍa concept”, cit., p. 115.
106 Cfr. al-Taṭāwī, al-Muʿāraḍāt al-šiʿriyya, p. 87.
107 al-Ḥātimī, Ḥilyat al-muḥāḍara, vol. II, p. 28-98; al-Qayrawānī, al-ʿUmda, p. 1072-1095.
108 A tal proposito, merita un ricordo anche la parodia di Ibn Dāniyāl al-Kaḥḥāl (m. 710/1311),
composta sul modello della Muʿallaqa di Ṭarafa b. al-ʿAbd (m. 569?) e che similmente
a quella di al-Ǧazzār riporta l’attenzione sullo stesso tema della povertà e dell’inquie-
tudine dei letterati in contrasto con la spensieratezza del passato. Cfr. al-Kutubī, Fawāt
al-wafayāt, vol. III, p. 332-333; al-Ṣafadī, al-Muḫtār min šiʿr b. Dāniyāl, p. 154; al-Ǧammāl,
al-Adab al-ʿāmmī, p. 208-209.
109 Cfr. Van Gelder, “Frivolous Iqtibās (Quotation from the Qurʾān)”, p. 3-16; Szombathy,
Mujūn, p. 60-75.
110 Bauer, “ʿAyna Hādhā min al-Mutanabbī!”, p. 10.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
332 Ismail
parodica di opere specifijiche appartenenti all’alta cultura era rivolta a un pub-
blico istruito che conosceva l’ipotesto ed era capace, perciò, di mettere in
relazione i due testi e capirne le trasformazioni e i richiami.111 Come affferma
Gregory Bateson, il paradosso e l’umorismo sono un’efffijicace alternativa alla
rigidità della logica.112 L’importanza afffijidata in quel periodo al ruolo del gioco
e del riso, intesi come arti fondamentalmente partecipative, nell’interazione
sociale pare fosse una strategia impiegata dagli intellettuali, dai letterati e dagli
ʿulamāʾ per stabilire un equilibrio relazionale all’interno di un gruppo sociale
detentore della cultura e dell’ideologia religiosa.
Bibliografijia
Fonti
al-ʿAbbāsī, ʿAbd al-Raḥīm b. Aḥmad, Maʿāhid al-tanṣīṣ ʿalà šawāhid al-talḫīṣ, ed.
Muḥammad Yaḥyà al-Dīn ʿAbd al-Ḥamīd, Bayrūt, ʿĀlam al-Kutub, 1947, 4 vols.
al-ʿAlawī, Yaḥyà b. Ḥamza, al-Ṭirāz al-mutaḍammin li-asrār al-balāġa wa-ʿulūm ḥaqāʾiq
al-iʿǧāz, ed. ʿAbd al-Ḥamīd Hindāwī, Bayrūt, al-Maktaba al-ʿAṣriyya, 2002, 3 vols.
al-Āmidī, Abū al-Qāsim, al-Muwāzana bayna šiʿr Abī Tammām wa-l-Buḥturī, ed.
al-Sayyid Aḥmad Ṣaqr, al-Qāhira, Dār al-Maʿārif, 1992, 3 vols.
al-ʿAskarī, Abū Hilāl, Kitāb al-ṣināʿatayn, ed. M.A.F. Ibrāhīm, al-Qāhira, Dār Iḥyāʾ
al-Kutub al-ʿArabiyya, 1952.
al-ʿAsqalānī, Ibn Ḥaǧar, al-Maǧmaʿ al-muʾassis li-l-muʿǧam al-mufahris, ed. Yūsuf ʿAbd
al-Raḥmān al-Marʿašlī, Bayrūt, Dār al-Maʿrifa, 1994, 4 vols.
Badawī, ʿAbd al-Raḥmān, Fann al-šiʿr maʿa al-tarǧama al-ʿarabiyya al-qadīma wa-šurūḥ
al-Fārābī wa-Ibn Sīnā wa-Ibn Rušd, al-Qāhira, Maktabat al-Nahḍa al-Miṣriyya, 1953.
al-Ḏahabī, Šams al-Dīn, Tārīḫ al-Islām wa-wafayāt al-mašāhīr wa-l-aʿlām, ed. ʿUmar
ʿAbd al-Salām al-Tadmurī, Bayrūt, Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 2000, 53 vols.
al-Ḏahabī, Šams al-Dīn, Siyar aʿlām al-nubalāʾ, ed. Šuʿayb al-Arnāʾūṭ, Muḥammad
Naʿīm al-ʿIrqsūsī, Bayrūt, Muʾassasat al-Risāla, 1983, 29 vols.
al-Damīrī, Kamāl al-Dīn, Ḥayāt al-ḥayawān al-kubrà, ed. Ibrāhīm Ṣāliḥ, Dimašq, Dār
al-Bašāʾir, 2005, 4 vols.
al-Ǧāḥiẓ, Abū ʿUṯmān, Risālat al-tarbīʿ wa-l-tadwīr, ed. Charles Pellat, Dimašq,
al-Maʿhad al-Firansī bi-Dimašq, 1955.
al-Ǧāḥiẓ, Abū ʿUṯmān, al-Bayān wa-l-tabyīn, ed. ʿAbd al-Salām Hārūn, al-Qāhira,
Maktabat al-Ḫānǧī, 1998, 4 vols.
111 Cachia, “From Sound to Echo”, p. 224.
112 Bateson, “The position of Humor”, p. 3.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Considerazioni teoriche e critiche sull ’ imitazione parodica 333
al-Ǧazzār, Abū al-Ḥusayn, Šiʿr Abī al-Ḥusayn al-Ǧazzār, ed. Aḥmad ʿAbd al-Maǧīd
Ḫalīfa, al-Qāhira, Maktabat al-Ādāb, 2007.
al-Ǧurǧānī, ʿAbd al-Qāhir, Dalāʾil al-iʿǧāz fī ʿilm al-maʿānī, ed. Maḥmūd Šākir, al-Qāhira,
Maktabat al-Ḫānǧī, 1984.
al-Ǧurǧānī, ʿAlī ʿAbd al-ʿAzīz, al-Waṣāṭa bayna al-Mutanabbī wa-ḫuṣūmih, ed.
Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, al-Qāhira, ʿĪsà al-Bābī al-Ḥalabī, 1966.
al-Ḥamawī, Ibn Ḥiǧǧa, Ḫizānat al-adab wa-ġāyat al-arab, ed. ʿIṣām Šaʿaytū, Beirut, Dār
wa-Maktabat al-Hilāl, 1987, 2 vols.
al-Ḥamawī, Yāqūt b. ʿAbd Allāh, Muʿǧam al-udabāʾ, ed. Iḥsān ʿAbbās, Bayrūt, Dār
al-Ġarb al-Islāmī, 1993, 7 vols.
al-Ḥātimī, Abū ʿAlī Muḥammad b. al-Ḥasan, Ḥilyat al-muḥāḍara fī ṣināʿat al-šīʿr, ed.
Ǧaʿfar al-Kitānī, Baġdād, Dār al-Rašīd, 1979, 2 vols.
al-Ḥuṣrī, Abū Isḥāq Ibrāhīm b. ʿAlī, Zahr al-ādāb wa-ṯamar al-albāb, ed. Ṣalāḥ al-Dīn
al-Hawwārī, Bayrūt: al-Maktaba al-ʿAṣriyya, 2001, 4 vols.
Ibn Abī al-Iṣbaʿ, Taḥrīr al-taḥbīr fī ṣināʿat al-šiʿr wa-l-naṯr wa-bayān iʿǧāz al-Qurʾān,
Ḥifnī Muḥammad Šaraf, al-Qāhira, al-Maǧlis al-Aʿlà li-l-Šuʾūn al-Islāmiyya, 1963.
Ibn al-Aṯīr, Ḍiyāʾ al-Dīn, al-Ǧāmiʿ al-kabīr fī ṣināʿat al-manẓūm min al-kalām wa-l-manṯūr,
ed. Ǧawād ʿAlī et al., Baġdād, Maṭbaʿat al-Maǧmaʿ al-ʿIlmī al-ʿIrāqī, 1956.
Ibn Diḥya, ʿUmar b. Ḥasan, al-Muṭrib min ašʿār ahl al-Maġrib, ed. Ibrāhīm al-Abyārī
et al., Bayrūt, Dār al-ʿIlm li-l-Ǧamīʿ, 1955.
Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-aʿyān wa-anbāʾ abnāʾ al-zamān, ed. Iḥsān ʿAbbās, Bayrūt, Dār
Ṣādir, 8 vols.
Ibn Kaṯīr, Abū al-Fidāʾ Ismāʿīl, al-Bidāya wa-l-nihāya, ed. Ḥasan Ismāʿīl Marwa et al.,
Bayrūt, Dār Ibn Kaṯīr, 1992, 20 vols.
Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿarab, Bayrūt, Dār Ṣādir, 1956, 15 vols.
Ibn al-Muʿtazz, ʿAbd Allāh, Kitāb al-badīʿ, ed. Ignatius Kratchkovsky, London, Luzac
and Co, 1935.
Ibn al-Muʿtazz, ʿAbd Allāh, Ṭabaqāt al-šuʿarāʾ, ed. ʿAbd al-Sattār Aḥmad Farrāǧ,
al-Qāhira, Dār al-Maʿārif, 1976.
Ibn Ṭabāṭabā, ʿĪyār al-šiʿr, ed. ʿAbbās ʿAbd al-Sātir, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya,
2005.
al-Iṣfahānī, Abū al-Faraǧ, Kitāb al-aġānī, ed. Iḥsān ʿAbbās et al., Bayrūt, Dār Ṣādir, 2008,
14 vols.
al-Kutubī, Muḥammad b. Šakir, Fawāt al-wafayāt, ed. Iḥsān ʿAbbās, Bayrūt, Dār Ṣādir,
1974, 5 vols.
al-Kutubī, Muḥammad b. Šakir, ʿUyūn al-tawārīḫ, ed. Fayṣal al-Sāmir et al., Baġdād,
Dāʾirat al-Šuʾūn al-Ṯaqāfijiyya wa-l-Našr, 1984.
al-Maqrīzī, Taqī al-Dīn, Kitāb al-muqafffà al-kabīr, ed, Muḥammad al-Yaʿlāwī, Bayrūt,
Dār al-Ġarb al-Islāmī, 1991, 8 vols.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
334 Ismail
al-Mustaʿṣimī, Muḥammad b. Aydamur, al-Durr al-farīd wa-bayt al-qaṣīd, ed. Sulaymān
al-Ǧabūrī, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 2015, 13 vols.
al-Nuwayrī, Šihāb al-Dīn, Nihāyat al-arab fī funūn al-adab, ed. Mufīd Qamīḥa et al.,
Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 2004, 33 vols.
al-Qayrawānī, Ibn Rašīq, al-ʿUmda fī ṣināʿat al-šīʿr wa-naqdi-h, ed. Muḥammad Muḥyi
al-Dīn ʿAbd al-Ḥamīd, Bayrūt, Dār al-Ǧīl, 1981, 2 vols.
al-Ṣafadī, Ṣalāḥ al-Dīn Ḫalīl b. Aybak, al-Muḫtār min šiʿr b. Dāniyāl al-Ḥakīm Šams
al-Dīn al-Mawṣilī al-Kaḥḥāl, ed. Muḥammad Nāʾif al-Dulaymī, al-Mawṣil, Maktabat
Bassām, 1979.
al-Ṣafadī, Ṣalāḥ al-Dīn Ḫalīl b. Aybak, al-Wāfī bi-l-wafayāt, ed. Aḥmad al-Arnāʾūṭ et al.,
al-Qāhira, Dār Iḥyāʾ al-Turāṯ al-ʿArabī, 2000, 29 vols.
al-Ṣafadī, Ṣalāḥ al-Dīn Ḫalīl ibn Aybak, Alḥān al-sawāǧiʿ bayna al-bādiʾ wa-l-murāǧiʿ,
ed. Ibrāhīm Ṣāliḥ, Dimašq, Dār al-Bašāʾir, 2004, 2 vols.
al-Ṣūlī, Abū Bakr b. Yaḥyà, Adab al-kuttāb, ed. Muḥammad Bahǧa al-Aṯarī, al-Qāhira,
al-Maṭbaʿa al-Salafijiyya, 1341/1923.
al-Ṯaʿālibī, Abū Manṣūr, Yatīmat al-dahr fī maḥāsin ahl al-ʿaṣr, ed. Mufīd Qamīḥa,
Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1983, 5 vols.
al-Tawḥīdī, Abū Ḥayyān, Maṯālib al-wazīrayn, ed. Muḥmmad b. Tāwīt al-Ṭanǧī, Bayrūt,
Dār Ṣādir, 1992.
al-Yūnīnī, Mūsà b. Muḥammad, Ḏayl mirʾāt al-zamān, al-Qāhira, Dār al-Kitāb al-Islāmī,
1992, 4 vols.
Studi
Abū Zayd, ʿAlī, al-Badīʿiyyāt fī l-adab al-ʿarabī, Bayrūt, ʿĀlam al-Kutub, 1983.
Amaldi, Daniela, Le Muʿallaqàt. Alle origini della poesia araba, Venezia, Marsilio, 1991.
Antoon, Sinan, The Poetics of the Obscene in Premodern Arabic Poetry: Ibn al-Ḥajjāj and
Sukhf, New York, Palgrave, 2014.
ʿAwaḍayn, Ibrāhīm, al-Muʿāraḍa fī l-adab al-ʿarabī, al-Qāhira, Maṭbaʿat al-Saʿāda, 1980.
Bakhtin, Michail, “Problemi dell’opera di Dostoevskij”, in Michail Bakhtin e il suo cir-
colo, eds Augusto Ponzio e Luciano Ponzio Milano, Bompiani, 2014, p. 1053-11424.
al-Baldāwī, Muzāḥim Aḥmad, “al-Muʿāraḍāt al-šiʿriyya wa-naš’atu-hā fī l-adab al-
ʿarabī”, Maǧallat Kulliyyat al-Ādāb-Ǧāmiʿat Ṣanʿāʾ, 18 (1995), p. 339-366.
Bateson, Gregory, “The position of Humor in Human Communication”, Cybernetics,
vol. CXLVII (1953), p. 1-25.
Bauer, Thomas, “Mamlūk Literature: Misunderstandings and New Approaches”,
Mamlūk Studies Review, 9 (2) (2005), p. 105-132.
Bauer, Thomas, “‘Ayna hādhā min al-Mutanabbī!’ Toward an Aesthetics of Mamluk
Literature”, Mamlūk Studies Review, 17 (2013), p. 5-22.
Bauer, Thomas, “Mujūn epigrams by Ibn Nubāta and his contemporaries (686-768/1287-
1366)”, in The Rude, the Bad and the Bawdy. Essays in Honour of Professor Geert Jan
van Gelder, eds Adam Talib et al., Oxford: Gibb Memorial Trust, 2014, p. 160-185.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Considerazioni teoriche e critiche sull ’ imitazione parodica 335
Bosworth, C.E., “Takhmīs”, in P.J. Bearman et al., Encyclopaedia of Islam, Leiden, Brill,
2000, vol. X, p. 123-125.
Cachia, Pierre, “From Sound to Echo in Late Badīʿ Literature”, JAOS, 108 (1988), p. 219-25.
Campanini, Massimo, Il Corano e la sua interpretazione, Roma-Bari, Gius. Laterza &
Figli, 2004.
Ḍayf, Šawqī, Tārīḫ al-adab al-ʿarabī. al-ʿAṣr al-ʿabbāsī al-awwal, al-Qāhira, Dār al-Maʿārif,
1966.
Ḍayf, Šawqī, al-Maqāma, al-Qāhira, Dār al-Maʿārif, 1973.
Ḍayf, Šawqī, Fī l-šiʿr wa-l-fukāha fiji Miṣr, al-Qāhira, Dār al-Maʿārif, 1999.
Falk, Robert P.; Beare, William, “Parody”, in The Princeton Handbook of Poetic Terms,
eds. Alex Preminger et al., Princeton, Princeton University Press, 2014, p. 183-185.
Farrell, Jeremy, “Comic Authority. Sarcasm in Pre-modern Arabic Literature”, in Words
that Tear the Flesh: Essays on Sarcasm in Medieval and Early Modern Literature
and Cultures, eds Stephen Alan Baragona and Elizabeth Louise Rambo, Berlin: De
Gruyter, 2018, p. 85-118.
al-Ǧammāl, Aḥmad Ṣādiq, al-Adab al-ʿāmmī fī Miṣr fī l-ʿaṣr al-mamlūkī, al-Qāhira,
al-Hayʾa al-Miṣriyya al-ʿĀmma li-l-Kitāb, 2013.
Ghersetti, Antonella, “‘Word’ in the linguistic thinking of ʿAbd al-Qāhir al-Jurjānī”, in
The Word in Arabic, eds Giuliano Lancioni e Lidia Bettini, Leiden: Brill, 2011, p. 85-108.
Gully, Adrian, “Taḍmīn, ‘Implication of Meaning,’ in Medieval Arabic”, Journal of the
American Oriental Society, vol. CXVII, n. 3 (1997), p. 466-480.
Hämeen-Anttila, Jaakko, Maqama: A History of a Genre, Wiesbaden, Otto Harrassowitz
Verlag, 2002.
Haxen, Ulf, “The Muʿāraḍa concept and its musico-rhythmical implications. A prelimi-
nary clue”, Al-Andalus, 43.1 (1978), p. 113-124.
Homerin, Emil, “Arabic religious poetry, 1200-1800”, in Arabic Literature in the
Post-Classical Period, eds Roger Allen and D.S. Richards, Cambridge, Cambridge
University Press, 2008, p. 74-86.
Householder Jr, Fred W., “Π APΩ IΔ IA”, Classical Philology, 39.1 (1944), p. 1-9.
Hutcheon, Linda, “Ironie, Satire, Parodie: Une Approche Pragmatique de l’Ironie”,
Poetique, 46 (1981), p. 140-155.
Hutcheon, Linda, A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-century Art Forms,
Urbana, University of Illinois Press, 2000.
Kanazi, George J., Studies in the Kitāb Aṣ-Ṣinā‘atayn of Abū Hilāl Al-‘Askarī, Leiden, Brill,
1989.
Larkin, Margaret, “Popular Poetry in Post-Classical Period”, in Arabic Literature in the
Post-Classical Period, eds Roger Allen and D.S. Richards, Cambridge, Cambridge
University Press, 2008, p. 191-242.
Meisami, Julie Scott, “Imruʾ al-Qays Praises the Prophet”, in Tradition and Modernity in
Arabic Literature, Fayetteville, eds Issa J. Boullata and Terri De Young, The University
of Arkansas Press, 1997, p. 223-245.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
336 Ismail
Meisami, Julie Scott, Structure and Meaning in Medieval Arabic and Persian Lyric Poetry:
Orient Pearls, London, Routledge, 2003.
Montgomery, James Edward, “Al-Jāḥiẓ on jest and earnest”, in Georges Tamer (ed.),
Humor in Arabic Culture, Berlin, Walter de Gruyter, 2009, p. 209-240.
Muḥammad, ʿĪd al-Waṣīf, Šarḥ maqṣūrat Ibn Durayd, Dubai, Muʾassasat Sulṭān b. ʿAlī
al-ʿUways al-Ṯaqāfijiyya, 2012.
al-Musawi, Muhsin J., Arabic Poetry: Trajectories of Modernity and Tradition, London,
Routledge, 2006.
Peled, Mattitiahu, “On the Concept of Literary Influence in Classical Arabic Criticism”,
in Sasson Somekh (ed.), Studies in Medieval Arabic and Hebrew Poetics: 1991. Volume
11 di Israel Oriental Studies, Leiden, Brill, 1991, p. 37-46.
Pellat, Charles, “Seriousness and Humour in Early Islam (al-jidd waʾl-hazl fī ṣadr
al-Islām)”, Islamic Studies, 2.3 (1963), p. 353-362.
Sadān, Yūsuf, al-Adab al-ʿarabī al-hāzil wa-nawādir al-ṯuqalāʾ, ʿAkkā, Ǧāmiʿat Tel
Aviv-Maṭbaʿat al-Surūǧī, 1983.
Sadān, Yūsuf, “Risāla fī l-damāma li-Muḥammad b. Ḥamza al-Kūzalḥiṣārī al-Aydīnī
wa-mā sabaqa-hā min mawāqif al-udabāʾ min al-ʿāhāt wa-l-qubḥ”, al-Karmil. Abḥāṯ
fī l-Luġa wa-l-Adab, 9 (1988), p. 7-33.
Sallūm, Yūnus Ṭurkī, al-Muʿāraḍāt fī l-šiʿr al-andalusī, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya,
2008.
Sangsue, Daniel, La parodia, ed. Fabio Vasarri, Roma, Armando Editore, 2006.
Sanni, Amidu, “Again on Taḍmīn in Arabic Theoretical Discourse”, Bulletin of the School
of Oriental and African Studies, 61.1 (1998), p. 1-19.
al-Šāyib, Aḥmad, Tārīḫ al-naqāʾiḍ fī l-šiʿr al-ʿarabī, al-Qāhira, Maktabat al-Nahḍa
al-Miṣriyya, 1954.
Stetkevych, Suzanne Pinckney, The Mute Immortals Speak: Pre-Islamic Poetry and the
Poetics of Ritual, Ithaca and London, Cornell University Press, 1993.
Stetkevych, Suzanne Pinckney, “From Jāhiliyyah to Badīʿiyyah: Orality, Literacy, and the
Transformations of Rhetoric in Arabic Poetry”, Oral Tradition, 25/1 (2010), p. 211-230.
Szombathy, Zoltan, Mujūn: Libertinism in Mediaeval Muslim Society and Literature,
Warminster, Gibb, 2013.
al-Taṭāwī, ʿAbd Allāh, al-Muʿāraḍāt al-šiʿriyya anmāṭ wa-taǧārib, al-Qāhira: Dār Qubāʾ
li-l-Ṭibāʿa wa-l-Našr, 1997.
Van Gelder, Geert Jan, “Arabic Debates of Jest and Earnest”, in Dispute Poems
and Dialogues in the Ancient and Mediaeval Near East, eds G.J. Reinink and
H.L.J. Vanstiphout, Leuven, Peeters Press, 1991, p. 199-211.
Van Gelder, Geert Jan, “Mixtures of Jest and Earnest in Classical Arabic Literature:
Part I”, Journal of Arabic Literature, 23.2 (1992), p. 169-190.
Van Gelder, Geert Jan, “Muʿāraḍa”, in Encyclopedia of Arabic Literature, eds Julie Scott
Meisami and Paul Starkey, London, Routledge, 1998, vol. II, p. 534.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Considerazioni teoriche e critiche sull ’ imitazione parodica 337
Van Gelder, Geert Jan, “Taḍmīn”, in P.J. Bearman et al., Encyclopaedia of Islam, Leiden,
Brill, 2000, vol. X, p.78-79.
Van Gelder, Geert Jan, “Frivolous Iqtibās (Quotation from the Qurʾān) According to
Medieval Arab Critics”, Quaderni di Studi Arabi, vol. XX/XXI (2002-2003), p. 3-16.
Van Gelder, Geert Jan, Of Dishes and Discourse: Classical Arabic Literary Representations
of Food, London, Routledge, 2011.
Von Grunebaumm, Gustave E., “The Concept of Plagiarism in Arabic Theory”, Journal
of Near Eastern Studies, vol. III, n. 4 (Oct., 1944), p. 234-253.
Quaderni di Studi Arabi 15 (2020) 313-337
This content downloaded from
94.32.214.69 on Sun, 28 Apr 2024 09:02:05 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Potrebbero piacerti anche
- Conte Barchiesi Lo Spazio Letterario I 1989Documento35 pagineConte Barchiesi Lo Spazio Letterario I 1989kiaraNessuna valutazione finora
- 3 Mathnawi PDFDocumento8 pagine3 Mathnawi PDFValentina Baglione IINessuna valutazione finora
- Bettini - Verso Un'antropologia Dell'intreccioDocumento64 pagineBettini - Verso Un'antropologia Dell'intrecciodanielefrabottaNessuna valutazione finora
- Abu Nuwas, GabrieliDocumento19 pagineAbu Nuwas, GabrieliFederica KamberiNessuna valutazione finora
- La Filologia Omerica Antica e La Storia Del Testo Omerico: Franco MontanariDocumento18 pagineLa Filologia Omerica Antica e La Storia Del Testo Omerico: Franco MontanarilicornutNessuna valutazione finora
- Clericus VagansDocumento20 pagineClericus Vagansneobarroco71Nessuna valutazione finora
- Capezio, Oriana (2017) Nota Sulla Danza Nel Mondo Arabo Medievale. en Quaderni Di Studi Arabi, 2017, Vol. 12 (2017), Pp. 59-68. Istituto Per L'oriente C. A. NallinoDocumento11 pagineCapezio, Oriana (2017) Nota Sulla Danza Nel Mondo Arabo Medievale. en Quaderni Di Studi Arabi, 2017, Vol. 12 (2017), Pp. 59-68. Istituto Per L'oriente C. A. NallinojosefinazuainNessuna valutazione finora
- Alvaro Barbieri - CavalleriaDocumento246 pagineAlvaro Barbieri - CavalleriaMarty FarinaNessuna valutazione finora
- Servio e I Poeti Romani Arcaici PDFDocumento31 pagineServio e I Poeti Romani Arcaici PDFvalentinoNessuna valutazione finora
- Boccali - 2012 - KalidasaDocumento20 pagineBoccali - 2012 - KalidasapervincarumNessuna valutazione finora
- Riti Di PassaggioDocumento13 pagineRiti Di PassaggioMariù RussoNessuna valutazione finora
- JHVH JVDocumento3 pagineJHVH JVMatteo ZanonNessuna valutazione finora
- ArtifexDocumento215 pagineArtifexAser DliveNessuna valutazione finora
- Annali 1995 (f.4) R.tottoli PDFDocumento9 pagineAnnali 1995 (f.4) R.tottoli PDFSerena CepollaroNessuna valutazione finora
- Muqarnas: History and InterpretationsDocumento28 pagineMuqarnas: History and InterpretationsStefano PelosatoNessuna valutazione finora
- Nora Moll Marinai Ignoti-LibreDocumento26 pagineNora Moll Marinai Ignoti-LibreHULIOSMELLANessuna valutazione finora
- 1957 - Cremaschi - La Lingua Latina Nel MedioevoDocumento24 pagine1957 - Cremaschi - La Lingua Latina Nel MedioevoMarco LuchiNessuna valutazione finora
- UntitledDocumento144 pagineUntitledmamomauroNessuna valutazione finora
- ArticoloDocumento13 pagineArticoloMarianna GemelliNessuna valutazione finora
- ΑΙΩΝ Aion Da Omero Ad Aristotele (Enzo Degani)Documento164 pagineΑΙΩΝ Aion Da Omero Ad Aristotele (Enzo Degani)masanta11Nessuna valutazione finora
- Artifex Additus ArtificiDocumento184 pagineArtifex Additus Artificimatteoveronesi100% (3)
- Sobre AnceschiDocumento16 pagineSobre AnceschiPablo López CarballoNessuna valutazione finora
- GT2Pavese Metrica3 DicembreDocumento353 pagineGT2Pavese Metrica3 DicembreGiorgio RoncellaNessuna valutazione finora
- VinoDocumento1 paginaVinoFrancesco GarozzoNessuna valutazione finora
- D'Alfonso F., Euripide in Giovanni Malala PDFDocumento120 pagineD'Alfonso F., Euripide in Giovanni Malala PDFAndrea RossiNessuna valutazione finora
- 1089-Article Text-3880-1-10-20151016Documento18 pagine1089-Article Text-3880-1-10-20151016abirNessuna valutazione finora
- Profumo Mueller, Le Opere Geometrizzate Di Luca CambiasoDocumento9 pagineProfumo Mueller, Le Opere Geometrizzate Di Luca CambiasoClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Benedetto Croce, Il Concetto Del Barocco 1925Documento15 pagineBenedetto Croce, Il Concetto Del Barocco 1925Andrea Pinotti100% (1)
- Platone, Senofonte e AntisteneDocumento21 paginePlatone, Senofonte e AntisteneGeorge FelipeNessuna valutazione finora
- Rivista Semestrale Online / Biannual Online Journal: Fascicolo N. 26 / Issue No. 26 Dicembre 2022 / December 2022Documento27 pagineRivista Semestrale Online / Biannual Online Journal: Fascicolo N. 26 / Issue No. 26 Dicembre 2022 / December 2022Parole rubate. Rivista internazionale di studi sulla citazione / Purloined Letters. An International Journal of Quotation StudiesNessuna valutazione finora
- La Donna, Il Servo E Il Cittadino in AristotleDocumento17 pagineLa Donna, Il Servo E Il Cittadino in AristotleContra MundumNessuna valutazione finora
- Barocco e MarinoDocumento5 pagineBarocco e Marinoit's meeNessuna valutazione finora
- Propedeutica Traina RiassuntoDocumento16 paginePropedeutica Traina RiassuntoAnna CeccarelliNessuna valutazione finora
- Issue Nr. 26: 02. A Proposito Di Alcune Citazioni Della "Vita Di Feodosij" - Nicoletta Cabassi (Università Di Parma)Documento33 pagineIssue Nr. 26: 02. A Proposito Di Alcune Citazioni Della "Vita Di Feodosij" - Nicoletta Cabassi (Università Di Parma)Parole rubate. Rivista internazionale di studi sulla citazione / Purloined Letters. An International Journal of Quotation StudiesNessuna valutazione finora
- Istituto Per L'oriente C. A. Nallino: Info/about/policies/terms - JSPDocumento20 pagineIstituto Per L'oriente C. A. Nallino: Info/about/policies/terms - JSPTeresa CasagrandeNessuna valutazione finora
- Albrile DEMONEDocumento25 pagineAlbrile DEMONERoberto MonachesiNessuna valutazione finora
- AGOSTINO LONGO Concezioni e Immagini Dell'ispirazione Poetica in OrazioDocumento50 pagineAGOSTINO LONGO Concezioni e Immagini Dell'ispirazione Poetica in OrazioFiorenzo TassottiNessuna valutazione finora
- Amore Ed Eros Tra Kavya Ed Epigrammi Vis PDFDocumento94 pagineAmore Ed Eros Tra Kavya Ed Epigrammi Vis PDFjohnfanteNessuna valutazione finora
- GRS Mead La Gnosi Della Mente Saggio DiDocumento27 pagineGRS Mead La Gnosi Della Mente Saggio DiMarcello MucciniNessuna valutazione finora
- Ginzburg 2019 STORIA DELL'ARTE, DA VICINO E DA LONTANODocumento13 pagineGinzburg 2019 STORIA DELL'ARTE, DA VICINO E DA LONTANOGaoMingNessuna valutazione finora
- Gensini 1995 - Vico e L'ingeniumDocumento21 pagineGensini 1995 - Vico e L'ingeniumstefano53Nessuna valutazione finora
- Musica e IslamDocumento21 pagineMusica e IslamMartinaNessuna valutazione finora
- La Extensión Pragmática de La Parodia - L.Hutcheon PDFDocumento22 pagineLa Extensión Pragmática de La Parodia - L.Hutcheon PDFDaniela GutiérrezNessuna valutazione finora
- Saggi Leonardi Critica Del Manoscritto Base PDFDocumento31 pagineSaggi Leonardi Critica Del Manoscritto Base PDFDianaNessuna valutazione finora
- Ferrero, L'asindeto in Menandro PDFDocumento23 pagineFerrero, L'asindeto in Menandro PDFAntonis PetridesNessuna valutazione finora
- Issue Nr. 25: 10. Il Carme V Di Catullo in Torquato Tasso - Giandamiano Bovi (Università Di Parma)Documento21 pagineIssue Nr. 25: 10. Il Carme V Di Catullo in Torquato Tasso - Giandamiano Bovi (Università Di Parma)Parole rubate. Rivista internazionale di studi sulla citazione / Purloined Letters. An International Journal of Quotation StudiesNessuna valutazione finora
- Plotino e ÇankaraDocumento16 paginePlotino e ÇankaraMaria PalmaNessuna valutazione finora
- James Frazer Il Ramo D'oroDocumento31 pagineJames Frazer Il Ramo D'oroKillerKattNessuna valutazione finora
- Il Sogno e L'arco. Sofismi e Paradossi Nel Canto 19 Dell'odisseaDocumento47 pagineIl Sogno e L'arco. Sofismi e Paradossi Nel Canto 19 Dell'odisseaaristarchos76Nessuna valutazione finora
- Rosati 1979 L'esistenza LetterariaDocumento37 pagineRosati 1979 L'esistenza LetterariaLeleScieriNessuna valutazione finora
- 4 - Ghazal PDFDocumento7 pagine4 - Ghazal PDFValentina Baglione IINessuna valutazione finora
- La Letteratura Persianadocx 1Documento6 pagineLa Letteratura Persianadocx 1Anna Laura RossiNessuna valutazione finora
- OdisseaDocumento11 pagineOdisseaGiovanniNessuna valutazione finora
- Settis Futuro Del ClassicoDocumento5 pagineSettis Futuro Del Classicoiole0% (1)
- Il Linguaggio Della Poesia 2021-22Documento29 pagineIl Linguaggio Della Poesia 2021-22c.baccoNessuna valutazione finora
- Auctores Nostri 4 2006Documento688 pagineAuctores Nostri 4 2006MARIA VICTORIA CoceNessuna valutazione finora
- Amato ListyDocumento21 pagineAmato Listypigeon secretNessuna valutazione finora
- Vibii sequestris de fluminibus fontibus lacubus nemoribus paludibus montibus gentibus per litterasDa EverandVibii sequestris de fluminibus fontibus lacubus nemoribus paludibus montibus gentibus per litterasNessuna valutazione finora
- Il Bruco Affamato - Domande - ComprensioneDocumento1 paginaIl Bruco Affamato - Domande - ComprensioneUlisse SantusNessuna valutazione finora
- Pupazzo Di Neve - SequenzeDocumento1 paginaPupazzo Di Neve - SequenzeUlisse SantusNessuna valutazione finora
- UntitledDocumento1 paginaUntitledUlisse SantusNessuna valutazione finora
- Sequenze Cappuccetto RossoDocumento1 paginaSequenze Cappuccetto RossoUlisse SantusNessuna valutazione finora
- Lilli e Le Mele - ControlloDocumento1 paginaLilli e Le Mele - ControlloUlisse SantusNessuna valutazione finora
- La Leggenda Delle CastagneDocumento1 paginaLa Leggenda Delle CastagneUlisse SantusNessuna valutazione finora
- Rapporto Lupo 2022Documento31 pagineRapporto Lupo 2022daniele tambaloNessuna valutazione finora
- Introd Critica A.MinafraDocumento15 pagineIntrod Critica A.MinafraGustavo MedinaNessuna valutazione finora
- Karl Marx (In Pillole) - A Cura Di Mario BoyerDocumento168 pagineKarl Marx (In Pillole) - A Cura Di Mario BoyerDiavolo Rosso100% (1)
- Lettera Amm FilippiDocumento2 pagineLettera Amm FilippiIginoNessuna valutazione finora
- La Comunicazione Non Convenzionale 12Documento37 pagineLa Comunicazione Non Convenzionale 12Ailene FlemingNessuna valutazione finora
- Lotta Spirituale MANICARDIDocumento20 pagineLotta Spirituale MANICARDIbilaci2012Nessuna valutazione finora
- Le Nozze Di Figaro - TramaDocumento2 pagineLe Nozze Di Figaro - TramaGiulia BassettoNessuna valutazione finora
- Appunti Di Semiografia MusicaleDocumento5 pagineAppunti Di Semiografia MusicaleRosario CaponnettoNessuna valutazione finora