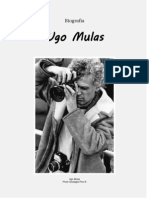Comunicazione Visiva Appunti
Caricato da
MonicaComunicazione Visiva Appunti
Caricato da
MonicaCOMUNICAZIONE VISIVA
11/02/2020
La post-fotografia è la pratica usata nei social. “Post” significa lavorare e deriva da
post-modernismo, indica l’idea del cambiamento.
“inter” significa incrociare metodologie/modalità che arrivano da parti diverse.
Temi: somiglianza, guerra/morte, nudo/specchio, tempo, animali, archivio.
Il 1839 è la data ufficiale del battesimo della fotografia, diversi inventori si erano posti il problema
di fissare un’immagine creata dall’azione della luce su delle sostanze chimiche. Daguerre ha
inventato uno dei metodi possibili e sancisce quindi questa scelta. I primi dagherrotipi dovevano
avere una condizione di luce per poter vedere l’immagine.
Le immagini sono sempre state di 2 tipi per l’essere umano:
1) FATTE A MANO: interpretate, soggettive (anche il realismo per quanto potesse essere oggettivo
dipendeva dalla mano dell’artista);
2) SPECCHIO: elemento non umano che fino a quel momento restituiva un’immagine. Lo specchio
è la metafora dell’immagine
Meta rappresentazione: rappresentazione che parla della rappresentazione, attraverso l’immagine
dà una riflessione sull’immagine stessa (ex: specchio nell’immagine).
Lo “shock” è determinato dal sapere che l’immagine è oggettiva ed è creata dalla natura stessa, non
è fatta dalla mano dell’uomo. La macchina/tecnologia è la seconda mano della natura.
SOMIGLIANZA: come somiglia l’immagine alla realtà?
Nadar racconta che le persone che andavano a ritirare i propri ritratti non si riconoscevano, la
somiglianza non è quindi scontata, perché scattano dei meccanismi, ciò che vedo è diverso da come
vorrei vedermi. Lui metteva un telo bianco per lo sfondo, isolava le persone dal contesto.
- André-Adolphe Eugéne Disdéri “Lo studio per ritratti” 1865. Ha un atelier di fotografia (per fare i
ritratti) composto da stanze preparatorie per la fotografia. La fotografia era un rituale borghese.
“Borghese” indica lo stato sociale borghese: classe sociale che stacca la sua indipendenza dalla
classe superiore e cerca una propria identità in tutti i livelli. Il rituale è graduale, fatto di numerosi
step, c’erano diverse stanze che accompagnavano all’ultima stanza.
La realizzazione di immagini era lunga: 20 minuti di posa, poi sempre di meno: bisognava stare
fermi altrimenti la foto veniva mossa, per farlo c’erano dei trucchi come il poggiatesta.
- Jean Dominique Ingres è il più grande ritrattista dell’epoca. “Coppia” 1845: dagherrotipo dove lei
tiene la mano sulla spalla di lui ed è vestita come le veniva imposto.
- André-Adolphe Eugéne Disdéri: ritratto della regina del 1861 e il dottor John Collins Warren del
1840: dagherrotipo, ritratto con scheletro perché lui faceva il medico
L’immagine mostra come le cose appaiono, non come le cose sono.
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
Il lavoro è un grande tema, la borghesia si fa ritrarre con i propri utensili anche se non nel luogo di
lavoro, ad esempio “fabbro” che è un dagherrotipo. Io sono il lavoro che faccio, questo vale
soprattutto per il terzo stato, i poveri. Courbet, esponente del realismo francese, ritraeva coloro
che lavoravano.
- Angelus di Millet del 1858/1859 rappresenta la fine della giornata.
Nadar nel 1870 si pone il problema della somiglianza interiore, come si può restituire non tanto
l’aspetto esteriore ma quello interiore? Lui frequentava artisti non solo in ambito letterario, ma
anche musicale e spesso questi erano antiborghesi con caratteri forti. Ciò che è dentro traspare
nell’apparenza, nel visibile.
- Nadar, “George Sand”: scrittrice che assume lo pseudonimo maschile per rappresentare la sua
potenza.
Nadar stabilisce una conversazione con il soggetto ed è così che emerge il carattere del soggetto ->
il fotografo coglie l’attimo in cui il soggetto si rivela. La fotografia inizia a indurre attenzioni su delle
azioni che prima erano superficiali, ad esempio l’assenzio di Edgar Degas.
La fotografia riduce i costi: Disdéri inventa un metodo per ridurli, l’immagine viene divisa in 6 lastre
(formato tessera).
Gli attori sono importanti nella scena ottocentesca: sono persone fuori dagli schemi come gli artisti,
amati per il loro lato trasgressivo, si fanno fotografare nel ruolo che recitavano, che li ha resi famosi.
Recitare è assumere un’altra parte, trasgredire la naturalezza e la spontaneità, ma mentre recito
sono me stessa, dietro il ruolo traspare quindi l’attore -> ex: Eleonora Duse, Sciutto, 1900.
All’inizio non c’era un’idea di tempo, la situazione è immobile, poi la gente inizia a muoversi, come
se fosse una scenetta. Questo cambia le cose perché c’è una spontaneità ricostruita (ossimoro):
distinguere finzione e realtà è molto difficile. Si attribuisce involontariamente oggettività,
rendendola un’immagine reale. La doppia moralità è una caratteristica della classe borghese, che
aveva istituzionalizzato un doppio comportamento.
12/02/2020
Nella società borghese esisteva una doppia moralità, in questo contesto si riteneva che all’estero
(nelle colonie) si potessero fare quelle cose che in patria erano ritenute oscene, il comportamento
dei colonialisti nelle colonie era al limite dell’umano.
Ritratti delle ragazze delle colonie di fine 800 si gioca
sull’ambiguo, sul vedo non vedo, non è totalmente nuda,
ma solo a metà. In questo modo si può comunicare un
messaggio lasciando solo intuire, non mostrandolo
esplicitamente. Tutte le foto sono studiate
attentamente: la sigaretta è un dettaglio studiato e
accurato. La fotografia in questione (“L’Algeria
pittoresca”, Albert, 1900) esalta i sensi e
l’immaginazione: venendo in Algeria si potrà trovare il
paradiso dei sensi. Nasce il concetto di immaginario: non si presenta un oggetto specifico, bensì
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
un’immagine (oggi molto usato nella pubblicità). Esiste quindi una differenza tra rappresentazione e
rappresentanza, simile a quella tra denotazione (=la ragazza con la sigaretta sul divano, quello che
vedo) e connotazione (=ciò che l’immagine suggerisce, la ragazza con emozione, ricordi). Questo è
un modo di usare le immagini/foto facendo finta di rappresentarle attraverso la denotazione per
esprimere un significato connotativo in modo subdolo (chi vede l’immagine la interpreta come
vuole).
- La connotazione in questa foto è data dalla posizione orizzontale, che diviene
un luogo come per giustificare il colonialismo: sono popoli pigri, su cui ci
dobbiamo imporre. Il califfo in orizzontale connota l’idea che i sovrani di
questi popoli siano pigri.
- Nel ritratto di Red Fish lo sguardo del capo tribù è orgoglioso e di sfida. Questi
popoli furono sconvolti dalla fotografia e quando vedevano i loro ritratti
fotografati si spaventavano molto, convinti che la loro immagine fosse stata
strappata. Non credevano possibile che si potesse fare un’immagine che non
fosse stata dipinta, infatti, in molte tribù come quelle africane, non esistono
immagini realiste. Teoria degli spettri: indiani d’America pensavano che la foto
imprigionasse un pezzo d’anima ed erano spaventati da ciò. Al contrario, per i
colonizzatori, il ritratto fotografico era un dato oggettivo.
- Gli inglesi fecero molti lavori di antropologia ed etnografia sui coloni,
per compararsi con i popoli colonizzati. Questa comparazione avveniva a
fini scientifici, tuttavia non c’era rispetto o considerazione per la persona.
Gli inglesi rappresentavano e catalogavano le cose, le persone venivano
oggettivate, come in questa foto che cataloga il corpo di un
sud-australiano (altezza, postura, grandezza), infatti è nudo.
Si definisce come positivismo questa tendenza a misurare e oggettivare
tutto. Ciò che è emotivo e personale deve essere lasciato da parte, a
favore dell’archiviazione dei dati. Un effetto ulteriore del positivismo è
l’idea che dal volto si possano intuire la personalità e i disturbi della psiche umana.
Gericaul (pittore) realizzò una serie di ritratti, quella dei monomaniaci, in cui cerca di mostrare quali
sono i volti che riflettono determinati disturbi: monomaniaco del furto, del gioco, ecc.
Il fratello di Nadar, Adrien Tournachoun, fu assoldato da un medico per dimostrare che, a seconda
di dove si fa la scossa, si ottiene una reazione umana, dunque la psicologia è solo una questione di
elettrodi. Darwin però svelò che queste immagini, private della didascalia, non fossero precise. Ciò
dimostra che la didascalia, ad esempio nel giornalismo, indirizza l’interpretazione della foto. Con la
fotografia nasce la carta d’identità come la conosciamo oggi perché è somigliante al vero: noi
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
somigliamo molto di più alla fotografia che non alla descrizione verbale. Con la fotografia si iniziano
dunque a schedare nasi, fronti ed altri caratteri somatici, per permettere ai poliziotti di riconoscerli.
Nasce un vero e proprio lessico di classificazione comune. Nascono gli identikit perché il sistema di
descrizione si fa sempre più dettagliato. Il metodo Bertillon ha per primo ideato e accettato il
metodo fronte profilo, per schedare i ricercati. Per capire la correlazione tra foto e psiche si fecero
una serie di immagini sovrapposte per capire se effettivamente i caratteri fossero comuni.
- August Sander attuò un progetto di schedatura di tutte le casistiche del modo di essere dell’essere
umano, chiamato “l’uomo del XX secolo”. Sander utilizzava tutte le categorie possibili per
identificare una persona: sesso, età, professione... Per Sander l’immagine non è solo oggettiva, ma
anche rivelatoria: nell’apparire c’è l’importante. Il rapporto tra apparenza e verità si sta quindi pian
piano rovesciando.
18/02/2020
Siamo agli inizi della fotografia, vediamo anticipate delle questioni generali. Oltre all'applicazione
della fotografia nei campi più evidenti come il ritratto, i luoghi montani, il ritratto della propria
famiglia e del proprio diario, vediamo che la fotografia ha anche delle applicazioni di tipo scientifico,
ad esempio la misurazione dei caratteri somatici della persona, durante il colonialismo.
La fotografia pone il problema della visibilità. Le persone con comportamenti asociali (che
nuocciono alla comunità) vengono rinchiuse nelle prigioni, quelli malati negli ospedali, quelli con
malattie incurabili in speciali tipi di ospedali, chiusi, in modo che non si veda: c'è una popolazione
invisibile che la fotografia comincia però a documentare, inizialmente solo in ambiti psichiatrici e
medici, ma che poi diventano visibili per libri e pubblicazioni.
- Si mostrano anche malformazioni fisiche come nella foto di O.G. Mason Elefanti da scarlattina,
1878. Avere un'immagine fissa di questo tipo fu uno shock notevole all'epoca per chi non voleva
vedere queste malformazioni. Il panno sulla testa significa: 1-lei si vergogna e nasconde i suoi tratti;
2-non si può vedere in faccia, siamo noi che non vogliamo personificare l'immagine. La privacy è il
rispetto della persona, la censura invece è dettata dalla società.
Queste immagini sono importanti per descrivere il periodo. Le persone isteriche sono malate di
mente in modo particolare, sullo studio dell'isteria nasce la psicanalisi. Delinquenti, malati di mente
e malformati sono una popolazione esotica, esterna, ma all'interno della società stessa: è la società
che isola queste persone e ne fa un "altro, diverso" all'interno della società. Questo tipo di
documentazione fotografica ci fa vedere per la prima volta determinate cose, sono immagini molto
strane. In un’altra immagine c’è l’inquadratura della parte sotto del corpo. Queste posizioni della
foto, coi piedi che si contorcono, sono immagini del tutto nuove, nuovi concetti.
- Bourneville e Régnard, Catalessi, 1789-1780. Ci rievoca le sante, ma è isteria. Vediamo che la
psicanalisi inizia a pensare che ci sia un legame.
Cominciamo a studiare grazie alle immagini (che ci rendono evidenti le cose) le analogie che
esistono tra i comportamenti "normali" e la loro esasperazione: vedo, attraverso le malattie, i
caratteri umani. Siamo un po' tutti paranoici, ci sono comportamenti che sono totalmente nella
normalità. Sono tutti, in piccolo, la manifestazione di una possibilità latente di questi. Queste
immagini rendono visibile questo mondo. L'invisibile è ancora più interessante. Perché tutto il
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
romanticismo aveva spostato l'attenzione sui fenomeni umani spirituali: sentimento, emozioni, ma
anche sullo spirito, l'anima, questa parte invisibile dell'essere umano. come si manifesta nel corpo?
- Ludwig Zehnder, radiografia di un corpo umano, 1896. Immaginiamo le persone in questo periodo
che, per la prima volta, vedono l'interno del proprio corpo, grazie ai raggi x. È un'idea che la vista
possa vedere qualcos'altro, di più di ciò che ha visto finora, forse anche l'invisibile ha dei modi di
manifestarsi, così migliaia di persone iniziano a cercare di catturarlo e a renderlo manifesto.
Dottor Hippolyte Baraduc, che è un pilastro di questo periodo, studia “L'aura di un'anima sensibile”,
1896. Cercava di rendere manifesto il pensiero, perché, se pensiamo, dove va questo pensiero? La
scoperta del magnetismo è collegata a questo. Le cose oltre che le persone quindi si attraggono,
per meccanismi fisici, anche se invisibili. Questo è anche l'anno della scoperta dell'illuminazione
elettrica. Quest'uomo chiede alla signora nell'immagine di pensare a qualcosa molto forte e la
fotografa, siamo nel periodo ancora della credulità che quell'alterazione nell'immagine (problemi di
messa a fuoco) siano l'emanazione della forza del pensiero della persona ritratta. Ovvero tutto ciò
che noi chiamiamo astratto, invisibile, sono delle emanazioni del corpo, che vengono catturate
(siamo a dei livelli fantasiosi). Sono ancora una volta immagini mai viste. Hereward Carrington in
“The problems of psychical reserarch experiments and theories in the realm of the supernatural”,
1921: idea di una sensibilità della fotografia che è superiore alla nostra, fiducia nella fotografia: le
macchine sono protesi per vedere meglio e potenziare le nostre possibilità. Fino a quel momento le
cose vengono condivise solo da gruppi esoterici, poi vengono rappresentati dalla fotografia.
L’ectoplasma è l’emanazione di queste cose, come le persone che dicono di vedere l'aura
positiva/negativa attorno alle persone, anche il passaggio dell'energia che guarisce, cosa comune
nel sud Italia. Le piccole alterazioni della superficie della fotografia vengono fatte passare come
questi fenomeni. L'aura la ritroveremo nel XX secolo. L'opera d'arte nella sua riproducibilità
tecnica > testo sulla perdita dell'aura. Lo spiritismo è molto importante dal punto di vista della
comunicazione: fino a che punto l'uomo arriva a credere all'incredibile. Dalle fotografie è evidente
che non siano spiriti quelle persone, ma sono problemi della fotografia o della superficie. Noi siamo
programmati per credere a qualsiasi cosa. Fino a questo punto la consapevolezza era padrona della
situazione, ora non lo è più.
Anche il fantasma diventa un tema pervasivo: a fine 800 arrivano romanzi sui fantasmi, dell'orrore.
Il fantasma cos'è? È la domanda del XX secolo. C’è il passaggio dall'idea che il fantasma sia la
sopravvivenza dell'essere, dell'anima, della persona morta, tra di noi. È un retaggio delle credenze
antiche o primitive. L'antropologia studierà molto il culto dei morti, uno dei racconti più diffusi sarà
che le popolazioni primitive pensino che le anime dei morti restino sempre tra di noi, oppure si
radunano in luoghi particolari, da cui nasce l'immaginario. Nel XX secolo nasce questa riflessione, la
psicanalisi stessa la studia. Il fantasma non indicherà più solo l'anima dei morti, ma un immaginario
che tutti si fanno.
MORTE: come venivano raffigurati i morti? Prima della fotografia:
1. modo canonico tramandato dall'iconografia: rappresentazione della vittima della morte, il morto,
in maniera cruenta, fantasiosa, più o meno realistica. Fino ad un certo punto la raffigurazione
pittorica del morto, per quanto violenta, colpiva, ma solo fino ad un certo punto; la
rappresentazione fotografica dello stesso soggetto farà un effetto 100 volte maggiore.
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
2. ritratto dal vivo, in presenza del cadavere: rappresentazione del morto celebre o a cui ci sia legati
per affetto. C'erano disegnatori e pittori che facevano prima il bozzetto a disegno e ritraevano
l'immagine: Marat di David fu ritratto al momento (reportage, in diretta). Non mi affido più a quello
che mi dicono, ma voglio essere testimone visivo.
- Nadar, Victor Hugo sul letto di morte, 1885. Stampa su carta all'albume.
Tutto questo viene rappresentato dalla fotografia, che sostituisce un'usanza e professione (del
disegno). Fotografare un morto non è come fotografare un vivo: non abbiamo più indagini
psicologiche della persona, non si possono fare. Cos'è la vita? Qual è la differenza tra una persona
viva e morte? Questa cosa che chiamiamo VITA viene spiritualizzata, perché non se ne capisce in
tutti sensi la causa. La medicina inizia ad interrogarsi in maniera materialistica su questo argomento.
Tutto l'esoterismo sulla sopravvivenza e immortalità trova la sua riformulazione moderna e
contemporanea. Parlando dell'immagine, c'è un sotto tema legato a questo: la vita dopo la morte,
la fama, la notorietà, la memoria, il tramandare il ricordo di una persona che non è più tra noi. Il
tema della morte è uno dei temi più importanti che si ritrova nei testi di Susan Sontag. Fotografare
è al tempo stesso uccidere (perché cattura un istante che subito dopo non esiste più, è morto, ogni
immagine fotografica è immagine del passato), e l’immagine tramanda la sopravvivenza di ciò che è
rappresentato nell'immagine stessa (come se fissasse l'immagine). Esiste sia un pensiero di morte
che di sopravvivenza nello stesso oggetto.
Un’usanza del mondo anglosassone era fotografare i bambini morti cari a noi, come se fossero
ancora vivi:
- Anonimo, Ritratto di bambina morta, 1850. L'affetto e l'emozione intervengono in questo
meccanismo. Questione dell'uso: un conto è quello che tramanda la foto, un conto è l'uso
(conservo l'immagine viva della persona, non della persona morta), quindi si passa sopra ad
immagini di verosimiglianza che si applica ad altre immagini.
- Secondo Pia, La Sacra Sindone, 1898. Cos'è la sacra sindone? Si inizia a chiedere dopo il suo
riconoscimento ufficiale, del sudario in cui è stato avvolto Gesù Cristo. Si tratta qui di un'impronta
lasciata direttamente da Gesù. Questo comporta due caratteristiche legate alla fotografia: non è
una rappresentazione, ma è un'impronta lasciata attraverso la luce su una lastra, la luce tocca e
altera le sostanze chimiche come il corpo; fotografia è impronta di un'impronta quindi.
L'immagine di qualcosa è anche l'impronta di questa, però a questo ci penso solo quando fotografo.
Anche l'arte cambierà perché si renderà conto di questa rappresentazione: diventerà la
rappresentazione della rappresentazione (nasceranno anche la linguistica, la semiotica, il pensiero
sul pensiero). Secondo la teologia se il corpo di Cristo è il corpo di Dio, la sua impronta conserva lo
statuto di sacro, ecco perché non si possono toccare i corpi dei santi. Per contatto, le due cose
conservano le stesse caratteristiche. La Sindone è un oggetto sacro, perché mantiene la divinità del
corpo, quindi non è possibile fotografarla.
MORTE E VIOLENZA: intorno al secondo decennio dell’800, la raffigurazione della violenza esplode.
- Théodore Géricault, La Zattera della Medusa, 1819 (metafora della Francia in quel periodo: nulla
funziona, neanche le navi). Raffigurazione del periodo vicino alla nascita della fotografia. L'uomo,
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
per dipingere i cadaveri, va a Marsiglia dove sono stati trasportati i morti. Per renderli
realisticamente va sul posto e fa il bozzetto. I corpi sono molli, privi di vita, riversi, con le parti
anatomiche non nascoste.
- Eugène Delacroix (pittore), La libertà guida il popolo, 1830. In fotografia per decenni non si può
rappresentare un cadavere e un corpo con ferite, sangue, mutilazioni… perché? Dipinto, un
soggetto può impressionare solo fino ad un certo punto. L'oggettività della fotografia rende le
immagini molto più potenti ai nostri occhi, alle nostre emozioni. Fotografare sangue è più vicino alla
realtà, perché vediamo la foto come un sostituto della realtà.
- Roger Fenton, The Valley of the Shadow of Death, 1885 (lui è il reporter della battaglia). La guerra
fotograficamente era raffigurata con il campo di battaglia, non la battaglia stessa. Passo seguente:
immagini dei cadaveri senza segno di violenza. I segni di violenza sono manifestazioni visive di
un'azione (pensarli e vederli non è la stessa cosa).
- O ‘Sullivan, messe di morte, scattata a Gettysburg nel 1863. Il fotografo per restituire la scena in
modo più veritiero, ha chiesto ai suoi assistenti di sdraiarsi nel campo. Quindi, fin dall'inizio, realtà e
finzione si mescolano, tanto da porsi il problema della falsificazione o manipolazione. L'immagine
fotografica è sempre stata corretta in qualche modo, anche con le buone intenzioni, ma fino a che
punto lo sono?
- Felice Beato, Esecuzioni capitali nel villaggio di Kiro, 1862. È il primo ad andare in oriente a
verificare sul posto e, non rispettando le volontà del popolo, ha fotografato la scena. Questa è una
delle prime immagini di una violenza cruda, non è compiaciuto il dettaglio, ma si vede che non è
una messinscena ma una situazione reale.
- Weege, Assassino di poliziotti, 1939. C’è una escalation, rincorsa ad aumentare sempre più la
realisticità dell'immagine per ottenere un soggetto che viene attutito dalla ripetizione. Da un lato, a
furia di vedere immagini realistiche della violenza, si è assuefatti, quindi si vuole sempre di più, c'è
un continua ricerca della realisticità della violenza, in modo da farla vedere sempre più. È un modo
di dire, o veramente siamo abituati a queste immagini? Da un lato è vero, ci abituiamo a sentire le
stesse notizie e la ripetizione crea degli effetti su cui ci interroghiamo, o di abitudine (quindi di
diminuzione del suo effetto) o di assuefazione e quindi si continua a mantenere viva l'attenzione sul
soggetto. Il soggetto dell'opera è una figura leggendaria: è il primo fotoreporter urbano delle
metropoli, di violenza e di delinquenza. La cosa che lui capisce è che bisogna arrivare quando la
situazione è ancora calda, nel momento, direttamente, se no perdi quello di cui si tratta. Anche qui
nascono immagini nuove, lui capisce che la gente e le persone si alterano nelle ore notturne,
durante le prime ore della notte. Così diventa un fotoreporter della notte. Inizialmente fu un
radioamatore e trova un modo di sintonizzarsi sulla lunghezza d'onda della polizia, quindi poteva
scattare le foto sul momento. Sono immagini di una diretta in cui l'evento criminoso era appena
accaduto ma i segni sono ancora lì.
- Weegee, Cadavere e revolver, 1940. Qui si tratta della foto di una pistola (in primo piano) che ha
ucciso l'uomo (in secondo piano). La pistola si identifica con la macchina fotografica, anche
l'immagine è come la pistola, uccide ("shoot" è la stessa parola per dire scattare e sparare).
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
- Robert Capa, Morte di un soldato repubblicano, 1936. È il momento esatto in cui il proiettile entra
nel corpo della persona ritratta. La fotografia è uno strumento di precisione perché cattura l'istante
preciso, perfetto (prima è troppo presto, dopo è troppo tardi). Il reportage, a partire da questa
immagine, è la professione dell'andare sul posto dell'evento proprio nel momento in cui sta
accadendo. Il fotografo è la persona intuitiva che arriva un momento prima, in modo da catturare il
momento perfetto. Questo diventerà così importante che, a partire da questa pratica della cattura
dell'istante decisivo, in molte circostanze, il gesto significativo verrà ripetuto, per farsi fotografare
da tutti i presenti. L'attimo, l'istante (da cui istantanea come sinonimo di fotografia) è il punto
culminante, solo da quell'istante riesco a dedurre ciò che accadde un momento prima e accadrà un
momento dopo. Anche la pittura ha ricercato ciò.
- Robert Capa, Sbarco in Normandia, 1944. Questa è quasi il contrario di quella di prima, qui ha
voluto far parte dell'evento. In questo caso, l'istante decisivo non c'è, c'è una situazione
drammatica, ma la particolarità è che ci dà uno scatto visto dall'interno, non dall'esterno.
Distinzione tra testimonianza e partecipazione. Lui per restituire questa partecipazione sacrifica
tutti i parametri della fotografia e, per la prima volta, giornalisticamente vengono proposte
immagini che qualsiasi fotografo amatoriale potrebbe fare. Vengono accettate perché si
comprende il tratto espressivo di questi difetti. Il non rispetto dei canoni è un difetto se devo fare
un certo tipo di immagine, ma può essere usato come valore espressivo per altre. Questo sarà il
cambio di parametro.
➢ Seconda guerra mondiale
Vengono presentate due questioni, che vediamo nelle seguenti due fotografie.
- Lee Miller, Buchenwald, 1945. Questione dei campi di concentramento: shock causato della
scoperta reale, non dell'informazione, per cui le prime persone che arrivavano a vederlo non
credevano ai propri occhi, non ci si credeva che fosse così disumana la scena. I mucchi di cadaveri
sono diventati il simbolo. La fotografa scrive ai giornali di Londra per informare della veridicità
dell'evento visivo, dicendogli di crederci. Siamo di fronte ad un nuovo tipo di immagini: incredibili.
La stessa fotografa si accorse che, scattando la fotografia, stava cercando l'inquadratura: rimase
talmente shockata da questo che smise di fare la fotografa per 10 anni. Le altre immagini proposte
"Immagini malgrado tutto" sono le uniche 4 immagini fotografiche rimaste dei campi di
concentramento durante, non dopo. Scattate malamente, da lontano, nascondendosi e sono
diventate argomento di analisi e di riflessione.
- Viaggio a Nagasaki, 1945. Questione delle 2 bombe atomiche: distruzione totale, un'esplosione
rade al suolo una superficie vastissima, e completamente tutto viene bruciato.
➢ Guerra del Vietnam
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
- Eddie Adams, Il grande generale Nguyen Ngoc Loan uccide un vietcong, 1968. Prima guerra
mediatizzata, teletrasmessa, con le cineprese. Ci sono due cose importanti a riguardo:
1. La concorrenza che si crea tra la televisione (immagine in movimento) e fotografia.
2. Ormai la televisione diventa più seguita (come conseguenza alla 1) della fotografia, quindi la
fotografia deve cercare di colpire di più, di innovarsi. L'immagine vista è un momento culminante, è
catturata un'esecuzione. Il FUTURO ANTERIORE è il tempo suggerito dall'immagine, un ossimoro, un
controsenso: il futuro è già dentro, è come se fosse già stato (siamo sicuri che il colpo partirà,
quindi lui sarà morto). È il potere di queste immagini (Rolan Barthes). Da questo punto di vista
questo è addirittura il culmine dell'acme (= momento culminante). È così se noi crediamo che sia
così, ma c'è la possibilità effettiva che sia una messa in scena a favore del fotografo. Il generale
stava per sparare alla persona, ha visto il fotografo, ha lasciato che il fotografo inquadrasse,
lasciandogli fare la foto, a beneficio del fotografo. È come se il generale avesse capito che l'evento
simbolico diventa efficace solo se visibile e fotografato: l'istante non è più solo l'istante di un
evento, ma è l'istante decisivo di un simbolo, di un significato. Questa immagine ferma può essere
più efficace della ripresa di tutta la scena fatta dalla televisione (non ha un momento culminante,
quindi il momento più va avanti più si cancella). Accadrà in modo particolare con l'immagine che
ebbe un significato decisivo sull'opinione americana.
19/02/2020
L’immagine della guerra del Vietnam à teletrasmessa e per la prima volta mette il pubblico di fronte
all’assuefazione, emozioni e reazioni diminuiscono d’intensità perché ci si abitua a vederla. Nel
momento in cui ci rendiamo conto, non abbiamo più reazioni, non proviamo più pietà e ci sale un
senso di colpa. Dalla parte del produttore c’è la rincorsa ad aumentare la dose per aumentare
l’effetto; la dose può essere data dalla sorpresa e bisogna tornare a colpire lo spettatore con
immagini memorabili. Noi dobbiamo creare eventi in tutti gli ambiti.
Susan Sontag fa un discorso sul passo di Platone del libro “La repubblica” in cui lui dice che noi
siamo come schiavi legati in fondo a una grotta fin dalla nascita. Questa grotta ha un foro nel
soffitto da cui entra una luce che si proietta sul fondo della grotta, la luce proietta ombre e noi
pensiamo che quelle siano la realtà. Scambiamo le apparenze per la realtà perché non avendo mai
visto fuori, non sappiamo distinguere le due. Sontag dice (anni ‘80) che noi tendiamo, per
automatismo, a scambiare le immagini per la realtà. È in corso una sostituzione: a furia di vedere le
immagini noi la scambiamo per la realtà stessa. Noi non specifichiamo mai di guardare “l’immagine”;
guardiamo la foto per ciò che rappresenta e iniziamo a guardare la realtà come un’immagine,
abbiamo della realtà un’esperienza sempre più basata sull’immagine (es. turisti giapponesi che
fanno un viaggio per fare foto, ma poi il vero viaggio è dato dalla proiezione delle diapositive a
casa).
Sontag scrive negli anni 70 (anni di impegno politico nei confronti di molti fenomeni sociali) e si
pone una domanda: noi comprendiamo ancora le cose? Le comprendiamo in maniera olistica
(=interdisciplinare/collettivistico) senza frammentare? Il rapporto realtà-immagine si rovescia
attraverso l’uso delle macchine fotografiche che diventano molto popolari, economiche, chiunque
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
se le può permettere. Il secondo effetto indotto è una riflessione sull’efficacia dell’immagine. Si
passa dal turismo all’immagine della guerra.
Lei adolescente vede l’immagine dei bambini in Vietnam, racconta che quell’immagine colpì
l’opinione pubblica più di qualsiasi altro video, foto, servizio.
La foto ci restituisce un’immagine fissa che poi possiamo guardare a lungo, un’immagine in cui,
dopo i primi sguardi, cerco i dettagli e cerco di comprenderla a fondo.
Sontag stabilisce la differenza tra l’immagine ferma e quella in movimento (cinema e televisione):
quella in movimento cattura nel senso che porta lungo tutta la trama, ma trascinandoti attraverso
questa narrazione, in modo tale che noi siamo portati da quel movimento ma non ne siamo padroni,
alla fine non ci resta in mano niente. Il movimento cancella l’immagine mentre la mostra a
Hollywood era identificata col cinema a lieto fine, che serviva per lasciare qualcosa di positivo allo
spettatore.
L’immagine del Vietnam è così forte da far fermare le persone e riprendere consapevolezza su cosa
stessero facendo gli americani, quindi ci si inizia ad informare, sapere, manifestare e opporre.
- C’è una foto con una storia particolare che mostra una bambina nuda in lacrime. Il fotografo ebbe
la fortuna che quando la bambina mostrò la sua espressione, tutti i fotografi avevano finito il rullino
tranne lui, che riuscì a scattare la foto nel momento giusto. Inoltre all’epoca erano proibite le
immagini di nudo nei mezzi di comunicazione di massa, anche in circostanze di questo tipo: quando
il fotografo mandò l’immagine al giornale, subì una censura e allora divenne oggetto di dibattito
(anche per la pornografia bisogna iniziare sempre di più la dose di esposizione dell’anatomia).
Questa fotografia è ancora in bianco e nero, tra gli elementi nuovi troviamo le fotografie a colori.
Bisogna caricare la situazione sull’aspetto simbolico, bisogna fare leva sull’emozione. Scena di
amicizia tra un bianco e nero che commuove. L’esagerazione è data dalle mani aperte del bianco
(come fosse un Cristo in croce): è un rimando iconografico a immagini sedimentate dentro di noi.
➢ Guerra del Golfo
Se la guerra in Vietnam è stata la prima documentata attraverso i mass media, quella del Golfo
(anni 90) è stata la prima de-mediatizzata, non ci è stato mostrato nulla. I servizi televisivi che
passavano erano immagini che venivano prese come fuochi d’artificio: a partire dalla guerra del
Vietnam, da un lato i foto-reporter hanno sempre voluto essere presenti, dall’altra l’esercito ha
posto delle regole a questi, chiudendo sempre di più. Dove c’è regolamentazione ferrea e censura
c’è qualcosa che non deve essere mostrato per tante ragioni, non sarebbero contestualizzate e
capite. Si è scoperto che si faceva uso di sperimentazioni come proiettili fatti di materiale
radio-attivo o uso di droghe per convincere soldati a determinate azioni. Non mostrare significa:
pudore/discrezione e nascondere/censurare. I reporter si dice fossero integrati nell’esercito e
quindi tutti si dovevano comportare nello stesso modo facendo giuramento di non parlare,
mostrare. Cambia quindi l’immagine che noi abbiamo della guerra.
➢ Abu Ghraib
Ai bombardamenti dell’11 settembre 2001 gli americani reagiscono nella città di Abu Ghraib e
detengono i prigionieri torturandoli per farli confessare. Tutte le immagini erano segrete, non si
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
sapeva nulla. Qui c’è un compiacimento, una negazione dell’identità e della cultura di un popolo
che non ammette la nudità, il contatto di letto, si parla di esecrabilità morale, non tanto di violenza.
Ogni volta che c’è un problema di immagine c’è un problema di ordine morale, ideologico ecc.
04/03/20
Le immagini di Abu Ghraib del 2004 rappresentano un cambio di raffigurazioni, di immagini che ci
giungono nel grande capitolo di guerra, morte e violenza e sono immagini particolari per molti versi.
Avviene uno dei cambi di registro sull’escalation della ricerca di immagini che continuino a fare
effetto sull’opinione pubblica di fronte a un possibile svuotamento di significato dovuto
all’abitudine creata dalle immagini. Questa abitudine è sorta perché le immagini producono un
effetto di saturazione, o meglio di assuefazione. Abu Ghraib non è importante solo per questo, ma
anche perché lo ritroveremo in altri esempi più avanti: ha segnato l’entrata di un tipo di immagini
come non si erano mai viste prima, cioè non più immagini fotografiche scattate con la macchina
fotografica analogica, bensì con quella digitale, che introdurrà molte questioni e problemi affrontati
in particolare dal libro di Gunthert.
A un certo punto intervengono immagini anche di questo ordine, già visto con immagini della
guerra in Iraq che erano censurate e trasmesse solo da una grande distanza, che finivano con essere
solo delle strisce di colpi dei bombardamenti senza che ne vedessimo gli effetti. Si tratta di
immagini edulcorate in cui non si vede né la morte né la violenza.
Queste però sono ancora più diverse, anche a queste ci siamo abituati soprattutto perché si
mostrano nel cinema/serie TV: sono immagini satellitari. Dagli USA qualcuno schiaccia un bottone e
un aereo o un drone scarica il missile che colpisce: l’unica immagine esistente è un’immagine a
bassissima risoluzione, presa dall’alto, cioè da AZIMUT (il punto azimutale esattamente
perpendicolare). Spesso le serie TV iniziano con questo tipo di immagini.
Qui siamo di fronte a un’immagine completamente nuova, tutto è a bassa risoluzione, così non mi
permette di entrare nel dettaglio e vedere ciò che succede. C’è tutta una storia dei pixel decisi, che
corrispondono alla grandezza di un uomo in modo da non potere ingrandire gli uomini e vedere i
loro dettagli. C’è anche la presenza del bersaglio, la croce che indica il mirino, la presa di mira del
luogo, una specie di sostituto astratto della violenza che non riusciamo più a vedere: ci fa
immaginare in maniera molto concreta il lancio della bomba.
Altre immagini rappresentano le guerre con i droni: anche qui c’è problema di pixel e bassa
risoluzione. Non c’è la presenza umana, sembra una guerra meccanica fatta di macchie e tecnologia,
senza niente di umano, nessuna emozione, sentimento, personalità.
Come reagisce il fotoreporter, colui che vuole continuare a restituire le immagini della guerra?
Essendo così cambiate le immagini di guerra i fotografi devono cercare le soluzioni diverse.
- L’esempio è Paolo Pellegrini, italiano che rappresenta molto bene questo tipo di scelta: continuare
a essere un fotoreporter classico ma producendo immagini molto espressive, accentuando
l’espressività dell’immagine. Il fotoreporter non registra solo l’evento come avviene, tratta anche
l’immagine in una maniera estetica, espressiva, non tanto per ciò che si rappresenta: non vediamo
violenza, ma posizione della persona, gioco di luci e ombre, polvere che sembra raggiungerci e
diventa un elemento di coinvolgimento, rendono l’immagine efficace in un altro modo.
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
- Un altro esempio è la ripresa del mosso in una foto che riprende dei profughi che scappano dalla
guerra della Bosnia, fotografati dal basso verso l’alto, con la zona scura in primo piano. Il mosso
dell’immagine restituisce l’agitazione, l’impossibilità di soffermarsi.
- Altra cosa è il gioco di riflessi, che rappresenta anche la scena a cui reagiscono le persone.
- Ci sono poi le immagini fortemente metaforiche: immagine con volo di uccelli tutti insieme che
diventa drammatica perché la didascalia ci dirà che l’evento si svolge in un luogo di guerra.
- Sophie Riestellhueber, Irak, 2001. Nascono altre soluzioni nuove e non rispondenti al reportage
tradizionale: poiché ormai la TV è più veloce nel riportare le notizie ed è anche più seguita della
fotografia, del giornale, ecc., ecco che i reporter sono quasi condannati ad arrivare in ritardo.
Piuttosto che arrivare secondi si inventano nuove strategie: non restituisco la guerra, ma le sue
conseguenze. Sophie mette insieme le immagini spesso come dittici (immagini a due a due): a
sinistra la bocca del bombardamento, a destra la cicatrice sulla pelle. Tra le due immagini c’è un
collegamento, uno scambio di caratteri e valori, anche simbolici. La bocca creata dalla bomba
corrisponde sul corpo alla cicatrice. La guerra viene evocata attraverso le sue conseguenze. Altra
coppia di immagini: riga nel terreno e cicatrice sulla schiena.
- Kent Klich, Black Friday, Gaza, 2014. Doppia documentazione creata con le fototessere delle
persone della guerra e sopra un’altra immagine della guerra.
Vengono introdotti altri tipi di problemi, come quello della falsificazione delle immagini, la società
delle immagini dove tutto è diventato immagine. Questo tema è stato già introdotto con il tema del
comandante che spara al prigioniero durante la guerra in Vietnam: non è un elemento vero, è stato
chiamato il fotografo e poi c’è stata l’esecuzione da parte del comandante per essere fotografata,
come se non avesse senso se non venisse poi trasmessa. C’è una specie di capovolgimento:
l’immagine non testimonia l’evento, bensì l’evento si fa diventare immagine. Ad esempio con le
Torri gemelle tutti fecero notare che l’attentato fu doppio: il secondo era proprio a disposizione
delle macchine fotografiche, cineprese, TV che dopo il primo sarebbero intervenute. Questo
capovolgimento è la società dell’immagine: ha creato dei modi di sollevare questioni.
- Paolo Ventura, Iraq 2008 qui ha restituito la guerra dell’Iraq: è talmente ben fatta che sembra una
foto vera, invece è ricostruita, sono soldatini di plastica, finti (tecnica molto usata anche nel
cinema). Ci sono intrecci tra finzione e documentarismo, non c’è più una distinzione netta, i due
ambiti si intrecciano in una maniera indistricabile.
- Joan Fontcuberta, Googlegramma: Abu Ghraib, 2005. Joan è l’autore del libro “la furia delle
immagini” e anche un artista. Ha fatto un’operazione su moltissime tematiche: quella che vediamo
è Abu Ghraib. Il particolare di questa immagine è che sembra di vedere dei pixel, che in realtà sono
a loro volta delle immagini: è un’immagine fatta di immagini selezionate da Google attraverso una
stringa di tematiche legate all’immagine. Fu una trovata molto interessante, che ha due
caratteristiche della post fotografia: l’uso di immagini già esistenti, in quanto non ha scattato né la
macro immagine né quelle che la formano; l’uso di un software, l’aggiunta esterna tecnologica per
realizzare l’immagine stessa.
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
Torniamo ad Abu Ghraib: Gunthert nel capitolo 2 del suo libro, ricostruisce la storia di queste
immagini. Nella ricostruzione si va al di là degli effetti generici, si scopre che dalla scoperta casuale
delle prime immagini fatte dai militari fino alla loro pubblicazione, ci sono stati diversi passaggi
prima di diventare lo scandalo che è stato. Non è stata l’evidenza della brutalità, ma è l’uso che ne
viene fatto, la catena di eventi. Un’altra questione è che queste immagini segnano il cambio di
quello che abbiamo anticipato prima: sono digitali. Queste non erano mai entrate prima nel
giornalismo perché considerate fortemente manipolabili. Erano falsificabili a tal punto che si erano
istituite, per esempio per i premi del fotogiornalismo, regole che accettano solo immagini
analogiche. Un’immagine digitale di un esplosione è stata eliminata dal premio una volta perché c’è
stata una manipolazione. La giustificazione dell’autore fu che non era un’alterazione della realtà,
solo un miglioramento per rendere più evidente il fumo. Tuttavia non si può, perché il fatto di
manipolare tocca la questione di principio della falsificazione. La questione dei valori espressivi
torna: il reportage, la testimonianza, la volontà di essere oggettivi ha sempre posto il valore
espressivo come valore artistico che non appartiene ai fotografi, è una cosa in più non in funzione
dell’informazione. Da un lato c’è la comunicazione, dall’altro l’espressione. In molti casi, come
quello di Paolo Pellegrini, troviamo un incrocio di queste due questioni. Ora soggettivo e oggettivo
viaggiano insieme.
La questione del digitale aveva lasciato fuori le immagini digitali e c’era un dibattito molto acceso:
la fotografia non possiede più il carattere oggettivo di documentazione della realtà che ha sempre
avuto. È il dilemma della società dello spettacolo, delle immagini, delle fake news: l’immagine non è
più considerabile come notizia oggettiva. Ora siamo diventati “sospettosi” della manipolazione
delle immagini, come se fosse una loro propria caratteristica (Ex: durante l’insurrezione in Iran
contro Saddam Hussein le folle si fermavano aspettando che qualcuno filmasse o fotografasse,
altrimenti è come se non esistesse).
- Gunthert parla anche delle immagini dell’attentato di Londra del 7 luglio 2005. Si era posto un
altro problema: è stato un evento imprevedibile, quindi non documentato per immagine, non sono
presenti fotografi, si può fotografare solo l’effetto dell’incidente. In questo caso due persone in
particolare hanno tirato fuori il cellulare e ripreso ciò che stava succedendo, o meglio quello che era
già successo, arrivando dove i giornalisti/fotoreporter non potevano arrivare. Giornali, Tv si sono
trovati a dover attingere a queste immagini: le fotografie mal fatte, casuali, di bassa risoluzione
sono le uniche disponibili e vanno a finire sulle prime pagine dei giornali. Diventano le uniche
testimonianze. È stato l’inizio di quello che è stato chiamato il citizen journalism: un giornale
francese dice che tutti ormai siamo diventati giornalisti. La professione del giornalismo ne risente in
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
due maniere: non c’è bisogno di essere professionisti per scattare e far circolare; non c’è bisogno
della qualità che fino ad allora era stata richiesta. Questo ci ha abituati a vedere queste immagini
mal fatte, sfocate, ecc. che fino a questo millennio non erano mai entrate in circolazione nelle
immagini accettate dal pubblico, mentre oramai queste sono di consumo normale.
Altra questione messa in evidenza da Gunthert su queste tematiche è il passaggio “dalla produzione
alla trasmissione”: non è importante la produzione dell’immagine, ma come viene trasmessa. Conta
di più anche l’uso dell’immagine. Cosa è importante? Il contesto. Le immagini sono veritiere se
fanno parte di un insieme di cose: il contesto certifica quello che prima davamo per intrinseco
all’immagine fotografica. È diventato un fenomeno di mediatizzazione: tutto è in circolazione nei
media, è trasmesso e noi valutiamo le immagini dentro questo circuito. È l’uso, la pratica che oggi è
l’atto più importante.
10/03/20
TEMPO
Idea che noi abbiamo della fotografia è combattuta tra due idee:
1. Fotografia è l’istante/il momento/il presente -> prima volta che l’uomo ha visto l’istante, e
quell’istante viene isolato nel flusso del tempo, diviene palpabile/concreto
2. Fotografia è passato. Susan Sonntag chiama la fotografia “oggetto melanconico”: dato che la
fotografia riguarda il passato è avvolta di malinconia/la guardiamo con malinconia
1. FOTO COME ISTANTE
-Donna con occhiali, 1850, dagherrotipo: Dimensione temporale gioca all’interno dell’immagine
stessa: immagine trasporta il tempo. Tempo di seduta molto lungo, sguardi intensi
- Edinburgh Ale, 1845, David Octavius Hill & Robert Adamson: quando tempi di impressione chimica
si ridussero fino a pochi secondi, intervenne un’altra questione temporale. Con l’accorciarsi dei
tempi, il fotografo cerca di cogliere una situazione più spontanea/mossa (non sono più persone che
posano per farsi fare il ritratto). Subentra la dimensione dell’attimo, della durata minima che non è
misurabile.
- Donne in giardino, 1857/66, Claude Monet: impressionismo sembra riprodurre una fotografia.
Figura lontana di spalle, sembra che si sta muovendo, Monet coglie l’istante nella sua casualità.
-Le moulin de la Galette, 1876, Renoir: posizioni dei personaggi colte in un istante. Coppia che balla
in primo piano a sx è girata verso di noi, come se ci fosse la macchina fotografica. Anche la pittura
prende in considerazione la dimensione dell’istante.
-Cabanès, 1858, André Eugène Disdéri: Invenzione dell’immagine-fototessera: se guardo tutte le
parti insieme le vedo come se fossero una sequenza. Come se le immagini fossero legate tra di loro,
c’è un ordine temporale/un prima, un dopo. (quando io giustappongo due immagini, subentra una
narrazione che collega due immagini/subentra la dimensione del tempo/l’ordine cronologico)
-Thomas John Bernardo, 1875: pubblicizza il suo orfanatrofio. Immagine a sx è il prima, quella dx è il
dopo -> immagine a sx mostra come era il bambino quando è stato raccolto dalla strada, immagine
a dx mostra come il bambino è stato educato nell’orfanatrofio.
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
-Cavallo in movimento, E. Muybridge, 1887: inventa dispostivi per cogliere il tempo in maniera più
evidente: la cronofotografia. Dispone più macchine fotografiche che sono collegate ognuna a un filo
e sono collegate al percorso del cavallo: il cavallo passa, tocca il filo e si scattano fotografie.
Cronofotografia nasce da una sfida di un amante di cavalli secondo il quale la pittura non
rappresentava veramente come stavano le gambe del cavallo nella corsa.
- Etienne Jules Marey, Camminare: no sequenza di immagini staccate, ma lastra è aperta e fotografa
4 istanti diversi.
-Futurismo: concezione del tempo/movimento/velocità/spostamento
-Idea del movimento come dimensione temporale influenza la moda: Lucille Brokaw, Munkacsi,
1933 -> abito non è portato in maniera statica come un manichino infatti noi ci muoviamo. Idea di
una donna libera autonoma, che decide il proprio vestire: donna moderna.
2. FOTO CON DIMENSIONE MELANCONICA:
-Au tambour, Atget, 1908: si fotografano gli oggetti che stanno perdendo la loro funzione/che
stanno scomparendo.
-Donne che trasportano pietre, Michetti, 1900: Italia del sud sembrava bloccata ad un passato che il
nord industrializzato non conosceva più.
-Eric Salomon, Conferenza al vertice tra Chamberlain, Streseman e Briand, 1928: Salomon è un foto
reporter che si inventò un metodo per essere un fotografo nascosto, cosicché le persone non
possano mettersi in posa -> vuole cogliere l’autenticità del reale. Egli si inventa un metodo per
nascondere la macchina fotografica e si intrufola in situazioni dove i fotografi non erano ammessi.
-Weegee, Cadavere e revolver, 1940: arrivare nell’istante più vicino al momento dell’evento (in
questo caso assassinio)
-Morte di un soldato repubblicano, 1936, Robert Capa: persona è stata appena colpita da un
proiettile oppure sempre di R. Capa, Sbarco in Normandia, 1944
-persone sono sedute su una panchina, immerse nei propri pensieri/preoccupazioni. Mondine nei
campi di coltivazione del riso: sembra una danza, hanno le braccia sollevate, sembrano in
movimento.
-Smith ha inventato i foto-racconti: immagini per essere efficaci devono essere costruite, solo così
sono cariche di significato. Smith vuole restituire l’efficacia dell’immagine, a discapito
dell’autenticità
- Cartier-Bresson: afferma che la fotografia cattura “l’istante decisivo”, che è l’acme di un’azione, il
culmine, ovvero quell’istante che è fondamentale tra il prima e il dopo. Questa concezione è l’idea
di fotografia più diffusa: noi tutti vogliamo fotografare un momento speciale, che vogliamo
ricordare.
-Il nonno va in paradiso, 1992, Michals: Bambino che assiste della morte di suo nonno: si vede la
sua anima, è un tempo misto tra tempo reale e immaginazione/sogno
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
-Douglas Huebler, Senza titolo, 1967: bambine giocano al gioco della corda. Huebler mischia le carte:
vuole mostrare che il tempo è mescolabile, che non è solo quello cronologico. Scatta una sequenza
di foto e ne accosta due che non sono in sequenza
-Christian Boltanski, fotografie di C.B, 1946-64: foto in ordine cronologico ma vengono scattate
tutte nello stesso posto. Idea del tempo progettato, multidimensionalità del tempo.
POSTFOTOGRAFIA:
Cap. 13 del libro “La furia delle immagini” Fontcuberta
-un ragno mentre cattura una vespa conservato in un pezzo d’ambra: scenetta fissata come se fosse
una fotografia (in realtà non è una foto). Idea di tempo come istante decisivo che fissa un momento
preciso.
Post-fotografia è quella che viene dopo Internet, dopo il digitale, in cui in nostro rapporto con la
fotografia è cambiato.
-Cartier-Bresson Place de l’Europe 1932 e Troppo presto: toglie la persona che salta e lascia soltanto
la scena/lo spazio. Vi è straniamento: appare come strano perché tradisce le abitudini.
Nell’accostamento tra foto di dx e di sx c’è un accostamento di tempo particolare, è come se ci
fosse un attimo di sospensione.
-Cartier-Bresson: cattura il passaggio della bicicletta, togliendo la biciletta tutto resta
vuoto/straniante. Togliendo il soggetto, io riconosco lo sfondo.
-Barrera Battaglia di Calatafini 1860 dalla serie campi di battaglia, 2011: guardando questo luogo io
ho la compresenza del passato/presente: anche se non c’è nell’immagine il passato, c’è un effetto
di evocazione di esso. Rappresenta com’è tutt’ora il campo della famosissima battaglia del 1860.
-con Internet tutti i momenti vengono fotografati, non c’è più la questione del momento decisivo, e
i momenti divengono di conseguenza tutti uguali. I momenti decisivi sono più nascosti. Mappe di
Googlemaps fotografano quello che trovano al momento (ci sono in giro persone, macchine, aerei):
per cui dentro Googlempas si trovano delle immagini singolari, strane.
-Nel mondo della fotografia il post fotografo non scatta il momento decisivo, ma lo va a cercare.
Postfotografo va a caccia di stranezze. Esempi: Philip Schuette, Serendigraphy, 2012: aspetta di
cogliere il momento in cui il pesce si sovrappone alla faccia della persona che nuota.
-Josh Pehlein, Modern History, 2007-2009: somma di più scatti fotografici, mette insieme tanti
scatti veri quindi immagine non esiste ma è veritiera. È un’immagine poliedrica: il tempo è
poliedrico, restituisce istanti diversi, il tempo è quindi multidimensionale.
11/03/20
DALLO SPECCHIO AL SELFIE
Specchio: dispositivo che incide sulla trasmissione stessa, ha la particolarità di essere l’unico
strumento che per molti secoli restituiva l’immagine. Riflette oggettivamente la realtà, non vi è
l’intervento umano, cosi come funziona con la fotografia (macchina fotografica prende tutto quello
che c’è davanti). Las pittura invece è umana, manuale, quando si dipinge si fa automaticamente una
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
selezione. Specchi più antichi risalgono all’età della pietra in Turchia (Cap. 9 “la furia delle immagini”
Fontcuberta)
-Tiziano, Venere allo specchio, 1555: donna simbolo bellezza/armonia/arte si specchia. Vi è una
metarappresentazione= rappre nella rappre. Così come la donna si specchia nello specchio, la
bellezza si specchia nella pittura. La donna è al centro dell’immagine.
-Veronese, Venere allo specchio, 1585: nello specchio la donna rappresentata ha gli occhi che
guardano nella nostra direzione. Usa lo specchio per guardare noi: c’è un gioco di riflessi e di
sguardi. Non a caso la donna rappresentata è di spalle, e così lo specchio ci permette di vedere
quello che non possiamo vedere con lo sguardo in modo diretto (ovvero la faccia della donna).
Opera d’arte trasferisce, come lo specchio, i cambiamenti dei canoni della bellezza. Specchio e
pittura assecondano i cambiamenti temporali.
-Jan Van Eyck, I coniugi Arnolfini, 1434: specchio convesso sullo sfondo della stanza cosicché rifletta
più spazio che lo specchio piatto. Dentro lo specchio si vede la scena così come viene riflessa dallo
specchio: due coniugi di spalle + Van Eyck che dipinge. Testimonianza della propria presenza sul
luogo dalla scritta sul muro sopra lo specchio in latino “Jan Van Eyck è stato qui”.
-Parmigianino, Autoritratto in specchio convesso, 1524: artista si fa l’autoritratto non curandosi
tanto della somiglianza ma approfitta della situazione per tramandare una certa immagine di sé.
Usa lo specchio convesso che deforma la sua presenza nello spazio, in primo piano vi è la mano
poiché lui è un artista ed usa la mano tanto quanto la testa (altro elemento in primo piano).
-Barocco, 600: specchio convesso è una sfera che riflette sia l’artista con la tela, sia la stanza con la
natura morta. Sfera riporta l’insieme e storpia la prospettiva. Sfera non è l’unico oggetto riflettente:
c’è anche un porta gioielli con coperchio riflettente + bicchiere convesso in cui si riflette la finestra.
Virtuosismo del pittore: lui può dipingere qualsiasi cosa, anche i riflessi.
-Anish Kapoor: palazzi restituiti su una superficie a specchio, sono deformati.
-Olafur Eliasson: soffitto con una superfice specchiante ma non piana, per cui c’è il gioco di
deformazione. Costringe a guardare con la testa verso l’alto, per cui disequilibra l’atto di camminare,
perdiamo il senso dell’orientamento.
-Copertine di libri di fotografia: The history of photography e A new history of photography. In
entrambe le situazioni sono state messe fotografie che giocano sullo specchio: foto di sx c’è lo
specchio retrovisore che riflette autista che sta fumando la pipa + si vede l’artista. Foto di dx c’è la
contessa Castiglione (Louis Pierson, 1864) che vuole essere ritratta con lo specchio in mano
orientato in modo che lei è presa di profilo ma noi vediamo lo stesso il suo sguardo diretto tramite
lo specchio.
-Clementina Hawarden, Studio dal vero, 1864: persona riflessa di profilo dallo specchio, in realtà lei
è di fronte a noi. Le due espressioni di fronte e di profilo della stessa persona sembrano molto
diverse tra di loro.
-Claude Monet, Regata a Argenteuil, 1872: con la nascita della fotografia, la pittura cambia. Gli
impressionisti adattano una nuova strategia e ad esempio introducono i riflessi. Per un pittore ciò
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
che conta non è la restituzione di un’immagine della realtà in modo oggettivo, per lui conta
l’interpretazione. Monet semplifica la rappresentazione: c’è una linea mediana, sopra c’è la realtà e
sotto il riflesso. C’è anche la semplificazione delle case, dell’albero e delle vele (sono triangoli). Il
riflesso inferiore riporta le forme geometriche che si sfaldano a causa delle onde e del movimento
dell’acqua. Attraverso la frammentazione delle forme nel riflesso, Monet ci fa vedere la pittura, le
pennellate di colore: a lui interessa la pittura, non la realtà, la realtà è solo un pretesto.
-Paul Cezanne, Il ponte di Maincy, 1879: Cezanne, impressionista, fa vedere il riflesso della
curvatura del ponte nell’acqua, la parte reale si completa con la parte riflessa formando un cerchio.
Idea di Cézanne è che l’arte si appropria della realtà e dà un’interpretazione che chiude il cerchio,
dà la chiave della visione della realtà stessa.
-Espressionismo, Karl Schmidt, Marina, 1912= opposto di Monet: gioco di barche ma è nel riflesso
che abbiamo la forma geometrica costruita, fuori dal riflesso invece le vele delle barche si
deformano nel paesaggio con lo stesso colore e sono tagliate. Orizzonte è molto alto così le forme
triangolari riflesse stanno al centro della nostra visione. Espressionismo è l’opposto
dell’Impressionismo
-Espressionismo, E.L. Kirchner, Donna allo specchio, 1912: specchio non riflette oggettivamente la
realtà (arte per espressionismo deve svelare i lati nascosti della realtà, non deve rappresentarla
oggettivamente). Nello specchio le mani sono davanti alla testa (nella realtà sono dietro la testa),
ciò rivela l’interiorità della fanciulla, la sua paura della vecchiaia, della morte. Vengono messe in
evidenza le paure dell’animo umano.
-L. Furtenagel: Hans Burkmair e sua moglie, 1529: ritratto coppia di cui il riflesso sono due teschi:
specchio riflette il valore simbolico e non la realtà.
-Clementina Hawarden, Ragazza che si riflette in uno specchio, 1863: specchio riporta un lato
nascosto della realtà: fanciulla fuori dallo specchio ragazza sembra timida di farsi ritrarre, nello
specchio viene invece messa in evidenza la spalla scoperta, il seno è più evidenziato e l’espressione
sembra più maliziosa.
-Edouard Manet, Bar alle Folies-Bergères, 1881: specchio è posto alle spalle della barista e riflette
tutto quello che la barista ha davanti. Nello specchio si vede un uomo, in realtà quell’uomo è
affacciato sul bancone del bar e quell’uomo siamo noi. Manet ha approfittato dello specchio x
introdurre nella rappre anche lo spettatore, noi siamo dentro nel quadro, siamo il cliente.
-O. Redon, Il silenzio, 1890: immagine dentro lo specchio che sembra rivolgersi a noi
autonomamente, senza la persona davanti. È come se lo specchio ci riproduce lui l’immagine, è
un’idea simbolista.
-Salvador Dalì (surrealismo), Metamorfosi di Narciso, 1937: idea di specchio che rivela qualcosa.
Dalì gioca con il riflesso e questo rivela la surrealtà: insieme di oggetti che a dx appaiono come
corpo di un fanciullo che si specchia nell’acqua; il suo riflesso non è sotto di lui ma accanto a lui ed è
una risistemazione delle stesse forme che nel riflesso però compaiono come se il corpo fosse una
mano che tiene un uovo (forma della testa del ragazzo), e dall’uovo sbuca il narciso. Dalì le chiama
“le figure doppie”. Ciò accade anche in Cigni che riflettono elefanti, 1937 (sempre Dalì): il cigno per
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
la strana forma che ha, ha un riflesso che somiglia all’elefante. Nel riflesso c’è una metamorfosi: il
riflesso mostra l’inconscio.
-Magritte: nell’immagine a dx lo specchio rovescia quello vi è dietro (testa e schiena della persona),
nell’immagine a sx, lo specchio riflette quello che c’è dietro lo specchio.
-Paul Delvaux (surrealista): gioco tra specchio e cornice vuota: mano dietro lo specchio può essere il
riflesso della mano dx o la continuazione della mano sx. Ombra dello specchio + ombra della
persona dietro lo specchio
-P. Delvaux, La nascita del giorno, 1937: specchio ovale in primo paino riflette un seno femminile
che noi dobbiamo supporre davanti.
-Florence Henri (fotografia), Autoritratto, 1928: autoritratto basato sullo specchio, autoritratto
basato sull’immagine riflessa. Realtà continua nel riflesso, fotografia è il proseguimento della realtà.
-M. Duchamp, Ritratto multiplo, 1917: sembrano 5 persone separate, in realtà è solo una persona.
-F. Henri, Jeanne Lanvin, 1929: specchi messi in modo particolare che fanno sembrare una collana
di palle di Natale quando in realtà è solo una palla.
-I. Bing, autoritratto, 1931: fotografo (a differenza del pittore) per fotografare sé stesso deve tenere
la macchina fotografica davanti agli occhi, quindi nega sé stesso perché la macchina fotografica lo
copre e trova strategie per mostrare il suo volto. Ciò che noi vediamo è tutta un’immagine nello
specchio, in questa immagine ci sono almeno 2 specchi.
-Brassai, Senza titolo, 1933: Gioco di specchi con l’uso della precisione. In questo modo la donna è
nel riflesso della cornice di sx. Lui uomo, vestito, fuori dal riflesso, ed è il cliente... lei è donna, nuda,
nel riflesso ed è una prostituta.
-specchio rivelatore: ci fa capire il volto della ragazza. Ma è un rivelatore capovolto.
-P. Donzelli, Sarto, 1953: ritratto del sarto dove nella realtà c’è il suo mondo e nello specchio il suo
volto
-Andy Warhol, photomatic: macchina per fare le fototessere è uno specchio: la posa che decidi di
assumere rivela il tuo carattere.
-F. Vaccari, esposizione in tempo reale, 1971: usa la photomatic come strumento fotografico e poi
appende gli scatti delle persone alle pareti come se fossero le opere dell’artista stesso.
-A. Warhol, I’ll be your mirror: io sarò il vostro specchio che vi mette di fronte alla realtà che voi non
vorreste vedere. Non è uno specchio meccanico ma mette di fronte la realtà del momento.
-M. Pistoletto: artista noto per uso degli specchi, realizza opere che sono degli specchi su cui incolla
delle figure fotografiche ritagliate che danno un effetto di realtà e restano immobili, tutto il resto
invece si muove e viene riflesso nello specchio intorno alle figure fisse.
-Ugo Mulas, Verifica n 21970: non si rappresenta come persona (non vediamo la sua faccia) ma
come fotografo, lo vediamo con la macchina fotografica. Al centro vi è la macchina fotografica, alle
sue spalle entra la luce e dinanzi a lui vi è la sua ombra. Fotografia è una foto grafia= è una scrittura
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
con la luce. Ugo Mulas fa foto per la moda e utilizza molte tecniche con gli specchi: vedi un pezzo di
abito sulla dx e il resto dell’abito lo vedo nello specchio.
-D. Mosconi fa foto di moda: gioco di riflessi e collage + scompone l’immagine come se fosse una
griglia e rende sproporzionati i corpi. Gioca sul contrasto nudo/vestito.
-M. Snow, Authorization (autor: autore + rization: autorizzazione dell’autore. Il procedimento
fotografico costruisce l’autorizzazione del mio sentirmi un autore/artista), 1969: fotografo mette
davanti alla sua macchina fotografica, disposta su un cavalletto, uno specchio (foto in alto a sx).
Scatta, poi prende questa foto e la incolla sullo specchio, si rimette dietro la macchina fotografica,
scatta e stampa la seconda foto (in alto a dx). Poi terza foto in basso a sx, infine quarta foto in basso
a dx. Come ultima cosa le 4 fotografie coprono (come si vede in alto a sx) completamente il
fotografo e la macchina da presa. Interazione tra macchina fotografica e specchio.
-D. Appelt, Autoritratto allo specchio, 1978: fiato: anima/vita
-N. Goldin, Autoritratto, 1974: ritratto della vita che si stava facendo/dei segni della vita che
lasciano sul volto. Goldin narra la violenza sessuale.
-Cindy Sherman, Segretaria, 1978: specularità -> ha sempre messo sé stessa nei ruoli della donna in
cui poi si è auto-fotografata. Realtà stessa diventa lo specchio
17/03/20
-Casa di moda Etro: accostamento tra dipinto a sx coniugi Arnolfini con specchio convesso e
immagine dx in cui c’è uno specchio di lato. C’è un richiamo ai coniugi: la coppia dei titolari della
casa di moda a sx richiama l’eleganza dei coniugi Arnolfini a dx, il tutto è arricchito da piramide in
prima piano, da una sfera sullo sfondo; e in più il pavimento sembra inclinato.
-Intimissimi 2009: specchio x moltiplicare l’immagine della persona e mostrarla da tutti i punti di
vista. Erotismo frequente nell’uso dello specchio, moltiplicazione
-Spot di Wind del 2017: uomo che allo specchio si fa la barba. Quotidianità. Messa in scena del
prodotto che porta con sé una narrazione e dei valori: mascolinità, virilità...
-Oral-B 2020: pubblicizza lo spazzolino elettrico per lavare i denti. Immagine sopra figura femminile
che ci guarda con spazzolino in mano e con un sorriso bianco, lo sfondo è sfuocato; è come se lesi
guardasse nello specchio e noi siamo lo specchio. Immagine sotto raffigura l’immagine nello
specchio che riflette diverso da come dovrebbe = funzione rivelatrice dello specchio. Pubblicità
approfitta x mettere in evidenza l’immaginario: la donna è una persona famosa, una cantante molto
amata. Specchio è il riflesso e la pubblicità è un gioco di riflessi: guadando l’immagine riflessa
questo riflesso si riflette su di me che a mia volta vorrei essere come lei…
I RIFLESSOGRAMMI
Cap. 9 del libro “La furia delle immagini” Fontcuberta
-Riflessogrammi: prodotto della scrittura (gramma) sui riflessi.
-Tre riferimenti (metà del secolo scorso)
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
1. Lewis Mumford: nella modernità l’uso dello specchio ha introdotto l’introspezione moderna.
Guardandoci allo specchio abbiamo imparato a riflettere su noi stessi, sulla nostra interiorità.
Identità, selfie, tema dell’autoritratto si collegano al tema della somiglianza, dell’appartenenza
ad una classe sociale.
2. Jacques Lacan: lo stadio dello specchio. Lacan è uno psicanalista e tratta questo tema da un
punto di vista psicoanalitico: afferma che il bambino tra i 6 e 18 mesi ha un’interazione con la
propria immagine nello specchio. Il bambino per la prima volta riconosce sé stesso
(=riconoscimento) in un’immagine che è fuori da lui, è la sua immagine riflessa nello specchio.
Lo specchio ha un ruolo determinante perché noi non possiamo mai vedere la nostra immagine
se non attraverso lo specchio, cioè fuori da me. Meccanismo in cui io contemporaneamente, in
maniera inscindibile, vedo un’immagine e poi mi riconosco in essa. Nel momento del
riconoscimento bambino vede che non è lui, vede che è un’immagine riflessa, che è un’illusione
e un’alienazione. Sono gli altri che mi restituiscono la mia immagine. Dialettica tra il
riconoscimento e l’illusione/alienazione
3. Roland Barthes (scrittore): dialettica dell’intermittenza tra il mostrarsi e il nascondersi.
Meccanismo sempre in atto nell’immagine speculare: mentre io mi mostro allo specchio, mi
nascondo al tempo stesso perché mostro solo una parte di me.
-Specchi per animali e animali allo specchio: molti mettono uno specchio nelle gabbie degli
animali (ex pappagallo) per non dare l’illusione all’animale di essere solo. Animale non si
riconosce e pensa che allo specchio ci sia un altro suo simile.
Riflessogrammi = sono gli autoritratti attraverso i riflessi. Pratica molto diffusa. Lo sguardo è
frontale, guarda nello specchio e si autoritrae. Nei riflessogrammi c’è riflessa anche la macchina
fotografica, ciò è importante per due ragioni:
1. Consapevolezza dell’immagine e padronanza della situazione: colui che tiene la macchina
fotografica decide come esce la scena, l’inquadratura.
2. Possiamo costruire una storia della macchina fotografica, vediamo tutte le evoluzioni: da
macchina fotografica a Iphone.
-Primo effetto dei riflessogrammi è quello di mettere in evidenza la circostanza: immagine di sx
macchina fotografica semi-professionale, bisogna fare attenzione all’estetica; immagini di dx
macchina fotografica è meccanica, non c’è bisogno di molta capacità nell’usarla.
- “Reality show su scala individuale”: noi ci fotografiamo in qualsiasi momento e situazione come
volessimo restituire/condividere con qualcuno il maggior numero di momenti della nostra vita.
Non mi scatto la fotografia allo specchio per guardarmi ma per condividerla con altri. Reality
show quotidiano è una specie di Grande Fratello alla rovescia: siamo noi stessi che ci
autoritraiamo e diamo continuamente informazioni di noi. Panottico: idea di vedere tutto, di non
nascondere niente e ciò è tipico della nostra società. Questo ha anche aspetti positivi, ovvero
che il controllo non è imposto da fuori, ma parte da noi. Fontcuberta distingue i riflessogrammi
in tipi a seconda della DESTINAZIONE che determina l’uso che se ne fa:
1. Riflessogramma postato sul blog personale: il blog è la sostituzione del diario personale, ed è
online. Inoltre è personale, come il diario, ma è fatto per essere condiviso. Ex: ragazza fa la foto
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
allo specchio con in mano un foglietto e vuole mandare un messaggio alle persone a cui si
riferisce (queste persone in genere sono un gruppo coeso).
2. I social network: sono le estensioni del blog, si passa da interazione di gruppo a interazione
sociale. Io mi metto in vetrina per condividere ma soprattutto per avere un feedback/una
risposta. Entra in ballo il meccanismo della seduzione: io cerco di piacere per ottenere più
followers.
3. Portali specializzati: io posto su quel portale solo un determinato tipo di immagine e so che
colui che si collega allo stesso portale ricerca lo stesso tipo di immagini. Ex: selfie nei bagni
pubblici. Scatta una gara tra i concorrenti che postano, vince il più originale.
4. Relazioni sentimentali e/o sessuali: reflectoporn. Condivisione per cercare un contatto per
stabilire un rapporto sentimentale/sessuale. Ci sono siti di questo tipo specializzati nei
riflessogrammi. Anche in questo caso scatta una gara di originalità.
FUNZIONI dei riflessogrammi:
1. Utilità: faccio una foto per controllare io stesso la mia linea/il progredire della mia dieta/per
vedere come mi sta un costume dopo un anno. Funzione di memoria e funzione probatoria
(=che fornisce la prova). Faccio una foto per poter fare un confronto
2. Celebrazione: ex ragazzi che si fotografano allo specchio per ricordare la partecipazione alla
festa
3. Sperimentazione: ovvero divertimento/ricerca a scattare immagini strane. Uso di applicazioni
(ex Photoshop) o uso di superfici deformanti per sperimentare
4. Introspezione: mi faccio foto per auto-analizzarmi, per vedere come l’immagine mi rivela degli
aspetti di me stesso. In questo modo io non mi guardo in diretta ma mi guardo dopo e dal di
fuori.
5. Seduzione: gioco sulla simpatia ma lo scopo è quello di catturare affetto tra chi mi guarda. Si va
dal semplice gioco al flirt
6. Erotismo: gioco erotico, esibizione vera a propria. Esibizione della sessualità come una forma di
liberazione
7. Trasgressione: esibizione dimostra che sono libero dai taboo/dalle imposizioni/dalle regole
sociali. Trasgressione attraverso la provocazione
24/03/20
Secolarizzazione dell’immagine: immagine è diventata pervasiva, è dappertutto ed è prodotta da
tutti quanti. Fattori che hanno portato a ciò:
1. Abbattuti i costi + le tecniche sono cambiate
2. Ubiquità (= è dappertutto) e fatte ad ogni età
3. Perdita della ritualità: prima c’era una scelta, una decisione prima di scattare una foto, le
immagini erano enfatizzate e cariche di significato. Ora invece scattiamo foto a qualunque cosa
e in qualsiasi momento
4. “nostalgia del presente”: ho nostalgia del momento che sto vivendo, viviamo in un presente che
rincorriamo. Vogliamo mantenere il presente in modo continuo, non c’è la memoria bensì il
consumo immediato. Immersione nel presente comporta un uso dell’immagine per operare:
immagine si consuma nell’uso, non è solo da guardare. Io scatto un’immagine per relazionarmi
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
con il presente (=per avere un parere, una reazione, un contatto). Il presente è vivo e io voglio
mettermi continuamente in contatto con esso.
Noi siamo autori e padroni delle nostre immagini. Io non sono più l’oggetto dell’immagine ma tutti
siamo diventati autori, siamo noi che decidiamo che cosa farne: ciò comporta l’uso democratico
della tecnologia/dell’immagine. Diffusione enorme di autoritratti allo specchio dimostra un uso
democratico di questo strumento. Rivendicazione di libertà di comportamento: soprattutto la
donna ha trovato nella tecnologia uno strumento di liberazione (lei stessa si fa le foto e le usa e lo
può fare quando vuole).
-Osservazioni estetiche: uso degli autoritratti allo specchio ha fatto saltare anche i parametri
estetici/lati artistici dell’immagine.
1. Errori dei fotografi professionisti vengono ripresi negli autoritratti: ad ex il mosso, il pasticcio sul
vetro che rovina la foto, il flash allo specchio. Errori sono diventati accettati e accettabili, ma
anche caratteristici: comunicano autenticità.
2. Salta l’idea di autorialità e cambia l’idea di originalità: originalità diventa una gara di stranezza,
follia
IL SELFIE
Cap. 5 e 9 del libro “La furia delle immagini” Fontcuberta
-Sintesi del paesaggio dalla fotografia al selfie. Tre tappe dell’espressione fotografica:
1. Ragazza trova cadavere in mare portato dalle onde e decide di fotografarlo/di documentare
2. Ragazza interviene sulla scena: la vuole rendere più realistica per cui mette vicino al cadavere
un pezzo di vestito portato a riva. Messa in scena dell’immagine prima di fotografarla
(=stagedphotography)
3. Passaggio alla nuova modalità: quella post-fotografica. Stacca la macchina fotografica
dall’occhio e si gira per fotografare sé stessa con il cadavere. È un autoritratto. = questa è
l’operazione che faccio ogni volta che faccio un selfie
-Riferimenti storici
• Edvard Munch, autoritratto come Marat, 1908: egli era malato, si trovava in un centro di cura e
prendendo la mira si è scattato delle foto.
• Fotografi della Byron Company, 1920: persone che si fanno una foto di gruppo. Ci sono tutte le
componenti del selfie: si mettono vicini, allungano le mani...
• Gunthert fa notare che c’è stato un processo di avvicinamento che ha portato a questo
cambiamento e possiamo individuarlo nell’autoscatto: Manuale della Kodak del 1954 che per la
prima volta pubblicizza questo dispositivo. Il testo della pubblicità sottolinea il fatto che il
fotografo non è più un’altra persona, ma sei tu stesso.
• Prima messa in scena di un selfie è nel film “Thelma e Louise” del 1991 di R. Scott.
• Battesimo effettivo del selfie: 2012 dove rivista Time inserisce la parola “selfie” tra le 10 parole
più popolari dell’anno e il dizionario Oxford English Dictionary la elegge come parola dell’anno.
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
-Cambiamenti:
• Perdita del contatto fisico tra l’occhio e il mirino: ciò priva la macchina dalla sua condizione di
protesi dell’occhio.
• Io faccio i selfie non più per documentare ma per far vedere che ero lì, che ero presente in quel
momento. Mi faccio i selfie per raccontare la mia vita: per far vedere i luoghi in cui sono stato
• Colui che invia il messaggio diventa il messaggio stesso: io invio come messaggio me stesso. C’è
una messa in discussione dei ruoli: i ruoli grazie a questo strumento coincidono.
-Tipi di selfie (secondo Gunthert):
• Allo specchio: ci riconduce ai riflessogrammi.
• Girato: mi giro per catturare la scena che c’è dietro di me. Deve essere effettuato con mira
• Fotocamera frontale iPad: si vede la mia faccia, è come se fossi allo specchio ma sto guardando
la fotocamera
• Selfie dei piedi
• Fotocamera frontale iPhone 4
-Aspetti nuovi del selfie:
• Selfie esprime un carattere fortemente contestualizzato: strettamente legato a quel
momento/contesto + collasso del carattere multidimensionale della comunicazione: non ci sono
odori, suoni.... La conversazione si appiattisce ma diventa interattiva
• Estetica dei selfie: errori vengono accettati e si creano immagini molto tipiche. Caratteri “fai da
te”: trasmettono autenticità, freschezza (ex: cose casuali, strane espressioni, gestacci,
scompostezza). Proprio perché siamo abituati a questo tipo di immagini, esse possono farci
credere che siano autentiche quando in realtà possono essere costruite. Immagini sono
manipolate, alcune sono fatte apposta per ingannare.
• Rischio del narcisismo (inizio anni 2000). Non c’è più la realtà senza dentro la nostra presenza.
Generazione “me me me”. Idea stessa di identità è cambiata nel tempo.
Identità ha avuto un picco significativo che va sotto la denominazione di “Post human” (passaggio
da vecchio concetto di identità a nuovo concetto di essa). Denominazione “Post human” è partita
da un’esposizione che mise al centro una questione: stiamo passando da una condizione umana e
una nuova condizione che comporta un cambiamento di identità. Rivista evidenza cambi di
personalità. Si è cambiato il paradigma: chirurgia plastica, mondo virtuale, mondo dello spettacolo,
pillole per qualsiasi condizione (essere felice, esaltarsi, dimagrire). Esempio: diversi modi di ritrarsi
dell’uomo, excursus storico.
25/03/20
-Fontcuberta: dice che il fenomeno del narcisismo non nasce negli anni 2000, ma esisteva già da un
ventennio. Siamo nell’epoca della costruzione dell’identità, io posso essere come voglio e cambiare
come voglio. Identità fluida = malleabile, non fissa. Uso del selfie va inserito nella questione
dell’identità: sui social io costruisco il mio diario/blog con i selfie, oppure i selfie sono usati per
costruire interazioni. Narcisismo perché nelle interazioni io metto sempre l’accento su me stesso.
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
Gunthert contrappone a vari dibattiti l’osservazione dei fatti. Fa una ricerca e afferma che nel 2015 i
selfie occupavano su Instagram dal 3 al 5 %: quindi era una piccola quantità che veniva ingigantita
dai critici. Altro fenomeno curioso: giovani star del mondo dello spettacolo hanno sfruttato i social
per potersi auto presentare, per costruire la propria immagine pubblica -> ciò ha indotto molti
giovani a imitare queste star/a copiare questi meccanismi ma questo fenomeno non c’entra con il
narcisismo, è un’interpretazione sbagliata.
-(libro Fontcuberta) Laia Abril, thinspiration, 2011-15: ha raccolto selfie delle anoressiche sui social.
Forse nella costruzione della propria immagine pubblica c’è sempre in gioco la distruzione del
proprio corpo, la sua manipolazione -> questo è un altro aspetto pericoloso dei social.
-Gunthert: altro fenomeno per denunciare il narcisismo della nostra generazione: rischi della messa
in scena/condivisione sui social della nostra vita personale. Ex: ragazzi che si fanno i selfie
durante/prima/dopo i funerali -> denunciano la superficialità delle nuove generazioni. In realtà non
sono solo le nuove generazioni -> ex Obama che si fa un selfie al funerale di Nelson Mandela.
-Parodie di ritratti con aggiunta di smartphone, 2013: questo dibattito ha suscitato delle reazioni: i
giovani usano ironia, affermano che non solo loro si fanno selfie ma chiunque avesse uno
smartphone si farebbe un selfie. Il successo è un po' come farsi un selfie, e quindi tutte le persone
famose si farebbero un selfie -> conta l’idea del selfie e non il selfie stesso.
-In questo rilancio delle questioni entra in scena l’arte: le persone famose sono anche quelle
dell’arte, si fanno parodie con artisti con in mano lo smartphone che si fanno selfie (Van Gogh…)
-Altra forma di rilancio è quella sul piano culturale: è stato istituito un giorno dove si fanno selfie nei
musei/si imitano le posizioni delle statue/dei personaggi nei quadri -> fotografie su Twitter in
occasione del #museumselfieday
-Ellen Degeneres, selfie alla cerimonia degli Oscar, 2014: volti sorridenti degli attori, sorriso si
trasmette e fa scattare l’empatia.
-Papa Francesco si fa fare un selfie con altri ragazzi, è molto disponibile VS Principe Henri che
recandosi in Australia si rifiuta di fare un selfie con una ragazza che glielo chiede e le consiglia di
fare una foto “normale”. Principe Henri vuole rimettere le cose a posto, è contro il cambiamento e
vuole farsi fotografare senza la ragazzina affianco, non vuole essere messo sullo stesso piano della
ragazza: vuole dividere il ruolo di colui che scatta la foto e di colui che viene fotografato, vuole dire
che il principe. Gunthert afferma alla fine del suo libro che il rapporto con la celebrità viene
determinato dall’utente: non è il principe a decidere se lui è celebre/fotografabile e quindi la
situazione si è rovesciata. Il discorso narcisistico ha fatto del selfie una forma culturale a tutto tondo
(non è un semplice fenomeno momentaneo della vita quotidiana) dotata di significati epocali,
politici ed esistenziali.
-Kurt Caviezel, users – glasses, 2014: selfie fatto davanti alla videocamera del computer. Kurt
Caviezel è un artista e va a vedere sui siti dei comportamenti che guardati in un determinato modo
risultano strani/particolari. Il formato delle sue opere è sempre lo stesso: si basano su una
moltiplicazione in modo da far vedere la molteplicità dei comportamenti che sono giustapposti uno
accanto all’altro. Kurt fa un’azione di isolamento: isola l’immagine dal suo contesto, e così facendo
la carica di significato diverso
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
• Ex: coppie che si fanno selfie in video, tutte le mattine, mentre fanno colazione (Couples,
2014)
• Ex: quelli che si fanno selfie sbadigliando (Users, 2014).
-Erik Kessels, My feet (I’m bored), 2014: tantissime foto dei piedi
-Penelope Umbrico, Sunset Portraits, 2010: foto al tramonto
-Christopher Baker, Hello World! ,2008 -> Fontcuberta tira una sua conclusione: afferma che in
fondo, la stragrande maggioranza dei selfie in rete vengono fatte per ragioni gioiose, ludiche, per
esplorare la propria identità, per ricordaci di alcuni momenti, quindi per ragioni che non hanno a
che fare con il narcisismo. Baker accosta migliaia di immagini tratte da video conferenze in
movimento, dove queste persone stanno parlando contemporaneamente: il titolo (hello world) è
molto positivo, come il pensiero di Fontcuberta. Diventa un ritratto collettivo: queste immagini
danno l’idea di vastità, di comunità. Si passa dalla riflessione/ denuncia della chiusura di ciascuno su
sé stesso (narcisismo) a una visione DEMOCRATICA dell’uso della tecnologia e delle nuove forme di
espressione -> secondo il pensiero di Fontcuberta
CORPO
Libro “Copro e figura umana nella fotografia” Grazioli + libro di Susan Sontag
In particolare faremo riferimento al il movimento artistico del surrealismo poiché non si limita a
concepire le immagini/la fotografia come forme realistiche.
-Corpo come esempio di bellezza. Il nudo entra nella fotografia a scopo utilitario: per sostituire le
modelle che erano costose/ non stavano ferme (Esempi: Auguste Belloc, nudo con colonna, 1860 e
Jean-Louis Durieu, Nudo, 1854).
-Fotografia di nudo ha una sua ambiguità/ un risvolto ambiguo: il nudo è sempre seduttivo.
PORNOGRAFIA
-Il suo uso subito dilaga nell’uso della fotografia.
-Nella pornografia c’ è una dialettica interessante da un punto di vista visivo: ti vedo ma non ti vedo,
mostro quello che serve ad eccitare lo spettatore, ma non mostro tutto. È più pornografico
mostrare maliziosamente un dettaglio piuttosto che mostrare tutto subito.
-Anonimo, Nudo, 1855: la donna ha la maschera sugli occhi
-Anonimo, Dagherrotipi stereoscopici, anni 1840: due fotografie leggermente spostate come punto
di vista. Gli stereoscopici accostano le immagini e il nostro occhio vedendole accostate ha un senso
di tridimensionalità. Nell’immagine pornografica però c’è un aspetto rivelatorio: nella
tridimensionalità dei corpi, il nostro tatto è sollecitato e quindi abbiamo voglia di toccare i corpi.
Occhio e tatto sono slegati tra di loro e la pornografia è falsa perché sollecita il mio desiderio e al
tempo stesso lo blocca = è una frustrazione perché ci fa immergere in immagini più reali ma al
tempo stesso è al di la della superfice fotografica quindi per me è intoccabile.
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
-Stanislas Ostrorog, Edmond Desbonnet, 1902: bodybuilding è un’invenzione sociale a cavallo tra 19
e 20 secolo. Attenzione verso il corpo, sempre + persone iniziano a pensare alla propria
salute/igiene e all’esercizio fisico.
-Fred Holland Day, Studio, 1898: a cavallo tra 19 e 20 secolo, la fotografia inizia a cercare la propria
indipendenza: i fotografi si mettono a fare fotografie costruite.
-Clarence White, nudo con specchio, 1909: inquadratura particolare per gli standard poiché il
soggetto è spostato verso l’alto, la testa non si vede e in basso c’è un grande spazio vuoto -> artista
vuole attirare la nostra attenzione non sul soggetto stesso, ma sulla sua interpretazione. Il riflesso
dell’immagine sta al centro, è quello che conta. Illuminazione mette sullo stesso piano la persona
reale e il suo riflesso
-E. J. Constant Puyo, Ventaglio, 1900: in ambito artistico ci sono gli stessi meccanismi dell’immagine
pornografica: ad esempio i veli (vedo-non vedo)
-Anne W. Brigman, The Hamadryards: ha usato la macchina fotografica per farsi degli autoritratti in
cui lei si è integrata nel mondo naturale: l’ha fatto per promuovere il fatto che la donna è più
integrata nella natura rispetto all’uomo.
-Alfred Stieglitz, Ritratto ,1918: innovazione -> fa ritratti non fotografando il volto ma fotografando
qualsiasi altra parte del corpo/altri dettagli. Infatti non è solo il volto ad essere peculiare in un
individuo, ma anche le altre parti del suo corpo. La fotografia ritaglia sempre un pezzo di realtà e
decide dove tagliare e cosa tagliare.
- Alfred Stieglitz, Ritratto, 1918: gioca sul fatto che il corpo femminile, tagliato in questo modo,
sembra una faccia: capezzoli -> occhi, ombelico -> naso, pube -> bocca. Nostro sguardo non ha il
ritaglio intorno a ciò che noi guardiamo ma gli occhi sfumano il contorno e la nostra attenzione si
focalizza sul centro. La fotografia invece, mette a fuoco tutto nello stesso modo.
-Edward Weston, Nudo, 1936: non è una posizione naturale ma è stata fatta assumere dal fotografo
per evidenziare alcune forme. La donna sembra uno strano animale, assomiglia a qualcos’altro.
-Imogen Cunningham, Nudo ,1932: raccoglie il corpo e lo dispone da un’angolatura innaturale:
mostra la realtà in modo diverso, non vedo il corpo ma le forme.
- Edward Weston, Anita nuda, 1925 -> Anita è chiusa su sé stessa, io vedo solo il sedere
-Excusado, Messico, 1935 -> base del water che ha la stessa rotondità e lucidità del corpo di Anita
Eroismo della visione (capitolo di Susan Sontag “l’eroismo della visione”): noi fotografiamo cose
belle, la fotografia è legata alla bellezza in due modi:
1. Fa scoprire nuove forme di bellezza che solo la macchina fotografica può rivelare (punti di vista,
angolature, nuovi paesaggi, momenti particolari)
2. La fotografia rende belle ciò che noi fotografiamo (fotogenia: venire bene in foto). Fotografia
abbellisce la realtà perché la allontana nel tempo. Realtà e immagine restituita dall’immagine
fotografica non sono la stesa cosa: questa è la differenza che c’è tra realtà e verità, esse non
coincidono. Eugene Smith afferma che la fotografia deve dare la verità non la realtà.
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
Fotografia mi mostra una visione che non è più finalizzata all’oggetto, ma è finalizzata su sé stessa.
1. Fotografo cacciatore: va a caccia di particolari/forme/momenti
2. Vista ha acquisito un privilegio rispetto agli altri sensi -> uomo si è identificato con il senso della
vista.
Susan Sontag conclude il suo testo con la frase “tutto è bello”: la fotografia ha introdotto il distacco
estetico dal mondo -> macchina fotografica concretizza la distanza che c’è tra noi che guardiamo e
l’oggetto che è distante. Distanza non è solo materiale e spaziale ma anche estetica (= cerchi di
restituire la bellezza di ciò che stai vedendo)
- Edward Weston, Peperone, 1930
-Deserto, 1928
analogie di forme tra soggetti apparentemente lontani tra di loro.
- Imogen Cunningham, Fianco, 1929: corpo è astratto, non si vede più. C’è solo una linea che
sembra una spirale. Il corpo è disincarnato
-Frantisek Drtikol, Composizione, 1927: artista lavora sull’idea della geometrizzazione del corpo che
è contestualizzato in una composizione astratta, fatta solo di forme che non rimandano alla realtà
(cerchi, cubi, quadrati, rettangoli). Il corpo è disposto a sua volta in modo da formare una forma
geometrica. Guardando l’immagine non pensiamo all’ oggetto rappresentato MA guardiamo la
realtà in un modo diverso, facendone una surrealtà.
SURREALISMO
-André Breton (fondatore del surrealismo) pubblica nel 1924 il manifesto del surrealismo dove
spiega quali sono gli intenti e i caratteri del movimento, che sono dettati da ciò che Freud ha
chiamato “inconscio” (inconscio è formato da quegli elementi che abbiamo sepolto sotto la
coscienza perché ci disturbavano). Inconscio ha portato nell’arte un mondo che prima era escluso
-> immagini dei sogni, dei bambini, dei folli. Sintesi della pratica surrealista è ciò che Breton ha
chiamato la scrittura automatica (1938): è il lasciar fluire ciò che viene dalla mente senza
controllarlo, senza che la coscienza possa filtrarne il contenuto e metterlo in ordine.
-Max Ernst, Sopra le nuvole cammina la notte, 1921: usa la tecnica del collage. Egli crea degli
accostamenti inconsueti: due gambe nella parte inferiore + un pizzo nella parte superiore ->
l’essere umano diventa un’altra cosa. Si mostra la realtà in un altro modo, tramite metamorfosi,
metafore, trasformazioni…
-Max Ernst, l’interno dello sguardo (l’uovo), 1929: si intravedono uccelli, facce, occhi.
-Max Ernst, La vestizione della sposa, 1939: usa la tecnica del frottage: sotto il foglio c’è una
superfice ruvida e se sopra il foglio passi con una matita vedi venire fuori delle figure.
-Joan Mirò, personaggio che tira un sacco a un uccello, 1926: personaggio è su una spiaggia e
percepisce i propri piedi come più grandi, c’è un occhio solo che è quello che fa prendere la mira e
le braccia sono usate come leva -> propriocezione (= percezione di sé stesso da fuori). Idea della
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
deformazione: Surrealismo vuole mettere in evidenza come le cose appaiono alla mente e non agli
occhi
-Joan Mirò, donna e bambino alla fonte, 1934: signorina formosa al centro dell’immagine che va alla
fonte a prendere l’acqua, davanti a sé ha un vaso e dietro bambino giocoso. Sullo sfondo c’è un
paesaggio naturale fatto di forme semplici, sembra disegnato da un bambino-> bambini non
disegnano quello che vedono ma come pensano le cose
-Salvador Dalì, il gioco lugubre, 1929: Dalì ha manipolato + di tutti la figura del copro. Questo
quadro ha creato scalpore: al centro uno strano insieme di figure + figura in basso dx e una a sx che
sembra una statua. Figura a dx si è sporcata le mutande e si vergogna (vergogna è rappresenta dalla
figura alle sue spalle) mentre tutto ciò che c’è davanti è provocato da questo suo problema. La
figura centrale è composta da tanti oggetti che sono trasformati e al centro c’è il ritratto di Dalì di
profilo.
- Salvador Dalì, Il grande masturbatore, 1929: anche qui c’è il ritratto di Dalì di profilo: esso si
trasforma in alto a destra in un busto di donna che tende verso un corpo maschile. Rimanda alla
sessualità e alla anamorfosi (=rappresentazione come se fosse in una superficie riflettente
irregolare: Si riesce a ricostruire la figura ma solo da un unico punto di vista)
-L’enigma di Guglielmo Tell, 1934: cappello si sviluppa verso sx su una stampella e gamba dx si
sviluppa verso dx su un’altra stampella. Stampella: rimando alla sessualità.
-Donna con testa di rose, 1935: fiori sostituiscono la testa
-Metamorfosi di Narciso, 1937
-Galatea con sfere, 1952: Dalì aveva sentito della scoperta dell’atomo. Noi siamo fatti di atomi e lui
cerca di darci una resa visiva di ciò. Inconscio è quindi un nuovo modo di guardare le cose: questo
quadro è una doppia figura, dipende da come la guardi.
-René Magritte, scoperta, 1928: scoperta ha due significati: nuda e scoprire qualcosa di nuovo -> c’è
un gioco tra questi due significati
-René Magritte, Gli amanti, 1928: hanno un velo in testa entrambi e si baciano
- René Magritte, Il doppio segreto, 1927: all’interno non c’è quello che ci si aspetta + il segreto è
doppio perché si è sdoppiato
-Man Ray, anatomia, 1930: come usare la macchina fotografica in senso surrealista? Ray ha trovato
delle modalità di trasfigurazione della realtà in modo da farla apparire come altra. In questo caso si
tratta del collo di una persona ma è difficile da individuare perché mi appare come altro e non si
vede la faccia della persona stessa.
-Man Ray, testa, 1923: cambia il punto di vista: la massa di capelli si trasforma, il volto diventa un
triangolo
-Man Ray, lacrime, 1930: occhio si trasforma in una pianta carnivora, le ciglia è come se avessero in
cima dei pistilli. La realtà diventa una metafora di qualcos’altro
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
-Brassai, senza titolo, 1933: illuminando il corpo in un determinato modo, esso diventa poi un ‘altra
figura. Vuole sembrare la testa di un animale: capezzoli diventano le orecchie e braccio il profilo del
volto dell’animale.
-Man Ray, primato della materia sul pensiero, 1929: tecnica della solarizzazione -> l'annerimento
delle zone più chiare che si verifica nel positivo in seguito a una sovraesposizione del negativo. C’è
una luce dove prima c’era l’ombra. Titolo attira la nostra attenzione: la materia ha avuto il
sopravvento sul pensiero.
-Raoul Ubac, la battaglia delle Pentesilee, 1939: è una multisolarizzazione. Immagina sviluppate
varie volte e ogni volta riesposta ad un nuovo colpo di luce = manipolazione tecnica
-Erwin Blumenfeld, Senza titolo, 1936: colpo di luce determina un contorno netto della figura = è
come se la donna fosse sollevata perché l’ombra va dietro e la figura sembra tridimensionale.
-Man Ray, ritorno alla ragione, 1923: tema del mimetismo -> c’è una donna alla finestra e le tende
semi-trasparenti proiettano effetti di luce/ombra sul suo corpo: sembra che lo spazio voglia
possedere il corpo.
-Raoul Ubac, ritratto in uno specchio, 1938: macchie che vediamo sul volto della ragazza dove si
situano? Il volto della ragazza è trasfigurato da un acido? È il trattamento della fotografia stessa che
è stata manipolata in fase si stampa? O la faccia è riflessa in uno specchio sporco? Nell’interrogarci
su cosa possa essere ci siamo posti delle domande che sottolineano come in ogni immagine ci siano
in gioco 2 tipi di superfici:
1. Superficie di ciò che è rappresentato (volto)
2. Superficie dell’immagine stessa
-Maurice Tabard, mano e donna, 1929: specchio nasconde il volto della donna in modo tale che
diventa uno scontro di corpi brutale. Idea del desiderio: mani messe in evidenza
- Maurice Tabard, Composizione, 1930: mani sovrapposte al corpo, ancora idea di
desiderio/possesso.
-André Kertesz, Distorsione 78, 1933: seno si è staccato, volto si è moltiplicato, e le braccia si sono
staccate/piegate: si ha una vera e propria distorsione.
-Jacques-André Boiffard, L’alluce, 1929: ingrandimento -> alluce è isolato e si trasforma in un
organo irriconoscibile
-Hans Bllmer, Bambola, 1935: tema della bambola è il tema del doppio, del manichino, dell’automa.
Bambola turba: è una presenza viva o non viva? Bllmer ha fatto due cicli di opere fotografiche
basati sulle bambole: ha preso le bambole, le ha smontate e ha ricombinato i pezzi non nel modo
corretto -> ha fatto nascere queste trasformazioni e questi pensieri sulla malleabilità del copro
umano. Nel suo secondo ciclo ha preso le bambole e le ha inscenate nei luoghi della casa (sulle
scale, nell’armadio).
-Bill Brandt, nudo, 1951: effetto della profondità + nudo e tavolo, 1948: tavolino sembra toccare il
soffitto
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
Conclusione: La surrealtà non ha a che fare con il mondo della fantasia e dell’inconsapevolezza
poiché nel comportamento umano c’è sempre l’azione dell’inconscio. I surrealisti vogliono
presentare la realtà in un ALTRO modo, in un modo trasfigurato.
30/03/20
SURREALISMO NELL’AMBITO DELLA PUBBLICITA’ E DELLA MODA
-Renè Magritte, la chiave dei sogni, 1936: la parola non coincide con l’immagine. Rapporto tra
nome, parola e cosa/immagine è arbitrario (=non c’è una vera ragione).
-Surrealismo a un certo punto ha abituato la visione a non riferirsi più alla realtà. Esempi:
“formaggio pastorella nutre più della carne”: formaggella è più grande della mucca + “biscottini di
Novara Pavesi”: bambino è nell’uovo, è paragonato ad un pulcino. Altri esempi: maiale che si taglia
da solo e diventa salame -> cattura l’attenzione. Bambino attaccato alle mammelle della mucca, in
realtà non è una mucca ma il contenitore di latte in polvere.
-Signora guarda macchina da scrivere come se fosse l’unica cosa che desidera -> adorazione,
l’oggetto è da desiderare
-René Magritte, Tonny’s, 1931: cane e gatto si contendono la caramella. Idea della destabilizzazione
che l’oggetto del desiderio crea nella contesa: le lettere della marca Tonny’s sono infatti in
equilibrio
-René Magritte, Sigerette Belga, 1936: pubblicità commissionata a Magritte, ma la sua realizzazione
è stata rifiutata-> non fa desiderare l’oggetto (sigaretta). Questa immagine è surrealista perché non
induce a desiderare l’oggetto pubblicizzato ma induce a fare una riflessione
-René Magritte, Exciting perfumes by Mem, 1946: albero si apre come un armadio e dentro ci sono
profumi -> indica che sono naturali (quando artista fa pubblicità, egli traspone delle sue immagini o
esprime il suo pensiero in arte) + La voce del sangue, 1948: grafico si ispira all’opera dell’artista:
1. per richiamare la fama dell’artista
2. Perché gli interessa un aspetto dell’artista e lo adatta alla pubblicità
-Herbert Bayer, pubblicità murale per la rivista “die neue Linie”, 1932: Surrealismo ha liberato le
immagini con il loro legame con la realtà: volto tagliato con sfondo nuvoloso diventa un paesaggio +
testa che esce dal tempio greco
-rivista Vanity fair, luglio 1933: strategia pubblicitaria per catturare l’attenzione -> persona seduta
sulle due Americhe + rivista Fortune, giugno 1946: pochi oggetti sparsi e oggetto centrale è
inventato
-Man Ray, le Violon d’Ingres,1924: violoncello simile al corpo della donna per le forme: trasforma il
corpo di donna in violoncello + Christian Lacroix, Violin dress, 1985: applica le chiavi di violino
sull’abito
-Serge Lutens, music colors- Shiseido, 1985: strumenti usati sulla testa come se fossero cappelli +
Serge Lutens, Les rythmiques-Dior, 1979: spartito usato come cappello
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
-Erwin Bumenfeld, Cappello, 1947: stravolgimento delle fotografie di moda tradizionali tramite la
frammentazione delle immagini: l’abito non è continuo; bocca e scialle della modella sono
moltiplicati
-Elsa Schiaparelli (=immersa nell’ambiente surrealista, fece lavorare per sé molti surrealisti ex: Dalì),
Rococò Mirror Jaket, 1939: abito con superfici specchianti + Yves Saint Laurent, Rococò Mirror
Jacket, 1978: omaggio a E. Schiaparelli, specchio copre la schiena e accieca colui che guarda nella
sua direzione. È sulla schiena perché non può acciecare color che stanno davanti e che parlano con
colui che lo indossa ma accieca quelli che lo guardano da dietro.
-Horst P. Horst, cornice, 1930: signora a dx potrebbe essere colta come il riflesso di quella di sx
-Cecil Beaton, fotografia di moda, 1938: nonostante io vedo mani e braccio che sostengono questa
cornice, l’immagine dentro la cornice non è dovuta alla trasparenza della cornice, è invece una
fotografia. Realtà e finzione sono fusi tra di loro
-Dominique Lacoustille, abito finestra, 1985: come la finestra è per guardare al di fuori, qui l’abito è
per guardare al di dentro, al corpo della modella. Sulla sx c’è una finestra e sulla dx una donna che
indossa un abito fatto in parte dalla griglia della finestra
-Jean Cocteau, le sang d’un poète, 1930: accostamento statua-automa: statua prende vita e uomo
si innamora. Altri esempi con questo tema: Alix Grès, manichino, 1937 + Horst P. Horst, vogue, 1936:
abito con scanalature e fa diventare questa presenza umana quasi una scultura
-Salvador Dalì, Night and day cloyhes of the body, 1936: abito-finestra -> a destra io posso aprire
l’abito e posso vedere dentro il corpo
-R. Magritte, Omaggio a Mack Sennett, 1934: corpo e abito sono indistinguibili. Vestito è appeso in
un armadio (anta aperta per vedere); abito è sospeso, si vede l’ombra sotto. L’abito ha dentro un
corpo o no?
-Yves Saint Laurent, Robes Lalanne, 1969: Gioco sull’ambiguità -> è come mettere una maschera
identica al mio viso, qui vale la stessa cosa: a sx il seno e dx il busto sono ricostruiti da un materiale
diverso rispetto all’abito, e il materiale è color pelle= seno/busto sono mostrati, evidenziati
31/03/20
➢ Occhio
-Salvador Dali e Luis Bunuel, Un chien andalou, 1929: occhio è lo sguardo, è l’organo attraverso cui
abbiamo il rapporto con l’immagine. Anche l’immagine ci guarda, immagini surrealiste hanno punti
che sembrano emergere e venire verso di noi. Per i surrealisti lo sguardo è tagliato, così come
l’essere umano è tagliato tra conscio e inconscio.
-Magritte, il falso specchio, 1928: sostituzione dell’iride con il cielo nuvoloso: dentro la testa c’è un
cielo nuvoloso
-Man Ray, oggetto indistruttibile, 1923: accostamento tra il metronomo e lo sguardo -> metronomo
misura il tempo dello sguardo, il tempo dell’occhio VS Dalì, l’occhio del tempo, 1949: gioiello sul
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
tema dell’occhio. Ha posto al centro dell’occhio un orologio, simbolo del tempo + lacrima che è un
tocco emotivo
-Cassandre, Copertine di Harper’s Bazzar, anni 1930: copertine con al centro l’occhio
-Tema dell’un occhio solo/ciclope: George Platt Lynes, Cyclop, 1937 + Tony Viramontes, The face,
1986 (rivisitazione moderna): sotto il cappello appare l’occhio del modello evidenziato perché
bianco su immagine nera
-Yves Saint Laurent, Les Yeux d’Elsa,1980 : omaggio a E. Schiaparelli. Giacca con gli occhi
-Larry Fox, Celestail Eye Suit, 1985: occhi sono moltiplicati sulla giacca.
-Man Ray, all’ora dell’osservatorio, 1934: isolare dei dettagli del corpo per farli diventare la zona
centrale, per calcarli di significato. La parte sospesa del quadro è formata da delle labbra che sono
spese nel cielo.
➢ Bocca
-Dalì, divano bocca, 1937: divano a forma di bocca in pelle (anche il materiale è realistico). La bocca
è ingrandita rispetto alla grandezza normale.
-Dalì, Spilla, 1949: spilla a forma di bocca
-Man Ray, collana: Ray ha realizzato una collana con “ciondolo” (non pende) a forma di bocca. Si
tratta sempre di surrealismo
-Valentine Hugo, des Gueules, 1934: mettere bocca al posto degli occhi e del naso
-Cassandre, copertine di Harper’s Bazaar, 1937: a sx occhi e bocca sono sovrapposti e hanno quasi
la stessa forma, a dx bocca con rossetto nello specchio
-Yves Saint Laurent, Lip Coat e Lip Dress, 1971 e 1966: tante bocche su tutta la giacca e su tutto il
vestito: rimando erotico
➢ Mani
-Maurice Tabard, senza titolo, 1930: mani simbolo del tatto, del prendere, del possedere. Mani
fanno un’ombra nera sul copro nudo di una donna bianco
-Magritte, i giorni giganteschi, 1928: avvolgimento di 2 corpi dentro uno.
-Hors P. Horst, foto per Cartier, 1938: A sx mano staccata dal resto del corpo e sembra autonoma+
donna con cappello che copre un occhio, è ciclopica + Hors P. Horst, Mani, 1941: mani sono
ripetute e sembrano appoggiate su un fianco femminile. Alternarsi bianco e nero mette in gioco
tema etnia
-Francois Lesage, Cintura, 1986: cintura fatta da mani
-Marc Jacobs, vestito trompe-l’oeil,1986: Mani sono disegnate sull’abito e la modella aggiungendo
le sue ci inganna
-Yves Saint Laurent, Pop Art Dress, 1966: abito con dentro due profili uniti.
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
-Dalì per Schiaparelli, 1937: cappello è un oggetto feticista come la scarpa con il tacco: quindi
signora indossa una scarpa con tacco come se fosse un cappello + Marcel Vertes, pubblicità, 1937
(ancora cappello fatto con scarpa con il tacco)
-Karl Lagerfeld, cappello sedia, 1985 + Bill Cunningham, cappello, 1950: cappello fatto da una barca
e il mare
-Altri cappelli a forma di ninfea, a forma di lattuga, a forma di mazzo di fiori
➢ Piedi
-Magritte, la filosofia nel boudoir, 1947: piedi sopra le scarpe (disegno)
-Pierre Cardin, scarpe da uomo, 1986: realizza in concreto l’idea di Magritte: le scarpe hanno inciso
la forma di un piede nudo
…
Surrealismo ha una lunga vita (fino agli anni 50) e un’influenza a livello globale. Anni 30/40
esplodono le dittature e la 2 guerra mondale. In arte negli anni ’40 vi è l’entrata degli USA ->
processo di americanizzazione
ARCHIVIO
➢ Anni 50
-Henri Cartier-Bresson, Images à la sauvette, 1952: istante decisivo, è unico = qui la ragazza viene
fotografata quando è nel punto illuminato. Immagine rappresenta un mondo quotidiano: c’è
l’uomo con i suoi problemi, c’è un ritorno alla fiducia nei propri simili, ritorno alla realtà dopo la
guerra (no desiderio, esaltazione, inconscio)
-Robert Frank, gli americani: parata, 1955: istante unico -> bandiera che cancella il volto di colui che
si affaccia alla finestra
-William Klein, Bikini, 1959: foto vuole dare il senso della realtà in maniera viva, c’è una scena in cui
mi sento partecipe. Giovinezza VS vecchiaia dietro
-pubblicità anni 50: fenomeno del testimonial = attrici/personaggi famosi testimoniano dei prodotti,
come a dire “se usi questo prodotto diventi bella ecc.…”. Attori di per sé recitano quindi anche qui
recitano e testimoniano la loro fama.
-Irving Penn, 1950: abito che cade dalla spalla diventa una forma e sta in primo piano; taglio della
foto all’altezza degli occhi, quel tanto che basta per vedere gli occhi; esalta la bocca + nella seconda
immagine foulard da un lato scende dall’altro sale, c’è un gioco di forme; sguardo laterale + nella
terza immagine donna toglie con la lingua il pezzo di tabacco che rimane sulla lingua, nonostante
questo gesto, l’abito è elegante, geometrico e lussuoso
- Irving Penn, Corpo terrestre II, 1950: tema dell’essere terrestre dei corpi -> questi corpi non
rispondono ai canoni della bellezza. Contrasti tra bianco e nero (=che è bruciato/non si intravede
nulla dentro e si infiltra nel corpo) + altra immagine con bianco bruciato + seni sembrano un’altra
cosa = dalla corporeità più terrestre (come dice il titolo) a quella più astratta.
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
-Richard Avedon, 1955: modella si atteggia da attrice (=bellezza) in contrasto con gli elefanti
(=animalità). Avedon, Twiggy: posa sgraziata che contrata con bellezza ed eleganza della modella e
dell’abito + Richard Avedon, Veruschka: eleganza non deve trasformare la donna in un manichino
Avedon: ricerca del movimento, non della posa statica. Avedon, Liz Taylor, 1964: piume che
costituiscono il copricapo fanno sembrare la modella una medusa, sembra che ha la capigliatura
viva. Avedon, Eva, 1981: corpo della modella diventa lineare come il copro del serpente. Avedon,
Ginsberg e Orlovsky, poeti, 1963: rappresentazione del corpo così com’è, senza essere trattato per
apparire bello, eppure si piacciono tra di loro. Avedon, Apicoltore, 1981: si lascia coprire dalle sue
api senza problemi.
➢ Anni 60 (anni della gioventù, del rock)
-Diane Arbus: fotografa che è andata a cercare le stranezze del comportamento dell’essere umano
in vari ambienti, mettendo in evidenza anche su questioni centrali. Esempio: tema delle gemelle:
due bimbe sono identiche ma in realtà una è felice e l’altra appare triste, nella loro somiglianza
sono diverse. Altro esempio: va alla ricerca di persone basse e le illustra nude, come se si piacciano.
Arbus, coppia di adolescenti, 1963: adolescenti vestiti da adulti -> straniamento: qualcosa che è
estraneo alla normalità.
-Garry Winogrand, American legion convention, Dallas, 1964: egli va nelle strade a cogliere la vita
così com’è, senza metterla in posa e manipolarla, per far ciò deve essere distaccato, impersonale
(=street photography). Questa foto rappresenta un reduce di guerra che passa sul marciapiede e
nessuno ci fa caso. Corpo non è scontato, la presenza del corpo irrompe nella realtà, si fa sentire.
Winogrand, senza titolo, 1975: Un uomo di colore e una donna bianca di pelle non hanno in braccio
figli ma scimmiette che assumono la stessa posizione dei bambini.
-Bill Owens, le tre inservienti, 1977: pop art -> attenzione per la società dei consumi, di massa
-Body art (metà anni 60) -> corpo non è più oggetto della rappresentazione ma è lo strumento per
realizzare l’opera d’arte. Spesso il corpo nella body art è in azione/in performance. Arnulf Rainer,
senza titolo, 1969: tensione e dinamica del corpo
-Urs Luthi, autoritratto, 1971: travestitismo -> maschile e femminile si mischiano, non ci sono più
sessi definiti (aggiunta transessuale). Arte riflette questo tipo di trasformazione
➢ Anni 70 (liberazione dal moralismo, libertà di comportamento sessuale e non, rimescolamento
tra realtà e finzione ma tuttavia vi è ancora il tormento personale -> vedi Tourbeville)
-Marina Abramovic, Ritmo O, 1974: lei resta nuda, immobile e inespressiva per ore in un’esibizione:
si sottopone a qualsiasi azione le persone volessero fare sul suo copro con qualsiasi oggetto (piume,
rose…) -> spettatore da passivo diventa attivo
-Helmuth Newton, 1975: ha introdotto nella fotografia l’immaginario in cui il rapporto tra donna e
uomo è liberato dal moralismo e scatena fantasie, è oggetto di liberazione. Donna è come se si
sottoponesse al desiderio maschile ma governandolo -> esaltazione del ruolo femminile,
emancipazione (opposto della donna oggetto di fantasie erotiche maschili).
- Guy Bourdin, 1972: sessualità molto spinta: aereo che entra tra le gambe di questa modella
dentro l’automobile + gusto estetico molto accentuato
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
-Pubblicità per Charles Jourdan, primavera 1975: scena cruda in cui il bambino è alla porta, si
affaccia e vede la donna nuda con parti coperte e televisione accesa con un film dell’orrore. È una
pubblicità per scarpe, quindi è come se il bambino spiasse le scarpe piuttosto che il corpo ->
subentra l’immaginazione dello spettatore
-Altra pubblicità per Charles Jourdan, primavera 1975: altra scena da film poliziesco: è successo un
assassinio, c’è la sagoma della vittima e resta la scarpa in primo piano
-Inedita, primavera, 1975: maschera anti-gas e sfondo di fantasia militare
-Vogue Paris, maggio 1975: sembrano più vivi i manichini a dx che le persone che passano sulla
strada (che sono vere). Il vetro della vetrina potrebbe essere ribaltato -> ribaltamento del rapporto
tra realtà e finzione che porta fino al post-modernismo dove tutto è diventato immagine
-Deborah Tourbeville, 1973: fotografa dispone come se fossero in un set cinematografico delle
donne che sono turbate/pensierose. Abiti che indossano rispecchiano questo modo di sentirsi. Da
un lato c’è la conquista di ogni libertà e dall’altro c’è ancora la volontà di approfondire la propria
condizione, il proprio essere. Spesso Tourbeville usa spesso bianco e nero e grigio
-Sara Moon, 1972: si parla di neo-romanticismo: atmosfere pittoriche, atteggiamenti involuti: lei è
immersa nei prooprio pensieri e anche il cane sembra avvolto nei pensieri suoi; le espressioni sono
indefinibili, è tutto sfocato, indefinito anche nel senso esistenziale di questo termine. Gli abiti non
sono eleganti
-pubblicità televisiva fa leva sul sex symbol che diventa molto esplicito -> ex pubblicità di una
benzina “Scappa con Superissima” oppure pubblicità Peroni “Chiamami Proni sarò la tua birra” dove
la ragazza stringe la bottiglia come stringesse un corpo.
-Due facce della stessa pubblicità: pubblicità di jeans della marca “Jesus” ideata da Toscani -> il
nome della marca permette a lui di giocare sugli slogan che prendono il sacro e lo fanno diventare
profano. Slogan: “non avrai altro jeans all’infuori di me”, “chi mi ama mi segua” (dato che è di
schiena). Toscani diventerà il pubblicitario di Benetton
-Pubblicità Prenatal: differenze di ruolo tra donna e uomo vengono rimescolate: uomo a sx sembra
incinta e donna a dx ha la salopette come fosse un maschio.
➢ Anni 80 (esplosione di un mondo che era rimasto sommerso a causa dell’impegno politico, del
boom economico, dell’inurbamento che avevano dato un ‘immagine troppo omogena della
società -> nasce la “Milano da bere”: dalle limitazioni che si avevano adesso vogliamo goderci le
cose, la società esce allo scoperto, si esibisce il piacere, il successo. Dall’ latra parte c’è un
mondo rimasto sepolto che è tragico, ex droga)
-Larry Clark, Tulsa, 1971: due ragazzi che fanno uso di droga pesante. Questi fenomeni hanno luogo
nelle periferie di grandi città, sono comportamenti devianti che portano all’autodistruzione. Sesso
inizia a essere fatto senza consapevolezza. Nascono i gruppi, le tribù giovanili. Questo fotografo è il
primo che ha fotografato dall’interno del gruppo: lui era uno di loro. La parte centrale della società
non vuole vedere queste scene.
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
-Larry Clark, Teenage Lust, 1981: affetto tra queste due persone ma sono in una condizione
degradata. Unico sentimento che fa da ancora di salvezza è l’amore, ecco perché assume toni
patetici
-Nan Goldin, the ballad of sexual dependency, 1985: la ballata è quel tipo di musica dai toni
lirici/nostalgici/sentimentali. Il tema è invece opposto ovvero drammatico, violento, distruttivo,
profondo = tema della dipendenza sessuale. Questa dipendenza è un problema da un lato, ma
dall’altro è una dipendenza dall’arte. Le rappresentazioni dei corpi sono intime, dall’interno = ne
consegue una naturalezza che ci fa entrare nell’intimità di questo gruppo.
-Nan Goldin si fotografa, il suo fidanzato la picchia: ha segni in faccia e ha un ematoma sulla gamba.
Violenza e amore sono contrapposti. Nan Goldin documenta la vita interna di tutti i componenti
della sua tribù. L’effetto che ella voleva cercare era quello del coinvolgimento dello spettatore.
Esasperare i toni può essere importante per indirizzare l’osservatore dall’esterno e per
trasmettergli la verità della situazione. I travestiti mettono in atto le stesse dinamiche delle altre
persone: l’amore. Frequente uso di specchi nelle foto di Nan Goldin.
-Pubblicità Calvin Klein 1985: tema dell’omosessualità non è nascosto ma viene messo sullo stesso
piano di altri temi. Si cerca il modo di poter piacere sia a maschi che a femmine. Mondo della
pubblicità e della moda è molto attento ai cambiamenti nella società, li coglie e li presenta secondo
le loro finalità che sono piacere e vendere. Corpo del modello è un canone estetico condiviso
-Herb Ritts, Richard Geere, 1978: Anni 80 = esplosione del mondo della musica, del cinema che non
viene + nascosto per motivi ideologici o morali. Geere diventa famoso per questa fotografia: era in
viaggio, la macchina si inceppa, e mentre aspettano che viene riparata si fa scattare questa
fotografia che inserirà nel suo curriculum e perciò diventerà famoso. (altre sue foto in garage ecc.…
molto gradite dal pubblico femminile). Ritts, Djimon con piovera,1989: situazione particolare dove i
tentacoli del polpo sembrano trecce di una capigliatura + Ritts, Vladimir, 1990: aggroviglia le
proprie braccia per fumare una sigaretta. Ritts, 1984: abito è trasparente ed evidenza il corpo. Fine
anni 80 e inizi anni 90 sono gli anni del bodybuilding: la bellezza si costruisce, non si eredita. Il
sentirti a tuo agio con il tuo corpo ti dà sicurezza.
-Campagne pubblicitarie dei luoghi di piacere/di vacanza che sono presentate sfacciatamente: ex
Club Mediterranée dove vai pere dormire, sognare, respirare e giocare
-Campagna dei Levis 501: giovane entra nella lavanderia pubblica, si spoglia e resta in mutande
perché ha solo quei jeans, poi si siede e aspetta che i jeans vengano lavati: ciò rappresenta una
gioventù sicura di sé, disinvolta che non ha malizia. Altra campagna Levis 501: c’è una coppia in cui
il maschio è presentato come fosse un impiegato bacchettone, e la fidanzata biondina ha i boccoli
ed è vestita in stile country. La macchina va in tilt, loro armeggiano nel cofano e si avvicina un
camion con su un giovanotto che va in loro aiuto. Per aiutarli si toglie i jeans e li lega alla macchina
per trainarla, però salendo sulla macchina e accelerando si strappano i jeans e lui rimane mutande
in macchina con la ragazza dell’altro.
-Vanni Codeluppi fa un manuale sulla pubblicità in cui analizza alcuni esempi con una metodologia
che introduce 4 formule per poter analizzare uno spot:
1. Contesto sociale di mercato: in questo caso Levis
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
2. Struttura del messaggio: bisogna descrivere ciò che viene pubblicizzato
3. Immagine del prodotto e la marca (caratteristiche del prodotto che vengono analizzate)
4. Destinatario
-Calvin Klein e Golden Lady = nudo non è più censurato e viene presentato in una maniera che è
apprezzabile
-Jane Evelyn Atwood, Jean-Louis, 1986: nonostante “la Milano da bere” c’è una malattia che
diventa metafora del decennio degli anni 80 = AIDS, che colpiva proprio i comportamenti sessuali,
in particolare quelli tra omosessuali.
-Rudolf Schefer, Der Ewige Schlaf, 1989: le malattie non si presentano visivamente nello stesso
modo, così come la morte non si presenta visivamente nello stesso modo.
-Andreas Serrano, la morgue: morte per polmonite, 1992: questo volto porta i segni della morte per
polmonite (altri esempi sono omicidi, colpo di proiettile…)
-Geneviève Cadieux, il corpo del cielo, 1992 + Cadieux, Buco di memoria, la bellezza inattesa, 1988:
dettagli di corpi giocati su un’ambiguità = sono cicatrici, segni di interventi sul corpo.
-Anni 80= anni dell’arte che ha il copro come superficie: moda dei tatuaggi che evolverà poi nei
piercing. Questi sono gesti estetici
-Anni 80: immagine dell’uomo politico: anche gli uomini politici si rendono conto che la loro
immagine va costruita/ il consenso va costruito attraverso la propria immagine. Politico si deve
piegare agli standard della pubblicità e della comunicazione. Ex: Francois Mitterrand affida la sua
campagna ad un pubblicitario perché si deve assicurare un pubblico maggiore a quello del suo
partito per vincere le elezioni. Se seguiamo le 4 formule per interpretare uno spot di Codeluppi:
1. Contesto sociale di mercato
2. Struttura del messaggio: sfondo della campagna è un classico paesaggio di campagna francese
(c’è anche una chiesa) -> significa che egli vuole conquistare i voti degli elettori fuori dalla città. La
pubblicità afferma nella prima immagine che questo uomo possiede “forza tranquilla” e nella
seconda immagine che egli vuole garantire l’unità nazionale. “Messaggio subliminale” della prima
immagine: i colori del cielo sono stati modificati per ottenere i colori della bandiera francese
3. Immagine del prodotto e la marca sono sostituiti dall’uomo politico
4. Destinatario: non è distretto ma deve essere + allargato possibile
Nasceranno da qui molti studi sulla figura del leader
➢ Anni 90
Post- umano dal punto divista del corpo. 3 questioni:
1. Modificazione del corpo: chirurgia plastica e modificamento della nostra immagine anche
contro i canoni di bellezza, modificazioni continue e si possono fare quando si vogliono (ex:
cambiamento sesso)
2. Cambiamenti dell’aspetto esteriore non comportano una crisi d’identità.
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
3. La trasformazione del corpo attraverso degli inserti meccanici che si integrano nel corpo.
-Aziz + Cucher: Tema della forzatura della chirurgia plastica. L’arte critica i pericoli della chirurgia
plastica ai quali si può andare incontro -> chiusura e perdita del rapporto con la realtà, corpo
soffoca. Critica inoltre al narcisismo: esiste solo l’io, non la realtà intorno
-Orlan si è sottoposta ad ogni operazione chirurgica per manipolare il proprio corpo secondo
un’idea che voleva esprimere (non per questioni di bellezza). Ad esempio voleva richiamare le
figure di alcune divinità, volendo assomigliare a loro in viso
-Christian Marclay: Corpo basato sul montaggio/collage dove addirittura si mischiano i generi.
-Robert Mapplethorpe, Nudi, 1984: corpo presentato come bellezza scultorea, nella sua
perfezione Classicità portata all’attualità, infatti sembrano statue greche. Egli è uno dei pochi
fotografi che ha saputo mettere insieme tecnica, perfezione e classicità nella contemporaneità
-Pierre et Gilles, Adamo e Eva, 1981: versione post-human/contemporanea adi Adamo ed Eva ->
mondo senza peccato originale, perfezione fisica. “Nuovi Adamo ed Eva”: iniziatori di una nuova
umanità
ANIMALI (sguardo non umano)
Cap. 7 del libro “La furia delle immagini” Fontcuberta
-Fontcuberta vede una pubblicità (del 2014) che rappresenta una scimmia e sopra c’è la scritta
“questa scimmia ci ha rubato la nostra macchina fotografica” -> pubblicità di agenzia di assicurazioni
che voleva far capire che assicurazioni coprono anche eventi improbabili come il furto della
macchina fotografica da parte di una scimmia. F. pensò ad una scena famosa di un film (Il pianeta
delle scimmie, 1968) dove scimmie prendono il posto degli uomini. In una scena del film c’è persino
una scimmia che sta dalla parte della camera a riprendere. Questa scena deriva da un film più
vecchio….
-Film The Cameraman, 1928: protagonista (Buster Keaton) è un cameraman che assiste all’
annegamento di una fanciulla, egli lascia la videocamera, va a scorrere la ragazza e ci riesce. Egli
solitamente era accompagnato da una scimmietta quando svolgeva il suo lavoro, e mentre
cameraman salva fanciulla, la scimmietta, che sapeva imitare il suo padrone, gira la scena del
salvataggio. Un altro uomo si prende i meriti del salvataggio della fanciulla ma scimmietta ha le
prove che è stato Keaton.
-Film L’uomo con la macchina da presa, 1928: l’uomo è diventato una macchina di produzioni
d’immagini.
-Progetto di Hilmar Pabel “Life” 1938: cosa pensano gli animali di noi quando siamo allo zoo e li
guardiamo? Pabel mette in mano le macchine fotografiche alle scimmie che scattano foto in cui noi
uomini li guardiamo dalle sbarre -> aspetto animalesco dell’essere umano. Una rivista tedesca
pubblica il servizio di Pabel ma non lo paga perché afferma che le foto non le ha fatte lui ma le
scimmie, quindi non devono pagargli i diritti d’autore. Scatta la domanda “cosa vuol dire essere
autore?”. Poi altra ripubblicazione su Life che lo paga per il suo servizio. Per la rivista tedesca
l’autore è chi realizza la foto concretamente/chi schiaccia il bottone, per la rivista americana autore
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
è colui che ha avuto l’idea e che ha realizzato il progetto. Questo sarà un passaggio fondamentale
per arrivare alla post-fotografia
-Selfie realizzati da un macaco, 2011: un fotografo naturalista inglese stava facendo un servizio in
una zona naturale quando si allontana per un momento dalla camera e un macaco si avvicina e,
osservando questo oggetto, riconosce la sua figura riflessa nella lente della macchina fotografica.
Casualmente schiaccia il bottone e si fa un selfie.
Fontcuberta conclude così questa riflessione: non si può dire che il macaco si sia fatto un
autoritratto perché non c’era INTENZIONE nel gesto -> ciò distingue l’uomo dagli animali (prima) e
dalle macchine (poi). Fontcuberta lo definisce “Umanesimo digitale” = rivendica le caratteristiche
umane dell’uso degli strumenti digitali. Queste questioni vanno oltre l’ambito della tecnica per
diventare parte della cultura che sta cambiando.
Altro tema che richiama Fontcuberta è quello della memoria: essere umano è colui che fa delle sue
azioni del passato un’esperienza e la memoria elabora l’esperienza del passato + essere umano è
caratterizzato dalla capacità di dimenticare
-Joan Fontcuberta, Paralipomena, 2018: F. trova cartoline nella posta smangiucchiate dalle lumache.
Ha fotografato le immagini mangiate dalle lumache e le ha presentate come sue opere… chi è
l’autore? Lui si è riappropriato dell’immagine che casualmente le lumache ha realizzato
concretamente
-Paul Schultz, Sea Turtle finds lost camera, 2010: turista in mare che si riprende perde la fotocamera
in acqua e non la ritrova più. Mette però un annuncio dove chiede di farsela riportare se qualcuno
la trova. La trova una tartaruga di mare che casualmente schiaccia il bottone e scatta delle foto. La
tartaruga poi porta la videocamera a riva, un signore la trova e la restituisce al proprietario
dell’annuncio che scoprirà gli scatti fatti dalla tartaruga. Tartaruga ha girato un film che un uomo
non potrebbe mai fare, siamo di fronte a delle immagini non umane
07/04/20
POSTFOTOGRAFIA: fotografia nella società digitale
-Inflazione di immagini senza precedenti: Erik Kessels, 24 hours in photos, 2012: stampe di foto
pubblicate in 24h sui social, Kessels le ha stampate e le ha rovesciate dentro delle stanze
-Caratteristiche:
• Le immagini hanno cambiato la loro natura e funzione.
-visual studies: i modi di produzione sono studiati sullo stesso piano, prima non era così (ex: artista
studiava solo la propria disciplina)
• Ordine visuale nuovo. 3 fattori
1. Immaterialità (immagini sono immateriali, solo sullo schermo) e trasmissibilità (file è
fatto per essere trasmesso e non per essere guardato)
2. Moltiplicazione (immagini digitali possono essere moltiplicate all’infinito) e disponibilità
(dato che ci sono moltissime copie, immagini sono + disponibili e arrivano dappertutto)
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
3. Enciclopedismo del sapere e della comunicazione: Internet è un archivio in cui si trova
qualsiasi contenuto.
• Trasformazioni:
1. Ontologica: prima la fotografia era una rappresentazione della realtà senza l’intervento
umano, si dava molta fiducia e credibilità alle foto. Ora invece l’immagine digitale può
essere cambiata e modificata quindi non rappresenta più la realtà così com’è -> si toglie
credito per cui alla rappresentazione naturalistica/alla foto
2. Sociologica: con l’immagine digitale sono cambiate le pratiche, gli usi, le funzioni
dell’immagine ma anche i ruoli (prima produttore e consumatore, ora prosumer) e i
contesti (immagine conquista tutta i contesti e li cambia di carattere/funzione-> ex
specchio del bagno pubblico)
3. Estetica: queste immagini mettono in discussione fondamenti dell’estetica come
l’originalità, l’autorialità, la creatività, la fruizione
Cap. 5 del libro “La furia delle immagini” Fontcuberta
-l’irruzione del digitale non interessa F. per le questioni ontologiche ma per quelle degli usi. Da un
lato siamo bombardati di immagini, c’è un enorme quantità di essere e siamo giunti ad una
saturazione -> ciò porta ad una massificazione, poiché le singole immagini si perdono in questo
oceano di immagini -> possiamo chiamarlo “inquinamento iconico”: ovvero esse sembrano non
servire più a qualcosa; dall’altro lato l’immagine cessa di essere appannaggio di professionisti o
privilegiati, e diventa una forma naturale di relazione con gli altri. Urgenza di scattare foto prevale
sulle questioni tecniche ed estetiche: non conta se la foto è ben fatta ma deve rappresentare
qualcosa di unico.
-Nel cap. 4 del libro “La furia delle immagini” Fontcuberta: dialettica tra due parole: ECCESSO (che comporta
sottrazione, svuotamento, appiattimento) e ACCESSO (immagine fatta in funzione
dell’accesso/della disponibilità. Le immagini sono fatte per essere trasmesse: tutto è legato e tutto
è in continua rielaborazione e trasformazione -> concetto di società liquida e postmoderna + tema
della transitorietà -> foto dura 24h o si cancella subito dopo la visione: ciò viene fatto per il
consumo e non peer essere osservate attentamente)
➢ Internet:
✓ È un archivio totale e unico dove si deposita materiale di ogni genere: è assoluto. Prima di
Internet l’archivio era limitato ad un’area (ex: archivio religioso nei monasteri, letterario
nelle biblioteche...). Ora Internet è infinito.
✓ Sul web possiamo trovare una “vita online” consumabile tramite le immagini poiché noi
consegniamo una parte della nostra vita a Internet
-Post fotografia a proposito dell’arte (ma non solo)
1. post fotografia usa materiali fotografici già esistenti = smaterializzazione dell’autorialità (non so
chi sono gli autori delle immagini che trovo sui social), originalità (in Internet tutti sperimentano
tutto, non c’è qualcosa di più originale), proprietà
[Link] dello statuto dell’opera d’arte: appropriazione (dal modello all’autore, dal consumatore al
produttore)
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
3. L’adozione: l’assegnazione di senso ma anche smaterializzazione dei contenuti che diventano
fluidi e rompono i canali tradizionali
4. Estetica dell’acceso: cosa + importante per Fontcuberta è che l’arte rende tutto accessibili a tutti.
F. è un’ottimista, crede molto negli aspetti liberatori e positivi: uso liberatorio e democratico della
fotografia
- Penelope Umbrico, Suns from Flickr, 2006: opera formata dalla selezione e dal taglio di varie foto
trovate su internet che raffigurano un tramonto. Gli aspetti di contemplazione al cielo/tramonto
sono esauriti
-Joachim Schmidt, Others people photographs, 2010: foto dei cibi trovate su internet
-Kurt Caviezel, Animals, 2012: animali sono sul vetro e si presentano come se fossero sulla
superficie che divide noi dal paesaggio. Rappresenta la tendenza che abbiamo a fotografare insetti
quando li vediamo sui vetri delle nostre case. Idea che gli insetti occupino lo spazio di passaggio/la
soglia
-Dina Kelberman, I’m Google, 2011: volontà di possedere tutto quando e di fotografare tutto
quanto. Io sono Google perché tutte queste immagini sono prese da Google
-Felix Hayes e Benjamin West, Google, volume 1, 2014: idea di costruire un dizionario in cui sono
state messe le foto trovate su Google che corrispondono alle parole. Dizionario fatto da foto e non
parole
-Juan del Junco, El sueno del ornitologo, 2008: idea della classificazione degli uccelli: J. Fotografa
uccelli in un museo spagnolo e poi li estrae dal loro contesto. Problema della classificazione è un
problema del giorno d’oggi, delle generazioni di oggi. Idea di archivio
-Daniel Mayrit, you haven’t seen their faces, 2015: face degli uomini potenti della city inglese
-Joan Fontcuberta, Googlegramma: Ozono, 2006: un’unica grande immagine fatta di immagini: qui
l’immagine grande forma la visione del buco dell’ozono dai satelliti
-Alessandro Calabrese, A Failed Entertainment, 2016: immagini una sopra l’altra, idea originale
perché di solito immagini sono accostate
-Roberto Pellegrinuzzi, Memoires,2015: macchine fotografiche digitali più diffuse sono progettate
per realizzare un det. n^ di immagini. P. ha scattato, durante la sua vita, tutte le foto che il
dispositivo permetteva di fare durante la sua vita: quest’opera contiene tutta la sua vita e tutta la
vita della macchina fotografica.
-After Face00k, In loving memority, 2015: installazione di tutti i profili Facebook che sono stati
abbandonati, che sono quindi morti
-Max Dean, as yet untitled, 1992-95: macchina ha un braccio meccanico che tiene una fotografia e
lo spettatore ha la facoltà di scegliere se conservarla o distruggerla.
David Fathi, wolfgang, 2016: selezionare le immagini per costruire un racconto: artista ha preso le
immagini e la ha montate selezionando solo alcuni aspetti
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
-Agnes Geoffray: operazione opposta a quella della censura -> ha ridato vita a ciò che era stato
cancellato: questa è una foto storica di una donna che era stata umiliata e spogliata: Geoffray le
rimette il vestito. Altro esempio: Geoffray restituisce ad un uomo il naso dopo che l’aveva perso in
un incidente
➢ Google Earth nasce nel 2001: alcuni artisti sono andati a cercare i malfunzionamenti, ovvero
dove il dispositivo si è inceppato (ex aerei con loro ombre sul paesaggio).
-Joachim Schmid, O campo, 2010: ha trovato tutti i capi da calcio deformi
-Mishka Henner, Dutch Landscapes, 2011: parti del paesaggio che sono state censurate. Ci sono due
tipi di immagini che sono l’una dentro l’altra: i pixel censurati che sono l’immagine astratta, e la
foto della realtà vera
-Deformazioni di Google Earth: strade, ponti…
➢ Google Steet View, 2007:
-John Rafman, Nine eyes, 2009: cerca nelle periferie immagini insolite: ha trovato una tigre che
stava passando sulla strada. Altro esempio: immagini con persone con maschere sulla strada o
bambina seduta in mezzo alla strada. Rottura dell’idea di spazio e di tempo che abbiamo -> foto in
cui un signore è stato fotografato due volte sullo stesso marciapiede mentre camminava, una volta
più avanti e una più indietro
-Mishka Henner, No man’s land, 2011: fotografa prostitute in luoghi abbandonati dove non c’ è
nessuno, che erano pronte ad esercitare il loro lavoro.
Obiettivo di questi lavori: vedere dove mal funziona il dispositivo -> anche la popolazione fa parte
del mondo, la realtà non è solo come questi dispositivi ci vogliono dimostrare
-Michael Wolf, a series of unfortunate events, 2010: riportare eventi in modo del tutto causale:
stava passando con la macchina e vede una signora in terra caduta, altri sono stati investiti da
automobili, o uno fa il dito medio dal finestrino
-Jeans Sundheim, 100100 views of Mount Fuji, 2009: rifacimento di progetti artisti famosi
attraverso immagini trovate in Internet -> quest’opera fa riferimento a quella di Katsushika Hokusai,
36 vedute del monte Fuji, 1826
-Thomas Ruff, jpeg, 2008: prende le immagini, le ingrandisce e fa vedere veramente com’è fatta
l’immagine, ovvero di pixel (ex: Torre gemelle, lago)
SORVEGLIANZA
cap. 12 del libro “La furia delle immagini” Fontcuberta
-usare dispostivi fotografici già esistenti
-rovesciare la sorveglianza-> tentativo di cercare una forma di ribellione
-Aran Bartholl, 14 seconds of fame, 2009: singor Bartholl vede passare questa macchina e la
rincorre salutandola + posta questa foto in Internet
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
-Jeff Guess, Fonce Alphonse, 1993: hanno mantenuto gli abiti del matrimonio e andando in strada
hanno fatto scattare l’autovelox-> autovelox è lo strumento della società del controllo, serve per
identificare le persone. In questa foto autovelox cattura un momento importante. Due stati
contrapposti: Stato dell’identità (normalità) e stato della trasformazione/cambiamento (giorno del
matrimonio)
-Remi Gaillard, foto di matrimonio con autovelox, 2015: usano l’autovelox per scattare la foto agli
sposi, quando passa una macchina girano autovelox verso gli sposi
-Jens Sundheim e Bernhard Reuss, taken into police custody, 2002: ha scelto di andare in posti
videosorvegliati dove interviene la polizia di fronte ad un comportamento anomalo.
-Manu Luksch, faceless, 2007: A Londra questa signora si sentiva continuamente sorvegliata, decide
di fare un progetto: andare in giro, essere ripresa dalle fotocamere per farsi dare i filmati e coprire
le facce delle altre persone -> gioco tra rappresentazione della realtà ed astrazione
FOTO-VUDU’
cap. 15 del libro “La furia delle immagini” Fontcuberta
-pratica vudù: (vudù =fare pupazzetti della persona con cui ci si vuole vendicare). È l’evocazione
della realtà nella sua rappresentazione oggettuale (In inglese picture: è l’immagine-cosa VS image
che è l’immagine senza materialità)
-Album fotografico è spartito ed è stato sostituito da nuove forme di registrazione biografica
(Facebook) -> senza la sua condizione di oggetto fisico l’immagine perde il suo carattere magico e
smette di agire come un talismano/una reliquia: nella dimensione della memoria, del ricordo e
dell’archivio le foto diventano gesti di comunicazione e non fanno più da supporto al ricordo
-Maneul Sendon, a memoria di album, 2004: mostra le fotografie sparite dagli album fotografici: o
sono spartite o qualcuno le ha tolte volontariamente. Vudù: io faccio qualcosa contro una persona
che mi da fastidio
-Isabelle Le Minh, re-play, 2009: mostra il retro delle fotografie -> vediamo commenti, storie, date +
la diversa gradazione del retro delle foto (alcune più chiare, altre più giallognole) è dovuta
all’invecchiamento della carta.
-Pratica personale di cancellazione delle persone con cui non abbiamo rapporto/con cui abbiamo
litigato -> fotografie dove queste persone non hanno la faccia, è stato staccato un pezzo di foto o
cancellato il volto con la penna (ex Inaki Bonillas, Martin-Lunas, archivio J.R. Plaza, 2004-12)
Fontcuberta dice che il post fotografo (ma in fondo anche il fotografo, l’artista) è colui che
attribuisce un senso a ciò che non lo aveva oppure evidenzia un senso in particolare. In conclusione
la domanda che si pone F. è “ma perché conservarle queste foto, una volta consumato il vudù?”
All’inizio sono stati atti di rabbia, di giustizia e di castigò, ma dopo sopravvivono come tracce del
torto subito, perché non si dimentichi: è come dire “questo è il mio dolore e voglio che venga
riconosciuto” -> dimensione della memoria
Beatrice Arrigoni Anno Scolastico 2019-2020
Potrebbero piacerti anche
- Introduzione Alla Cultura VisualeNessuna valutazione finoraIntroduzione Alla Cultura Visuale13 pagine
- La Nascita Della Fotografia e La Sua InfluenzaNessuna valutazione finoraLa Nascita Della Fotografia e La Sua Influenza13 pagine
- Scalabroni Semiotica Della FotografiaNessuna valutazione finoraScalabroni Semiotica Della Fotografia0 pagine
- Arte Del 1900. Modernismo Antimodernismo PostmodernismoNessuna valutazione finoraArte Del 1900. Modernismo Antimodernismo Postmodernismo61 pagine
- Piccola Storia Della Fotografia B. W.Nessuna valutazione finoraPiccola Storia Della Fotografia B. W.24 pagine
- Fotografia: Illusione o Rivelazione?Nessuna valutazione finoraFotografia: Illusione o Rivelazione?2 pagine
- Agamben, Giorgio - Il Cinema Di Guy DebordNessuna valutazione finoraAgamben, Giorgio - Il Cinema Di Guy Debord5 pagine
- Franco Vaccari. Fotografia e Inconscio TNessuna valutazione finoraFranco Vaccari. Fotografia e Inconscio T8 pagine
- Storia Dei Manifesti PubblicitariNessuna valutazione finoraStoria Dei Manifesti Pubblicitari5 pagine
- Fotografia - Medium Come Forma MentisNessuna valutazione finoraFotografia - Medium Come Forma Mentis37 pagine
- La Macchina Che Vede. L'Automazione Della Percezione - Paul Virilio - Immaginari, 1989 - SugarCo - 9788879904032 - Anna's ArchiveNessuna valutazione finoraLa Macchina Che Vede. L'Automazione Della Percezione - Paul Virilio - Immaginari, 1989 - SugarCo - 9788879904032 - Anna's Archive198 pagine
- Arte Del XX Secolo Riassunto LibroNessuna valutazione finoraArte Del XX Secolo Riassunto Libro39 pagine
- Postmodernismo: Modernismo AntimodernismoNessuna valutazione finoraPostmodernismo: Modernismo Antimodernismo900 pagine
- A Che Cosa Serve L'arte - Hans Ulrich ObristNessuna valutazione finoraA Che Cosa Serve L'arte - Hans Ulrich Obrist6 pagine
- Raccolta Fotografica Della Brera Degli Anni '50-'60Nessuna valutazione finoraRaccolta Fotografica Della Brera Degli Anni '50-'60105 pagine
- La Comunicazione Visiva - Identita - Politica - Consumo Giorgia Aiello Katy ParryNessuna valutazione finoraLa Comunicazione Visiva - Identita - Politica - Consumo Giorgia Aiello Katy Parry485 pagine
- La Furia Delle Immagini Note Sulla PostfotografiaNessuna valutazione finoraLa Furia Delle Immagini Note Sulla Postfotografia23 pagine
- J. Rancière - Il Destino Delle ImmaginiNessuna valutazione finoraJ. Rancière - Il Destino Delle Immagini100 pagine
- La Fotografia Intima, Tra Pubblico e Privato.Nessuna valutazione finoraLa Fotografia Intima, Tra Pubblico e Privato.15 pagine
- Affinare Lo Sguardo. Riflessioni Sulla Fotografia Di Guido Guidi100% (2)Affinare Lo Sguardo. Riflessioni Sulla Fotografia Di Guido Guidi27 pagine
- Architettura Della Prima Eta' Della MacchinaNessuna valutazione finoraArchitettura Della Prima Eta' Della Macchina10 pagine
- L'economia Della Cultura - Benhamou PDFNessuna valutazione finoraL'economia Della Cultura - Benhamou PDF14 pagine
- Spazi Metafisici Di Giorgio de ChiricoNessuna valutazione finoraSpazi Metafisici Di Giorgio de Chirico8 pagine
- Postproduction. Come L'arte Riprogramma Il Mondo (Nicolas Bourriaud) - RiassuntoNessuna valutazione finoraPostproduction. Come L'arte Riprogramma Il Mondo (Nicolas Bourriaud) - Riassunto6 pagine
- Forme e Modelli. La Fotografia Come Modo Di Conoscenza PDFNessuna valutazione finoraForme e Modelli. La Fotografia Come Modo Di Conoscenza PDF403 pagine
- Testo#1. Bazin - Ontologia Dell'immagine FotograficaNessuna valutazione finoraTesto#1. Bazin - Ontologia Dell'immagine Fotografica10 pagine
- La Nascita Della Fotografia (Teoria, Storia e Artisti)Nessuna valutazione finoraLa Nascita Della Fotografia (Teoria, Storia e Artisti)16 pagine
- 5 Sardegna Romana (Mara, Padria, Pozzomggiore100% (1)5 Sardegna Romana (Mara, Padria, Pozzomggiore24 pagine