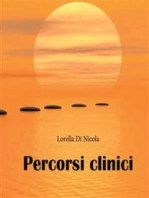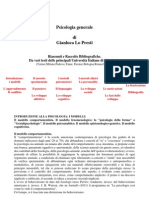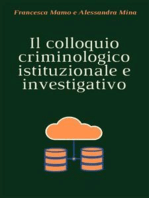Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Riassunto Clinica Aggiornato Al DSM 5
Riassunto Clinica Aggiornato Al DSM 5
Caricato da
Marsi FedericoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Riassunto Clinica Aggiornato Al DSM 5
Riassunto Clinica Aggiornato Al DSM 5
Caricato da
Marsi FedericoCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|9798018
Riassunto clinica Aggiornato AL DSM 5
Scienze e tecniche psicologiche (Università degli Studi di Enna Kore)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
“PSICOLOGIA CLINICA”
EZIO SANAVIO
E
CESARE CORNOLDI
Terza edizione
Aggiornata al DSM-5
Libro blu
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
CAP 1 -NASCITA E AFFERMAZIONE DELLA PSICOLOGIA
CLINICA
- LO PSICOLOGO CLINICO FORNISCE AIUTO IN CONDIZIONI DI SOFFERENZA
E MALATTIA MEDIANTE RICORSO A CONOSCENZE CHE DERIVANO DA VARIE
BRANCHE DELLA PSICOLOGIA-
1. CHE COSA SIGNIFICA “APPROCCIO CLINICO”
Il termine clinica deriva dal greco “klyne” (letto) e indica l’attività che il medico svolge
al letto del malato.
A cosa si riferisce la psicologia clinica.?
La psicologia clinica fa riferimento alla malattia e alla sofferenza e al fatto di dare
aiuto ricorrendo a conoscenze e metodi psicologici.
Finalità dello psicologo clinico è ispirata dall’intenzione di porgere aiuto e
rispondere alla dimensione psicologica di una sofferenza che ha luogo
immediatamente davanti a lui.
Approccio clinico significa centralità dell’osservazione diretta del malato, con un
osservazione prolungata e minuziosa.
Si contrappone alla medicina che faceva diagnosi e terapia per assiomi e sillogismi,
sostituendo l’osservazione con citazioni e rimandi all’autorità dei grandi medici e
filosofi del passato.
L’approccio clinico si avvicina a un approccio idiografico, che mira al singolo nella
sua forma storicamente determinata.
Contrapposta ad un Approccio nomotetico: cerca di scoprire le leggi e conoscere la
natura delle cose.
Un altro tratto costitutivo della Psicologia Clinica e dato dall’approccio: l’ottica del
particolare e l’approfondimento del singolo caso.
2. PSICOLOGIA CLINICA E PSICOLOGIA DI BASE
Che rapporto c’è tra Psicologia clinica e psicologia di base?
Nella cultura italiana sono sempre state rappresentate come due discipline separate,
diverse se non addirittura contrapposte.
Oggi è palese la continuità tra psicologia di base e lavoro clinico. Possiamo descrivere
questo legame come un rapporto senza soluzione di continuità:
La psicologia clinica è una scienza applicata, diretta emanazione e
applicazione delle conoscenze e delle metodologie sviluppate dalla psicologia di
base.
Korchin, scrive sulla Psicologia clinica: scienza-professione che ha il compito di
aiutare le persone bisognose sul piano psicologico e cerca di approfondire la
2
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
conoscenza necessaria per offrire un aiuto in futuro. I clinici sono diversi dai colleghi
psicologi perché hanno un modo diverso di pensare, il cosiddetto atteggiamento
clinico.
QUINDI: La psicologia clinica è empirica
Mentre quella di base è teorica
3. DEFINIZIONI
Gli Psicologi clinici - studiano e si occupano specificatamente di disturbi mentali. E
in alcuni casi svolgono la loro professione all’interno di servizi e strutture di salute
mentale.
DEFINIZIONE DI PSICOLOGIA CLINICA
Una delle prime definizioni di psicologia clinica risale al 1919 ad opera
dell'American Psychological Association (la più antica associazione di psicologi):
La psicologia clinica integra scienza, teoria e pratica al fine di:
• Capire, predire e alleviare disadattamento, disabilità e disagio
• Promuovere adattamento umano e sviluppo personale.
Essa si concentra sugli aspetti:
- Sociali
- Psicologici,
- Emotivi,
- Biologici,
- Intellettivi e comportamentali del funzionamento umano lungo tutto l’arco della vita
nelle varie culture e a tutti i livelli socio-economici.
La DEFINIZIONE del Collegio dei professori universitari e dei ricercatori di
Psicologia clinica delle Università italiane:
La psicologia clinica è un settore della psicologia i cui obiettivi sono:
• Spiegazione,
• Comprensione,
• Interpretazione
• Riorganizzazione dei processi mentali disfunzionali o patologici, individuali e
interpersonali, unitamente ai loro correlati comportamentali e psicobiologici.
La Psicologia clinica è identificabile con le metodiche volte alla:
Consulenza
Diagnosi
Terapia con interventi sulla struttura individuale o di gruppo, nei suoi aspetti
problematici o di sofferenza.
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Essa è inoltre finalizzata ad interventi atti a promuovere le condizioni di benessere
psico-fisico, nelle diverse situazioni cliniche e ambientali.
La psicologia clinica si articola nelle seguenti componenti:
• Psicodiagnostica,
• Psicopatologia,
• Psicoterapia –che è l’ambito evolutivo che più caratterizza la psicologia clinica,
punto di massima convergenza tra domanda, conoscenze psicologiche, fenomeni
indagati e metodi utilizzabili. Le finalità della Psicoterapia possono risultare
differenti ma non è quella di rendere la persona <<normale>>.
Si aggiungono come prospettive emergenti: psicologia della salute, riabilitazione e la
consulenza oggi detto counselling.
La parola Adattamento ricorre poco nel linguaggio dello psicologo clinico e
molto nel linguaggio comune. Questo crea il pericolo di considerare l’adattamento
come un obiettivo doveroso. Rischiando di confondere la salute mentale con il
conformismo. Lo stesso Korchin afferma che se da un lato il disturbo psichico è in
contrasto con le norme sociali, a sua volta una forte aderenze alle norme può
indicare uno stato patologico.
Lo psicologo clinico lavora con l’obiettivo di aiutare il suo cliente o paziente a
esprimere se stesso e a trovare il suo equilibrio.
4. TAPPE DI UN PERCORSO
1875 – Wund fonda a Lipsia il primo laboratorio di psicologia, segnando la sua
nascita.
1880 – Charcot, direttore della Salpetriere di Parigi, ottiene il riconoscimento ufficiale
dell’IPNOSI come legittimo trattamento medico in psichiatria.
1881 – Freud si laurea in Medicina all’università di Vienna.
1883 – Kraepelin pubblica il suo manuale grazie al quale sarà considerato “il padre
della psichiatria”.
1889 – Binet si occupa di misurare lo sviluppo intellettivo.
1890 – Cattell conia l’espressione mental test e promuove la creazione di test
mentali.
1892 – viene fondata l’American Psycological Association.
1897 – Sante de Sanctis, medico dell’università di Roma fonda la “Rivista quindicinal
di psicologia, psichiatria e psiconevrosi.
1904 – E’ approvata in Italia la legge 36 del 1904
4
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
La psicologia clinica nasce tra l’800 e il ‘900(in Europa,più precisamente in Francia e
in Germania,ma si sviluppa soprattutto negli Stati Uniti) dalla confluenza di 2
tradizioni e professioni:
1. Pratica dei reattivi mentali per la valutazione dei bambini con deficit
intellettivi,
2. Pratica dell’ipnosi nel trattamento dell’isteria.
Nonostante le matrici culturali siano europee( Binet, Janet, Freud, Jung),la psicologia
clinica ha avuto il suo maggiore sviluppo negli Stati Uniti per via dell'antisemitismo
nazista e perché la società era caratterizzata da un forte dinamismo economico e
sociale.
I momenti di maggiore espansione per tale disciplina furono:
- Durante i 2 conflitti mondiali, quando collaborò, con test attitudinale e mentali,
alla selezione dei militari e al reinserimento dei reduci di guerra.
- Nel primo dopoguerra,soprattutto negli Stati Uniti,troviamo un'equipè per i servizi
socio sanitari per l'infanzia.
-Nel secondo dopoguerra,troviamo equipè per i servizi negli ospedali
psichiatrici,anche in Italia.
Date rilevanti:
1875: nascita della psicologia - Wund fonda a Lipsia il primo laboratorio di
psicologia;
1896: nascita della psicologia clinica - Witmer istituisce la prima clinica
psicologica per studiare deficit ed incapacità mentali.
1952: l’APA mette a punto il DSM-I Diagnostic and Statistical Manual - classificazione
internazionale delle malattie mentali.
1978: in Italia la legge n. 180 “Legge Basaglia” vieta i ricoveri in ospedali psichiatrici
e dispone la chiusura di quelli esistenti.
1989: viene riconosciuta la professione di psicologo attraverso una legge.
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Capitolo 2 – PSICODIAGNOSTICA
- nella pratica clinica l’esame Psicodiagnostico è a volte il primo passo di un
percorso di sostegno e altre volte è un momento specialistico che richiede
competenze psicodiagnostiche.
1. ESAME PSICODIAGNOSTICO
Negli anni 50, lo psicologo Murray, espresse una formula per identificare ogni uomo,
che è sotto certi aspetti:
1. Come tutti gli altri uomini;
2. Come alcuni altri uomini;
3. Come nessun altro uomo.
L’ottica dello psicologo clinico è l’ottica del particolare, dove le classificazioni
personologiche, psicopatologiche e nosografiche non sono mai un punto di arrivo.
Ma in effetti le diagnosi di disturbo mentale sono punti di riferimento utili.
L'esame psicodiagnostico è un percorso di sostegno psicologico e di counseling, è
anche un momento altamente specialistico e richiede competenze e tecniche
psicodiagnostiche.
L'esame psicodiagnostico può essere descritto come:
• Processo di raccolta, analisi ed elaborazione di informazioni.
• Processo attivo simile al problem solving e decision making: un processo di
raccolta e di elaborazione di informazioni relative al soggetto in questione.
• Struttura formale - costituita da una successione sistematica e organizzata di
approfondimenti e analisi del singolo caso e delle sue peculiarità.
Lo psicologo durante tutta la durata dell’ assessment iniziale opera intelligentemente
per raccogliere informazioni, generando ipotesi che riguardano il caso in esame
attraverso l’uso delle sue conoscenze relative a leggi e principi delle scienze
psicologiche.
OBIETTIVO - acquisizione di una conoscenza approfondita del soggetto lungo
molteplici dimensioni psicologicamente rilevanti.
Durante l’assessment iniziale lo psicologo genera ipotesi e prende decisioni che
saranno tanto più varie a seconda dell’ampiezza della base di conoscenza della
ricerca scientifica ed esperienza dello psicologo.
L’esame psicodiagnostico è qualcosa che va oltre il semplice riconoscimento
diagnostico di un disturbo mentale. Esso è più di una diagnosi. Esso opera nell’ottica
dell’ approfondimento e dell’analisi e del singolo caso. Di conseguenza da una
valutazione iniziale del disturbo, che costituisce un tassello fondamentale, non è la
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
parte finale del percorso ma una componente importante da includere in una più
ampia diagnosi.
-Tecniche della psicodiagnostica:
-colloquio clinico,
-Assessment psicofisiologico,
-osservazione,
-interviste strutturate ,
-test psicodiagnostici autovalutativi,
-tecniche proiettive,
-test d'intelligenza,
-valutazione cognitiva e neuropsicologica.
1. COLLOQUIO CLINICO
E’ l’asse portante dell’esame psicodiagnostico che ha come finalità l’esame del
problema che porta il paziente a rivolgersi ad uno psicologo clinico,va al di là del
semplice ascolto empatico,è un processo di ricerca attiva e intelligente delle
coordinate che danno un senso psicologico a quanto il paziente propone.
Caratteristiche - Il colloquio clinico utilizza:
-sistema cognitivo-verbale: ciò che il paziente pensa e dice di sé.
-rappresenta un setting di osservazione specifico e strutturato,lo psicologo
osserva il comportamento del paziente in una data situazione(postura, mimica, ect.).
-costituisce un esempio di comportamento interpersonale significativo,consente
l'analisi delle variabili di relazione che si stabiliscono nell'interazione tra paziente e
psicologo.
FINALITÀ – il colloquio ha come finalità:
1.Esame del problema del paziente
2.Stabilire una relazione di fiducia e collaborazione nella diade paziente e
psicologo.
Il primo colloquio clinico prende avvio con alcune formalità:
- Fase dei preliminari, convenevoli sociali
- Apertura, dove viene posta la domanda “di che problema parliamo?”
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
1) FASE DEL PROBLEMA INIZIALE,lo psicologo cerca di ottenere una precisa
descrizione del problema. L’attenzione è sul presente.
2) -ANALISI DELLE VARIABILI, Il colloquio tenderà ad individuare variabili che
influenzano aspetti del problema in esame
3) STORIA DEL PROBLEMA, il colloquio risalirà al primo insorgere del problema e
lo ripercorrerà nel tempo fino al momento attuale.
4) ALLARGAMENTO, lo psicologo allargherà l’esame agli ulteriori problemi
presenti attualmente, al di là di quello proposto inizialmente.
5) FASE DEL PROFILO COMPLESSIVO, storia personale, in questa parte del
colloquio vengono messi tra parentesi gli elementi problematici o patologici
,per ripercorrere la storia della persona nei suoi elementi e nei suoi
avvenimenti.
6) -ANALISI DELLE ASPETTATIVE, nelle fasi conclusive il colloquio tornerà su
quanto il paziente si aspetta dallo psicologo clinico e dall’ esame
psicodiagnostico in corso.
Il colloquio clinico che conclude l’esame psicodiagnostico,non è più volto a raccogliere
le informazioni,ma a darle,lo psicologo spiega nel modo più semplice quanto l’ esame
psicodiagnostico ha messo in luce.
IL MODELLO MULTIDIMENSIONALE
Per condurre l’esame psicodiagnostico lo psicologo può utilizzare molte
informazioni,queste informazioni sono state classificate in “classi”, a seconda del
canale dal quale provengono.
Ne distinguiamo tre:
1. Informazioni provenienti da un canale verbale – consistono in tutto ciò che il
paziente dice nel corso del colloquio clinico( intervista strutturata, tavole di
Rorscharch), queste informazioni non sono neutre ma soggette a numerose variabili
legate al contesto entro il quale vengono raccolte.
2. Informazioni che provengono da un’osservazione diretta del comportamento
della persona, sono informazioni offerte dal comportamento non verbale nel corso
di un colloquio clinico( role playing, interazione con il coniuge, osservazioni su
campo).
3. sono le informazioni che lo psicologo può raccogliere attraverso le Registrazioni
strumentali dell’attivazione psicofisiologica dell’individuo - risposte
elettrodermiche, attività elettromiografica, temperatura periferica cutanea,
frequenza cardiaca, respiratoria e attività cerebrale.
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
La psicologia ha utilizzato questi tre canali sia nella pratica psicodiagnostica sia nella
ricerca clinica. Ma le misure relative all’uno o all’altro canale non sono
intercambiabili tra loro, esse vanno considerate come valutazioni di dimensioni tra
loro connesse ma relativamente indipendenti.
Obiettivo -Una “valutazione multidimensionale” cerca di integrare informazioni e
misurazioni provenienti da diversi piani( delle emozioni, delle relazioni, della
memoria, ecc).
L’esame psicodiagnostico utilizza una pluralità di tecniche, tra queste iniziamo da
quelle psicofisiologiche.
2. ASSESSMENT PSICOFISIOLOGICO
Esso è deputato alla valutazione delle specifiche modalità di risposte psicofisiologiche
della persona in esame. Tali valutazioni si riferiscono a una condizione di
riposo(valutazioni basali). Ma ci interessa, in questo caso valutare uno stato di
attivazione del soggetto, caratterizzato da modificazioni stabili e durature nel tempo.
Lo psicologo registra in forma continua,per un certo periodo di tempo(da 20 a 45
min.)una serie di indici psicofisiologici,i più comuni sono ad esempio: frequenza
cardiaca,respiratoria,pressione.
L’ assessment psicofisiologico indaga l’attività elettrica celebrale e si avvale delle
moderne tecniche di neuroimaging.
Una parte significativa dell’assessment psicofisiologico deriva dal LIE
DIRECTOR(rilevatore di bugie)cioè la macchina della verità che è capace di
evidenziare alterazioni fisiologiche associate alla produzione di risposte non veritiere
Una volta analizzata la linea di base, ci interessa valutare una reazione di attivazione
(fasica);lo psicologo intende confrontare il livello di attivazione a riposo con il livello
di attivazione in presenza di condizioni-stimolo, che inducono stress, forti emozioni,si
parlerà allora di profilo psicofisiologico importante nella valutazione del
rilassamento, che è obiettivo di molti training svolti dai clinici.
FASI
1. Analisi della linea di base (condizione di riposo)
2. Valutazione della reazione di attivazione (fasica);
3. Confronto del livello di attivazione a riposo con quello in presenza di condizioni-
stimolo specifiche.
4. Redazione del profilo psicofisiologico.
Spesso si rilevano correlazioni molto basse tra autovalutazione soggettiva e
rilevazioni psicofisiologiche e questo può essere causato da alessitimia, - incapacità
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
a riconoscere e verbalizzare il mondo delle emozioni; favorirebbe l’insorgenza di
malattie psicosomatiche.
3. OSSERVAZIONE
L’esame Psicodiagnostico può
acquisire campioni diretti del
comportamento in esame. Ciò è
possibile attravesro
l’osservazione che AIUTA NELLA
RACCOLTA DI CAMPIONI DI
COMPORTAMENTO. Essa può
essere:
- Osservazione naturalistica
- ha luogo nell’ambiente
naturale dove si può verificare
spontaneamente il
comportamento preso in
esame(ESEMPIO disturbi alimentari). Utile sarebbe seguire il paziente a casa o a
scuola, o nei luoghi in cui avviene il comportamento in esame. Ma queste situazioni
non sono immuni da artificialità. Ecco perché si parla di:
1. Reattività di comportamento –essa è il cambiamento di comportamento per il
fatto di sapere di essere osservati. Essa va scemando con il protrarsi del “periodo di
osservazione”.
Osservare e registrare il comportamento manifesto può sembrare semplice ma in
realtà essa richiede un grado di elaborazione concettuale non inferiore alle altre
tecniche psicodiagnostiche. Ad aiutare lo psicologo abbiamo le griglie ex novo. Come
la tabella qui accanto, la TIMED BEHAVIORAL CHECKLIST FOR PERFORMANCE
ANXIETY, messa a punto da Paul nel 1966 per la valutazione dell’ansia del parlare in
pubblico.
- Automonitoraggio - tecnica intermedia tra valutazione soggettiva e osservazione.
Anche l’automonitoraggio è soggetto ad effetti di reattività, infatti il solo fatto di
tenere l’automonitoraggio di un comportamento indesiderato porta ad una sua
piccola riduzione. È una procedura vicina all’osservazione. Utilizzata nei casi in cui
non sia possibile l’osservazione da parte di altre persone. Si chiede al paziente di
registrare il comportamento avvenuto; procedura di elezione per eventi interni come
impulsi, emozioni e pensieri.
10
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
4. INTERVISTE STRUTTURATE
La diagnosi è un processo decisionale complesso, legato al funzionamento mentale di
chi la effettua. È stato riscontrato le diagnosi possono essere influenzate da
distorsioni del pensiero degli stessi psicologi.
I BIAS(baias) DEL VALUTATORE sono tutte quelle condizioni che si mettono in atto
durante la somministrazione del test e non permettono di avere una diagnosi
neutrale. Essi sono:
-la propensione ad ancorare l’intero processo valutativo a specifiche informazioni,
-la tendenza a cercare conferme per l’ipotesi formulata ,
-la tendenza a farsi influenzare da fattori contestuali o dalla storia del paziente.
Le INTEVISTE STRUTTURATE SI COLLOCANO TRA L’OSSERVAZIONE DIRETTA E L’AUTOVALUTAZIONE
SOGGETTIVA. Si snodano in maniera simile al colloquio cinico, ma sono molto meno
libere. Tecnica standardizzata dalla quale un differente intervistatore ottenga le
medesime risposte.
Si compone di domande prefissate che vengono poste seguendo un ordine
ben preciso e prestabilito. Le differenze dal colloquio clinico:
Esse Indagano un costrutto specifico e ne attribuiscono un punteggio o una
classificazione.(diversamente dal colloquio clinico).
Sono state ideate al fine di ridurre gli errori diagnostici.
ESEMPI DI INTERVISTE:
1. AAI Adult attachment interview,fu sviluppata da GEORGE,KAPLAN E
MAIN,allo scopo di classificare lo stile di attaccamento in età superiore ai 16
anni,si tratta di un’intervista semistrutturata che richiede circa un’ora,consiste
in 18 domande aperte che indagano sull’esperienza del soggetto con le
principali figure di riferimento dell’infanzia,chiede di ripensare alle situazioni
di difficoltà dove la presenza del genitore è fondamentale,e si sofferma su
eventuali esperienze di separazione,rifiuto,maltrattamento e lutto vissute
nell’infanzia.
Le risposte vengono audio registrate e video registrate e in seguito trascritte
integralmente. Le operazioni di codifica sono ispirate allo stile narrativo
dell’intervistato e valuta come l’adulto concettualizza oggi i legami di
attaccamento. Il sistema di classificazione si conclude con l’assegnazione ad
una categoria principale dello stile di attaccamento.
2. SS Strange Situation.
Nel 1978 MaryAinsworth crea la Strange Situation Procedure
Procedura osservativa standardizzata, naturalistica ed affidabile, creata per
misurare e quantificare le differenze individuali nella qualità delle relazioni
11
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
d’attaccamento madre-‐bambino. La S.S. riflette lo stretto rapporto esistente
tra la responsività sensibile della madre e lo stile di attaccamento infantile del
bambino dipendente dalla modalità differenti di accedere alle informazioni
dovute alla sicurezza.
Essa costituisce la procedura elettiva di assessment dell’attaccamento nella
prima infanzia. È una osservazione strutturata per bambini tra i 12 e i 18
mesi,durante la quale il bambino vive una situazione di stress,in quanto si trova
in un ambiente non familiare,in presenza di un estraneo(UNO DEI
RICERCATORI)e vive2 separazioni di 3 minuti dal caregiver seguite dal
ricongiungimento.
Si giunge ad una classificazione sulla base di tre categorie principali di
Attaccamento Organizzato:
-Attaccamento sicuro: libero di esplorare i propri sentimenti e pensieri, e
presenta un quadro di consapevolezza sia rispetto alla realtà sia ai significati
ad essa attribuiti;
-ATTACCAMENTO DISTANZIANTE, svalutazione delle situazioni di
attaccamento o mancanza di ricordi specifici delle esperienze con la figura di
attaccamento. Qui l’individuo manifesta un tentativo attivo di limitare
l’influenza delle relazioni rispetto alla vita attuale;
-ATTACAMENTO PREOCCUPATO, l’individuo offre un quadro confuso che mostri
un invischiamento attivamente disturbante con coinvolgimento attuale nelle
passate relazioni di attaccamento di tipo passivo o conflittuale.
- ATTACCAMENTO CON LUTTI, mancata risoluzione di lutti o traumi;
-ATTACCAMENTO INCLASSIFICABILE, la sovrapposizione degli aspetti non
consenta una classificazione.
L’INTERVISTA STRUTTURATA è la più celebre intervista della storia della psicologia,
ed è possibile indicarla con il nome di Type A coronary prone behavior structured
interview, è stata introdotta da due cardiologi ROSENMAN e FRIEDMAN,è
un’intervista provocativa, tesa a far emergere nel paziente reazioni di irritazione e
ostilità. L’attenzione è volta sia al contenuto delle risposte ma anche al
all’osservazione del comportamento dell’intervistato, che è videoregistrato. Il
costrutto indagato è detto TIPO A. esso è messo a punto attraverso l’esame di un vasto
campione di individui sani, studiandone le possibili ricadute cardiovascolari subite nel
tempo. Alcuni soggetti andava in contro a un maggior rischio ed erano quelli stessi
che in passato avevano riscontrato un particolare pattern di risposte, detto appunto
TIPO A. Con il TIPO B si connotano gli individui sani.
12
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Nonostante siano utilizzate in strutture di altissima specializzazione, c’è ne una, che
fa eccezione in ambito psichiatrico, cioè l’intervista clinica strutturata per il DSM-5
La SCID Structured Clinical Interview For The DSM IV,intervista molto diffusa in
ambito psicologico e psichiatrico,è un intervista di carattere diagnostico che fa
riferimento al sistema di diagnosi delle malattie mentali DSM.
Si tratta di un flow-chart diagnostico, dove l’intervistatore utilizza moduli
diversi a seconda del paziente che ha davanti e a secondo delle risposte iniziali.
Ciascun modulo prevede una serie di domande che vanno poste al paziente
quasi alla lettera e che riflettono criteri diagnostici che riguardano questo o
quel disturbo,in base alle risposte del paziente l’esaminatore deve registrare se
quella caratteristica è presente o meno.
La durata è variabile ma è consigliabile dividerla in 2 sedute
-la prima parte dura 45-90 minuti e contempla moduli di disturbi detti di asse I
-La II parte dura 40-60 min. e riguarda i disturbi della personalità
il CFI Camberwell Family Interview ,che misura l’impatto emotivo che la
personalità del paziente e la sua malattia hanno sui familiari. Esamina solo
l’emotività esplicita del familiare. Intervista standardizzata , ma lascia l’intervistatore
libero di assecondare il corso delle risposte dell’intervistato. Le interviste sono
videoregistrate. La valutazione è condotta sia dall’intervistatore, sia da uno psicologo
abilitato. Da studi si evince una stretta correlazione tra alto livello di emotività
espressa familiare e la probabilità di recidive da parte dei soggetti malati.
La Y-BOCS Yale Brown Obsessive Compulsive Scale, è un’intervista
semistrutturata sviluppata dai ricercatori di Yale. È riferita ai criteri diagnostici del
disturbo ossessivo compulsivo. È una valutazione di parametri formali di ossessione e
convulsione indipendentemente dal loro contenuto e dalla loro numerosità. Utilizzata
in psicofarmacologia.
La Kiddie-SADS(6-17 anni), è un intervista che prevede la somministrazione
prima ai genitori e poi ai bambini. Intervista prima introduttiva poi diagnostica
utilizzata in ambito evolutivo. Nell’intervista vengono esplorati gli atteggiamenti del
bambino nei confronti della visita.
5. TEST PSICODIAGNOSTICI AUTOVALUTATIVI
A INTEGRAZIONE DEI COLLOQUI CLINICI SI COOLOCANO I TEST PSICODIAGNOSTICI.
Essi vanno concepiti come approfondimenti successivi.
13
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Si tratta di test di carattere molto generale nelle prime fasi,e più mirato nel corso
delle successive. Da essi emergono ipotesi di allargamento del problema, che possono
aiutare lo psicologo nella messa a fuoco della strategia da usare.
I test vengono integrati con il colloquio clinico e altre procedure nel corso dell'esame
psicodiagnostico.
Questi test potenziano il lavoro di esplorazione che lo psicologo svolge attraverso il
colloquio e permettono di esplorare meglio un costrutto psicodiagnostico.
Questi test sono:
Autovalutativi - si basano sulle risposte che il pz fornisce relativamente ai suoi
comportamenti e alle sue caratteristiche psicologiche.
NELLE FASI INIZIALI DELL’Esame Psicodiagnostico SI UTILIZZANO TEST PSICODIAGNOSTICI
CHE OFFRONO ANALISI “AD AMPIO SPETTRO”:
1.MMPI MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY, esso è un QUESTIONARIO DI
PERSONALITÀ. Ideato negli anni 30 per opera di HATHAWAY e MCKINLEY. L’intento
principale del test era di screening: discriminare tra normalità e psicopatologia.
Presupposto teorico alla base era che le differenti forme psicopatologiche non fossero
altro che la caratterizzazione in grado estremo di caratteristiche personologiche
distribuite nella popolazione. Sono infatti introdotti una serie di item che
permettevano di differenziare la popolazione normale dai soggetti con diagnosi
psichiatriche. Le scale che raccolgono gli items sono dette scale cliniche:
1. ipocondria;
2.depressione;
3.isteria;
4.paranoia.
Alle scale cliniche si aggiungono le scale di controllo che servono a far fronte ad
alcuni problemi. Dal MMPI-II si ricavano molteplici scale supplementari e di
contenuto che indagano aspetti specifici.
La batteria CBA-2.0 COGNITIVE BEHAVIORAL ASSESSMENT, sono una serie di
TECNICHE DI ANALISI DELLE INFO PROVENIENTI DALL ’AUTOREFERTO DEL SOGGETTO. Essa ha
2 fondamentali presupposti. Il primo è detto integrazione orizzontale e il
secondo integrazione verticale. Le scale CBA indagano problematiche di
interesse clinico. Il nucleo della batteria CBA è una particolareggiata cartella
autobiografica che guida il paziente lungo una ricostruzione della storia
personale. Al fine di considerare valido un protocollo CBA bisogna considerare
diversi indici di validità. La batteria CBA ha avuto una diffusione in ambito
ospedaliero. La Forma H(Hospital) è stata sviluppata al di potenziare l’utilizzo
di queste per molteplici problematiche ospedaliere.
• MCMI-III DI MILLON MILLION CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY, è un QUESTIONARIO CHE
VALUTA I DISTURBI DI PERSONALITÀ. Creato da Theodore Millon, psicologo statunitense che
14
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
si è occupata dei disturbi della personalità. il MILLON CLINICAL MULTIAXIAL
INVENTORY è il test per antonomasia dedicato alla valutazione dei disturbi della
personalità. si tratta di un questionario di autosomministrazione formato da 175
items e richiede dai 30 ai 60 minuti per la compilazione. Va ricordato che accanto ai
suoi risultati è importante tenere presente i dati provenienti dall’osservazione diretta,
dal colloquio clinico e dalla storia personale. Il MCMI-III è destinato ad una
popolazione di adulti. Ma Millon ha ideato il MACI( MILLON ADOLESCENT CLINICAL
INVENTORY) utilizzato per l’età adolescenziale.
• STAI STATE TRAIT ANXIETY INVENTORY - misurazione dell’ansia.
Risale a Cattell la distinzione all’interno del costrutto di ansia, tra due accezioni
fondamentalmente diverse:
- L’una riferita a uno stato emotivo di un individuo in un dato
momento/situazione;
- L’altra riferita a una variabile di personalità che può differenziare tra loro
individui diversi.
È con SPIELBERGER che si ha una diffusione internazionale di due denomnazioni
tecniche:
1. Ansia di STATO(Y1): Stato transitorio emozionale, caratterizzato da sentimenti
soggettivi percepiti a livello cosciente di tensione e apprensione.
2. Ansia di TRATTO(Y2): differenze individuali relativamente stabili nella
disposizione verso l’ansia, tendenza a rispondere con elevazioni dell’intensità
dell’ansia di stato a situazioni percepite come minacciose.
Lo STAI consiste di 40 items distribuiti in due scale di 2° items. Una di stato segnata
con Y1 e una di tratto segnata con Y2. Il punteggio su STAI-Y1 si riferisce all’ansia di
stato. E il punteggio su STAI-Y2 si riferisce all’ansia di tratto.
Un'altra distinzione nella valutazione dell’ansia si riferisce a due componenti, quella
dell’attivazione fisiologica e quella dell’attivazione cognitiva, cioè del lavorio della
mente che è invasa da pensieri minacciosi.
Per la MISURAZIONE DELL’ANSIA si utilizza inoltre :
• Il BAI(BECK ANXIETY INVENTORY- sviluppato per riuscire ad individuare items
che producano la minor sovrapposizione con la depressione. Esso propone 21 items
presentati come comuni sintomi d’ansia. Il BACK ANXIETY INVENTORY fa riferimento
alla corrente psicopatologica dell’ansia. Test d’elezione per la valutazione clinica di
pazienti con disturbi d’ansia monitorati per il periodo dell’evoluzione dell’ansia.
Il BDI BECK DEPRESSION INVENTORY- è il test per la depressione per antonomasia.
Scopo del test è la misura dell’intensità della depressione. Permette di monitorare
l’evoluzione dello stato dell’umore nel corso dell’episodio depressivo. L’inventario è
composto da 21 item che indagano, tra questi troviamo: tristezza, pessimismo,
15
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
fallimento, perdita di piacere, senso di colpa, sentimenti di punizione, autostima,
suicidio.
Riscontrare la presenza di uno di depressione non significa che il soggetto debba
essere considerato come affetto da disturbo, poiché la definizione diagnostica di un
paziente non può basarsi su un test, ma su un assessment psicodiagnostico
multidimensionale.
EFFETTO BARNUM( O EFFETTO DI CONVALIDA SOGGETTIVA): I ricercatori si sono interrogati su
come mai sia possibile che venga dato credito ad oroscopi e letture della mano. Le ricerche hanno
dimostrato che viene dato maggior credito se:a)il soggetto crede che l’analisi sia personalizzata; b)l’analisi
elenca principalmente tratti positivi; c)il soggetto in esame attribuisce credibilitaa all’esaminatore. Questo
effetto è noto come <<effetto Barnum>>. P.T.Barnum è stato un uomo di circo di successo. È ricordato per la
sua capacità di attrarre al circo folle di persone mettendo in giro le più grandi fandonie a scopo
pubblicitario. Ecco spiegato il successo dell’astrologia.
16
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
6. TECNICHE PROIETTIVE
Esse Hanno come fondamento teorico l’ipotesi proiettiva: le risposte di un individuo
a stimoli ambigui che gli vengono presentati, riflettono attributi significativamente
stabili della sua personalità. Consistono nella presentazione di stimoli poco strutturati
con la richiesta al soggetto in esame di interpretarli. Qui il materiale funziona da
schermo bianco sul quale il soggetto proietta le sue caratteristiche psicologiche. Qui si
fa così riferimento al ruolo attivo e costruttivo della persona nell’interpretazione della
realtà.
Consistono in valutazioni più complesse di aspetti caratteriali e personologici che
impiegano strumenti che stimolano il paziente a elaborare delle risposte sulla base
delle proprie fantasie e delle proprie convinzioni.
Si preferisce parlare di tecniche proiettive e non di test, perché un test presume una
rigida standardizzazione dei risultati, invece queste tecniche risentono di stati emotivi
temporanei, dando risultati diversi.
La Gestalt e la psicoanalisi hanno fornito un background scientifico di riferimento ai
primi metodi proiettivi (fine dell’800) che consistevano in liste di libera associazione
di parole.
In seguito si svilupparono test proiettivi che hanno riguardato :
- L’interpretazione degli stimoli, ( Z test di Zullinger, il reattivo psicodiagnostico
di Rorscharch)
- produzione di disegni , (il disegno della casa, della famiglia)
- la scelta dei colori, ( come il Test di Luscher, che utilizza come stimoli cartoncini
colorati;)
- la manipolazione e il gioco.
I test proiettivi hanno una certa affidabilità.
La più nota tecnica proiettiva è il Reattivo psicodiagnostico di Rorschach fù elaborata
nel 1921 dallo psichiatra Rorschach. Egli fece esperimenti con molte macchie di
inchiostro in gruppi di pazienti psichiatrici per studiare problemi di percezione. Si
trattava di macchie casuali di inchiostro approssimativamente simmetriche. Alla fine
Rorscharch selezionò 10 tavole: 5 grigie e nere, 2 con tocchi di rosso, 3 con sfumature
di vari colori.
4 FASI DEL TEST
1. Presentazione di ogni tavola chiedendo al pz cosa ci veda,
2. Annotazione delle risposte, tempo impiegato per rispondere, posizione in cui
vengono tenute le tavole...
3. Ripresentazione di ciascuna tavola, chiedendo quali aspetti della figura abbiano
determinato le risposte.
4. Codifica delle caratteristiche formali delle risposte.
17
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
In merito alla siglatura del protocollo così raccolto( lo scoring nei test classici), essa
consiste nella codifica di una serie di caratteristiche formali. Le caratteristiche sono 4:
- il fattore determinante la risposta;
- la localizzazione all’interno della tavola;
- il contenuto della risposta;
- l’originalità della risposta
Interpretazione delle risposte - basata sulla frequenza delle caratteristiche delle
risposte e su indici (numero delle risposte, tempi di reazione, rifiuti).
OFFRE:
• valutazione globale della personalità
• valutazione qualitativa dell’intelligenza
• aiuto alla diagnosi differenziale.
Oggi esistono una pluralità di metodo del metodo di Rorscharch, diversi tra loro:
a) il metodo tedesco-svizzero;
b) il metodo svizzero-francese;
c) il metodo Klopfer;
d) il sistema comparativo di Exner.
18
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
7. TEST DI INTELLIGENZA
La valutazione clinica può includere l’uso di test che riguardano la sfera cognitiva:
esaminano abilità di percezione, pensiero, memoria, apprendimento, visualizzazione,
attenzione.
OBIETTIVI: permettono di raccogliere indici specifici del funzionamento mentale o di
darne una stima complessiva e unitaria.
Tenendo conto dell’importanza delle valutazioni complessive dell’intelligenza non è
un caso che siano stati creati numerosi test.
Un classico strumento in questo campo è
• La Scala Stanford-Binet- che costituisce uno dei riadattamenti dello strumento di
Binet per valutare il quoziente intelletivo(Q.I.) - valuta il Q.I. cioè il rapporto tra età
mentale(età corrispondente alle prove cognitive che l’individuo è in grado di
superare) ed età cronologica(ovvero la sua età effettiva).
Un'altra scala molto conosciuta è rappresentata delle
• Matrici progressive di Raven – che si basano sulla richiesta di una specifica
operazione di ragionamento induttivo su stimoli visivi. Di facile somministrazione e
non è particolarmente influenzato dal livello culturale e misurano aspetti centrali
dell’intelligenza. Esse si basano su una concezione unitaria dell’intelletto oggi critica
a favore di una concezione frazionaria dell’intelligenza per cui vi sono componenti
che hanno diverso peso.
SCALE DI WECHSLER - molto popolari per solidità, flessibilità e standardizzazione.
Lo psicologo David Wechsler ha selezione prove che risultano le più idonee per la
valutazione dell’intelligenza, pervenendo ad una scala complessiva per adulti –
WAIS(Wechsler Adult Intelligence Scale) - e due scale per bambini – WISC e WPPSI-
rispettivamente sopra e sotto i 6 anni.
Le Scale di Wechsler si basano sulla somministrazione di prove che esaminano aspetti
differenti del funzionamento cognitivo.(per capire i punteggi basta tenere presente
che un punteggio ponderato di 10 costituisce la media e la deviazione standard è di 3.
Quindi un punteggio di 7 presenta difficolta).
• Ipotizzano la scomponibilità dell’intelligenza in differenti abilità.
• Esaminano vari aspetti del funzionamento cognitivo (prove di tipo verbale, non
verbale e di esecuzione).
• Permettono di ottenere una stima complessiva di intelligenza, in un punteggio che
separa in QI verbale e QI di performance.
In merito al decadimento intellettivo dell’anziano, si fa riferimento alla distinzione tra
intelligenza cristallizzata(ancora al possesso di un buon bagaglio di conoscenze e
quindi meno sensibile al calo dell’efficienza intellettiva) e intelligenza fluida( più
19
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
influenzata dall’invecchiamento). In merito a ciò è comunque necessario procedere ad
una più specifica diagnosi di eventuali disfunzioni dell’anziano.
8. VALUTAZIONE COGNITIVA E NEUROPSICOLOGICA DI SPECIFICHE
FUNZIONI
La necessità di VALUTAZIONI CLINICHE di specifici aspetti del funzionamento mentale
insorge quando non è sufficiente avere una stima complessiva dell’efficienza
intellettiva del soggetto. In presenza di un disturbo molto selettivo, dissociato dal
resto del funzionamento mentale è necessario ottenere valutazioni specifiche:
offrono info sulle aree interessate dal disturbo neurologico e consentendo una
diagnosi più precisa. Inoltre permettono di riconoscere lo specifico problema
dell’individuo relativamente alle aree che richiedono un trattamento riabilitativo.
Gli strumenti utilizzabili per le valutazioni specifiche vengono distinti a seconda che si
riferiscano all’esame di:
1. Funzioni cognitive(memoria, linguaggio,..);
2. Aree del cervello.
Per lo psicologo italiano una buona panoramica degli strumenti standardizzati è
reperibile presso la GIUNTI O.S.
Tra il repertorio degli strumenti standardizzati per valutare la memoria, abbiamo:
• Test della figura complessa di Rey(percezione e memoria visiva),
• Scale di memoria di Wechsler.
11 CLASSIFICAZIONE DEI DISTURBI MENTALI
In passato si avevano traduzioni culturali diversi in merito allo stesso disturbo, quindi
poteva capitare che tra due ricercatori vi fossero delle discordanze in merito alla
valutazione e alla diagnosi che veniva fatta. In merito a ciò nell’800 si ebbero tentativi
di realizzare una classificazione delle malattie internazionalmente condivisa. Quando
fu istituita l’Organizzazione Mondiale della Sanità(OMS), nacque un Manual of
the International Statistical Classification of Diseases (ICD) che
ignorava le malattie mentali. Solo nella sua 6° edizione del 1946 fu inserita una
sezione relativa ai disturbi mentali. Nel 1952, un gruppo di psicologi americani diede
vita al Diagnostic and Statistical Manual of Mental Diseases (DSM).
Oggi siamo al DSM-5. Per l’ICD oggi siamo alla versione 11.
Quindi oggi esistono due principali sistemi diagnostici che offrono classificazioni
categoriali e che suddividono i disturbi mentali sulla base di set di criteri con
caratteristiche descrittive...ovvero sistemi nosografici. Il DSM ha una vasta base
empirica e alla sua redazione hanno contribuito vari gruppi di lavoro, con la
20
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
collaborazione importante dell’ AMERICAN PSYCOLOGICAL ASSOCIATION. La
classificazione attraverso questi due strumenti:
ICD
- classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati
- stilata dall'organizzazione mondiale della sanità
DSM
- Uno dei sistemi nosografici per i disturbi mentali o psicopatologici più utilizzato da
medici ,psichiatri e psicologi di tutto il mondo,sia nella pratica clinica che nell'ambito
della ricerca.
- E' ateorico cioè non ha preteso di fare scelte teoriche di campo,ma si è limitato ad
identifiare le tipologie più frequenti di disturbo psichicoe a fotografarne gli elementi
associati.
Il DSM ,forse il sistema più diffuso e usato dai clinici,prevede una
valutazione/classificazione multiassiale;il pziente è valutato lungo 5 assi ognuno dei
quali si riferisce ad un diverso campo di informazioni che vanno al di là della diagnosi
e possono aiutare il clinico a pianificare il trattamento.
I. Disturbi oggetto di attenzione clinica
II. Disturbi di personalità e dello sviluppo come autismo e ritardo mentale
III. Malattie organiche
IV. Eventi psicosociali stressanti
V. Valutazione globale del funzionamento (in scala da 0-100), che monitora il livello di
funzionamento sociale del paziente.
Oggi il DSM, più accurato dell’ICD, viene utilizzato nella ricerca scientifica e
valutazioni specifiche.
• Entrambi i sistemi sono a-teorici: identificano le tipologie più frequenti di disturbo
mentale e le suddividono sulla base di set di criteri con caratteristiche descrittive.
L’ICD è d’obbligo ha livello mondiale in base ad accordi tra i governi , è alla base
delle statistiche e della burocrazia ospedaliera.
• Oggi tra DSM-5 e ICD-11 esistono differenze di dettaglio e l’uno rimanda all’altro.
PDM <<MANUALE DIAGNOSTICO PSICODINAMICO>>
Il PDM è stato pubblicato nel 2006. Esso è il risultato della collaborazione delle
maggiori organizzazioni di professionisti presenti negli Stati Uniti.
Esso non si pone in alternativa agli altri sistemi diagnostici(DSM ,ICD) ma in una
posizione di integrazione e complementarietà aggiungendo prospettive:
<<l’obiettivo del PDM è quello di spiegare l’intero range del funzionamento
mentale andando a completare gli sforzi di catalogazione dei sintomi promossi
negli ultimi trent’anni dal DSM e dall’ICD>>.
21
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
a) Esso guarda ai disturbi mentali da un punto di vista psicodinamico.
b) Utilizza un approccio multidimensionale. La PRIMA DIMENSIONE prende in
considerazione la collocazione della persona lungo un continuum di
funzionamento, dal livello più sano a quello più disturbato. E include sistemi
di credenze e valori morali, indicata come asse P(personalità); la SECONDA
DIMENSIONE guarda alla vita mentale, alla capacità di elaborare
informazioni e a mantenere le relazioni, usare strategie di coping, indicata
con M(funzionamento mentale; la TERZA DIMENSIONE origina dalle
categorie diagnostiche del DSM-IV-TR e descrive i pattern sintomatici,
indicato con S(SINTOMI).
22
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
CAP 3 - PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO
-un bambino, nel complesso e faticoso processo di maturazione, presenterà in
determinati casi problematiche psicologiche specifiche. Alcune scompariranno altre
invece potranno permanere-
1. PROBLEMATICHE DELLO SVILUPPO: DISTURBI SPECIFICI E GENERALI
Lo studio dei disturbi psicologici in età evolutiva riprende gli ELEMENTI che:
• Validi a tutte le età,
• Specifici, che nell’adulto non compaiono o sono diversificati.
Non è sempre facile tracciare un confine tra crisi transitoria nel percorso maturativo
e un vero e proprio disturbo.
È importante conosce le diverse problematiche che compaiono a varie età e che poi
con la crescita tendono a scomparire; la loro presenza non costituisce un elemento
psicopatologico a meno che l’intensità e frequenza di comparsa siano eccessive.
Esistono tipiche problematiche che compaiono nelle diverse fasce d’età, e che poi
scompaiono.
età dei soggetti problemi comportamentali
1 ½-2 sfuriate di umore, rifiuto di fare cose quando
richieste, iperattività, richieste di attenzioni,timori
specifici.
3-5
Sfuriate d’umore, rifiuto di fare le cose quando
richieste, ipersensibilità, falsità, negativismo.
6-10
Sfuriate d’umore, iperattività, paure specifiche,
problemi scolastici, riservatezza.
11-14
Sfuriate d’umore, ipersensibilità, gelosia,
malinconia, problemi scolastici.
15-18 Problemi scolastici, assenze, imbrogli agli esami,
abuso di droghe, trasgressioni.
23
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Ma ciò non esclude che anche disturbi gravi possono avere tipiche età d’insorgenza.
In merito al manuale di psicopatologia dello sviluppo di Carr, questo si articola
distinguendo per fasce i principali disturbi evolutivi.
INFANZIA Sonno
Toilette
Apprendimento e comunicazione
Disturbi pervasivi
FANCIULEZZA Condotta
Disturbo attenzione/iperattività
Paura e ansia
Disturbi ripetitivi-Tourette
Dis. Psicosomatici
ADOLESCENZA Droga
Umore
Alimentazione
Schizofrenia
Vi sono teorie che forniscono dei quadri originali di riferimento. Fra questi particolare
influenza è stata esercitata dalla descrizione delle fasi dello sviluppo psicosessuale
compiuta dalla teoria psicoanalitica di Freud, dove la scarsa, nulla presenza di queste
tappe e considerata indice di problematicità. Le fasi sono.
primo anno: fase orale;
secondo-terzo anno: fase anale;
dal terzo al quinto anno: fase fallica;
dal sesto alla pubertà: fase di latenza;
dall’adolescenza: fase genitale.
2. IL CONCETTO DI DISTURBO IN ETA’ EVOLUTIVA
L’apparente analogia con i disturbi fisici può indurre in errore nella considerazione
della gravità di un disturbo. Una fonte di errore è legata all’idea che esista
necessariamente una soluzione di continuità fra normalità e disturbo. In effetti, la
malattia fisica segue questo principio: l’influenza o il morbillo sono disturbi che ci
sono o che non ci sono. Lo stesso discorso non vale per il disturbo psicologico.
La presenza di problematiche caratteristiche di una certa età non costituisce
elemento psicopatologico, a mano che l’intensità e frequenza di comparsa siano
eccessive(l’iperattività- normale tra i 6 e i 10 anni nei maschi, ma può assumere un
grado elevato che non è accettabile).
Se non esiste soluzione di continuità fra normalità e disturbo, la definizione del grado
particolare (cut-off) oltre il quale si può parlare di disturbo è, entro certi limiti,
arbitraria. C’è chi ha in mente modelli ottimali di adattamento personale e quindi,
confrontando i bambini a questi modelli, trova sempre delle incrinature nel loro
equilibrio psicologico. C’è invece chi usa dei principi statistici elementari e stabilisce a
priori che si può considerare problematico un comportamento “disadattivo” che viene
presentato da mano di una certa percentuale della popolazione di cui il bambino fa
parte.
24
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
C’è chi stabilisce il cut off non tanto in base a un dato percentuale, ma in base alla
probabilità che il disturbo ha di permanere nel tempo con la stessa intensità e di
comportare problemi più gravi per lo sviluppo della personalità. Si parla di “sindromi”
per far riferimento al fatto che un singolo elemento, anche se poco frequente, non
deve costituire fonte di preoccupazione, mentre una serie di elementi, non
casualmente compresenti, possono giustificare una severa diagnosi clinica. Per una
diagnosi è richiesta quindi la compresenza dei vari elementi di un determinato
disturbo. Un riferimento obbligato per la valutazione della gravità di un problema sia
quello a bambini che appartengono alla medesima popolazione del bambino che ci
interessa (stessa età, sesso e cultura). La <<stessa popolazione>> riguarda non solo
l’età ma anche il sesso e la cultura a cui i bambini appartengono.
In ambito educativo si sono individuate dimensioni utilizzabili come punti di
riferimento per la valutazione relative alla gravità del caso.
Gli aspetti che un sistema educativo può prendere in considerazione in relazione a
un disturbo evolutivo:
- Disordini emotivi
- Problemi interpersonali
- Problemi d’apprendimento/insuccesso scolastico
- Cronicità
- Prognosi
- Necessità intervento
3. LA CLASSIFICAZIONE DEI DISTURBI PSICOLOGICI EVOLUTIVI
Due grossi nodi nella classificazione dei disturbi psicologici evolutivi riguardano il
grado di tassonomicità e il grado di continuità.
La psicopatologia è animata da un acceso dibattito volto a definire se sia meglio un
sistema dimensionale o uno categoriale.
Il grado di tassonomicità si riferisce alla misura in cui i disturbi vengono classificati
con i sistemi tassonomici che distinguono in categorie distinte i vari disturbi che
possono presentarsi.
Un elevato grado di tassonomicità lo riscontriamo nel DSM-5 e nell’ICD-10. Questi
sistemi hanno il vantaggio di una maggiore chiarezza e della possibilità di ricondurre
casi diversi ad una famiglia comune di disturbo( se invididuiamo un profilo di
anoressia nervosa questo permette di collegarlo ad altri simili e di orientare la
valutazione diagnostica).
Ma nonostante i suoi vantaggi, esistono degli Svantaggi:
1) esiste il limite di qualsiasi sistema classificatorio di semplificare e ridurre la
complessità dei fenomeni reali; per es.molti disturbi non sono come distinguibili,
25
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
infatti tipicamente i bambini che presentano un problema ne presentano un altro
associato (la cosiddetta comorbidità) non per una semplice coincidenza ma per il
fatto che i due disturbi rientrano in un comune quadro sindromico.
2) Effetti della “etichettatura” per cui il bambino che viene classificato in relazione ad
un preciso disturbo può finire per essere condizionato, nel suo modo di affrontare la
vita e soprattutto per l’atteggiamento che gli altri assumono nei suoi confronti,
dall’etichetta che lo caratterizza.
3) Il grado di continuità,che è scarso in molti sistemi psichiatrici e elevato in molte
analisi psicologiche. Un grado di continuità scarso sta ad significare che, considerato
un certo aspetto patologico, si assume che un bambino lo possieda(e allora presenta il
disturbo) o non lo possieda.
La grande parte delle rivelazioni relative al grado di presenza di tratti patologici
rivela distribuzioni continue suggerendo che i tratti patologici siano continui e il
riferimento ad un’eventuale etichetta è legata alla definizione, in parte arbitraria di
un cut-off, e debba essere fatto con prudenza quando il bambino presenta un valore
prossimo al cut-off.
Il DSM5 ha esplicitato i gradi diversi di gravità che un determinato disturbo può
presentare. Ma dobbiamo dire che l’analisi psicologica può trarre vantaggio da
sistemi che non accettano elevata tassonomicità e soluzione della continuità. Alcuni di
questi sistemi sono stati elaborati dalla ricerca psicologica in base ad analisi
psicometriche.
3.1. ESEMPI DI DESCRIZIONE DIMENSIONALE
Molti classici test di personalità come l’MMPI, forniscono una descrizione
dell’individuo e di sue eventuali problematiche lungo una serie di dimensioni.
Questo approccio è stato usato nella clinica dello sviluppo. Ciò è possibile
esaminando una serie di problematiche descritte nei sistemi classificatori e
considerarle tutte potenzialmente compresenti in uno stesso individuo e a tutti i
livelli possibili di intensità.
La scala COM (Marzocchi, Cornoldi 2010) considera le problematiche presenti nei
disturbi di comportamento disattento e iperattivo, e basandosi su DSM e ICD
fornisce una descrizione multidimensionale.
CASO-ESEMPIO DI FRANCESCO: Un bambino di 8 anni che mostra problemi di comportamento. Sia i
familiari(caratterizzati da ansia), sia le maestre si lamentano del comportamento iperattivo e
oppositivo. Pratica sport, è bravo ma non rispetta le regole. Il test consiste nella somministrazione a
genitori e insegnanti per valutare come vedono il bambino. I genitori lo vedono disattento, iperattivo e
oppositivo. Gli insegnanti solo iperattivo.
26
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Un sistema dimensionale che ha raggiunto una certa influenza è stato proposto da
Achenbach e colleghi e ha portato anche all’elaborazione di scale (le scale CBCL) di
valutazione del comportamento psicopatologico che hanno avuto un cospicuo seguito.
Achenbach e colleghi chiesero a insegnanti e genitori di osservare e valutare molte
centinaia di bambini in relazione ad una serie di tratti, rilevabili senza bisogno di una
specifica preparazione clinica.
Essi ottennero valutazioni relative a numerosi aspetti potenzialmente problematici,
ma poterono vedere come questi aspetti potessero essere ricondotti a due fattori
(sintomi internalizzanti e sintomi esternalizzanti) forse parte di un'unica dimensione.
Percorriamo i due tipi di sintomi.
I sintomi internalizzanti si riferiscono a problemi su cui il bambino ripiega, senza
esibirli in direzione degli altri (ansia, fobie, eccessivo autocontrollo, timidezze, ecc.).
I sintomi esternalizzanti sono invece diretti verso l’ambiente e altre persone
(aggressività, disobbedienza, opposività, ecc.).
CASO ESEMPIO DI GAR: Ragazzino di 12 anni che presenta problemi legati a
comportamenti di tipo delinquenziale- furti, bullismo,vandalismo, delinquenza)-. Un
sistema tassonomico come il DSM-5 lo classificherebbe nella categoria dei
<<disturbi della condotta>>; una valutazione come il CBHCL-Child Behavior
Checklist permette di ottenere un profilo articolato lungo diverse dimensioni
continue, riconducibili tuttavia alle dimensioni di internalità ed esternalità. Il
profilo della figura è basato sulle valutazioni della madre, confrontate con quelle di
altri ragazzi
Gar costituisce un esempio di ragazzino i cui problemi non si riferiscono alla
dimensione interiore ma piuttosto al comportamento rivolto verso l’esterno.
Con l’esempio di Gar abbiamo visto come dimensioni specifiche possono assumere
tutti i valori della gamma prevista, con una specificazione di problematicità che è
determinata dal confronto di Gar con i ragazzi della sua età o di età simile.
Una stessa logica può essere applicata alla dimensione dell’autocontrollo(caso
francesco); secondo essa, i problemi di un bambino potrebbero essere caratterizzati o
da un eccessivo autocontrollo, maggiormente caratterizzato sul versante della
internalità, per cui egli fa fatica a manifestare le proprie difficoltà e ha paura ad
affrontare il mondo esterno, o da uno scarso autocontrollo, per cui si reagisce
impulsivamente, o si rivolge verso gli altri i propri disagi.
Un bambino eccessivamente timido costituisce un esempio di soggetto ipercontrollato;
in certi contesti sociali e culturali, esso è considerato con particolare preoccupazione,
mentre in altri può essere addirittura valorizzato. Al contrario, un bambino iperattivo
è un esempio di soggetto ipocontrollato. Il disturbo di ipercontrollo è più frequente
nelle femmine, mentre quello di ipocontrollo nei maschi. Per quanto questa differenza
di genere possa essere riportata a fattori biologici, non si può escludere che un certo
27
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
ruolo sia giocato anche da fattori culturali che valorizzano nel maschio l’attività e
nella femmina il controllo. La valenza culturale della dimensione del controllo è stata
studiata da Weisz e colleghi, che hanno osservato in Tailandia più disturbi di
ipercontrollo (legato alla religione buddista) e nelle società occidentali più disturbi di
ipocontrollo.
4. TEORIE E FATTORI SOTTOSTANTI AI DISTURBI PSICOLOGICI DELLO
SVILUPPO
Vi sono numerosi approcci al campo che possono influenzare largamente la maniera
con cui il bambino viene preso in considerazione nella valutazione e nel trattamento.
Questi approcci riflettono in parte le grandi scuole psicologiche e gli orientamenti più
generali di psicologia clinica/psichiatria, in parte si riferiscono a maggiori
specializzazioni del campo psicoterapeutico. Sulla loro importanza esistono posizioni
differenti.
Una tipica contrapposizione riguarda la valutazione del ruolo dei fattori biologici
(nature) e di quello dei fattori legati all’esperienza (nurture). Ci si chiede in che
misura un disturbo psicologico sia il risultato delle caratteristiche con cui il bambino
è venuto al mondo, e in che misura invece esso dipenda da esperienze successive alla
sua procreazione. La stragrande maggioranza di ricercatori e di clinici converrebbe
sicuramente verso una posizione che attribuisce importanza a entrambi gli ordini di
fattori, ma presenterebbe infinite sfaccettature e sfumature nella definizione dei modi
e dei pesi. Uno clinico ambientalista ammetterà che sarà l’ambiente a produrre certe
conseguenze.
L’impostazione biologica trova la sua conferma più evidente in quelle malattie
psicologiche il cui riscontro genetico non solo è chiaro, ma è anche determinante per
produrre un vero disturbo producendo una condizione dicotomica (presenza o
assenza del disturbo) che abbiamo già detto non essere comune a molti aspetti del
mondo psicologico. Per es., vi sono profili genetici che producono inequivocabilmente
certi disturbi psicologici. Tuttavia, anche all’interno di questi profili ben delineati, ci
sono molti elementi di variabilità. Inoltre, per molti altri disturbi psicologici la
causalità genetica non è affatto evidente, anche se in qualche modo una
predisposizione può essere rintracciata. Due modalità attraverso cui si valuta questa
predisposizione sono rappresentate dallo studio rispettivamente della familiarità e
dei gemelli monozigoti.
La familiarità si riferisce al fatto che un determinato disturbo ha maggiori
probabilità di comparire in un bambino di una famiglia in cui qualcuno fra genitori,
antenati, fratelli o parenti presentavano il disturbo (es. la dislessia). La familiarità
spesso riguarda parenti con cui nemmeno il bambino è venuto in contatto, anche se il
28
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
ruolo di un ambiente familiare deprivante sono state prese in considerazione, cn
connotazioni deboli.
Lo studio dei gemelli monozigoti conferma che gemelli che presentano lo stesso
patrimonio genetico hanno maggiori probabilità di presentare lo stesso disturbo
rispetto a gemelli dizigoti, che condividono solo metà del patrimonio genetico (in
particolare la schizofrenia, dove la probabilità per un gemello monozigote è stimata
intorno al 40%, rispetto all’1% della popolazione)). Si potrebbe obiettare che la
somiglianza dei gemelli monozigoti potrebbe essere dovuta a fattori ambientali, dal
momento che di solito essi hanno condiviso le stesse esperienze di vita, tuttavia si sono
trovate somiglianze anche tra gemelli monozigoti separati alla nascita, mentre si
trovano somiglianze più ridotte fra gemelli di zigoti cresciuti nello stesso ambiente.
Quindi, ciò che fa la differenza nel grado di somiglianza fra le due coppie deve essere
almeno in parte attribuito a fattori genetici.
L’approccio psicobiologico non si limita alla ricerca genetica e alla valutazione del
peso delle componenti genetiche, ma si muove in numerose altre dimensioni
interessate a studiare diversi aspetti psicofisiologici sottostanti ai disturbi psicologici.
In queste ricerche, la direzione del rapporto fra caratteristiche biologiche e
caratteristiche psicologiche non è necessariamente definita. Va osservato che quasi
sempre la ricerca che si occupa dei risvolti psicobiologici dei disturbi evolutivi tende
ad attribuire a tali risvolti un peso centrale. In ambito psicobiologico, possiamo
sinteticamente individuare due fondamentali settori di ricerca che si occupano
rispettivamente del funzionamento del sistema nervoso centrale (neuroscienze,
neuropsicologia) e del funzionamento degli altri organi del corpo (psicofisiologia).
Entrambi questi settori hanno fornito contributi importanti nell’esame dei disturbi
psicologici dello sviluppo. In particolare la neuropsicologia si è dimostrata in grado
di stabilire precise connessioni fra funzionamento psicologico, soprattutto per il suo
versante cognitivo, e funzionamento del sistema nervoso. Alcuni disturbi psicologi(il
disturbo da deficit attentivo) sono stati quindi messi in relazione con disfunzionalità
del sistema nervoso centrale e con alcuni disturbi neurologici e sono state studiate le
implicazioni o le conseguenze di carattere psicologico.
In ambito psicobiologico, i modelli cognitivisti di funzionamento sono:
- La ricerca eziologia che vuole capire quali fattori hanno prodotto un certo effetto;
- la ricerca funzionale che vuole descrivere come agisce e si configura questo
effetto. Questo atteggiamento è stato presente in molta ricerca cognitivista volta ad
analizzare i meccanismi di funzionamento cognitivo sottostanti vari disturbi
psicologici.
In generale, negli approcci cognitivisti si sono di solito ritrovate posizioni volte a
riconoscere l’importanza sia della struttura biologica, sia dell’esperienza. Per altri
versi, anche le teorie dello stress hanno spesso sottolineato come una predisposizione
al disturbo sfoci in patologia solo se si verificano condizioni di particolare stress.
29
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Il concetto di stress, che fa parte anche del linguaggio psicologico ingenuo, appare a
sua volta rappresentare una condizione psicofisica indotta da differenti fattori, la cui
concomitanza può rendere la miscela esplosiva( bambino con ADHD presenterà in
maniera cospicua il problema non solo in presenza di un solo fattore ma dalla
compresenza di più fattori). Sul versante delle posizioni che hanno attribuito
maggiore peso a fattori esperienziali che hanno una diretta influenza sulla psiche si
possono individuare tre orientamenti psicologici rispettivamente di ispirazione:
1) sociale o sociologica;
2) comportamentista;
3) psicodinamica.
Un Vantaggio di questi orientamenti è che sono accompagnati da una maggiore
fiducia nelle possibilità del cambiamento e dell’intervento psicologico.
Al contrario, le posizioni psicobiologiche radicali → idea che, se il disturbo è di natura
biologica, c’è poco da fare(uso farmaci). Questa posizione è criticabile, poiché blocca
la motivazione a sforzi nella direzione di un cambiamento psicologico impedendo
miglioramenti.
Si incorre così nel problema dell’etichettatura. Al contrario posizioni teoriche hanno
enfatizzato al tal punto il ruolo dell’esperienza da creare livelli alti di fiducia utili per
ottenere progressi.
Ciò è stato rilevato nell’approccio comportamentista, nelle sue versioni più
antiche, era portato a pensare che lo sviluppo psicologico fosse quasi totalmente la
risultante dell’esperienza assimilata attraverso i principi base dell’apprendimento,
quali il condizionamento classico, il condizionamento operante, l’apprendimento
basato sull’osservazione. Il comportamentismo classico si è ora sviluppato in diverse
posizioni e direzioni più sfumate, ma ha indubbiamente mantenuto una tendenza ad
attribuire le problematiche psicologiche a processi sottostanti di apprendimento
dall’esperienza.
L’approccio cognitivo-comportamentale ha coniugato concetti cognitivisti e
comportamentismi;
L’approccio della teoria socio-motivazionale dell’apprendimento ha illustrato
come delle problematiche psicologiche possano essere il risultato di interazione fra
fattori esperienziali, motivazionali e sociali.
Anche la teoria psicoanalitica ha attribuito notevole peso alle esperienze di vita del
bambino, spostando però l’accento dalle esperienze in parte consapevoli e riguardanti
l’intero arco di vita, di cui si è interessato il comportamentismo, ad esperienze precoci
e inconsce. Qui le esperienze inconsce sono quelle più significative poiché si rivelano
incontrollabili. Il peso dell’inconscio è in relazione con l’ipotesi che la vita psicologica
sia influenzata da tre istanze: dall’Es, cioè la parte inconscia di noi che spinge per una
soddisfazione immediata dei suoi impulsi e desideri, dal Super-Io, che rappresenta il
sistema interiorizzato di norme di comportamento, e dall’Io che dovrebbe costituire il
30
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
punto di mediazione consapevole fra le diverse istanze. L’Io consapevole svolge però
solo una parziale funzione di controllo degli impulsi, perché una parte significativa è
svolta dai meccanismi inconsapevoli di difesa che talvolta riescono a ridurre l’ansia
dell’individuo, e hanno quindi una funzione adattiva, ma talvolta falliscono dando
corso ad una nevrosi. Col passare degli anni, una crescente importanza è stata
attribuita alle fasi più precoci dello sviluppo. Un altro ambito importante di influenza
riguarda lo sviluppo sessuale e le sue fasi(vedi fasi). Ma anche, la teoria delle relazioni
d’oggetto, derivata dall’idea che le persone sono oggetto di impulsi di altre persone, si
sofferma sulla relazione precoce d’oggetto madre-bambino assumendo che essa sia
cruciale per lo sviluppo della capacità di un individuo di relazionarsi con altri. Un
parallelo sviluppo psicodinamico ha riguardato la dimensione
dell’attaccamento(BOWLBY), assumendo che un buon attaccamento originario
costituisca le premesse per un buono sviluppo dell’affettività. Un cattivo attaccamento
produrrà ansia e un’eccessiva preoccupazione nel bambino di essere separato dalle
persone cui è emotivamente “attaccato” (es. ansia da separazione).
Il tema dell’attaccamento fa riferimento a 4 stili fondamentali di attaccamento
evidenziati nel bambino attraverso la <<STRANGE SITUATION>> introdotta da Mary
Ainsworth, e basata sulla presenza in un primo tempo del bambino con la mamma e
poi dalla compagnia di una persona estranea:
STILE SICURO: il bambino esplora l’ambiente e gioca sotto lo suardo della
madre con cui interagisce, quando poi rimane solo con lo sconosciuto si turba
ma torna tranquillo al ritorno della madre;
STILE INSICURO-EVITANTE: il bambino appare piuttosto indifferente nei
confronti della madre, anche dopo il suo ritorno;
STILE INSICURO-AMBIVALENTE: il bambino ha comportamenti contradditori
nei confronti della madre, a tratti la ignora/cerca contatto, soffre della sua
assenza e non si conforta con il suo rientro;
STILE DISORGANIZZATO: il bambino mette in atto comportamenti stereotipati
con reazioni strane e di sorpresa quando la mamma si assenta.
5. FATTORI SOCIALI E SOCIOLOGICI PROBLEMATICI
Gli approcci psicosociali e sociologici attribuiscono grande peso a fattori che vanno
dai contesti interattivi più immediati all’ambito allargato del gruppo sociale in cui il
soggetto vive. Gli studi sul rischio psicosociale sono orientati a riconoscere come un
concorso di fattori d’ordine sociale possa produrre un valore di rischio cumulativo
che, se superata una certa soglia, produrrà un problema.
Sameroff e Seifer hanno esaminato i fattori precoci di rischio e sommando il numero
delle variabili di rischio hanno calcolato un indice complessivo di rischio.
31
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Una prima serie di fattori è legata alla famiglia.
In generale, la famiglia costituisce l’ambito fondamentale di vita del bambino ed esso
può essere più o meno ottimale. Più specificatamente, fattori d’ordine storico,
culturale, religioso, sociale, ecc. influiscono sull’assetto familiare e questo non può non
avere conseguenze sullo sviluppo psicologico del bambino. Attualmente nella società
occidentale → nucleo familiare a singolo-genitore (di solito la madre),dove la figura
dell’altro genitore sia sbiadita o assente.
È piuttosto questa condizione di assenza di un genitore (o la conflittualità fra i
genitori) che può indurre problemi nel bambino, piuttosto che il divorzio per se stesso.
Un divorzio fonte di sofferenza può avere Ripercussioni più negative nel caso dei
maschi. Non vi sono invece chiare indicazioni sull’età del bambino più a rischio nel
caso di divorzio. Più grave appare invece la situazione di nuclei a singolo genitore che
sono associati a svantaggio sociale e culturale e che possono portare a condizioni di
grave disagio. I fattori di rischio legati a situazioni familiari sono comunque
molteplici. Per es., l’importanza che stanno oggi assumendo fenomeni nuovi di
adozione, maternità favorite, maternità parziali, ecc. possono far ipotizzare che nuove
problematiche evolutive potranno riguardare questi ambiti. Tuttavia i rischi e le
conseguenze negative di queste situazioni possono essere anche esagerati.
Lo svantaggio socioculturale costituisce condizione handicappante che ha un
effetto moltiplicativo per tutte le situazioni già per se stesse a rischio o disagiate.
L’importanza dei fattori socioculturali nella psicopatologia evolutiva è documentata
dagli effetti degli interventi preventivi sulle realtà urbane a rischio. Questi interventi
costituiscono uno degli obiettivi primari dei servizi sociali di tutto il mondo. Molti
studi rivelano un effettivo vantaggio dell’intervento precoce. Ma tenendo conto che la
prevenzione non è sempre la soluzione più funzionale, poiché interviene su presunti
problemi magari poi non si sarebbero mai verificati, molti studi ne rivelano un
effettivo vantaggio.
Molti sono i risvolti dello svantaggio socioculturale:
1) condizione di povertà della famiglia che non permette di offrire al bambino tutte le
opportunità e le sicurezze di cui può godere un coetaneo di ambiente agiato.
2) I familiari non possiedono le risorse culturali e intellettuali per offrire stimoli ricchi
e articolati al bambino.
3) Lo svantaggio può essere accompagnato alla emarginazione della famiglia.
Le minoranze etniche e linguistiche costituiscono, anche in Italia, un fenomeno di
crescente impatto. I bambini di gruppi minoritari affrontano spesso, fra i vari disagi,
anche quello di non conoscere bene la lingua del paese che li ospita e questo può
metterli in difficoltà ulteriore tanto nella vita, quanto nella scuola. Lo scarso successo
di bambini come questi a test d’intelligenza aveva indotto gli psicologi più sensibili a
cercare di ideare test su cui il possesso della lingua avesse scarsa influenza (test
culture-free), ma aveva portato altre persone, compresi taluni psicologi, a ritenere
32
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
che in alcune minoranze i bambini presentassero minori abilità a causa di fattori
genetici.
Povertà, discriminazione e isolamento sociale sono condizioni che, insieme con lo
stress e la scarsa accettazione del ruolo parentale, aumentano la probabilità che si
verifichino fenomeni gravi di abuso dell’adulto sul bambino. Una forma frequente di
abuso è rappresentata dalla violenza fisica, che in certi contesti socioculturali è
tollerata e valorizzata. Il maltrattamento (non solo fisico , ma anche psicologico) del
bambino può avere serie conseguenze sia psicologiche che fisiche. Una forma
particolarmente grave di abuso sul bambino riguarda la sfera sessuale. Anche
bambini piccoli possono essere oggetto di attenzioni particolare da parte degli adulti,
ma il fenomeno è particolarmente frequente per ragazze preadolescenti o adolescenti.
Le persone che abusano del bambino sono spesso adulti che hanno un rapporto un
rapporto di parentela o vicinato con la vittima: questo ha particolari implicazioni
emotive per il bambino, ma implica anche il fatto che l’adulto non ricorre alla forza,
che il bambino non riporta l’evento, che si stabilisce fra adulto e bambino una
particolare relazione distorta e che essa può mantenersi a lungo nel tempo. Nei casi
più gravi, l’abuso proviene da estranei, è episodico ed è associato a violenza fisica.
In taluni casi di abuso sessuale si è parlato di traumi talmente gravi da produrre una
psicopatologia profonda, pervasiva e quasi irreversibile. In altri casi, si sono
evidenziate conseguenze più specifiche nella sfera relazionale e sessuale, danni alla
personalità e alla crescita intellettiva, disturbi aggressivi e distruttivi, ecc. E’ stata poi
avanzata un’ipotesi di trasmissione dei rapporti interattivi secondo cui gli esseri
umani tenderebbero a riprodurre col più debole il rapporto che essi hanno in qualche
modo subito quando erano a loro volta i più deboli. L’ipotesi appare in alcuni casi
confermata, ma non certo generalizzabile.
6. PROBLMEATICHE EVOLUTIVE CON FORTI IMPLICAZIONI SOCIALI:
BULLISMO, TOSSICODIPENDENZA, DELIQUENZA GIOVANILE
I fattori sociali di rischio possono produrre conseguenze rilevanti sul piano dello
sviluppo della personalità e delle relazioni sociali del bambino. Menesini (1999) osserva
che le relazioni sociali fra coetanei sono sia un fattore di rischio, sia una conseguenza
del rischio psicosociale; l’autrice prende in considerazione, in particolare, il fenomeno
del bullismo, che pare dovuto non solo a caratteristiche individuali, ma anche a sistemi
di interazione sociale.
33
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Il bullismo si riferisce al comportamento prepotente manifestato, con costanza nel
tempo, che produce, una interazione prevaricante su una vittima. Il bullo può essere un
bambino con caratteristiche di dominanza e assertività, aggressività e rifiuto dei
coetanei, che entra in un’interazione disturbata con un bambino con caratteristiche di
debolezza e introversione. Il profilo del bullo può quindi essere associato a profili
psicopatologici; tuttavia, molti bambini senza problematiche psicopatologiche gravi
possono esibire comportamenti da bullo. In questi casi, la rete si relazioni in cui agisce il
bullo ha un peso determinante, influenzando nella strutturazione dei ruoli. Per es., un
ruolo importante viene giocato dagli altri membri del gruppo, i sostenitori del bullo o
della vittima o coloro che si pongono come osservatori passivi. Il bullismo può essere
precursore di disturbi e comportamenti più gravi, ma può anche – fortunatamente –
mantenersi limitato a contesti più specifici e non svilupparsi ulteriormente.
Problematiche indubbiamente più serie, e a caratterizzazione sociale molto forte, sono
rappresentate dalla tossicodipendenza e dalla delinquenza giovanile. Anche in questi
casi, ancor più che per il bullismo, a profili individuali a rischio si assommano, con un
peso maggiore, fattori sociali a monte e sistemi di interazione attuale. Per es., per
l’assunzione di droga si è parlato spesso di un concorso di fattori che vanno da difficoltà
di carattere personale, all’insuccesso scolastico, alla mancanza di reti sociali forti, alla
presenza di modelli culturali o alla frequenza di ambienti che inducono all’abuso di
stupefacenti. Gelfand e Drew forniscono un elenco di correlati all’uso adolescenziale di
droga:
Caratteristiche dell’adolescente: anticipare l’età adulta, curiosità, rifiuto dei valori,
ribellione, sesso maschile, delinquenza;
Caratteristiche della famiglia: esempio genitoriale, permissività, scarso rapporto
genitori-figli;
Influenza dei compagni: amici che usano droga, influenza da loro esercitata;
Caratteristiche dell’ambiente: facile accesso alla droga.
Nei paesi in cui l’assunzione dell’alcol da parte del giovane è tipicamente associata a
problematiche sociali (questo non è il caso dell’Italia, dove può assumere
comportamenti regolativi e adattativi!), ci si è posti il problema di come attenuarne i
rischi. Per es., si è deciso di alzare a 21 anni l’età minima richiesta per poter prendere
bevande alcoliche. Gli effetti di queste iniziative non sono facili da studiare; sembra
tuttavia che, a breve termine, l’innalzamento d’età abbia delle conseguenze positive,
riducendo i casi di ubriachezza e di incidenti associati all’alcolismo, ma, sembra che, alla
lunga, questi effetti non siano mantenuti.
È noto che la tossicodipendenza è, almeno in Italia, strettamente legata alla
delinquenza giovanile. Poiché la droga è proibita, il suo uso costituisce atto di
34
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
violazione della legge, cosa questa che può essere assimilata dal ragazzo, sul piano del
vissuto, ad altre violazioni. Inoltre, procurarsi stupefacenti richiede di frequentare
ambienti delinquenziali. Il costo elevato della droga e la dipendenza che essa induce
pongono il ragazzo nella necessità impellente di procurarsela e di trovare il denaro
necessaria ad acquistarla. Se dunque è vero che il comportamento tossicodipendente
non necessariamente nasce da un profilo individuale chiaro, lo stesso discorso può
valere per altre forme di comportamento delinquenziale, in cui certe caratteristiche del
ragazzo, per es. profili legati a disturbo della condotta o DDAI, sono facilitatori. Si può
dunque dire che il giovane delinquente non presenta un profilo psicologico univoco,
mentre appare maggiore predittore di delinquenza un indice cumulativo di rischio
psicosociale che venga associato ad una storia del ragazzo. Vi sono anche stati tentativi
di differenziare tipologie di adolescenti con comportamenti delinquenziali.
Per es. si è distinto fra:
- Delinquente socializzato → si caratterizza per la condivisione con altri compagni del
proprio comportamento delinquenziale; su questa tipologia influiscono da un lato certe
rappresentazioni letterarie e cinematografiche e dall’altro forme di aggregazione
giovanile (“gang” o “banda”).
- Delinquente non socializzato psicopatico → non è legato ad un gruppo, ma, pur
mostrando un profilo esternalizzante, agisce da solo, sfida l’autorità, è aggressivo,
impulsivo, nn ha sensi di colpa.
- Delinquente nevrotico-disturbato → tende ad agire da solo e presenta
caratteristiche internalizzanti, che si riflettono in alta inibizione, timidezza, isolamento e
ansia.
Il profilo clinico più frequentemente associato alla delinquenza giovanile è
rappresentato dal disturbo della condotta. Tuttavia una serie di approfondimenti ha
indagato anche gli aspetti cognitivi e scolastici del delinquente. Per es., si è osservato
che il delinquente manca di abilità cognitive di problem solving, di pianificazione, di
anticipazione delle conseguenze delle proprie azioni, di gestione di tali conseguenze.
Sul piano scolastico, numerose ricerche hanno messo in luce come bambini con
difficoltà di apprendimento presentino maggiore probabilità di comportamento
delinquenziale. Da un lato ci può essere una serie di rapporti casuali che va dalla
difficoltà d’apprendimento alla delinquenza (la difficoltà scolastica può indurre
comportamenti delinquenziali), ma è anche possibile che il comportamento
delinquenziale porti il bambino a un basso impegno nelle attività scolastiche e ad un
conseguente insuccesso.
7. I PRINCIPALI DISTURBI EVOLUTIVI
35
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
I due principali sistemi di classificazione dei disturbi psicologici, DSM e ICD, presentano
un quadro quasi del tutto sovrapponibile.
Disturbi diagnosticati per la prima volta nell’infanzia, nella fanciullezza o
nell’adolescenza
1.Disabilità intellettuale, un funzionamento intellettivo al di sotto della
media con concomitanti deficit del funzionamento adattivo e con esordio
prima dei 18 anni.
2.Disturbo specifico dell’apprendimento, rendimento scolastico nella
lettura, in matematica o nell’espressione scritta inferiore a quanto ci si
aspetterebbe in base all’età, all’istruzione e alla valutazione psicometrica
dell’intelligenza.
3. Disturbo della coordinazione motorie: Difficoltà nella coordinazione
motoria.
4. Disturbi della comunicazione: Problemi nell'espressione e/o nella
ricezione del linguaggio.
5. Disturbi generalizzati dello sviluppo (autismo): Gravi deficit e
compromissione generalizzata di molteplici aree dello sviluppo, inclusa
compromissione della capacità di interagire e di comunicare con gli altri e
presenza di un comportamento stereotipato.
6. ADHD Disturbo da deficit di attenzione/iperattività: persistente
modalità di disattenzione e/o di iperattività-impulsività che è più
frequente e più grave di quanto si osserva tipicamente in soggetti a un
livello di sviluppo paragonabile. I sintomi devono essere presenti prima
dei 7 anni e interferire con il funzionamento in almeno due contesti.
7. DC Disturbo della condotta: modalità ripetitiva e persistente di
comportamento gravemente antisociale, solitamente di natura criminosa.
8. DOP Disturbo oppositivo provocatorio: modalità ricorrente di
comportamento provocatorio, negativistico e ostile verso le figure dotate
di autorità.
9. Disturbi persistenti della nutrizione e dell'alimentazione, come ingerire
sostanze non commestibili (pica), il ripetuto rigurgito e rimasticamento
del cibo (disturbo di ruminazione) o la persistente incapacità di mangiare
adeguatamente, che si riflette in una significativa perdita di peso o
nell'incapacità di aumentare di peso (disturbo della nutrizione
dell'infanzia e della prima fanciullezza).
10. Disturbi da tic: Caratterizzati da un movimento o da una
vocalizzazione improvvisi, rapidi, ricorrenti, aritmici e stereotipati (es.
36
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
disturbo di Tourette).
11. Disturbi dell'evacuazione: La ripetuta evacuazione delle feci in luoghi
inappropriati dopo i 4 anni d'età (encopresi) o l'emissione di urine nel
letto o nei vestiti dopo i 5 anni d'età (enuresi).
12. Disturbo d'ansia di separazione: ansia eccessiva riguardante la
separazione da casa o da coloro ai quali il soggetto è affezionato, che
arriva a causare disagio clinicamente significativo e compromissione di
importanti aree dei funzionamento.
13. Mutismo selettivo: Persistente incapacità di parlare in specifiche
situazione sociali (es. a scuola), nonostante in altre situazioni sia possibile
parlare (es. con i genitori).
14. Disturbo reattivo dell'attaccamento: modalità di relazione sociale
notevolmente disturbata e inadeguata rispetto al livello di sviluppo, inizia
prima dei 5 anni ed è associata a un accudimento grossolanamente
patogeno da parte dei genitori o di altre persone che si prendono cura del
bambino.
La definizione potrà aiutare il lettore in un primo orientamento fra le varie
psicopatologiche. Nella tabella viene presentata una distinzione fra diagnosi che
riguardano la fascia evolutiva(dis.apprendimento) e diagnosi che si applicano a tutte le
fascie d’età(schizofrenia).
L’OMS ha condotto un'altra classificazione-ICDH-2- che riguarda l’handicap, sostenendo
l’importanza di distinguere fra:
MENOMAZIONE: fa riferimento a perdite transitorie o permanenti,
<<all’esistenza di anomalie, difetti o perdite a carico di arti, organi, tessuti, incluso
il sistema delle funzioni mentali. Essa è l’esteriorizzazione di uno stato
patologico(lesione sistema nervoso centrale).
DISABILITA’: indica qualsiasi restrizione o carenza(conseguente a menomazione)
della capacità di svolgere un’attività nel modo o nei limiti ritenuti normali per un
essere umano(la difficoltà di lettura).
HANDICAP: è una condizione di svantaggio vissuta da una determinata persona
in conseguenza di una menomazione o disabilità che limita o impedisce la
possibilità di ricoprire il ruolo normalmente proprio per quella persona in
relazione al sesso, all’età, e ai fattori socioculturali(impedimento in determinate
situazioni).
L’accento è posto sui bisogni determinati da una certa condizione. L’OMS ha proposto
così un prospetto delle dimensioni. Questo prospetto offre un’idea di come sia
organizzato il sistema classificatorio; le dimensioni dell’attività(apprendimento,
37
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
comunicazione) e della partecipazione(relazioni sociali, istruzione) sono quelle che
interessano l’ambito psicologico del soggetto con handicap. completa se l’individuo ha
una compromissione superiore al 96%, “grave” se oltre il 50%. Gravità.
Funzioni e strutture attività partecipazione Fattori contestuali
8. DISTURBI DELLA CONDOTTA E I DISTURBI D’ATTENZIONE/IPERATTIVITA’
I disturbi della condotta si riferiscono a comportamenti scarsamente controllati
che violano i diritti degli altri e, nei casi più gravi, le norme sociali.
I disturbi di attenzione/iperattività si riferiscono alla difficoltà di mantenere
l’attenzione (inattenzione) e di controllare il grado della propria attività
(iperattività).
I disturbi della condotto (DC) e i disturbi di attenzione/iperattività (DDAI-
ADHD)) sono presenti in misura molto maggiore nei maschi che nelle femmine e
hanno notevoli somiglianze, soprattutto quando il disturbo DDAI riguarda anche la
componente iperattiva e presenta tratti del disturbo oppositivo-provocatorio
(DOP).
Associati ad un autocontrollo basso per entrambi i tipi di disturbo. Il fatto che
entrambi questi disturbi siano maggiormente presenti nei maschi, induce a pensare a
un eventuale fattore biologico associato al maggior grado di attività del maschio ,
accompagnato da un fattore socioculturale che porta più i maschi ad assumere profili
DC e DDAI.
I due disturbi appaiono maggiormente presenti in certi ambienti facilitanti (es.
ambienti urbani o di basso livello socioculturale). Ma questo non impedisce la
comparsa di questi disturbi in qualsiasi ambiente e contesto culturale. Oggi si tende
ad evidenziare la differenza tra DC e DOP da un lato , e ADHD anche in relazione al
fatto che per il DDAI è sempre più chiara la base psicobiologica(DSM-5). Un elemento
di differenziazione è rappresentato dalla presenza o meno di comportamenti rivolti
verso gli altri.
Nei sistemi classificatori classici i due disturbi vengono tuttavia considerati
separatamente, ma si ammette che in molti casi vi sia “comorbidità”, la presenza cioè
di entrambi gli aspetti.
Un elemento tipico di differenziazione fra DC, DOP e DDAI è rappresentato dalla
presenza o meno di comportamenti rivolti contro gli altri. (tab pag 90).
Questa griglia rappresenta i sintomi proposti dal DSM-5 per la diagnosi di ADHD. In
Italia la scala si chiama SDAI. Qui l’item sono dispari e riguardano la dimensione
dell’inattenzione e quelli pari la dimensione dell’iperattività. La parte inferiore
38
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
presenta esempi di item da utilizzare per essere sicuri che il bambino con DDAI non
presenti anche o solo disturbi del comportamento e di tipo DOP/DC.
L’ Osservazione degli insegnanti è importante perché queste problematiche
sono più evidenti nei contesti di vita quotidiana, caratterizzati da richieste di
controllo più prolungate nel tempo, da maggiore pressione emotiva, dalla presenza di
molte altre persone e dalla mancanza di un rapporto diretto interpersonale con un
adulto che possa aiutare il bambino a regolarsi.
Nel caso di Bambini con DDAI questi sono capaci di eteroregolazione, ma non di
autoregolazione. Questi bambini presentano difficoltà a pianificare i loro
comportamenti e a usare strategie efficaci per affrontare compiti, perché da soli non
riescono a imporsi una regolazione strategica, mentre, se sono aiutati dagli altri,
hanno successo nel compito. Queste osservazioni hanno notevoli implicazioni sul
piano educativo e scolastico(ADHD), là dove il DC ha implicazioni più estese che
riguardano il contesto sociali, può portare a conseguenze estreme.
Per capire le differenze fra le varie etichette diagnostiche possiamo fare riferimento
agli aspetti menzionati dal DSM-5. Esso elenca 18 sintomi caratterizzanti l’ADHD e
ipotizza che vi siano bambini che presentano solo problemi d’attenzione, o bambini
con soli problemi di iperattività e infine bambini con entrambi i problemi.
Sia il DC che il DOP si riferiscono ad una dimensione di scarso autocontrollo con
implicazioni sociali.
Tuttavia, il DOP è principalmente rivolto ad altre persone, rispetto alle quali il
bambino si mette in opposizione, senza conseguenze antisociali particolarmente gravi
e senza violazioni della legge, mentre il DC presenta un profilo di maggiore gravità e,
in qualche modo, include le caratteristiche del DOP.
Se pertanto viene effettuata una diagnosi di DC non si effettua una diagnosi
congiunta di DOP, perché si ritiene che esso sia potenzialmente già implicito nel
profilo DC. Caratteristiche che portano ad una diagnosi di DOP sono la presenza
prolungata nel tempo (almeno per 6 mesi) di almeno 4 delle seguenti caratteristiche:
1 - va spesso in collera;
2 - polemizza spesso con gli adulti;
3 – sfida spesso le regole o si rifiuta di venire incontro alle richieste degli adulti;
4 - spesso disturba intenzionalmente la gente;
5 - rimprovera spesso gli altri;
6 - è ipersensibile;
7 - è spesso arrabbiato e risentito;
8 - è spesso dispettoso e vendicativo
Nel caso, invece, del DC, la situazione appare estremamente compromessa e non facile
da gestire.
39
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Nel DSM-5 i disturbi di condotta vengono suddivisi in due momenti, quelli con
esordio nell’adolescenza(posteriori ai 10 anni) e quelli con esordio nella
fanciullezza(prima dei 10anni). Mentre per l’ICD10 si parla di disturbi di condotta con
esordio nella preadolescenza e di disturbi emozionali nel periodo antecedente
all’adolescenza.
CRITERI DIAGNOSTICI DEL DSM-5 PER IL DISTRUBO DELLA CONDOTTA(DC)
Il disturbo della condotta implica un pattern ripetitivo e persistente di comportamento in cui i
diritti degli altri sono violati. Per una diagnosi di DC devono essere stati presenti almeno tre
aspetti negli ultimi 12 mesi di cui almeno 1 negli ultimi 6 mesi.
Aggressione a persone e animali(7 aspetti tra cui bullismo, aggressioni e crudeltà)
Distruzione di proprietà(2 aspetti)
Furto(3 aspetti)
Violazioni delle regole(3 aspetti)
Il disturbo può avere insorgenza infantile o successiva e può essere di gravità leggera, moderata o
severa
L’insorgenza del disturbo è stata considerata un indice prognostico importante. nel
disturbo che si presenta solo con l’adolescenza vi sono elementi legati al contesto
sociale, che una volta venuti meno fanno scaturire i comportamenti associati.
La forma antisociale di tali comportamenti sarebbe enfatizzata dal difficile momento
di transizione, avvertito sia sul piano fisico che su quello sociale, che porta il ragazzo
ad acquisire i modi dell’età adulta (“scarto di maturità” → il ragazzo è fisicamente un
adulto, ma sul piano psicologico non lo è, ma vuole sentirsi tale.).
Una volta divenuto un adulto, l’individuo non presenterà più questo scarto e
nemmeno i problemi connessi. In altri casi, invece, il profilo DC è in qualche modo
intuibile anche nel comportamento precoce del bambino e tende a permanere nel
tempo. In effetti, la possibilità di rilevare la presenza in bambini molto piccoli di
problemi di autocontrollo è stata confermata da numerosi studi fra cui quelli sul
temperamento di G. AXIA, che ha adattato le scale per le rilevazioni degli aspetti
fondamentali del temperamento già in bambini di 1 mese. Gli studi sul
“temperamento” si sono volti a individuare stili comportamentali essenziali rilevabili
dall’osservazione del bambino anche molto piccolo. Per es. Thomas e Chess
rilevarono le 9 dimensioni temperamentali.
DIMENSIONI FONDAMENTALI DEL TEMPERAMENTO SECONDO THOMAS E CHESS:
1. ATTIVITA’- livello dell’attività motoria
2. RITMICITA’- regolarità delle funzioni biologiche(sonno, nutrizione)
3. APPROCCIO-RITIRATA- prime reazioni a stimoli nuovi
4. ADATTABILITA’- facilità di adattamento
5. INTENSITA’- livello energetico delle risposte
6. SOGLIA-livello di stimolazione utile per provocare reazione
7. UMORE- felice/non felice
8. DISTRAIBILITA’- effetto stimoli esterni sul comportamento in atto
9. PERSISTENZA- tempo per la stessa attività
40
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
I bambini piccoli, che presentano valori più bassi nelle dimensioni della ritmicità,
adattabilità, umore, persistenza e più alti nelle dimensioni della attività e
distraibilità, sono dei candidati ad avere, più avanti negli anni, problemi DDAI o DC e
altre difficoltà (es. nell’apprendimento della lettura).
9. I BAMBINI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO,
DELLA COMUNICAZIONE E DELLA COORDINAZIONE MOTORIA
Abbiamo visto come bambini e ragazzi con vari problemi possano presentare
difficoltà scolastiche anche gravi. Per esempio bambini con ADHD hanno cospicui
problemi di apprendimento. Non sempre questi problemi nascono da un nucleo
sottostante comune, perché può essere successo che un comportamento antisociale
abbia implicato un problema di adattamento scolastico.
Tuttavia, studi sulla comorbidità hanno mostrato che sono geni comuni che
contribuiscono all’insorgenza, tanto di ADHD quanto di dislessia.
I bambini con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) si caratterizzano per il
fatto di presentare a scuola difficoltà gravi e mantenute nel tempo che non sono
riferibili ad un chiaro fattore esterno (demotivazione, cattivo insegnamento).
In altre parole, disturbi specifici di
lettura(DISLESSIE EVOLUTIVE),
calcolo(DISCALCULIE),
scrittura(DISGRAFIE E DISORTOGRAFIE), ecc.
non sono dovuti al fatto che il bambino si è trovato in condizioni che gli hanno
pregiudicato questi apprendimenti, ma ad una difficoltà intrinseca (bambini dislessici
molto intelligenti ma hanno difficoltà a leggere a voce alta).
L’indipendenza degli aspetti dell’apprendimento non impedisce tuttavia che questo
determini secondariamente difficoltà emotivo-motivazionali, la cui attenuazione può
attivare un circolo positivo anche per l’apprendimento. Appaiono, quindi, efficaci
quegli approcci che non solo cercano di <<abilitare>> il bambino all’apprendimento
deficitario, ma cercano di agire su i suoi processi metacognitivi e sulla sfera
emozionale.
I criteri diagnostici dei DSA condivisi in Italia sono una bassa prestazione in una
prova standardizzata di apprendimento, una intelligenza nella norma e la possibilità
di escludere il ruolo causale di fattori come danno celebrale, scarsa istruzione.
La CONSENSUS CONFERENCE e la legge 170/2010 si sono soffermate sui disturbi
legati I primi apprendimenti scolastici, ma anche alle fasi di comprensione del testo e
la soluzione dei problemi. Come è accaduto nel DSM-5 dove la categoria DSA è unica.
Inoltre oggi si tende sempre più ad analizzare la relazione dei disturbi specifici
dell’apprendimento con varie problematiche. Due casi particolarmente contigui sono
41
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
rappresentati dai disturbi della comunicazione e dai disturbi della coordinazione
motoria.
Nell’ambito dei disturbi della comunicazione (nei casi più specifici si parla anche
di DSL e cioè di disturbo specifico del linguaggio) possono essere previste molte
categorie distinte a seconda che il problema riguardi maggiormente la sfera ricettiva
o quella espressiva o interessi maggiormente una delle dimensioni del
linguaggio(fonologica, lessicale).
Inoltre si evidenzia come un disturbo del linguaggio, tipicamente preso in
considerazione soprattutto per la fascia prescolare, possa poi sfociare in un disturbo
dell’apprendimento. In effetti, la diagnosi di DSL diminuiscono tanto più si procede
con gli anni e sembrano costituire spesso delle rilevazioni di difficoltà di sviluppo
cognitivo. Un caso particolare di disturbo del linguaggio, che non segue la storia degli
altri disturbi della comunicazione, è rappresentato dalla balbuzie(difficoltà a
produrre un discorso fluente e ritmato). La balbuzie provoca nell’individuo
interessato un disagio emotivo e comunicativo che può essere anche di elevata entità,
ma questo non significa che esso ne sia la causa, mentre più facilmente può essere un
fattore che agisce per il suo mantenimento. Vi sono elementi che mostrano il concorso
del fattore biologico, come la frequente presenza dello stesso disturbo in familiari, la
differente comparsa nei due sessi (4 volte più frequente nei maschi) o il concorso di
fattori fisiologici (scarso coordinamento fra controllo della voce, articolazione e
respirazione) che configurano il disturbo. Tuttavia il fattore biologico diventerebbe
critico in concorso con fattori di apprendimento.
Un altro disturbo evolutivo che è in relazione col disturbo specifico
dell’apprendimento è rappresentato dal disturbo della coordinazione
motoria(DISPRASSIA) e che si caratterizza per una difficoltà a sviluppare abilità di
movimento e di coordinazione del corpo. Il bambino con tale disturbo può presentare
ritardi nelle prime fasi dello sviluppo neuromotorio, ma soprattutto nella esecuzione
di azioni coordinate e finalizzate, risultare goffo e impacciato. È stato osservato che
aspetti specifici dell’apprendimento (relativi soprattutto alle aree visuospaziali)
possono essere tipicamente in difficoltà
10.Disabilità intellettiva-Ritardo mentale
A differenza del disturbo specifico dell’apprendimento, il ritardo mentale si
caratterizza per la pervasività delle difficoltà cognitive che si estendono a tutti gli
aspetti del funzionamento mentale e dell’apprendimento, provocando problemi di
adattamento alla vita sociale.
La diagnosi di disabilità intellettiva si basa sulla compresenza di un deficit
intellettivo globale e di un problema di adattamento. Il deficit intellettivo viene
stimato in base a test di intelligenza che permettono di riconoscere i livelli bassi di
42
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
intelligenza. Viene utilizzata una stima del QI(quoziente intellettivo) del bambino e
per una diagnosi di ritardo mentale, il QI deve risultare sotto i 70.
Il problema di adattamento viene valutato in relazione alla capacità dimostrata dal
bambino di affrontare contesti della vita quotidiana. La definizione di Adattamento
specifica le seguenti aree di abilità adattiva: comunicazione, cura personale, abilità
sociali, salute. In base alla definizione di disabilità intellettiva, se un bambino ha un QI
minore di 70 ma ha un adattamento sufficiente non ci sono le condizioni per la
diagnosi di ritardo mentale. Va aggiunto che se la diagnosi viene effettuata su un
soggetto con più di 18 anni, prima di diagnosticare ritardo, bisogna verificare che la
persona abbia presentato problemi simili anche durante lo sviluppo.
Esistono dei criteri tradizionali di distinzione delle fasce di gravità della disabilità
intellettiva con riferimento al livello di QI globale e al livello tipico di sviluppo.
Fascia Livello di QI Livello tipico di sviluppo
Lieve 55-69 Può raggiungere in tarda
adolescenza le Competenze tipiche di
un bambino di 10-11
Moderata 40-54 Livello di un bambino di 9 anni
Severa 25-39 Può parlare e apprendere a
comunicare
Profonda <25 Il bambino presenta un certo
sviluppo motorio
Il riferimento al QI è critico anche per la definizione della fascia di gravità della
disabilità. Ai grossi problemi di sviluppo manifestati dai bambini sono presenti
handicap associati(mentali e motorio). Nella valutazione dei fattori sottostanti alla
disabilità intellettiva, si è distinto tra fattori biologici e fattori ambientali. I fattori
ambientali(ambiente disagiato, deprivazioni) sono risultati potenziali cause di basso
funzionamento intellettivo.
Nella considerazione dei fattori biologici sta assumendo centrale importanza la
ricerca di profili comportamentali riconoscibili a seconda del genotipo sottostante. In
uno studio di Rondal, aveva cercato di sintetizzare i risultati volti a riconoscere i
diversi profili di competenza linguistica di alcune importanti forme di ritardo mentale
con genotipo identificato(down, x-fragile, williams). Questi studi sono importanti per
la conoscenza del ritardo mentale e anche perché permettono di riconoscere la
differenziabilità di diverse funzioni e il loro rapporto con assetti genetici.
43
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
11. DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO
L’espressione disturbi generalizzati dello sviluppo era stata riferita per il DSM-IV
a un ben definito gruppo di problematiche di cui l’autismo era quella più significativa.
AUTISMO - problematica nota sotto l’etichetta di disturbi generalizzati dello
sviluppo (pervasivi).
Presenta gravi deficit e compromissioni di molteplici aree dello sviluppo (di
interazione e comunicazione) e la presenza di comportamenti stereotipati.
Il disturbo più significativo è rappresentato dall’Autismo infantile precoce di Kanner,
che nel 1943 lo descrisse.
Inoltre si parla oggi di altri particolari tipi che presentano elementi di specificità,
come il Disturbo di Asperger, con profilo simile all’autismo ma con minore
compromissione dell’autonomia e della comunicazione,
Nel Disturbo disintegrativo: il disturbo compare più tardi rispetto all’autismo, e poi
abbiamo il Disturbo di Rett: degenerazione di competenze precedentemente acquisite.
Questi profili sono già evidenti nel bambino piccolo(nel caso dell’autismo compaiono
prestissimo) e questo costituisce un elemento di diagnosi differenziale rispetto alla
schizofrenia, che condivide con l’autismo il distacco dal mondo.
Gli elementi fondamentali per una diagnosi differenziata di schizofrenia e disturbo
generalizzato sono:
<l’età di comparsa
<la presenza/assenza di deliri.
L’ambito della ricerca sull’autismo è in continua evoluzione e i criteri e i cut-off per la
diagnosi non sono ben definiti.
Il DSM-5 ha apportato cambiamenti nel campo. Ha considerato in maniera unitaria
tutti i profili di autismo e ha indicato due aspetti fondamentali per la diagnosi:
1. <<Deficit persistenti nella comunicazione sociale e nell’interazione sociale in
contesti multipli>> che si riferiscono a scarsa reciprocità emotiva-sociale(con
approccio atipico all’altro e timidezze eccessive, carenze nei comportamenti
interattivi non verbali(scarso contatto oculare/uso di gesti
comunicativi)difficoltà nel fare amicizia.
2. <<Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi>> che si
riferiscono a comportamenti ripetitivi, aderenza rigida alla routine, reazioni
insolite a stimoli sensoriali.
Questi criteri diagnostici non fanno riferimento al funzionamento intellettivo globale,
per cui una diagnosi di autismo può aversi anche bambini intelligenti(chiamati “alto
funzionamento”) o con ottime capacità intellettive.
L’AUTISMO è stato oggetto di interesse per la sua fisionomia tipica , per la sua estrema
gravità, per la presenza nel bambino autistico di tratti affascinanti( bellezza,
movenze).
44
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
In merito alla natura sono state avanzate proposte di segno radicalmente opposto che
sottolineavano le difficoltà relazionali o cognitive.
In italia, in merito alle origini dell’autismo, anche sotto l’influenza di Bettelheim, che
aveva pubblicato un libro dove sosteneva che sull’autismo ha un’influenza decisiva
l’atteggiamento freddo e privo d’amore dei genitori. Non ricevendo risposte ai suoi
bisogni da parte del mondo esterno, il bambino ripiegherebbe su di sé. Ma questa
visione trova oggi poco seguito per le scarse prove empiriche e per l’emergere di
indicazioni che vanno nella direzione di evidenze su fattori organici e
neuropsicologici.
Sono state messe in evidenza nell’autismo condizioni biologiche che compromettono:
• Efficienza delle operazioni prefrontali di controllo della mente (funzioni esecutive)
• Sviluppo di una teoria della mente, cioè la capacità di concepire l’esistenza di stati
mentali altrui
• Unificazione delle rappresentazioni mentali - spiegherebbe stereotipie, rigidità e
focalizzazione sui dettagli senza una visione di insieme.
Quest’ultima teoria appare capace di spiegare le stereotipie e le rigidità, come gli
aspetti cognitivi, che indicano tutti una focalizzazione sui dettagli e l’assenza di un
quadro d’insieme.
Il Bambino Autistico non è portato a concepire l’insieme, ha cioè una predisposizione
a elaborare le caratteristiche di dettaglio degli stimoli, presente nella quotidianità.
Sul piano delle “teorie esplicative”, secondo la TEORIA SOCIOMOTIVAZIONALE
DELL’AUTISMO(TSM) l’assenza di attenzione verso i pattern sociali è dovuta
all’alterazione dei meccanismi neurali che mediano i rinforzi sociali. Un deficit
nell’attribuire un valore emotivo e di rinforzo agli stimoli sociali determinerebbe una
scarsa attenzione verso l’interazione sociale.
La scoperta dei Neuroni Specchio ha portato a evidenziarne l’importanza per
l’autismo: meccanismi imitativi(attivazioni dei neuroni specchio) sono infatti meno
presenti nel bambino con autismo.
Il trattamento dell’autismo
-l’opzione psicodinamica è stata spesso associata alla posizione psicogenetica di Bettelheim che collegava il disturbo
a carenze affettive della madre. Una conseguenza estrema di questa posizione era la rottura del legame inadeguato.
Ma nell’ambito dei settori psicanalitici si sono avuti proposte diversificate di trattamento con effetti positivi.
- fin dagli anni 70 si è assistito ad una reazione di marca comportamentistica. I pionieri tra cui Lovaas hanno
mostrato che è possibili modificare il comportamento. Questi successi hanno avuto simpatie per le tecniche
comportamentali(ABA-Applied Behavior Analysis)
-metodi come il TEACCH di ispirazione cognitivo comportamentale, che prendono in considerazione l’intero contesto
di vita del ragazzo sono i più completi.
12. DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL’ALIMENTAZIONE
45
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Nella sfera del rapporto con il cibo possiamo trovare, in età evolutiva disturbi
diversificati:
DISTURBI DELLA NUTRIZIONE, della prima infanzia e della fanciullezza,
che si riflettono nell’ingestione di sostanze non commestibili, nel ripetuto
rigurgito, nell’incapacità di consumare adeguatamente il cibo e quindi di
crescere;
DISTURBI SEVERI DELL’ALIMENTAZIONE, caratterizzato dell’ingestione di
cibo eccessivamente scarsa( anoressia nervosa) o abbondante(bulimia
nervosa). Sono presenti a tutte le età in entrambi i sessi, ma compaiono nelle
ragazze tra i 14 e i 18 anni.
13.DISTURBO DA TIC E DI EVACUAZIONE
Molti bambini presentano piccoli tic, legati al movimento o alla vocalizzazione.
Questi, se sono presenti, costituiscono indice psicopatologico solo se si mantengono
nel tempo e assumono accentuazioni eccessive.
Un caso particolare è il DISTURBO DI TOURETTE che lo diagnosticò per la prima
volta nel 1885, che si diagnostica quando:
<<compaiono con elevata frequenza sia tic motori, sia almeno un tic legato all’uso
della voce. Qui, il tic è così presente ed inopportuno da provocare serie difficoltà
sociali>>.
In merito ai DISTURBI DELL’EVACUAZIONE si riferiscono <<all’incapacità di
controllare l’eliminazione dell’urina(enuresi) e delle feci(encopresi)>>.
Il sintomo è considerato rilevante se compare con frequenza dopo i 5 anni. Anche se a
5 anni continua da essere abbastanza comune soprattutto nei maschi, ma dovrebbe
risolversi entro i 12 anni, poiché se presente in questa fascia d’età richiede un’attenta
considerazione.
La ricerca ha individuato fattori genetici, fisiologici e psicologici correlati al disturbo
dell’enuresi. I fattori organici pesano moderatamente sull’enuresi notturna, mentre
possono avere un peso maggiore nei casi di enuresi diurna. I fattori organici possono
essere legati a infezioni del sistema genito-urinario.
In merito alle possibili procedure di trattamento è stata ideata da due studiosi la
tecnica del “pad and bell”, vicina al principio del condizionamento classico.
La tecnica ha subito variazioni. Sono previsti anche interventi farmacologici.
14. DISTURBI D’ANSIA E DEPRESSIONE
46
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Nei bambini possono comparire diversi problemi emozionali, riscontrabili anche negli
adulti ma con caratteristiche specifiche.
Le paure dei bambini costituiscono un elemento tipico dello sviluppo. Ovviamente a
diverse età i bambini presentano tipiche paure specifiche o vere e proprie fobie legate
a differenti oggetti.
8 mesi-2 anni Ansia da separazione(mamma-caregiver)
2-4 anni Animali, buio
4-6 anni Fantasmi,mostri
6-13 anni Timori di essere attaccati o feriti
adolescenza Paura di non essere accettati
Con il passare degli anni il bambino impara a riconoscere la sua paura e a trovare
modi per gestirla, ma possono emergere nuove paure.
In generale a diverse età i bambini presentano paure specifiche legate a differenti
oggetti che con il passare del tempo vengono riconosciuti e valutati.
I PROBLEMI DI ANSIA si caratterizzano per:
• un’eccessiva risposta emotiva a situazioni che non la giustificano;
• Associati ad una errata valutazione cognitiva della situazione.
• Inducono a reazioni fisiologiche(male allo stomaco) che possono stabilizzarsi e
produrre malattie psicosomatiche(l’asma).
PRINCIPALI DISTURBI D’ANSIA
DISTURBO D’ANSIA GENERALIZZATO: il bambino prova un’ansia irrealistica
ed eccessiva, che non è giustificata dal contesto, né ha carattere transitorio;
DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO: il bambino presenta frequentemente
ossessioni o pulsioni a ripetere certi atti che causano tensione e difficoltà a
svolgere una vita normale. Il bambino è ad esempio agitato frequentemente
da immagini, o ripete comportamenti non funzionali;
DISTURBO D’ANSIA DA SEPARAZIONE: il bambino presenta un eccessiva
ansia di separazione da casa o dalla persona cui è affezionato dimostrando
disagio e incapacità di affrontare la vita di ogni giorno;
FOBIA PER LA SCUOLA: il bambino presenta paura per la scuola, evita il più
possibile di andare a scuola con lunghi periodi di assenza di cui i genitri sono
a conoscenza.
Molti di questi disturbi compaiono negli adulti ma possono aversi nei bambini. Da una
ricerca sul disturbo ossessivo-compulsivo del bambino esso riguarda dei rituali legati
alla pulizia.
Un disturbo d’ansia presente nello sviluppo è quello di separazione, in cui il bambino
ha paura di essere separato dalla madre. Disturbo che compare verso i 6- mesi. Gli
studi sull’attaccamento(Bowlby-Ainsworth) di questa fase e il suo superamento hanno
avuto importanza in merito all’individuazione di se stesso da parte del bambino. Si
ipotizza che se non ci sono state condizioni per un buon attaccamento o che la
47
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
separazione sia avvenuta in maniera non ottimale, il bambino continui a mantenere
un ansia si essere separato dalla persona che si prende cura di lui. La fobia per la
scuola può essere associata ad ansia da separazione, perché essa costituisce una
forma di separazione forte dalla casa.
In merito alle cause delle ansie dei bambini, oltre ai fattori psicodinamici legati al
rapporto figura madre-bambino sono state citate cause genetiche, fisiologiche e
comportamentali. In particolare l’analisi comportamentale si è interessata a
individuare fattori di apprendimento che possono aver portato il bambino ad
associare a determinate situazioni certe risposte d’ansia.
Il disturbo d’ansia può essere associato al disturbo depressivo. Nel bambino vengono
rilevati gli stessi sintomi dell’adulto ma risultano spesso accentuati gli elementi di
irritabilità. Un’altra relazione fra depressione in fase evolutiva e depressione
nell’adulto è legata al fatto che l’una se presente in adolescenza ha elevate probabilità
di portare all’altra. In merito al trattamento nei bambini sono risultati utili gli
interventi di tipo cognitivo comportamentali.
15. PSICOLOGIA CLINICA E MEDICINA
Gli aspetti psicologici possono causare disturbi fisici “psicosomatici” o essere elementi
concomitanti importanti di malattie fisiche.
• in casi di disturbi del sistema nervoso centrale(SNC) a un disturbo neurologico
corrispondono difficoltà di funzionamento cognitivo che possono riguardare la
cognizione, la percezione, il linguaggio...
• Una malattia somatica può indurre disturbi neuropsicologici.
• Una malattia fisica può apportare problemi emozionali.
Qui si inserisce il ruolo dello Psicologo Clinico dello sviluppo che può offrire un aiuto ai
medici in caso di bambini affetti da HIV o cancro, utile per alleviare le difficoltà del
bambino. Può attuare alcune modalità come:
Colloqui
Presentazioni di modelli positivi
Esercizi di respirazione.
48
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
CAP 4 - LA MALATTIA MENTALE. LA FOLLIA E LA SUA
STORIA
- La follia ha percorso la storia dell’umanità attraverso i secoli e ha spesso suscitato
terrore. Nel tempo si è fatta strada un atteggiamento civilmente responsabile. Gli
psicologi clinici sono coloro che si occupano di malattie mentali-
1. LA FOLLIA E LA SUA STORIA
Nell’antichità classica troviamo 2 concezioni della follia:
1. Follia inviata dagli dei per punire qualcuno
2. Follia per i filosofi (Ippocrate di Cos) è una malattia come le altre e più
precisamente in un’affezione del cervello. Queste due concezioni convivono
nell’antichità greco-romana.
Con il cristianesimo scompaiono gli dei ma rimangono i demoni. Un esempio è la
comparsa del termine <<ossessione>> è derivazione di <<ossesso>>, che non è altro
che un demone minore codificato nella demonologia medievale.
Per tutto il medioevo i folli venivano visti come persone indemoniate che dovevano
essere allontanate dalla città o addirittura uccise, solo la preghiera li poteva salvare.
Con l’umanesimo e il rinascimento la condizione dei folli accenna a migliorare.
Anche nella pittura fiamminga si riscontrano eventi del genere, come la “NAVE DEI
FOLLI”.
Nel 1527 vicino a Londra viene fatto costruire l’Hospital of St. Mary Of
Betlehem(betlemme) per custodire i lunatici che viene storpiato in Bedlam sinonimo
di confusione caotica.
Il termine ospedale non deve trarre in inganno poiché i luoghi della follia erano ospizi
e prigioni in cui i soggetti non erano affatto curati ma semplicemente gettati in
prigione.
Solo l’illuminismo e la rivoluzione francese liberarono queste persone dalle catene
inflitte loro e da una rappresentazione sociale imperniata su superstizioni e
stregonerie.
Philippe Pinel <<spezzando le catene degli alienati>> attuò una riforma di carattere
umanitario affermando che i sofferenti affidati alle sue cure erano esseri umani e in
quanto tali spettavano loro diritti e dignità proclamati dalla rivoluzione francese.
Pinel affermava che i sofferenti affidati alle sue cure erano esseri umani e in quanto
tali spettavano loro diritti e dignità. Pinel sosteneva che<< i malati di menti lungi
dall’essere per questi meritevoli di punizione, avevano bisogno di rispetto. Noi dal
canto nostro dobbiamo sostenerli e restituire loro ragione>>. È questo il cosiddetto
<<trattamento morale>>
49
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Pinell sviluppò una nosografia medico-filosofica con un trattato del 1801 che
classifica i disturbi mentali in 4 categorie:
1. Melanconia e depressione
2. Mania ed estrema eccitazione
3. Idiozia e ritardo mentale
4. Demenza e confusione mentale
In Italia Chiarugi fece riadattare l’ospedale di Bonifazio e introdusse un
atteggiamento di assistenza ai malati di mente improntato all’umanità e alla
razionalità. Il folle è vittima di errori di giudizio, ovvero fallaci interpretazioni della
realtà.
Chiarugi viene considerato forse il primo professore al mondo di malattie mentali.
In Germania invece sul finire dell 800’ Kraepelin considerato il vero padre della
psichiatria moderna attua una differenziazione tra psicosi maniaco-depressiva e
schizofrenia (dementia precox che esordisce in età giovanile).
Con K. Si apre la stagione della psichiatria descrittiva il cui compito principale era
quello di descrivere quadri clinici ed evoluzioni al fine di dare anche il proprio nome
alla malattia ,come fù per Alzheimer.
50
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
In questa ottica i fenomeni psicopatologici vengono concettualizzati come
manifestazioni di sottostanti malattie mentali, cioè una modalità della persona di
essere nel mondo, ciascuna con un’evoluzione tipica.(box paresi generale p. 114)
La cultura tedesca sviluppò oppositori della nosografia psichiatrica di Kraepelin.
Binswanger e Jaspers diedero vita alla psicopatologia fenomenologica che vede la
malattia mentale come uno dei modi di porsi dell’essere umano e una particolare
disposizione soggettiva nei confronti della realtà e della vita interpersonale.
Il rimprovero mosso alla psichiatria descrittiva fu quello di interessarsi più alle
malattie che ai malati.
In un’ombra totale sorse e prosperò l’istituzione manicomiale per tutto il
Novecento.
Ma la grande svolta si ha con Freud e con il pensiero psicanalitico, che:
- ammorbidì il concetto di malattia mentale
-ridiede continuità tra normalità e patologia
-venne sviluppata la psicogenesi delle malattie mentali meno gravi, le psiconevrosi.
-venne indicata una metodologia di trattamento.
La prospettiva psicoanalitica anche se non assoluta e incontrastata fu egemone per
gran parte del secolo scorso. Sono nell’ultimo terzo del 900’ si affermò un paradigma,
quello comportamentale e cognitivo che si pose in alternativa a quello
psicoanalitico, dalla perdita dell’egemonia psicoanalitica emerse una terza forza: il
modello familiare e sistemico.
Oggi si è sviluppata una diffidenza verso ogni sorta di riduzionismo- l’atteggiamento
che spiega un fenomeno sulla base di una sola ipotesi- e prevale il riferimento al
principio di causalità multipla cioè che a nessun caso di malattia mentale è
attribuibile una sola causa ma le malattie mentali sono sempre ascrivibili al concorso
di molteplici fattori.
Si è soliti distinguere tali fattori a seconda che:
• Fattori remoti al momento dell’esplosione del disturbo, detti Fattori di diatesi
(vulnerabilità)
• Fattori prossimi al momento del disturbo, detti Fattori precipitanti (stress)
Si parla quindi di “modelli diatesi-stress” in quei casi dove si cerca di ricostruire le
complesse interazioni tra molteplici fattori e si avanza l’ipotesi che la maggior parte
dei disturbi sia causata da una combinazione di vulnerabilità predisponente (diatesi)
e alcune circostanze precipitanti (stress).
Si parla anche di modelli socio-psico-biologici che ci porta a considerare le 3 classi di
fattori che si incontrano nello studio delle malattie mentali:
1. Fattori che traggono origine dall’ambiente sociale, culturale, educativo e familiare
51
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
2. Fattori che traggono origine dalla specifica elaborazione psicologica che il
soggetto opera nell’esperienza(personalità, emozioni, pensiero)
3. Fattori che traggono origine dalla ereditarietà e da successive possibili alterazioni
del funzionamento del sistema nervoso.
(box 4.2pag116)
2. STIGMA SOCIALE
Il termine “STIGMA” indica un insieme di atteggiamenti, stereotipi e credenze che un
gruppo sociale o la società nutre nei confronti di gruppi sociali particolari che ritiene
devianti e tiene ai margini.
I <<malati di mente>> continuano oggi ad essere oggetto di uno stigma sociale e
l’OMS ritiene che lo stigma sia l’ostacolo più importante e negativo ai futuri progressi
nel campo della salute mentale.
Il processo di stigmatizzazione prevede 4 fasi:
1. Etichettatura: si crea una etichetta che identifica un gruppo di persone e che può
essere descritta come un marchio negativo
2. Etichetta viene associata a credenze e stereotipi propri di quella società
3. le persone che rientrano nell’etichetta non sono considerate per se stesse, ma in
virtù dell’etichetta e Attributi propri all'etichetta connotano le persone che
rientrano nell'etichetta come diverse, meno umane.
4. In virtù dell’etichettamento il gruppo stigmatizzato perde lo status e diviene
oggetto di discriminazioni.
Lo stigma è spesso basato sull’ignoranza, su mancanza di informazioni, su
convinzione infondate, su paure irrazionali, su fenomeni di contagio e conformismo
sociale, e può essere fomentato dai media.
La prima fase-etichettatura- è cruciale e clinici e psichiatri sono restii a formulare
diagnosi che possano generare stigma. I professionisti della salute mentale hanno un
sacrosanto terrore delle profezie autoattuate- quelle in cui chi prevede contribuisce
all’attuazione dell’evento predetto.
Etichettare una persona con un qualche termine potrebbe esacerbare i
comportamenti problematici dell’interessato.
Gli psicologi sanno che l’etichetta potrebbe diventare una profezia che si
autoadempie, e conoscono l’effetto Rosenthal. Robert Rosenthal fu reso celebre da una
sua ricerca nella quale ad alcuni insegnanti viene detto all’inizio dell’anno scolastico,
52
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
cha alcuni loro allievi avrebbero avuto presto uno sviluppo brillante. A ciò non era
vero, i bambini erano stati scelti a caso. Alla fine dell’anno scolastico, questi bambini
avevano raggiunto risultati scolastici alti. Essere guardati con aspettative positive
dagli insegnanti è un aiuto oggettivo.
La dignità della persona non deve essere mai sminuita da una diagnosi clinica, e viene
deprecato il vizio di sostantivizzare attributi tratti dal lessico diagnostico.
3. INCAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE
Per capacità di intendere significa riconoscere correttamente il significato e il
valore dei fatti e delle azioni e le loro conseguenze morali e giuridiche secondo la
cultura corrente.
Per capacità di volere intendiamola capacità di agire o il non agire come
conseguenza di una scelta libera e ragionata.
<<CAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE>> è quindi un concetto legale, quando una
persona è affetta da infermità mentale è incapace di provvedere ai propri interessi e
su provvedimento del tribunale può essere interdetta o viene nominato un tutore.
Attualmente chi compie un reato per vizio di mente può essere imputabile e costretto
al ricovero in un ospedale psichiatrico giuridico.
Una incapacità di intendere e di volere riduce o elimina addirittura la responsabilità
in sede penale.
4. TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
Il trattamento sanitario obbligatorio(TSO) ha sostituito il ricovero coatto previsto
dalla legislazione psichiatrica del 1904,che si basava sul concetto di pericolosità per
se e per gli altri.
Ora è una procedura finalizzata alla tutela della salute e viene disposto quando:
• Esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici
• L’infermo non vuole sottoposi volontariamente a questi trattamenti
• Non ci sono le condizioni che consentono di adottare tempestive e idonee misure
straordinarie extraospedaliere.
Il TSO è disposto dal sindaco del comune dove risiede la persona su proposta
motivata di un medico. La persona viene accompagnata insieme ai vigili, medici o
infermieri entro 48 ore.Il ricovero ha luogo presso servizi psichiatrici di diagnosi e
cura. Il TSO è stato istituito dalla legge cosiddetta Basaglia di riforma psichiatrica.
(box 4.4-p 122)
53
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
.
5. ISTITUZIONI TOTALI E RIFORMA PSICHIATRICA
GOFFMAN- in “ASYLUMS, LE ISTITUZIONI TOTALI-Un istituzione totale viene
definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che si trovano a
dividere una situazione comune cioè l’essere tagliate fuori dalla società trascorrendo
parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato.
Goffmann descrive ciò che realmente succede in una istituzione totale, li descrisse
come prigioni, manicomi e campi di concentramento, dove vi è una degradazione
degli esseri umani, descrive queste come delle situazioni che derubano l’individuo
della sua identità producendo una patologia specifica chiamata sindrome da
istituzionalizzazione.
Molti studiosi hanno ritenuto che la cronicità manicomiale fosse in gran parte il
prodotto di una patologia istituzionale: abolendo l’istituzione si aboliva la patologia
aggiuntiva data dall’istituzionalizzazione.<<Il manicomio va distrutto e non
riformato>> è stata La parola d’ordine del movimento antistituzionale legato alla
figura di Franco Basaglia.
Franco Basaglia (1924-1980) nacque a Venezia è studiò Medicina e neurologia a
Padova. La sua formazione culturale fu influenzata dalla fenomenologia di
Heidegger. Pensava che la follia fosse presente in ognuno di noi come la ragione, ma
la società denigra la prima e accetta solo la seconda, dando il compito alla
psichiatria di eliminarla. Arrivato all’Ospedale psichiatrico di Gorizia come
Direttore trovò una situazione degradata. Presto quello di Gorizia divenne un
<<Ospedale aperto>>, operando una rivoluzione nella prassi assistenziale da
divenire il punto di riferimento del movimento “antiistituzionale italiano”.
Basaglia nel 1963 operò una trasformazione della cultura e della prassi assistenziale
e ottenne l’approvazione della legge 180/1978 nota come legge Basaglia.
Questa impose la chiusura dei manicomi e limitò il TSO, obiettivo era ridurre la
segregazione e attuare riconoscendo pieno dei diritti e la necessità di una vita di
qualità dei pazienti meglio seguiti e curati da ambulatori territoriali. Accanto al
rifiuto dell’istituzione totale veniva quindi proposta una rete di servizi diffusi con
ricorso all’assistenza domiciliare, all’uso di strutture residenziali non ospedaliere, day
hospital e comunità terapeutiche orientate verso la riabilitazione. La legge 180 era
una legge Quadro che affidava alle regioni il compito di organizzarne l’applicazione.
Ma Oggi esiste il rischio di sviluppare una nuova cronicità relativa all’inadeguatezza
delle cure. Poiché dalla dimissione dei pazienti questi, dopo un periodo ritorno
nell’istituzione, creandosi così il fenomeno della porta girevole. Inoltre
54
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
l’inadeguatezza delle cure porta il soggetto a ricadute sul piano fisico e a una deriva
sociale.
6. SALUTE MENTALE BASATA SULLE EVIDENZE(p. 125)
Dagli anni 80 si è diffuso in tutto il mondo delle professioni sanitarie un nuovo
atteggiamento volto a migliorare la qualità delle cure e delle prestazioni sanitarie.
Il Pioniere di questa svolta è stato, l’epidemiologo Cochrane, il quale richiama
l’attenzione sulla grande ignoranza che c’è circa la reale efficacia di molte pratiche
sanitarie, e sull’assenza di valutazioni e controlli nelle strutture e nelle attività
sanitarie.
Il primo punto ruota intorno:
• l’Opportunità di far dipendere le decisioni sanitarie da un’adeguata prova di
efficacia(una terapia va considerata inefficace fino a prova contraria). Questa
posizione in contrasto con interessi consolidati. Decidere in base a evidenze di
efficacia implica una crescita della metodologia e della qualità della ricerca e la
necessità di non dar credito allo sperimentalismo dozzinale, ovvero una teoria va
considerata inefficace fino a prova contraria. Si apriva una stagione di confronto
collegiale basta sulla forza della documentazione.
• Diffusione delle conoscenze in materia sanitaria.
Con la diffusione di internet la consultazione sulla letteratura scientifica non era
agevole per il professionista. Inoltre pochi professionisti hanno poca familiarità con
una grande biblioteca scientifica presenti negli ospedali. Inoltre è complesso il
problema dell’accesso alle conoscenze da parte dei malati. Sono apparse cosi riviste
scientifiche on-line(EVIDENCE-BASED MEDICINE).
Gli sviluppi delle comunicazioni informatiche infatti hanno potenziato e diffuso
l’accesso all’informazione più qualificata.
Questo movimento internazionale va sotto il nome della Medicina Basata sulle
Evidenze ed è volto a:
1. Promuovere standard di cura migliori
2. Attenuare le differenze nel livello delle prestazioni sanitarie tra diverse regioni
3. Basare sull’evidenza scientifica le decisioni nelle politiche sanitarie
4. Valutare quantitativamente l’efficacia degli interventi
5. Valutare la qualità delle cure e la soddisfazione degli utenti
6. Disseminare tra i professionisti i risultati di ricerca in forme accessibili
7. Creare linee guida di aiuto e indirizzo.
55
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
La pratica di questa Medicina non è altro che l’uso coscienzioso, esplicito delle
migliori evidenze nel prendersi cura di singoli pazienti. La pratica della medica
basata sull’evidenza significa integrare l’esperienza clinica individuale con le migliori
evidenze cliniche esterne offerte dalla ricerca. In questo contesto la pratica clinica e
l’esperienza attuata dalle evidenze scientifiche attuali possono offrire migliore
applicabilità e risultati.
Ma questo atteggiamento incontra ancora resistenze; esse comportano una
diminuzione di potere della politica e dell’ideologia nelle grandi scelte sanitarie.
Questo mutato clima culturale ha interessato anche il mondo della salute mentale e
sempre più spesso si parla di salute mentale basata sulle evidenze.
56
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
7. LINEE GUIDA
L’espressione LINEE GUIDA indica una serie di strategie diagnostiche e terapeutiche
mirate a facilitare le decisioni cliniche, si tratta di una serie di raccomandazioni o
norme comportamentali cliniche, utili nell’iter diagnostico, per specifiche categorie di
pazienti.
Le linee guida sono opera di comitati rappresentativi basate sulle evidenze
scientifiche sempre più aggiornate. Possono essere sviluppati da gruppi locali di
professionisti, da società o riviste scientifiche. L’autorevolezza di tali linee guida varia
in rapporto alla credibilità scientifica degli organismi e alla validità dei percorsi
metodologici utilizzati.
I comitati nello specifico integrano i vari dati empirici e le opinioni del gruppo di
lavoro e rendono esplicito il livello di affidabilità di ogni raccomandazione.
Le singole raccomandazioni sono siglate con delle lettere:
• A: procedura o test diagnostico fortemente raccomandato perché sostenuto da prove
scientifiche di buona qualità
• B e C: procedure sulle quali si nutrono dubbi
• D e E: riservate a procedure sconsigliate.
Le linee guida classificano anche i livelli di prova che sono alla base delle
raccomandazioni. Si parla di <<prove di tipo I>> quando derivano da più studi clinici
controllati. Le cifre successive indicano prove via via meno solide, la cifra più
alta(VI)indica il caso più debole dove sono assenti evidenze scientifiche.
Gli obiettivi principali della redazione delle linee guida sono:
1. Migliorare la qualità dell’assistenza
2. Ridurre le disparità geografiche e sociali
3. Ridurre i costi
4. Promuovere comportamenti professionali rivolti vs efficacia e appropriatezza.
Le linee guida possono essere d’aiuto per facilitare la comunicazione tra pazienti e
professionisti attraverso l’uso di un linguaggio comprensibile.
Le linee guida non hanno mai carattere prescrittivo: il giudizio finale deve essere
espresse dal clinico, alla luce dei dati clinici del paziente. Le linee guida non devono
essere confuse con i protocolli diagnostici-terapeutici.
Le linee guida sono raccomandazioni e suggerimenti per il curante con un elevato
grado di flessibilità mentre i protocolli sono schemi predefiniti che descrivono il
percorso diagnostico-terapeutico di gruppi di pazienti.
Esistono dei limiti e dei pericoli associati alla diffusione delle linee guida:
• Difficoltà di applicazione in contesti assistenziali degradati e disomogenei
57
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
• Rischio di sviluppare dei ricettari e di trascurare lo studio approfondito del paziente
• Difficoltà di coniugare l’inevitabile rigidità delle linee guida con il bisogno di
specificità e il desiderio di autonomia degli operatori sanitari
• Timore dell’incremento del numero di cause intentate per negligenza professionale.
Le linee guida sono presenti anche in merito alla sfera della salute mentale. Dal 1851
l’APA(American Psychiatric Association) pubblica raccomandazioni specifiche allo
scopo di assistere gli psichiatri nel processo decisionale al fine di migliorare
l’assistenza ai pazienti.
Il NICE (National Institute For Health and Clinical Excellence) è l’agenzia di governo
inglese incaricata di fornire indicazioni e linee guida per promuovere la salute in
termini di prevenzione e assistenza da parte del SSN(servizio sanitario nazionale).
Cosa fa il NICE? Stende periodicamente linee guida nei vari ambiti della salute
mentale. Esso ha attivato un sito per la più ampia consultazione. È considerata
un’agenzia autorevole.
8. EPIDEMIOLOGIA DEI DISTURBI MENTALI
L’epidemiologia è la disciplina che studia la frequenza e la distribuzione dei
fenomeni morbosi –nel nostro caso dei disturbi mentali- e alcune variabili che
contribuiscono alla loro insorgenza e diffusione. Il tasso di prevalenza è il numero di
casi presenti in un dato momento in una popolazione, specificando l’intervallo
temporale cui ci si riferisce(12 mesi o per tutta la vita).
Gli studi epidemiologici sono complessi e costosi. Per quanto concerne lo studio
epidemiologico italiano quello più importante è stato condotto a Sesto Fiorentino, ma
tali studi mancano di rappresentatività cioè i risultati non possono essere
generalizzati con sicurezza, poiché i risultati possono essere influenzati da un’infinità
di variabili. Una strategia consiste nel fare ricorso a procedure di campionamento
statistico. Così è possibile rappresentare nel campione un’intera nazione.
In Italia nel 2000 ha preso vita un ampio progetto internazionale per uno studio
epidemiologico delle comunità, chiamato WHO.(box 4.5 pag. 130)
La sezione Europea(ESEMeD) di studi sui disturbi mentali mette in luce che in Europa
1 persona su 4 va incontro ad un disturbo mentale almeno una volta nella vita,
(depressione, ansia o fobie sono quelli più comuni).
Si può stimare che in Italia più di 8,5 milioni di Adulti abbiano sofferto di disturbi
mentali.
58
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Nell’epidemiologia delle malattie mentali, non sono insolite differenze tra paesi vicini.
A denotazione della crucialità di fattori ambientali, il livello dello sviluppo
socioeconomico, gli stili di vita.
La differenza in rapporto al genere: le donne hanno il doppio delle probabilità di
andare incontro a disturbi mentali rispetto agli uomini, per via degli stereotipi che
descrivono l’uomo forte e la donna fragile. Gli unici disturbi che hanno tassi comuni
nei due sessi sono le psicosi(schizofrenia), mentre a carattere prevalentemente
maschile abbiamo l’abuso di sostanze e il disturbo antisociale di personalità.
Una delle variabili comunemente considerata in questi studi è l’età: la malattia
decresce con il procedere dell’età. Ma bisogna tenere conto del fatto che le
generalizzazioni e le inferenze possono essere ingannevoli, bisogna quindi attenersi
sempre a dati empirici puntuali.
9.COMORBIDITA’
Le diagnosi dei disturbi mentali, non sono autoescludenti, anzi il fatto di soffrire di un
determinato disturbo aumenta la probabilità di soffrire anche di altri disturbi
mentali. Con il termine “Comorbidità” si indica la presenza contemporanea di due o
più disturbi mentali. Notoriamente, la Depressione è la categoria in cui più spesso si
osserva comorbidità, mentre le fobie specifiche sono il disturbo cui meno si associano
altri disturbi.
Altra categoria dove si riscontrano percentuali elevate di comorbidità è quella dei
disturbi di personalità.
10. RICORSO AD AIUTO SPECIALISTICO
Secondo diversi studi la maggior parte delle persone con problemi mentali non è
assistita né da professionisti né dai servizi sanitari e in ciò pesano variabili culturali e
storici, pregiudizi e disponibilità delle strutture. In Italia il servizio sanitario
nazionale è gratuito(diversamente da altri paesi), e gli interessati possono accedere
ai servizi di salute mentale senza la mediazione del medico di famiglia.
CAP 5 - SCHIZOFRENIA E ALTRI DISTURBI PSICOTICI
59
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
La schizofrenia è la malattia mentale per eccellenza e anche la più temuta.
Gli psicologi clinici sono presenti a vari livelli: valutazione, cura, riabilitazione,
sostegno familiare.
1. ALLUCINAZIONI E DELIRIO
Allucinazioni e deliri sono i sintomi psicotici per eccellenza.
Per ALLUCINAZIONE – si indica lo stato psichico in cui un individuo percepisce come
reale ciò che è immaginario
Le allucinazioni possono riguardare ciascuna modalità sensoriale(olfatto, vista,
somatiche) e possono essere con o senza consapevolezza.
Inoltre esperienze allucinatorie possono aversi anche in soggetti non affetti da
disturbi mentali.
Esse vanno distinte dalle illusioni nelle quali viene erroneamente interpretato e
percepito uno stimolo esterno effettivamente presente.
Per DELIRIO – si intende una falsa convinzione, è costituito da false credenze che una
persona mostra su qualcosa o su qualcuno, tale convinzione è basata su errate
deduzioni riguardanti la realtà esterna e viene fortemente sostenuta a dispetto di
quanto tutti gli altri credono e di prove incontrovertibili della sua falsità.
I DELIRI vengono suddivisi sulla base del loro contenuto:
-DI CONTROLLO = la persona ritiene che i propri sentimenti o comportamenti siano
sotto il controllo di una forza o di una volontà esterna.
-EROTOMANICI = la persona crede che una persona sia innamorata di lei e cerca di
corrispondere a distanza opprimendola.
-DI GELOSIA = la persona è convinta che il proprio partner sia infedele.
-DI GRANDIOSITA’ = il soggetto è convinto di disporre di un particolare talento.
- DI PERSECUZIONE = essere vittima di cospirazione
-DI RIFERIMENTO = ad esempio leggendo il giornale una persona interpreta un
titolo di un articolo come messaggio rivolto direttamente a se stesso.
-SOMATICO = ha come tema centrale l’ aspetto o il funzionamento del proprio
corpo(pensare di avere insetti all’interno del proprio corpo,o emanare cattivo odore)
-DI TRASMISSIONE DEL PENSIERO= credono che i loro pensieri sono visti o letti dagli
altri.
I sintomi psicotici vengono raggruppati in 2 ampie categorie, utilizzati per la diagnosi
della schizofrenia:
60
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
1. SINTOMI POSITIVI: riflettono una distorsione e un eccesso di funzioni normali.
Essi includono:
• Allucinazioni
• Deliri
•Eloquio disorganizzato: distorsioni del linguaggio e comunicazione nella quale si
riflette la disorganizzazione del pensiero(perdere continuamente il filo del discorso)
•comportamento disorganizzato = distorsioni del controllo del comportamento che
possono variare da stupidità infantile a difficoltà nell’esecuzione di attività della vita
quotidiana. Si parla di comportamento <<catatonico>> quando vi sono marcate
anomalie motorie, che corrispondono a gradi diversi di reattività all’ambiente fino
alla totale immobilità motoria. Sempre nel comportamento catatonico si indicano
mutacismo, ecolalia(ripetizione frase pronunciata da un’altra persona) ed ecoprassia
(imitazione movimenti).
2. SINTOMI NEGATIVI: riflettono una diminuzione o perdita delle funzioni normali:
• Appiattimento dell’affettività: si dimostra come una sorta di indifferenza emotiva
all'ambiente circostante e come scarsa reattività emotiva agli stimoli
• alogia = il paziente ha ridotta iniziativa e trascorre molto tempo in stato di
inattività, si interessa di poche cose o di nulla, appare trascurato.
• abulia= il paziente prova diminuito piacere o interesse scarso o nullo per molti
aspetti della vita
2. SCHIZOFRENIA
CONSIDERATA IL DISTURBO MENTALE PIÙ GRAVE, È FORTEMENTE INVALIDANTE E
LIMITA L’AUTONOMIA SIA NELLA VITA PRIVATA CHE IN QUELLA RELAZIONALE.
La famiglia del paziente è di solito estremamente coinvolta e si trova ad affrontare un
carico notevole di preoccupazioni.
Ma oggi si sono fatti passi avanti nelle cure di questo disturbo, diminuendo così
l’allarme e lo stigma sociale.
La schizofrenia rappresenta tutto un mondo enormemente diversificato. Essa assume
diverse forme tanto che alcuni autori ritengono che il termine sia usato per includere
tutta una serie di disturbi in realtà diversi, altri parlano di spettro schizofrenico, cioè
un gruppo di disturbi collegati e in sovrapposizione tra loro con origini comuni.
Si tratta di un disturbo universale, che si trova per lo più nei paesi sviluppati, ma
risulta più elevato in aree urbane rispetto a quelle rurali,è un disturbo complesso e
multiforme.
Per parlare di schizofrenia è richiesta la presenza di almeno 2 dei sintomi positivi o
negativi sopracitati.
61
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
La schizofrenia comporta un grave deterioramento di una o più delle principali aree
di funzionamento (come il lavoro,le relazioni interpersonali,la cura di sé),la durata è
superiore a 6 mesi. Vi sono diversi <<sottotipi>> che sono definiti dalla sintomatologia
predominante al momento della valutazione, che può variare nell’evoluzione della
malattia.
I SOTTOTIPI sono:
• di tipo Paranoide: che ha come manifestazione essenziale la presenza di deliri e
allucinazioni uditive in un contesto di funzioni cognitive e di affettività preservato
•di tipo Catatonico: che ha come manifestazione principale la sintomatologia
catatonica.
di tipo Disorganizzato: è caratterizzata da discorsi disorganizzati,
comportamenti incoerenti.
di tipo indifferenziato: che non si caratterizza in nessuno dei tre tipi
precedenti pur presentando i sintomi della schizofrenia;
di tipo residuo: che descrive un quadro clinico successivo alla fase attiva, nella
quale i sintomi positivi sono molto attenuati.
Sembra lievemente più comune nel sesso maschile, dove tende ad avere un decorso più
grave con minori probabilità di guarigione.
L’esordio è giovanile (15 e 35 anni) ed è per questo che è stata denominata da
Kraepelin “demenza precox”. L’esordio ha un valore mediano di 22-23 anni.
Il decorso si ha in 3 FASI :
1. PRODROMICA: non è sempre identificabile, dove l’esordio dura mesi o anni;
2. ATTIVA: compresenza della sintomatologia acuta tipicamente psicotica,
3. RESIDUALE: non sono più presenti i sintomi psicotici precedenti ma non è ancora
possibile la ripresa della vita precedente; si osserva scarsa attività e appiattimento
dell’emotività.
3. ALTRI DISTURBI PSICOTICI(pag.142)
Il termine PSICOTICO – è un termine “scientificamente ambiguo”, non ha una
definizione unanimemente accettata, sulla base della quale si sono costruite tutte le
violazioni e i processi di stigmatizzazione ed emarginazione. Esso:
62
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
• sul Piano concettuale - indica la perdita dei confini dell’io ed una compromissione
importante dell’esame della realtà.
• sul Piano normativo - viene definito psicotico un disturbo mentale che comporta
menomazioni che interferiscono consistentemente con le capacità di soddisfare le
esigenze ordinarie della vita.
Oggi si tende a privilegiare le Definizione basata sulla sintomatologia - circoscrive il
termine psicotico a deliri e allucinazioni rilevanti senza consapevolezza. Definizioni
più inclusive non richiedono l’assenza di consapevolezza della natura patologica del
Delirio o delle Allucinazioni. Alcuni disturbi possono essere ricondotti a una
condizione medica generale(neoplasie, malattie cerebrovascolare), oppure possono
essere indotti da sostanze. Allucinazioni e deliri possono essere anche la conseguenza
di stati di astinenza da alcool o droghe.
I disturbi sono:
1. DISTURBO DELIRANTE
2. DISTURBO PSICOTICO BREVE
3. DISTURBO SCHIZOAFFETTIVO
4. DISTURBO SCHIZOFRENIFORME
DISTURBO DELIRANTE
La caratteristica di questo disturbo è la presenza di uno o più deliri, che persistono
per un mese. Il tipo di disturbo delirante è specificato in base al tema delirante
predominante(gelosia, di grandezza). A parte il delirio il normale funzionamento
dell’individuo non è compromesso. L’esordio si ha in età avanzata. Il decorso è
variabile; in alcuni casi il disturbo può guarire entro pochi mesi o può diventare
cronico.
DISTURBO PSICOTICO BREVE -
È un’alterazione che comporta l’insorgere improvviso di: deliri, allucinazioni, eloquio
disorganizzato, comportamento catatonico. E' un episodio di grave alterazione
mentale che si risolve nell'arco di qualche giorno, senza esiti e con completo recupero.
L'esordio è acuto spesso in seguito ad un evento psicosociale gravemente stressante
Caratteristiche:
• Stato di confusione e agitazione emotiva molto intensi, rischio di suicidio molto alto.
Il rischio di suicidio è alto. La sua insorgenza può aversi a seguito di eventi che
provocherebbero segni di sofferenza(grave incidente, morte). Se ne considera
l’insorgenza nel post partum.
DISTURBO SCHIZOAFFETTIVO
E' una grave forma di disturbo mentale.
63
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Presenta la combinazione di sintomi psicotici con caratteristiche di un disturbo
dell’umore, durante il periodo di malattia sono presenti allucinazioni ed episodi
maniacali . Forte rischio di suicidio. La prognosi è migliore della prognosi della
schizofrenia.
DISTURBO SCHIZOFRENIFORME - la sintomatologia è costituita dai sintomi
positivi della schizofrenia. L’episodio di malattia ha durata compresa tra uno e sei
mesi. La durata della malattia è intermedia tra quella del disturbo psicotico breve e
quella della schizofrenia.
4. EREDITA’ E AMBIENTE NEI DISTURBI MENTALI: IL CASO DELLA SCHIZOFRENIA
L’eziologia della schizofrenia esemplifica il Principio di causalità multipli e offre
l’opportunità di valutare con un caso particolarmente significativo e studiato , quanto
possa pesare il fattore genetico nell’insorgenza del disturbo mentale. Nell’anamnesi
uno dei primi dati da raccogliere è la familiarità. Le evidenze a sostegno di un rischio
genetico sono molto forti e provengono da tre tipi di studi:
-1.studi sulla frequenza di schizofrenia tra i familiari di pazienti schizofrenici
-2.studi sui gemelli
-3.studi sulle adozioni
Gli studi sulla Famiglia di pazienti schizofreneci provano che Il fattore di rischio più
importante è la familiarità: nelle famiglie in cui un membro soffre di questa malattia
gli altri membri hanno una probabilità più elevata di sviluppare la malattia; inoltre i
membri di una stessa famiglia condividono sia i geni sia un’ambiente abitativo
culturale e sociale e vicende relazionali e affettive. Ma non si può provare un
contributo genetico.
2. Gli studi sui gemelli, ricordano che i gemelli monozigoti hanno tra loro una
similarità genetica del 100% mentre i gemelli dizigoti non sono più simili tra loro dei
fratelli normali e condividono solo metà dei geni. Qui si ha una dimostrazione
inequivocabile di un contributo genetico nella trasmissione della schizofrenia
3. Nel confronto tra i bambini adottati quelli che hanno genitori biologici schizofrenici
hanno un rischio nettamente superiore di sviluppare la malattia. Il meccanismo di
trasmissione genetica è tuttora sconosciuto. Studi di genetica molecolare ci dicono
che la vulnerabilità per la schizofrenia non è trasmessa da un solo gene e almeno sette
64
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
diverse regioni cromosomiche sono state identificate, negli studi sui legami genetici
come possibili siti di geni di trasmissione della schizofrenia. L’idea di una vulnerabilità
poligenetica è molto più di un ipotesi: geni multipli concorrerebbero a trasmettere il
disturbo.
È affascinante la Tesi evoluzionistica - sostiene che i geni connessi alla malattia hanno
un vantaggio evolutivo adattivo e il corredo genetico essendosi mantenuto nel tempo
potrebbe indicare un vantaggio adattivo della specie.
Questi dati consentono osservazioni abbastanza fondate sul problema eredità-
ambiente. Se la schizofrenia fosse dovuta interamente a cause genetiche il tasso di
concordanza tra gemelli monozigoti dovrebbe essere al 100% invece non è che la
metà. Ma dobbiamo dire che un gemello dizigote condivide tutta la vita
intrauterina(influenze, fumo, paure). Circa l’importanza della vita uterina è
interessante sapere che tra i gemelli monozigoti il tasso di concordanza è doppio in
merito alla condivisione della stessa placenta. Nella vita successiva, l’ambiente è la
mamma che prepara tutto. Cosa diversa con fratelli nati in momenti diversi.
5. EZIOLOGIA DELLA SCHIZOFRENIA
Sono state riscontrate anomalie strutturali nel cervello dei pazienti schizofrenici
attraverso studi post mortem e tecniche di neuroimaging.
La dilatazione dei ventricoli comporta una perdita di tessuto cerebrale e una
riduzione della materia grigia della corteccia prefrontale. L’origine di tali anomalie
deriverebbe da danni sottili prodottisi durante la gestazione o il parto. Poiché la
corteccia prefrontale matura tardivamente durante l’adolescenza tali danni si
manifesterebbero solo nelle fasi successive. Gli studi post mortem hanno mostrato
anomalie nei sistemi neurotrasmettitoriali. Particolare rilevanza ha assunto il
sistema dopaminergico ( Ipotesi dopaminergica –afferma che i sintomi psicotici e
la schizofrenia derivano da un’eccesiva trasmissione di dopamina in alcune aree
cerebrali) a partire dagli anni 50, alcuni studiosi francesi scoprirono che un
antistaminico il Cloropromazina (neurolettico) primo farmaco antipsicotico - riduce
la disponibilità di dopamina nel cervello ed elimina deliri ed allucinazioni. Si era
aperta una nuova stagione per il trattamento della
65
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
schizofrenia. Ma questo farmaco aveva però come effetti. collaterali sintomi di tipo
parkinsoniano. A riprova di ciò le amfetamine, che aumentano il rilascio di dopamina,
esacerbano i sintomi schizofreneci. La teoria doparminegica non pretende però di
essere una teoria esaustiva, ma è incontestabile che i sistemi neurotrasmettitoriali
giocano un ruolo centrale nella malattia.
L’eziologia della schizofrenia è INQUADRABILE NEL MODELLO DIATESI-STRESS. I
fattori genetici sono solo predisponenti ed è necessario per l’insorgenza della
patologia l’intervento di fattori ambientali. È verosimile che i pazienti ereditano
fattori genetici di rischio, ma è comune nella popolazione generale e ha un effetto di
ampiezza ridotto. L’interazione tra tali fattori e di essi con l’ambiente deve
raggiungere una soglia critica. Limiti di alcune teorie eziologiche che si sono
avvicendate nel passato recente: fra queste quella di Frieda From-Reichemann –
psicoanalista tedesca, divenuta famosa per aver coniato l’espressione madre
schizofrenogena ed aver sostenuto che sarebbero le madri a causare la schizofrenia-
madri fredde, dominanti, manipolative, distaccate, oppressive, rifiutanti e
ipercoinvolte sono tra le cause della patologia. Qui l’indice puntato sulla madre
rifletteva una società rurale dove la famiglia era forte è la madre il perno. Ma la
Fromm-Reichmann scontava limitate basi empiriche e autarchia culturale.
Un'altra analisi deriva dalla Scuola di Palo Alto dove Bateson –antripologo inglese,
che si era occupato di società primitive. Sviluppo la tesi che la schizofrenia trae
origine nelle disfunzioni di comunicazione all’interno della famiglia. Bateson qui
riconosceva caratteristiche comuni con la sua TEORIA DEL DOPPIO LEGAME.
La Teoria del doppio legame(box 5.1 pag 149)
Il doppio legame indica una situazione in cui la comunicazione tra due individui, uniti
da una relazione emotivamente rilevante, presenta una incongruenza tra il livello
verbale (quello che viene detto a parole) e quello non verbale (gesti, atteggiamenti,
tono di voce ecc.), e la situazione sia tale per cui il ricevente del messaggio non abbia
la possibilità di uscire fuori da questo schema stabilito dal messaggio, o
metacomunicando o chiudendosi in sé stesso. Come esempio Bateson riporta l'episodio
della madre che dopo un lungo periodo rivede il figlio, ricoverato per disturbi mentali.
Il figlio, in un gesto d'affetto, tenta di abbracciare la madre, la quale si irrigidisce; il
figlio a questo punto si ritrae, al che la madre gli dice: "Non devi aver paura ad
esprimere i tuoi sentimenti".
66
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
A livello di comunicazione implicita (il gesto di irrigidimento) la madre esprime
rifiuto per il gesto d'affetto del figlio, invece a livello di comunicazione esplicita (la
frase detta in seguito), la madre nega di essere la responsabile dell'allontanamento,
alludendo al fatto che il figlio si sia ritratto non perché intimorito dall'irrigidimento
della madre, ma perché bloccato dai suoi stessi sentimenti; il figlio, colpevolizzato, si
trova impossibilitato a rispondere.
Rifacendosi ai suoi studi sui livelli di apprendimento, Bateson e il suo gruppo
ipotizzano che nei contesti schizofrenogeni si possano riscontrare delle esposizioni
croniche a situazioni familiari, con particolare riguardo alla madre, di doppio legame .
Tale esposizione comporterebbe nel soggetto l'incapacità di valutare correttamente i
legami tra comunicazione esplicita ed implicita adoperati dalle persone normali. Ad
esempio, la persona, posta di fronte a semplici domande quali "come stai oggi?", "cosa
stai facendo?", non riuscirebbe ad accettarle come domande prive di doppi fini non
contraddittori. La sindrome schizofrenica diviene così un tentativo di fuga, di non
comunicazione in un contesto in cui ogni comunicazione è "pericolosa. Questa
situazione per verificarsi ha bisogno di alcune condizioni:
1. due o più persone;
2. esperienza ripetuta;
3. un’ingiunzione primaria negativa;
4. un’ingiunzione secondaria in conflitto con la prima;
5. una terza ingiunzione negativa che impedisce alla vitta di fuggire.
Questo costrutto ebbe larga eco, tanto che nel 1961 gli autori vennero insigniti
del Frieda Fromm-Reichmann Award dall'Academy of Psychoanalysis[3]. Tuttavia da
allora l'ipotesi per la quale ricorrenti esposizioni a situazioni di doppio legame
fossero riscontrabili in contesti schizofrenogeni viene costantemente distorta,
sostenendo che Bateson e il suo gruppo dichiararono che il doppio legame causa la
schizofrenia (si veda più sotto il paragrafo Critiche).
Oltre al doppio legame come situazione patogena, Bateson propone
in psicoterapia l'uso di forme di doppio legame terapeutico, in grado di sbloccare le
situazioni di discomunicazione, in cui lo schizofrenico precipita costantemente. Una di
queste tecniche è la “prescrizione del sintomo”, un intervento paradossale a fini
terapeutici basato sul doppio legame fra paziente e terapeuta
Tra i neuropsicologici attratti dagli enigmi dei deliri troviamo Frith che ha ipotizzato
che i sintomi positivi derivano dal cattivo monitoraggio di pensieri, impulsi e azioni.
67
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Non vengono riconosciuti come tali e confusi con pensieri estranei (voci che gli
parlano) che si inseriscono nella propria mente.
Secondo Frith è possibile identificare un unico processo cognitivo definibile come
meta-rappresentazione o consapevolezza di sé (processo cognitivo) responsabile di
alterazioni che impediscono al soggetto di mantenere il controllo di azioni e pensieri
percependoli come creati dall’esterno.
In linea con la scuola di Palo Alto, Laing uno dei padri dell’antipsichiatria, egli
sosteneva che la schizofrenia è una reazione di difesa di individui soffocati dalle
pressioni sociali e familiari (risposta sana ad un ambiente malato). Dove ad essere
malata è la società. La Malattia mentale, non va repressa ma accettata. Riteneva che
lo sviluppo della schizofrenia in un componente di una famiglia disfunzionale potesse
ridurre tensioni presenti all’interno. In un certo senso il malato si sacrificava per il
bene della famiglia.
L’attenzione alle famiglie dei pazienti schizofrenici è sfociata nell’identificazione di un
costrutto quello di emotività espressa familiare, che compendia i sentimenti
negativi espressi dai familiari nei confronti del congiunto sofferente di schizofrenia. Si
è visto da studi che nelle famiglie ad alta emotività espressa maggiore è il tempo
d’esposizione, maggiore è il rischio di ricadute. Utile in questi casi sarebbe alleggerire
il clima familiare.
6. TRATTAMENTO
Il trattamento della schizofrenia e della psicosi, richiede l’intervento di più figure
professionali coordinate e il ricorso ad una struttura che garantisca la presa in carico
articolata.
Nelle fasi acute il ricovero è necessario e i Servizi di diagnosi e cura ne sono le
strutture dedicate.
Il ricovero è breve e dopo la dimissione il trattamento prosegue presso strutture
territoriali (ambulatori di igiene mentale, centri diurni, servizi di riabilitazione).
Tra le terapie il Trattamento ideale è quello che abbini terapia farmacologica e
interventi psicosociali mirati ad abbassare il livello di emotività fatti soprattutto in
quelle famiglie ad alta emotività espressa. Sono utili gli interventi di psicoeducazione,
dove prevale il contenuto informativo.
Nel caso di pazienti senza un retroterra familiare servono strutture intermedie, come
alloggi protetti e residenze psichiatriche.
L’intervento riabilitativo per pazienti che hanno perso competenze elementari per la
vita è svolto in un regime di day hospital. Si utilizzano tecniche di social skills training.
Le attività propriamente psicologiche attuano un recupero e un potenziamento delle
competenze cognitive di base e il nome generale entro cui vengono ricondotte queste
attività è la riabilitazione neuropsicologica.
68
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Altre pratiche diffuse sono:
-il counseling psicologico
-la terapia di sostegno
Le esperienze più promettenti si collegano ad interventi su pazienti giovani al primo
esordio.
7. INTERVENTI PRECOCI
Anche se oggi non si ricorre a compagne di screening e di preparazione, è di estrema
attualità l’intervento precoce con soggetti al primo episodio psicotico per prevenire
la transizione alla psicosi conclamata e rendere meno drammatica l’evoluzione della
malattia. Anche in Italia si parla di diagnosi precoce della schizofrenia, nella
speranza che un intervento preventivo possa scongiurare la crisi psicotica. ELEMENTI
CHIAVE DELL’INTERVENTO PRECOCE:
1. Riconoscimento dell’esordio psicotico e assistenza precoce
2. Valutazione e trattamento della crisi
3. Sostegno nella fase di recupero.
Nella Valutazione diagnostica, le scale di valutazione sono le sole capaci di assicurare
una discreta accuratezza diagnostica, esempi di tali scale sono:
-La SCID-5
-La Brief Psychiatric Rating Scale
-La PANSS
La valutazione neuropsicologica , la presenza di segni neurologici sfumati, le tecniche
di imaging, non sono dotate di accuratezza diagnostica dimostrata.
La Terapia farmacologica antipsicotica è doverosa e consiste in basse dosi di
neurolettici atipici(remissione dei sintomi nei primi 3 mesi nel 50% dei casi, al 75%
nei sei mesi e all’80% nei 12 mesi) . L’aderenza farmacologica costituisce un problema
poiché percentuali elevate di pazienti interrompono la terapia o non rispettano i
tempi. Se è vero che il Trattamento farmacologico può ridurre i sintomi psicotici e
anche vero che il recupero funzionale non è rapido ed i pazienti dopo un primo
episodio psicotico tendono ad avere un deterioramento del funzionamento generale
sociale che può perdurare anche se presente un trattamento farmacologico
ottimale.Da ciò l’interesse degli interventi psicosociali per ridurre la disabilità.Sono
raccomandati trattamenti psicoeducativi familiari mirati ai nuclei familiari e training
di competenza sociale in gruppo/individualmente.
La configurazione ideale dell’assistenza richiede:
-team specializzato nell’intervento precoce
-collocazione dedicata
69
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
-domiciliazione dell’assistenza farmacologica e degli interventi familiari
-personalizzazione del piano di crisi
-gestione integrata dei casi.
PROGNOSI- LAREGOLA DEI TERZI
Dopo un periodo acuto si può fare riferimento alla regola dei terzi(OMS):
- circa 1\3 guarirà tornando alla vita precedente senza ricadute;
- 1\3 si riprenderà ma dovrà continuare ad assumere farmaci, con una diminuzione nella vita sociale;
- L’ultimo 1\3 evolverà verso una condizione cronica. Condurrà una vita di <<malato mentale>>.
70
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
8. TRATTAMENTI BIOLOGICI INVASIVI
Ippocrate aveva osservato che chi soffriva di convulsioni traeva giovamento dalla
febbre quartana (febbre intermittente che si presenta ogni 4 giorni). Nella storia
della medicina si trova a lungo l’idea che una malattia(ad esempio l’induzione di una
febbre) potesse risolversi in un beneficio per una malattia più grave.
Negli anni ’30 del ‘900 acquistò popolarità l’idea che potesse essere terapeutico
indurre crisi di tipo epilettico nei pazienti psichiatrici, se presentavano soprattutto
sintomi catatonici.
-Meduna(psichiatra ungherese)sperimentò diverse sostanze che potessero produrre
crisi convulsive(assenzio, caffè, canfora), ebbe qualche successo terapeutico con una
sostanza chiamata Metrazol che divenne di uso frequente con i pazienti affetti da
schizofrenia o psicosi maniaco-depressiva.
-Nello stesso periodo alcuni psichiatri tedeschi svilupparono metodiche convulsivanti
iniettando dosi di insulina sufficienti a far entrare in coma il paziente attraverso
shock ipoglicemico,una metodica molto pericolosa che poteva risultare fatale.
-Nel 1938 due neurologi italiani Cerletti e Bini scoprirono di poter indurre convulsioni
facendo passare impulsi di corrente elettrica attraverso le regioni
temporali(elettroshock),questa metodica essendo meno pericolosa ebbe più fortuna
delle altre, continuò e continua ad essere utilizzata anche se raramente. L’essenza del
trattamento era lo scatenamento di una crisi epilettoide, così la metodica
elettroconvulsionante ebbe più successo di altre.
-Sempre negli anni ’30 risale la Psicochirurgia - Il neurologo Moniz scoprì
l’importanza dei lobi prefrontali nei deliri e nei comportamenti violenti. Pensava che
resecando le innervazioni che connettono i lobi al talamo si potessero avere benefici.
Nonostante ricevette il Nobel nel 1949, dalle sperimentazioni si mostrò che non si
otteneva la scomparsa dei deliri, ma una diminuzione del .
Gli storici si sono interrogati su come sia stato possibile che metodiche di dubbia
fondatezza potessero essere praticate. Tra le spiegazioni:
- assenza di risorse nel trattamento degli psicotici;
- la spregiudicatezza della classe medica
- il bisogno di autoconvincimento di poter fare qualcosa di utile.
<<Suggerimenti per il colloquio clinico e l’assessment>>
Identificare l’esordio della fase prepsicotica è tutt’altro che facile. I sintomi
psicotici raramente insorgono all’improvviso.
I Sintomi Psicotici positivi attenuati: idee di riferimento, credenza bizzarre,
pensiero e linguaggi bizzarri. Altri sintomi sono: diminuzione significativa
dello stato mentale, decadimento neuropsicologico.
È importante riconoscere la Fase Prodromica(deliri, allucinazioni,
71
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
abbassamenti dell’umore).
Sappiamo che la familiarità è un fattore di rischio. L’anamnesi cercherà la
presenza di malattie mentali nei familiari.
Gli elementi scatenanti sono: delusioni, affettive, fallimenti( scolastici e
lavorativi). Attraverso il colloquio possiamo concentrarci sul tema.
72
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
CAP 6 - DISTURBI DEPRESSIVI E BIPOLARI
I Disturbi dell’umore sono molteplici, presentano differente gravità e diverse sono le
modalità di intervento. Più di una persona su dieci va incontro a un disturbo
depressivo. Valutazione e trattamento di tali disturbi sono problemi comuni nella
pratica psicologica clinica.
Un EPISODIO DEPRESSIVO MAGGIORE - episodio perchè costituisce un fatto
transitorio; un episodio di almeno due settimane che presenta un cambiamento
rispetto al precedente livello di funzionamento dell'individuo con sintomi che causano
disagio clinicamente significativo, o compromissione del funzionamento sociale,
lavorativo o in altre importanti aree. - si caratterizza per la presenza di almeno 5 dei
seguenti sintomi in assenza di un lutto nei due mesi precedenti l'episodio. I sintomi
possono essere vari:
• Cambiamento rispetto al precedente livello di funzionamento dell'individuo
• Umore depresso per la maggior parte del giorno
• Diminuzione di interesse o di piacere per quasi tutte le attività
• Significativa perdita o aumento di peso o dell’appetito
• Insonnia o ipersonnia quasi ogni giorno
• Agitazione o rallentamento psicomotorio
• Faticabilità o mancanza di energia
• Sentimenti di autosvalutazione
• Ridotta capacità di pensare o di concentrarsi
• Pensieri ricorrenti di morte
La loro presenza può in molti casi essere negata dall’interessato, ma osservata e
riferita dai famigliari.
Spesso l’episodio fa seguito a un grave evento stressante(morte di un caro).
Nella maggior parte dei casi con la conclusione dell’episodio si ha una remissione
completa dei sintomi, e il funzionamento ritorna ai livelli premorbosi.
La prognosi non è favorevole dopo il primo episodio poiché si ha alta probabilità di
avere altri episodi.
Un Disturbo depressivo maggiore è caratterizzato dalla presenza di un episodio
depressivo dal decorso variabile a cui si seguono altri episodi
Si parla di Depressione ricorrente con decorso clinico quando si hanno almeno 2
episodi depressivi maggiori in un intervallo di 2 mesi.
73
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Un Disturbo distimico –si caratterizza per un umore cronicamente depresso in un
periodo di almeno 2 anni con sintomi meno negativi che non pervengono a un
episodio depressivo maggiore. Non va confuso con lo stile ritirato e introverso
dell’individuo.
1. EZIOLOGIA DELLA DEPRESSIONE
La causa della depressione è multifattoriale, dove interagiscono molteplici fattori di
diatesi (predisposizione costituzionale allo sviluppo della malattia) e fattori di
scatenamento; nell’eziologia della depressione va attribuito a fattori genetici poco più
di un terzo della varianza, un ruolo moderatamente importante che può determinare
una maggiore o minore vulnerabilità a fronte di ulteriori fattori depressogeni che si
possono incontrare nel corso della vita. Oggi si ritiene che il modello di ereditarietà
sia poligenico. Il concorso di più geni che modulino le strutture celebrali coinvolte
nella regolazione dell’umore, meglio ai accorderebbe con le anomalie biologiche che si
possono avere nei disturbi depressivi( aumento di peso, aumento /diminuzione di
sonno(ereditarietà). Gli Studi di brain imaging riscontrano nel
corso di depressione una forte iperattività dell’amigdala e fronte di una
diminuzione dell’attività della corteccia prefrontale. Esso suggerisce l’idea di una
risposta emozionale estremamente intensa a determinati stimoli, risposta che non
viene controbilanciata dai sistemi cerebrali coinvolti.
Vari dati collegano la depressione all’alterazione endocrine ed elevati livelli di
cortisolo. Il cortisolo è il principale ormone dello stress e viene secreto nei momenti di
stress per preparare l’organismo a far fronte a eventuali minacce, ma un eccesso di
cortisolo dà luogo a sintomi simili a quelli della depressione. Le anomalie
neuroendocrine derivano dallo squilibrio dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, cioè dal
sistema che controlla la reattività dell’organismo allo stress. Qui è l’amigdala che
durante un episodio depressivo sollecita l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene.
Anche il protrarsi di stressor (maltrattamenti, assenza supporto genitoriale) durante
lo sviluppo infantile, potrebbe aver compromesso il meccanismo omeostatico che
regola l’adattamento allo stress. Accanto alla diatesi biologica sono alcuni FATTORI
DI RISCHIO di natura PSICOLOGICA:
1. STRUTTURA DI PERSONALITÀ: il costrutto prognostico più solidamente attestato
è una dimensione di personalità definita nevroticismo o labilità emozionale,
misurata nei test della personalità. i risultati di tali test sono in grado di predire il
rischio di un individuo di sviluppare un episodio depressivo.
2. MODALITÀ DI ELABORAZIONE COGNITIVA: sul piano cognitivo sono stati
identificati stili di pensiero che possono rappresentare veri e propri fattori di
vulnerabilità cognitiva. oggi si ritiene che talune peculiarità nei processi di pensiero
possano giocare un ruolo causale e che nella malattia si rendano conclamate
74
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
anomalie prima latenti. Costrutto cruciale è quello di schemi cognitivi (es. visione
negativa del sé) di origine infantile e adolescenziale dovuti a esperienze
negative( genitori ipercontrollanti, madri depresse, favoriscono la tendenza a
sviluppare uno stile attribuzionale interno, stabile e globale in base al quale gli eventi
negativi della vita vengono attribuiti dall'interessato a cause a lui interne, che lo
coinvolgono nella totalità della sua vita. Eventi negativi nella vita adulta
attiverebbero tali schemi favorendo la depressione. I fattori cognitivi rappresentano
una via ultima comune dove confluiscono l’insieme di fattori psicologici che
conducono all’insorgenza della depressione.
3. SUPPORTO SOCIALE – la persona che vive all’interno di una rete sociale ricca,
stimolante può recepire sostegno quando si trovi ad affrontare periodi negativi della
sua vita. Essa riguarda la percezione soggettiva dell’interessato rispetto alla sua rete
familiare o sociale; può essere più o meno positiva e originare reazioni di isolamento.
La TEORIA ATTUALE della depressione si colloca nella cornice diatesi-stress: non
necessariamente un episodio depressivo è scatenato da accadimenti particolari.
4 CASI PIÙ COMUNI a cui si può ricondurre l’episodio depressivo:
1. PERDITE: incapacità di elaborare il lutto,
2. TRANSIZIONE DI RUOLO: divorzio e difficoltà ad adattarsi alla nuova condizione,
3. CONFLITTI DI RUOLI: riguardanti il mondo del lavoro, difficoltà nel trovare un
proprio ruolo e nelle relazioni
4. DEFICIT INTERPERSONALE: scarse competenze sociali.
Ma stressors altrettanto comuni sono di tipo cronico:
- matrimonio sbagliato;
- condizione di povertà;
anche situazioni banali possono far insorgere depressione, come la perdita di un
animale domestico o un trasloco.
Linee guida NICE per il trattamento della IN CASO DI DEPRESSIONE MODERATA
depressione - Proporre una terapia farmacologica
Il NICE –National Istituite for Health and
Clinical Execellence- riporta le indicazioni in
- Valutare il rischio di suicidio
merito alla depressione. - Controllare la risposta ai trattamenti.
Esso utilizza la terminologia suggerita dall’ICD- - in caso di risposte parziali indicare la
10:depressione lieve(4 sintomi),moderata(5-6 psicoterapia cognitivo-comportamentale
sintomi), severa(7 o più sintomi) come trattamento d’elezione.
IN CASO DI DEPRESSIONE LIEVE: IN CASO DI DEPRESSIONE SEVERA
- prendere in considerazione eventuali - Proporre l’abbinamento farmacologico
casi di ansia o mancanza di sonno con la psicoterapia cognitivo-
- informare i pazienti che in ogni età comportamentale
l’umore trae giovamento dall’esercizio In caso di depressione ricorrente
fisico. - Continuare per 2 anni il tratt.
- I farmaci antidepressivi non sono Farmacologico e prendere in
consigliati considerazione una psicoterapia
cognitiva.
75
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
- Considerare un programma di Ospedalizzazione
autoaiuto - Il ricovero ospedaliero deve essere con
- Considerare il trattamento psicologico pazienti a rischio di suicidio.
focalizzato sulla
depressione(counseling).
Siamo lontani dal disporre una teoria della depressione ma possiamo dire che, la
DEPRESSIONE è un esempio di ciò che si intende per causalità multipla, dove
convergono in interazione molteplici fattori di diatesi e molteplici fattori di
scatenamento(stress). Il ruolo dei geni è presenta ma i fattori genetici hanno un peso
moderato e al massimo possono giustificare poco più di un terzo della varianza. Per
arrivare al disturbo abbiamo bisogno di molteplici fattori. Nel corso delle sue prime
fasi di vita l’individuo può sviluppare caratteristiche di personalità di tipo
depressogeno che in contatto con eventi di vita negativi determinano l’episodio
depressivo. Allo psicologo clinico è richiesto di ricostruire ad personam – senza
generiche ricette_ un modello verosimile dei fattori in gioco in un episodio depressivo.
2. I FARMACI COME AIUTO AL LAVORO DELLO PSICOLOGO CLINICO: IL CASO
DEGLI ANTIDEPRESSIVI
L'uso dei farmaci può aiutare il lavoro psicologico sui disturbi mentali, sia a livello di
placebo ma anche di nocebo(cambiamento negativo). Questo vale anche per i disturbi
psichiatrici, tra cui la depressione è il caso più significativo.
AGLI INIZI DEGLI ANNI 50'
A rivoluzionare la terapia della depressione fù un farmaco l'iproniazide(della classe
IMAO-inibitori della monoaminossidasi) sviluppato in origine per la tubercolosi, che
rendeva inattivi gli enzimi che ossidano le monoamine( serotonina, dopamina),i pazienti
in trattamento dovevano osservare una dieta ferrea per non incorrere a crisi
ipertensive- detto effetto formaggio e Chianti.
VERSO LA FINE DEGLI ANNI 50'
Fu introdotta l'imipranina capostipite di una seconda classe di
antidepressivi(antidepressivi triciclici) che inibiscono la ricaptazione di noradrenalina e
seretonina. Questi bloccano la pompa che riassorbe parte delle molecole del
neurotrasmettitore. Questi che hanno sostituito le IMAO hanno alcuni effetti collaterali,
come aumento di peso, stanchezza nausea.
Verso la fine degli anni 80, Si è sviluppata una terza classe di antidepressivi gli SSRI –
inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina-la loro azione sui
neurotrasmettitori è più selettiva
76
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Essi presentano minori effetti secondari e sono considerati i farmaci di prima scelta e
non danno dipendenza ma va comunque evitata un'interruzione brusca.
Un trattamento biologico innovativo è la STIMOLAZIONE MAGNETICA
TRANSCRANICA. essa consiste nell'applicazione di campi magnetici al cervello diretti
su precise aree cerebrali(corteccia prefrontale dorsolaterale sinistra), il trattamento
pare privo di effetti collaterali non è doloroso e non richiede anestesia.
Gli antidepressivi agiscono aumentando la disponibilità di serotonina e
noradrenalina, i due neurotrasmettitori al cui calo è legata la maggior parte dei
sintomi.
EFFETTI
• Aumento del sonno,
• Miglioramento dell’umore,
• Aumento di appetito,
• Stanchezza riduzione di prestazioni cognitive, motorie ed erettili.
77
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
3. LA TERAPIA PSICOLOGICA DELLA DEPRESSIONE
Gli antidepressivi hanno il vantaggio di poter dare sollievo già dopo due settimane,
mentre la psicoterapia ha tempi più lunghi per evidenziare un miglioramento.
L’OBIETTIVO: non è il sollievo immediato, ma la prevenzione delle ricadute
Si attende la fine o l’alleviamento dell’episodio depressivo prima di iniziare il
trattamento (durante la depressione il pz è poco recettivo ad un’analisi psicologica).
L’efficacia aumenta con l’abbinamento di antidepressivi.
Il trattamento raccomandato dalle linee guida è di tipo cognitivo-comportamentale,
con procedure che si sono considerate empiricamente utili.
Una variante di trattamento è la terapia cognitiva orientata alla
<<mindfulness>>. Il termine mindfulness indica uno stato mentale nel quale si pone
attenzione al momento presente in maniera non giudicante. Col tempo il paziente
apprende a collocarsi in un ottica decentrata, osserva i propri pensieri come se fossero
oggetti da esaminare. Questa forma di trattamento è utilizzata nei casi di depressione
ricorrente.
Esistono altre forme di trattamento psicologico che possono essere prese in
considerazione. La Psicoterapia interpersonale(IPT) è un intervento
psicodinamico breve, derivato dalla prospettiva delle relazioni oggettuali. È un
intervento strutturato e limitato nel tempo. L’attributo <<interpersonale>> descrive il
cardine dell’approccio., cioè l’attenzione va alle relazioni che il paziente intrattiene
con gli altri
Tale trattamento è appropriato per i casi di depressione lieve, dove sia possibile
ricondurre l’episodio depressivo a problemi interpersonali:
- Perdite
- Transizione di ruolo
- Conflitti di ruolo
- Deficit interpersonali
Un approccio terapeutico di tipo familiare è utile quando il paz depresso è un
bambino/adolescente. Poiché spesso la depressione infantile è deputata a un
problema all’interno della famiglia.
78
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
4. EPISODIO MANIACALE E DISTURBO BIPOLARE
EPISODIO MANIACALE – è caratterizzato da alterazione grave dell’umore che si
presenta persistentemente elevato, espansivo e irritabile.
Gli episodi maniacali iniziano bruscamente e possono presentare manifestazioni
psicotiche. È richiesta la presenza di tre sintomi
SINTOMI (necessaria la presenza di almeno 3):
• Autostima ipertrofica o grandiosità
• Diminuito bisogno di sonno
• Loquacità maggiore del solito
• Fuga delle idee
• Distraibilità
• Aumento dell’attività finalizzato o agitazione psicomotoria
• Eccessivo coinvolgimento in attività con alto potenziale di conseguenze dannose.
La loro prognosi non può essere ottimistica. Poiché circa il 90% dei pazienti che
hanno un episodio maniacale va incontro ad altri episodi uguali o con maggiore
intensità.
Un EPISODIO IPOMANIACALE è una manifestazione meno grave di un episodio
maniacale, non compromette ambiti lavorati o sociali e non richiede
l’ospedalizzazione.
Il DISTURBO BIPOLARE – era noto come psicosi maniaco-depressiva. Tra tutti i
disturbi psichiatrici è quello che presenta un alta componente genetica e meccanismo
eziologico simmetrico a quello della depressione (livelli aumentati di monoamine
neurotrasmettitoriali).
il trattamento fa ricorso a stabilizzazione dell’umore. Il farmaco dell’elezione è il
Carbonato di litio. Questo trattamento richiede periodici esami amatici. La
sospensione brusca può innescare un episodio maniacale da sospensione. Date le
oscillazioni d’umore di tali pazienti, l’aderenza terapeutica può essere problematica.
Il trattamento farmacologico è d’obbligo e la psicoterapia può solo avere un ruolo
parallelo non sostitutivo. Lo psicologo clinico può essere una preziosa figura di
accompagnamento per gran parte della vita. La sua competenza può essere
sviluppata su tre livelli:
- aiutare il paziente ad accettare la malattia.
- Aiutare il paziente a fronteggiare le fasi depressive.
- Aiutare la famiglia a mantenere una propria omeostasi.
-
Si tratta distingue tra disturbo:
BIPOLARE I: decorso clinico con uno o più episodi maniacali
79
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
BIPOLARE II: decorso con uno o più episodi depressivi maggiori e almeno un
EPISODIOipomaniacale.
DISTURBO CICLOTOMICO - alterazione dell’umore cronica con numerosi episodi
ipomaniacali e periodi con sintomi depressivi che non confluiscono mai in un episodio
depressivo maggiore.
5. SUICIDIO
Il SUICIDIO è Qualunque atto a esito fatale in cui un individuo provochi
deliberatamente la propria morte.
• SUICIDIO MANCATO - atto suicidario fallito ma potenzialmente mortale. Il tasso di
suicido in Italia è maggiore tra i gli uomini, nel rapporto 4:1.
• per PARASUICIDIO –si intende qualunque atto a esito non fatale in cui un individuo
provochi deliberatamente danno a sé stesso. Si presenta come u n tentativo di suicidio
mancato ma i mezzi utilizzati non sono appropriati. In questo caso l’intenzione non è
tanto togliersi la vita ma rappresenta un gesto vendicativo, di richiamo
dell’attenzione o richiesta di aiuto. Al contrario dei suicidi sono tre volte più frequenti
nelle donne e nelle classi di età giovanile.
IDEAZIONE SUICIDARIA (pensieri suicidi) è comune nella popolazione normale
specialmente in età adolescenziale. La maggior parte dei suicidi è associata a
malattia mentale. Nell’esame clinico di un paziente depresso è doveroso esplorare i
pensieri suicidi e cercare di mettere in luce l’esistenza di un progetto suicidario. La
sofferenza presente in un episodio depressivo possono indurre la persona a pensare
che morte sia preferibile alla sua condizione. La condizione in cui si trova un paziente
depresso è detta “ mondo atemporale”: il pz non riesce a credere che la sua condizione
possa essere transitoria, davanti a sé vede solo dolore e si presta alle cure per
compiacere gli altri non per intima convinzione. Quindi il suicidio sembra l’unica
soluzione possibile.
Un progetto suicidario assume diversi significati:
• Gesto estremo per conquistare un amore perduto
• Modo per ricongiungersi a una persona amata
• Ritorsione per punire gli altri
• Tentativo di riparare colpe reali o presunte
• Tentativo di liberarsi da sentimenti ritenuti inaccettabili
• Frutto di un impulso momentaneo e incontenibile.
La stragrande maggioranza dei suicidi è associata a malattie mentale ciò non toglie
che i tentativi e i suicidi portati a termine possono essere frutto di una scelta
responsabile. Si parla di SUICIDIO RAZIONALE.
80
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
La tesi che il suicidio sia non solo un diritto ma un gesto nobile è un’affermazione
della libertà dell’uomo contro la necessità. Idea ripresa da Hume, Jaspers, Sartre. Il
SUICIDIO ASSISTITO implica la visione della vita e della morte e la concezione della
libertà dell’uomo.
6. VALUTARE IL RISCHIO SUICIDARIO
Allo psicologo clinico è richiesta la valutazione dell'ideazione suicidaria;
-quanto a lungo il paziente sia assorto in pensieri suicidari
-quanto gli sia difficoltoso distogliere l'attenzione e pensare a cose diverse.
Valutare il rischio suicidario è capire qual è la probabilità teorica che un soggetto
presenti condotte suicidarie. L’idea di parlare del suicidio durante il colloquio clinico è
utile poiché accompagnato spesso dal senso di sollievo del paziente che ha modo di
condividere un segreto.
Il costrutto da esplorare nel colloquio clinico è chiamato disperazione e può essere
rappresentato da pensieri e convinzioni del tipo "la vita non vale la pena di essere
vissuta". Accanto all’ideazione occorre indagare il grado di sofferenza interiore, la
mancanza di motivi per vivere. Altri aspetti da indagare sono l’impulsività, eil
passaggio all’atto.
Se il rischio è alto lo psicologo è costretto a interrompere il segreto professionale
avvertendo la famiglia o i servizi di salute mentale.
Il progetto suicidario deve avere altri significati:
Un gesto estremo per un amore appena perso
Un gesto per ricongiungersi all’amata morta
Riparare colpe reali o presunte
Frutto di un impulso momentaneo
Sono 8 gli elementi ritenuti importanti per valutare il rischio di suicidio:
1. Gravità dei tentativi precedenti
2. La storia dei tentativi precedenti
3. La presenza dell’idea suicidaria
4. Condizione psicologica di grave disperazione
5. La forza d’attrazione della morte come sollievo
6. Storia familiare con presenza di suicidi
7. L’assunzione di alcool
8. La presenza di episodi recenti di perdita
Una volta accertate le intenzioni suicidarie, lo psicologo clinico è tenuto in prima
istanza a lavorare per proteggere la vita del suo paziente, alleviando la sua sofferenza
81
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
aiutandolo a vedere soluzioni alternative. Può prevedere incontri quotidiani. Durante
il colloquio clinico alcuni spunti possono essere:
Richiamo alla mente delle ragioni per vivere e morire
Rivalutare le une e le altre
Stabilire il dubbio sulle convinzioni del pz
Programmare attività all’apparire dei pensieri suicidi
L’accertamento del rischio consiste nel costringere lo psicologo clinico a infrangere il
segreto professionale(il codice deontologico), informando familiari e suggerendo
precauzioni. È opportuno prendere contatti con i servizi di salute.
82
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
CAP 7 - DISTURBI D’ANSIA L'ansia è un meccanismo utile e
fondamentale per l'adattamento, ma a volte può diventare disadattiva e patologica.
L'ansia di per se non è un fattore patologico ,ma rappresenta un meccanismo utile
all'adattamento e alla sopravvivenza, perché consente di far fronte ad un pericolo e di
far fronte alla situazione. La funzione informativa dell'ansia è quindi paragonabile a
quella del dolore: è un segnale che distoglie l’individuo dalle attività in atto e lo spinge
a prendere provvedimenti per prevenire danni futuri. Il problema dei disturbi d'ansia
non è la presenza dell'ansia in quanto tale, ma la sua presenza eccessiva al di fuori di
un contesto realistico d'allarme. Per ANSIA si definisce
l’anticipazione apprensiva di un pericolo futuro, accompagnata da sentimenti di
disforia o sintomi fisici di tensione. L’ansia è un costrutto che implica aspetti cognitivi
e psicofisiologici. I DISTURBI D’ANSIA sono:
1. Disturbo di ANSIA GENERALIZZATO
2. ATTACCHI E DISTURBO DI PANICO
3. FOBIE SPECIFICHE
4. FOBIA SOCIALE
5. Disturbo CORRELATI A EVENTI TRAUMATICI E STRESSANTI
6. Disturbo OSSESSIVO-COMPULSIVO E DISTURBI CORRELATI
1. L’ANSIA E LA SUA STRUTTURA
ANSIA:
• Anticipazione apprensiva di un pericolo accompagnata da un sentimento di disforia
(alterazione dell'umore in senso depressivo) o da sintomi fisici di tensione.
• Meccanismo utile all’adattamento e alla sopravvivenza perché consente di
riconoscere un pericolo e mobilitare le risorse atte a fronteggiarlo.
• Implica aspetti cognitivi e psicofisiologici.
• Diviene disadattiva quando la sua presenza al di fuori di un contesto realistico di
allarme è eccessiva.
IL TERMINE PREOCCUPAZIONE INDICA:
• Attività cognitiva involontaria associata a disagio emotivo; processo nel quale un
problema viene elaborato per fronteggiarlo.
• Diviene disadattiva quando assume dimensioni eccessive e rallenta il processo di
soluzione del problema (evitamento cognitivo), inducendo sul piano
comportamentale indecisione e procrastinazione.
La COMORBIDITA’ tra i disturbi d’ansia è elevata. Chi presenta un disturbo d’ansia
presenterà nel corso della vita un altro disturbo d’ansia. L’elevata comorbidità ha
avuto 2 spiegazioni, che si integrano: da una parte l’artificiosità delle classificazioni
83
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
nosologiche e dall’altra il fatto che i processi sottostanti sono comuni sia livello
biologico che psicologico.
L'ipotesi neurobiologica spiega i disturbi d'ansia con un'iperattività dell'amigdala,
quella parte del cervello che consente di elaborare una valutazione semplice e rapida
dell’ambiente e ha un ruolo chiave nell’attivare paura e collera.
Si colloca nel lobo temporale. LeDoux ha chiamato strada inferiore la rapida
evoluzione del pericolo svolta dall’amigdala, mentre la valutazione più dettagliata
della corteccia strada superiore. Secondo questa ipotesi i disturbi d’ansia si
spiegherebbero con un’iperattività dell’amigdala che risponde in eccesso agli stimoli.
Le variabili associate al rischio di sviluppare disturbi d’ansia è sterminato: modelli
d’attaccamento, stili educativi, eventi di vita.
Sul piano dell’organizzazione cognitiva, nei disturbi d’ansia è stata descritta una
rappresentazione del mondo come minaccioso e pieno di pericoli e di se stessi come
entità fragile e povera di risorse. Ai fini di un trattamento sia cruciale intervenire a
livello cognitivo ed emozionale.
2. DISTURBO DI ANSIA GENERALIZZATO
Ansia e preoccupazioni croniche ed eccessive sono considerate l’aspetto centrale del
disturbo d’ansia generalizzato. Si parla di <<generalizzazione>> perché ansia e
preoccupazioni riguardano una quantità di eventi e di attività che vengono elaborate
come pericolose. Nell’esame psicodiagnostico possiamo attenderci un punteggio
elevato nello STAI( il test di tratto di Spielberger. Per raggiungere la soglia di disturbo
si richiede che:
L’ansia, o i sintomi fisici causino disagio clinicamente significativo o
menomazione nel funzionamento sociale
L’ansia e la preoccupazione si manifestano per la maggior parte dei giorni per
almeno 6 mesi
La persona abbia difficoltà a controllare la preoccupazione
Siano presenti almeno tre dei seguenti sintomi per la maggior parte dei giorni:
1. Irrequietezza
2. Affaticabilità
3. Vuoti di memoria
4. Irritabilità
5. Tensione muscolare
6. Alterazione del sonno
L’essenza del disturbo è cognitiva, è nel lavorio della mente che si mantiene di
continuo uno stato di allarme, dove l’aspetto emozionale e somatico ne sono una
conseguenza. La terapia oggi consigliata rispetto ad un passato fatto di ansiolitici è
quella degli interventi psicologici come trattamento di prima scelta. In merito alla
84
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
comorbidità del disturbo d’ansia generalizzato le linee guida proposte dal NICE
nascono da un esame sistematico della letteratura e dall’elaborazione di alcuni punti
fermi, tali da guida il clinico. È proprio in quest’ottica che si dovrebbe caratterizzare
un servizio pubblico attento capace di supportare l’intervento psicologico. Nelle linee
guida NICE fra gli interventi di autoaiuto vengono presi in considerazione l’offerta di
testi, informazioni su gruppi di supporto e informzioni su aspetti dell’ansia.
NICE-Linee Guida per il trattamento INTERVENTI PSICOLOGICI
del disturbo d’ansia generalizzato - TERAPIA cognitivo-
TRATTAMENTO A BREVE TERMINE comportamentale
Quando si presentasse la necessità di - Pratica da un professionista
gestione immediata del disturbo - Durata di 16-20 ore totali
d’ansia generalizzato si considerano - Da completare entro 4 mesi
le seguenti possibilità: Con interventi più brevi tra le 8-10
- Informazioni e sostegno ore si integra un programma di
- Problem solving autoaiuto
- Autoaiuto EVIDENCE STATEMENTS
- Benzodiazepine - non esistono evidenze che
TRATTAMENTO DI LUNGO PERIODO permettono di fare previsioni
Gli interventi efficaci sono: - nel breve periodo le tecniche
- Terapia psicologica cognitivo-comportamentali
- Terapia farmacologica sono efficaci come quelle
- Autoaiuto farmacologiche
- - esiste un elevato effetto
placebo
- comorbidità>il trattamento
dei disturbi d’ansia ha uno
benefico effetto su altri
disturbi.
85
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
3. ATTACCHI E DISTURBO DI PANICO
1. ATTACCO DI PANICO
L'attacco di panico è un episodio critico di ansia molto intensa, breve e transitoria,
detto in passato <<angoscia>>. Un <<attacco di panico>> è un periodo ben delimitato
di intensa apprensione, paura o terrore durante il quale sono avverti almeno 4 tra
questi sintomi:
1. tachicardia
2. sudorazione
3. tremori
4. sensazione di soffocamento
5. dolore al petto
6. nausea
7. svenimento
8. depersonalizzazione
9. paura di perdere il controllo
10.paura di morire
11.brividi/vampate di calore
Nell’attacco di panico sono in evidenza la violenza delle manifestazioni fisiche. È
possibile distinguere tra attacchi di panico provocati dalla situazione e attacchi
inaspettati(non provocati). I primi si manifestano o durante l’esposizione o durante
l’attesa di uno stimolo temuto. In questi casi è evidente il rapporto stimolo-risposta.
Questo genere di attacchi di panico provocati dalla situazione può presentarsi nel
caso di vari disturbi d’ansia.
Diverso è il caso degli attacchi di panico non provocati. L’attacco sopravviene del tutto
inatteso, sorprendendo la persona. Raggiunge l’apice rapidamente. L’esperienza
soggettiva più comunemente descritta è quella di essere sul punto di morire, oppure di
impazzire o di perdere il controllo.
Questi attacchi il più delle volte restano isolati, ma avvolte si ripetono innescando
gravi reazioni di disagio.
Il DISTURBO DI PANICO, è' dato da esperienze di attacchi di panico inaspettati e
ricorrenti, per un periodo non inferiore ad un mese, cui seguono persistenti
preoccupazioni di poter avere nuovi attacchi e alterazioni del comportamento.
• Agisce un processo di condizionamento classico per cui il ritorno in certe
situazioni può provocare lo scatenamento di un nuovo attacco.
Esordio tra tarda adolescenza e 35 anni. Può manifestarsi come voglia di fuggire dal
luogo in cui si sta manifestando l’attacco per raggiungere un luogo sicuro. Tale
processo può portare a un disturbo di panico con o senza agorafobia.
86
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Per Agorafobia – si intendo l’ansia relativa all’essere in luoghi o situazioni in cui è
difficile allontanarsi o dove sia impossibile ricevere aiuto, nel caso in cui si verifichino
attacchi di panico. Situazioni del genere possono essere evitate o affrontate con un
accompagnatore. Sono 2 le componenti dell’agorafobia : 1) l’ansia esperita e 2)le
condotte di evitamento.
Sintomi: palpitazione, tachicardia, sudorazione, sensazione di svenimento,
depersonalizzazione, brividi, vampate di calore.
Il trattamento del disturbo di panico è breve, semplice e coronato da ottimi risultati,
ma se associato ad agorafobia diventa lungo e difficoltoso.
NICE-LINEE GUIDA PER IL INTERVENTI FARMACOLOGI
TRATTAMENTO DEL DISTURBO DI - Il farmaco prescritto deve essere
PANICO un SSRI
Per il trattamento vanno presi in - In caso di mancata risposta
considerazione i seguenti interventi: considerare altre forme di
-terapia psicologica trattamento
-terapia farmacologica - Non vanno prescritte
-autoaiuto benzodiazepine
INTERVENTI PSICOLOGICI SUGGERIMENTI
- TRATTAMENTO proposto - Uso di questionari di
nella sua durata ottimale di 7- autocompilazione
14 ore - Il rilassamento è un placebo
- Sotto forma di sedute di 1-2
ore
- Integrato con materiale per
l’autoaiuto
- Con un appropriato
trattamento cognitivo-
comportamentale
87
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
4.FOBIE SPECIFICHE In passato erano legate al nome dell’
oggetto temuto. Oggi una FOBIA SPECIFICA è rappresentata da una paura marcata,
persistente, irragionevole per stimoli precisi o situazioni circoscritte e chiaramente
discernibili. Esempi comuni sono: la paura per alcuni animali, paura delle
iniezioni. Per parlare di una Fobia clinicamente significativa è necessario che
l’interessato sia colpevole dell’irragionevolezza della paura, ma non sia in grado di
controllarla e dall’altra parte ricavi da tale fobie significative compromissioni nella
propria vita sociale. È l’estensione degli evitamenti a creare limitazioni ed è questa
che va indagata nel dettaglio durante l’assessment. Solo in pochi casi viene richiesto
un aiuto professionale. Un cenno particolare merita un sottotipo di fobia, indicato
come : sangue-iniezioni-ferite. Questo tipo presenta un elevata familiarità e
presenta svenimenti. La reazione fisiologica è caratterizzata da una risposta
lipotimica vasovagale: una breve accelerazione iniziale della frequenza cardiaca
seguita da una decelerazione e da un calo di pressione sanguigna. Dalle
ipotesi eziologiche, la storia della fobia si presenta affascinante e lunga. Fin dagli inizi
del ‘900 si sono creati due filoni teorici.
1. Il primo filone ragionava così: non è possibile che una persona grande e grossa,
intelligente e colta possa avere paura di un topo. La spiegazione fù che dietro
quell’innocuo topo il pz avvertiva un pericolo micidiale che stava al di fuori di
ciò che potesse essere colto dalla ragione. Capostipite di questo filone fu Freud
col suo celebre caso del piccolo Hans(complesso di edipo).
2. Il secondo filone ha guardato le fobie come puri esempi di apprendimenti
infelici. Capostipite di questo filone fu Watson che contraddisse la tesi di Freud
indicendo sperimentalmente una fobia attraverso il condizionamento(Il caso
del “Little Albert”). Coltivarono questo filone psicologi sperimentali che
utilizzarono ratti albini per i loro esperimenti.
gli psicologi clinici svilupparono tecniche come il modeling. L’ingrediente
terapeutico più efficace è l’esperienza diretta, detta esposizione che può essere
modulata, graduata.
Oggi nessun farmaco psicotropo viene raccomandato come trattamento
d’elezione nelle fobie specifiche.
88
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
5. FOBIA SOCIALE
La FOBIA SOCIALE E' caratterizzata da una paura marcata e persistente relativa a
una o più situazioni sociali o prestazionali(un esame, parlare in pubblico). La persona
teme di agire e comportarsi in modo inadeguato in presenza di persone non familiari,
di mostrare imbarazzo e vergogna. Conseguentemente le situazioni sociali sono
evitate o tollerate con fatica. Le persone possono presentare forti reazioni a carico del
sistema nervoso autonomo nelle situazioni ritenute più temute. Si può manifestare
una marcata ansia anticipatoria, istaurando un circolo vizioso che porta ad uno stato
di apprensione e sintomi d’ansia. La diagnosi di fobia sociale e appropriata solo se
l’interessato è consapevole del carattere irragionevole della propria paura e se va
incontro a limitazioni gravi per la propria vita quotidiana. Un aspetto critico e dato
dalle condotte di evitamento che si possono sviluppare e che possono essere
gravemente invalidanti( parlare in pubblico, andare alle feste). Altra limitazione
può aversi nel rapporto con l’altro sesso. Si può ricorrere all’abuso di alcool.
Di aiuto, ma in modo limitato sono: la farmacoterapia e la psicoterapia. Il modello di
CLARK e WELLS è quello che ha avuto più successo, che individua alcuni elementi di
diatesi cognitiva:
Distorsioni nella valutazione della probabilità e della gravità di eventi sociali
negativi-fallimenti che hanno conseguenze dolorose-
Criteri elevati nelle prestazioni sociali-ballare, cantare-
Convinzioni autosvalutative su di sé
Convinzioni disfunzionali sugli altri
Clark e Wells descrivo poi il circolo vizioso in cui si imbatte il pz quando deve
affrontare una situazione ansiogena: sintomi di attivazione neurovegetativa, produce
pensieri autovalutativi negativi, ignora eventuali feedback di simpatia
dell’interlocutore, può finire con il mostrarsi superbo, disinteressato. Questi autori
hanno dato il via alle ricerche sull’elaborazione post-evento->nel raccontarsi e nel
raccontare l’evento il pz scambierà i suoi timori per quanto è realmente accaduto, per
cui racconterà quelle situazioni come rifiuti.
.
6. DISTURBI CORRELATI A EVENTI TRAUMATICI E STRESSANTI
EVENTI traumatici estremi che causino morte o minaccia di morte o minaccia
all’integrità fisica propria/altrui, possono provocare una fortissima reazione
d’ansia(rapimenti, violenze, guerre, incendi). Oggi questo viene riferito con
l’espressione stress estremo.
Durante l’esposizione a eventi traumatici possono presentarsi sintomi:
89
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
• Dissociativi - sensazione di insensibilità, distacco o assenza di realtà emozionale,
riduzione consapevolezza dell’ambiente circostante.
Un sintomi che risulta dall’esposizione a un trauma estremo è:
Il continuo rivivere l’evento traumatico, la persona presenta ricordi spiacevoli
ricorrenti dell’evento, che comprendono immagini, pensieri nei quali si rivive
l’evento.
Vengono così evitati gli stimoli associati con il trauma. Di regola la persona presenta
sintomi Persistenti di ansia o di aumento dell’arousal(difficoltà ad addormentarsi,
incubi, scoppi d’ira) di fronte a eventi che assomigliano all’evento traumatico.
Dopo l’evento traumatico inizia una riduzione della reattività verso il mondo esterno,
a cui ci si riferisce con anestesia emozionale( distacco verso il sociale, con una
marcata riduzione della capacità di provare emozioni). La sintomatologia su detta
può interferire con la possibilità dell’individuo di mobilitare le difese personali, di
ottenere l’aiuto necessario. In questo caso si parla di disturbo acuto da stress(nelle
4 settimane successive al trauma) e di disturbo post-traumatico da stress( ove il
disturbo persista da oltre un mese. Qui si ricorre all’intervento specialistico.
7. DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO e DISTURBI CORRELATI(PAG. 191)
Le ossessioni sono un fenomeno specifico che non va confuso con le preoccupazioni
che accompagnano i fenomeni di ansia e di depressione. Per OSSESSIONI si intendono
pensieri, impulsi o immagini mentali che sono ricorrenti e persistenti, che causano
ansia, che sono vissuti dall’interessato come intrusivi. La persona tenta di allontanare
tali pensieri oppure di neutralizzarli. Nel caso delle ossessioni, la persona è
perfettamente consapevole di detti pensieri. La persona qui ne riconosce l’estraneità e
l’irragionevolezza per cui lotta per allontanarle dalla propria mente. Le OSSESSIONI
sono <<godistoniche>>, cioè rappresentano un tipo di pensiero che contrasta con le
convinzioni più radicate della persona(pensieri blasfemi in una persona pia).
Le COMPULSIONI sono comportamenti ingiustificati e ripetuti in modo stereotipato e
sproporzionale(sistemare, allineare) oppure possono essere azioni mentali. La
persona si sente spinta a mettere in atto la compulsione per ridurre il disagi che
accompagna un’ossessione. La persona si rende conto dell’irragionevolezza della
compulsione e si sforza di non attuarla ma senza successo. Tra le compulsioni:
- Decontaminazione>pulizia
- Controllo e ricontrollo
Ossessioni e Compulsioni sono spesso banali ma in alcuni casi possono estendersi fino
ad occupare l’intera giornata della persona.
Il DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO -è caratterizzato dalla presenza di
ossessioni e compulsioni che causano marcato disagio e interferiscono con le normali
90
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
abitudini della persona. Il disturbo è parimenti presente nei maschi e nelle femmine.
Negli studi sui gemelli si mostra maggiore concordanza tra i gemelli omozigoti.
La ricerca eziologica sui disturbi ossessivi ruota intorno a quello chiamato paradosso
nevrotico: come sia possibile che una persona lucida perseveri in condotte che sa
essere assurde. Analogie d’obbligo sono il comportamento superstizioso e il gioco
d’azzardo.
Fin dagli anni ’60 il trattamento scelto per le psiconevrosi era la psicoanalisi.
Attualmente la psicoterapia cognitiva è impiegata con soggetti che presentano
ossessioni senza compulsioni. Attualmente la terapia farmacologica utilizzata è la
SSRI e la clomipramina.
Nello spettro ossessivo è incluso il disturbo di dismorfismo
corporeo(preoccupazione per un difetto nell’aspetto fisico). Questo disturbo insorge
durante l’adolescenza. questi soggetti solitamente stanno ore a pensare al difetto e
ricorrono anche a interventi per la loro correzione.
Altri disturbi dello spettro ossessivo sono la tricotillomania(strapparsi i peli) e il
disturbo di accumulare oggetti senza valore.
91
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
CAP 8 - DISTURBI ALIMENTARI, SESSUALI, DA
DIPENDENZA, SOMATOFORMI, DISSOCIATIVI E DI
PERSONALITA’Si tratta di un raggruppamento di disturbi che ha visto negli
ultimi decenni un incredibile aumento, in passato erano considerati rarissimi. Questo
fenomeno pare essere determinato in relazione a cambiamenti culturali specialmente
nei paesi maggiormente industrializzati . i disturbi mentali sono fenomeni che
riflettono la cultura e le sue variazioni.
I DISTURBI ALIMENTARI: Sono un gruppo di sindromi cliniche in cui ad una
condizione psicopatologica corrisponde un alterato comportamento alimentare. Nei
disturbi alimentari si ha una differenza tra i generi, in un rapporto tra femmine e
maschi di 10:1.
I quadri clinici proclamati più critici sono:
-Anoressia nervosa si tratta di un rapporto patologico con il proprio corpo, con la
propria identità e con la propria sessualità. Dove la paura di ingrassare è fortissima.
Il rifiuto di mangiare è in questo caso più che un problema con il cibo,è il tentativo di
modificare,dimagrendo,il proprio corpo.
L’età di insorgenza ha una distribuzione bimodale con due picchi a 14 e 18 anni.
L'evoluzione e gli esiti sono variabili:
- a un episodio di anoressia nervosa fa seguito una completa remissione
- Altri casi presentano un'evoluzione cronica che richiede il ricovero in un ambiente
ospedaliero per il ripristino del peso corporeo.
Il DECESSO può verificarsi sia in rapporto alla denutrizione, sia in seguito al suicidio.
L’anoressia è il disturbo mentale con maggiori mortalità. Il termine anoressia può
essere forviante, poichè in questo disturbo è la perdita dell’appetito. La
manifestazione fondamentale dell’anoressia nervosa è il rifiuto di mantenere il peso al
di sopra del peso minimo per età e statura. Per questo si fa riferimento all’indice di
massa corporea(BMI) .La perdita di peso si ha dopo drastiche restrizioni ad
assumere cibo, dette condotte restrittive. Il soggett può imporsi pratiche eccessive di
attività fisica. In aggiunta può praticare condotte di eliminazione(vomito, uso di
lassativi). L’anoressia nervosa ha ulteriori manifestazioni essenziali:
Intensa paura ad acquistare peso
Distorsioni relative alla percezione dell’aspetto fisico
Nelle donne può aversi l’amenorrea, cioè l’assenza del ciclo per lungo tempo-
nelle preadolescenti può aversi il ritardo nella comparsa del menarca.
Si registra un’alterazione dell’immagine corporea per ciò che riguarda la forma e
dimensioni del corpo, tali da sfiorare il delirio. Si osserva un’eccessiva influenza del
peso sui livelli di autostima, infatti la perdita del peso viene considerata come una
92
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
conquista e un segno di disciplina, mentre l’aumentare del peso come una
inaccettabile incapacità di controllo. Questi soggetti raramente riconoscono di avere
un problema con il peso. La quasi totalità delle persone interessate è di sesso
femminile alle prese con: l’immagine corporea, la conquista della propria identità, la
conquista dell’autonomia dei genitori, la conquista della propria identità sessuale.
L’attenzione per l’anoressia è recente (1960), pioniere ne fu H. Bruch(psicoanalista
tedesca, trapianta in america); negli anni 70 venne introdotta la terapia familiare,
una grande rivoluzione che permise di affrontare pazienti ostici con pochissima
motivazione al trattamento Il ricorso al setting familiare(la famiglia al completo)
forniva uno spiraglio prezioso. La Gabbia dorata di cui parla la Bruch è una famiglia
perfetta dove il tema del perfezionismo è alla base del disturbo. MINUCHIN sostenne
la tesi che i disturbi dell’alimentazione colpissero le famiglie invischiate (dove ogni
membro è estremamente coinvolto con gli altri). Qui pochi spazi di autonomia
personale e di differenziazione tra i genitori e i membri della famiglia.
Questa eccessiva coesione può rendere difficili i processi di cambiamento, crescita e
autonomia, quindi l’anoressia non è una patologia del singolo ma una patologia del
sistema familiare. Su queste basi la terapia della famiglia ha rappresentato la prima
seria proposta terapeutica per l’anoressia.
Oggi prevale l’idea che la cura dell’anoressia nervosa vada affidata a un equipe
multidisciplinare con competenze psicoterapeutiche. Nei casi più gravi è necessario il
ricorso al ricovero ospedaliero. Alla dimissione è di regola un intervento psicologico
strutturato. Nel caso di trattamento psicologico ambulatoriale, le linee guida del NICE
raccomandano un costante monitoraggio dello stato fisico del pz. Non tutti i
trattamenti psicologici sono accettati, quelli validi sono:
- La terapia cognitiva analitica
- La terapia cognitiva e comportamentale
- La terapia interpersonale
- Interventi familiari.
2.Bulimia nervosa
Un’abbuffata o crisi bulimica è l’ingestione in un certo lasso di tempo(breve) di una
quantità di cibo esagerata rispetto a quello che la maggior parte delle persone
potrebbe mangiare nello stesso tempo/condizioni. Durante l'episodio il soggetto ha la
sensazione di perdere il controllo, di non riuscire a smettere di mangiare, di non poter
controllare cosa e quanto stia mangiando. L’episodio termina quando non c’è più
nulla da mangiare o per la sensazione di malessere. Va oltre la golosità, qui si
caratterizza per la quantità del cibo e non per la qualità. Le Crisi Bulimiche
avvengono di nascosto e in solitudine. Sono indotte da stati depressivi di umore ,
93
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
condizioni di stress interpersonale. Possono aversi anche a seguiti delle forti
restrizioni che il soggetto si impone.
Durante l'abbuffata vi può essere una momentanea interruzione dell'umore depresso,
con sentimenti di vergogna che subentrano dopo.
Dette abbuffate si possono osservare anche in casi di anoressia nervosa, ma sono
tipiche di un disturbo dell’alimentazione: la bulimia nervosa. Le sue manifestazioni
sono:
Presenza di abbuffate
Appropriati metodi compensatori per prevenire l’aumento del peso(induzione
del vomito)
- Tra le misure compensatorie troviamo ->digiuno per giorni, sport eccessivo
Gli individui con bulimia nervosa attribuiscono importanza spropositata al peso e alla
forma e questi fattori condizionano i loro livelli di autonomia. Maggiore tra il genere
femminile.
Fattori psicologici possono avere un ruolo nell’eziologia e nel decorso di moltissimi
casi di obesità.
L’obesità non compare tra le classificazioni dei disturbi mentali, perché non è stata
accertata l’associazione con alcuna sindrome psicologica.
3.DISFUNZIONI SESSUALI
La sfera sessuale implica infinite sfaccettature . E’ evidente la relazione tra
problematiche sessuali e problemi della relazione affettiva di coppia. Qui parleremo
delle DISFUNZIONI SESSUALI che Possono riguardare: uno o più fasi del ciclo di
risposta sessuale:
a) IL DESIDERIO, le fantasie sull'attività sessuale ed il desiderio di praticare
l'atttività sessuale.
b) ECCITAZIONE, riguarda la sensazione soggettiva di piacere sessuale
c) ORGASMO, che consiste nel picco del piacere sessuale
d) LA RISOLUZIONE, sensazione di benessere generale
Da punto di vista eziologico possono distinguersi 4 possibilità:
I fattori psicologici hanno un ruolo preminente nell’insorgenza, nella
gravità, nell’esacerbazione o nel mantenimento della disfunzione sessuale.
I fattori psicologici hanno un ruolo ma si ritiene che anche una condizione
medica generale contribuisca al mantenimento della disfunzione.combinata
Si ritiene che la disfunzione sia dovuta agli effetti fisiologici diretti di una
condizione medica generale.
La disfunzione sessuale sia del tutto spiegata dagli effetti fisiologici di una
sostanza di abuso.
94
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Sono 4 i disturbi che interessano le fasi del desiderio: 1.Disturbo da
desiderio ipoattivo maschile(assenza o insufficienza delle fantasie sessuali)
2.Disturbo dell'eccitazione sessuale femminile (assenza di pensieri o desideri
sessuali)
3.Disturbo erettile (incapacità di mantenere/raggiungere l'erezione fino al
compimento dell'attività sessuale)
4.distrubo del dolore genito-pelvico ( disturbo che presenta differenti forma di
dolore, contrazione del pavimento pelvico, marcata paura per il dolore prima o
durante il rapporto)
Sono 3 i disturbi che interessano la fase dell’orgasmo:
1. Disturbo dell’orgasmo femminile-assenza o ritardo nella sensazione
2. Eiaculazione precoce
3. Eiaculazione ritardata
Queste disfunzioni sessuali possono essere di tipo:
1. PERMANENTE: disfunzione è presente dall’inizio dell’attività sessuale,
2. ACQUISITO: si sviluppa dopo un periodo di funzionamento normale,
3. SITUAZIONALE: è limitata a certi tipi di stimolazione, di situazioni o partner,
4. GENERALIZZATO: si manifesta indipendentemente dai fattori precedenti.
Tutte la disfunzioni sessuali possono creare sentimenti di inadeguatezza nei confronti
del partner e compromettere le relazioni.
4. DISTURBI PARAFILICI(PERVERSIONI SESSUALI)
Le loro caratteristiche sono: Fantasie, impulsi o comportamenti ricorrenti e
intensamente eccitanti sessualmente che riguardano oggetti inanimati, bambini o
altre persone non consenzienti o che producono la sofferenza e l’umiliazione
propria o del partner.
Le parafilie devono essere distinte dall’uso non patologico di fantasie utilizzate come
stimolo per l’eccitazione nella comune vita delle persone
Le Fantasie e i comportamenti sono parafilici solo quando portano ad un disagio
clinicamente significativo o inducono menomazioni in aree importanti della
vita( interferiscono con le relazioni sociali, danno esito a complicanze legali)
Riguardano in massima parte individui di sesso maschile
Le singole parafilie Si differenziano in base alla specifica focalizzazione:
• Nel caso dell'esibizionismo le fantasie riguardano l'esposizione dei propri
genitali ad un estraneo che non se lo aspetta,generalmente non vi sono tentativi di
vera e propria attività sessuale con l'estraneo.
95
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
A volte il soggetto si masturba mentre si esibisce
Nel caso del voyeurismo la focalizzazione parafilica si ha nell’osservare i
soggetti che non se lo aspettano, mentre si spogliano. Non viene ricercata
nessuna attività sessuale con la persona osservata.
• Frotteurismo comporto il toccare o lo strofinarsi contro una persona non
consenziente.
• Feticismo la focalizzazione parafilica riguarda oggetti inanimati(mutande
reggiseni calze)con la quale il soggetto si masturba.
• disturbo da travestimento comporta il procurarsi eccitazione sessuale indossando
abiti del sesso opposto
Il disturbo riguarda maschi eterossessuali o bisessuali,il disturbo può essere
accompagnato da disforia di genere un senso persistente di disagio connesso al
proprio ruolo sessuale.
• Pedofilia: impulsi riguardano bambini prepuberi di una specifica fascia di età.
I soggetti con pedofilia hanno attrazione per bambini o bambine di una specifica
fascia d'età.
• Masochismo sessuale: atto reale e non simulato di essere umiliato, percosso o fatto
soffrire in vario modo.
• Sadismo sessuale il soggetto ricava eccitazione sessuale dalla sofferenza
psicologica i fisica della vittima.
5.DISFORIA DI GENERE
Nella maggior parte del secolo scorso l’omofobia è stata classificata come malattia.
Nel 1973 l’APA(American Psychiatric Association) rimuoveva questa dal DSM. L’OMS
ha cancellato l’omofobia dall’elenco delle malattie mentali nel 1990.
Il caso dell’omosessualità rientra nel cosiddetto relativismo storico e culturale che
permea la storia della psicopatologia. In questo contesto si sono sviluppate nuove
attenzioni verso i termini di <<sesso>> e <<genere>>.
SESSO->va riferito agli indicatori biologici di maschio e femmina(organi sessuali,
capacità riproduttiva);
GENERE-> è utilizzato per indicare il ruolo vissuto dal soggetto in pubblico(donna ,
uomo, bambino). Qui i fattori biologici si integrano con fattori sociali e psicologici
nello sviluppo del genere.
La DISFORIA DI GENERE costituisce una delle nuove classi diagnostiche introdotte
nel 2015 col DSM-5. Nel DSM-IV era previsto il “disturbo dell’identità di genere”, oggi
cancellato. Qui non si pone l’accento sull’identificazione con un genere diverso dal
sesso biologico, ma sulla sofferenza connessa al fenomeno dell’incongruenza di
genere, ossia alla sofferenza affettiva e cognitiva di chi si ritrova estraneo nel proprio
96
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
corpo e non sente di appartenere al genere assegnatoli alla nascita, ma vorrebbe
appartenere al sesso opposto.
La DISFORIA DI GENERE descrive il disagio affettivo e cognitivo di individui che si
identificano in modo permanente o temporaneo con un genere diverso da quello
assegnatoli alla nascita. Tra le caratteristiche della disforia:
- Desiderio di liberarsi dalle proprie caratteristiche sessuali
- Ricorre ad ormoni del sesso opposto
- Chirurgia
Queste problematiche sono connesse con il relativismo storico e culturale e variano al
variare delle modifiche culturali. Questo determina una classificazione sempre
influenzata e influenzabile dal contesto sociale. In merito all’ OMOFOBIA – questa è
un neologismo del linguaggio comune e indica <<paura e un’avversione irrazionale
nei confronti di alcune categorie come omossessuali, gay, lesbiche e transessuali
basata sul pregiudizio. Descritta così dal Parlamento Europeo nel 2006. E' una
patologia che nega a queste persone il loro diritto di uguaglianza e si manifesta nella
sfera pubblica attraverso violenza verbale,psicologica,istigazioni alla
discriminazione.
4. DISTURBI SOMATOFORMI
Si tratta di una famiglia di disturbi piuttosto ampia,accomunata dalla presenza di sintomi fisici che fanno pensare a malattie di natura somatica.
I disturbi somatomorfi sono accumunati da:
- Attenzione focalizzata su uno o più sintomi o fenomeni di natura somatica
-Tali sintomi causano forte disagio o limitazioni significative del normale funzionamento sociale,lavorativo o in altre aree
- I sintomi lamentati non sono suffragati dai reperti attesi negli esami di laboratori e non sono diagnosticabili in nessuna condizione medica
riconoscibile.
1. Disturbo di somatizzazione(che corrisponde in buona parte alla classica isteria),include contemporaneamente dolori riferiti ad almeno 4
localizzazioni,sintomi gastrointestinali,sintomi sessuali e pseudoneurologici .
E' un disturbo cronico
L'insorgenza si colloca di regola prima dei 30'anni
Il decorso successivo è fluttuante ed i sintomi possono modificarsi nel tempo.
2. Disturbo somatoforme indifferenziato - E' caratterizzato dalla presenza di una o più lamentele fisiche che persistono per sei mesi o più.
I sintomi più frequenti sono stanchezza cronica e perdita dell'appetito.
3. Disturbo di conversione - I sintomi di conversione non corrispondono all'alterazione d'alcuna struttura anatomica,ma all'idea che l'interessato si è
fatto di una condizione patologica.
4. Disturbo algido - il dolore diviene la preoccupazione principale nella vita del soggetto,si ha il ricorso frequente ai servizi sanitari,uso sostenzioso di
medicinali...
5. Ipocondria - Preoccupazione di avere una grave malattia che scaturisce dall'erronea interpretazione di sintomi somatici.
Spesso i pazienti ritengono che i loro sintomi non ricevano l'attenzione appropriata e le cure necessarie ;frquente è quindi il deterioramento della
relazione medico-paziente.
6. Disturbo di dismorfismo corporeo - Le preoccupazioni possono riguardare ogni aspetto del proprio corpo;difetti lievi o immaginari del volto,la
sudorazione,la forma o la dimensione del naso,delle orecchie del seno.
97
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
6.DISTURBI DISSOCIATIVI Sono disturbi caratterizzati da
alterazioni marcate della coscienza e della memoria, del senso di identità e della
percezione dell’ambiente.
• L’alterazione può essere improvvisa, graduale, transitoria o cronica.
•Essi Rappresentano una dissociazione di funzioni che usualmente sono tra loro
integrate.
I sintomi dissociativi non vanno considerati come manifestazioni psicopatologiche. In
altri casi possono dare a luogo a disturbi mentali.
Possono includere fenomeni di:
• Amnesia dissociativa - l'incapacità di rievocare uno o più episodi personali importanti.
Queste lacune sono collegate ad eventi traumatici o estremamente stressanti,l'amnesia
può essere circoscritta ad un determinato periodo di tempo,di solito le prime ore
seguenti ad un intervento disturbante. Alcuni soggetti possono gradualmente rievocare
i ricordi dissociati.
• Fuga dissociativa – che ha come manifestazione centrale l’ allontanamento
improvviso e inaspettato da casa accompagnato dall’incapacità di ricordare in toto o in
parte il proprio passato. La comparsa di una fuga dissociativa è collegata a eventi di vita
traumatici e stressanti. Il recupero è rapido. Nei casi di amnesia dissociativi si possono
mantenere tentativi di simulazione.
• Disturbo dissociativo dell'identità – è caratterizzato dalla presenza di due o più
identità distinte, ciascuna con i suoi modi relativamente costanti di percepire e di
pensare nei confronti di se stessa. incapacità di ricordare notizie personali importanti. Il
soggetto vive ciascuno stato della personalità come se avesse una sua storia personale.
• Depersonalizzazione: alterazione nella percezione o nell’esperienza di sé tale per cui
la persona si sente staccata dal proprio corpo. Il soggetto si sente come se stesse
vivendo un sogno.
La derealizzazione – si intende un’esperienza di irrealtà o distacco nei confronti
dell’ambiente circostante. Persone e oggetti sono percepiti come irreali.
RAPTUS- è utilizzato per indicare un episodio improvviso a carattere esplosivo il cui soggetto
compie, in uno stato di coscienza obnubilata, atti impulsivi che possono avere conseguenze
drammatiche. Può essere
- R.ansioso
- R. omicida
- R. suicida
98
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
7.DISTURBI CORRELATI A SOSTANZE Benché sia illimitata la gamma
di sostanze che possono dare luogo a fenomeni di abuso e dipendenza con gravi
conseguenze fisiche e comportamentali.
Le Sostanze rilevanti per la psicologia clinica, sono raggruppate in 11 classi:
1. Alcol: segni di intossicazione sono: incoordinazione, marcia instabile,
nistagmo(movimento involontario degli occhi), con comportamenti disadattivi
significativi
2. Cocaina: presenta una breve emivita quindi si necessita di ripetere
frequentemente le dosi per mantenere un senso di elevato benessere. Il principale
sintomo di astinenza è un umore disforico. Effetti potenti. Sintomi di intossicazione
sono sudorazione, tachicardia
3. Nicotina: considerato più una dipendenza. include umore disforico o depresso,
irritabilità e ansia come sintomi.
4. Anfetamine -l'assunzione può avvenire con varie
modalità(orale,inalazione,endovena). Crea benessere fisico, euforia per poi avere
effetti di intossicazione. Colpisce il sistema nervoso centrale
5. Caffeina tachicardia e aritmia
6. Cannabis- il consumo avviene generalmente per inalazione in questo caso gli
effetti si rendono evidenti immediatamente,o per ingestione in questo caso gli effetti
si vedono dopo qualche ora dall'assunzione. Si può cadere in uno stato di sonno
profondo, con anche episodi di riso inadeguato
7. Allucinogeni si distinguono in naturali e sintetiche e vengono abitualmente
assunte per via orale(LSD).
8. Inalanti(BENZINA, COLLA, DILUENTI)
9. Oppiacei sono sostanze utilizzate anche come analgesici,anestetici.
Vengono definiti tali in quanto derivano dall'oppio. EROINA
10. Feniciclidina
11. Sedativi, ipnotici o ansiolitici
99
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
L'ABUSO / DIPENDENZA DA SOSTANZE è la modalità patologica di uso della
sostanza che conduce a ricorrenti e significative conseguenze dannose,porta a
menomazione e/o a disagio clinicamente significanti. Il lasso di tempo da considerare
è di 12 mesi;
L’abuso da sostanze dà luogo alle seguenti CONDIZIONI RICORRENTI:
• Incapacità di adempiere ai principali compiti connessi con il proprio ruolo sociale
• Uso della sostanza in situazioni fisicamente rischiose
• Uso della sostanza nonostante problemi sociali o interpersonali causati dagli effetti
di questa.
Ripetuti abusi possono portare al fenomeno della dipendenza da quella determinata
sostanza. Per avere dipendenza abbiamo bisogno di due fenomeni(pag 211). L’uso
continuativo di una sostanza dà luogo a effetti via via minori: quindi occorrono al
soggetto quantità crescenti prima di raggiungere l’intossicazione
1. TOLLERANZA: corrisponde al bisogno di quantità notevolmente più elevate
della sostanza per raggiungere l’intossicazione o l’effetto desiderato. Questo
grado varia da sostanza a sostanza.
Quando però le concentrazioni ematiche di una sostanza declinano rapidamente, si
sviluppano spiacevoli sintomi di 2. ASTINENZA. Sintomi e caratteristiche
dell’astinenza variano anche essi da sostanza a sostanza e si riferiscono all’emivita
della stessa(la sua capacità di restare in circolo nel sangue).
Nel caso di astinenza da alcool , gia dopo 12 ore si presentano le prime crisi di
astinenza: sudorazione, tremore, insonnia
Nel caso della cocaina a causa della sua breve emivita bisogna ripetere con frequenza
l’assunzione.
Nel caso dei cannabinoidi non si riscontrano sintomi clinicamente rilevabili.
La DIPENDENZA DA SOSTANZE è definita come modalità patologica d’uso
della sostanza che conduce a menomazione o a disagio clinicamente
significativo, sulla base della presenza di 3 o più condizioni presenti nell’arco
di un anno:
Tolleranza
Astinenza
La sostanza è assunta in quantità maggiori
Il soggetto tenta senza successo di ridurre l’uso della sostanza
Riduzione di importanti attività sociali
100
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
La comunità terapeutica: è un’invenzione inglese, nata per
<<umanizzare>> i reclusori giovanili, le carceri, gli ospedali. Nata con
JONES, direttore delle prime istituzioni psichiatriche a carattere
comunitario. Fu MAIN a coniare il termine di “comunità terapeutica”-
>trasformare l’ospedale in un microcosmo cui concorrono pazienti ed
operatori.
L’esperienza della comunità terapeutica è legata al rifiuto del
rapporto duale tra medico e paziente e all’idea che le forze
ambientali giochino un ruolo nel trattamento. Le sue caratteristiche
sono:
appiattimento della piramide dei rapporti
presenza di riunioni di tutta la comunità
permissività
interazione
negli anni 70-80 per via dell’aumentare del fenomeno della
tossicodipendenza si vede il proliferare di comunità terapeutiche. Ma
al loro interno furono introdotte regole.
Per Creare una comunità occorre avere uno staff istruito e che sappia
riconoscere i bisogni dei pz.
Nel nostro sistema sanitario la COMUNITA’PSICO-SOCIO-
TERAPEUTICA è un presidio sanitario assistenziale residenziale
extraospedaliero rivolto a soggetti che hanno un disagio psichiatrico
importante.
8. DISTURBI DI PERSONALITA’
La personalità
Prima di parlare dei disturbi della personalità occorre inquadrare il concetto stesso di
Personalità cioè modalità perduranti o modelli abituali di percepire, rapportarsi e
pensare nei confronti dell’ambiente e di se stessi che si manifestano in un ampio
spettro di contesti sociali e personali.
L’aspetto chiave è quello della stabilità: la diagnosi di disturbo di personalità si basa
sul funzionamento a lungo termine della persona, al di là di periodi stressanti. Tali
caratteristiche sono riconoscibili durante l’adolescenza.
101
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
I disturbi di personalità sono vari e rappresentano dei modelli abituali di esperienza
interiore e di comportamento che deviano rispetto alle aspettative della cultura
dell’individuo. Esse possono coinvolgere più aree:
>> cognitiva: cioè le modalità di percepire e interpretare se stessi e gli avvenimenti
>> affettiva: la varietà e l’adeguatezza della risposta emotiva
>>interpersonale
>>impulsività
Tale modello <<abituale>> ha caratteristiche estreme, cioè è rigido e inflessibile da un
lato ed estremamente permissivo dall’altro. Infatti è questa estremizzazione che
determina un disagio clinicamente significativo.
Nella tradizione psicopatologica dei disturbi della personalità ha da sempre prevalso
un approccio <<categoriale>>. Oggi invece si assiste a un’alternativa che è l’approccio
<<dimensionale>>, dove si ha un continuum tra un disturbo e un altro. Dove sta
proprio l’elevata comorbidità esistente tra i vari disturbi di personalità. la CO-
PRESENZA di un disturbo di personalità ha importanti riflessi sulla prognosi,
sull’aderenza del trattamento e sui risultati. Infatti i tratti di personalità sono
presenti nella popolazione secondo un continuum. Attualmente si è soliti distinguere
10 principali disturbi di personalità, raggruppabili in 3 CLUSTER -> CIOE’ GRUPPI
CON ASPETTI DI SOMIGLIANZA TRA LORO. I disturbi si dividono così:
CLUSTER “A” CLUSTER “B” CLUSTER “C”
- disturbo paranoide -disturbo antisociale -disturbo evitante
-disturbo schizoide -disturbo borderline -disturbo dipendente
-disturbo schizotipico -disturbo istrionico -disturbo ossessivo
-disturbo narcisistico compulsivo di
personalità
CLUSTER “A”
gruppi di personalità caratterizzati dalla
stravaganza e dall'eccentricità
1) DISTURBO PARANOIDE DI PERSONALITA’>> le persone analizzano la
realtà all’insegna della diffidenza e del sospetto. Le intenzioni altrui sono
viste come malevoli. Presumono di essere ingannate. Dubitano
dell’affidabilità di chi le sta accanto. Scorgono significati minacciosi nelle
parole altrui. Possono essere gelosi in modo patologico.
2) DISTURBO SCHIZOIDE DI PERSONALITA’>> modalità pervasiva di
distacco dalle relazioni sociali. Le persone con tale disturbo presentano le
seguenti caratteristiche:
- non desiderano relazioni intime
- preferiscono stare da sole
102
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
- non hanno piacere o interessi verso le varie attività
- indifferenti alle critiche altrui
- non hanno amici
3) DISTRUBO SCHIZOTIPICO DI PERSONALITA’>> presenta un quadro
pervasivo di deficit sociali e interpersonali. Ridotta capacità riguardanti le
relazioni strette ed ha eccentricità del comportamento. Essi presentano tali
caratteristiche:
- Idee di riferimento, cioè interpretazioni scorrette di avvenimenti casuali
come se avessero un significato particolare per l’interessato
- Presentano credenze strane, o di avere un potere speciale
nell’influenzare gli avvenimenti
- Comportamenti eccentrici/strani
- Eccessiva ansia sociale.
CLUSTER “B” gruppo di disturbi della personalità caratterizzati
dalla marcata espressività delle manifestazioni cliniche
1) DISTURBO ANTISOCIALE DI PERSONALITA’>> corrisponde al termine
psicopatia e sociopatia. È dato da un quadro di violazione dei diritti dell’altri.
Non si ha conformismo alle norme sociali. Può mentire, truffare. Ha condotte
spericolate e non si cura della sicurezza propria e altrui.
2) DISTURBO BORDERLINE>> è caratterizzato da un quadro di instabilità
delle relazioni interpersonali, dell’immagine di sé, ha una marcata
impulsività. Presenta:
- Sforzi per evitare un abbandono reale o immaginario
- Relazioni interpersonali instabili
- Impulsività(gioco d’azzardo, abuso di sostanze9
- Comportamenti suicidari
- Rabbia intensa e immotivata
- Ideazione paranoide
3) DISTURBO ISTRIONICO DI PERSONALITA’>> sono caratterizzati da
un’emotività eccessiva e un comportamento di ricerca di attenzione. Si
sentono a disagio quando non sono al centro dell’attenzione. Attirano
l’attenzione attraverso l’aspetto fisico o con un comportamento provocante.
Le loro espressioni emotive possono essere superficiali, con un’espressione
delle emozioni esagerata e teatrale.
4) DISTURBO NARCISISTICO DI PERSONALITA’>> qui si ha un caso di
grandiosità, necessità di essere oggetto di ammirazione. Questi soggetti
103
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
hanno un senso di autostima grandioso. Sono assorbiti da fantasie di illimitati
successi. Si ritengono superiori. Mancano di empatia.
CLUSTER “C”
gruppo di disturbi della personalità causati
dall'ansietà e da problemi di controllo emotivo
1) DISTRUBO EVITANTE DI PERSONALITA’>> modalità pervasiva di
inibizione sociale, sentimenti di inadeguatezza e ipersensibilità al giudizio
negativo. Nel timore di essere criticate evitano comportamenti che
necessitano di un contatto interpersonale. Si vedono poco attraenti, e si
possono sentire umiliate dalle critiche.
2) DISTURBO DIPENDENTE DI PERSONALITA’>> hanno un bisogno
eccessivo di essere accuditi. Con un forte timore di separazione. Essi si
reputano incapaci di badare a se stessi. Permettono ad altri di prendere
decisioni al posto loro. Stentano a fare progetti.
3) DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO DI PERSONALITA’>> classificato
nell’ICD-10 come DISTURBO ANANCASTICO . E’ caratterizzato dalla
preoccupazione per l’ordine, da un’attenzione ai dettagli perfetta, che
interferisce con il completamento dei compiti intrapresi. Presentano una
dedizione al lavoro che porta a ignorare ogni altro aspetto della vita sociale.
Inflessibile e piena di scrupoli morali. Ha un attaccamento eccessivo agli
oggetti. Diverso dal DOC DEI DISTURBI D’ANSIA.
Si può definire come uno schema individuale caratteristico di comportamenti pensieri
ed emozioni.
Deriva dalla parola latina persona che significa maschera.
E' determinata da influenze biologiche,psicologiche e ambientali
La personalità e la malattia sono riconducibili all'equilibrio e allo squilibrio di 4
umori o fluidi presenti nell'organismo umano(sangue,bile,bile nera e flegma)
- Dunque a seconda dell'eccesso di uno degli umori si possono distinguere:
• Tipo melanconico - con eccesso di bile nera che è magro,debole,pallido,avaro,triste.
• Tipo collerico - Con eccesso di bile gialla che è magro asciutto di bel
colore,irrascibile,permaloso,furbo,generoso,superbo.
• Tipo flemmatico - Con eccesso di flegma che è beato lento,pigro,sereno,talentuoso.
• Tipo collerico - Con eccesso di sangue che è
rubicondo,gioviale,allegro,goloso,dwdito ad una sessualità giocosa.
104
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
TEORIE DEI TRATTI
TRATTI - tendenza relativamente stabile della personalità
(generoso,ambizioso,aggressivo,timido).
Allport definì la presenza di tratti centrali (fondamentali da influenzare quasi ogni
comportamento della persona)e secondari(si manifestano solo in alcune situazioni).
Cattei individua le componenti primarie della personalità attraverso l'analisi
fattoriale condotta su tutti gli aggettivi della lingua inglese riferibili al
comportamento umano.
Scopo dello studio - fornire una completa descrizione della personalità non patologica
.
105
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
CAP 10 – DISTRUBI DA SINTOMI SOMATICI,
PSICOSOMATICA E PSICOLOGIA DELLA SALUTE
Si analizza il rapporto tra psicologia clinica e medicina. Analizzando i risvolti
psicologici delle malattie fisiche e alla possibilità di intervenire psicologicamente per
analizzare stati ottimali di salute e benessere
1. DISTURBI DA SINTOMI SOMATICI
Nella professione medica si incontrano pazienti che lamentano disturbi somatici, per i
quali sono cruciali aspetti di natura psicologica.
La maggior parte di tali pazienti riceve una diagnosi di:
DISTURBO DA SINTOMI SOMATICI-> in questo disturbo la sofferenza deriva dal
modo in cui l’interessato interpreta la presenza dei sintomi somatici, ponendoli al
centro della propria vita. La diagnosi è fatta in base alla presenza di pensieri
preoccupazioni, comportamenti eccessivi correlati ai sintomi somatici, al tempo, alle
energie che essi assorbono, alla presenza di un alto livello di ansia. Oggi si da
importanza ad una concezione integrata dell’unità mente-corpo.
DISTURBO DI CONVERSIONE-> o disturbo da sintomi neurologici funzionali, perché
qui la caratteristica essenziale è la presenza di sintomi o deficit riguardanti le
funzioni motorie volontarie o sensitive. I sintomi/deficit motori più comuni sono:
l’alterazione della coordinazione e dell’equilibrio, paralisi o astenia localizzate,
afonia, ritenzione urinaria. I sintomi/deficit sensitivi sono: perdita di sensibilità
tattile, cecità, sordità. Altri sintomi: attacchi epilettici.
Questi sintomi di conversione corrispondono all’idea che l’interessato si è fatto di una
condizione patologica
2. LO STRESS
Il termine stress descrive la reazione da parte dell’organismo agli stressors cioè
fattori di stimolo che causano la reazione di stress e che possono essere gravi, minori,
acuti o cronici.
Hans Selye introduce per primo la sindrome generale di adattamento cioè il modo
nel quale l’organismo fa fronte a eventi stressanti.
Egli distingue tre fasi successive:
1. Fase di allarm: in cui si attiva il sistema nervoso autonomo di fronte a eventi
stressanti intensi
2. Fase di resistenza: l’organismo si adatta allo stress e se questo è intenso presenta
manifestazioni transitorie
3. Fase di esaurimento: l’organismo non è in grado di mettere in atto risposte
adeguate al perdurare dello stress andando incontro a danni irreversibili.
106
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Secondo Selye la reazione di stress ha un carattere adattivo cioè non è una condizione
patologica anche se può produrla.
Lo stress è una reazione dell’organismo aspecifica collocata sul piano endocrino.
Per quanto riguarda la misurazione di questo fenomeno un primo problema posto dai
ricercatori fu l’identificazione degli avvenimenti esistenziali stressanti in rapporto
con la malattia fisica.
Si tentarono di isolare una serie di 43 eventi che presentavano una frequenza
significativa prima dell’insorgenza di malattie somatiche.
Lazarus integra il modello di Selye con gli aspetti cognitivi connessi all’elaborazione
soggettiva circa gli specifici fattori stressanti.
Le differenze individuali sono cruciali nel rendere stressante qualcosa che per altri
può essere indifferente; inoltre a fronte a fattori inequivocabilmente stressanti
persone diverse reagiscono con modalità diverse.
Lazarus distingue due tipi di strategie di reazione:
1. Strategie focalizzate sul problema: azioni dirette alla soluzione di questo o
ricerca di info che ne facilitano la soluzione
2. Strategie focalizzate sull’emozione: riguardano una riduzione delle reazioni
emotive negative Un adattamento ottimale richiede strategie molteplici, flessibili e
calibrate sulla specificità dei fattori o degli eventi stressanti.
La risposta di stress è modulata in un duplice modo dalle caratteristiche psicologiche
del soggetto:
- Fase di percezione ed elaborazione dei fattori stressanti
-Fase di fronteggiamento di tali fattori.
Le caratteristiche che intervengono in questa fase e che modulano le strategie sono
denominate coping skills.
L’intero processo di reazione e fronteggiamento dello stress è il coping.
Per quanto riguarda la misurazione dello stile di coping e la valutazione di questo il
principale test è denominato COPE cioè un questionario che distingue il coping in 3
categorie:
1. Meccanismi focalizzati sul problema
2. Meccanismi focalizzati sull’espressione emotiva
3. Meccanismi potenzialmente disadattivi.
Nella storia sulla ricerca dello stress si distinguono due stagioni:
1. Incentrata sulle proprietà degli stimoli stressanti e sulle caratteristiche della
risposta a questi
107
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
2. Incentrata sulle variabili di mediazione che modulano l’elaborazione cognitiva ed
emotiva e le risorse messe in atto per fronteggiare lo stress
2. STRESS E MALATTIA
La sperimentazione sullo stress indotto sugli animali ha prodotto risultati eclatanti,
tuttavia non è potuta essere replicata su soggetti sperimentali umani; per questo
motivo sono state introdotte in questo ambito ricerche correlazionali che consentono
solo di dire se esiste una relazione tra indici di stress e malattia senza dire il motivo.
Le ipotesi e teorie prodotte sono diverse:
1. Teoria della debolezza somatica: sostiene che lo stress esercita un effetto
sull’organismo dove esso è più debole. Es: fattori genetici.
2. Teoria della reazione specifica: afferma che esistono forti differenze individuali
nella reazione del sistema nervoso autonomo. Nell’eziopatogenesi di un disturbo
psicofisiologico si trova la specificità della risposta individuale allo stress.
3. Teorie psicoanalitiche: ritengono che nell’eziologia si trovino conflitti psicologici e
che la natura di tali conflitti abbia un rapporto simbolico con lo specifico disturbo.
4. Mediazione dello stile di vita: rapporto tra stress e malattia sia indiretto cioè
mediato dallo stile di vita e modificazioni dei comportamenti che incidono sulla
salute.
108
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
3. RUOLO DI MALATO E COMPORTAMENTO DI MALATTIA
Due diverse persone di fronte agli stessi sintomi agiscono sotto l’influenza di una
varietà di emozioni, convinzioni, atteggiamenti, paure, aspettative e valori.
Parsons introduce il concetto di ruolo di malato sottolineando come l’individuo
debba riconoscere che tale stato è indesiderabile ed egli debba impegnarsi e
cooperare per raggiungere la salute il prima possibile; egli inoltre deve dare prova di
ciò utilizzando servizi e professionisti.
Perché l’individuo sia legittimato socialmente nel ruolo di malato non è quindi
sufficiente la presenza dei sintomi.
Il costrutto di comportamento di malattia indica l’insieme dei comportamenti
manifestati dall’individuo che indicano che egli è fisicamente malato.
Il concetto quindi rappresenta l’atteggiamento in generale nei confronti della
malattia e il modo in cui i sintomi sono percepiti e valutati.
Una sottoclasse di questi comportamenti ampiamente studiata è denominata
comportamento-dolore che definisce gli aspetti osservabili del dolore come lamenti,
movimenti lenti e cauti del corpo.
Pilowsky si è occupato del persistere di un modo inappropriato e disadattivo di
percepire, valutare e agire in relazione al proprio stato di salute.
È una nozione che collega concettualmente diverse problematiche come ad esempio la
simulazione, l’ipocondria, la negazione della gravità o l’esistenza di una malattia.
L’adesione ad un concetto di sé come malato o disabile in grado estremo rappresenta
un indicatore di rischio.
La malattia può avere un vantaggio secondario, comportando potenziali benefici e
inducendo a promuovere o mantenere il ruolo di malato.
In questo ambito è importante l’analisi delle variabili di contesto e l’interazione con la
struttura sanitaria e il nucleo familiare.
Il bisogno psicologico di assumere il ruolo del malato è uno dei criteri diagnostici dei
disturbi fittizi ed è la motivazione chiave alla produzione di sintomi fisici o psichici.
La misurazione del comportamento di malattia è sottoposta ad osservazione diretta e
attraverso un questionario IBQ che esplora atteggiamenti rispetto alla malattia e la
sua percezione delle reazioni di persone significative.
4. PRINCIPALI SINDROMI PSICOSOMATICHE
Un gruppo di studiosi ha suggerito precisi criteri definitori per le principali sindromi
psicosomatiche. Tale classificazione ha lo scopo di semplificare la comunicazione tra
ricercatori e al suo interno rientrano:
• Alessitimia: incapacità di utilizzare parole appropriate all’espressione delle
emozioni
109
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
• Comportamento di tipo A: fattori comportamentali di rischio di malattia
coronarica
• Comportamento abnorme di malattia: modalità disadattive che vanno da un
estremo di attenzione e allarme eccessivo all’estremo opposto della sottovalutazione e
della negazione.
• Fobia di malattia: paura persistente e priva di fondamento di soffrire di una
malattia espressa sotto forma di attacchi.
• Tanatofobia: paura di morire e l’evitamento di stimoli che si collegano alla morte
• Ansia per la salute: preoccupazione generalizzata relativa alla malattia, al dolore
e alle funzioni somatiche
• Negazione di malattia: a fronte della presenza di sintomi, segni clinici e
conoscenza della diagnosi si attua una negazione persistente della malattia e della
necessità di trattamento medico
• Somatizzazione: tendenza ad esperire la sofferenza psicologica in forma di sintomi
fisici. Si riferisce a disturbi medici funzionali, a reazioni esagerate ad effetti secondari
di una terapia medica e suggestionabilità o soglia bassa di tolleranza del dolore.
• Sintomi di conversione: sintomi a carico di funzioni sensoriali o motricità
volontaria in assenza di un riscontro organico.
• Reazione da anniversario: fenomeno per cui al raggiungimento della stessa età o
in occasione dell’anniversario, della data nel quale un familiare stretto è morto o ha
sviluppato una grave malattia si attivano sintomi di attivazione neurovegetativa,
disturbi medici funzionali o sintomi di conversione. Il paziente non ha consapevolezza
di tale associazione.
• Umore irritabile: stato d’animo caratterizzato da umore irritabile in contrasto con
il temperamento abituale che richiede autocontrollo per evitare reazioni esagerate.
• Demoralizzazione: stato d’animo di sconforto o disperazione caratterizzato dalla
consapevolezza di aver mancato il raggiungimento di obiettivi esistenziali o
l’incapacità di far fronte a problemi presenti.
5. GESTIONE DELLO STRESS E TERAPIE PSICOFISIOLOGICHE
Si parla di gestione dello stress perché lo scopo non è eliminare lo stress ma ridurlo o
fronteggiarlo efficacemente.
Si possono raggruppare in 2 categorie le soluzioni possibili alla riduzione dello stress:
1. Necessità di cambiamenti esterni: riguardano modificazioni ambientali in cui è
utile prendere decisioni, allontanarsi da situazioni eccessivamente stressanti. Le cause
riguardano:
• Vita familiare e affettiva
• Sfera professionale e rete sociale più ampia
110
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
• Scivolamento in abitudini e carichi di lavoro eccessivi Lo psicologo clinico interviene
con un lavoro di approfondimento psicodiagnostico e di successivo counseling.
2. Necessità di cambiamenti interni: significa cambiare il modo di vedere le cose e
le risposte emotive.
Si parla in questo caso di ristrutturazione cognitiva secondo cui il sistema di
convinzioni della persona è fondamentale per il cambiamento e la persona attraverso
tecniche di autosservazione e organizzazione cognitiva viene aiutata a modificare
aspetti disfunzionali di pensiero abituale.
Tali modificazioni si estendono anche alla sfera delle emozioni.
Altre tecniche di gestione dello stress sono indirizzate alla riduzione del livello di
attivazione e tendono a far acquisire la capacità di ottenere volontariamente un
rilassamento profondo.
Per rilassamento si intende una risposta opposta all’allarme che sul piano fisiologico è
caratterizzata da:
• Riduzione del tono muscolare
• Riduzione della frequenza cardiaca
• Riduzione della pressione arteriosa
• Riduzione della frequenza respiratoria
• Aumento della temperatura periferica cutanea
• Riduzione dell’attività elettrodermica spontanea
• Aumento dell’intensità del ritmo cerebrale La risposta di rilassamento esprime sia
una riduzione dell’attivazione dell’SNA e del sistema endocrino con diminuzione del
livello di arousal a carico del SNC sia una sensazione soggettiva di calma e benessere.
Un rilassamento profondo può essere raggiunto per vie molto diverse ad esempio
attività che assorbono il soggetto, metodiche extrapsicologiche (yoga, meditazione),
ipnosi che comporta importanti modificazioni neuropsicologiche alla pari dello stato
di coscienza.
In generale le tecniche di induzione operano un destrutturazione che altera i
sottosistemi che costituiscono lo stato di coscienza, modifica le certezze del soggetto e
le trasforma da dati di fatto a mere costruzioni soggettive.
La forma più evoluta di trattamento psicofisiologico è il biofeedback cioè l’uso della
moderna strumentazione psicofisiologica per fornire all’individuo informazioni
immediate e precise su variazioni di processi dell’organismo quali la temperatura
cutanea periferica, attività cerebrale e quella mioelettrica.
Si presume che il fornire all’individuo info relative all’aumentare o diminuire di questi
indici possa facilitare sia l’acquisizione di un autocontrollo di certe funzioni, sia
apprendimenti impliciti che portano a sviluppare stati fisiologici compatibili con
111
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
quelli associati a feedback positivo. Il biofeedback è utilizzato come trattamento
specifico per alcuni disturbi psicofisiologici, in particolare le applicazioni nell’epilessia
e nella riabilitazione motoria.
6. DALLA MALATTIA PSICOSOMATICA ALLA MALATTIA
L’ipotesi psicosomatica è dualistica:
• Disturbi somatici che non hanno nulla di psicologico
• Disturbi psicosomatici che hanno una commistione di aspetti somatici e psichici.
Nella metà del 900 si è affermata in medicina e psicologia una posizione che richiama
il fatto che tutti i disturbi biologici hanno elementi psicologici e che tutti i disturbi
psicologici hanno elementi biologici che vanno considerati sia nella diagnosi sia nel
trattamento.
L’espressione disturbi psicosomatici e disturbi psicofisiologici non indicano una classe
di malattie ed è stata abbandonata la pretesa di considerarli nei disturbi mentali e
nervosi.
Nel DSM IV si prevede piuttosto la diagnosi di fattori psicologici che influenzano una
condizione medica.
La categoria diagnostica va riservata quindi a quelle condizioni in cui i fattori
psicologici hanno un effetto clinicamente significativo sul decorso o sull’esito di una
condizione medica generale. Sul piano della professione, per quanto riguarda il ruolo
dello psicologo clinico si pensa ad una figura con competenze di psicologia clinica,
della salute, esperta nei processi psicologici che hanno spazio in tutto il campo della
medicina.
7. MEDICINA COMPORTAMENTALE
Nella seconda metà del 900 si coniò l’espressione behavioral medicine per indicare
l’applicazione di tecniche comportamentali e cognitive a problemi della malattia
fisica.
Un ambito studiato dalla medicina comportamentale riguarda l’insonnia primaria
che si caratterizza per:
• Persona fatica a iniziare il sonno
• Una volta iniziato fatica a mantenerlo
• Al risveglio viene riferito che il sonno non è stato ristoratore e si accusa uno stato di
affaticamento e stanchezza.
L’insonnia è un’esperienza comune ma per raggiungere la soglia clinica deve
persistere per oltre un mese, causare disagio clinicamente significativo, menomazione
del funzionamento sociale.
112
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
L’insonnia primaria riguarda il caso in cui il disturbo non è dovuto ne ad altri disturbi
né agli effetti di sostanze di abuso o farmaci.
Per l’insonnia gli interventi psicologici sono raccolti in 3 gruppi:
- Interventi che mirano in maniera diretta a diminuire il livello di attivazione
psicofisiologica
- Interventi mirati a modificare pattern comportamentali, abitudini e risposte
condizionate
- Interventi che si focalizzano su convinzioni, pensieri, abitudini alimentari,
apprensioni, paure.
Nella cura dell’insonnia è preferibile un approccio integrato e un assessment
approfondito identifica i fattori implicati nella genesi e nel mantenimento
dell’insonnia.
8. DALLA MALATTIA ALLA SALUTE
Nella seconda metà del 900 è mutato sia il concetto di malattia sia quello di salute;
questa era concepita in termini monodimensionali cioè lo stato fisico dell’organismo
quando ha piena funzionalità senza evidenza di malattie.
L’organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto la natura multidimensionale
di questo concetto integrandolo a dimensioni sociali, culturali e soggettive.
La definizione di salute quindi non è più quella di assenza di malattia ma quella di un
completo stato di benessere fisiologico, psicologico e sociale.
Conseguentemente si modificano e si arricchiscono le misure della salute e nasce
l’esigenza di indicatori, di costrutti in positivo, oltrepassando gli indici epidemiologici
e biomedici e il ricorso a misurazioni psicologiche e di carattere soggettivo.
Un altro concetto importante è quello di qualità della vita cioè una percezione
soggettiva rispecchiata da una valutazione soggettiva che abbraccia in maniera
integrata la salute fisica, lo stato psicologico, il grado di autonomia, le relazioni
sociali, le convinzioni e i valori personali.
Il costrutto di qualità della vita connessa a salute e malattia è ad ampio spettro e
include:
• Stato fisico e abilità funzionali
• Stato psicologico e benessere soggettivo
• Interazioni sociali
• Stato e fattori economici e professionali
• Fattori di ordine religioso e spirituale
113
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
9. PSICOLOGIA DELLA SALUTE
Le prospettive integrative aperte e sviluppate dalla psicosomatica e dalla medicina
comportamentale sfociano oggi nella psicologia della salute cioè l’insieme dei
contributi specifici (scientifici e professionali formativi) della disciplina psicologica
alla promozione e al mantenimento della salute, alla prevenzione e al trattamento
della malattia, all’identificazione di correlati eziologici e diagnostici della malattia.
La psicologia della salute:
- Pone l’accento più sulla prevenzione che sul trattamento
- Ha come oggetto di studio comportamento sano e malato
- È attenta più alla salute fisica che a quella mentale privilegiando le malattie di
maggiore impatto sociale
- È interessata alla salutogenesi piuttosto che patogenesi. Una prova della crescita
della psicologia della salute nel nostro paese è offerta dalla nascita di scuole
pubbliche di specializzazione focalizzate sulla salute e dalla nascita di riviste
specifiche.
114
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
CAP 11 - PSICOTERAPIA
1. CARATTERISTICHE COMUNI E PREREQUISITI DEI DIVERSI TIPI DI PSICOTERAPIA
Il termine psicoterapia si riferisce a trattamenti di disturbi mentali o problemi
psicologici che utilizzano metodi psicologici.
Oggi accanto alle terapie tradizionali, troviamo psicoterapie estremamente brevi,
mirate su singoli problemi e legate ad un predefinito protocollo e questo suggerisce di
privilegiare l’espressione trattamento psicologico piuttosto che psicoterapia.
Le caratteristiche di base comuni alle varie forme di psicoterapia:
1. Una relazione interpersonale tra pazienta e terapeuta e un’alleanza a esclusivo
beneficio del paziente
2. Un luogo specifico e sicuro (setting) all’interno del quale si svolge questa relazione
3. La proposta da parte del terapeuta di nuove prospettive e punti di vista che danno
un senso a sensazioni confuse e indefinite
4. Un insieme di tecniche e procedure che specificano il modo di operare del
terapeuta.
La relazione terapeutica presuppone questi requisiti:
1. Rispetto della riservatezza e tutela rigorosa del segreto
2. Accettazione del paziente e assenza di giudizio sul suo comportamento
3. Assenza di un interesse o coinvolgimento personale del terapeuta
4. Messa tra parentesi delle convinzioni religiose, morali, politiche e dei valori e dei
principi Vi sono differenti gradazioni dell’importanza che la relazione assume nel
processo terapeutico.
Si va da una posizione estrema che la considera elemento necessario e sufficiente
quindi l’unico motore attivo del cambiamento, ad una posizione che privilegia il ruolo
della tecnica e la considera come fattore necessario ma non sufficiente a produrre un
cambiamento.
Le diverse finalità dell’intervento psicoterapeutico sono:
1. Far fronte ad una situazione di emergenza, ad un momento di crisi o a situazioni di
difficoltà psicologica transitoria
2. Far fronte ad una condizione psicopatologica in atto e alla sintomatologia
connessa
3. Prevenire le possibili ricadute una volta risolta la situazione acuta con trattamenti
psicofarmacologici o di altra natura
115
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
4. Promuovere la crescita personale mediante il cambiamento di aspetti strutturali
della persona In rapporto alle finalità del trattamento si pone il problema della
direttività.
Si usa parlare di psicoterapia breve per le forme di trattamento contenute in 20-50
sedute ed esistono forme di psicoterapia individuale, di coppia, di famiglia e di
gruppo.
2. PSICOANALISI
È il nome di:
• Procedimento per l’indagine di processi psichici cui altrimenti sarebbe possibile
accedere
• Metodo terapeutico per il trattamento dei disturbi nevrotici
• Serie di conoscenze psicologiche che gradualmente si assommano e convergono in
una nuova disciplina scientifica
Essa è stata sviluppata da Freud ed è nata per la cura dei disturbi nevrotici
principalmente isterici; comprende un insieme di costrutti teorici sul funzionamento e
sviluppo della personalità.
Una delle assunzioni di base è che la vita psichica si svolge in prevalenza fuori dalla
consapevolezza e dal controllo in forma inconscia.
L’inconscio comprende contenuti psichici, attivamente esclusi dalla coscienza ai
quali non si può accedere se non in maniera indiretta e deformata.
I sintomi e le varie forme di disagio esprimono la presenza di conflitti inconsci la cui
origine risale ai primi anni di vita e un particolare disturbo dipende:
- Caratteristiche costituzionali del soggetto
- Ambiente di vita
-Esperienze
- Conflitti affrontati
- Configurazione della struttura psichica.
La psicoterapia in quest’ottica ha una funzione esplorativa cioè l’analisi fa
ripercorrere la storia personale facendo emergere le rappresentazioni inconsce.
Tale percorso riorganizza il mondo interno del soggetto e il cambiamento è dovuto ad
un processo di ristrutturazione che coinvolge varie sfere.
Il metodo utilizzato è quello delle associazioni libere cioè l’espressione libera dei
pensieri senza censure.
116
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Nel setting l’analista rivela neutralità e regola dell’astinenza ma interviene con
interpretazioni per rendere il soggetto più consapevole dei significati di
comportamenti, parole e fantasie.
La psicoanalisi presume un lavoro molto impegnativo e rappresenta un’esperienza
centrale nella vita affettiva del paziente che può favorire lo sviluppo di atteggiamenti
emotivi nei confronti dell’analista. La formazione dello psicoanalista prevede
un’analisi personale e un vero e proprio training con seminari e lezioni e periodi di
pratica sotto supervisione. Il candidato viene poi valutato da organismi
dell’associazione e la selezione è severa.
Senza la formazione dell’analista questo avrebbe difficoltà nel discernere ciò che
proviene dalle reazioni di transfert da ciò che proviene dalle scorie inconsce riattivate
e finirebbe per manipolarlo inconsapevolmente.
La formazione degli psicoanalisti avviene attraverso associazioni private e tramite
diverse associazioni è nata la distinzione tra psicoanalisi e psicoterapia psicoanalitica
più direttamente finalizzata al miglioramento del malessere e alla risoluzione dei
sintomi. La psicoterapia ha obiettivi più circoscritti e limitati ad alcuni nuclei di
conflitto e sofferenza.
Sul piano tecnico la durata riguarda sedute più brevi.
Con il tempo la psicoanalisi è andata allargando l’ambito di applicazione a disturbi
psicosomatici, di personalità e alle psicosi.
Si sono avute diverse scuole di psicoterapia breve che condividono il principio di una
durata definita della terapia meno rigorosa e con proprie tecniche.
Inoltre la psicoterapia psicoanalitica ha sperimentato setting diversi da quello
individuale quindi quello familiare, istituzionale e gruppale.
PSICOTERAPIE PSICODINAMICHE
Nella storia delle associazioni psicoanalitiche sono state frequenti le controversie che
si sono tramutate in scissioni e rotture.
Nel 1911 Adler si trovò in distacco con Freud,se ne stacco è fondo' una sua scuola che
denominò PSICOLOGIA INDIVIDUALE.
Un secondo scisma si ebbe nel 1913 quando Jung si staccò da Freud e coniò
l'espressione di PSICOLOGIA ANALITICA.
NEGLI ANNI 30 Reich fù espulso dalla sociètà viennese ,tale esplulsione fu
determinata dall'insorgere di una sua patologia mentale.Egli sosteneva l'esistenza di
117
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
interconnessioni tra la sfera psichica e quella somatica così profonde e complesse da
rendere indispensabile che in psicoterapia si intervenisse anche sul versante corporeo.
Da Reich prendono così vita le varie correnti di psicoterapia corporea.
Nella seconda metà del 900 sono fiorite varie forme di psicoterapie psicodinamiche di
gruppo.
Si usa distinguere tra psicoterapia di gruppo e psicoterapia in gruppo.
Un altro scisma molto importante fù quello di lacan,che venne espluso dalla sociètà
psicanalitica e organizzò una sua scuola tuttora presente nei paesi francofoni.
Lacan si limitò ad eliminare una vovale e parlò di psicanalisi anzichè psicoanalisi
Altre volte la presa di distanza dal modello psicoanalitico si accompagna a
psicoterapie che mutuano elementi da più modelli. È il caso dell’analisi
transazionale ideata da Berne che riprende concetti sistemici.
L’analisi transazionale comprende un approfondito esame delle “transizioni” che le
persone mettono in atto tra se stesse e le altre persone. Nell’analisi delle transizioni
personali, l’attenzione è rivolta ai “giochi che le persone giocano”, cioè alle interazioni
ripetitive che possono risultare distruttive ed ai “copioni” che le persone adottano nel
gioco relazionale.
Un esempio contemporaneo di terapia psicodinamica breve è la terapia
interpersonale di Klerman e Weissman che fanno prevalentemente riferimento non
allo sviluppo infantile ma ai problemi del hic et nunc.
Il terapeuta interpersonale non farà le seguenti cose:
1. non interpreterà i vostri sogni
2. non farà proseguire il trattamento a tempo indefinito
3. non scaverà nella vostra prima infanzia
4. non vi incoraggerà ad abbandonarvi ad associazioni libere
5. non vi farà sentire molto dipendenti dal trattamento o dal terapeuta
4. PSICOTERAPIA COGNITIVA E COMPORTAMENTALE
118
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Già trent’anni fa, la British Association for Behavourial Psichotherapy, una delle
prime associazioni costituitesi in tale ambito, proponeva nel proprio statuto la
seguente definizione:
la psicoterapia comportamentale è l’applicazione delle scoperte della
psicologia sperimentale e delle scienze connesse al problema di aiutare le
persone a modificare quegli aspetti del proprio comportamento e della propria
esperienza che procurano loro disagio.
Le origini della terapia del comportamento si collocano nel mondo anglosassone
negli anni ’60 e sono dovute al confluire di due spinte sinergiche:
1. la valorizzazione di esperienze pionieristiche che provenivano dalla scuola
pavloniana;
2. un diffuso scontento per i modelli di intervento psicoterapeutico dell’epoca.
Questi motivi di scontento possono essere ricondotti a quattro piani:
- il piano dell’epistemologia dove troviamo motivi di insodisfazione per la struttura
logica della teoria psicoanalitica;
- il piano dell’integrazione con le acquisizioni che provenivano dai vari rami delle
scienze psicologiche e delle neuroscienze;
- il piano dei risultati, dove esisteva insoddisfazione per i limitati benefici a fronte di
un trattamento lungo e impegnativo;
- il piano dell’ampiezza delle applicazioni dove si lamentava la possibilità di un
utilizzo con un numero limitato di problemi.
Nel corso degli anni ’70 l’approccio comportamentale ebbe, nei paesi
anglosassoni,uno sviluppo esponenziale che lo portò presto a superare per diffusione
la stessa psicoanalisi.
Per quanto riguarda la prospettiva cognitiva comportamentale, l’intervento
psicoterapeutico d’eccezione non è sintomatico, ma è di carattere eziologico: con ciò si
intende che il fulcro dell’intervento è dato dall’identificazione e dalla modificazione
delle variabili che intervengono con maggior peso nel problema o nel disturbo.
119
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Per esempio in caso di balbuzie il fulcro dell’intervento potrebbe essere non la
balbuzie, ma un eccessivo livello di ansia sociale o un eccessivo livello di
perfezionismo. In genere in età adulta il setting è individuale e viso a viso, in età
infantile è più spesso familiare. Comune e anche il setting gruppale. Il gruppo è
preferito dove i cambiamenti auspicati hanno a che vedere con le relazioni
interpersonali. In linea di massima la durata dell’intervento si colloca al di sotto
dell’anno e la frequenza delle sedute è settimanale.
È difficile però dare delle informazioni di massima perché esistono moltissimi piani di
trattamento diversi.
All’interno di alcune impostazioni e filoni teorici emersi negli anni ’90 la durata del
trattamento tende ad allungarsi.
Obiettivo di tale trattamento è una rivisitazione dell’organizzazione cognitiva della
persona sia nell’attualità sia nel lungo sia lungo le sue principali linee evolutive a
partire dai processi di attaccamento infantile. Ciò sembrerebbe permettere un più
incisivo trattamento dei problemi esistenziali dei disturbi dissociativi e di disturbi
della personalità.
5. PSICOTERAPIE UMANISTICHE
La psicologia umanistica viene indicata come la “terza forza” della psicologia
accanto alla psicoterapia psicoanalitica e a quella psicodinamica.
Questa terza forza consiste in un gruppo eterogeneo di forme di psicoterapia che
hanno in comune un approccio fondamentalmente umanistico alla psicoterapia.
Queste prospettive si collocano, nei confronti della persona, da una prospettiva di tipo
filosofico; tutte assumono l’esistenza di una“condizione” di autenticità dell’essere
umano.
Il senso della terapia è raggiungere tale autenticità e favorire il dispiegamento delle
potenzialità insite nella persona.
Nella prima metà del secolo in Europa ha avuto un grande rilievo la concezione
filosofica fenomenologia, che ha avuto Husserl come massimo esponente.
120
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
La fenomenologia ha influenzato fortemente la psicologia umanistica, la psichiatria e
in particolare la riflessione psicopatologica di Minkoswski e in Italia Barison e
Cargnello.
Anche l’esistenzialismo è uno degli antecedenti, Kierkegaard, Heidegger, Jaspers e
Sartre sono i punti di riferimento di questo movimento. Nella prospettiva
esistenzialista la condizione umana presenta tutta una serie di caratteristiche
dolorose e difficili da accettare:
- la consapevolezza della morte
- la consapevolezza della nostra impotenza rispetto a molti avvenimenti esterni
- la consapevolezza di una fondamentale solitudine
- la consapevolezza che di fronte alle scelte siamo soli e destinati a
portarne piena responsabilità
- la consapevolezza che la vita e l’esistenza non hanno senso in sé ma
bisogna costruirlo e crearlo.
Da tutto questo si evince che la condizione umana è contraddistinta da una
fondamentale angoscia esistenziale. Compito del terapeuta è rendere il rapporto
terapeutico un incontro autentico tra due esseri umani, offrire sostegno empatia.
5.1. La terapia centrata sul cliente di Carl Rogers
La terapia centrata sul cliente di carl rogers ha come presupposto l’ottimismo e la
fede nella bontà intrinseca della natura umana. Le persone sono per loro natura
buone,capaci di comportarsi in maniera efficace e motivate a migliorare se stesse.
Concetto cardine è quello di “realizzazione di sé”, essa rappresenterebbe una tendenza
innata dell’organismo definita da Rogers “tendenza attualizzante” a sviluppare tutte
le proprie capacità in modo che ciò serva a mantenerlo e migliorarlo.
Compito del terapeuta è di offrire un’atmosfera non direttiva e facilitante ed un
rapporto che consenta dispiegarsi di 3 principali caratteristiche:
121
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
• Congruenza: egli deve esprimere il vero sé comunicando in maniera informale e
sincera i propri sentimenti e i propri pensieri quando opportuno. Al terapeuta è
richiesto di presentarsi quale egli realmente è.
• Empatia: il terapeuta guarda il mondo del cliente assumendo come propria la
prospettiva e il punto di vista del cliente stesso, e gli comunica che il suo punto di
vista, il suo modo di pensare e di reagire emotivamente è compreso e apprezzato.
Questa empatia perette l’emergere di pensieri e emozioni intime.
• Accettazione positiva incondizionata: l’accettazione è definita incondizionata a
differenza delle relazioni nelle quali l’accettazione e l’amore sono condizionati al
rispetto di alcune regole e condizioni. Le persone hanno valore per il fatto stesso di
essere persone e il terapeuta ha profondamente a cuore il proprio cliente all’interno di
una relazione calda ma non invasiva.
Rogers utilizza l’espressione cliente in aperta contrapposizione con quella di paziente
giacché rigetta radicalmente la diagnostica psicopatologica e la nozione di malattia.
Rogers è comunque pienamente consapevole che il proprio metodo rappresenta una
metodologia di counseling e una modalità di crescita individuale raccomandabile in
presenza di problemi subclinici piuttosto che una forma di trattamento dei principali
disturbi psicopatologici. Tra i meriti di Rogers c’è quello di aver per primo fatto uso
della registrazione audio delle sedute terapeutiche ai fini di ricerca.
Rogers è stato anche uno dei maggiori propugnatori dei gruppi di incontro.
L’approccio centrato sul cliente si presta in un setting gruppale a creare un ambiente
facilitante.
5.2 La terapia della Gestalt
La terapia della Gestalt è dovuta Fritz Perls , il riferimento alla psicologia della gestalt
si limita al carattere solistico ed integrativo. Tale terapia da una concessione
ottimistica della natura umana essa tende spontaneamente ad esprimersi
creativamente ed a sviluppare tutto il potenziale umano.
In tale concezione ci si concentra sull’ hic et nunc il passato non esiste più, il futuro
non esiste ancora. Porsi domande sul passato o sul futuro significherebbe perdere
contatto con il presente.
122
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
La terapia gestaltica ha sviluppato una ricca serie di tecniche e di esercizi per
facilitare la crescita e la consapevolezza personale dei clienti. A questi fini la terapia
fa un ampio ricorso all’espressione non verbale. Più del setting individuale la terapia
gestaltica predilige il setting gruppale.
I gruppi di gestalt si focalizzano su quanto avviene qui ed ora e tendono ad aiutare
ciascun membro del gruppo a integrare i propri sentimenti e le proprie convinzioni.
Ciascun membro viene posto a turno sulla cosiddetta “sedia calda” ed è incoraggiato a
identificare sensazioni e emozioni presenti, particolarmente se dolorose o
incongruenti. Il terapeuta commenta l’aspetto non verbale più di quello verbale.
6. TERAPIA SISTEMICA
Almeno nello scenario italiano è presente una quarta forza della psicoterapia:
l’approccio sistemico alla terapia familiare.
L’oggetto di studio privilegiato in tale prospettiva è quanto avviene tra le persone, non
le caratteristiche delle singole persone. In quest’ambito, il contributo teorico
principale è stato offerto da Bateson e da un gruppo di ricercatori del Mental
Research Institute di Palo Alto in California, a partire dagli anni ’50.
Nozione cardine è quella di sistema un concetto ripreso analogicamente dalla fisica
matematica: un raggruppamento di elementi all’interno dei quali intercorrono delle
interazioni tali per cui ogni variazione nello stato di un elemento finisce con il
modificare lo stato di ognuno degli altri.
Dunque lo studio del singolo elemento è marginale: centrale è l’analisi della totalità
del sistema nel quale si colloca l’elemento singolo.
Il principio di causalità lineare viene sostituito dal principio di causalità circolare: in
una famiglia il comportamento del suo membro A influenza il comportamento di B e il
comportamento di tutti gli altri membri, ma a sua volta il comportamento di B
influenza quello di A e di tutti gli altri membri.
Le transazioni che hanno luogo all’interno di una famiglia possono essere descritte
solo con sequenze circolari e sarebbe arbitrario fissare un punto di origine. In ottica
sistemica la psicopatologia non è vista come problematicità del singolo, ma come
risultante del sistema disfunzionali: pattern interattivi che si ripetono rigidamente nel
123
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
tempo sono fonti di psicopatologia. esempi di situazioni relazionali patogene sono
descritte dalla teoria: per esempio: doppio legame, triangolo perverso.
Un sistema tende a mantenere la propria omeostasi la terapia è appunto una di
queste azioni volte a perturbare l’omeostasi, nella speranza di favorire u
cambiamento ed un riequilibrio in termini più adattivi. Sul piano della tecnica, esiste
un notevole eclettismo; la terapia sistemica è piuttosto un modo generale di pensare
che una pratica di intervento puntualmente definita.
Su linee in parte diverse dalla scuola di Palo Alto si evolve il cosiddetto modello
strutturale: la famiglia è vista meno dal punto di vista delle regole di comunicazione
e più come struttura che assolve le molteplici funzioni legate al ciclo vitale. I terapeuti
strutturali sono meno inclini ad elaborare il retroterra teorico. In particolare
Salvatore Minuchin sviluppa modalità di concettualizzazione delle famiglie in base ai
loro confini che avranno vasta diffusione: ad un estremo una famiglia invischiata con
confini estremamente permeabili, all’estremo opposto di un immaginario continuum
una famiglia disimpegnata caraterrizzata da confini impermeabili. Un terzo filone
non approfondisce affatto la dimensione familiare ma quel particolare fenomeno che
è la comunicazione suggestiva e l’ipnosi: con Erickson l’ipnosi conosce una seconda
giovinezza e diventa un fenomeno interpersonale.
Negli anni ’80 si è aperta una profonda fase di revisione che va sotto il nome di
seconda cibernetica nella quale confluiscono principi derivati dalla biologia in
particolare dalla cosiddetta scuola di Santiago (Maturana e Valera) altri principi
derivano dall’approccio conversazionale, dal costruttivismo radicale.
Il setting in terapiafamiliare è particolare: alla seduta è invitata l’intera famiglia
intesa come nucleo che vive abitualmente insieme. Secondo una modalità tipica di
intervento nella stanza con la famiglia sono presenti due terapeuti familiari, altri due
terapeuti osservano la seduta dietro uno specchio unidirezionale.
Nel modello classico la seduta di terapia familiare può suddividersi in 5 fasi:
1. la preseduta: nella quale i componenti l’equipe terapeutica discutono prima
dell’arrivo della famiglia le informazioni già disponibili e le modalità di conduzione
della seduta.
2. l’intervista familiare : viene condotta dai 2 terapeuti a contatto con la famiglia.
124
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
3. la discussione: si svolge tra i quattro terapeuti in assenza della famiglia nella quale
viene discusso e concordato l’intervento successivo.
4. la conclusione: nella quale uno dei terapeuti riferisce alla famiglia le valutazioni
conclusive dell’equipe con un eventuale commento su cui invitare la famiglia a
riflettere o una prescrizione pratica.
5. la post seduta: nella quale l’equipe dopo aver congedato la famiglia discute le
reazioni che la famiglia ha manifestato durante l’intervento conclusivo.
In Italia l’approccio sistemico ha avuto origine e diffusione grazie alla presenza di
Mara SelviniPalazzoli.
Ancora nel 1967 ella aveva fondato a Milano il centro per lo studio dellafamiglia nel
quale si formarono ed operarono quanti costituirono la scuola di Milano.
7. INTEGRAZIONE IN PSICOTERAPIA
Come si è visto lo scenario psicoterapeutico è articolato in 4 approcci fondamentali,
che a loro volta si frammentano in una purità di orientamenti. Questa varietà di
approcci appare ad alcuni una ricchezza mentre per altri significa che lo sviluppo
della psicoterapia è ancora ad un livello prescentifico.
Negli anni 80 si è affacciata una corrente caratterizzata dall’insoddisfazione per i
diversi approcci e per gettare le basi dell’integrazione della psicoterapia.
Il terapeuta di una determinata scuola aderisce al corpo teorico su cui quell’approccio
si fonda e usa procedure e tecniche coerenti con tale impianto teorico. Il movimento
integrativo invece, non aderisce ad alcun approccio in particolare ma è aperto verso
teorie e tecniche diverse e tende a costruire una struttura teorica globale.
Attualmente si possono distinguere tre tendenze che caratterizzano il movimento per
l’integrazione della psicoterapia:
1. Integrazione teorica in questa prima tendenza vengono integrati tra loro due o più
modelli nella speranza che il risultato sia migliorativo rispetto ai modelli di partenza.
Si opera dunque una fusione di elementi concettuali e una interpretazione degli uni
nel linguaggio degli altri.
125
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
2. Fattori comuni questa tendenza prende in esame differenti forme di psicoterapia
per cercare di individuare gli elementi che si hanno in comune , i cosiddetti fattori
comuni. Obbiettivo di questa tendenza è tracciare un profilo dei fattori che risultano
maggiormente associati al processo terapeutico.
3. Eclettismo tecnico a differenza delle prime due tendenze quest’ultima attribuisce
una importanza molto ridotta agli aspetti teorici, ha un atteggiamento pragmatico e
non si interessa di capire perché funzionino le varie tecniche psicoterapeutiche. La
dizione “eclettismo tecnico” è stata data da Lazarus, il quale sostenne che in campo
clinico ha da prevalere un’istanza pragmatica e che il clinico può adottare tecniche di
vari approcci psicoterapeutici senza per questo accettare i fondamenti teorici da cui
tali tecniche discendono. L’ eclettismo tecnico volge la propria attenzione
all’individuazione del trattamento che risulti più efficace per la specifica persona eper
lo specifico problema. Invece di chiedersi “perché” una tecnica funzioni, si chiede “per
chi” essa funzioni.
8. EFFICACIA DELLA PSICOTERAPIA
E’ efficace l’intervento psicoterapeutico? Questa è la domanda fondamentale a cui
rispondere è molto delicato. Ad avviare il dibattito scientifico su tale questione
troviamo Eysenck, il quale osservava che per poter parlare di efficacia bisognava
confrontare i dati con le “remissioni spontanee” che si registravano in pazienti che
non usufruivano della psicoterapia, ma solo dell’opera di sostegno non specialistico
offerto dalle strutture mediche. L’analisi delle ricerche sull’efficacia della psicoterapia
ha mostrato una forte variabilità nei risultati dell’intervento: per alcuni soggetti
produce grandi miglioramenti, per alcuni non produce miglioramenti diversi dalla
semplice remissione spontanea, mentre per altri produce un peggioramento. La
psicoterapia in effetti può essere responsabile del cosiddetto effetto deterioramento:
peggioramento dei sintomi, manifestarsi di sintomi nuovi e problemi diversi.
Nell’ambito della questione sull’efficacia della psicoterapia una svolta fondamentale
si ebbe nel 1977 con lo sviluppo delle tecniche meta-analitiche. La meta-analisi è una
tecnica statistica innovativa.
126
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
lOMoARcPSD|9798018
Oggetto delle elaborazioni meta analitiche sono non gruppi di soggetti ma i
raggruppamenti dei gruppi di soggetti esaminati in ciascuna ricerca. In particolare,
la meta- analisi calcola un indice, detto dimensione dell’effetto che esprime
quantitativamente quanto il gruppo trattato sia migliorato rispetto al proprio gruppo
di controllo.
Come abbiamo visto quindi il primo elemento da prendere in considerazione per poter
sostenere l’efficacia della psicoterapia è il fenomeno della remissioni spontanee. Un
secondo importante elemento da valutare è l’effetto placebo. Questo termine si
riferisce ad un miglioramento delle condizioni fisiche o psicologiche del paziente che
va attribuito alla sua convinzione di star ricevendo una qualche forma di cura
piuttosto che al fatto che quella cura sia effettivamente efficace. Negli ultimi vent’anni
le ricerche si sono concentrate sull’efficacia della psicoterapia con problematiche
specifiche.
FINE
127
Scaricato da UAUUU UAUUU (meowxd8@gmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- Le Psicoterapie - Teorie e Modelli D'intervento (Gabbard)Documento25 pagineLe Psicoterapie - Teorie e Modelli D'intervento (Gabbard)Codruta Terbea100% (1)
- La Diagnosi Psicoanalitica (MC Williams)Documento33 pagineLa Diagnosi Psicoanalitica (MC Williams)Elisa ZanonNessuna valutazione finora
- Riassunto Psicologia ClinicaDocumento33 pagineRiassunto Psicologia ClinicaVanna Amicizie Esaurite IsaiaNessuna valutazione finora
- PSICODIAGNOSTICA RiassuntoDocumento64 paginePSICODIAGNOSTICA RiassuntoDario Brizi100% (1)
- dsm5 Edizione 5Documento4 paginedsm5 Edizione 5netshidoNessuna valutazione finora
- Manuale di Psicologia Clinica, Psichiatria Clinica e PsicoterapiaDa EverandManuale di Psicologia Clinica, Psichiatria Clinica e PsicoterapiaNessuna valutazione finora
- Psicologia Delle Relazioni Interpersonali - Slides 1-118Documento118 paginePsicologia Delle Relazioni Interpersonali - Slides 1-118AlysiaNessuna valutazione finora
- Riassunto Completo Metodologia Della Ricerca PsicologicaDocumento48 pagineRiassunto Completo Metodologia Della Ricerca PsicologicaDavide Pika-pika LucianiNessuna valutazione finora
- Sbobinature PsichiatriaDocumento123 pagineSbobinature PsichiatriaSalò Marziali100% (2)
- Psicopatologia e Ragionamento ClinicoDocumento5 paginePsicopatologia e Ragionamento Clinicobarra_marcoNessuna valutazione finora
- Ansia e NeurobiologiaDocumento56 pagineAnsia e NeurobiologiaSalvatore CaciNessuna valutazione finora
- Parte 4 L'Approccio Sistemico Relazionale La Psicologia Dei Gruppi e La Leadership Nelle Professioni Di AiutoDocumento19 pagineParte 4 L'Approccio Sistemico Relazionale La Psicologia Dei Gruppi e La Leadership Nelle Professioni Di Aiutolulujolie100% (2)
- Psicologia Delle DipendenzeDocumento35 paginePsicologia Delle DipendenzeAnnamaria Spinoglio100% (1)
- Analisi Della DomandaDocumento13 pagineAnalisi Della DomandaFederico ConteNessuna valutazione finora
- Psicologo Domani Kaneklin PDFDocumento0 paginePsicologo Domani Kaneklin PDFzuzendinoNessuna valutazione finora
- Psicologia Clinica EsameDocumento82 paginePsicologia Clinica EsameCaterinaNessuna valutazione finora
- Psicologia Clinica 1Documento99 paginePsicologia Clinica 1Martina BauccioNessuna valutazione finora
- Lezioni - Psico. ClinicaDocumento19 pagineLezioni - Psico. ClinicaAmbra BerettiNessuna valutazione finora
- LA SALUTE MENTALE E IL DISTURBO PSICOLOGICO: cosa sono e come funzionanoDa EverandLA SALUTE MENTALE E IL DISTURBO PSICOLOGICO: cosa sono e come funzionanoNessuna valutazione finora
- Depressione, ansia e panico domande e risposteDa EverandDepressione, ansia e panico domande e risposteValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- La Psicoanalisi - Manuale di Psicologia comparata per medici e psicologiDa EverandLa Psicoanalisi - Manuale di Psicologia comparata per medici e psicologiNessuna valutazione finora
- La psicologia dell'ansia: Conoscerla per capirne i meccanismi di funzionamento (psicologia per tutti)Da EverandLa psicologia dell'ansia: Conoscerla per capirne i meccanismi di funzionamento (psicologia per tutti)Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- LA PSICOLOGIA RESA SEMPLICE - VOL 2 - Introduzione alla psicologia delle emozioni. Da Darwin alle neuroscienze, cosa sono le emozioni e come funzionano.Da EverandLA PSICOLOGIA RESA SEMPLICE - VOL 2 - Introduzione alla psicologia delle emozioni. Da Darwin alle neuroscienze, cosa sono le emozioni e come funzionano.Nessuna valutazione finora
- Il DSM 5 e La Diagnosi Dimensionale Dei Disturbi Di PersonalitaDocumento3 pagineIl DSM 5 e La Diagnosi Dimensionale Dei Disturbi Di PersonalitaAndrea MinelliNessuna valutazione finora
- Riassunti Moderato Rovetto - Psicologo Verso La ProfessioneDocumento68 pagineRiassunti Moderato Rovetto - Psicologo Verso La Professioneanno666100% (3)
- Diagnosi in Psicologia Clinica - Pdffare Bene Disturbi D'ansiaDocumento58 pagineDiagnosi in Psicologia Clinica - Pdffare Bene Disturbi D'ansiaSabaDubaNessuna valutazione finora
- DSM 5 - L'essenzialeDocumento41 pagineDSM 5 - L'essenzialeCynthia Katherine Gonzales CastillaNessuna valutazione finora
- Manuale Diagnostico PsicodinamicoDocumento22 pagineManuale Diagnostico PsicodinamicoAnnarita Morabito100% (1)
- AnamnesiDocumento53 pagineAnamnesilulujolieNessuna valutazione finora
- Psicologia GeneraleDocumento57 paginePsicologia GeneraleValentina F. NelielNessuna valutazione finora
- Psichiatria e Dsm-5Documento405 paginePsichiatria e Dsm-5Ale cNessuna valutazione finora
- Lezioni Sbobinate BoveDocumento123 pagineLezioni Sbobinate BoveDan ValiumNessuna valutazione finora
- Linee Guida Per L'Accertamento E La Valutazione Psicologico Giuridica Del Danno Biologico Psichico E Del Danno Da Pregiudizio EsistenzialeDocumento38 pagineLinee Guida Per L'Accertamento E La Valutazione Psicologico Giuridica Del Danno Biologico Psichico E Del Danno Da Pregiudizio EsistenzialeMassimo BottiNessuna valutazione finora
- NEUROPSICOLOGIADocumento21 pagineNEUROPSICOLOGIABeatrice Sciotto100% (2)
- Trattato Di Psichiatria Forense PDFDocumento153 pagineTrattato Di Psichiatria Forense PDFsimoneNessuna valutazione finora
- Riassunto Analisi Della Domanda Paniccia e CarliDocumento11 pagineRiassunto Analisi Della Domanda Paniccia e CarliManuela Agazzi100% (2)
- Preparare Strategicamente L Esame Di StatoDocumento32 paginePreparare Strategicamente L Esame Di StatoAlex DuranteNessuna valutazione finora
- DiagnosticoDocumento109 pagineDiagnosticopati100% (1)
- Criminologia GeneraleDocumento4 pagineCriminologia GeneraleMariela Ribeiro PaivaNessuna valutazione finora
- La Psicologia InvestigativaDocumento6 pagineLa Psicologia InvestigativalulujolieNessuna valutazione finora
- Gabbardone-Le PsicoterapieDocumento52 pagineGabbardone-Le PsicoterapievaleriaNessuna valutazione finora
- DSM 5 Disturbi Di PersonalitàDocumento12 pagineDSM 5 Disturbi Di PersonalitàJelena TrajkovicNessuna valutazione finora
- Schemi Cognitivi e Credenze Di Base - Cap1Documento18 pagineSchemi Cognitivi e Credenze Di Base - Cap1Massimo Del MonteNessuna valutazione finora
- Il colloquio criminologico istituzionale e investigativoDa EverandIl colloquio criminologico istituzionale e investigativoNessuna valutazione finora
- La Psicologia Investigativa e Lo StudioDocumento49 pagineLa Psicologia Investigativa e Lo Studiovictoria100% (1)
- Caso Clinico Bambino Con Disturbo OpposiDocumento121 pagineCaso Clinico Bambino Con Disturbo OpposiGiuseppe LeporeNessuna valutazione finora
- Manuale Psicologia DinamicaDocumento296 pagineManuale Psicologia DinamicaSzandorLaveyNessuna valutazione finora
- Le Teorie Psicologiche PDFDocumento139 pagineLe Teorie Psicologiche PDFAnonymous sFS4Dg100% (3)
- Esame Stato Caso ClinicoDocumento8 pagineEsame Stato Caso ClinicoAna Rosegarden100% (1)
- I Giochi Del Familiare DipendenteDocumento51 pagineI Giochi Del Familiare Dipendentem0r9anNessuna valutazione finora
- Riassunto McwilliamsDocumento18 pagineRiassunto McwilliamsMatteoNessuna valutazione finora
- Terapia Cognitivo-Comportamentale Delle Psicosi: Diagnosi, Trattamento e Intervento PrecoceDocumento3 pagineTerapia Cognitivo-Comportamentale Delle Psicosi: Diagnosi, Trattamento e Intervento PrecoceState of MindNessuna valutazione finora
- Riassunti Mitchell Psicologia DinamicaDocumento35 pagineRiassunti Mitchell Psicologia Dinamicasere14100% (1)
- Psicopatologia Del Ciclo Di Vita - RiassuntoDocumento73 paginePsicopatologia Del Ciclo Di Vita - RiassuntoElena SantarelliNessuna valutazione finora
- Manuale Di Psicopatologia Dell InfanziaDocumento39 pagineManuale Di Psicopatologia Dell InfanziaporavNessuna valutazione finora
- I Test Proiettivi in Ambito Giudiziario PDFDocumento31 pagineI Test Proiettivi in Ambito Giudiziario PDFjaverianaNessuna valutazione finora