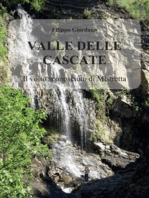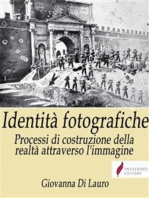Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Storia e Tecnica Della Fotografia
Caricato da
Francesca Festa0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
267 visualizzazioni37 pagineRiassunto integrale del libro di Zannier escluse antologie
Titolo originale
STORIA E TECNICA DELLA FOTOGRAFIA
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoRiassunto integrale del libro di Zannier escluse antologie
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
267 visualizzazioni37 pagineStoria e Tecnica Della Fotografia
Caricato da
Francesca FestaRiassunto integrale del libro di Zannier escluse antologie
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 37
STORIA E TECNICA DELLA FOTOGRAFIA
IDEA, SOGNO E GESTAZIONE DELLA FOTOGRAFIA
Le macchine ottiche
La fotografia si è realizzata attraverso una gestazione di un’idea (la memoria dello
sguardo) chiamata eliografia e poi fotografia, di cui si intendeva memorizzare gli
eventi, conservarne e trasmetterne l’immagine.
Gli storici della fotografia propongono Aristotele tra coloro che per primi hanno
teorizzato il fenomeno della CAMERA OBSCURA, come è indicato dall’ottico e
astronomo Alhazen Ibn Al-Haitham in un’opera in cui descrive il principio di questo
strumento per osservare un’eclisse di sole, seguendone le fasi indirettamente
nell’immagine proiettati, per non rimanere abbagliati dalla forte luce diretta
dell’astro. L’impegno scientifico per i primi sperimentatori di meccanismi ottici era
suggerito e stimolato dalla curiosità per i fenomeni naturali.
In questo periodo gli studi sulla prospettiva sembrano essere al centro dell’attenzione
di architetti e pittori che credono di aver finalmente definito un codice che offre
molte garanzie di precisione, tra cui la “verosimiglianza”, da cui traspare già l’idea di
fotografia.
Nella controversa attribuzione dell’invenzione della camera obscura (che in seguito si
chiamerà camera ottica) compare spesso in evidenza il fisico napoletano Giovanni
Battista Della Porta che, nel trattato Magiae naturalis riferisce alcune sue
osservazioni, si tratta ancora di una stanza e non di uno strumento mobile o
comunque facilmente adattabile all’ambiente circostante; è nel secolo successivo che
la camera obscura trova finalmente una sua più funzionale e estesa applicazione.
Questa “macchina” sta diventando indispensabile per il mestiere di disegnatore,
mentre si sviluppano contemporaneamente le tecniche dell’incisione che favoriscono
la riproduzione e la moltiplicazione delle immagini, avviando un processo di
massificazione iconografica. A Roma, Marco Antonio Cellio progetta addirittura un
nuovo strumento “per trasportare qualsiasi figura disegnata in carta, mediante i raggi
solari” mentre il matematico e filosofo Athanasius Kircher, occupandosi della camera
oscura, aveva ideato modelli mobili e addirittura abitabili; in un’edizione successiva
propone un’altra macchina ottica, la lanterna magica. Mentre la camera obscura uno
strumento per la riproduzione, la lanterna magica serve allo spettacolo, alla
proiezione delle immagini disegnate e dipinte su supporti trasparenti, quindi alla
comunicazione. Tra i molti strumenti progettati vi è anche una camera oscura reflex,
dove l’immagine viene proiettata su un piano orizzontale mediante uno specchio
inclinato a 45°, che è all’interno di una scatola. Anche la camera lucida (o chiara) farà
parte del bagaglio di molti viaggiatori, oltre che di artisti e studiosi. Consiste in un
prisma di vetro applicato a un’astina metallica agganciata ad una tavoletta, dove
viene appoggiato un foglio di carta; il disegnatore, guardando attraverso il prisma,
può seguire quasi contemporaneamente, con la coda dell’occhio, l’oggetto da
riprodurre che vede virtualmente sul foglio sottostante.
Le sostanze fotosensibili
L’idea della fotografia si stava concretizzando e ha inizio con l’alchimista olandese
Johan Simoonis Van der Beeck, chiamato Torrentius che infine venne condannato per
stregoneria, avendo eseguito dipinti così perfetti da sembrare realizzati dal diavolo e
che furono quindi dati alle fiamme. Non c’erano ancora stimoli effettivi che
portassero ad accomunare le ricerche chimiche a quelle ottiche. George Fabricius
aveva osservato e descritto in un suo testo che alcuni materiali contenenti cloruro
d’argento si alteravano se esposti alla luce e chiamò questa sostanza LUNA
CORNEA (si trattava del solfato di bario). Il chimico svedese Carl wilhelm Scheele,
cinquant’anni dopo, ripropose l’argento corneo di Fabricius in studi che ottenne
anche tracce di colore sulla carta impregnata di questo cloruro, in variazioni dal
violetto al rosso, a seconda del tempo di esposizione. Durante le sue prove constatò
anche che la luca violetta è quella più efficace. In questa complessa vicenda di
ricercatori si inserisce il fisico Jules-Alexandre Cesar Charlesm il quale, mediante un
potente fascio di luce proiettò il profilo di uno dei suoi allievi su un foglio di carta
spalmato di cloruro d’argento. La carta cominciò immediatamente a iscurirsi nella
regione illuminata, mentre quella in ombra rimase bianca; l’immagine però non era
stabile e si scurì dappertutto appena rimosso il soggetto che la proteggeva con la sua
ombra (aveva realizzato fotograficamente una silhouette).
Le silhouette di Charles, se esistite, sarebbero le prime immagini registrate per effetto
della luce, senza alcun intervento manuale, ma non vi sono prove sicure. Mentre si
concludeva il secolo dei lumi, l’idea della fotografia finalmente si materializzava, ma
di questa prima sua comparsa non è rimasta traccia, se non una breve testimonianza,
pubblicata nel “Journal of the Royal Institution” di Londra in cui è descritto un
procedimento per copiare disegni su vetro e fare silhouette con l’azione della luce sul
nitrato d’argento.
L’invenzione della fotografia
La carta bianca, o la pelle bianca bagnata con una soluzione di nitrato d’argento, non
cambia tinta sino a quando viene conservata nell’oscurità, ma esposta alla luce del
giorno esse passano rapidamente al grigio, poi al bruno e quindi pressoché al nero.
Questi mutamenti sono tanto più rapidi quanto più la luce è intensa e la luce
trasmessa attraverso vetri diversamente colorati agisce con diversi gradi d’intensità;
con i raggi rossi hanno poco effetto, i gialli e i verdi sono più efficaci ma i blu e i
violetti hanno l’azione più energica.
Quando si colloca una superficie bianca, coperta di una soluzione di nitrato
d’argento, dietro una pittura su vetro, e si espone tutto ai raggi del sole, i raggi
trasmessi producono delle tinte assai intense di bruno e di nero, che differiscono di
intensità secondo che esse corrispondono alle parti del quadro più o meno scure; e
dove la luce è trasmessa nella sua tonalità, in quei punti il nitrato assume la tinta più
cupa. Quando si fa cadere sulla superficie impregnata di nitrato, l’ombra della figura,
la parte che essa nasconde rimane bianca e il resto passa prontamente al bruno scuro.
Questa tinta è molto permanente e non la si può annullare né con l’acqua né con il
sapone. La soluzione si prepara mescolando una parte di nitrato di argento in dieci
parti d’acqua. In queste proporzioni, la quantità di sale di cui la carta o la pelle si
troveranno impregnate sarà sufficiente a renderle suscettibili di essere colpite dalla
luce, senza che la loro composizione o il loro tessuto siano del tutto alterati.
INVENZIONI E PERFEZIONAMENTI
Dalla litografia all’eliografia
Prima che “photography” appaia comunemente nel vocabolario di artisti e scienziati,
è stata chiamata ELIOGRAFIA, DAGHERROTIPIA, CALOTIPIA.
Pur utilizzando il termine “profiles”, Wedgwood e Davy sono stati i primi a prendere
coscienza delle possibilità grafiche della luce, non solo appoggiando oggetti sul
materiale fotosensibile, ma in modo più complesso utilizzando il microscopio solare e
la camera oscura; è incerto comunque se abbiano eseguito prove soddisfacenti
giacché le immagini che essi produssero svanirono a causa della stessa luce che le
aveva generate. Come conservare i disegni scritti dalla luce era dunque un problema
fondamentale e la litografia di Alois Senefelder riscosse subito un notevole successo.
La litografia offriva la possibilità di riprodurre delicatamente anche i mezzi toni e
quindi ottenere sfumature di grigio e passaggi di chiaroscuro, avvicinandosi così
all’idea primitiva della fotografia. È proprio alla tecnica della litografia che si
riferiscono le prime ricerche di Niépce, il quale ha realizzato le più antiche immagini
impresse dalla luce, fissandone alcune in modo permanente.
Joseph Nicéphore Niépce
Era stato avviato alla carriera ecclesiastica, come il fratello Claude, con cui lavorò a
molte altre invenzioni, oltreché all’eliografia. In particolare si dedicarono al progetto
di una “macchina destinata ad azionare i battelli, senza remi né vele”, il
pyréolophore, anticipatore del motore a scoppio, che i due brevettarono nel 1807, ma
con il quale non ebbero successo. Al tempo della rivoluzione, insegnava presso la
Congregation des Peres de l’Oratoire ad Angers, ma abbandonò ben presto questa
occupazione per arruolarsi nell’esercito napoleonico; nel 1792 fu in Italia, a Cagliari,
dove pare abbia avviato il suo “sogno” della fotografia. Sposatosi, preferì occuparsi
dell’amministrazione delle sue proprietà, dove eseguì anche i primi esperimenti
sull’eliografia e si dedicò con Claude alle altre invenzioni.
L’idea di migliorare o, perlomeno rendere più semplice la tecnica litografica,
sollecitò in un primo tempo i due fratelli a sperimentare la possibilità di utilizzare il
metallo anziché la pietra; pensarono inoltre di ottenere con la luce l’impronta di un
disegno posto a contatto della lastra metallica. Niépce adoperò anche il vetro e la
carta come supporto, impregnandola di cloruro d’argento e acido nitrico. Ma
l’impossibilità di fissare l’immagine dissuase i due fratelli dall’insistere in queste
prove, di cui esistono solo vaghe indicazioni per adottare un altro materiale
fotosensibile, il bitume di Guidea, che si rivelerà miracolosa; questo asfalto era di uso
comune a quel tempo e ne era conosciuta l’alterabilità alla luce. Il bitume di Guidea,
che indurisce se colpito dalla luce per un lungo periodo, rimane invece solubile nelle
altre parti non esposte, se immerso in petrolio, olio di lavanda o di Dippelio, un
grasso animale; esso tende anche a schiarire, determinando con lo sfondo della lastra
un chiaroscuro che riproduce il disegno dell’immagine; quest’ultima poteva essere
ottenuta da un disegno su matrice di carta resa più trasparente con olio e cera e posta
a contatto con la lastra biutmata oppure mediante l’uso della camera ottica.
Nell’agosto del 1827 fece un viaggio in Inghilterra per visitare il fratello Claude,
gravemente ammalato e in quella occasione si incontrò con Bauer. Tornato in
Francia, l’anno successivo, continuò la corrispondenza con Bauer fino al 1829,
interrompendo questo dialogo probabilmente perché stava concludendo un accordo
con Daguerre, inventore del diorama; entrambi speravano di trarre profitto dalle
possibilità offerte dalla tecnica eliografica e il contratto tra i due era stato siglato a
Chalon-sur-Saone e avrebbe avuto la durata di dieci anni se Niépce non fosse
scomparso prima, lasciando però erede il figlio Isidore.
Niépce aveva fino ad allora compiuto esperimenti usando tre diversi supporti: il rame,
l’argento e il vetro. Il primo veniva trattato, dopo l’esposizione, come l’acquaforte,
ottenendo una matrice che, inchiostrata, consentiva di stampare un grande numero di
copie. L’argento veniva utilizzato per ottenere una copia unica, positiva, mediante
l’annerimento del metallo con i vapori dello iodio. Il vetro doveva essere invece
esaminato in trasparenza. Quest’ultima esperienza avrebbe potuto essere decisiva
qualora Niépce si fosse reso conto che con queste lastre trasparenti aveva inventato il
negativo.
Louis-Jacques-Mandé Daguerre
Aveva iniziato a fare ricerche sulle sostanze fotosensibili sin dal 1825, dopo essersi
occupato di pittura e di scenografia e queste esperienze lo sollecitarono a realizzare
von Charles-Marie Bouton, uno spettacolo analogo al “panorama” che egli chiama
DIORAMA e con il quale ottenne subito un notevole successo di pubblico.
Consisteva nell’allestimento di gigantesche scenografie trompe l’oeil, realizzate con
tele semitrasparenti dipinte con prospettive di luoghi e edifici famosi, cercando di
ricostruire suggestioni di spazi reali, con artifizi di luce e di effetti ottici. I diorama gli
diedero grande notorietà e si diffusero in varie città europee, preannunciando
spettacoli visivi, quale sarebbe stato in seguito il cinematografo. L’8 marzo 1839
però, il diorama parigino si incendiò e ogni cosa venne distrutta, mettendo
economicamente in crisi Daguerre il quale fu sollecitato, anche da questo incidente, a
rendere pubblica l’invenzione, nel frattempo perfezionata, in cambio di un aiuto
economico da parte dello Stato francese. Tra un diorama e l’altro si è cimentato nelle
ricerche sulle sostanze fotosensibili, in continua corrispondenza con Niépce, per un
reciproco scambio di informazioni sui risultati raggiunti. Il 20 agosto 1839 Daguerre
diffuse un manuale di 79 pagine, subito ovunque avidamente utilizzato e entro la fine
dell’anno ne vennero stampate ben cinque edizioni; la prima edizione italiana uscì a
Genova nel 1839 con testo francese. La più antica trascrizione di un dagherrotipo
ricopiato manualmente in litografia è stata eseguita a Napoli da parte del litografo G.
Forino. Il procedimento è sostanzialmente diviso in cinque fasi, mediante le quali si
ottiene l’immagine definitiva:
1. Lucidatura con acido nitrico della lastrina di rame placcato d’argento
2. La lastra viene collocata in una cassetta di legno dove riceve i vapori di iodio
(sulla superficie di forma ioduro d’argento, che è fotosensibile)
3. Si introduce la lastra, al buio, nell’apparecchio di ripresa, dove viene esposta
per un periodo di tempo che varia da un quarto d’ora a pochi minuti
4. Dopo l’esposizione viene inserita, sempre al buio, in una boite a mercure di
legno, con un’inclinazione a 45°, sopra una capsula di metallo che contiene
circa un chilogrammo di mercurio, riscaldato a circa 60°, con una lampada a
olio o a spirito (10 minuti circa)
5. Si procede al fissaggio in acqua e iposolfito di sodio e a un successivo lavaggio
in acqua distillata
Nel frattempo veniva presentata un’altra tecnica per eseguire rigorose immagini
“senza saper disegnare”; un procedimento che si diffuse egualmente perché più
“povero”, considerando che il supporto era carta invece che di rame placcato
d’argento. Inventore di questa tecnica di fotografia su carta, o più propriamente del
disegno fotogenico, fu l’inglese William Henry Fox Talbot.
William Henry Fox Talbot
Si era dedicato giovanissimo alle scienze e gli strumenti ottici, soprattutto il
microscopio, erano d’uso quotidiano per Talbot. Aveva studiato al Trinity College di
Cambridge, laureandosi nel 1821 e in seguito aveva viaggiato in vari paesi europei
portando con sé la camera ottica o la camera lucida, per poter schizzare più
facilmente scorci e cedute dei luoghi visitati. Nel 1833 a Bellagio sul lago di Como,
mentre stava disegnando gli venne l’idea di trovare un modo per fissare il disegno
della luce senza l’intervento manuale. Nei primi esperimenti riuscì a conservare le
immagini lavandole con ioduro di potassio, ma l’amico Herschel gli propose
l’iposolfito di sodio, risolvendo definitivamente il problema per tutti.
Preoccupazione di Talbot era che non gli fosse riconosciuta la priorità
dell’invenzione, visto che Daguerre aveva presentato per primo il procedimento del
dagherrotipo; Talbot non sapeva ancora che la dagherrotipia era un processo diverso
e utilizzò quindi tutti gli espedienti per far conoscere le sue ricerche e porre in risalto
le date delle sue scoperte. Sembrò essere stimolato dalla polemica sul primato
dell’invenzione della fotografia e migliorò in breve tempo il suo procedimento
negativo-positivo, che aveva sul dagherrotipo il vantaggio di consentire la stampa di
molte copie, rendendo trasparente con cera o glicerina la carta su cui veniva impressa
con la camera oscura l’immagine negativa. Talbot brevettò molte sue invenzioni,
proibendone l’uso senza il suo consenso, come la CALOTIPIA: stendeva una
soluzione di nitrato d’argento su della buona carta da lettere e, dopo averla asciugata,
la immergeva in una soluzione di ioduro di potassio; la carta così preparata poteva
essere riposta al buio per un periodo abbastanza lungo, una volta che era stata
essiccata, utilizzandola al momento opportuno dopo averla di nuovo imbevuta di un
liquido composto da due soluzioni A e B: la prima, con nitrato d’argento in cristalli,
acqua distillata e un’aggiunta di acido acetico, la seconda, con acido gallico diluito in
acqua distillata (le due soluzioni erano mescolate in parti uguali). La carta così
trattata permetteva di eseguire le calotipie con un brevissimo tempo di esposizione,
facendo apparire l’immagine solo dopo lo sviluppo. Il fissaggio era ottenuto sia con
bromuro di potassio, che con iposolfito di sodio. Le calotipie venivano quindi
incerate, per renderle più trasparenti e ottenere da questi negativi un numero
indefinito di copie positive.
Nel 1839 oltre al disegno fotogenico e al dagherrotipo, altri sono i procedimenti
sperimentali: quelli di Herschel e di Bayard hanno il vantaggio di essere stati
documentati.
John Herschel e Hippolyte Bayard tra gli inventori
John Herschel fu lo scienziato al quale la fotografia deve l’importante scoperta
dell’iposolfito di sodio come agente fissatore e in una sola settimana riuscì a
reinventare il procedimento fotografico. Herschel eseguì anche un’immagine negativa
su di una lastrina di vetro di forma circolare, riprendendo un traliccio
dell’osservatorio astronomico di suo padre (è la più antica lastra fotografica su questo
materiale conservata allo Science Museum).
A Parigi, un impiegato del ministero delle finanze, Hippolyte Bayard, si inseriva tra i
grandi inventori della fotografia, senza avere però allora i riconoscimenti che si
sarebbe meritato, in quanto erano tutti affascinati dall’invenzione di Daguerre. Era
stato incoraggiato a portare a termine vecchi studi sulle sostanze fotosensibili ed era
riuscito in breve tempo a ottenere soddisfacenti risultati; solo un mese dopo era in
grado di mostrare alcuni dessins photogénés o images photogénées, come chiamò le
sue prove su carta sensibilizzata con ioduro d’argento, direttamente positive. Lo
stesso anno si metteva in contatto con Arago e il 24 giugno esponeva circa quaranta
immagini nella Salle des Commissaires Priseurs. Dopo queste ricerche che tendevano
a ottenere immagini positive sulla carta, Bayard comprese che il negativo su carta
poteva consentirgli di moltiplicare il numero delle copie e realizzò quindi un nuovo
procedimento. Egli va ricordato non solo come inventore, ma come fotografo,
essendo autore di alcune serie di immagini dove sono fissate situazioni di luce e
scorci di una singolare vivacità prospettica, favorita senza dubbio dalla sua tecnica.
Albumina e collodio
Tra il 1839 e il 1851 la fotografia dagherrotipica e calotipica si diffonde, ma al tempo
stesso vengono apportati continui miglioramenti. La ricerca procede soprattutto in
funzione dei principali difetti impliciti nel dagherrotipo (esemplare unico) o nel
calotipo (granulosità delle stampe); si tende inoltre a ottenere una maggiore
fotosensibilità e si esplora la possibilità di fissare il colore della realtà, per una
maggiore “verosimiglianza”.
Louis-Desiré Blanquart-Evard sperimenta una carta salée (papier salée) che ottiene
bagnando la carta in acqua e cloruro di sodio al 30% e, dopo averla asciugata,
spalmandovi sopra del nitrato d’argento diluito al 20% in acqua distillata; sottopose
poi la carta a un altro successivo trattamento, poi chiamato viraggio, con cloruro
d’oro al 2 per mille. Il viraggio al cloruro d’oro ha la capacità di stabilizzare
maggiormente l’immagine e di attribuirle un’intonazione calda più gradevole.
Abel Niépce de Saint-Victor ottenne le prime lastre fotosensibili, stendendo sul vetro
un sottile strato di albumina sensibilizzata con aceto-nitrato d’argento. Le uova
utilizzate per la preparazione della carta all’albumina dovevano essere
preferibilmente fresche e di galline vecchie, perché i risultati fossero eccellenti.
Mentre si continuò a utilizzare il procedimento all’albumina soprattutto per le copie
positive, la tecnica di ripresa su lastre sensibilizzate con l’emulsione al collodio
sostituì in breve tempo ogni altra.
Il collodio era usato nell’arte medica per le proprietà che possiede di evaporarsi
prontamente lasciando una pellicola solida impermeabile all’aria. Venne preso in
considerazione come collante fotografico da Gustave Le Gray nel 1849 e,
contemporaneamente, l’architetto inglese Frederick Scott Archer pubblicava a sua
volta una nota sull’uso del collodio in fotografia. Il metodo consiste nella
preparazione di una soluzione alcolica di ioduro di potassio e di ioduro d’argento,
mescolata al collodio e successivamente sensibilizzata con il nitrato d’argento; lo
sviluppo avviene in acido pirogallico e il fissaggio con iposolfito di sodio. Questo
miscuglio risultava assai più sensibile alla luce se la lastra veniva utilizzata prima che
il collodio asciugasse; il collodio umido consentì quindi di ridurre i tempi di
esposizione (all’aperto si ottennero fotografie con tempi di frazioni di secondo,
consentendo finalmente l’istantanea).
In molti si dedicarono alla ricerca sulla tecnica del collodio e Taupenot risolse
parzialmente le difficoltà operative del collodio umido proponendo una sua formula
di collodio secco, grazie al quale la lastra poteva essere usata anche dopo un certo
periodo dalla preparazione, senza che ciò diminuisse la sua iniziale sensibilità.
Questo collodio secco venne pure chiamato collodio albuminato, in quanto utilizzava
anche l’albumina.
La ricerca dei fotografi si indirizzò verso la composizione delle emulsioni sempre più
sensibili e armoniche nella registrazione in bianco-nero del colore, mentre gli ottici si
impegnarono a migliorare la qualità degli obiettivi, sia inventando nuove formule per
i vetri, sia progettando assemblaggi di lenti più sofisticate e funzionali alla ripresa
fotografica. I costruttori fecero a gara per realizzare ottiche adatte ai vari usi
fotografici, per il ritratto e la veduta soprattutto, mentre gli apparecchi erano costruiti
con una migliore meccanica, più leggeri e trasportabili, oppure specificamente per
riprese particolare come l’ingegnoso apparecchio panoramico di Frédérich von
Martens con il quale realizzò la prima panoramica della Senna vista dal Louvre, con
una lastra dagherrotipica ricurva, di cm 12x38, con un obiettivo rotante che copriva
un angolo di 150°.
Gelatina e gomma
Nell’evoluzione della tecnica, il collodio umido e secco trova applicazione per circa
trent’anni fino a quando viene sostituito dal procedimento alla gelatina-bromuro
d’argento. Il primo sforzo serio per fare una emulsione alla gelatina fu tentato da R.
L. Maddox nel 1871 che pubblicò il suo processo nel “The British Journal of
Photography” suggerendo un nuovo metodo per ottenere lastre fotosensibili secche,
in alternativa al collodio; lava in acqua fredda trenta grani di gelatina di Nelson, poi li
scioglie in 3-4 grammi d’acqua addizionata con due gocce d’acqua regia. Aggiunge
poi 8 grani di bromuro di Cadmio, agita e vi introduce 15 grani di nitrato d’argento,
precedentemente sciolto in mezza dracma d’acqua. Si ottiene così un’emulsione
bianca che si stende su lastre di vetro in uno strato sottile che si lascia poi seccare. Lo
sviluppo era fatto con l’acido Pyrogallico.
Negli anni successivi si provvide a migliorare il procedimento anche in funzione
della sensibilità ai colori. Hermann Vogel registrò la sensibilità delle carte
fotografiche alle varie radiazioni dello spettro e ottenne inoltre emulsioni
ortocromatiche, ossia sensibili a molti colori in precedenza non influenti.
Pure il supporto del materiale negativo subì nel frattempo modifiche; dalla carta si
passò al vetro e, in seguito, a materiali più elastici e infrangibili, fino alla celluloide.
Oltre alle carte albuminate e alla gelatina-bromuro, venne utilizzata a partire dal 1873
una carta al platino, inventata da William Willis e perfezionata da Pizzighelli. Ebbe
molto successo assieme ad altre tecniche di stampa utilizzate dai fotografi pittoralisti,
che cercavano nuovi effetti creativi. Queste tecniche hanno avuto origine dalle
ricerche di Poitevin, ingegnere chimico che aveva iniziato a interessarsi di fotografia
realizzando molti procedimenti, spesso però portati a compimento da altri; il brevetto
della stampa au charbon di Poitevin è del 1855 e consiste nella stesura su un foglio di
carta di un sottile strato di gelatina e bicromato di potassio ì, mescolati ad una polvere
colorante. Il foglio viene quindi sottoposto per un certo tempo alla luce del sole,
ponendovi sopra una lastra negativa. Lo sviluppo e il fissaggio, avviene in acqua
tiepida, che scioglie la gelatina e il colore solo nelle zone non colpite dalla luce.
FOTOGRAFIA E SCIENZE
Fotomicrografie
Nel settore scientifico l’uso della fotografia viene subito acquisito e durante le prime
esperienze fotografiche il microscopio e il cannocchiale sono stati strumenti di
osservazione e di analisi tra i più usati e li si è applicati quindi subito alla fotografia,
per rendere la realtà micro e macro. Anche il dagherrotipo venne subito applicato alla
microscopia, e pare che il primo a ottenere immagini in tal modo sia stato John
William Draper, professore di chimica dell’università di New York, ma attribuiscono
questa gloria al francese Donné. Alfred Donné presentò alcune prove eseguite con il
suo microscope-daguerrotype all’Accademia delle scienze di Parigi e fu in grado di
pubblicare un’opera in quattro volumi, che è la più antica pubblicazione sulla
microfotografia; gli ingrandimenti che Donné ottenne al microscopio sono 200 e
anche 400 volte l’oggetto preso in esame. Anche il colore venne utilizzato nelle
ricerche fotomicrografiche e nell’ottobre del 1907 vennero presentate le prime
diapositive in micro-autocromia di tubercoli, germi malarici ecc.
Fotografia astronomica
La fotografia si è occupata, fin dalle origini, del cielo e degli astri che ci circondano,
al punto che uno dei primi soggetti del fotografo è stato la Luna. La prima immagine
fotografica è stata eseguita nel 1839 da Samuel Morse, professore di letteratura e
disegno all’università di New York, subito dopo il suo rientro da Parigi dove aveva
incontrato Daguerre e appreso i rudimenti della dagherrotipia. Il sole è stato a sua
volta un soggetto molto fotografico, soprattutto per la curiosità degli astronomi, che
applicarono la nuova tecnica ai telescopi, trasformandoli così in enormi obiettivi
fotografici. Lo stesso Arago, che era astronomo, tentò di fotografare il sole al
dagherrotipo, con l’aiuto di Gustave Le Gray, ma non c’è traccia di questa immagine.
In occasione di ogni eclisse, quando la tecnica fotografica si fa più semplice e offre
migliori risultati, si organizzano regolarmente spedizioni in vari punti del globo, dove
si suppone sia migliore l’osservazione. Per indagare in modo più preciso sui
fenomeni della volta celeste vennero progettati e costruiti strumenti sempre più
specifici, come il revolver astronomico, realizzato per consentire di cronofotografare
il passaggio del pianeta Venere dinanzi al sole. L’apparecchio venne in seguito
mutato e adattato dal Marey, per il suo fucile fotografico, con il quale studiò
soprattutto le fasi del volo degli uccelli e il movimento rapido di alcuni animali.
La tecnica di ripresa astrofotografica venne ulteriormente migliorata con la
utilizzazione delle emulsioni alla gelatina-bromuro d’argento, al punto che si realizzò
una carta fotografica del cielo stellato, che registrava be venti milioni di stelle (1887).
Applicazioni in medicina
Anche la medicina ha utilizzato subito la fotografia come strumento di analisi e
documentazione visiva delle conseguenze di molte malattie; i grandi calotipisti
inglesi Hill e Adamson pare siano stati i primi a occuparsi di questo settore; si deve a
loro quella che viene considerata la prima fotografia “medica” che raffigura una
donna anziana, vestita alla moda del tempo che mostra un voluminoso gozzo. In Gran
Bretagna viene istituito per la prima volta un laboratorio fotografico in un ospedale,
per intervento di Hugh Welch Diamond, medico sovrintendente del manicomio
femminile della contea del Surrey. Quattro anni dopo un analogo servizio è istituito a
Berlino nello studio dell’ortopedico dr. Berend, che usa la fotografia per documentare
l’evoluzione delle malattie che sta curando. Tra le ricerche fotografiche ottocentesche
ricordiamo quelle del dottor Guillaume-Benjamin Duchenne de Boulogne relative
allo studio della mimica facciale in soggetti catalettici, tramite l’applicazione di
elettrodi sui muscoli che in tal modo vengono fatti reagire secondo precisi
programmi. Pubblicò anche un album di 17 fotografie, un volume in due tomi e in
differenti edizioni. Nei manicomi il rito della fotografia diventò d’obbligo, e
dappertutto si composero allucinanti album di immagini, ma la più affascinante
applicazione fotografica in campo medico è stata realizzata in seguito alla scoperta
dei raggi X da parte di Wilhelm Konrad Rontgen che ha aperto nuove possibilità
d’indagine fotografica anche nello spazio invisibile all’occhio umano e alle comuni
emulsioni fotosensibili. L’indagine fotografica non ha trascurato nulla nel campo
della medicina e dopo lunghe ricerche affidate all’evoluzione della tecnica della
fotografia, si riuscì a fotografare ogni cosa: la retina dell’occhio, l’interno dello
stomaco umano, persino l’embrione umano durante la sua maturazione nel grembo
materno.
Fotogrammetrie e panoramiche
Tra il “molto piccolo” e il “molto grande” c’è però il nostro quotidiano spazio
esistenziale e si affida al codice fotografico il compito di eseguirne la misurazione,
per un controllo e un confronto; una parte di queste ricerche rientrano nel settore
della fotogrammetria. Questi studi sono stati avviati dal colonnello A. Laussedat dal
1850 con la camera lucida e dal 1854 con la fotografia; la prima esperienza ufficiale
con la camera oscura topografica è della primavera del 1861 quando eseguì il rilievo
fotogrammetrico del villaggio di Buc. Ma la prima idea di impiegare le vedute del
terreno per la costruzione di piante e di carte è dovuta al celebre idrografo francese
Beautemps-Beaupré.
I primi studi seri fatti in Italia risalirebbero al 1878 per merito dell’Istituto geografico
militare, diretto dal colonnello Ferrero, ma il luogotenente Michele Manzi aveva
utilizzato la fotografia in alcuni rilievi sul Gran Sasso. Anche la fotografia
“panoramica” venne utilizzata nell’800 per eseguire un più suggestivo rilievo del
territorio. Vi si impegnarono particolarmente Aimé Civiale e Pierre Moessard. Il
primo eseguì giganteschi panorami circolari (vedute dei Pirenei e delle Alpi)
componendo una accanto all’altra persino quattordici fotografie in montaggi che
raggiungono le dimensioni di cm 51x378. Il secondo progettò un ingegnoso
apparecchio chiamato cylindrographe photographique, con cui era in grado di variare
l’angolo di ripresa, sino a 170°, con un tempo di posa minimo di 1/ 200 di secondo;
con sole due immagini gli era possibile ottenere pressoché una panoramica completa.
Nella ricerca della panoramicità si applicò anche Thomas Sutton, costruendo un
curioso apparecchio dotato di un obiettivo fisso; è composto di due emisfere in vetro
riunite mediante una giuntura stagna, e il cui vuoto interno è riempito d’acqua prima
dell’uso; si tratta dunque di una palla d’acqua contenuta in una sfera di vetro i cui
centri coincidono.
Per queste immagini panoramiche la Kodak mise in commercio nel 1899 una camera
a obiettivo mobile, la N°4 Panoram Kodak Camera. Nel 1902 i Lumiere si
dedicarono a questo settore della visione panoramica costruendo un complesso
apparecchio da proiezione, il photorama. Il concetto di panoramicità coinvolse e
comprese quello della veduta “aerea”, ampia, lontana e si utilizzavano i “cervi
volanti”, una specie di aquiloni, grandi anche m 2,50x1,80 con i quali si poteva
esplorare fotograficamente il territorio anche per fini militari.
Stereogrammi e fotografia integrale
La stereoscopia consentì rilievi topografici ancora più precisi e venne subito applicata
in queste ricerche. La ricerca era stata avviata da sir Charles Wheastone con un
semplice apparecchio stereoscopico, ma non ebbe molto successo perché i disegni
non consentivano risultati molto efficaci. Fu la fotografia a rilanciare quindi questo
strumento, da Duboscq che sostituì il vetro alla carta e le coppie di immagini
stereoscopiche poterono così essere osservate, con uno specifico stereoscopio per
trasparenza e non solo per riflessione. Da allora vi si dedicarono in molti, sia per la
costruzione degli apparecchi da ripresa, sia per quelli relativi alla visione delle
immagini; l’ottico e fotografo Carlo Ponti progettò e costruì molti di questi
apparecchi per la lettura delle fotografie come l’ateloscopio, il megateloscopio, il
grafoscopio che ebbero successo nelle Esposizioni internazionali. La presentazione
ufficiale della stereofotografia è avvenuta all’Esposizione di Londra nel 1851 e da
allora furono in molti a cercare di perfezionare la tecnica. La stereoscopia consente
con il suo codice di controllare con maggiore precisione la dimensione oggettiva
degli elementi di cui è composto lo spazio; nei rilievi aerei si impiega oggi la ripresa
stereografica, utilizzando l’aerofotogrammetria e la fotogrammetria, con strumenti di
avanzata tecnologia, sia della dinamica aerea che della fotografia che della
restituzione cartografica.
Queste tecniche di rilievo sono state applicate anche in archeologia e con esse
l’archeologo Dinu Adamesteanu scoprì l’intero assetto urbano dell’antica città di
Spina, in Emilia, utilizzando l’effetto dei raggi infrarossi su speciali emulsioni
sensibili alla loro lunghezza d’onda che gli consentirono di distinguere il segno dei
muri perimetrali dalle case, ricoperti dal terreno e quindi altrimenti invisibili.
Questa tecnica fotografica ai raggi infrarossi venne risolta dalla Kodak nel 1925
quando alcuni ricercatori americani prepararono una pellicola sensibile all’infrarosso,
in un intervento di lunghezza d’onda tra i 7000 e i 9000 A°. La luce ultravioletta è
stata a sua volta utilizzata in molti settori scientifici e vi si ricorre spesso anche
nell’esame delle opere d’arte.
L’indagine fotografica non ha avuto soste: nella ripresa subacquea (servendosi della
luce al magnesio, che venne accesa in un contenitore impermeabile) e nella
registrazione dei fenomeni visivi che si determinano con il movimento dei corpi alle
alte velocità.
Fotografia criminologica
Una applicazione scientifica della fotografia è quella relativa alla segnaletica
poliziesca e alla criminologia. Fino dal 1870, in Inghilterra, si fotografarono i
criminali, mentre in Francia la polizia si servì della fotografia dal 1868 per
documentare i luoghi dove avvenivano delitti, secondo griglie prospettiche
determinate dalla lunghezza focale dell’obiettivo; sovrapponendoli all’immagine
fotografica, questi schemi grafici consentivano la misurazione delle distanze degli
oggetti all’interno del cono visivo. Ricordiamo in questo settore Umberto Ellero che
progettò un’ingegnosa macchina per eseguire una fotografia segnaletica di fronte e
una di fianco simultaneamente. Le “gemelle Ellero” avevano lo scopo di evitare
possibili alterazioni della mimica facciale ed erano un metodo assai più pratico e
preciso del consueto uso dello specchio, tenuto in mano dal presunto criminale
accanto al viso. L’apparecchio consiste in due camere identiche, applicate a due
treppiedi sistemati ai vertici di un triangolo equilatero, istallato in modo che gli assi
focali degli obiettivi siano perpendicolari tra di loro e rivolti verso il terzo vertice,
dov’è seduto il malcapitato. Gli otturatori di entrambi gli apparecchi scattano
assieme, per cui si ottiene una fotografia frontale e una di profilo
contemporaneamente.
FOTOGRAFIA E ARTE
Una rivoluzione nelle arti
L’idea della fotografia è stata suggerita dall’esigenza di sostituire all’immagine
manuale quella meccanica, più semplice, facile e economica oltre che più precisa e
razionale. La fotografia venne però assunta subito “al servizio dell’arte” e nonostante
ogni rivendicazione di autonomia, appare una tecnica artigianale, simile alla stampa e
alla stenografia, non essendole riconosciuto alcun ruolo, se non una modesta capacità
creativa. I fotografi credevano che la specifica qualità della fotografia andava cercata
nel vincolo che essa ha con il soggetto, con la sua scelta, che va operata nello spazio
reale, ritagliandone un frammento, evidenziando il punto di vista. La fotografia deve
molto all’apporto dei pittori che lasciarono il pennello per l’obiettivo. David Octavius
Hill, uno dei più illustri protofotografi, dipingeva, e al nuova tecnica gli fu molto
d’aiuto quando insieme al giovane Robert Adamson usò la calotipia per realizzare un
grande dipinto con i ritratti di 474 sacerdoti della Chiesa scozzese, che sembra essere
stata la prima applicazione pratica della fotografia alla pittura.
Gustave Le Gray, oltre che inventore di una tecnica al collodio, cercò di utilizzare la
fotografia per le sue capacità di fissare gli istanti, come quello del transito di una
nuvola in cielo o dell’impennarsi di un’onda del mare.
Baldus realizzò nel 1855 un reportage dove era già avvertibile il concetto fotografico
della sequenza spazio-temporale, riprendendo un itinerario lungo la ferrovia Paris-
Boulogne per un album commissionatogli dal barone de Rothschild, che pubblicò la
raccolta di 74 vedute in venticinque esemplari. Di Baldus va ricordato inoltre il
famoso album eseguito nel 1875 su “Les Palais du Louvre e des Tuileries” che è una
delle prime documentazioni sistematiche di architettura.
Modelli fotografici
Il modello fotografico offriva indubbi vantaggi ai pittori. Dal punto di vista tecnico,
le fotografie offrivano al pittore immagini già trascritte su una superficie
bidimensionale. Fu la copia da fotografare che ebbe fortuna, dando al fotografo la
convinzione di essere utile, un essere utile che risultava in qualche modo gratificante.
Il nudo fu uno dei soggetti più richiesti dagli artisti; a Parigi eccelse nella fotografia
di nudo Jean-Louis-Marie Eugène Durieu, ex pittore, operante all’Accademia delle
Belle arti di Parigi. Anche in Italia la fotografia è ampiamente utilizzata dai pittori;
tra questi Federico Faruffini che passò dalla pittura alla fotografia, ma le scene
fotografiche che componeva erano troppo ben composte per essere utili ai colleghi
pittori e quindi ebbe in questo settore molte difficoltà ad imporsi.
A Parigi, nel frattempo, Corot utilizzava la nuova tecnica per stampare su carta
fotosensibile disegni che tracciava su lastre collodionate, chiamate clichés verres.
L’idea di questo procedimento nacque quando frequentava l’atelier dell’amico pittore
litografo Constant Dutilleux, dove si recava in vacanza; grattando con una punta
d’acciaio una lastra ricoperta di nerofumo, ma ancor meglio di collodio, Corot
otteneva una matrice dalla quale si potevano ricavare, a contatto, una serie di copie su
carta “salata” fotosensibile che oltretutto è opaca come superficie e dà all’immagine
l’aspetto di un disegno.
Anche Degas scoprì l’istantanea tramite la fotografia, che iniziò ad utilizzare nel
1860, dipingendo cavalli e danzatrici che sono evidenti trascrizioni di rapidi scorci e
annotazioni fotografiche: i gesti sono bloccati a mezz’aria, i personaggi sfuggono,
escono addirittura dalla cornica e la prospettiva segue le rigorose leggi dell’ottica,
mentre la luce ripropone atmosfere quotidiane, meno sublimi del solito.
Pure alcuni scultori tentarono di utilizzare la fotografia per la copia del vero, dopo
che venne brevettato a Parigi da Francois Willème un sistema per riprodurre
volumetricamente, mediante la fotografia, qualsiasi oggetto. Si eseguivano
ventiquattro fotografie attorno al soggetto, a distanza di 15° l’una dall’altra, e quindi
si riportavano i 24 profili con un pantografo, su un blocco d’argilla, rifinendo a mano
i dettagli; il procedimento non ebbe successo. Artisti contemporanei hanno invece
preferito ricorrere al calco di gesso, eseguito sul soggetto, anziché a quello
fotografico, ottenendo una verosimiglianza che semmai ironizza su se stessa e mette
in crisi quella fotografica.
Ritratti e cartes de visite
Il ritratto è stato, assieme all’architettura e al paesaggio, il soggetto cui i fotografi si
sono dedicati maggiormente, con buoni risultati economici. Il processo di
massificazione dell’immagine iniziò proprio con la diffusione del ritratto e la
clientela era naturalmente quella dell’ambiente borghese e intellettuale. I contadini e i
ceti poveri ottennero questo “diritto” soltanto più tardi. I pittori-fotografi provvidero
ad alimentare questo rito negli atelier, sotto luminosi lucernari, in soffitte allestite
come salotti, dove si accumulano mobili, fondali, tappeti, tendaggi per realizzare
effimere ma efficaci scenografie, con lo scopo di dare dignità all’immagine e di
connotare la classe sociale del cliente. Il fotografo si travestì da artista perché il titolo
gratuito di pittore, accanto a quello di fotografo, sembrava quasi indispensabile per il
prestigio professionale; Nadar fu tra i primi a sottrarsi a quest’obbligo. Iniziò tardi
questo mestiere, a trentatré anni, aiutato dal fratello nella speranza che la fotografia
risolvesse i suoi problemi finanziari. Il lucernario del suo primo studio era orientato a
nord come quello di molti pittori e ciò attribuiva ai soggetti un chiaroscuro simile a
quello che si potrebbe ottenere all’aperto; i personaggi fotografati da Nadar
acquistavano così una vivacità naturale. Eseguì soprattutto ritratti nel cosiddetto
“piano americano”, cioè dalle ginocchia in su, con lo sguardo rivolto all’obiettivo; la
luce scende dall’alto, l’espressione è intensa, colta in una posa quasi istantanea, per
cui qualcuno ha scritto che quelli di Nadar sono “ritratti psicologici”. L’unico in
grado di competere fu Antoine Samuel Adam-Salomon che proveniva dalla scultura e
aveva iniziato a fotografare. Si dedicò alla ritrattistica con un preciso schema di
lavoro, le sue fotografie, formato cm 20x25, furono ottenute con ottiche di lunga
focale e lo sfondo usato era semicilindrico e di colore marrone, con tre alti mobili,
due ai lati e uno sopra. In concorrenza commerciale fu invece André Adolphe Disderi
che proveniva dalla gestione di un negozio di berretti. Aprì un atelier a Brest e una
volta a Parigi ottenne molto successo soprattutto per merito di un’invenzione di un
apparecchio a obiettivi multipli, con il quale eseguiva ritratti in serie di sei e otto
immagini 6x9, in una successione di pose cui venne dato il nome di “carte da visita”,
poiché avevano il formato e la funzione di un biglietto da visita. Questo rese la
fotografia definitivamente popolare, specialmente per il ritratto, il cui prezzo era alla
portata anche di gente modesta. Desderi creava addirittura le scenografie, con mobili
e oggetti di prestigio e inoltre “travestiva” le persone, per attribuire un ruolo. Nadar
comunque ebbe la meglio e il suo atelier progredì, mentre Desderi fu vittima della sua
stessa invenzione, che collaborò al processo di massificazione e di semplificazione
tecnica della fotografia e quindi determinò una concorrenza senza pari.
La ritrattistica d’arte si sviluppò dappertutto; a New York c’erano 300 atelier nel
1870; a Londa, John Mayall applicava la tecnica carte da visite anche ai ritratti dei
reali d’Inghilterra, mentre dilettanti si dedicavano ad una fotografia più creativa. In
Italia la ritrattistica ebbe a sua volta autori significativi tra cui Alphonse Bernoud a
Napoli che fu addirittura fotografo di corte, dopo aver attraversato letteralmente la
penisola, lasciando traccia del suo passaggio in splendidi ritratti al dagherrotipo di
dame e gentiluomini.
Architetture e opere d’arte
I fratelli Alinari nel 1852 avviarono un’attività di ampie dimensioni, nella sede di via
Cornina a Firenze, con il progetto di catalogare fotograficamente il patrimonio
artistico, io ogni settore, per soddisfare la crescente richiesta di queste immagini sia
da parte degli studiosi che da parte dei turisti in continuo aumento; la diffusione delle
fotografie della Ditta Fratelli Alinari venne organizzata razionalmente, tramite ricchi
cataloghi, costantemente aggiornati, oltre a una rete di distribuzione in tutto il mondo.
Gli Alinari progettarono e realizzarono anche un pionieristico apparecchio
“basculante” con il quale risolsero tra l’altro il problema di fotografare integralmente
il Campanile di Giotto. Ma in generale il monumento appare decisamente isolato dal
contesto ed è presentato soprattutto nel suo valore oggettuale, come si trattasse di una
scultura gigantesca, in modo del tutto indipendente dall’ambiente urbano circostante.
Scultura e pittura venivano a loro volta riprodotte e catalogate in fotografia,
favorendo rapidamente un florido commercio; nel contempo andava modificandosi
anche la lettura e l’interpretazione dell’opera d’arte, ma essendo la fotografia fedele
al vero non vi fu opera d’arte che non venisse fotografata e riprodotta in centinaia di
copie; Luigi Sacchi a Milano fotografò per primo l’Ultima cena di Leonardo nel 1857
e la riprodusse in un formato di cm 100x165 allora inconsueto. L’avvento del colore,
soprattutto dell’autochrome che i Lumiere mettono in commercio nel 1907,
determinò uno sviluppo eccezionale, soprattutto nella riproduzione con lastre a
mosaico dei quadri di artisti celebri, antichi e moderni. Negli ultimi decenni del
secolo vennero perfezionate anche le tecniche di stampa a inchiostro delle fotografie,
specie mediante la fototipia che consentì all’editore veneziano Ferdinando Ongania di
realizzare la monumentale opera dedicata alla basilica di S. Marco, “Dettagli di altari,
monumenti, sculture, ecc. della Basilica di S. Marco in Venezia” che è tra le prime
pubblicazioni d’arte con fotografie stampate a inchiostro.
La fotografia artistica
Il più spettacolare intervento dei “fotografi artisti” ottocenteschi avvenne attraverso la
negazione, persino l’annullamento del dettaglio con la sfocatura, che alcuni
teorizzano sostenendo che l’immagine “a fuoco” in tutti i piani non corrisponderebbe
al nostro modo di vedere fisiologico, avviando così anche i primi studi sulla
percezione visiva dell’occhio umano. Le fotografie “artistiche” di Julia Margareth
Cameron suscitarono subito molto interesse perché avevano il fascino del flou,
essendo spesso annebbiate, sfocate, a volte mosse; interponeva a volte una lastra di
vetro tra la carta positiva e la lastra al collodio, per sfocare maggiormente, oppure
adoperava obiettivi imprecisi; ma in altri casi il mosso dell’immagine era inevitabile,
specialmente nei ritratti ripresi molto da vicino, nonché a causa della lunga posa,
durante la quale risultava difficile al soggetto rimanere immobile. Questo flou
attribuiva alle immagini un’atmosfera inconsueta nella fotografia del tempo, dove
invece la nitidezza era sinonimo di qualità ed era “diversa” anche dalla pittura; oltre a
ritratti in primissimo piano la Cameron realizzò molte composizioni di figure, anche
travestendo con i costumi i modelli per definire e interpretare allegorie di gusto
vittoriano. La querelle tra i sostenitori della fotografia nitida o sfocata era però nata
tempo prima, già nel confronto tra i calotipi e dagherrotipi, per cui nei calotipi si
produceva un segno largo, morbido, che però a molti egualmente piacque,
specialmente nei paesaggi.
Come la Cameron si dilettava a cogliere in evanescenti ritratti i suoi celebri amici,
Lewis Carroll, matematico e scrittore si esercitava in gradevoli giochi fotografici
riprendendo soprattutto fanciulle in tiepide, delicate immagini, a volte sottilmente
erotiche. Le sue immagini rimasero occultate o comunque dimenticate, sino a quando
Gernsheim non le riscoprì, assieme a un diario. Sono però nitide, considerate
“artistiche” per la posa costruita scenograficamente dei modelli, le espressioni
abbandonate alla malinconia, l’allusione a luoghi fiabeschi, tendente persino alla
fantascienza; erano nitidi i grandi collages di Rejlander e di Robinson il quale si
occupava di scultura e letteratura, ma iniziò a fotografare presto, approfondendo
anche una sua teoria sulla “fotografia artistica”. Nel 1858 realizzò una delle sue
immagini più famose, Fading Away. A Robinson piacevano i preraffaelliti anche
perché le loro opere erano caratterizzate dall’imitazione più minuziosa di quanto si
sia mai conosciuto in pittura; questa imitazione minuziosa egli la otteneva con la
fotografia, mentre la struttura compositiva era delegata al disegno; dopo aver
disegnato con rapidi ed essenziali segni la composizione del quadro fotografico,
Robinson e Reylander realizzavano le varie fotografie delle persone e degli elementi
dello sfondo, anche in tempi e luoghi diversi; queste immagini venivano in seguito
incollate una accanto all’altra, come in un puzzle, e il conseguente tableau vivant era
riprodotto e stampato su un unico foglio di grandi dimensioni. Mentre i professionisti
insistevano nei vecchi schemi figurativi, aggiornando solo la tecnica, i fotoamatori
cercarono di evidenziare l’aspetto artistico della fotografia.
Il pittoricismo e le sue tecniche
Nel dibattito a Vienna nel 1891, in occasione di un convegno organizzato dal Camera
Club locale, si ribadì la distinzione tra fotografia commerciale e quella artistica: si
inserì indirettamente un fotografo dilettante propugnatore di una fotografia
naturalistica, il medico cubano Peter Henry Emerson che tra l’altro, aveva scritto un
saggio molto stimolante, Naturalistic Photography for Students of Art che ebbe larga
popolarità e suscitò molto interesse, soprattutto nell’ambiente fotoamatoriale.
Emerson aveva abbandonato provvisoriamente la carriera di medico per la fotografia
e realizzava soprattutto paesaggi, con una tecnica semplice che gli consentiva di
ottenere immagini di un’insolita freschezza naturalistica, mediante la selezione visiva
dei piani, attenuati con la sfocatura o sottolineati con la nitidezza della messa a fuoco.
La sua proposta di fotografia naturalistica si scontrò con il realismo della fotografia
accademica; questi fotografi rifiutano decisamente il flou proposto da Emerson.
Si cercò in tutti i modi di rendere la tecnica fotografica più complessa e personale,
anche mediante l’applicazione di nuovi procedimenti di stampa, che avevano la
prerogativa di far rassomigliare ancor di più la fotografia a un disegno o a
un’incisione. Si cercò quindi di convincere il fotografo a intervenire manualmente
sull’immagine, in modo da eliminare il più possibile la sua freddezza meccanica;
pareva necessario distruggere questa nitidezza, non solo attraverso il flou (si
fabbricarono anche appositi obiettivi anacromatici, che “sfocavano” leggermente
l’immagine), ma per mezzo di nuove tecniche di stampa, come la gomma bicromata o
il charbon-velours che consentono di ottenere immagini vellutate, dall’aspetto di un
carboncino o di una sanguigna.
A Londra alcuni fotografi pittoralisti si organizzavano nel Linked Ring Brotherhood,
un circolo esclusivo, fondato da Alfred Maskell e da “cinque artisti inglesi” solidali
tra loro. Il motto del Linked Ring, organizzato come una setta segreta e dove gli
associati usavano uno pseudonimo e si riunivano incappucciati, era “Liberty,
Loyalty”. Fu il Linked Ring a dare vita a un Photographic Salon internazionale, che
fu per vari anni il più prestigioso salon mondiale della fotografia. Alfred Maskell
pubblicò nel 1896 un saggio che ebbe molto successo, perché rese pubblico il
procedimento della gomma bicromata; era stato proprio Maskell a esporre al Salon di
Londra le prime immagini ottenute con questa tecnica, che si basava sulla proprietà
del bicromato di potassio, aggiunto a sostanze organiche quali la gelatina o la gomma
arabica, di rimanere insolubile nell’acqua se viene illuminato per un determinato
tempo dai raggi del sole; al miscuglio viene aggiunto un pigmento che consente, dopo
l’esposizione di un foglio di carta reso fotosensibile o collocata sotto un negativo nel
torchietto fotografico, di ottenere un’immagine che ha un chiaroscuro proporzionale a
quello del negativo utilizzato.
Dopo questa prima esposizione, vennero apportati perfezionamenti e modifiche, ma i
più diffusi furono i procedimenti al charbon-velours e quello all’olio, o la ozobromia
che è una modifica del classico procedimento al carbone.
Sublimi risultati mediante il procedimento alla gomma bicromata vennero comunque
ottenuti da Robert Demachy e da Emile Joachim Puyo, i quali lavorarono spesso
assieme e scrissero anche un libro, Les procedes d’art en photographie.
Leondard Misonne fotografava greggi di pecore nella foschia di tramonti piovosi.
Richard Polak o Guido Rey proponevano antiche scene fiamminghe o romane
ricostruite con modelli travestiti in posa.
La detestabile ma accattivante esperienza del pictoralism è stata comunque la
maggiore provocazione, quasi una rivoluzione, nel mondo della fotografia alla fine
dell’Ottocento e fu un’occasione di dibattito e di esplorazione del suo linguaggio.
FOTOGRAFIA E INFORMAZIONE
Viaggiatori in Oriente
Per convenzione, la prima fotografia di cronaca, venne eseguita ad Amburgo nel
maggio del 1842 da Herman Biow e da Carl Stelzner dopo un grande incendio che
distrusse un quartiere della città.
Il concetto di fotografia come documento sollecitò subito il suo uso nella
riproduzione degli eventi di cronaca; la fotografia non inganna, corrisponde senza
alcun dubbio al vero, è un ottimo testimone e le fotografie di cronaca risultavano
lucide schede all’avvenimento, anche se questo era già compiuto e ne rimaneva
soltanto le tracce, come nel caso dell’incendio di Amburgo, del quale i due fotografi
raffigurano soltanto le conseguenze, cioè quattro ruderi bruciacchiati. Queste
fotografie avevano il pregio di essere mute e di trasmettere all’osservatore la realtà
così com’è; la sua capacità documentaria e comunicativa non poté subito essere
utilizzata soprattutto per la difficoltà di moltiplicare i suoi esemplari. Subito dopo
l’invenzione ci si preoccupò quindi di realizzare una tecnica che consentisse di
riprodurre le fotografie, soprattutto i dagherrotipi. Il problema della diffusione delle
immagini non era però soltanto tecnico, ma anche politico e socioeconomico, e
giungerà a maturazione soltanto quando il sistema di informazione giornalistica sarà
potenziato e rivolto ai nuovi strati sociali coinvolti nella vita pubblica.
I viaggiatori portarono nel loro bagaglio anche l’attrezzatura per dagherrotipo o
calotipie, al posto delle vecchie camere oscure o lucide; stava nascendo il fotografo di
viaggi, pronto a immortalare avventure e guerre. Lo scrittore Maxime Du Camp fece
subito parte della schiera di questi itineranti e partì per un viaggio esotico assieme a
Gustave Flaubert con l’incarico di riprodurre, durante il viaggio in Egitto e Nubia,
geroglifici e bassorilievi egiziani; al Cairo incontrò il barone Alexis da Lagrange che
gli indicò il metodo analogo di Blanquart-Evrard (del papier ciré) con il quale ottenne
risultati ancora migliori, su negativi di carta di formato cm 22x16 o cm 30x44.
L’inglese Francis Frith viaggiò a sua volta in Egitto, Palestina, Siria con una camera
di cm 40x50 e realizzò le immagini poi raccolte in ben sette volumi. Tra i più
conosciuti fotografi-viaggiatori nei paesi del Mediterraneo va ricordato Felix Bonfils
il quale pubblicò cinque album, dedicati all’architettura, al paesaggio e al costume,
avviando il commercio di immagini sul folklore e i “tipi locali” (diffuse le sue
fotografie soprattutto attraverso raccolte di stampe fotografiche originali che i turisti e
gli studiosi acquistavano come preziosi souvenirs o opere di studio.
Alpinisti e esploratori
Anche il reportage fotografico all’aperto richiedeva tempi lunghi di posa ed era
necessario progettare in anticipo la ripresa, studiando il punto di vista più favorevole
per ottenere un’immagine unica. A questo genere si dedicò con successo l’italiano
Vittorio Sella nel corso di molti viaggi sulle Alpi, e di studi antropologici sul
Ruwenzori, il circolo polare artico. Eseguì inoltre ampie vedute panoramiche, che
fecero conoscere paesaggi allora quasi irraggiungibili. Il francese Desiré Charnay si
spinse fino all’America centrale dove fotografò per la prima volta le rovine dei Maya;
William Notman preferì a volte ricostruire in studi improvvisati nei villaggi, con
fondali e scenografie, le condizioni di vita dei pionieri canadesi, ma riprese anche en
plein air. Questi fotografi hanno dato inizio alla grande esplorazione fotografica del
territorio americano.
Non soltanto il paesaggio naturale e l’architettura vennero compresi nel carnet del
fotografo viaggiatore, ma anche la vita animata delle città cominciò ad essere
esplorata, non appena le emulsioni si fecero più sensibili e il procedimento al collodio
e poi quello alla gelatina si semplificarono.
La luce artificiale
Fu inevitabile che molti fotografi ricorressero anche alla luce artificiale, per rendersi
indipendenti da quella solare. La prime esperienze furono quelle dei fratelli Johann e
Joseph Natterer a Vienna, che eseguirono nel 1841 pose notturne di dieci secondi
soltanto; Talbot utilizzò la scintilla elettrica per fotografare nel 1851 una rotativa del
“Times” in movimento; ma Nadar fu in grado, nel 1860, di illuminare ampi spazi
delle catacombe parigine con pile Bunsen e di ottenere nitide immagini con pose dai
diciotto ai venti minuti.
La luce artificiale venne resa di uso più semplice innanzitutto utilizzando meglio il
magnesio e, nel 1925, costruendo speciali lampadine Vacublitz, che contenevano
polvere di magnesio e si accendevano con una scintilla elettrica. Il lampo al magnesio
fu ampiamente usato specie nella fotografia di cronaca e in quella poliziesca.
Jacob-August Riis esplorò un mondo sconosciuto, immerso nell’ombra, nel buio dei
precari e delle periferie dove trovavano rifugio una moltitudine di persone giunte
dall’Europa; sono immagini “sociologiche” schiette, dal quale le persone a volte
rimanevano attonite, nuove anche sotto il profilo estetico grazie all’aggressività del
disegno determinato dal flash, con grande contrasto bianco-nero.
Il sociologo si fa fotografo
Lewis Wickes Hine, autodidatta come fotografo, utilizzò la fotografia per illustrare i
suoi articoli sulla vita degli immigrati europei e scoprì che questo messo espressivo
gli consentiva di essere assai efficace nel raccontare una vicenda umana triste e quasi
improbabile; la fotografia divenne quindi la sua arma preferita e la utilizzò quando
iniziò a lavorare per la rivista “Charity and the Commons” come strumento ideale per
i reportage che stava realizzando sui minatori di Pittsburgh e soprattutto sullo
sfruttamento del lavoro minorile.
Per iniziativa di Hine nacque nel 1928 la “Photo-League”, un organismo di fotografi
e cineasti tesi alla ricerca sociologica.
Anche il fotografo clochard Eugene Atget ha contribuito a un’analisi sociologica
dell’ambiente parigino con il suo grande censimento fotografico di Parigi avviato nel
1898 e teso soprattutto a documentare le ultime sopravvivenze architettoniche e
ambientali.
Nasce il fotogiornalismo
L’istantaneità ha occupato un posto determinante nello sviluppo della tecnica e del
linguaggio fotografico; essa sembrava un traguardo irraggiungibile, ma Arago ne
aveva subito colto l’importanza: due o tre minuti basteranno di certo, sottolineava e
ridurre questi tempi di posa divenne un impegno professionale per ogni fotografo. È
opportuno indicare l’evoluzione subita dagli apparecchi fotografici:
Nel 1862 Leon Vidal aveva progettato un apparecchio a mano, senza treppiede, ma il
suo autopoligraphe non ebbe però pratica applicazione a causa della lentezza del
collodio che sconsigliava l’abbandono del cavalletto; nel 1855 ebbe più successo con
l’en-cas, dotato di telaio doppio per le lastre, che non dovevano essere più cambiate
con il sacco nero. In quegli anni sembrano utilizzabili per l’istantanea apparecchi
come: il velocigrafo Laverne o l’alpiniste Enjalbert, che utilizzava un caricatore di 12
lastre, pesava due chili e si poteva portare a tracolla come un cannocchiale; il
detective Nadar e quello di Steinbeil, a cassetta, simili alla Kodak N°1 (montava
all’inizio una pellicola a nastro con supporto di carta, con la quale si ottenevano in
negativo 100 fotografie rotonde). Ma il “piccolo formato” era nel destino della
fotografia, e pochi anni dopo, Franois Molliè costruiva la cent vues con otturatore a
diaframma Compur per riprese sino a 1/300 di secondo; nel 1923 la Leitz di Wetzar
era finalmente in grado di produrre trentuno esemplari di un apparecchio minuscolo,
chiamato Leica, che montava pellicola cinematografica 35 mm (fu commercializzata
solo nella primavera del 1925). L’obiettivo delle prime Leica consentiva tempi di
esposizione da 1/25 a 1/500 di secondo e l’apparecchio ebbe un eccezionale fortuna,
al punto di divenire quasi il simbolo del moderno fotogiornalismo. La Leica ebbe
presto una concorrente nella Contax che utilizzava egualmente pellicola
cinematografica, producendo negativi di 24x36 mm, adatti all’ingrandimento, che
creavano comunque problemi di qualità nella stampa finale.
Nel 1929 si inserì nel mercato la Rolleiflex, una biottica 6x6cm cui fece seguito un
modello più economico, la Rolleicord, subito apprezzata e adottata dai fotoamatori.
Nell’evoluzione della macchina fotografica, vanno ricordate l’Exacta, che è stata la
prima reflex monoculare di piccolo formato, la Primarflex e la Asahiflex con visore a
pentaprisma e un esposimetro interno, siglato TTL (Through The Lens) che legge la
qualità di luce riflessa dal soggetto attraverso l’obiettivo, intercambiabile.
Gli otturatori sono stati via via adeguati ai nuovi apparecchi, come pure le emulsioni
fotosensibili, che oltre ad aumentare progressivamente la sensibilità consentirono
ingrandimenti giganteschi, senza che l’immagine perdesse nitidezza.
Riproduzione e veicolazione della fotografia
Quasi parallelamente ai progressi fatti dalla tecnica fotografica si perfezionarono i
procedimenti di riproduzione della fotografia mediante la stampa a inchiostro, per
giornali e libri illustrati. Quest’idea di riportare l’immagine su carta sollecitò subito le
ricerche di vari scienziati; Alfred Donné era riuscito a incidere una lastra
dagherrotipica con acido nitrico diluito in acqua e a stampare l’impronta già nel 1839;
a questo primo tentativo fece seguito quello di Hippolyte Fizeau con risultati che
permisero di utilizzare due dagherrotipi direttamente come clichés da stampa. Questo
procedimento si svolgeva in tre fasi: mordenzatura del dagherrotipo, granitura della
superficie e stampa a inchiostro con il torchio. Il mordente, acido nitrico e acido
cloridrico, veniva versato caldo sul degherrotipo e incideva i neri dell’immagine,
ossia le zone non protette dal mercurio; lastra con olio di lino cotto, che penetra nelle
parti incise, dove rimane anche dopo una leggera pulitura superficiale. L’olio
depositato nell’incisione veniva sciolto con soda caustica; si procedeva a un’altra
morsura dell’argento messo a nudo e si rinforzava la lastra con un bagno
galvanoplastico. La lastra veniva resinata, ossia spolverata con della resina in
polvere, per creare la granulosità sulla superficie. La lastra veniva finalmente
stampata come un’acquaforte. I risultati furono però deludenti. Dopo le prove di
Donné e Fizeau, un processo di stampa fotolitografica, con matrici al bitume, venne
proposto da Zurcher a Parigi e nel 1848 Poitevin segnalò all’accademia delle scienze
un suo metodo di fotoincisione; fu in grado di presentare due procedimenti di stampa,
uno agli inchiostri grassi, che chiamò photolitographie, l’altro alla gelatina bicromata,
l’helioplastie. Nel 1853 anche Talbot aveva inventato un processo alla gelatina e
bicromato di potassio e risolse inoltre un altro problema, sostanziale per la stampa
delle mezze tinte; era indispensabile suddividere l’immagine in innumerevoli puntini,
e vi riuscì, oltre che resinando la lastra, interponendo durante l’esposizione, tra il
negativo e la matrice, una leggera stoffa di seta che svolgeva la funzione degli attuali
retini tipografici. Anche Niépce da Saint-Victor adoperò le lastre d’acciaio, ma come
sostanza sensibile riesaminò il bitume di Giudea; dopo aver seccato al calore l’asfalto
disteso sulla piastra, vi poneva sopra un negativo di vetro albuminato, esponeva al
sole per un periodo, che andava da un quarto d’ora a un’ora, sviluppava in un bagno
di petrolio ed effettuava la morsura della lastra con acido nitrico.
Nel 1864 Walter Bentley Woodbury realizzò matrici in rilievo sfruttando i bicromati,
con una tecnica che venne chiamata woodburytipia o photogliptia ed era un processo
fotomeccanico nel quale si produce su gelatina bicromata un’immagine in rilievo:
viene coperta una lamina di piombo, si comprime il tutto con un torchio idraulico
finché il piombo abbia preso in incavo la forma dell’immagine in rilievo. Poi si
empiono gli incavi della forma di piombo con gelatina pigmentata fluida, e si usa la
lamina così preparata per tirare delle stampe; il chiaroscuro di esse risulta dalle
leggere differenze di spessore.
Contemporaneamente agli studi sulla riproduzione e sulla moltiplicazione delle
fotografie mediante la stampa con gli inchiostri, vennero analizzate le possibilità di
diffusione delle immagini, anche tramite la loro trasmissione a distanza. La prima
immagine di cronaca a essere stata inviata telegraficamente con il sistema Belin, fu
l’arrivo a Lione del presidente della Repubblica francese Poincaré nel 1914; la
fotografia venne ricevuta da “Le Journal” di Parigi, ma si trattò di un esperimento
sporadico perché la belinografia fu adottata soltanto nel 1924.
L’illustrazione fotografica
All’inizio degli anni Venti del Novecento, i giornali furono in grado di pubblicare
fotografie quotidianamente e la fotografia sostituiva l’illustrazione disegnata.
In Germania, Alfred Marx e Simon Gutman organizzarono un’agenzia, la Dephot,
specializzata nel commissionare a un gruppo di fotografi i reportage d’attualità da
fornire ai giornali, nei quali queste immagini assumevano sempre maggiore
importanza come mezzo di informazione autonomo e autosufficiente.
Eric Salomon affidava soltanto alla fotografia il compito di spiegare, oltre che di
informare sugli eventi della società. Tra il 1928 e il 1933 egli fornì ai giornali
tedeschi dei reportage fotografici “a luce ambiente”, eseguiti con una tecnica che
escludeva la posa in favore dell’istantaneità e che rendeva le immagini ancor più
realistiche e i personaggi più credibili e vicini al lettore; riuscì ad ottenere immagini
istantanee in qualunque condizione di luce. Egli riuscì a convincere che il valore
dell’immagine non dipende dalla nitidezza ma dal soggetto e dall’emozione che
riesce a suscitare.
In Italia gli esordi del fotogiornalismo furono più difficili e tra i pionieri italiani si
qualificò Luca Comerio che ebbe la ventura di riprendere coraggiosamente alcune
fasi della tragica repressione del generale Bava Beccaris, durante i suoi moti a
Milano; Luigi Barzini, con una Panoram Kodak e una piccola folding 6x9, realizzò,
nei primi del Novecento inconsueti racconti di viaggio fotografici, durante la
permanenza in Oriente e le sue foto trovarono spesso spazio su “La Lettura” e in
volumi di racconti di viaggio.
La fotografia è stata utilizzata in Italia, durante il fascismo, dall’Istituto L.U.C.E.
(L’Unione del Cinema Educativa, voluta da Mussolini) quale mezzo di persuasione e
di celebrazione, oltre che di controllo dell’immagine dei miti del regime. Non sono
comunque mancate alcune coraggiose iniziative indipendenti, come quella di Leo
Longanesi che fondò “Omnibus” (settimanale di attualità politica e letteraria”), il
primo rotocalco italiano, soppresso dopo due anni perché al ministro della Cultura
non era piaciuto un articolo di Alberto Savinio se Leopardi.
Fotogiornalisti e paparazzi
La grande macchina dei mass media si avviò proprio con il giornale d’immagine,
dove la fotografia svolge il suo ruolo più congeniale, d’informazione.
Un gruppo di fotografi legati tra di loro, oltre che da amicizia, si accordarono per
proporre, in piena autonomia, dal loro “punto di vista” la storia del mondo. Una storia
costruita di immagini obiettive degli avvenimenti, filtrate dall’occhio sensibile del
fotografo, che non intende più essere succube dell’editore, ma esprimere la propria
ideologia senza alcun compromesso commerciale o politico. Fondarono un’agenzia
strutturata in cooperativa, dove soci sono gli stessi fotografi e la chiamarono Magnum
Photos, un marchio d’occasione nato, si dice, dalla bottiglia magnum di birra che
avevano sul tavolino del bistrot parigino mentre siglavano questo progetto. I fotografi
della Magnum, nel distribuire i più importanti rotocalchi del momento, i loro
reportage, hanno in breve tempo caratterizzato con il loro stile il fotogiornalismo
mondiale, del quale sono stati tra i massimi esponenti.
Un fotogiornalismo più sciatto e meno intellettuale, ma provocatorio per la sua
“volgarità” è stato invece quello realizzato da alcuni fotografi soprattutto italiani, a
Roma in particolare, dove si pubblicavano alcune tra le prime riviste scandalistiche
del dopoguerra; vennero chiamati “paparazzi”, dal nome del personaggio di un
fotografo nel film di Fellini “La dolce vita” e la parola paparazzo assunse ben presto
un significato dispregiativo. Fotografi improvvisati, anche detestabili, hanno proposto
un’efficace alternativa dell’edonismo dei rotocalchi di lusso, in cui la realtà appariva
perlopiù levigata e sterilizzata, come se si trattasse di una scenografia. La foto dei
paparazzi aprì uno spiraglio nuovo nella giovane fotografia italiana, penetrando nel
mondo della borghesia, quindi restituendo l’immagine di un’altra Italia.
Fotografi in guerra
In una storia del fotogiornalismo, un’ampia parte va riservata alla fotografia di
guerra, per ribadire come il fotografo sia spontaneamente, attratto da ogni
avvenimento drammatico, dinamico e irripetibile. Anche la guerra, come altre
catastrofi, è stata inizialmente rappresentata postuma.
È stata la guerra a sollecitare l’interesse dell’editore Danesi, che commissionò uno
specifico lavoro al fotografo lombardo Stefano Lecchi. Si tratta di alcune vedute della
campagna romana dopo l’assedio della città nel luglio del 1849, che evidenziano le
conseguenze della battaglia e dei bombardamenti. Sono dei ruderi di splendide ville
romane come apparivano dopo la battaglia. Lecchi non ebbe il riconoscimento che gli
spettava a livello mondiale di primo cronista-fotografo di guerra, un primato che
invece diede fama all’inglese Roger Fenton, autore del celebre reportage sulla guerra
di Crimea del 1855; le fotografie formano un organico corpus di alcune centinaia di
pezzi (360, ma parecchie sono disperse tra i collezionisti) e rappresentano campi di
battaglia deserti, ripresi dopo l’evento e senza cadaveri, accampamenti con soldati in
posa, ufficiali che bevono il tè, ma non vengono mai ritratti dei corpi sui campi di
battaglia, che sarebbero stati oltretutto dei soggetto “fotogenici” e adatti alle lunghe
pose del collodio. Il suo reportage venne continuato da un altro fotografo, James
Robertson e dai suoi cognati, i giovani Antonio e Felice Beato. Insieme formarono un
gruppo che operò lungamente assieme, in un itinerario che dopo la Crimea li portò in
Egitto, Palestina e India, dove aprirono un atelier a Calcutta. In questo ultimo
viaggio, furono al seguito di una spedizione inglese che Felice Beato fotografò dopo
gli scontri, riprendendo però anche i cadaveri, in scene di grande drammaticità e
queste foto dovevano essere testimonianza della severità della repressione inglese e
un monito per ogni ulteriore tentativo di ribellione.
Tra gli italiani impegnati anche in queste imprese “militari”, va ricordato il sacerdote
Antonio D’Alessandri, che oltre ad essere fotografo pontificio e noto ritrattista, aprì
uno studio assieme al fratello a Roma ed eseguì una serie di fotografie sul campo di
Mentana, dopo la battaglia del 1867; tutte fotografie di guerra così come quelle che
compongono la cosiddetta “serie Migliorato” con i cadaveri dei briganti meridionali.
A fotografarli furono anonimi autori che a volte hanno ricostruito finte scenette, dove
il macabro si mescola con il cosmico, con i morti che dovrebbero sembrare vivi.
Durante la Prima Guerra Mondiale, venne addirittura istituito uno speciale Servizio
Fotografico dell’Esercito Italiano, con il compito di documentare le varie situazioni.
Accanto a questa schiera di soldati-fotografi d’occasione, che usavano per lo più
piccole macchine, operavano al fronte fotografi-specializzati, coloro che venivano
inviati dai grandi giornali per alimentare i miti bellici e l’orgoglio per gli eroi.
Robert Capa iniziò questo “mestiere” in Spagna nel 1936 assieme alla sua compagna
Gerda Taro, che morì proprio in quei giorni travolta da un carro armato. La foto di
Capa finirono sulle pagine dei grandi rotocalchi e sostituirono gli esotici paesaggi
colorati del tempo di pace. La crudeltà della fotografia di guerra si è rivelata
soprattutto in un’immagine di Edward T. Adams che, senza tremare, in 1/250 di
secondo ha fissato il tempo che è servito al generale Loan per uccidere a sangue
freddo, con la pistola puntata alla tempia del condannato, un povero ragazzo con le
mani legate e un’ampia camicia bianca.
LA MASSIFICAZIONE DELLA FOTOGRAFIA
La Daguerréotypomanie
Il 1880 sembrò essere l’anno fatale che segnò una rivoluzione in fotografia, ma si
trattò di una rivoluzione preparata a lungo e che sia stata favorita quando Daguerre si
preoccupò di diffondere la conoscenza del suo procedimento; chiunque fu in grado di
appropriarsene e con essa si suppose di possedere anche una nuova concezione della
realtà, poiché questa era così fedelmente rappresentata da ingigantire all’occorrenza
con una lente. La fotografia propone anche il problema di una quantificazione di
immagini, praticamente all’infinito. Se Talbot fu il primo a “moltiplicare” le
immagini mediante il negativo su carta, Desderi coinvolse, con la carte de visite,
strati sociali meno ricchi, offrendo le sue sequenze a basso prezzo, per un pubblico
medio borghese; una dozzina di queste piccole immagini costava soltanto venti
franchi, mentre Nadar ne pretendeva almeno cento per un ritratto in copia unica.
Ambrotipi, ferrotipi, stereogrammi
Per merito del collodio e dell’albumina si erano inventate altre tecniche fotografiche
“povere” come quelle degli ambrotipi, amfitipi e ferrotipi ecc. eseguiti perlopiù da
modesti fotografi girovaghi. Di piazza in piazza, questi ambulanti viaggiavano con il
loro atelier trasportabile, una camera oscura contenuta in un piccolo carretto-
limousine.
L’amfitipo consiste in una lastra di vetro albuminato, che, dopo l’esposizione, lo
sviluppo, il fissaggio, se applicata su un fondo nero, può apparire di conseguenza, per
contrasto con lo sfondo più scuro, positiva, specialmente se osservata in una certa
inclinazione. Simile è il procedimento dell’ambrotipia, dove viene sensibilizzata la
lastrina di vetro, che diviene, dopo l’esposizione e il solito trattamento sviluppo-
fissaggio, un comune negativo; ma se questo è applicato sul velluto nero, si ottiene un
effetto di inversione del chiaroscuro e si legge l’immagine in positivo.
I ferrotipi furono ancora più popolari, soprattutto perché molto economici; eseguiti
direttamente su una lastrina di lamiera verniciata di nero e sensibilizzata al collodio,
il loro aspetto risulta positivo, in quanto sfrutta il contrasto tra l’emulsione di colore
giallastro del collodio e il nero della vernice, che fa da sfondo; l’immagine nei
ferrotipi risulta invertita, come in uno specchio. In Italia il prezzo di un ferrotipo si
aggirava tra i 40 e i 50 centesimi, ed anche la povera gente si metteva volentieri in
posa, con il vestito della festa, che garantiva a tutti una fotografia da lasciare in
eredità.
La stereoscopia, dopo l’invenzione del collodio, alimentò molto il mercato
fotografico, specialmente quello pornografico, favorendo naturalmente il voyerismo;
i cataloghi degli atelier fotografici proposero migliaia di immagini di varie
dimensioni, ma la carte de visite e la stereoscopia furono preferite dai turisti
soprattutto per il prezzo.
“Voi premete il bottone noi facciamo il resto”
La “rivoluzione” della gelatina incentivò la produzione e la vendita di fotografie e
quindi anche l’attività industriale del settore. L’americano George Eastman, che
aveva fondato la Kodak, dimostrò di possedere un grande intuito commerciale
creando la moderna industria fotografica. Inizialmente impiegato in banca a
Rochester, iniziò a fabbricare e a commerciare lastre secche alla gelatina-bromuro,
dopo le ore d’ufficio, in un piccolo magazzino. Questo lavoro veniva fatto con una
macchina da lui stesso inventata con la quale veniva steso sul vetro lo strato di
emulsione. Le lastre Eastman furono in seguito vendute dalla Ditta Anthony, ma
Eastman studiò la possibilità di usare la carta come supporto per la ripresa negativa, e
nel 1886 fu in grado di produrre un apparecchio fotografico nel quale era montato un
rocchetto di pellicola fotosensibile di gelatina, appoggiata alla carta, con cui si
riprendevano quarantotto fotografie di cm 10x12,5. Inventò anche il fortunato slogan
“You press the bottom, we do the rest” anche se all’inizio si trattava di “tirare una
funicella” che faceva scattare l’otturatore. Nel 1888 lanciò la N°1 Kodak Camera, a
cassetta, del peso di 759 gr e delle dimensioni di cm 17x9x8, con un telaio a rullo per
cento pose, in immagini circolari di mm 65 di diametro; aveva un obiettivo a fuoco
fisso. Nel 1890 produsse la N°4 Folding Kodak Camera, una macchina a soffietto di
notevoli prestazioni; tra gli apparecchi più interessanti, realizzati negli anni seguenti
vi sono la N°4 Panoram Kodak Camera, la N°2 Stereo Kodak Camera, i modelli
Instamatic e un modello poi concorrenziale alla Polaroid, che lo contestò legalmente
obbligando l’industria a ritirare il prodotto già distribuito nel mondo.
Il fotoamatorismo
Gli inconvenienti del “piccolo formato” delle pellicole Kodak vennero risolti da
apparecchi ingranditori, a luce solare che venivano applicati su un muro esterno, in
modo che la luce, concentrata e riflessa da uno specchio, consentisse la proiezione in
camera oscura; si ricorreva però anche alla luce artificiale.
L’industria fotografica favorì in ogni modo il fotoamatore, proponendogli macchine e
obiettivi sempre più perfezionati e di livello professionale; una gara per diffondere al
massimo questo procedimento, attorno al quale si stavano sviluppando molte
industrie.
Klary, editore del giornale parigino “Le Photogramme” e autore di molti manuali di
divulgazione per dilettanti, insegnò anche a eseguire fotografie di nudo dal punto di
vista artistico. Anche la pornografia, a volte mascherata da fotografia artistica stava
approfittando della massificazione delle immagini; a sua volta, la cartolina illustrata,
da “vera fotografia” venne commercializzata dappertutto, ma fu perfezionata solo nel
1900. Essa ha affermato un’immagine della realtà che sembra quella vera perché
tende ad essere “sublime”, mediante la decontestualizzazione, un colore tassativo e la
lucentezza d’un cristallo, che la rende dolcemente kitsch.
La fotografia alla portata di tutti sembrò inizialmente un fatto negativo, ma la
massificazione era inevitabile e, ribellarsi a ciò, significava opporsi in modo
reazionario alla diffusione di un nuovo linguaggio.
Circoli e società fotografiche
I fotografi più impegnati e consapevoli dell’importanza culturale della fotografia si
organizzarono in associazioni e circoli, spesso corporativi come il Linked Ring
Brotherhood di Londra, con lo scopo di dibattere i problemi tecnici e artistici della
fotografia e di predisporre un ampio confronto tramite esposizioni e convegni.
La più antica associazione di fotografi fu la Societé héliographique, fondata nel 1851
a Parigi con lo scopo di affrettare i perfezionamenti della fotografia, ma non ebbe
lunga vita e chiuse nel 1853, non prima di aver fondato una sua rivista “La Lumière”.
Sulle spoglie della Societé héliographique nacque la Societé francaise de
Photographie che organizzò alcune grandi esposizioni.
In Inghilterra nel 1853 alcuni giovani fotografi avevano fondato la Photographic
Society of London, ma il cui nome venne ben presto cambiato in quello di
Photographic Society of Great Britain.
Negli Stati Uniti venne fondata The American Amateur Photographer e dalla fusione
di questo organismo con il New York Camera Club nacque nel 1896 il circolo The
Camera Club che pubblicò anche una rivista “Camera Notes”; concentrò nel suo
organismo soprattutto il pubblico dei dilettanti.
Oltre alle grandi associazioni nazionali, tuttora in Italia, sono centinai i circoli
amatoriali e si dice che i fotoamatori “evoluti” siano oltre diecimila nel nostro paese.
Nei primi anni del Novecento, oltre agli innumerevoli circoli fotoamatoriali, si sono
invece distinti organismi come il Group f.64, fondato da Edward Weston nel 1932
assieme ad alcuni compagni di fede nella fotografia “diretta”, affidata quindi a
immagini nitide sino all’incredibile, immuni da manipolazioni pittoristiche.
Alla diffusione della cultura fotografica hanno contribuito le Esposizioni e i Salons,
che hanno conferito alla fotografia l’aura dell’opera d’arte.
Esposizioni e Salons
La prima esposizione pubblica di fotografie fu quella di Hippolyte Bayard a Parigi
nel 1839. Si trattò però di un fatto privato, un’esibizione personale nell’ambito di una
mostra per beneficenza. Nel 1849 la fotografia venne ufficialmente presentata
all’Esposizione di Parigi e nel 1851 all’Esposizione universale di Londra dove gli
espositori americani guadagnarono cinque medaglie, per la perfezione tecnica e la
bellezza dei loro dagherrotipi.
In Italia la prima esposizione di rilievo nazionale venne organizzata a Firenze nel
1861, ma in ogni città la fotografia era da molto tempo mostrata e premiata nelle
varie esposizioni “agrarie, industriali artistiche”; dopo la fondazione della Società
fotografica italiana si organizzarono con regolarità esposizioni di fotografia,
soprattutto a Firenze e Torino. Alcune tra le innumerevoli manifestazioni fotografiche
risultano particolarmente importanti, ad esempio, alla mostra allestita dal Camera
Club di Vienna nel 1891, quando si accese il dibattito tra “nettisti” e “flouisti”, ad
alcuni fotografi inglesi nacque l’idea di costruire un Club autorevole per lo studio
rigoroso della fotografia, il Linked Ring Brotherhood di Londra.
Sono molte inoltre le gallerie private che si dedicarono esclusivamente alla
fotografia. La prima gallerie europea dedicata esclusivamente alla fotografia è stata il
Diaframma, fondata a Milano da Lanfranco Colombo nel 1967. I grandi musei
americani hanno istituito specifici dipartimenti per la fotografia, producendo rassegne
e custodendo collezioni fondamentali per la conoscenza della storia di quest’arte.
Riviste specializzate
Nel 1890 si pubblicavano in tutto il mondo 76 riviste specializzate, ma il primo
giornale fotografico, nel frattempo scomparso, è stato l’inglese “The Daguerrian
Journal” che nel 1853 cambiò nome in “Journal of the Daguerrotype and
photographic art”. Tra le più importanti riviste di fotografia ricordiamo:
La Lumière, che nacque come periodico della Société héliographique
Das photographische journal, in Germania a Berlino
Camera Work, negli Stati Uniti, della quale uscirono cinquanta numeri in
quattordici anni
Fotologia, edita dagli Alinari di Firenze e Fotostorica, dedicata a ricerche
filologiche del settore
La scuola, che in altri paesi si occupa di fotografia in ogni livello di studi, in Italia è
rimasta a lungo quasi assente, emarginando questa disciplina tra le attività artigianali
e tecniche. Un attivo e avanzato organismo di ricerca sulla fotografia è il centro studi
e archivio della comunicazione presso l’Istituto di Storia dell’arte dell’università di
Parma. Oltre a proporsi come museo della fotografia, questa istituzione è un luogo di
vivace dibattito e di informazione, che promuove questa arte attraverso mostre e
pubblicazioni di estremo rigore scientifico. La prima vera scuola di fotografia venne
istituita a Dresda nel 1853, in uno stabilimento fotografico che così preparava i suoi
stessi tecnici.
Intellettuali e aristocratici
Tra gli scrittori, uno tra i più celebri fotografi dilettanti dell’Ottocento è stato Victor
Hugo che, soprattutto durante l’esilio nell’isola di Jersey, si dedicò a riprendere
semplici vedute e istantanee familiari; anche i suoi figli realizzarono molte fotografie
di paesaggio, che raccolsero in un prezioso album.
Emile Zola fu a sua volta fotoamatore e ha lasciato un archivio di circa seimila lastre
6x9 e 13x18 che tendono a cogliere in veloci appunti l’ambiente cittadino di Parigi,
Roma e Londra.
Ma il più grande dilettante dell’Ottocento fotografico è stato il conte Giuseppe
Primoli, “Gegé”. Portava sempre con sé l’apparecchio fotografico, con cui ha
tracciato un vivace racconto sulla nobiltà romana, oltre che sull’ambiente
popolaresco. L’unico cliente di Giuseppe Primoli è stato lui stesso. La Roma
umbertina ma anche Parigi o Venezia, vennero documentate nelle frizzanti immagini
di Primoli, realizzate secondo schemi prospettici, con primi piani improvvisi e
insoliti, da punti di vista spesso troppo bassi e ravvicinati, al punto da creare quelle
orribili deformazioni che la manualistica del tempo imponeva di evitare. Tra gli
apparecchi usati preferibilmente da Primoli, il kinegraphe, una Reflex 8x9 oppure il
Traveller 13x18; presso la fondazione Primoli a Roma sono conservate 12.575 lastre,
nei più vari formati che egli solitamente stampava a contatto.
Principi e re si sono a loro volta dedicati alla fotografia, mentre si sviluppava la
massificazione di questa tecnica. Il principe di Napoli, il futuro Vittorio Emanuele III,
fu a sua volta un dilettante di fotografia; al contrario la regina Alessandra
D’Inghilterra si dedicò alla fotografia con molto impegno, al punto da essere in grado
di pubblicare un libro fotografico dal titolo “Queen Alexandra’s Christmas Gift
Book”, strutturato come un brioso album di famiglia, con tutti i componenti della
corte, oltre a principi e re, e il reportage di una rilassante crociera nel Mediterraneo.
ISTANTANEA, MOVIMENTO, COLORE, SIMULTANEITA’
Verso l’istantanea
Due difetti vennero subito riscontrati nella fotografia: l’assenza del colore e
l’incapacità di fissare nelle immagini una situazione dinamica. Iniziava una gara per
risolvere questi due inconvenienti tecnici, a per assegnare alla fotografia ulteriori
capacità di rilievo fisionomico della realtà. La olografia, che è la tecnica più avanzata
di riproduzione ottica tridimensionale, sembrava aver portato a soluzione questo
anelito. Inventata da Denis Gabor dell’Imperial College di Londra, è stata
perfezionata dopo la scoperta del laser.
Il concetto di istantaneità si è sviluppato nel tempo, subito dopo che Niépce riuscì a
fare la sua prima “istantanea” con una posa di otto, forse dieci o più ore, puntando la
camera verso il cortile della casa di Gras.
Talbot aveva un tale desiderio di fissare un’azione rapida che mise in posa i suoi
modelli come se stessero mimando un gesto veloce ottenendo immagini più
disinvolte e apparentemente più reali.
L’istantaneità venne concepita come una tecnica che attribuiva più credibilità
all’immagine e il collodio umido consentì di raggiungere tempi compatibili con le
nuove esigenze di istantaneità, anche nella ripresa en plein air: dai trenta secondi di
posa delle prime prove, si arrivò al venticinquesimo di secondo.
La visualizzazione del movimento
Nel 1853, Franz von Uchatius propose un suo apparecchio da proiezione che,
partendo dalla struttura della lanterna magica, consentiva di vedere le immagini in
movimento: lo spettacolo consisteva nella proiezione in sequenza di dodici
diapositive, corrispondenti ad altrettante fasi di un movimento, mediante un eguale
numero di obiettivi.
Anche i fotografi si erano inseriti con successo in questa ricerca sulle immagini in
movimento, essendo ormai possibile affidarsi a quell’istantaneità tanto desiderata e
indispensabile per queste prove. Si può far riferimento alle esperienze dell’astronomo
Pierre-Jules-Cesar Janssen che con un fucile fotografico (o revolver astronomico)
riprese da un osservatorio in Giappone il passaggio del pianeta Venere dinanzi al
Sole, scattando un’immagine ogni settanta secondi su un disco rotante fotosensibile.
L’astronomo ottenne in questo modo diciassette silhouettes di Venere, in
un’operazione che può essere considerata la prima ripresa cronofotografica.
A quel tempo anche il fotografo Eadweard James Muybridge, di origine inglese,
faceva ricerche in questo settore ottenendo nel 1877 le prime sequenze di un cavallo
al trotto, utilizzando un suo metodo, l’automatic electro-photograph. L’impianto
consisteva in una batteria di dodici macchine fotografiche, i cui otturatori erano
collegati mediante dei cavetti metallici, che attraversavano la pista e venivano
strappati dal cavallo durante il trotto. Tra un apparecchio e l’altro c’era un intervallo
di 58 centimetri9 e la ripresa avveniva su lastre al collodio umido, con una velocità
molto alta, pare di 1/1000 di secondo, essendo sufficiente fissare soltanto la silhouette
nera del cavallo. Le sequenze di Muybridge furono fondamentali per gli studi sulla
rappresentazione visiva della realtà dinamica, risolti pochi anni dopo da Edison e
soprattutto dai fratelli Lumiere con il cinematographe.
Fu Jules-Etienne Marey a occuparsi con impegno di questi studi, dopo essere venuto
a conoscenza delle prove di Muybridge. Progettò un fucile fotografico che ricorda il
revolver astronomico: uno strumento in cui la canna del fucile, molto grossa, serve da
mirino e contiene l’obiettivo, mentre al posto della batteria, una camera oscura
cilindrica a meccanismo automatico contiene una lastra sensibile rotonda oppure
ottagonale, che gira su sé stessa, e un otturatore rotante comandato da un movimento
ad orologeria. Le prime immagini eseguite con questo fucile furono scattate nel
tempo di 1/720 di secondo. Per un certo periodo Marey risedette anche in Italia, a
Napoli, dove realizzò alcune sequenze cronofotografiche sugli uccelli, usando per la
prima volta lastre flessibili e adeguandosi così all’uso di materiali elastici. Nel 1883,
con un contributo governativo, costruì a Parigi una “stazione fisiologica” per
compiere studi; consisteva anche di due hangar, costruiti perpendicolarmente tra di
loro, in modo che le aperture facessero da sfondo buio all’animale o alla persona che
vi si trovava di fronte all’aperto, facendo risaltare la silhouette chiara contro il nero.
Tra i due hangar c’erano una pista circolare e varie altre apparecchiature, di volta in
volta predisposte per gli esperimenti.
Ottomar Anschutz eseguì riprese analoghe a quelle di Muybridge e riuscì a proiettare
una serie di 24 fotografie con un tachiscopio elettrico, facendo coincidere, al
passaggio di ogni diapositiva, il brillio di una scintilla elettrica. Proiettando le
immagini in sequenza, otteneva così l’illusione del movimento, proponendo una
riproduzione ancor più fedele del mondo reale. Di questo apparecchio ne costruì 78
esemplari.
Il pittore americano Thomas Eakins, in contatto con Muybridge realizzò le prime
strobofotografie, analizzando il movimento, anziché in sequenza, con un’unica lastra
che registra uno dopo l’altro gli spostamenti successivi di un oggetto dinamico. La
tecnica consisteva nel far ruotare dinanzi all’obiettivo in posa un disco con quattro
fori, che formavano una specie di croce di Malta e lasciavano che la luce pervenisse
alla pellicola soltanto quando erano in coincidenza con la lente, “cieca” nelle altre
quattro fasi. A seconda della velocità di rotazione del disco si otteneva un’immagine
stroboscopica, con un numero maggiore o minore di istantanee dell’oggetto
fotografico durante il suo spostamento. La ripresa era eseguita in condizioni di luce
particolari, contro uno sfondo nero, affinché il soggetto illuminato potesse scagliarsi
chiaramente. Questa tecnica venne in seguito perfezionata usando l’illuminazione
elettronica.
La celluloide e il cinematografo
Durante le ricerche sulla fotografia in movimento si considerò l’opportunità di
utilizzare materiali diversi dal vetro; tra i primi a risolvere questo problema furono
W. Friese e M. Evans, che nel 1890 registrarono una scena in movimento, mediante
una sequenza di istantanee impresse su pellicola fotosensibile con il supporto di
celluloide.
Sin dal 1887 si erano fatti esperimenti con la celluloide, reinventata e perfezionata da
Hannibal Goodwin. La pellicola di celluloide consentì l’invenzione del cinema;
l’elasticità e la resistenza del materiale permisero a Edison di eseguire con il
kinetographe una serie di istantanee, con una celerità di 46 pose al secondo, sopra un
rotolo continuo di pellicola sensibile, dalla larghezza di tre centimetri. A Parigi, i
fratelli Lumiere, misero a punto un procedimento che trovò subito applicazione
pratica e al quale diedero il nome di cinematographe. I primi film dei Lumiere, che si
proiettavano con la velocità di 15 fotogrammi al secondo, hanno una lunghezza da 15
a 18 metri, per complessive 900 immagini di mm 25x20, impresse su pellicola della
larghezza di 35 mm.
La riproduzione del colore
Tra gli inventori della fotografia, anche Talbot aveva compiuto ricerche per registrare
i colori. In Italia il primo a occuparsi del colore in fotografia fu Francesco
Zantedeschi che riferiva, negli “Annali delle scienze Lombardo-Veneto” di aver
ottenuto immagini fotocromatiche dove erano distintissimi il rosso, il verde, il
violetto. Nel frattempo, ai fotografi, non rimaneva che colorare a mano le fotografie,
imitando anche in questo i miniaturisti.
Richard Beard brevettò un procedimento per la “coloritura del dagherrotipo” e
Chevalier adottò un’ingegnosa tecnica che dava risultati simili alla miniatura, con in
più l’eccezionale fisionomicità della fotografia; spiega in una lettera il suo
procedimento e consiste nel dipingere una lastrina di vetro e nel farla poi aderire a un
dagherrotipo corrispondente alla coloritura.
Il collodio favorì queste tecniche imitative della miniatura, e la carta albuminata, oltre
ad essere colorata a mano con aniline e acquarelli, venne spesso anche “vetrificata”
cospargendo Sali fusibili sopra l’immagine e ricorrendo poi alla “cottura” come se si
trattasse di ceramica.
Lo scienziato inglese James Clerk Maxwell riuscì ad ottenere nel 1861 un’immagine
a colori naturali, senza però ricorrere a pigmenti o a formule chimiche, masoltanto
applicando le teorie della natura dei colori. La più antica fotografia a colori esistente
riproduce una coccarda colorata, la cui immagine è però visibile solo tramite la
proiezione di tre diapositive in bianco-nero, con appropriati filtri colorati, gli stessi
utilizzati per le tre riprese bianco-nero; tre fotografie di un nastro colorato,
rispettivamente ripreso attraverso tre soluzioni colorate (rosso, verde, blu) sono
introdotte nell’apparecchio. Esse forniscono immagini rappresentanti separatamente
gli elementi rossi, verdi e blu. A sovrapposizione compiuta, si vede un’immagine
colorata.
Soltanto nel 1873 venne perfezionata la sensibilità ai colori nelle emulsioni in bianco-
nero per merito di Hermann Vogel, che aggiunse sperimentalmente dei coloranti
nell’emulsione, i cosiddetti copulanti cromogeni, rendendo le lastre ortocromartiche.
In questo susseguirsi di inventori, i fotografi insistono nella coloritura a mano. Per la
fotografia a colori “diretta”, ossia ottenuta con un unico scatto, si dovette attendere.
Non fu di alcuna utilità pratica nemmeno il geniale procedimento inventato dal fisico
francese Gabriel Lippmann: la cromofotografia interferenziale. Le fotografie a colori
interferenziali resistono a qualunque luce e si possono proiettare anche sopra un
diaframma, per mezzo di una intensa luce ad arco. Le lastre vanno guardate da una
posizione perpendicolare, mentre di sbieco le varie tinte appaiono molto alterate. Per
migliorare la leggibilità di queste immagini, i fratelli Lumiere proposero di incollare
sullo strato di gelatina della lastra Lippmann una lamina di vetro leggermente
prismatica. Il tempo di posa necessario per ottenere un’immagine a colori
interferenziale era di pochi minuti, ma era comunque impossibile fare dei ritratti. Nel
frattempo venne analizzata la possibilità di utilizzare anziché tre, un solo filtro,
frammentandolo con finissimi reticoli incrociati, ottenuti con i tre colori
fondamentali.
La pratica della fotografia a colori
Con un unico filtro, l’irlandese Charles Jasper Joly realizzò un procedimento
abbastanza pratico, il processo Joly, ad un solo negativo; egli si servì di un filtro di
vetro, dove erano tracciate linee sottilissime, invisibile a occhio nudo, nei tre colori
fondamentali, facendolo aderire a una lastra fotosensibile pancromatica e collocando
poi il sandwich nella camera fotografica, in modo che il filtro tricromo fosse rivolto
verso l’obiettivo. Durante la posa i colori del soggetto vengono quindi filtrati dal
reticolo e colpiscono la lastra fotografica retrostante; dal negativo si ricava un
diapositivo, naturalmente in bianco-nero, che ha un chiaroscuro condizionato dal
filtro. Ora facendo aderire nuovamente il filtro tricromo al diapositivo bianco-nero, in
modo che il reticolo abbia lo stesso orientamento che aveva durante la ripresa, se
questo viene osservato in trasparenza, si coglie una discreta immagine nei colori
naturali del soggetto.
I fratelli Lumiere risolsero le difficoltà di fabbricazione e di utilizzazione dello
schermo “trilineato” sostituendolo con un miscuglio di finissimi granelli di fecola di
patate, colorata in rosso, arancio, verde e viola. Le lastre autochrome Lumiere
vennero presentate, per la prima volta, al Congresso fotografico di Nancy nel 1904 e
messe in vendita nel 1907. Con le autochrome si ottenevano diapositive a colori
naturali, adatte alla selezione tricroma, in caso di riproduzione a stampa per
l’illustrazione di giornali e libri; in questi ultimi le tavole venivano spesso applicate
su fogli e pagine fuori testo.
Il procedimento dei Lumiere ebbe fortuna sino agli anni successivi al primo conflitto
mondiale, quando la Kodak riuscì a fabbricare un materiale fotosensibile ai colori,
che dava migliori risultati anche sotto il profilo della fedeltà della riproduzione. Nel
1929 venne messa in commercio la pellicola Kodak, utilizzabile anche nel cinema;
nell’emulsione era impressa una fittissima rete di elementi sferici, “cellule
lenticolari”, che erano simili a minuscole lenti, le quali ricevevano, al momento dello
scatto, la luce filtrata da un filtro selettore, colorato in tre bande parallele rosse, verdi
e blu; ogni cellula lenticolare proiettava, quindi, sulla superficie sensibile soltanto il
colore che l’aveva raggiunta. Pochi anni dopo questa industria americana mise in
commercio un nuovo materiale, il Kodachrome, che finalmente consentiva la stampa
a colori su carta; i coloranti erano incorporati alle emulsioni fotosensibili e lo
sviluppo veniva effettuato direttamente dalla Kodak.
Nell’ultimo dopoguerra i progressi tecnici furono rapidi e collegati alle nuove
esigenze del fotogiornalismo, dove il colore sostituì quasi del tutto il bianco-nero. Un
mondo improbabile sembra essere quello delle immagini di Franco Fontana, dove il
colore è essenziale a tal punto da far dimenticare che esista la fotografia bianco-nero,
con la quale non si tentano neppure confronti, perché il colore non è un’aggiunta al
chiaroscuro, ma diventa un diverso modo di vedere.
La diffusione della fotografia
Tra i mezzi di comunicazione visiva più congeniali all’immagine fotografica, venne
subito preso in considerazione il suo trasferimento a distanza, accontentandosi
all’inizio della semplice proiezione dell’immagine da un lato all’altro di una stanza,
nella tradizione di lanterne magiche e fantasmagorie. Una prima “leggendaria”
proiezione di fotografie sarebbe avvenuta a Venezia nel 1840, per opera di Francesco
Malacarne, ma è Jules Duboscq, con l’applicazione dell’illuminazione elettrica alla
lanterna magica a incrementare notevolmente le possibilità di proiezione delle
fotografie. Essendo allora realizzate su lastre di vetro, esse avevano una trasparenza
tale da favorirne l’utilizzazione con l’antico strumento; si cominciava così a farle
osservare non solo da singole persone, ma da gruppi, stimolando al dialogo e alla
critica collettiva. Ma è dal 1870 che le proiezioni fotografiche illustrano con
maggiore frequenza le conferenze, avviando un commercio di diapositive e libretti,
con didascalie relative, che trovarono addirittura applicazione anche nella scuola.
Agli inizi del secolo di stampava a Parigi addirittura un giornale su questo
argomento, “Le Conferencier”. È opportuno ricordare il metodo adottato nel 1870 da
Dagron, su sollecitazione di Nadar, quando, con l’aiuto di centinaia di colombi
viaggiatori, inviò messaggi miniaturizzati fotograficamente. Le minuscole pellicole
flessibili di collodio, del formato di cm 3x5, portate dai piccioni venivano quindi
proiettate e ingrandite con una lanterna magica, per leggerne il testo.
Nel frattempo si stavano sperimentando e perfezionando tecniche di trasmissione a
distanza anche delle immagini, sulla scorta delle entusiasmanti ricerche di Morse
(telegrafo), Meucci e Bell (telefono) e Marconi (radio) che riguardavano suoni e
parole, cercando di applicarne i principi o di utilizzarne i canali. Il fisico italiano
Giovanni Caselli, inventore del pantelegrafo, avrebbe trasmesso addirittura
un’immagine a distanza, tramite il telegrafo, tra Londra e Liverpool.
Ma è Arthur Korn di Monaco a risolvere concretamente, nel 1904 il problema della
“telefotografia”: dopo alcuni anni di prove, egli telegrafa in successione gli elementi
di un’immagine considerati come segnali luminosi di intensità variabile. Per la
trasmissione a distanza di un ritratto, durante le prime prove, gli servirono 14 ore, in
quanto l’immagine veniva divisa in ben 10.000 elementi; per ridurre questo tempo di
trasmissione, pensò di usare il selenio, per la sua proprietà di avere una resistenza
elettrica variabile con l’intensità della luce incidente. L’immagine, sistemata in un
cilindro, viene “letta” da una cellula al selenio, che trasmette impulsi proporzionali ai
punti luminosi successivi. Il ricevente applica, su un analogo cilindro, un foglio di
carta fotosensibile che viene quindi, a mano a mano, impressionata punto per punto.
La prima significativa trasmissione di una fotografia con questa tecnica avvenne nel
1907, utilizzando la linea telefonica Monaco-Norimberga; ci vollero 40 minuti perché
l’immagine si ricomponesse, ad oltre 150 chilometri di distanza.
Ricerche analoghe faceva, contemporaneamente, il francese Edouard Belin cercando
di trasmettere fotografie mediante il telefono. Spiegò il suo procedimento,
classificandolo in tre metodi: 1) metodo di trasparenza; 2) metodo di riflessione; 3)
metodo di utilizzazione dei rilievi. Le prime due prime categorie fanno appello alla
fotoelettricità e la terza a principi più propriamente meccanici. Il documento da
trasmettere deve essere considerato come formato da un certo numero di punti; questi
punti, che si possono assimilare alle pietre di un edificio, sono trasmessi
successivamente, il valore di ognuno d’essi dovendo, alla partenza, essere tradotto in
una corrispondente intensità. Il filo e le onde hertziane servono dunque da veicolo a
questi fenomeni successivi, che pervengono l’uno dopo l’altro all’arrivo, dove
l’edificio sarà costruito pietra su pietra. Nel 1931 Belin trasmise un’immagine tra
Sainte-Assise e Buenos Aires, usando le onde corte come veicolo e una cellula al
selenio per ottenere gli impulsi coerenti con il chiaroscuro della fotografia. Da allore
le fotografie hanno percorso in ogni direzione e coperto ogni distanza, consentendo
un’informazione visiva simultanea.
LINGUAGGIO E AVANGUARDIE
Dal “naturalismo” di Emerson, al “pluralismo” di Stieglitz
Sono gli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento quando si fece più acuta la diatriba
non solo tra fotografi e pittori, ma anche tra fotografi e fotografi. Henry Peach
Robinson, esponente dei Preraffaelliti fotografi, sottolineava che i loro sforzi hanno
fatto tanto per salvare l’arte fotografica dalla rovina prodotta dalla semplificazione
dei procedimenti tecnici, per cui non si riscontrerebbero più grandi differenze di
qualità tra il lavoro di un fotografo e quello di qualsiasi altro artigiano. Se chiunque
può ora eseguire senza troppa fatica una nitida fotografia, si dissero questi
aristocratici studiosi, sembrava opportuno dimostrare l’esistenza anche di un’altra
fotografia, quella artistica che necessitava di maggiore impegno tecnico e che
complicavano con manipolazioni e interventi insoliti e sofisticati, mentre i fotografi
di mestiere e la nuova schiera di fotoamatori rinunciavano ben volentieri a queste
nuove difficoltà, soddisfatti dalle semplificazioni di cui godeva la fotografia.
Emerson cercò di dimostrare come il flou consentisse di riproporre nella fotografia il
modo di vedere dell’occhio umano, evidenziando o annebbiando una parte del
quadro, indirizzando la lettura e quindi offrendo un’interpretazione della realtà.
Alfred Stieglitz, dopo il rientro a New York entrò nella New York Society of
Amateur Photographers, iniziando un’attività editorial per la rivista del club che lo
porterà alla direzione della stessa nel 1893. L’anno seguente fu invitato a far parte
dell’esclusivo Linked Ring di Londra che dimostrava così di essere un club aperto ai
nuovi talenti e alle nuove teorie. Egli suggerisce un uso diretto della tecnica, per
ottenere immagini spontanee, affidate a regole tecniche ed estetiche proprie e
implicite nel mezzo; è a queste regole che corrispondono le sue vivaci immagini di
strada, eseguite i Europa prima del 1890 e poi le straordinarie fotografie di New York
sotto la pioggia e la neve; non rifiuta radicalmente il pittoralismo e tende a utilizzare
gli elementi validi di queste tecniche ai fini di una più ricca potenzialità espressiva.
Nel 1897 fondò e diresse la rivista “Camera Notes” che divenne l’organo ufficiale del
Camera Club di New York e nel gennaio del 1903 pubblicò il primo di cinquanta
numeri della rivista “Camera Works” cassata nel 1917, quando presentò un portfolio
di Paul Strand che influenzò moltissimo la giovane fotografia americana.
Lo specifico fotografico
Paul Strand si distinse dal fotogiornalismo d’azione di quegli anni per il rifiuto
dell’istantaneità e la scelta della “lunga posa” e delle camere lente di grande formato.
Le fotografie astratte che Strand esegue utilizzando dettagli di roccia, elementi
vegetali, ombre sono caratterizzate da una eccezionale nitidezza dei particolari, che è
alla base dell’ideologia del “tutto a fuoco” in contrasto con il morbido flou
pittoralista, ma vogliono essere fini a sè stesse senza voler mostrare alcunché, ecco
perché vengono definite “astratte”.
L’indagine sulla realtà, effettuata da questi fotografi, induce alla scoperta e alla
lettura di forme inedite oltre che insolite: dissociate dal contesto acquistano quasi un
significato diverso, in quanto viene loro assegnato un concetto innanzitutto con il
semplice atto della scelta e quindi per la loro coerente trasposizione nel codice
dell’immagine bidimensionale, che diventa l’unico tramite con la realtà della quale la
fotografia vuole essere soltanto il simbolo.
Strand ha considerato con molta attenzione la struttura compositiva delle sue
immagini, quasi sempre frontali o basate su un rigoroso disegno ortogonale, per un
cosciente rifiuto anche della prospettiva, come dell’istantanea.
Nella fotografia degli anni Venti e Trenta si configurano quindi due grandi filoni:
quello della fotografia “dinamica” e quello della fotografia “statica”; la prima si
affida a una lettura del reale nelle sue fuggevoli trasformazioni temporali, la seconda
all’evidenza della struttura geometrica compositiva, grafica e del dettaglio nei
particolari. Rappresentate della fotografia “statica” degli anni Venti, Edward Weston,
dopo un’esperienza pittoralista scoprì le immense possibilità estetiche della stright
photography, influenzato da una esposizione di opere dei fotografi del circolo di
Stieglitz, e da un incontro con Strand e Charles Sheeler, il quale si occupava anche di
fotografia e di cinema, oltre che di pittura.
Nel 1923 partì per il Messico con l’amica Tina Modotti, un’aspirante attrice italiana;
frequentarono lì soprattutto i pittori muralisti locali, assai impegnati anche
politicamente, ma Weston fotografò il territorio messicano con distacco, quasi con
indifferenza per ogni problematica sociale, in immagini la cui forza espressiva è
determinata dall’estraniamento delle forme di elementi naturali. Il Messico fu in
quegli anni luogo di scorribande per fotografi e cineasti, una specie di “terra
promessa” dell’immagine. Vi si recò anche Strand; una prima volta nel 1926 dove
riprese ritratti in primo piano di peones, ma anche architetture locali e nodose radici
di alberi e una seconda volta dove fotografò paesaggi con nuvole, mattoni, città
morte. Tina Modotti si soffermò sugli aspetti sociali del Messico, pur utilizzando
spesso l’aristocratico segno fotografico suggeritole da Weston che, nel 1932 diede
vita al Group f.64, esprimendone già nella sigla il programma: ossia una fotografia
“nitida” al limite delle possibilità di lettura dell’obiettivo, diaframmato quindi nel
valore estremo, f:64, nelle ottiche degli apparecchi di grande formato usati da questi
fotografi. Per ottenere la massima nitidezza fotografica dei particolari, adoperò
preferibilmente lastre pancromatiche di bassa sensibilità (16 ASA) e di grande
formato 8x10 pollici.
In Europa il pittoralismo concludeva lentamente il suo percorso, mentre il
giornalismo fotografico diffondeva una vivace, inedita immagine del mondo, per una
informazione visiva più spontanea e fedele alla nuova ideologia della realtà, nel clima
di ripresa economica o culturale negli anni successivi alla Grande Guerra.
“Il mondo è bello” è il titolo di un fotolibro di Albert Renger-Patzsch in cui le
immagini sono una sfida alla “documentarietà” della tecnica fotografica; alberi,
animali, paesaggi, architetture sono esplorati con lo scopo di individuare forme e
strutture grafiche e inconsuete. L’esplorazione del linguaggio fotografico gli consentì
anche d’individuare nuovi schemi espressivi, con cui esprimere esattamente i
significati degli elementi della realtà, ossia i suoi simboli: le figure retoriche sono
così chiaramente individuabili nelle sue immagini.
Il fermento provocato dai movimenti d’avanguardia fin dai primi anni del Novecento,
aveva coinvolto necessariamente la fotografia, nonostante le solite differenze. Le
fotografie di August Sander ad esempio, hanno catalogato i personaggi della
Germania dell’inizio del secolo in una tipizzazione così aspra da indurre i nazisti a
distruggere le lastre e le copie del volume di Sander perché questi tipi germanici non
coincidevano con l’idea della razza ariana, com’era intesa da Hitler. Le immagini di
Sander, proprio per l’apparente semplicità della ripresa, dimostrano come la
fotografia possegga un suo flessibile linguaggio, con il quale l’operatore riesce a
esprimere idee e concetti, e non soltanto informazioni.
Fotografia e avanguardie storiche
La fotografia venne coinvolta anche in uno tra i primi movimenti d’avanguardia
europei, il futurismo italiano, presentato a Parigi il 20 febbraio 1909 da Marinetti
come l’esaltazione della “velocità”, della “macchina”, di tutto ciò che è simbolo del
progresso; in questo contesto si applicarono soprattutto i fratelli Anton Giulio e
Arturo Bragaglia con una serie di sperimentazioni fotografiche, relative al
“fotodinamismo”, inserendosi nella ricerca futurista come corrispettivo fotografico di
un’immagine che andava maturando. Bragaglia si preoccupò di precisare che
innanzitutto lui e suo fratello non erano dei fotografi, ma anzi erano ben lontani dalla
professione di fotografi. Nel saggio in cui Anton Giulio teorizza le ricerche fatte
assieme al fratello sono adattati alla fotografia molti concetti del futurismo
marinettiano e in particolare di Boccioni sulla pittura; Bragaglia insiste sul fatto che
la sintesi richiesta per la rappresentazione del movimento non dovrà essere che sintesi
di movimento.
Anton Giulio Bragaglia, contraddetto e ostacolato da alcuni amici futuristi, tra cui
Boccioni, dopo il 1913 abbandonò questa tecnica per dedicarsi agli studi teatrali e al
cinema, come autore di alcuni film d’avanguardia.
Solo tra il 1928 e il 1930, questa esperienza d’avanguardia della fotografia venne
nuovamente considerata nell’ambito del movimento futurista, quando Marinetti e
Tato scrissero un “manifesto” in cui suggeriscono sedici “regole” per ottenere
fotografie, in questa occasione specificamente “futuriste”, esplorando alcune facoltà
espressive del linguaggio.
Durante il regime fascista, il fotomontaggio fu una tecnica abituale, cui si ricorreva
per accentuare e enfatizzare la “mistica fascista, facendo largo uso dell’immagine
fotografica; singolare il fotomontaggio “la tavola degli orrori” di Pier Maria Bardi,
esposto a Roma nella grande mostra del 1932.
Ricordiamo anche i fotomontaggi politici dell’artista dadaista John Heartfield che con
forbici, colla e aerografo creò una tragica immagine della realtà sociale tedesca
all’avvento del nazismo. Le sue immagini sono caricaturali e grottesche, e mirano a
sottolineare, emblematicamente, quanto spietati fossero gli assunti dell’ideologia
nazista e dei suoi protagonisti principali. L’antimilitarismo fu uno dei temi ricorrenti
nel fotomontaggio di Heartfield che non era un fotografo e che usava immagini di
repertorio, collegate tra di loro a mosaico, costruendo una figura retorica, d’impatto
popolare.
Fotogrammi e rayographs
La “città industriale” impressionò fortemente l’artista e grafico Laszlo Moholy-Nagy
quando giunse a Berlino dall’Ungheria, dopo un breve soggiorno a Vienna; influenzò
anche il suo lavoro di fotografo, di grafico e di docente alla Staatliche Bauhaus. Fu
nominato nel 1923 direttore del corso preliminare della Bauhaus dove inizialmente
insegnò tecniche dei metalli e non la fotografia, e rimase fino al 1928, quando fuggì
dal nazismo trasferendosi a Londra e poi a Chicago, dove fondò la New Bauhaus.
Durante quegli anni sperimentò tutte le possibilità espressive della fotografia e del
cinema; la tecnica di fotomontaggio, che egli chiamò “fotoplastik”, venne utilizzata
con intenzioni comunicative meno popolari, spesso espresso tramite una grafica di
segno costruttivista, soprattutto geometrie in diagonale.
La fotografia alla Bauhaus però venne insegnata istituzionalmente solo a partire dal
1935 da Walter Peterhans.
Moholy-Nagy ha sperimentato la ripresa foto-cinematografica di oggetti, progettati
per questo scopo, in metallo, vetro, plastica, che egli movimenta e chiama
“modulatori di luce”, ma che sono vere e proprie “sculture mobili”, che gli hanno
consentito una programmata riproduzione di immagini, nel variare della loro
illuminazione e della velocità di spostamento e di rotazione degli oggetti durante le
varie fasi della ripresa; queste esperienze sono state riprese negli anni Sessanta dagli
artisti optical.
La sperimentazione caratterizzò anche l’opera di Man Ray specialmente dopo il
1920, quando giunse a Parigi da New York, dove aveva stretto amicizia con Marcel
Duchamp. A New York aveva eseguito alcuni clichè-verres (una tecnica di disegno a
graffio, su lastra fotosensibile) oltre a ritratti tradizionali di amici artisti, dei quali
riproduceva anche le opere; poi nel 1920 fotografa, come un paesaggio fantastico, il
Grande vetro di Duchamp, in un’immagine dal titolo “allevamento di polvere”,
considerata la sua prima fotografia creativa.
Man Ray inventò, per suo conto, il fotogramma a contatto che chiamò rayograph,
chiarendo che questa sua tecnica non aveva nulla a che fare con le prove sperimentali
di Moholy-Nagy o Schad, dalle quali si differenziava per la “tridimensionalità”
dell’immagine, ottenuta dalle ombre più o meno intense degli oggetti variamente
trasparenti, appoggiati sulla carta fotosensibile per creare misteriose prospettive e
insolite profondità.
Nuove esperienze visive
Dopo il 1925 si avvia un’esaustiva e magistrale sperimentazione del fotografo
ungherese André Kertész che può essere considerato tra i più significativi maestri
della moderna fotografia.
In Italia emerge tra gli sperimentatori Luigi Veronesi, presente tra Milano e Parigi.
Max Ernst realizzò vari collages con la fotografia, e questa tecnica fu allora una
tentazione alla quale era difficile sottrarsi perché consentiva di utilizzare
l’immediatezza comunicativa della fotografia, che, innestata nel dipinto, interagisce
creando un vortice di significati.
Negli anni tra le guerre, molti fotografi si liberarono definitivamente da ogni
pregiudizio e con ogni mezzo tesero a stravolgere l’immagine convenzionale della
realtà.
Da Film und Foto a Subjektive Fotografie
Nel 1929 si tenne a Stoccarda l’esposizione “Film und Foto”, organizzata dal
Deutcher Werkbund su progetto di Gustav Stotz, che era però influenzato da alcuni
articoli di Moholy_Nagy sulla “nuova visione”. Vennero presentate le più avanzate
ricerche sperimentali sulla fotografia, a livello mondiale, in una mostra che consentì
un confronto e un dibattito proficui per il rinnovamento della fotografia; si
evidenziarono alcuni aspetti, come i nuovi messi di “creazione”, forniti da obiettivi,
apparecchi e lastre fotosensibili, posti in commercio in quegli anni. Si sviluppò una
particolare attenzione per gli oggetti apparentemente irrilevanti, quotidiani, mentre la
possibilità di immobilizzare il movimento appariva un problema definitivamente
risolto e superato.
In Germania Hinrich Hoffmann nel frattempo, metteva in posa Hitler per alimentare
la retorica dell’immagine del dittatore; e Mussolini si faceva riprendere dagli anonimi
operato dell’istituto LUCE (L’unione cinematografica educativa) mentre, a torso
nudo, faceva la pubblicità alla “battaglia del grano” tra sorridenti e ignari contadini.
Nell’ambito fotoamatoriale si organizzarono gruppi di fotografi-intellettuali, come
quello “degli otto” nel 1942, che faceva capo a Giuseppe Cavalli. L’anno successivo
questo gruppo pubblicò un annuario che si configura come una sintesi della moderna
fotografia italiana del tempo e un manifesto del suo nuovo corso.
Nella fotografia europea il fenomeno venne caratterizzato soprattutto dal gruppo di
Subjektive Fotografie, promosso dal medico tedesco Otto Steinert ed ufficializzato
con una mostra itinerante e un iniziale volume fotografico. In esso vennero pubblicate
opere dei più significativi fotografi del tempo, perlopiù giovani, in favore di
immagini che dimostrassero originalità e “soggettività”.
Il dopoguerra in Italia
In Italia, nel 1947, Cavalli aveva costituito un più modesto cenacolo, il gruppo “La
Bussola”. Analogamente al Groupe 30 x 40, organizzato a Parigi da Daniel Masclet,
il gruppo italiano tendeva a differenziare la sua fotografia da quella giornalistica o dal
“documentario fotografico”. Riaffiorava l’annoso problema della “fotografia
artistica” e si riaccendeva un dibattito che si sperava definitivamente risolto. Cavalli
trovò un’opposizione, spesso indiretta e implicita nel lavoro professionale, da parte di
alcuni giovani fotoreporter, ma anche di fotoamatori.
Il dibattito fu comunque fertile, i neorealisti combatterono la loro battaglia chiedendo
alle immagini di raccontare, se possibile, la storia “vera” dell’uomo, senza maschere
estetiche, ma con semplicità.
Nella fotografia italiana del dopoguerra si sono particolarmente avvertite le
contraddizioni tra fotografia e cultura umanistica e si è assistito alla crescita del
fotogiornalismo, quindi a una rapida massificazione dell’immagine. Si sono posti in
luce alcuni fotografi italiani come Ugo Mulas, il quale, mediante una serie di
“verifiche” sul linguaggio fotografico, ha sollecitato una salutare meditazione e
riflessione metalinguistica, cancellando antiche e sterili diatribe e avviando la
fotografia a svolgere un ruolo primario, concettuale, nel differente mondo culturale
italiano.
Dal realismo al concettualismo
Il concettualismo delle verifiche di Mulas riabilitò la fotografia “d’arte”, affidando
alla creatività fotografica ogni possibile effervescenza, anche fantastica. Mulas, in un
suo saggio ha affermato che ogni attimo è significativo e quindi può essere
“sublime”, se racconta efficacemente un frammento del tempo che trascorre, mentre
la luce o un gesto si trasformano nello spazio.
Nella seconda metà degli anni Cinquanta, William Klein compone immagini di città,
New York, Roma, Tokyo, Mosca. Le sue sequenze sono raffiche di immagini nere e
bianche, fortemente contrastate, mosse, sfocate, sgranate, sovra e sottoesposte,
deformate dal grandangolo: immagini che scavano dentro l’involucro urbano, alla
ricerca di segni drammatici della sua nevrosi. Le immagini, spesso in sequenza,
hanno una chiarezza comunicativa autonoma e affidano soltanto alla loro ambiguità,
specifica della fotografia, il commento e il giudizio del lettore.
La fotografia è ideologia, quindi è l’autore responsabile del risultato; il fotografo
sceglie nella realtà, con eccezionali libertà da condizionamenti tecnici ed è una scelta
che si compie soprattutto nella cornice dell’apparecchio, nella cosiddetta
inquadratura. La realtà viene esaminata nei suoi infiniti particolari, nostri frammenti
di vita, che la fotografia insegna a considerare e far conoscere. I frammenti della
realtà quotidiana sono stati anche i soggetti delle fotografie di Robert Frank, che
tramite questi episodi scandisce il tempo e l’azione della città, proponendo squarci di
realtà, apparentemente incompleti, ma in effetti più credibili, in quanto meno
stupefacenti.
Anche la fotografia professionale ripropose con disinvolture i nuovi stilemi
dell’avanguardia, nella pubblicità, nella moda, nell’architettura.
Il fotografo, si rifugia, oggi, in un concettualismo in cui l’immagine, invece di essere
un valore reale, obiettivo, tende ad assumere il valore di una metafora, la quale, pur
sempre testimonianza della capacità creativa della fotografia.
Ma c’è ancora chi crede nella possibilità della fotografia di essere testimonianza di
situazioni sociali immanenti, e uno dei modi “utili” per rivelare una realtà obsoleta, di
cui si dimentica o contesta la verità: per esempio Paolo Gasparini, autore di un
convincente volume sul drammatico, caotico contesto sudamericano, “Para Verte
Meyor, America Latina.
Potrebbero piacerti anche
- Dallo Scatto Alla Stampa PDFDocumento38 pagineDallo Scatto Alla Stampa PDFilloNessuna valutazione finora
- Il Cinema Del No Visioni Anarchiche Della Vita e Della Società Goffredo Fofi Z Lib - Org 1Documento102 pagineIl Cinema Del No Visioni Anarchiche Della Vita e Della Società Goffredo Fofi Z Lib - Org 1José MoraisNessuna valutazione finora
- Usi Ed Abusi Dell'Immagine FotograficaDocumento228 pagineUsi Ed Abusi Dell'Immagine FotograficadareusdareiNessuna valutazione finora
- Fotografia Storia DonneDocumento22 pagineFotografia Storia DonneGerman LopezNessuna valutazione finora
- TractatusDocumento39 pagineTractatusjoshua3100% (1)
- Le Avanguardie RusseDocumento42 pagineLe Avanguardie RusseCITA100% (1)
- Neuroni Specchio, Empatia e DesignDocumento168 pagineNeuroni Specchio, Empatia e DesignAngelo AvellinoNessuna valutazione finora
- Percezione VisivaDocumento143 paginePercezione VisivamatteoNessuna valutazione finora
- Fotografia - Medium Come Forma MentisDocumento37 pagineFotografia - Medium Come Forma MentisAndrea PirazziniNessuna valutazione finora
- Storia Dei Manifesti PubblicitariDocumento5 pagineStoria Dei Manifesti Pubblicitariarge_deianiraNessuna valutazione finora
- RuscaDossierpdf 4930Documento205 pagineRuscaDossierpdf 4930Eu OutroraNessuna valutazione finora
- Paolo Fani - Photoshop in Bianco e Nero (2010) PDFDocumento102 paginePaolo Fani - Photoshop in Bianco e Nero (2010) PDFGiovanniNessuna valutazione finora
- Fotografia, immagine e social network al tempo delle nevrosi collettiveDa EverandFotografia, immagine e social network al tempo delle nevrosi collettiveNessuna valutazione finora
- Design Anonimo - Da Cosa Nasce CosaDocumento3 pagineDesign Anonimo - Da Cosa Nasce CosaGabriele Testa0% (2)
- Storia e Teoria Dei Nuovi MediaDocumento15 pagineStoria e Teoria Dei Nuovi Mediafederica landi100% (1)
- D Baroni M Vitta Storia Del Design GrafiDocumento318 pagineD Baroni M Vitta Storia Del Design Grafisofia bugettiNessuna valutazione finora
- Cenerentola - Roald DahlDocumento4 pagineCenerentola - Roald DahlJacopo GiloneNessuna valutazione finora
- Breve Storia Della FotografiaDocumento15 pagineBreve Storia Della FotografiaChiara SilvestriNessuna valutazione finora
- Piccola Storia Della Fotografia-2Documento47 paginePiccola Storia Della Fotografia-2pinneto100% (1)
- Portfolio - Claudia Pulvirenti - CopywriterDocumento24 paginePortfolio - Claudia Pulvirenti - CopywriterclaudiaNessuna valutazione finora
- Progettazioen Grafica - BrochureDocumento100 pagineProgettazioen Grafica - BrochureesmerildoNessuna valutazione finora
- Valle delle Cascate. Il volto sconosciuto di MistrettaDa EverandValle delle Cascate. Il volto sconosciuto di MistrettaValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Portfolio FotograficoDocumento17 paginePortfolio FotograficoGiorgio MarrasNessuna valutazione finora
- La Scienza Del DisegnoDocumento16 pagineLa Scienza Del DisegnoDouglas PastoriNessuna valutazione finora
- Fotografia e StoriaDocumento2 pagineFotografia e StoriaLizzieNessuna valutazione finora
- Storia Del Logo RaiDocumento8 pagineStoria Del Logo RaidanmiNessuna valutazione finora
- Storia Della Stampa e Dell'editoria AppuntiDocumento41 pagineStoria Della Stampa e Dell'editoria AppuntiGinevra Rosa100% (1)
- Riassunto Manuale Una Storia Della FotografiaDocumento58 pagineRiassunto Manuale Una Storia Della FotografiaViola BossolascoNessuna valutazione finora
- Fotografia ConcettualeDocumento12 pagineFotografia ConcettualeDaria PiccottiNessuna valutazione finora
- FotografiaDocumento20 pagineFotografiaAndreaNessuna valutazione finora
- Mondi sotterranei: e il mito della terra cavaDa EverandMondi sotterranei: e il mito della terra cavaNessuna valutazione finora
- Quando La Fotografia Diventa Arte?Documento13 pagineQuando La Fotografia Diventa Arte?Cristiano Toffoletti100% (1)
- Tesina (Fotografia)Documento52 pagineTesina (Fotografia)KatherineNessuna valutazione finora
- Identità fotografiche: Processi di costruzione della realtà attraverso l'immagineDa EverandIdentità fotografiche: Processi di costruzione della realtà attraverso l'immagineNessuna valutazione finora
- Riassunto Di MarraDocumento27 pagineRiassunto Di MarraYaxuan Liu100% (1)
- Antropologia in Sette Parole ChiaveDocumento17 pagineAntropologia in Sette Parole ChiaveLea CaneNessuna valutazione finora
- Tesina Progetto Campagna PubblicitariaDocumento8 pagineTesina Progetto Campagna PubblicitariaRafael DrescherNessuna valutazione finora
- Dispensa Acrilico AADocumento29 pagineDispensa Acrilico AADavide Benincaso100% (1)
- I Poteri Degli Schermi 1Documento33 pagineI Poteri Degli Schermi 1Francesca FestaNessuna valutazione finora
- 1 Fotografia Filosofia ArteDocumento44 pagine1 Fotografia Filosofia ArteElias QueirozNessuna valutazione finora
- Fototerapia in ItaliaDocumento6 pagineFototerapia in ItaliaayresNessuna valutazione finora
- (Ebook - Fotografia - ITA - PDF) Sviluppo e Stampa in Camera Oscura PDFDocumento12 pagine(Ebook - Fotografia - ITA - PDF) Sviluppo e Stampa in Camera Oscura PDFarantxa16100% (3)
- Tecniche Di StampaDocumento8 pagineTecniche Di StampaElettra RizzottiNessuna valutazione finora
- Pictorial TurnDocumento26 paginePictorial TurnMartina CasaleNessuna valutazione finora
- Bollettino FilosoficoDocumento556 pagineBollettino FilosoficoluxfidesNessuna valutazione finora
- Manuale ITA qSlrDashboardDocumento38 pagineManuale ITA qSlrDashboardCarlo ChiolaNessuna valutazione finora
- UgoMulasVerifiche PDFDocumento4 pagineUgoMulasVerifiche PDFFrancesco FioridoNessuna valutazione finora
- Il Racconto Della GraficaDocumento25 pagineIl Racconto Della GraficaElena RiiliNessuna valutazione finora
- Introduzione Alla Cultura VisualeDocumento13 pagineIntroduzione Alla Cultura VisualeElvira GiannettiNessuna valutazione finora
- ArnheimDocumento12 pagineArnheimlulujolie0% (1)
- 03 - Elementi Di Semiotica VisivaDocumento10 pagine03 - Elementi Di Semiotica Visivasemi_oticiNessuna valutazione finora
- Invalsi 1Documento23 pagineInvalsi 1Enzucc BrandoNessuna valutazione finora
- Un Caso Di Spiritualità Nell'arte ContemporaneaDocumento144 pagineUn Caso Di Spiritualità Nell'arte Contemporaneasefora severinoNessuna valutazione finora
- Remediation J.D. Bolter Grusin - OdtDocumento15 pagineRemediation J.D. Bolter Grusin - OdtLarisaNessuna valutazione finora
- Grafica&StampaDocumento171 pagineGrafica&StampahelenaladeiroNessuna valutazione finora
- Design ItalianoDocumento11 pagineDesign Italianosmithangelo2Nessuna valutazione finora
- Carotenuto Et Pluriverso Ottimizzato PDFDocumento720 pagineCarotenuto Et Pluriverso Ottimizzato PDFCaterina Duraccio100% (1)