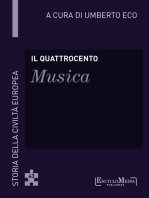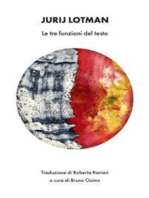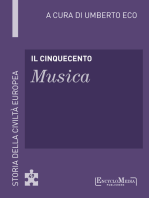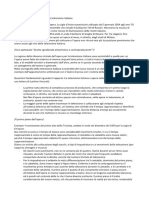Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Lux Aeterna Tommaso Campanella
Lux Aeterna Tommaso Campanella
Caricato da
Tommaso CampanellaCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Lux Aeterna Tommaso Campanella
Lux Aeterna Tommaso Campanella
Caricato da
Tommaso CampanellaCopyright:
Formati disponibili
Tommaso Campanella
Lux Aeterna
La scrittura Ligetiana, si è sempre distinta, rispetto ai suoi contemporanei per delle tecniche compositive
che in un certo senso si distaccavano dagli stili di scrittura in voga all’epoca.
Ligeti, nella sua opera si è sempre lasciato ispirare dagli insegnamenti dei fiamminghi per quel che riguarda
la gestione del contrappunto e dell’indipendanza delle linee vocali. Nel brano in analisi, viene rivalutato il
rapporto tra suono e parola.
Nel cantus planus la parola è la rivelazione della divinità "attraverso" il suono che, a sua volta, è la
glorificazione della parola. Successivamente nella grande stagione della polifonia fiamminga si assiste,
invece, alla trascendenza del rappresentato, grazie alla quale l’opera d’arte stessa è considerata essere
espressione del sacro. Dal sedicesimo secolo si svilupperà poi il madrigale, cioè l’intima relazione fra parola
e suono. Il suono, o meglio il profilo della melodia rispecchia il significato della parola. Successivamente si
assisterà all’avvento del melodramma.
Dall’altra parte, dopo le due scuole liederistiche di Berlino, approderà a Vienna il Lied che raggiungerà vette
altissime grazie a compositori come, ad esempio, F. Schubert.
Nel ventesimo secolo il rapporto fra parola e suono diventa molto delicato, quasi inesistente, perché si è
esaurito, la parola è totalmente assimilata al suono e con esso è trasfigurata.
Ligeti in questa composizione recupera, quella dimensione nella quale la parola perde la sua funzione
referenziale, ossia in essa non c’è alcuna funzione dialettica tra significante e significato.
“E’ una musica che suscita l’impressione di un fluire senza inizio e senza fine. Vi si ascolta una frazione di
qualcosa che è iniziato da sempre e che continuerà a vibrare all’infinito. Tipico di componimenti siffatti è il
non avere cesure che l’idea di flusso non consentirebbe". Con queste parole Ligeti parla della sua musica. In
effetti all’ascolto si percepisce un continuum che subisce varie metamorfosi, ma che non "inizia" e non
"finisce" mai. Questo continuum ha la caratteristica di essere statico e dinamico contemporaneamente. E’
statico perché utilizza le stesse note alla stessa altezza per tutte le voci, ed è dinamico perché all’interno di
questo tessuto si possono individuare linee "virtuali", ogni micro-articolazione nasce e muore, ossia è
indipendente dalle altre ma allo stesso tempo interagisce con le altre.
Il testo usato è liturgico, tratto dalla "missa pro defunctis", ed è il seguente: "Lux aeterna luceat eis,
Domine, cum sanctis tui in aeternum quia pius es. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua
luceat eis".
Il testo è distribuito nelle tre macro-sezioni che compongono la composizione. Addirittura in due di esse c’è
un vero e proprio scivolamento di due parti di esso, una sopra l’altra. L’organico è costituito da un coro
misto a cappella, formato da soprani, contralti, tenori e bassi; ciascuna voce si suddivide in quattro
sottogruppi.
Le voci si avvicendano secondo schemi non simmetrici, che trovano la loro ragion d’essere solo nel
determinare diverse macro-articolazioni, appunto, nelle quali la composizione è suddivisa.
La composizione può essere suddivisa in tre macro-sezioni: la prima dalla batt.1 alla batt..37, la seconda
dalla batt.39 alla batt.89 ed infine la terza dalla batt.90 alla batt.119. Sono presenti dei suoni di
collegamento fra una macro-articolazione e l’altra, non essendo esse giustapposte.
Potrebbero piacerti anche
- Analisi Sonata Op. 24 N. 5 BeethovenDocumento10 pagineAnalisi Sonata Op. 24 N. 5 BeethovenArturo SusaniNessuna valutazione finora
- Tesi Finale Su Ennio Morricone Arrangiatore Di Musica Leggera (1) - 13-25Documento13 pagineTesi Finale Su Ennio Morricone Arrangiatore Di Musica Leggera (1) - 13-25Lorenza CNessuna valutazione finora
- Lineamenti Di EsteticaDocumento28 pagineLineamenti Di EsteticaGiada CigognaniNessuna valutazione finora
- Docslide - It - Semiografia e Semiologia Della Musica ContemporaneaDocumento3 pagineDocslide - It - Semiografia e Semiologia Della Musica ContemporaneascanneNessuna valutazione finora
- Debussy WebernDocumento4 pagineDebussy Weberndavide_fabbri84Nessuna valutazione finora
- 5-Luciano Berio - Poesia e MusicaDocumento10 pagine5-Luciano Berio - Poesia e MusicaMNessuna valutazione finora
- Segnali di luce dalla periferia elettrica: l'utopia sonora di Fausto RomitelliDa EverandSegnali di luce dalla periferia elettrica: l'utopia sonora di Fausto RomitelliNessuna valutazione finora
- L’espressività come modello interpretativo dell’esperienza musicaleDa EverandL’espressività come modello interpretativo dell’esperienza musicaleNessuna valutazione finora
- Il Quattrocento - Musica (43): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 43Da EverandIl Quattrocento - Musica (43): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 43Nessuna valutazione finora
- Il Cinquecento - Musica (49): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 44Da EverandIl Cinquecento - Musica (49): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 44Nessuna valutazione finora
- Dallo Stile Galante Allo Stile ClassicoDocumento3 pagineDallo Stile Galante Allo Stile ClassicogiorgioNessuna valutazione finora
- Gli Inizi Della PolifoniaDocumento17 pagineGli Inizi Della PolifoniaAlfredo RestucciaNessuna valutazione finora
- I BiciniaDocumento14 pagineI BiciniaMarco LonghiNessuna valutazione finora
- WOZZECKDocumento214 pagineWOZZECKAmir100% (1)
- Il Metodo Dodecafonico Nel Pierrot LunaireDocumento14 pagineIl Metodo Dodecafonico Nel Pierrot LunaireRocco Barocco100% (1)
- Inchiesta Sulla Melodia e Sulla Musica ContemporaneaDocumento17 pagineInchiesta Sulla Melodia e Sulla Musica Contemporanealeandrogale100% (1)
- Senici - L'Opera e La Nascita Della Televisione ItalianaDocumento2 pagineSenici - L'Opera e La Nascita Della Televisione Italianatommaso fondriestNessuna valutazione finora
- Nattiez 1Documento20 pagineNattiez 1Anonymous xfUYiKoDWNessuna valutazione finora
- Analisi Scene Infantili Di Schumann N°2Documento2 pagineAnalisi Scene Infantili Di Schumann N°2Gianmarco RufinoNessuna valutazione finora
- Bartòk - Il Mandarino MiracolosoDocumento6 pagineBartòk - Il Mandarino MiracolosoAnonymous LbA4uvdANessuna valutazione finora
- Analisi Brahms PDFDocumento11 pagineAnalisi Brahms PDFOe FreeglutenNessuna valutazione finora
- Bruno MadernaDocumento6 pagineBruno MadernaLisa FalòNessuna valutazione finora
- FAVARO La Categoria Del BruttoDocumento5 pagineFAVARO La Categoria Del BruttoMarco LombardiNessuna valutazione finora
- PUSTIJANAC La Polifonia Rivisitata. Studio Degli Schizzi in Ligeti Lachenmann e Grisey PDFDocumento32 paginePUSTIJANAC La Polifonia Rivisitata. Studio Degli Schizzi in Ligeti Lachenmann e Grisey PDFMarco LombardiNessuna valutazione finora
- Tesi 4Documento9 pagineTesi 4Massimo PizziraniNessuna valutazione finora
- Musica Del Primo NovecentoDocumento5 pagineMusica Del Primo NovecentoGianlucaNessuna valutazione finora
- Tesina 8Documento15 pagineTesina 8Lorenzo MatteiNessuna valutazione finora
- Bodei AdornoDocumento5 pagineBodei AdornoAndrea PreoNessuna valutazione finora
- Dall'analisi Alla Riscrittura (Malvano)Documento19 pagineDall'analisi Alla Riscrittura (Malvano)Patrizia MandolinoNessuna valutazione finora
- 56 La Scuola Musicale Di ViennaDocumento20 pagine56 La Scuola Musicale Di ViennaThomasjNessuna valutazione finora
- Liszt RWVenezia AnalisiDocumento2 pagineLiszt RWVenezia AnalisiAntonio GrandeNessuna valutazione finora
- La Musica GrecaDocumento5 pagineLa Musica GrecaaryNessuna valutazione finora
- Berio - SEQUENZA III Per Voce Femminile (Analisi Di R. Castagnola)Documento10 pagineBerio - SEQUENZA III Per Voce Femminile (Analisi Di R. Castagnola)Gianfranco TinelliNessuna valutazione finora
- Passione Secondo Luca Penderecki, Analisi Generale Dell'opera (William Limonta)Documento39 paginePassione Secondo Luca Penderecki, Analisi Generale Dell'opera (William Limonta)paoloNessuna valutazione finora
- Nicholas CookDocumento18 pagineNicholas CookCecilia Regini100% (1)
- La Retorica - Tesi Di Laurea Alessandro BonettiDocumento147 pagineLa Retorica - Tesi Di Laurea Alessandro BonettiGrulletto GrulloneNessuna valutazione finora
- ANALISIDocumento12 pagineANALISIGianni LaterzaNessuna valutazione finora
- Sinfonie Di BeethovenDocumento7 pagineSinfonie Di BeethovenAlessio TiezziNessuna valutazione finora
- Musica DodecafonicaDocumento2 pagineMusica DodecafonicaRosario CaponnettoNessuna valutazione finora
- Sergio Lanza - Il Concetto Di Ornamento in MusicaDocumento55 pagineSergio Lanza - Il Concetto Di Ornamento in MusicapaulgaspardNessuna valutazione finora
- Anzani BeghelliDocumento81 pagineAnzani BeghelliSergio Anderson de Moura MirandaNessuna valutazione finora
- Le Avanguardie MusicaliDocumento169 pagineLe Avanguardie MusicaliPaolo CeccarelliNessuna valutazione finora
- Brahms Analisi Impaginata PDFDocumento21 pagineBrahms Analisi Impaginata PDFSimone AnelliNessuna valutazione finora
- La Formazione Del Veneziano Illustre - Ivano PaccagnellaDocumento26 pagineLa Formazione Del Veneziano Illustre - Ivano PaccagnellaPatrick CoNessuna valutazione finora
- 2013 Versolatto PDFDocumento79 pagine2013 Versolatto PDFEmanuele GolfettoNessuna valutazione finora
- Storia Della Musica, Lezione 13, Pozzi, La Musica A Programma PDFDocumento7 pagineStoria Della Musica, Lezione 13, Pozzi, La Musica A Programma PDFMiriamBuonoNessuna valutazione finora
- LisztDocumento4 pagineLisztSusanna MarescalchiNessuna valutazione finora
- Busoni - Bach ThesisDocumento31 pagineBusoni - Bach ThesisConsueloNessuna valutazione finora
- Bene! 4 Diversi Modi Di Morire in VersiDocumento17 pagineBene! 4 Diversi Modi Di Morire in Versicttnll100% (4)
- Simone Frangi - André Schaeffner, Maurice Merleau-Ponty, Demetrio StratosDocumento6 pagineSimone Frangi - André Schaeffner, Maurice Merleau-Ponty, Demetrio StratosPaolinoPaperino1968Nessuna valutazione finora
- Analisi Als Luise Mozart K520Documento3 pagineAnalisi Als Luise Mozart K520Vito MoschittaNessuna valutazione finora
- Mario Totaro - Petruska e Le SacreDocumento5 pagineMario Totaro - Petruska e Le SacreEzioNessuna valutazione finora
- Beghelli Che Cosa Dicono Travature VivaldianeDocumento4 pagineBeghelli Che Cosa Dicono Travature VivaldianeMyriam TokerNessuna valutazione finora
- Tesi ArmoniaDocumento11 pagineTesi ArmoniaAnonymous o45unJNcNessuna valutazione finora
- Appunti Di StoriaDocumento89 pagineAppunti Di StoriaPierFrancesca Di GiovanniNessuna valutazione finora
- Anal Is I PetrushkaDocumento12 pagineAnal Is I PetrushkaLudwigNessuna valutazione finora
- Garbuglia - Stripsody Vocazione Musicale Fumetti (Def.)Documento7 pagineGarbuglia - Stripsody Vocazione Musicale Fumetti (Def.)giulio pirondiniNessuna valutazione finora
- Schoenberg - Interpretazione Delle Opere Atonali PDFDocumento11 pagineSchoenberg - Interpretazione Delle Opere Atonali PDFAnonymous wI852RTwPnNessuna valutazione finora
- Bach SlideDocumento2 pagineBach SlideGufyNessuna valutazione finora
- UntitledDocumento9 pagineUntitledCiro MangiameliNessuna valutazione finora
- Brocchi - Ronchetti. Conchiologia Fossile SubapenninaDocumento55 pagineBrocchi - Ronchetti. Conchiologia Fossile Subapenninapopo papoNessuna valutazione finora
- Fire Control SystemDocumento14 pagineFire Control SystemDobri CundevNessuna valutazione finora
- Quadri e MalizieDocumento169 pagineQuadri e MalizieClaudio CiavattaNessuna valutazione finora
- La Forma Impersonale EserciziDocumento12 pagineLa Forma Impersonale EserciziFotini OsiouNessuna valutazione finora
- Diagramma Ferro CarbonioDocumento24 pagineDiagramma Ferro CarbonioLorenzoCampaniNessuna valutazione finora
- Next Avanzato5 0 1 3 Classi StregoneDocumento10 pagineNext Avanzato5 0 1 3 Classi StregoneGiorgio1980Nessuna valutazione finora