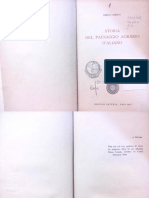Approfondire lo studio dello Zibaldone
Leopardi: ragionamento filosofico e linguaggio della poesia nelle pagine dello Zibaldone In USA boom per Leopardi: il suo Zibaldone diventa un successo editoriale Zibaldone - Wikipedia
Leopardi: ragionamento filosofico e linguaggio della poesia nelle pagine dello Zibaldone
di Raffaella Faggella Venerd 4 gennaio 2008 "uscita n. 2"
In cinque capitoli, cos agili e di facile lettura che scorrono come la rena fra le mani, Donatella Di Stefano ha raccolto il meglio delle sue approfondite indagini su Leopardi, lautore che stato anche argomento della sua brillante tesi di [Link] sanno che non certo agevole muoversi nel grande labirinto degli studi leopardiani, vista la continua produzione critica che continua a fiorire intorno al poeta recanatese, che tanto vasta da poter competere solo con quella di [Link] circostanza ha scoraggiato pi di una volta anche studiosi maggiormente esperti della nostra letteratura che hanno rinunciato di portare legna al bosco, ma non la nostra autrice, il cui volume non tradisce il minimo sospetto dellazzardo, anzi, dichiara senza ombra di dubbio il possesso di due importanti qualit: un entroterra di solidi studi e una passione autentica per il poeta dei Canti. Dando alle stampe il suo volume Ragionar da poeta Donatella, pur affrontando una materia tanto complessa, come quella che circola intorno al poeta di Recanati, non arretrata di fronte alla difficolt dellarte ma, dando prova di saper affrontare con paziente attenzione il difficile lavoro del critico, ha consegnato alla bibliografia leopardiana un altro pregevole saggio che non sfigura certamente allinterno della copiosa messe di studi sul [Link] saggio, che vuole essere innanzitutto una puntuale analisi dello Zibaldone di Leopardi, in particolare del suo linguaggio poetico, cos interessante che pu essere recensito non tanto sovrapponendosi con linvadenza del giudizio, quanto piuttosto riportando il contenuto dei capitoli che trattano, approfondendoli, alcuni degli aspetti cruciali delle problematiche che hanno a che fare col poeta. Dopo una prefazione nella quale innanzitutto sono dichiarati gli obiettivi della ricerca quale tentativo di rielaborare dei pensieri sparsi dello Zibaldone al fine di rendere chiara una teoria linguistico-estetica attraverso le argomentazioni in prosa di Leopardi, cui segue una puntale considerazione del termine Zibaldone di incerta etimologia e una rapida considerazione della storia redazionale dellopera, il primo capitolo fondamentalmente incentrato sulla complessa questione del difficile rapporto in Leopardi di poesia e pensiero, che, come sostiene giustamente lautrice, a partire da Croce stato un tema dominante allinterno della riflessione critica leopardiana. Occorre aggiungere che la questione ha trovato forse la migliore soluzione non tanto nelle argomentazioni degli studiosi quanto piuttosto nelle stesse conclusioni del poeta che sono registrate nello Zibaldone ( dove, dopo aver indicato nella poesia e nella filosofia i due termini distinti di unantitesi, arriva al punto che tra esse le pi nobili e difficili facolt cui possa applicarsi lingegno umano non vi pu essere disparit o inimicizia, ma uno straordinario rapporto analogico),malgrado la natura provvisoria e frammentaria dellopera, la cui considerazione richiede certamente una o pi chiavi di lettura, ma poco si presta ad essere indicata come opera poetica in s, non fosse altro perch una tale definizione si scontra innanzitutto con lidea stessa della poesia pi di una volta indicata da Leopardi in molte pagine della sua pi estesa opera in prosa. Chi ha letto con attenzione una tale miniera di appunti sa che non certo agevole seguire il percorso del pensiero leopardiano, anzi particolarmente difficile tracciare o seguire un suo corso lineare evolutivo, sicch in quella numerosa congerie di dati non sempre possibile trovare un comune fondo sistematico. Comunque, al di l dell intima natura della speculazione leopardiana, un pensiero estremamente flessibile e poco propenso a farsi schematizzare, come stato detto, non si pu negare che il compilatore di questi strani appunti fu innanzitutto un poeta, e non un poeta qualsiasi, non fosse altro perch in un certo momento della sua storia pens originalmente di fare dellarte la forma privilegiata e pi adatta per esprimere il suo pensiero. A queste giuste conclusioni non poteva non approdare il giudizio critico della nostra sensibile lettrice dellopera [Link] interessanti sono le considerazioni intorno alla Questione della lingua in relazione al poeta, che viene affrontata nel secondo capitolo, con una sapiente considerazione della critica fiorita intorno al problema e col proposito dichiarato che dalle pagine dello Zibaldone possibile, per quanto non sempre agevole, desumere la teoria linguistica del recanatese, contraria sia ai puristi del primo 800 sia ai troppo libertini illuministi del secolo precedente. Ma, al di l, delle conclusioni, condivisibili o no, di quanti ( Gensini e altri) ritengono, come suggerisce lautrice, di poter collocare le idee sulla lingua di Leopardi allinterno della linea di quel filone di filosofia del linguaggio che parte da Locke, da Leibniz, da Vico e da Condillac, mi pare pi motivata la conclusione, del resto condivisa dalla critica pi avveduta sul Leopardi, che linteresse del poeta circa la natura della lingua, al di l delle ragioni scientifiche, sia da motivare innanzitutto dal suo interesse per la lingua poetica, quella che prima e pi di ogni altra certamente gli stava a [Link] mi sembra, a maggior ragione, la scelta del terzo capitolo, tutto incentrato sui caratteri del linguaggio poetico che possibile estrarre dagli appunti disseminati nello Zibaldone, in particolare quelli del 21. Qui Leopardi allestisce un autentico catalogo di quelle parole, diversissime dai termini eccessivamente geometrici del linguaggio scientificofilosofico, che a suo dire risultavano pi adatte alla poesia proprio in virt della loro indeterminatezza, concludendo che il vago dellimmaginazione e lindeterminato della rappresentazione richiedevano di necessit un linguaggio speciale, un lessico poetico della stessa natura. Del tutto condivisibili, infine, le conclusioni finali dello stesso capitolo dove giustamente si propone come metodo una lettura comparata dello Zibaldone, da cui possibile verificare la frequente e stretta correlazione tra molti dei pensiericon i Canti, in particolare con [Link] sistemata risulta anche lanalisi del suddetto idillio, fondato innanzitutto sulle teorizzazioni sul piacere e del cosiddetto vago-indefinito e sulla complessa definizione dellinfinito-indefinito, e sorretta da un metodo che, se non privilegia in modo assoluto il procedimento strutturale, tuttavia tiene nel conto dovuto la conoscenza dei livelli del teso, in particolare la metrica, il lessico, e la sintassi. Di un certo interesse, anche se non nuove, le pagine dove viene confrontata la soluzione estetico-mistica dellinfinito leopardiano distinta dallapprodo esclusivamente religioso di [Link] capitolo quinto, che risulta pi riuscito nella parte iniziale,- dove lautrice si sofferma su alcuni aspetti della poetica contemporanea ai cosiddetti piccoli idilli: il motivo fondamentale della ricordanza e il sentimento indefinito della malinconia quali generatori di una poesia che si rivela a questo punto non pi rispondente al modello dellassoluta immaginazione degli antichi, ma sentimentale e moderna, in una parola romantica a causa del suo carattere filosofico e introspettivo- ci sembra meno convincente nella conclusione dellopera, dove per seguire un certo filone della critica, orientato a leggere anche nella vita e nellarte di Leopardi ragioni psicanalitiche, il discorso mette da parte la pi congeniale lettura dei testi per concentrarsi su una ipotetica nevrosi di Leopardi, che, si sottolinea, avrebbe trovato una definitiva soluzione nella funzione igienico-terapeutica della scrittura e dellarte. Si ribadisce, in conclusione, il pregio complessivo del libro che, quando non si affida eccessivamente alla cultura, riesce ad ottenere il meglio di s astraendo preferibilmente le sue considerazioni dallopera leopardiana. E questa mi sembra, al di l del valore di alcune conclusioni, il suggerimento di un ottimo metodo di lettura.
�In USA boom per Leopardi: il suo Zibaldone diventa un successo editoriale
Lincredibile statura poetica di Giacomo Leopardi ha sempre oscurato la reale portata della sua produzione cosiddetta minore, quella per intenderci pi schiettamente filosofica. Certo, i temi sviluppati nelle opere in prosa, trovano dirette e precise corrispondenze a livello lirico e, in particolare tra gli anni 30 e 50, sono stati interpretati come segni premonitori di un atteggiamento esistenzialista ante litteram. Tuttavia, possiamo ben dire che tanto in Italia quanto, soprattutto, allestero del poeta di Recanati si abbia una visione approssimativa e limitata: la sua straordinaria e proverbiale sensibilit, infatti, difficilmente si lascia inquadrare nelle categorie convenzionali e, come scrive il critico americano John Gray, la reale portata del suo genio sovversivo non ha ancora ricevuto un adeguato riconoscimento. Cos stanno, o quantomeno stavano fino a oggi, le cose. Gi, perch la notizia di cui vogliamo darvi conto che il nuovo caso letterario di cui si discute sulle pi eminenti riviste letterarie inglesi e americane proprio relativo a Giacomo Leopardi e in particolare al suo Zibaldone appena tradotto oltre oceano e pubblicato rispettivamente da Penguin Books e da Farrar, Straus e Giroux. Un successo editoriale che ha il carattere di unimpresa epica: oltre sei anni di riflessioni, sette di traduzione, ad opera di una folta schiera di studiosi, due coordinatori/curatori che portano il nome di Micheal Cesar, ordinario di letteratura italiana alluniversit di Birmingham e fondatore nel 1998 della cattedra di studi leopardiani, e Franco DIntimo, docente alla Sapienza e noto studioso di Leopardi. Questo team di specialisti ha raccolto la sfida di proporre al pubblico di lingua inglese le oltre duemilacinquecento pagine di un lontano poeta romantico, ottenendo un successo che va molto oltre le aspettative: Sunday Times, New Statesman, New York Review of Books e molti altri ancora, hanno definito lo Zibaldone come un tesoro ritrovato, un punto di riferimento imprescindibile per il pensiero moderno. Il Financial Times arriva a definire Leopardi come uno dei pensatori pi radicali del diciannovesimo secolo accostandolo a Coleridge, Emerson, Kirkegaard e Nietzsche. Elisabetta Rasy, riportando un suo colloquio con Micheal Cesar, proprio in occasione della pubblicazione del volume, riferisce che lo studioso inglese parla di un inatteso e autentico major event nella storia delle idee, aggiungendo che anche in Italia lo Zibaldone poco considerato come libro autonomo, ritenuto solo un punto di riferimento per le opere maggiori. In effetti, basta pensare che la prima pubblicazione del testo integrale avvenne nel 1898, per celebrare il centenario della nascita del poeta. Non solo, anche ledizione critica del 1937, curata da Francesco Flora, parla esplicitamente di preparazione culturale, di una anteriore e men elaborata stesura rispetto allopera poetica. Insomma, siamo probabilmente alle soglie di un ribaltamento curiosissimo e del tutto inaspettato: il Leopardi filosofo che scavalca e si impone sul Leopardi poeta! In realt, almeno in Italia esistono una serie di ragioni storiche che hanno, per cos dire, oscurato lo spessore filosofico del pensiero leopardiano: una fra tutte, la sua rigorosa avversione per lidealismo, a lungo dominante qui da noi, a favore di un sensismo materialista che naturalmente trova maggiore sponda nel mondo anglosassone. Inoltre, Leopardi pur accettando il Cristianesimo come unica illusione possibile, era un pensatore radicalmente anticristiano, e riteneva che lasserzione militante della sua verit rivelata fosse nociva per lintera umanit, non gi da un punto di vista teologico, ma storico, morale. Luniversalismo propugnato dal Cristianesimo, infatti, era, secondo Leopardi, una licenza senza limiti per la ferocia e loppressione. John Gray, nel suo appassionatissimo articolo apparso sul New Statesman, ricorda che il poeta di Recanati non riusc a prendere mai sul serio la fede nel progresso, lidea che la civilt migliori gradualmente col tempo, e partendo da queste considerazioni, valutava limpatto della religione Cristiana sul mondo antico come una sciagura: La scelleratezza dei cristiani nel Medioevo era molto differente e pi orribile di quella dellet antiche anche pi barbare. In altre parole Leopardi, molto prima dellImperialismo di fine Ottocento, dei genocidi di et moderna e delle guerre della nostra epoca, che si svolgono sotto lo stendardo della democrazia, aveva intuito si celasse quella che soleva definire barbarie della ragione, vale a dire il tentativo di ordinare il mondo secondo un modello pi razionale. Ma laspetto pi pessimista di tutta la vicenda , come ci ricorda ancora Gray, che Leopardi accettava, seppur amaramente, il fatto che non esiste alcun rimedio per lignoranza di coloro che si credono incarnazioni della ragione. In conclusione, lasciateci soltanto dire che la lucidit e lincredibile attualit di questi ragionamenti tale da provocare inquietudine e incanto, turbamento e malia. Pertanto consigliamo vivamente di ritornare a leggere Leopardi avendo per un attimo il coraggio di scansare il richiamo seducente delle poesie per dedicarsi alla prosa. Unoperazione peraltro simile a quella suggerita dal recente percorso del regista Mario Martone, che dopo aver portato in giro per lItalia le Operette morali, sta realizzando un ambizioso progetto cinematografico dal titolo: Il giovane favoloso, che vedr Elio Germano nei panni del grande poeta.. Ops! del grande filosofo italiano.
Zibaldone - Wikipedia
Lo Zibaldone, o col titolo completo Zibaldone di pensieri, un diario personale che raccoglie una grande quantit di appunti scritti tra luglio/agosto 1817 e dicembre 1832 da Giacomo Leopardi, per un totale di 4 526 pagine. Il titolo deriva dalla caratteristica della composizione letteraria, in quanto mistura di pensieri, come per l'omonima vivanda emiliana che costituita da un amalgama vario di molti ingredienti diversi[1]; a volte, il termine usato per descrivere un mucchio confuso di persone[2]. Anche se il termine era conosciuto anche prima[3], dopo la composizione di Leopardi il termine usato per annotazioni su quaderni o diari di pensieri sparsi. "Zibaldone" pu essere usato anche in modo dispregiativo per discorsi o scritti senza filo logico, disordinati, fatti di idee eterogenee. Dopo la morte del poeta (nel 1837) il fascio di carte era rimasto presso l'amico Antonio Ranieri il quale lo tenne per oltre cinquant'anni con altri manoscritti, lasciandolo in un baule a sua volta finito in eredit a due donne di servizio. Dopo la morte di Ranieri e un processo per stabilirne la propriet, gli studiosi poterono finalmente avere accesso all'autografo che oggi conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli. L'opera stata pubblicata per la prima volta in sette volumi, durante il triennio 1898-1900 da una commissione di studiosi presieduta da Giosu Carducci con il titolo Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura (ed. Le Monnier). Le edizioni successive di una certa importanza filologica sono quelle di Francesco Flora (2 voll. del 1937-38, ma in ed. successive ne fece anche una scelta ridotta), poi la stessa rivista da Walter Binni ed Enrico Ghidetti (nel 1969) e finalmente l'edizione critica a cura di Giuseppe Pacella (in 3 voll., presso Garzanti, 1991) sulla base della quale impostata quella di Lucio Felici (1997, con premessa di Emanuele Trevi), quella, rivista, di Rolando Damiani (per "I Meridiani" Arnoldo Mondadori Editore, 1997 e 19992) e quella tematica stabilita sugli indici leopardiani (uscita, a cura di Fabiana Cacciapuoti[4], dal 1997 al 2003). Un'ed. fotografica del manoscritto uscita a cura di Emilio Peruzzi in 10 voll. (Pisa, 1989-1994), mentre un'ed. in CD-ROM uscita presso Zanichelli (2009). Antologie di passi scelti sono state pubblicate a cura di Giuseppe De Robertis (1922), Valentino Piccoli (1926), Giuseppe Morpurgo (1934 e 1946), Guido Marpillero (1934), Flavio Colutta (1937), Giuseppe Petronio (1938), Francesco Biondolillo (1945), Anna Maria Moroni (1972, con una fondamentale introduzione di Sergio Solmi, a sua volta curatore di una scelta nel 1977), Carlo Prono (1976), Mario Andrea Rigoni (1997) e Vincenzo Gueglio (1998). Anche Vincenzo Cardarelli ne scelse e annot alcuni passi. Si tratta di annotazioni di varia misura e ispirazione, spesso scritte in presa diretta e pertanto caratterizzate da un tono di provvisoriet, da uno stile per lo pi asciutto; a volte brevissime, a volte ampie e articolate per punti. Eppure la loro importanza
�fondamentale, in quanto contengono un notevole insieme di temi e spunti che spesso costituirono ispirazione prima per i Canti, le Operette morali, e, soprattutto[5] i Pensieri. In qualche caso, invece, queste pagine vedono riflettersi quanto gi detto altrove, o riportano commenti su libri letti, osservazioni su incontri o esperienze ecc. Sono di particolare interesse le numerosissime pagine che elaborano gli elementi essenziali della poetica e del pensiero di Leopardi, di cui il lettore pu cogliere l'intimo dinamismo e il procedere per successivi momenti problematici. Tra l'11 luglio e il 14 ottobre 1827 Leopardi stesso ne redasse un indice tematico (evidentemente incompleto, visto che continu a scriverlo fino al 4 dicembre 1832). La prima pagina infatti datata "luglio o agosto 1817" (data ricostruita dal Leopardi successivamente alla sua decisione di datare gli appunti da p. 100, ovvero in data 8 gennaio 1820), l'ultima "Firenze, 4 dicembre 1832". Il maggior numero delle 4.525 pagine venne scritto tuttavia fra il 1817 e il 1823 per un totale di pi di 4.000 pensieri elaborati. Lo studioso Claudio Colaiacomo lega il dislivello di frequenza della scrittura ai vari viaggi e alla sedentariet del poeta la cui "scrittura dello Zibaldone appare legata essenzialmente ad un'immagine dell'esistenza come claustrazione o reclusione, quale fu quella nella quale spesso l'autore si present nelle sue lettere, e che al di l del suo fondamento biografico immediato, costituisce il segno di una volont di integrale letterarizzazione dell'esistenza"[6]. I temi trattati sono: la religione cristiana, la natura delle cose, il piacere, il dolore, l'orgoglio, l'immaginazione, la disperazione e il suicidio, le illusioni della ragione, lo stato di natura del creato, la nascita e il funzionamento del linguaggio (con anche diverse annotazioni etimologiche), la lingua adamica e primitiva, la caduta dal paradiso, il bene e il male, il mito, la societ, la civilt, la memoria, il caso, la poesia ingenua e sentimentale, il rapporto tra antico e moderno, l'oralit della cultura poetica antica, il talento, e, insomma, tutta la filosofia che sostiene e nutre la propria poesia. Il dolore la legge della realt ed universale. Esso riguarda "non gli individui, ma le specie, i generi, i regni, i globi, i sistemi, i mondi" (Zibaldone, 3). Il ricordo ha un'importanza fondamentale in quanto fa emergere una folla di sensazioni, sentimenti, riflessioni, arricchendoli del fascino della lontananza, che le immerge in un'atmosfera di vago, di indefinito, impreciso. (Zibaldone, 6). La ricordanza poetica diventa memoria di emozioni e sensazioni della prima et. Si tratta di un atteggiamento che sar anche alla base degli Idilli (Zibaldone, 8). Il ricordo ha, come detto, un'importanza fondamentale nella poesia leopardiana: "La rimembranza essenziale e principale nel sentimento poetico, non per altro se non perch il presente, qual ch'egli sia, non pu essere poetico; e il poetico, in uno o in altro modo si trova sempre consistere nel lontano, nell'indefinito, nel vago" (Zibaldone, 6). Questi concetti sono il punto di partenza dell'idillioL'infinito e l'anelito a un'esperienza interiore che vada al di l del mondo limitato della nostra esperienza sensibile. La ricordanza lo stato d'animo poetico soprattutto perch ci permette di recuperare la dimensione fantastica e commossa che nella prima adolescenza l'uomo ha assunto di fronte alla vita: l'adolescenza l'et in cui si viene formando la nostra sensibilit. "La sensazione presente non deriva immediatamente dalle cose, non un'immagine degli oggetti, ma della immaginazione fanciullesca; una ricordanza, una ripetizione, una ripercussione o riflesso della immagine antica. [....] In maniera che, se non fossimo stati fanciulli, tali quali siamo ora, saremmo privi della massima parte di quelle poche sensazioni indefinite che ci restano, giacch non le proviamo se non rispetto e in virt della fanciullezza" (Zibaldone, 7)". La poesia poi identificata da Leopardi con il senso dell'indeterminato e con le emozioni interiori cui corrispondono alcune particolari parole evocatrici di immaginazioni e rimembranze infinite: lontano, antico, notte, notturno, oscurit, profondo, ecc. (Zibaldone, 9). Giovanni Gentile, La filosofia di Leopardi, Firenze 1938 Benedetto Croce, Leopardi (1922), in Poesia e non poesia, Bari 1923 Angelandrea Zottoli, Storia di un'anima, Bari 1927 Giovanni Amelotti, Filosofia di Leopardi, Genova 1937 Adriano Tilgher, La filosofia di Leopardi, Roma 1940 Cesare Luporini, Leopardi progressivo, in Filosofi vecchi e nuovi, Firenze 1947 Romano Amerio, L'ultrafilosofta di Leopardi, Torino 1953 Sebastiano Timpanaro, Appunti per il futuro editore dello Zibaldone e dell'epistolario leopardiano, in Giornale storico della letteratura italiana, CXXXV (1958), pp. 607-17 Sergio Solmi, Studi leopardiani (1967-74), Milano 1987 Antonio Prete, Il pensiero poetante. Saggio su Leopardi, Milano 1980 Emanuele Severino, Il Nulla e la Poesia. Alla fine dell'et della tecnica: Leopardi, Roma 1990 Elio Gioanola, Genesi della malinconia in Leopardi, in Nuova Corrente, XXXIX (1992), 4, pp. 251-88 Franco Ferrucci, Il Moto, la quiete, Leopardi e il principio di contraddizione, in Lettere italiane, XLIV (1992), 4, pp. 579-97, poi integrato in Il formidabile deserto. Lettura di Giacomo Leopardi, Roma 1998 Alberto Folin, La natura leopardiana da vicino e da lontano, in aut-aut, n. 258 (1993), pp. 51-67, poi integrato in Leopardi e la notte chiara, Venezia 1993; e in Leopardi e l'imperfetto nulla, Venezia 2001 Giuseppe Pacella, Vicende e fortuna dello Zibaldone tra '800 e '900, in Italianistica, XXII (1993), 1-3, pp. 39-51 Lucio Felici, La luna nel cortile. Trame di poesia nello Zibaldone, in Filologia e critica, XVIII (1993), 2, pp. 175-93 Alberto Caracciolo, Leopardi e il nichilismo, Milano 1994 Cesare Galimberti, Cose che non son cose. Saggi su Leopardi, Venezia 2001 Antonio Carrannante, Rileggendo lo "Zibaldone", in "Rivista di letteratura italiana", 2004, 2, pp. 111-133 Emanuele Severino, Cosa arcana e stupenda. L'Occidente e Leopardi, Milano 2006