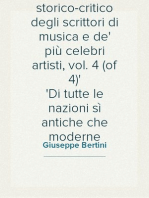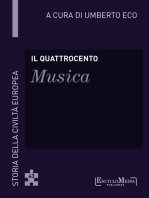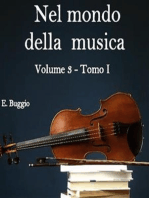Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
02 Bonaccorsi02 Bonaccorsi
02 Bonaccorsi02 Bonaccorsi
Caricato da
pincopirola0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
9 visualizzazioni9 pagine02 BONACCORSI 02 BONACCORSI
Titolo originale
02 BONACCORSI02 BONACCORSI
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documento02 BONACCORSI 02 BONACCORSI
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
9 visualizzazioni9 pagine02 Bonaccorsi02 Bonaccorsi
02 Bonaccorsi02 Bonaccorsi
Caricato da
pincopirola02 BONACCORSI 02 BONACCORSI
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 9
Da sempre, e con ottimismo forse eccessivo, la musica viene
definita linguaggio universale quasi a riassumere nel suo esclusi-
vo mondo di suoni le propriet della lingua che, nella loro variet,
distinguono e caratterizzano culture e civilt diverse elaborando
estetiche ben definite nelle loro successive, continue evoluzioni.
La ricerca sempre pi attuale e insistente di una autentica
prassi esecutiva ha portato a interpretazioni riferite sempre pi
al confronto sistematico fra musica e retorica intese come appli-
cazione alla musica della struttura verbale, incarnata nel tempo
dalla retorica vera scienza della oratio considerata ars bene
loquendi. Lampio repertorio di documenti conferma il ruolo deci-
sivo della metafora dellorazione in musica basata sulla distin-
zione fra regole della composizione, che costituiscono la parte
grammaticale del discorso musicale, e regole della retorica, rivolte
a persuadere. Le analogie fra musica e linguaggio verbale sono
dunque oggetto di ricerca nellinterpretazione e comprensione
del linguaggio musicale per tradurne lidioma specifico e trovare
il collegamento fra grammatica e sintassi.
La teoria musicale greco-romana, basata sul concetto pitago-
rico di musica come disciplina matematica, si era trasferita al
pensiero medievale scolastico tramite Severino Boezio (480-524).
In tale pensiero la musica occupava un posto di rilievo accanto alle
tre arti sorelle che con essa formavano il quadrivium: aritmetica,
NUNZIATA BONACCORSI
INTRODUZIONE
geometria e astronomia; unite alle tre rimanenti arti liberali (trivium):
grammatica, dialettica e retorica, erano il percorso obbligato di ogni
ratio studiorum medievale. Nelle Lateinschulen della Germania lute-
rana il curriculum degli studenti pi avanzati comprendeva setti-
manalmente otto ore di latino, tre di dialettica, due di retorica e due
ore per lo studio di Cicerone. Tutto era integrato dalla lettura dei
testi classici che serviva a ricercare le regole linguistiche da imitare,
trascurandone il valore letterario sacrificato al culto della forma.
Lapprendimento e lesercizio della struttura oratoria si con-
giungono allapplicazione delle figurae retoriche. Nel termine
latino, figura limmagine della forma originale ed simile alla
parola greca schema, tradotta con figura da Cicerone. Anche su tale
soggetto testimonianze significative sono gli insegnamenti di
Quintiliano che nella terza parte della sua Institutio oratoria (libri
VIII-XI) discute i concetti di tropi e figure che aggiungono forza
e grazia allorazione; i tropi sono lespressiva alterazione di una
parola o di una frase dal suo significato ad un altro, le figurae sono
un adattamento del nostro linguaggio alterato dalluso comune.
Una figura perci una nuova maniera di esprimersi
1
. Cos il
tropo attribuisce nuovo contenuto al linguaggio comune, la figura
costruisce in modo nuovo il linguaggio.
Allinizio del Rinascimento le materie linguistiche (Trivio),
fino ad allora considerate inferiori e subordinate alle discipline
del Quadrivio, innalzandosi a ranghi pi alti resero retorica e
poesia arti sorelle della musica e chiamarono il compositore ad
assolvere nuovi elevati compiti.
Introducendo i termini della struttura retorica in musica
Athanasius Kircher, nella sua Musurgia Universalis del 1650, indica
1
MARCO FABIO QUINTILIANO, Institutio oratoria, trad. it. di Orazio Frilli, Zanichelli,
Bologna 1972.
34 NUNZIATA BONACCORSI
come raggiungere lespressivit con uno stile razionale e preor-
dinato. Si affermer cos il concetto di composizione legata a
principi razionali di forma e di espressione condivisi da tutti; da
questo concetto conseguir che il materiale tematico diventa di
dominio pubblico, comune a tutti i compositori e comprensibile
a tutti gli ascoltatori.
Le materie linguistiche del trivium, con la loro enfasi e la loro
capacit di comunicazione, diventano preminenti e acquistano
legittimit per essere applicate alla musica. La felice sintesi fra
teoria (quadrivium) e pratica (trivium) conduce al nuovo concetto
di musica poetica:
La Musica Poetica, o composizione musicale, una scien-
za matematica che consente di riprodurre su un foglio
unarmonia gradevole e corretta e cos, in un secondo
tempo, poterla suonare o cantare conducendo lascolta-
tore alla devozione di Dio e al piacere e diletto dellani-
ma e della mente []. Il suo stesso nome indica che il
compositore non solo deve capire il linguaggio, come
fa il poeta, ma deve anche rispettare il tempo del testo;
egli scrive poesia e melodia, cos attribuendosi il titolo di
Melopoeta o Melopoeus
2
.
La musica poetica cerca di bilanciare scienza e arte, ratio e
sensus, ma il suo principale obiettivo condurre lascoltatore
verso linterpretazione affettiva del testo e la rappresentazione
musicale dellordine cosmico. Essa considera la natura speculati-
va della musica theoretica come una sintesi di arte e scienza che si
volge non solo a un approccio razionale del concetto di affetto,
relegato prima nel trivium e appartenente alla retorica, ma inclu-
de il concetto di temperamento, materia gi appartenente alle
discipline mediche.
2
JOHANN GOTTFRIED WALTHER, Praecepta der musicalischen Composition, ms., Weimar
1708 (pubbl. a cura di Peter Benary, Breitkopf & Hrtel, Lipsia 1955, p. 75).
Introduzione 35
Nel corso del Settecento, con la combinazione di cosmologia
medievale, teologia protestante e arte della retorica si giunger
alla sostituzione del numerus con natura e allattribuzione di si-
gnificato ad affetti e principi retorici.
Il crescente rilievo delle discipline linguistiche e la umanizza-
zione del pensiero musicale conferiscono nuovo spazio allespres-
sione del testo; laffectus exprimere del Rinascimento sostituito con
laffectus movere dellet barocca e gli affetti, vero fine della com-
posizione, per essere chiaramente espressi hanno bisogno di
figurae ma anche di tonalit, tempo e modi appropriati nonch di
tutto il campionario di artifici e metodi propri dellarte retorica.
Il compositore deve osservare i fenomeni fisici e il comporta-
mento umano e usare la imitatio per appropriarsi delle composi-
zioni dei grandi maestri; praeceptum, exemplum et imitatio sono
fondamentali alla musica quanto lo la retorica e le grandi opere
dir Mattheson non devono essere risultato di ispirazione o
di esperienza soggettiva ma calcolato sangue freddo.
Luso di determinate figurae nella musica legata a un testo d
concretezza al significato della singola parola quando questa ri-
veste particolare importanza e la ricorrenza della stessa figura
sulla medesima parola, anche in opere diverse, assai frequente
in tutta la storia della musica.
Lillustrazione pittorica del testo in musica ha origini antiche
e il sistema pi usato per rappresentare le immagini era il voca-
lizzo che con landamento della sua linea melodica risultava
adatto ad evocare parole: locchio prima dellorecchio percepisce
il messaggio simbolico e onde, lacci oppure catene e serpenti
sono cos chiaramente espresse
3
:
3
Cfr. RENATO DIONISI - BRUNO ZANOLINI, La tecnica del contrappunto vocale nel Cin-
quecento, Edizioni Suvini Zerboni, Milano 1988, pp. 237-238.
36 NUNZIATA BONACCORSI
Qualche esempio di immagini evocative in Johann Sebastian
Bach si ha nel corale Nun komm der Heiden Heiland (BWV 599).
Sopra il testo Komm [vieni] a batt. 1 e Gott solch Geburt ihm beftellt
[Dio ci conceda questa prodigiosa nascita] a batt. 8, landamento
dei gradi congiunti, interrotto dallampio salto, simbolizza la croce:
o ancora nel corale Puer natus in Bethlehem (BWV 603), a batt. 1
sgg., la ripetitiva alternanza di due note vicine simbolizza loscil-
lare della culla del bambino
4
:
4
Cfr. MICHAEL RADULESCU, Le opere organistiche di J.S. Bach. Orgel-Bchlein, a cura di
Arnaldo Bassini, Editrice Turris, Cremona 1991, pp. 204, 221.
Luca Marenzio: madrigale Scherzando con diletto
Luca Marenzio: mottetto Estote fortes
Introduzione 37
38 NUNZIATA BONACCORSI
La figura retorica utilizzata lhypotyposis che consiste nella
descrizione visiva di una scena o di un oggetto e pu anche esse-
re espressa come ascensus, o anabasis, figura che sale; descensus, o
catabasis, figura che scende; circulatio, o kyklosis, figura che gira.
Cos simbolicamente usata con significati precisi: ascensus in
contesti dove tutto sale, come ad esempio nel corale (BWV 628)
Erstanden ist der Heilge Christ [Cristo Santo risorto], dove il basso
ha un movimento ascendente; descensus, dove tutto scende, nei
motivi di morte ma anche simbolo della discesa del Signore sulla
terra (Natale); la circulatio ricorrente nelle espressioni di gioia
in quanto figura danzante.
I tipi di simbolismo sono tuttavia anche di altro genere e,
soprattutto alla fine della sua produzione, Bach fa ampio uso di
rapporti numerici. La gematria, il sistema di esprimere una lettera o
una parola con numeri, era una tecnica diffusa che aveva origine
dalla cultura ebraica; essendo il sistema ebraico privo di numeri
erano utilizzate normalmente le lettere per indicarli: Aleph signi-
ficava testa di toro e sostituiva il numero 1, Beth il 2, etc. Il sistema,
accolto in Europa, applicato per analogia alle parole che, con la
somma delle lettere, assumono un significato numerico. La lette-
ratura alchimistica prodiga di esempi e Bach ne usa i significati
in relazione a determinate parole ma anche come allegoria legata
alla teologia luterana, cos 7 simboleggia i sette doni dello Spirito
Santo o le sette parole di Cristo sulla croce; 3, ovviamente, la Trinit;
5 lumanit, etc. Seguendo il principio della cabala Bach scrive il
suo nome in cifre, e le lettere stesse in numeri (A=1, B=2 etc.). Alla
parola assegnato un valore numerico ottenuto con la somma dei
valori delle lettere. Il numero personale di Bach 14:
BACH 2+1+3+8=14
J.S. BACH 9+18+2+1+3+8=41 (inverso di 14)
JOHANN SEBASTIAN BACH=158 (1+5+8=14)
La ricerca della simmetria nel numero si spinge alla divisione
formale che privilegia la fraseologia musicale regolare, basata
sulle divisioni classiche del discorso verbale e cadenzata sul
modello periodico del verso poetico.
Il musicus poeticus ricercando la relazione fra testo e musica
usa evidenti analogie ma anche tali oscuri artifici. Alla base il
tradizionale metodo di praeceptum, exemplum et imitatio che fa
pensare al musicista come a un normale artigiano che esercita un
mestiere. Bach era solito affermare che egli era riuscito ad otte-
nere risultati grazie alloperosit e alla pratica. Non modestia ma
modo di pensare del tempo: Nel genio umano i molti esempi di
diversit e livelli di superiorit non sono in realt il risultato di
un dono di natura ma il frutto dellacquisizione
5
.
La musica di Bach ha come metodo di lavoro ed elemento car-
dine la ripetizione e la variazione; il tema originario si espande
seguendo un progetto che insieme diviso e organico, come un
corpo composto da varie parti unico. Le procedure usate pro-
cedure pi attente alla conformit delle relazioni musicali che
alle associazioni di gusto alterano il significato originario e
sono tanto singolari da renderne difficoltoso il riconoscimento.
La logica dellinventio e della dispositio sempre agganciata al
labirinto della memoria:
La mnemotecnica, formalizzata da Cicerone e Quintiliano,
e divenuta attraverso i secoli uno strumento formidabile
del sapere, attinse nuova forza nelle et del Rinascimento
e del Barocco, portando alla creazione di linguaggi arti-
ficiali, alfabeti, simboli, emblemi, immagini, allegorie,
5
WILLIAM SHARPE, A Dissertation upon Genius, Charles Bathurst, Londra 1755
(rist. anast. a cura di William Bruce Johnson, Delmar Scholars Facsimiles & Reprints,
Londra 1973). La dissertazione fa parte del titolo: The several instances of distinction,
and degrees of superiority in human genius are not, fundamentally, the result of
nature, but the effect of acquisition.
Introduzione 39
figure, geroglifici, segni, sigilli, tutti di ispirazione mistico-
religiosa che avevano per scopo recondito o dichiarato la
comunicazione col divino. Alla retorica, cos come era
stata intesa dai classici, fu affidato il compito di regolare
linterno sviluppo del pensiero mediante lindividuazione
di luoghi (topica) ai quali la memoria potesse agganciarsi
e, attraverso un singulare ac mirabile artificium, ritrovare la
conoscenza delle cose, di tutte le cose. Scopo della retori-
ca quello di ordinare il materiale, selezionare quegli
elementi di conoscenza presenti nella mente che meglio
si confanno a chi ascolta e allargomento trattato; inoltre,
di indurre nellimmaginazione un numero di osservazio-
ni il pi possibile vasto e tale da favorire la ragione senza
mortificarla e senza prevaricarla. Loperazione, al tempo
stesso, persegue anche un fine etico, di determinazione
del comportamento morale. E lo strumento per realizzar-
lo organum, clavis universalis, formula che dir si voglia
tale da consentire di superare qualsiasi labirinto e
portare alla costruzione di unenciclopedia del sapere,
di un compendio organico delle scienze assoggettato
alla legge dellassociazione, per cui somiglianza, oppo-
sizione, contiguit formano le coordinate nella quali
costringere la conoscenza
6
.
La perfectio perseguita da Bach con gli strumenti della scientia
universalis magnificamente rappresentata da questa figura che
lo ritrae al centro di un sole, luce originaria dalla quale ogni altro
si irradia
7
.
6
ALBERTO BASSO, Frau Musika. La vita e le opere di J.S. Bach, vol. 2, EDT, Torino 1983,
pp. 730-731.
7
Immagine riprodotta da Breitkopf & Hrtel a Lipsia su Allgemeine musikalische
Zeitung, II, 5, ottobre 1799.
40 NUNZIATA BONACCORSI
Introduzione 41
August Friedrich Christoph Kollmann, Il Sole dei Compositori
Potrebbero piacerti anche
- SCHOENBERG Stile e Pensiero Scritti Su Musica e Società ESTRATTODocumento30 pagineSCHOENBERG Stile e Pensiero Scritti Su Musica e Società ESTRATTOjhon drinkwater100% (2)
- Schumann - Consigli Ai Giovani MusicistiDocumento3 pagineSchumann - Consigli Ai Giovani MusicistiGabriele ToiaNessuna valutazione finora
- Reverie RegondiDocumento13 pagineReverie Regondiorphenica2002100% (2)
- Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 4 (of 4) Di tutte le nazioni sì antiche che moderneDa EverandDizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 4 (of 4) Di tutte le nazioni sì antiche che moderneNessuna valutazione finora
- Newton Lo Spettro MisolidioDocumento16 pagineNewton Lo Spettro MisolidioFabrizio FestaNessuna valutazione finora
- L’espressività come modello interpretativo dell’esperienza musicaleDa EverandL’espressività come modello interpretativo dell’esperienza musicaleNessuna valutazione finora
- Il Seicento - Musica (55): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 50Da EverandIl Seicento - Musica (55): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 50Nessuna valutazione finora
- Il Quattrocento - Musica (43): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 43Da EverandIl Quattrocento - Musica (43): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 43Nessuna valutazione finora
- Circulata MelodiaDocumento46 pagineCirculata MelodiaparisipromoNessuna valutazione finora
- Il sentimento del suono: L’espressività musicale nell’estetica analiticaDa EverandIl sentimento del suono: L’espressività musicale nell’estetica analiticaNessuna valutazione finora
- Alfonso D'Avino Hans Haug e La Sua Musica Per ChitarraDocumento198 pagineAlfonso D'Avino Hans Haug e La Sua Musica Per Chitarraorphenica2002100% (1)
- Alfonso D'Avino Hans Haug e La Sua Musica Per ChitarraDocumento198 pagineAlfonso D'Avino Hans Haug e La Sua Musica Per Chitarraorphenica2002100% (1)
- Keplero e La MusicaDocumento585 pagineKeplero e La MusicaDæveNessuna valutazione finora
- La danza e l'agitprop: I teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo NovecentoDa EverandLa danza e l'agitprop: I teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo NovecentoNessuna valutazione finora
- Iconografia Musicale 06-02Documento28 pagineIconografia Musicale 06-02AngeloNessuna valutazione finora
- Metodologia Dell'Insegnamento Strumentale - Bibliografia - Guida Allo Studio Della Tecnica Chitarristica - Alfonso D'AvinoDocumento4 pagineMetodologia Dell'Insegnamento Strumentale - Bibliografia - Guida Allo Studio Della Tecnica Chitarristica - Alfonso D'Avinoorphenica2002100% (2)
- 120 Arpeggi Di GiulianiDocumento12 pagine120 Arpeggi Di Giulianiorphenica2002Nessuna valutazione finora
- Choraliter 22 Def Ruolo DirettoreDocumento52 pagineChoraliter 22 Def Ruolo DirettoreLuca BuzzaviNessuna valutazione finora
- Nel mondo della musica. Vol. 3 - Tomo I. Da sant’Agostino ai TrovatoriDa EverandNel mondo della musica. Vol. 3 - Tomo I. Da sant’Agostino ai TrovatoriNessuna valutazione finora
- Solita FormaDocumento3 pagineSolita FormaMarzia FicarraNessuna valutazione finora
- Giorgio Agamben - L'Albero Del LinguaggioDocumento11 pagineGiorgio Agamben - L'Albero Del Linguaggiodavi pessoaNessuna valutazione finora
- Riflessioni Sull'articolazione in J.S BachDocumento10 pagineRiflessioni Sull'articolazione in J.S BachLorenzo BernardiNessuna valutazione finora
- La Cantata Da Camera ItalianaDocumento14 pagineLa Cantata Da Camera ItalianaFrancesco PalmieriNessuna valutazione finora
- Confuso Smarrito, Op. 39 Mauro Giuliani (Voz e Violão)Documento3 pagineConfuso Smarrito, Op. 39 Mauro Giuliani (Voz e Violão)VISITA MUSICALNessuna valutazione finora
- Classicismo MusicaleDocumento6 pagineClassicismo MusicaleMartina CatanutoNessuna valutazione finora
- Aneddoti Sui Musicisiti PDFDocumento56 pagineAneddoti Sui Musicisiti PDFMirko MuscoNessuna valutazione finora
- Teatro Politico in ItaliaDocumento278 pagineTeatro Politico in ItaliaKatia GorbunovaNessuna valutazione finora
- PasoliniDocumento18 paginePasoliniValeria Valentina RibaudoNessuna valutazione finora
- Thesis BaschDocumento13 pagineThesis BaschRiccardo CogoniNessuna valutazione finora
- Appunti Intavolature - OdtDocumento3 pagineAppunti Intavolature - OdtCUloNessuna valutazione finora
- Roberto CalabrettoDocumento12 pagineRoberto Calabrettoanon_909918698Nessuna valutazione finora
- Musica e Cervello (Music and Brain)Documento8 pagineMusica e Cervello (Music and Brain)Marco SuraceNessuna valutazione finora
- Guide Alla Musica Di Christoph Wolff - Bach PDFDocumento474 pagineGuide Alla Musica Di Christoph Wolff - Bach PDFJoeJonesNessuna valutazione finora
- Introd Uzi OneDocumento13 pagineIntrod Uzi Oneliszt_brNessuna valutazione finora
- Saggi AntropologiaDocumento4 pagineSaggi AntropologiaRoberto IacuzioNessuna valutazione finora
- La Retorica - Tesi Di Laurea Alessandro BonettiDocumento147 pagineLa Retorica - Tesi Di Laurea Alessandro BonettiGrulletto GrulloneNessuna valutazione finora
- Gli Strumenti Musicali Nei Salmi - M.B.ZorziDocumento16 pagineGli Strumenti Musicali Nei Salmi - M.B.Zorzif7gmailNessuna valutazione finora
- Quartetto D'archiDocumento4 pagineQuartetto D'archistef1234567890Nessuna valutazione finora
- Clementi Muzio Vita OpereDocumento11 pagineClementi Muzio Vita OperelucacassinoNessuna valutazione finora
- Teoria Dello Stile Analisi Delle Forme Com Positive I 1 MelodiaDocumento32 pagineTeoria Dello Stile Analisi Delle Forme Com Positive I 1 MelodiaDiego MezzasalmaNessuna valutazione finora
- Linguaggio Dei Segni e IconicitàDocumento2 pagineLinguaggio Dei Segni e IconicitàPsycHomerNessuna valutazione finora
- Suonodonne Newsletter 08Documento3 pagineSuonodonne Newsletter 08Simon UkaNessuna valutazione finora
- Ts1016 (Roberto Caetani) L Improvvisazione Musicale in MusicoterapiaDocumento44 pagineTs1016 (Roberto Caetani) L Improvvisazione Musicale in MusicoterapiaAnonymous ufe3JtPcLoNessuna valutazione finora
- La Teoria Degli Umori Dei Fluidi Corporei Al ComportarsiDocumento53 pagineLa Teoria Degli Umori Dei Fluidi Corporei Al ComportarsiDebora Corbucci PetersNessuna valutazione finora
- Aspetti Della TragediaDocumento113 pagineAspetti Della TragediaAlfredo Luigi CornacchiaNessuna valutazione finora
- Benedetto Marcello - Il Teatro Alla Moda (1720)Documento52 pagineBenedetto Marcello - Il Teatro Alla Moda (1720)PippoNessuna valutazione finora
- Il Suono e L'immagine Capitoli 4-5Documento6 pagineIl Suono e L'immagine Capitoli 4-5Pietro Di MariaNessuna valutazione finora
- TostiDocumento4 pagineTostiLillaliNessuna valutazione finora
- Bela Bartok - Catalogo Delle Opere Con Guide All'ascolto e Link A YouTubeDocumento223 pagineBela Bartok - Catalogo Delle Opere Con Guide All'ascolto e Link A YouTubenilalienumNessuna valutazione finora
- Scuola Di FrancoforteDocumento8 pagineScuola Di Francoforte_fiacoNessuna valutazione finora
- Metodo Di AguadoDocumento2 pagineMetodo Di AguadoAndrea BiancoNessuna valutazione finora
- Tesi MusicaleDocumento66 pagineTesi MusicaleMauro MarcheseNessuna valutazione finora
- Tesi 15Documento6 pagineTesi 15Massimo PizziraniNessuna valutazione finora
- Beghelli Che Cosa Dicono Travature VivaldianeDocumento4 pagineBeghelli Che Cosa Dicono Travature VivaldianeMyriam TokerNessuna valutazione finora
- Il Discorso Musicale Scritti Su Monteverdi Bach e MozartDocumento1 paginaIl Discorso Musicale Scritti Su Monteverdi Bach e MozartJoel CardosoNessuna valutazione finora
- Decreto Ministeriale 382 Dell'11 Maggio 2018 - Armonizzazione Della Filiera MusicaleDocumento6 pagineDecreto Ministeriale 382 Dell'11 Maggio 2018 - Armonizzazione Della Filiera MusicalepidoNessuna valutazione finora
- Appunti Di Semiografia MusicaleDocumento5 pagineAppunti Di Semiografia MusicaleRosario CaponnettoNessuna valutazione finora
- La Scuola Nazionale Russa e Il Gruppo Dei CinqueDocumento12 pagineLa Scuola Nazionale Russa e Il Gruppo Dei CinqueViktoria MeyerNessuna valutazione finora
- Neoclassicismo in Musica e I CompositoriDocumento3 pagineNeoclassicismo in Musica e I CompositoriCaterina DellaereNessuna valutazione finora
- SemiografiaDocumento10 pagineSemiografiamarioNessuna valutazione finora
- Meucci - FondamentiDocumento17 pagineMeucci - FondamentiSerena CanevaNessuna valutazione finora
- La Dimensione Europea Dell'educazioneDocumento49 pagineLa Dimensione Europea Dell'educazioneTommaso ImperioNessuna valutazione finora
- Tesi Chiara PellegattaDocumento50 pagineTesi Chiara PellegattaGraziaPellegattaNessuna valutazione finora
- L'educazione Estetico-Musicale Fra Psicologia e Neuroscienze. Musica DomaniDocumento4 pagineL'educazione Estetico-Musicale Fra Psicologia e Neuroscienze. Musica DomaniOksana TverdokhlebovaNessuna valutazione finora
- Alfonso D'Avino Chitarra - Promo Guida Allo Studio Della Tecnica ChitarristicaDocumento4 pagineAlfonso D'Avino Chitarra - Promo Guida Allo Studio Della Tecnica Chitarristicaorphenica2002100% (1)