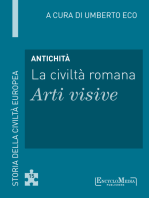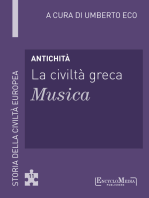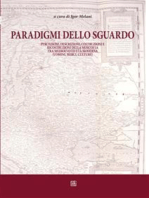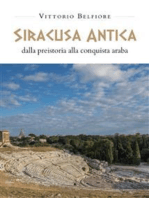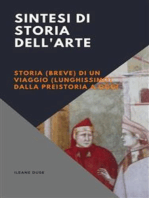Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
EAA IV SV Iconografia Trasmissione Delle Iconografie
Caricato da
VirgoMoreCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
EAA IV SV Iconografia Trasmissione Delle Iconografie
Caricato da
VirgoMoreCopyright:
Formati disponibili
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
Trasmissione Delle Iconografie
Enciclopedia dell' Arte Antica - stampa
TRASMISSIONE DELLE ICONOGRAFIE (v. vol. iv, p. 84, s.v. Iconografia). - Egitto e
Vicino Oriente. - L'iconografia, prescindendo dalla definizione di E. Panofsky, viene qui
intesa come analisi di tutto ci che concerne il significato delle immagini: la loro
ermeneutica. Sulla base di questa definizione, le immagini appaiono come elementi del
vissuto, della realt politica, sociale e culturale delle societ che in esse si riflettono. E come
tali esse esprimono messaggi differenti o quanto meno valorizzati in maniera diversa
secondo l'epoca, l'area, il modo e il mezzo di espressione. La storia dei motivi e della loro
trasmissione si lega, oltre che al contesto storico, a quella dei generi nei quali la
produzione artistica si esprime.
L'articolazione per generi, che ha una sua realt concreta, nel caso specifico dell'antico
Oriente tale da richiedere che le categorie vengano tenute in conto nella considerazione
delle espressioni artistiche. La tipologia, infatti, indica le condizioni entro le quali il processo
creativo opera, le tradizioni ambientali che incontra e il modo nel quale con queste si
confronta; i fattori economici, politici e religiosi dai quali l'artista non pu prescindere.
La stessa specializzazione artigianale e le funzioni politico-religiose della produzione, che
attestano il primo rapporto permanente tra committente e produttore dell'arte,
favoriscono l'emergere di tendenze che portano alla costruzione di patrimoni di conoscenze
e di esperienze. La mancanza della coscienza dell'individualit dell'arte e della sua
autonomia alla base dell'aderenza alla tradizione, che sembra caratterizzare il Vicino
Oriente, contrapposto alla Grecia. Tradizione che intesa come modello di riferimento,
complesso di scelte tematiche, tecniche e talora stilistiche, di moduli iconografici, ai quali gli
artisti erano tenuti a conformarsi per motivazioni legate alle funzioni della stessa arte e
delle sue finalit, derivanti dalla originaria tipica natura palaziale-templare e quindi
religioso-votiva. E ancora nelle interconnessioni che caratterizzano l'arte del Vicino
Oriente, l'impronta formativa delle c.d. civilt superiori si conserva appunto nell'eredit di
un patrimonio figurativo di tradizione millenaria, che viene trasmesso diacronicamente, sia
pure mediato, anche in Occidente.
evidente che la canonizzazione del modello originario, legato al potere politico
assolutistico che lo ha espresso, viene meno nel corso dell'irradiazione; il motivo
iconografico subisce inevitabilmente innovazioni, alterazioni, evoluzioni legate anche alla
sua utilizzazione nei diversi generi artistici, dai maggiori (rilievo in senso lato) ai minori
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
1/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
(glittica, oreficeria, ecc.), che ne sfumano o ne alterano, fino eventualmente a vanificarlo,
l'originario significato storico o simbolico-religioso a favore di una valenza pi decorativoornamentale.
Considerate l'enorme ampiezza della documentazione in senso areale e cronologico nonch
la mancanza di omogeneit delle testimonianze, inevitabile limitarsi a qualche
esemplificazione del discorso fin qui condotto. Si prenda uno schema tipico come quello del
faraone che afferra per i capelli il nemico vinto e lo abbatte. Le numerose ripetizioni del
soggetto fin dagli iniz della storia (la paletta di Narmer e i rilievi rupestri lasciati dai
primi faraoni nella penisola del Sinai) rivelano in Egitto l'indubbio intento propagandistico
della figurazione; anche l'immagine del vincitore che prende come un mazzo i nemici un
ulteriore esempio del medesimo schema, nato in Egitto per il desiderio di esaltare le
conquiste effettuate, e poi trasmesso con realizzazioni diverse in tutto l'Oriente antico. A
questo stesso prototipo egiziano, attraverso il repertorio iconografico del Nuovo Regno,
risale il modello che appare riprodotto sulle coppe fenicie del VII sec. a.C.: l'immagine, per
quanto preminente, ha carattere allusivo e simbolico che trasfigura l'originaria realt
storica dell'iconografia, anche se forse non da escludere un'intenzionale ripresa del motivo
in funzione politica, in concomitanza con le direttive della dinastia saitica.
La scena, frequente nell'arte mesopotamica, dell'eroe che abbatte un mostro, emblema
delle forze distruttrici della natura, ha una realt simbolico-religiosa, al pari del motivo del
giovane in lotta con il grifone, che tanta parte ha nella documentazione mediterranea di
ambito egeo-cipriota e fenicio. Indipendentemente dal fatto che alla base della
raffigurazione vi siano una o pi narrazioni mitologiche, che l'eroe sia Gilgame, o il Daniele
della Leggenda di Aqhat o l'egiziano Inaro o ancora il Royal Hero, evidente che il
motivo, pur con le diversit iconografiche legate alla stratificazione o alle varianti delle
tradizioni locali ovvero alle attestazioni su diversi media artigianali (avor, gioielli, glittica,
toreutica, ecc.), conserva una sua costante e precipua valenza simbolica, che esula dalla
definizione temporale e che comunque pu essere applicata anche a casi specifici e a
ispirazioni concrete con uguale valore semantico. In tal senso pu essere esemplificativa la
lettura dell'iconografia quale Eracle in lotta con il leone nemeo, che appare sia nelle coppe
fenicie sia nella glittica di epoca punica accanto alla forma pi aderente ai moduli originali.
Altrettanto significativa l'iconografia della sfinge. La sua immagine in Egitto simboleggia
la potenza e la saggezza riunite nella persona del faraone, del quale quasi sempre la sfinge
la rappresentazione. In virt del suo stretto legame con la simbologia regale, nell'area
asiatica la sua figura viene presto adottata e adattata in versione anche femminile da
diversi generi artistici, che vanno dal rilievo alla scultura sia in pietra sia in avorio.
In ambiente fenicio la sfinge presente in diverse categorie artigianali (avor, gioielli,
glittica), ove conserva molti degli attributi originali egiziani (doppia corona, barba, ecc.) che
ne rivelano la lettura in chiave regale, come sembra suggerire anche il passo di Ezechiele
(28, 11-14), nel quale il profeta utilizza la sfinge quale simbolo della potenza del re di Tiro.
Ed principalmente attraverso i generi dell'avorio di scuola fenicia e delle coppe, ai quali
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
2/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
affidato il patrimonio culturale classico proprio dei Fenici, che l'iconografia egiziana,
assieme a motivi assiri ed egei, viene inizialmente trasmessa nell'Occidente, ove passa
come eredit comune dell'Oriente antico. Le tematiche di remota origine orientale si
diffondono quindi nel mondo occidentale attraverso il fenomeno dell'irradiazione sia diretta
sia mediata e in conformit alle esigenze della committenza e alle richieste di un mercato
molto differenziato e totalmente estraneo alle realt culturali che le hanno originariamente
create ed espresse.
Bibl.: M. Th. Barrelet, Les desses armes et ailes, in Syria, XXXII, 1955, pp. 222-259;
E. Panofsky, Il significato nelle arti visive, Torino 1962; P. Matthiae, Il motivo della vacca
che allatta nell'iconografia del Vicino Oriente antico, in RivStOr, XXXVII, 1962, pp. 1-31;
R. L. Scranton, Aestetic Aspects of Ancient Art, Chicago-Londra 1964; A. M. Bisi, Il
grifone. Stona di un motivo iconografico nell'Antico Oriente mediterraneo (Studi
semitici, 13), Roma 1965; W. Stevenson Smith, Interconnections in the Ancient Near
East, New Haven-Londra 1965; S. Moscati, Apparenza e realt. Arte figurativa
nell'Antico Oriente, Milano 1976; E. Acquaro, Arte e cultura punica in Sardegna, Sassari
1984, pp. 94-103; G. Markoe, Phoenician Bronze and Silver Bowls from Cyprus and the
Mediterranean, Berkeley-Los Angeles 1986; D. Ciafaloni, Eburnea Syrophoenicia (Studia
Punica, 9), Roma 1992; C. Doumet, Un motif sumrien sur un cachet phnicien:
archasme ou modernit, in Akkadica, 81, 1992, pp. 29-36; G. Pisano, Una sfinge in osso
da Cadice, in RStFen, XXI, 1993, Suppl., pp. 63-73; D. Ciafaloni, Iconographie et
iconologie, in AA.W., La civilisation phnicienne et punique. Manuel de recherche, LeidaNew York-Colonia 1995, pp. 535-539.
(G. Pisano)
Grecia e Mondo romano. - Il problema della t. i. non pu andare disgiunto da quello delle
modalit di formazione e diffusione di una cultura figurativa: in questo i due termini della
questione appaiono strettamente interrelati. Per cultura figurativa si intende un sistema
di immagini realizzate in base alle esigenze di una committenza - in un primo tempo
esclusivamente religiosa e politica, successivamente anche privata - che suggerisce
tematiche epico-mitiche ovvero storico-politico-sociali (Hlscher, 1987).
Una cultura figurativa si forma per creazione (intendendo con tale termine l'invenzione e
la realizzazione di un'opera specifica che costituisca l'inizio di una serie), standardizzazione
(vale a dire ripetizione seriale di un modello) e trasmissione del modello stesso, che viene
scelto non tanto per il suo valore storico-artistico quanto piuttosto per la sua
comprensibilit e funzionalit (Settis, 1989; Bejor, De Maria, Frugoni, Ghedini, 1993).
Opere di grande respiro sono rimaste confinate nell'ambito di una ristretta cerchia di
fruitori e non sono state n copiate n imitate, mentre creazioni artigianali si sono imposte
e hanno trovato diffusione sia all'interno di una determinata koin culturale sia al suo
esterno.
Il problema della t. i. deve dunque essere indagato non tanto frammentandolo in ambiti
culturali diversi (cultura greca, etrusco-italica, romana), quanto esaminando i presupposti
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
3/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
e le modalit secondo cui tale fenomeno si realizzato; il che ci porta a distinguere in primo
luogo fra produzione a tutto tondo e produzione bidimensionale, ovverosia fra
composizione semplice (una o al massimo due iconografie) e complessa (pi iconografie
inserite in un contesto narrativo).
La t. i. nell'ambito della produzione a tutto tondo di grandi dimensioni avveniva
sostanzialmente attraverso il sistema della copia da un modello (calco in gesso, copia ai
punti, ecc.: v. copie e copisti), mentre nel caso di prodotti di piccole dimensioni (terrecotte
e bronzi) poteva realizzarsi attraverso l'utilizzo della medesima matrice, eventualmente
riprodotta ed esportata, oppure attraverso la riproduzione a occhio o addirittura a
memoria di modelli consolidati.
La larga circolazione dei manufatti di piccole dimensioni, spesso ispirati alle creazioni
statuarie dei grandi maestri greci, contribu grandemente alla diffusione del patrimonio
figurativo che in tal modo veniva acquisito da strati sempre pi larghi di possibili
committenti.
Attraverso tale diffusione capillare, a cui si deve aggiungere l'ampia circolazione delle copie
delle sculture pi rinomate e dei calchi in gesso delle stesse (Landwehr, 1985; De Maria,
1993, p. 229; Barone, 1994), si giunse alla formazione di un patrimonio figurativo
ampiamente condiviso dalla committenza.
Una bottega di scultori poteva dunque proporre al cliente un campionario di statue o
statuette oppure di bozzetti, ma anche creare su commissione del cliente un'opera nuova
che ricalcava, o meno, schemi o modelli largamente noti. Ne consegue che, se il proprietario
di una villa desiderava esporre nel suo giardino la ninfa con conchiglia, non era necessario
che si utilizzasse un calco o una riproduzione in scala del modello originario, in quanto esso
apparteneva al patrimonio figurativo sia del committente sia dell'artigiano. La nuova
creazione poteva dunque essere riprodotta a memoria e ci rende ragione delle varianti
spesso assai significative che interessano modelli consolidati e che riguardavano
eventualmente ponderazione, attributi, acconciatura e altro.
Il problema risulta ben pi complesso quando si passi dalla produzione a tutto tondo a
quella bidimensionale, in quanto questa per lo pi caratterizzata da composizioni
articolate, in cui si trovano ad agire diversi personaggi spesso inseriti in un contesto preciso
e caratterizzante.
E proprio sulla produzione a carattere narrativo (e in particolare sui mosaici) si fissata
l'attenzione degli studiosi e si aperta una querelle che vede contrapposti i sostenitori di
una trasmissione che potremmo definire spontanea, in cui le analogie compositive
vengono giustificate sulla base di una cultura figurativa comune diffusa grazie alla mobilit
di oggetti e persone (artigiani, committenti; Bruneau, 1984), e quelli che sostengono invece
l'ipotesi di una trasmissione intenzionale, basata cio sulla riproduzione volontaria e
possibilmente puntuale di un modello specifico, il quale pu essere copiato direttamente
dall'archetipo oppure tramite un intermediario tecnico (v. infra) realizzato in funzione della
trasmissione iconografica.
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
4/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
Fermo restando che uno dei fattori determinanti di persistenza e diffusione degli schemi fu
senz'altro l'apprendistato presso le botteghe, dove si insegnava ai giovani a riprodurre, fino
quasi a giungere all'automatismo, i diversi modelli, sembra ora necessario cercare di
definire il diverso grado di incidenza sulla formazione di un repertorio di immagini di tutti
quei vettori che sono chiamati generalmente in causa per giustificare analogie o identit
iconografiche. Questi sono: la tradizione letteraria con le illustrazioni librarie; gli artigiani
itineranti; gli oggetti mobili (stoffe, vetri, manufatti toreutici, produzione ceramica,
emblmata, sarcofagi); gli intermediar tecnici (modelli in gesso, cartoni, punzoni).
1. Tradizione letteraria. - L'incidenza della tradizione epico-mitica sulla formazione del
patrimonio iconografico classico fenomeno ampiamente noto e indagato: essa appare
infatti fonte primaria di ispirazione forse gi nel Tardo Geometrico, certamente a partire
dal primo arcaismo e poi via via, seguendo le nuove creazioni e le diverse redazioni dei miti,
fino a et tardoantica. Ci premesso, va tuttavia sottolineato che non altrettanto
chiaramente definiti appaiono da un lato il livello di dipendenza delle immagini dai testi
(formazione), dall'altro la funzione del testo stesso nella diffusione di uno schema figurativo
(trasmissione: cfr. Lavagne, 1978; Baldassarre, 1981; Gury, 1986). Se infatti appare
indubitabile che la narrazione omerica sia servita come fonte di ispirazione per la creazione
sia di raffigurazioni singole sia di interi cicli figurativi (basti ricordare la serie di tabulae
iliache, opera di Theoros di Samo: Plin., Nat. hist., xxxv, 144; sui cicli epici e mitici v.
Horsfall, 1983, p. 213), altrettanto documentato che spesso la redazione figurativa si
stacca in maniera anche sostanziale dal testo. Se consideriamo episod come il
trascinamento del corpo di Ettore, non si pu non notare che nella ceramica attica, ma
anche in molte testimonianze posteriori, viene aggiunto un personaggio del tutto estraneo
alla tradizione omerica, vale a dire l'auriga Automedonte (Kossatz-Deissmann, 1981, n. 585
ss., passim); ci pu dipendere dal fatto che l'immagine si ispirata a una narrazione
diversa da quella omerica oppure che alla sua formazione hanno contribuito altre
componenti, quali p.es. la suggestione della pratica bellica contemporanea che
presupponeva che il guerriero fosse accompagnato dal suo auriga. Analogamente, la scena
del riscatto resa nella ceramica arcaica con la raffigurazione di Achille disteso sulla klne,
secondo un costume introdotto in Grecia in et ben posteriore rispetto a quella in cui si
formato l'episodio epico (Kossatz-Deissmann, 1981, n. 643 ss.; Ghedini, 1993, p. 162 ss.):
anche in questo caso il riferimento al costume coevo travalica sulla narrazione poetica.
Sembra dunque che in taluni casi la tradizione letteraria fornisca solamente il tema senza
influenzare minimamente la resa figurativa, che presenta soluzioni autonome. Di
conseguenza, perch sia possibile ritenere che un'immagine dipenda da una specifica
narrazione, essa deve puntualmente riprodurre i particolari caratterizzanti forniti dalla
narrazione stessa.
Per stabilire relazioni precise fra un dato testo e una data immagine necessario anzitutto
che il testo presenti elementi caratterizzanti che consentano di istituire con la redazione
figurativa un rapporto sicuro. Se infatti analizziamo p.es. la tradizione iconografica relativa
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
5/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
al rapimento di Europa da parte di Giove in forma di toro, non possiamo fare a meno di
ipotizzare che le numerose raffigurazioni comprendenti un toro (stante, accovacciato,
natante, ecc.) e una fanciulla (stante accanto all'animale oppure a cavalcioni su di lui, ecc.;
Robertson, 1988) siano da porre in relazione con la tradizione narrativa; e tuttavia risulta
altrettanto evidente che non appare possibile legare l'immagine al testo a causa della
genericit delle indicazioni letterarie che, se anche talvolta descrivono l'abbigliamento della
fanciulla, i gesti, l'ambientazione, danno tuttavia egualmente adito a varianti figurative
anche importanti. Inoltre la precoce fortuna dello schema della fanciulla a cavalcioni del
toro consente di ipotizzare una sua trasmissione autonoma attraverso la tradizione
figurativa senza il continuo ricorso alla descrizione letteraria.
Diversamente, quando si tratta di miti poco noti o di episod di nuova creazione, talvolta
possibile individuare uno specifico testo che pu essere posto alla base di una tradizione
figurativa. Nel caso p.es. del gruppo di affreschi pompeiani riproducenti l'episodio di
Piramo e Tisbe in una versione che sembra attestata per la prima volta in Ovidio (Met., iv,
55 ss.), difficile non ritenerli copia di una creazione esemplata proprio sul testo ovidiano
(Baldassarre, 1981).
Anche nel caso dei due mosaici di Aix-en-Provence e Villelaure con la raffigurazione
(altrimenti non documentata) del combattimento fra Darete ed Entello, il riferimento alla
narrazione virgiliana cos puntuale da consentirci di ipotizzare che un colto committente
abbia voluto, per ragioni che oggi ci sfuggono, eternare proprio quello specifico e poco noto
episodio dell'Eneide, che godette di una certa rinomanza nella tradizione letteraria tarda
(Polverini, 1984), ma di poca o nulla fortuna iconografica (Lavagne, 1978 e 1994).
Lo stretto legame che unisce testo e immagine particolarmente ben esemplificato dalle
raffigurazioni riconducibili alla tradizione teatrale: dalla ceramica attica a quella
magnogreca, dai sarcofagi ai prodotti di lusso, dagli affreschi ai mosaici troviamo
innumerevoli testimonianze di iconografie teatrali (Webster, 1960, 1961 e 1962; Trendall,
Webster, 1971; Moret, 1975, pp. 260-272; Burkhalter, Arce, 1984; per ulteriori
approfondimenti e bibl. v. anche il paragrafo successivo Illustrazioni di libri). D'altronde il
testo teatrale, per sua stessa natura destinato a essere tradotto in immagini, meglio di altri
si prestava a una redazione figurativa, la quale poteva anche essere ulteriormente
influenzata dalle rappresentazioni vere e proprie.
Meno chiara appare invece la funzione dell'kphrasis nella formazione del patrimonio
iconografico: infatti assai difficile stabilire se la descrizione di un'opera, spesso puntuale e
minuziosa, nascesse dall'osservazione di un monumento reale, costituisse modello per una
redazione figurativa oppure, infine, fosse mera esercitazione retorica (sul problema v. da
ultimo Heffernan, 1991, pp. 297-316; Zeitlin, 1994, pp. 138-196; Goldhill, 1994, pp. 197223; Bryson, 1994, pp. 255-283).
Se prendiamo la descrizione della merenda all'aperto dopo la caccia, che costituiva
l'elemento centrale del quadro intitolato I cacciatori, descritto da Filostrato Minore
(Imag., 3), non si pu non notare la somiglianza in numerosi particolari con monumenti di
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
6/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
poco posteriori, quali il mosaico di Piazza Armerina o il piatto di Seuso: il retore parla infatti
di cinque commensali sdraiati su uno stibadium, di reti appese agli alberi, di servi
affaccendati, di una polla d'acqua in primo piano, elementi tutti che ritroviamo nelle citate
raffigurazioni in cui ritorna anche il commensale che offre un boccone al suo cane (Ghedini,
1992, p. 81). In tal caso Filostrato potrebbe aver tratto ispirazione da un quadro realmente
esistente oppure - ma ci sembra meno plausibile - il suo testo potrebbe essere servito da
modello per una qualche composizione, poi variamente imitata nei secoli successivi da
mosaicisti, pittori, toreuti, tessitori, ecc. Ma se risulta difficile stabilire un rapporto di
priorit fra testo e immagine, sembra invece indubitabile che la descrizione filostratea
abbia contribuito alla fortuna di un soggetto che stava diventando di moda anche grazie al
trasparente significato di autorappresentazione sociale che era venuto assumendo (per
tutto il problema v. ancheEKPHRASIS).
In conclusione si pu affermare che il ruolo della tradizione letteraria pu essere
considerato determinante non solo per la formazione di un'iconografia (ricordiamo a tale
proposito che Gregorio di Tours nella sua Historia Francorum, II, 17, descrive la
committente mentre tiene un libro in grembo e in esso legge historias actionis antiquas,
pictoribus indicans quae in parietibus fingere deberent), ma anche per la diffusione di un
tema. Del tutto ininfluente appare invece la tradizione letteraria nella trasmissione di una
determinata iconografia: infatti la lettura di un testo, anche se semplice e fortemente
caratterizzato, pu dare luogo a una variet quasi infinita di soluzioni (cfr. supra le
considerazioni relative a Europa; v. anche le diverse versioni di Danae nella pittura
pompeiana: Andersen, 1985, p. 119).
Accettato il presupposto che per riprodurre una determinata raffigurazione necessario
conoscere direttamente l'originale o almeno una sua riproduzione, ne consegue che un testo
poteva al pi avere la funzione di richiamare un'immagine, a patto che questa fosse gi
entrata a far parte del patrimonio figurativo collettivo o personale; in tal caso l'artigiano
poteva decidere di riprodurla a memoria, di copiarla da altro monumento figurativo oppure
di ricrearla liberamente secondo la sua sensibilit.
Illustrazioni di libri. - I libri possono essere serviti anche da vettori pi specifici per la
trasmissione di determinati schemi figurativi grazie alle illustrazioni che a partire dall'et
ellenistica sembrano aver arricchito prima i testi scientifici poi quelli letterari (Horsfall,
1983; Cavallo, 1989).
Nell'ambito delle illustrazioni di libri dobbiamo tuttavia distinguere fra le raffigurazioni
schematiche che troviamo nei testi pi antichi (v. p.es. Papyrus Oxyrinchi, 22.2331;
Cavallo, 1991, fig. 250; Andersen, 1985), le quali appaiono poco pi che silhouettes
(Cavallo, 1989, p. 717), e quelle pi articolate e complesse, di cui abbiamo testimonianza a
partire dal II sec. d.C. sia su papiro (v. p.es. il frammento di rotolo del II sec. d.C. con la
raffigurazione al tratto di Amore e Psyche: PSI, 919; Cavallo, 1989, fig. 30; il papiro
Monacense 128 del IV sec. d.C. con labductio di Briseide, raffigurata sempre al tratto:
Frangini, Martinelli, 1981, p. 4 ss.; il papiro da Antinoe della met del V sec. con un gruppo
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
7/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
di aurighi effigiati a colori: Turner, 1973, p. 192 ss.; ulteriori riferimenti in Weitzmann,
1981, p. 48), sia su pergamena (basti ricordare tra l'altro lIliade Ambrosiana, la Itala di
Quedlinburg, la Genesi di Vienna, il Virgilio Vaticano).
Le dimensioni ragguardevoli delle raffigurazioni sopra citate, che talvolta si espandevano
fino a occupare l'intera pagina (Cavallo, 1989, p. 718, con bibl. sul problema), unitamente
alla chiara indicazione di particolari specifici e caratterizzanti (gesti, ambientazione, colori,
ecc.), ne fanno certamente vettore privilegiato, soprattutto in et tardoantica, non solo
per la diffusione dei temi ma anche per la conoscenza di certe soluzioni iconografiche.
L'interscambio fra le illustrazioni dei testi e le testimonianze monumentali risulta
particolarmente evidente qualora si passino in rassegna le raffigurazioni di soggetto
teatrale: in questo caso infatti accanto a scene genericamente ispirate ai diversi episodi
(che possono essere inserite in quelle esaminate al paragrafo precedente), troviamo
composizioni la cui dipendenza dall'illustrazione di libri sembra suggerita o dall'apposizione
dei nomi dei protagonisti o da precise citazioni di interi brani di dialogo oppure
dall'indicazione di elementi tipici del repertorio teatrale (strutture sceniche, personaggi
mascherati, gestualit accentuata, ecc.: Weitzmann, 1981, p. 45 ss.).
La ricchezza delle testimonianze rende impossibile un'esemplificazione esaustiva. Ci
limiteremo pertanto a ricordare:
le coppe a rilievo ellenistiche (c.d. coppe megaresi; Sinn, 1979; Weitzmann, 1981, p. 45 ss.,
figg. 1-2);
un bicchiere di vetro a Los Angeles (Weitzmann, 1981, p. 39 ss.);
gli affreschi del columbarium di Villa Doria Pamphilj;
il coperchio di sarcofago a Napoli (Schefold, 1976, p. 799, fig. 2);
i mosaici della Casa del Menandro a Mitilene (Kharitonidis, Kahil, Ginouvs, 1970);
alcuni mosaici e affreschi pompeiani (Weitzmann, 1981, p. 43; Ling, 1991, figg. 235-236);
un mosaico da Oscus (Ivanov, 1994, tav. lxxxii);
alami affreschi di Efeso (Strocka, 1977, p. 53 ss., figg. 62-69, in particolare n. 85);
un mosaico a Fuente Alamo (Daviault, Lancha, Lpez Palomo, 1987);
gli affreschi della Tomba dei Ludi a Cirene (Bacchielli, 1993, p. 91 ss.).
In tutti i casi citati il riferimento teatrale stato ampiamente provato e l'ipotesi che le
immagini dipendano da illustrazioni di testi piuttosto che da rappresentazioni sceniche,
appare senz'altro plausibile.
Pi complesso si presenta il problema qualora si cerchi di distinguere, nell'ambito delle
raffigurazioni epico-mitologiche o cristiane, tra quelle che possono dipendere da vignette e
quelle liberamente ispirate alla narrazione (cfr. paragrafo precedente). Un'indicazione pu
venire dall'analisi delle modalit della narrazione: vale a dire quando la scena presenta
carattere riassuntivo, cio contiene in s spunti che consentano di ricostruire in sequenza
gli antefatti o le conseguenze del momento raffigurato (cfr. Meyboom, 1978:
Complementary Method), essa pu essere pi plausibilmente inserita fra quelle in cui il
testo appare determinante solo nella fase della formazione dell'immagine (Baldassarre,
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
8/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
1981), mentre quando la raffigurazione fissa un momento unico dell'azione, secondo il modo
che stato definito monoscenico, allora pu forse essere ricollegata al modello librario,
dal momento che una delle caratteristiche delle vignette dei libri consiste proprio
nell'istantaneit della narrazione.
Un ulteriore e pi sicuro indizio di dipendenza dalle illustrazioni di testi pu essere fornito
dalle citazioni letterarie apposte, a mo' di didascalia, alla raffigurazione stessa.
Sulla base di queste considerazioni potremmo ritenere riproduzione di illustrazioni da libro
il mosaico di Carranque con scene desunte dalle Metamorfosi di Ovidio (Fernandez
Galiano, 1994), gli affreschi pompeiani e il mosaico di Themetra illustranti la metamorfosi
di Aci, il mosaico di Low Ham con l'arrivo di Enea a Cartagine, il mosaico di Mopsuestia con
la storia di Sansone (Kitzinger, 1973, pp. 133-344), il tessuto di Sens con storie di Giuseppe
(Cavallo, 1991, fig. 252).
A ulteriore conferma dell'ipotesi che pittori e mosaicisti abbiano talvolta utilizzato vignette
da libri, possiamo ricordare che Sant'Agostino (Civ., 16,8 = 135, 24 D) descrive alcuni
mosaicisti intenti a decorare la platea maritima di Cartagine con immagini mostruose
deprompta ex libris velut curiosioris historiae.
2. Artigiani itineranti. - Vettori di cultura figurativa furono certamente gli artigiani che si
spostavano da una citt o da una provincia all'altra portando con s il proprio bagaglio di
conoscenze tecniche e figurative, il quale andava mano a mano arricchendosi anche grazie
alle nuove esperienze. Il ritrovare in aree lontane lo stesso schema iconografico pu perci
essere spiegato ipotizzando la presenza di un artigiano itinerante, che riproduceva a
memoria un'opera vista altrove, oppure realizzava per committenti diversi la medesima
raffigurazione ( ormai noto che gli antichi non erano ossessionati come noi dal presupposto
dell'originalit); tale opera poteva poi, successivamente, venire copiata fedelmente (o con
modifiche) dagli artigiani del luogo (nell'ambito della stessa o di una diversa manifattura
artigianale), dando origine a due serie parallele, ma sostanzialmente indipendenti in quanto
riferibili a due archetipi diversi, pur se opera di uno stesso artigiano.
Gli spostamenti di scultori e pittori di et arcaica e classica sono ben noti e attestati dalle
fonti; tale pratica si generalizz ovviamente in et ellenistica, grazie al moltiplicarsi dei
centri di potere e all'allargarsi della clientela, come conferma, p.es., la carriera di famiglie di
scultori quale quella di Timarchides (v.), le cui peregrinazioni tra Atene e Roma sono state
oggetto di attenta ricostruzione (v. da ultimo Queyrel, 1991, pp. 448-464).
La forza di attrazione di Roma convogli nella capitale, fra III e I sec. a.C., le firme pi
rinomate nei var campi della produzione artistica; successivamente, fra la tarda
repubblica e il primo impero, durante la grande fase espansionistica, si registra anche un
notevole flusso, dall'Italia verso le provincie, di botteghe artigianali che ponevano
tecnologia e cultura figurativa al servizio della nuova ricca committenza che desiderava
allinearsi allo standard di vita della capitale.
Non desta pertanto meraviglia il ritrovare a Cirta mosaici che possiamo ipotizzare eseguiti
da maestranze campane, giunte in Africa al seguito di quel Sittius di Nocera che ebbe in
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
9/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
dono da Cesare una piccola porzione di territorio per i suoi servizi (Dunbabin, 1978, p. 255
s.). Sempre restando nell'ambito del mosaico si pu ancora ricordare che i legami che
uniscono la produzione africana, almeno fino a et flavio-traianea, a quella italica oppure
quella aquileiese a quella gallica sono stati spesso giustificati proprio con l'ipotesi di
spostamenti di botteghe artigianali (Darmon, 1981, p. 292 s.; Lancha, 1983; Joly, 1988; sui
mosaicisti itineranti v. anche Daviault, Lancha, Lopez Palomo, 1987, p. 54; Donderer,
1989).
Una conferma epigrafica dell'esistenza di artigiani itineranti ci viene dall'iscrizione di
Savaria (CIL,III 4222), in cui sono ricordati pictores peregrini (si ricordi anche l'epitafio di
Perinto: Bruneau, 1988, p. 67; ulteriori riferimenti in Ling, 1991, p. 214).
Il costume divenne cos generalizzato in et tardo-antica da lasciare addirittura traccia
nella legislazione: una costituzione emanata da Costantino nel 337 esentava dall'obbligo di
residenza diverse categorie di artigiani, fra cui sono espressamente ricordati gli architecti, i
pictores, gli statuari!, i marmorari, i laquearii, gli Sculptores, i musivarii, ecc. (Cod.
Theod., XIII, 4,2), mentre nel 374 Valentiniano concesse ai pittori, oltre a una serie di
esenzioni, la possibilit di mutare il proprio domicilio a piacimento (Cod. Theod., XIII, 4,4;
sugli artigiani itineranti in et tardoantica v. Sodini, 1979).
A ulteriore conferma della mobilit dei tecnici e degli artigiani tardoantichi ricordiamo
anche la richiesta che Teoderico inoltr ad Agapito, prefetto di Roma, che gli fossero inviati
marmorarios peritissimos per restaurare la Basilica Herculis a Ravenna (Epistulae, I, 6);
analogamente Gregorio di Nissa si fece mandare da Anfilochio, vescovo d'Iconio, degli
specialisti per la costruzione di volte e Teodoreto, vescovo di Cirro, promise a Isocasio di
inviargli un ebanista, Geronzio, richiesto anche dal tribuno Euriciano (Eristov, 1987, p. 118,
nota 31, ivi referenze). D'altronde, ancora nel X sec. l'esecuzione del mosaico della Grande
Moschea di Cordova venne affidata alle capaci mani di un mosaicista fatto venire da
Bisanzio (Stern, 1976).
Quindi, se forse giusto convenire con C. Balmelle e P. Darmon che il raggio di azione delle
botteghe, soprattutto musive, poteva essere pi ridotto di quanto generalmente supposto
(Balmelle, Darmon, 1986), non si pu tuttavia troppo ridimensionare l'importanza del
fenomeno degli artisti itineranti che dall'arcaismo all'et tardoantica interess in vario
modo e con diversi gradi di intensit tutte le categorie artigianali, contribuendo non poco
alla diffusione sia di cultura figurativa sia di specifici schemi iconografici.
3. Oggetti mobili. - Vettori di cultura figurativa furono anche i manufatti, oggetto di
esportazione e commercio gi in et arcaica lungo le rotte della colonizzazione e,
successivamente, sotto la spinta di una domanda sempre pi ampia e allargata, oltre i
confini del mondo greco-romano.
In un primo tempo a far circolare le iconografie furono soprattutto i vasi, le stoffe, i bronzi,
gli avor, a cui poi si aggiunsero i prodotti di un artigianato sempre pi specializzato: vetri,
argenti, gemme, manufatti in terracotta (lucerne, coppe, lastre, ecc.) e in marmo (statue,
rilievi, sarcofagi, ecc.). Tutti questi oggetti, facilmente trasportabili, contribuirono alla
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
10/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
conoscenza non solo dei temi, ma anche di redazioni particolarmente fortunate di
determinati soggetti.
Stoffe. - L'uso di decorare le stoffe per abbigliamento e per arredo con raffigurazioni
intessute, ricamate o dipinte ne fece fin dall'et arcaica un vettore privilegiato di cultura
figurativa: i tessuti pi preziosi infatti, oltre a essere oggetto di commercio venivano spesso
esposti nei templi all'ammirazione dei fedeli (basti pensare al peplo di Atena con
raffigurazione di Gigantomachia o al mantello di Alcistene a cui il retore Polemone dedic
addirittura un breve saggio, come ci informa Ateneo, XII, 541 a-b. Inoltre tali manufatti,
che erano di facilissimo trasporto, presentavano anche il vantaggio di fornire raffigurazioni
policrome.
Le decorazioni delle stoffe arcaiche e classiche ci sono note anzitutto dalle fonti (Hom.,
Iliade, III, 125 ss.; xn, 441 ss.; Aesch., Choeph., 231 s.; Eurip., Ion, 1141 ss., 1421;
riferimenti in Ghedini, 1995), a cui si possono aggiungere alcune significative testimonianze
archeologiche e le raffigurazioni vascolari riproducenti, spesso con minuzia, le eleganti
decorazioni geometriche, fito-morfe o figurate dei tessuti da abbigliamento e arredamento:
ed grazie alle testimonianze monumentali che possibile in taluni casi stabilire rapporti
precisi fra il repertorio tessile e quello di altre manifatture (per i mosaici v. Ghedini, 1995).
La nostra conoscenza delle raffigurazioni tessili di et ellenistico-romana resta per gran
parte affidata alle testimonianze letterarie che per difficilmente consentono di istituire
raffronti iconografici a causa della genericit degli accenni. Quindi, se pure noto che il
mito di Ganimede fu frequentemente riprodotto sui tessuti, come confermano Plauto
(Men., I, 142-144), Virgilio (Aen., V, 250 ss.), Valerio Fiacco (Arg., II, 407 ss.) e Igino
(Fab., 274), tuttavia risulta impossibile stabilire una netta corrispondenza fra le
raffigurazioni tessili e le versioni pervenuteci del tema (Ganimede a terra, stante, in corsa,
in ginocchio, in volo), dal momento che le descrizioni appaiono generiche e non
sufficientemente caratterizzate sul piano iconografico.
Per l'et tardoantica la nostra conoscenza dei manufatti tessili si amplia grazie ai tessuti
rinvenuti nelle necropoli copte, che documentano una scelta tematica quanto mai ricca e
variata tale da consentire pi specifici raffronti con la tradizione figurativa coeva.
Fra i numerosi esemp che si possono citare di interscambio con altre manifatture
artigianali, ci limitiamo a ricordare quello emblematico della Venere in conchiglia retta da
Tritoni, di cui abbiamo testimonianza, oltre che sulle stoffe copte (Del Francia, 1984), nel
repertorio to- reutico e musivo (Toso, 1995). Ma accanto ai temi mitologici (Apollo e Dafne,
cicli dionisiaci, trionfo di Nettuno, Selene ed Endimione, ecc.) ampia risonanza ebbero le
raffigurazioni ispirate alla vita quotidiana, fra cui spiccano la caccia e il banchetto en plein
air, che ripropone l'iconografia di cui abbiamo gi parlato (v. supra il paragrafo tradizione
letteraria e Ghedini, 1991), pure attestata in ambito toreutico e musivo.
A tal punto il repertorio tessile appare compenetrato di iconografie classiche che in un
merletto prodotto a Venezia nel XVI sec. ritroviamo soggetti mitologici quali le fatiche di
Ercole, Atteone e i cani, Dioniso sul carro, resi in soluzioni figurative chiaramente desunte
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
11/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
dal repertorio ellenistico-romano, pervenuto probabilmente non per recupero dotto ma
per trasmissione interna alle botteghe tessili (Schmidt, 1965, tav. 395; v. anche Calcani,
1993).
Tuttavia le dimensioni spesso ridotte delle raffigurazioni inserite nei tessuti - perlomeno da
quel che risulta dalla documentazione tardoantica - unitamente alla cursoria trattazione di
molti particolari, ci induce a considerare questi manufatti vettori di cultura figurativa
piuttosto che veri e propri modelli da copiare. Analoga funzione i tessuti copti sembrano
aver svolto nella diffusione di certi schemi geometrici (cerchi inscritti in riquadri, cerchi
allacciati intorno a un elemento centrale, quadrati allacciati a formare stelle a pi punte,
ecc.), tipici della tradizione musiva tardoantica che condivideva con il repertorio tessile
anche il gusto per le bordure geometriche o vegetalizzate (a trecce, a onde correnti, girali
d'acanto, ecc.; Cantino Wataghin, 1990).
Vetri. - Vetri cammei, vetri incisi, dipinti, smaltati, dorati presentano un repertorio
figurato quanto mai ricco e variato, ispirato in parte alla tradizione epico-mitica, in parte
alla vita quotidiana (scene di battaglia, di caccia, ludi gladiator, venationes, corse nel circo,
ecc.; Harden, 1987).
Il raffronto con la tradizione figurativa coeva rende evidente l'interscambio sia tematico sia
compositivo soprattutto con quelle classi di manufatti in cui meglio si esprimeva l'ideologia
delle classi dominanti.
Gli amori di Giove, p.es., che godettero di tanta fortuna nelle raffigurazioni musive delle
ricche case romane (ornavano soprattutto oeci e triclin e, frequentemente, i cubicoli), sono
presenti in soluzioni iconografiche tradizionali (Europa e il toro, Ganimede e l'aquila) nel
bicchiere da Begram, di fabbrica alessandrina, ora al Museo Guimet.
L'episodio dello scoprimento da parte di Ulisse e Diomede di Achille nascosto a Sciro si
ritrova invece nel bicchiere dipinto di Colonia in cui sono riprodotti particolari quali il
trombettiere con la tuba levata o il cesto di lana ai piedi dell'eroe, che ricorda le mansioni
femminili che Achille svolgeva con le fanciulle (cfr. Stat., Ach., I, 580 ss.), particolari
registrati anche su altri manufatti ispirati al medesimo soggetto (Kossatz-Deissmann,
1981, nn. 54, 98, 121, 175 e passim).
Il mito di Atteone, quale trattato nelle tazze, forse gemelle, raffiguranti il bagno di Diana
e Atteone sbranato dai cani, rinvenute a Leuna e a Dura Europos, presenta schemi ben
documentati nel repertorio musivo (per i mosaici v. Guimond, 1981, nn. 108, 117 a, b; per i
vetri v. Harden, 1987, n. 107; sui pendants nelle arti suntuarie v. Burkhalter, Arce, 1984),
a cui si ispira anche la straordinaria coppa a rilievo di Licurgo (Harden, 1987, n. 139).
Ancora al repertorio dei mosaici, ma attraverso forse la mediazione della toreutica, si
ispirano le raffigurazioni di caccia, fra cui spicca quella al cervo con le reti della bottiglia di
Chiaramonte Gulfi (v.) che trova raffronti a Piazza Armerina, a Ippona, nel piatto di Seuso,
ma anche nei sarcofagi di tradizione urbana (Ghedini, 1991).
Tuttavia, nonostante le analogie spesso puntuali che legano le varie raffigurazioni, la
precisione nel dettaglio e l'aggiunta talvolta del colore e la larga circolazione di tali oggetti,
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
12/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
dovuta alla scarsit dei centri di produzione, i vetri possono senz'altro essere considerati
vettori di cultura figurativa, ma pi difficile risulta ipotizzare che essi siano serviti da
modello per altre classi di manufatti. Sembra invece pi verosimile che sia i mastri vetrai
sia i mosaicisti, i toreuti, gli scalpellini, che ponevano la loro capacit artigianale al servizio
della medesima committenza, attingessero a un repertorio comune, fortemente connotato
sul piano dell'ideologia.
Manufatti toreutici. - Le puntuali tangenze esistenti fra le raffigurazioni documentate su
oggetti in metallo e quelle di altre manifatture artigianali sono state da tempo messe in
evidenza dagli studiosi che le hanno poste in relazione con l'uso e, forse, il commercio, delle
matrici utilizzate per la loro realizzazione e dei calchi in gesso che da esse potevano essere
tratti nel corso dell'esecuzione o a prodotto finito. Tuttavia, se pure tale presupposto
appare plausibile, risulta altrettanto evidente che anche l'oggetto, per le sue caratteristiche
di mobilit e per la sua natura di prodotto di lusso, pot svolgere una funzione di vettore
di cultura figurativa, analogamente a quanto ipotizzato per altre categorie di manufatti.
Significativo in tal senso appare il raffronto fra la raffigurazione di Danae che si appresta ad
accogliere in grembo la pioggia d'oro di uno specchio greco del IV sec. a.C. e quella
riproposta, con una lieve variante nella posizione del braccio, su alcune lkythoi plastiche
all'incirca coeve (D'Abruzzo, 1993): dall'analisi di tali manufatti sembra infatti potersi
inferire un interscambio che pare pi plausibile ipotizzare dal prodotto di lusso al
manufatto corrente piuttosto che viceversa.
Il fenomeno del passaggio delle iconografie dagli oggetti metallici ad altre classi artigianali
risulta particolarmente evidente nel Giudizio di Oreste, quale a noi noto dal Vaso
Corsini: le varie scene infatti riecheggiano su gemme, lucerne, sarcofagi, come ha ben
dimostrato lo Hafner in un saggio ormai classico (Iudicium Orestis. Klassisches und
klassizistisches, Berlino 1958).
Analogie significative si registrano anche con altre manifatture artigianali: si pensi p.es. alla
Venere in conchiglia retta da Tritoni che ritroviamo nello stesso schema figurativo nel
mosaico di ahba', nel cofanetto di Proiecta e nella Tensa Capitolina (Toso, 1995; Ghedini,
1995 b); o alla scena di toilette del mosaico di Sidi Ghrib che ritorna ancora nel cofanetto di
Proiecta e su un oggetto del tesoro di Seuso (Baratte, 1992, p. 95). Anche il gi citato tema
della merenda all'aperto nella soluzione figurativa attestata nel mosico della Piccola Caccia
a Piazza Armerina appare puntualmente ripetuto nel piatto di Seuso (v. supra), mentre la
singolare Menade con campanello e frusta del mosaico dionisiaco di Sarrin appare identica
nel piatto d'argento della Collezione Ortiz (Baity, 1991)
Una citazione a parte merita il Bellerofonte che abbevera Pegaso del piatto di Ginevra (inv.
AD 2382): qui troviamo rielaborata una soluzione figurativa ispirata a una creazione
augustea, a noi nota dal rilievo Spada (Helbig4 , pp. 765-768) e dall'osteoteca di Megiste
(Strocka, 1984, pp. 203-208; v. anche la base di Como: Frova, 1993), che viene
puntualmente ripresa nel cofanetto di Veroli, databile in piena et medievale (Simon, 1964,
p. 324 ss.; v. anche Sichtermann, 1993). In questo caso, fermo restando che si potrebbe
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
13/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
anche invocare l'ipotesi dell'intermediario tecnico, probabilmente un calco in gesso (v.
infra), resta tuttavia ipotizzabile anche per il manufatto toreutico la funzione di vettore
del soggetto, addirittura oltre i limiti cronologici dell'et classica.
Produzione ceramica. - Fra gli oggetti che contribuirono alla circolazione delle iconografie e
di conseguenza alla diffusione di una cultura figurativa possiamo annoverare anche i
manufatti ceramici, dalle lastre di rivestimento alla suppellettile d'uso domestico (piatti,
coppe, bicchieri, vasi, lucerne, ecc.), decorata a rilievo e a stampo, che riproduceva in
materiale pi povero i preziosi serviz in metalli pregiati.
Proprio l'identit del repertorio, pi volte sottolineata, consente di ipotizzare che fra
manifattura toreutica e ceramica vi fosse un interscambio di tipo tecnico (uso dei medesimi
calchi o matrici: per la ceramica aretina v. Ettlinger, 1967; per le lastre Campana, Borbein,
1968; per le lucerne, Di Filippo Balestrazzi, 1988, pp. 7-18, con bibl.). Ma la ceramica
decorata, proprio per il costo minore rispetto alla suppellettile in metallo, svolse
ovviamente anche un'importante funzione nella diffusione di soggetti e iconografie,
consentendone l'acquisizione a strati sempre pi larghi di utenti che in tal modo facevano
propri i temi prediletti dalle classi dominanti. Tale ruolo di vettore di schemi iconografici,
spesso fortemente connotati in senso ideologico, appare ben illustrato p.es. dalla lucerna
dell'Agor di Atene con scena del riscatto del corpo di Ettore (Kossatz-Deissmann, 1981, n.
710): proprio per il fatto che la versione scelta per decorare il disco della lucerna si
differenzia dal pi fortunato schema augusteo, attestato p.es. nella tazza di Hoby e nella
sigillata coeva (Kossatz-Deissmann, 1981, nn. 681 ss., 687), mentre si apparenta
strettamente alla soluzione preferita dagli scalpellini attici (posizione di Achille che distoglie
il capo dalla vista del vecchio padre inginocchiato, aggiunta della coppia Hermes-Teti in
secondo piano: Kossatz-Deissmann, 1981, n. 690 ss. e passim) possiamo dedurre che le
lucerne, cos facilmente trasportabili, possono aver contribuito, unitamente ai sarcofagi, a
far circolare questo particolare schema figurativo.
Analoghe considerazioni si possono fare per il singolare gruppo di Perseo e Andromeda
seduti su roccia di fronte a una polla d'acqua, creazione di I sec. d.C. ispirata al gruppo
piramidale di Marte e Venere. Tale soluzione figurativa, che non trova riscontro nella
tradizione letteraria e pu dunque essere considerata una creazione ad hoc, probabilmente
di et augustea e verisimilmente connotata sotto il profilo ideologico (Perseo potrebbe
essere Augusto e Andromeda Livia), non godette di soverchia fortuna: le uniche
testimonianze a noi note sono infatti un gruppo di affreschi pompeiani, alcune lucerne e un
cammeo ora a Pietroburgo (per il gruppo di Marte e Venere, v. Andersen, 1985; per gli
affreschi pompeiani, le lucerne, il cammeo, v. Schauenburg, 1981, . 102 ss.). Il ritrovare
tale singolare raffigurazione in una libera rielaborazione su un mosaico da Brading del IV
sec. d.C. (Schauenburg, 1981, n. 116), quindi a significativa distanza cronologica e areale
rispetto all'archetipo e alle sue derivazioni, sembra suggerire che proprio lucerne e gemme
possono aver contribuito a preservare e far circolare questa particolare soluzione
figurativa.
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
14/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
A tale proposito appare necessario anche ricordare che fra repertorio ceramico e glittico
esisteva un rapporto altrettanto stretto che fra repertorio ceramico e toreutico (v. anche
Di Filippo Balestrazzi, 1988, p. 11): ne sono significativa testimonianza p.es. la Venere
pudica entro conchiglia, che ritroviamo identica su una gemma di Berlino e su una lucerna
di Cipro (Lawrence, 1967, figg. 16-17), la Leda erotica della lucerna di Preimos e di alcune
gemme (Dierichs, 1990, p. 42,III, 26; Linant de Bellefonds, 1992, p. 244, n. 130), l'Atteone
aggredito dai cani della lucerna di Monaco, della gemma di Bonn, del medaglione in bronzo
di Boston (Guimond, 1981, nn. 58 a, 68, 69, ivi ulteriori confronti), che riproduce forse un
archetipo statuario (cfr. la statua da Lanuvio ora al British Museum: Guimond, 1981, n.
38), acquisito anche dal repertorio musivo (cfr. mosaico di Ivailograd: Guimond, 1981, n.
108).
Emblmata. - L'uso di inserire nei pavimenti o nelle pareti pannelli musivi eseguiti in
laboratorio, allettando le tessere su lastre di marmo o di terracotta, attestato gi in et
ellenistica e godette di ampia fortuna fino alla piena et imperiale (Balil, 1976; Donderer,
1983; Lavagne, 1988, p. 407); ma in realt sembra oggi dimostrabile che tale tecnica sia
stata in uso fino in et tardoantica anche se in quest'epoca la tradizionale decorazione
figurata che assimilava lmblema a un vero e proprio quadro sembra cedere il posto a
decorazioni di tipo geometrico o floreale.
A tale proposito possiamo ricordare i bipedali di Ostia (Sear, 1977, p. 122 s.) e la lastra
marmorea del Museo Nazionale Romano raffigurante un marmorarius intento a eseguire
in bottega un mblema geometrico di opus sedile.
Anche il passo della lettera di Simmaco (Ep., VIII, 42, 2), in cui il panegirista latino chiede
all'amico di inviargli un campione del novum quippe musivi genus... vel in tabulis vel in
tegulis... potrebbe essere interpretato nel senso che i modelli di particolari schemi
decorativi venivano realizzati secondo l'antica procedura dell'mblema e poi fatti oggetto di
esportazione o commercio (in tal senso mblema sembrerebbe equivalente al pardeigma
del papiro Cairo Zenone 59665, su cui v. infra il paragrafo intermediar tecnici: Cartoni e
Cantino Wataghin, 1990, p. 281).
Gli emblmata, per le loro caratteristiche di facile trasportabilit e per la loro funzione
decorativa, costituirono fin dalla tarda et repubblicana un vettore di cultura figurativa
e di schemi iconografici (Suet., lul, 46, ci informa che Giulio Cesare amava esporre nella sua
tenda i tessellata e sectilia preferiti; cfr. anche Wattel de Croizant, 1986, pp. 200-215). A
tale proposito non sembra inutile ricordare gli emblmata con le raffigurazioni del gatto
che afferra l'uccello e di una natura morta, chiaro esempio di una trasmissione interna alla
categoria (Parlasca, 1975, p. 365; Balil, 1976, p. 14, c), a cui si pu aggiungere lmblema di
Zliten con la singolare raffigurazione della battitura del grano sull'aia, di cui si coglie l'eco,
sia pure in una soluzione figurativa leggermente variata, nel mosaico della Tomba della
Mietitura della necropoli ostiense dell'Isola Sacra (Angelucci, 1990, fig. 51). Tale soggetto,
non essendo infatti altrimenti attestato nelle arti figurative, potrebbe essere stato
trasmesso di bottega in bottega proprio grazie alla circolazione di emblmata.
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
15/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
Infine non si pu recisamente escludere che gli esemplari di dimensioni pi ridotte
potessero addirittura essere esposti come campionario nelle botteghe dei mosaicisti,
analogamente a quanto ipotizzato per bozzetti e calchi in gesso.
Sarcofagi. - L'incidenza dei sarcofagi sulla trasmissione di soggetti e iconografie appare
tanto innegabile quanto difficilmente valutabile: da un lato infatti la loro destinazione
funeraria li sottraeva all'uso quotidiano, dall'altro per la forte carica emblematica che da
essi promanava e la loro larga circolazione nell'ambito del cospicuo fenomeno del
commercio, che interess in et imperiale tutto il bacino del Mediterraneo, li qualificava
senz'altro come vettore privilegiato di temi simbolici e fortemente autorappresentativi.
Il repertorio dei sarcofagi, riconducibile alla tradizione epico-mitica da un lato, alla vita
quotidiana dall'altro, presenta una variet di soggetti e di soluzioni iconografiche che
consentono raffronti talvolta assai puntuali con diverse classi artigianali. Per giustificare la
molteplicit delle fonti di ispirazione gli studiosi hanno ipotizzato l'uso di modelli di vario
tipo: libri illustrati, cartoni, calchi in gesso da opere toreutiche, ecc. (Koch, Sichtermann,
1982; Froning, 1980 e 1981). E che gli scalpellini che realizzavano le complesse
raffigurazioni dei sarcofagi utilizzassero intermediar tecnici, su cui torneremo anche pi
oltre, sembra dimostrato anche dal modo con cui le raffigurazioni complesse potevano
essere scomposte o ricomposte: nei sarcofagi con il mito di Ifigenia in Tauride, p.es., sono
state individuate otto scene originarie che sviluppano in sequenza temporale i momenti
salienti della vicenda, ma che non compaiono necessariamente in ordine cronologico o in
successione logica e vengono diversamente assemblate secondo il gusto dell'artigiano o del
committente (Bonanno, 1993). Tuttavia la fedelt iconografica dei gruppi originari sembra
suggerire che vignette in serie completa o ridotta fossero a disposizione degli artigiani:
diversamente non si spiegherebbe l'incoerenza di certe successioni narrative,
evidentemente non pi comprese dall'esecutore delle nuove sequenze.
Ma non sempre necessario ricorrere all'ipotesi degli intermediar tecnici: gli stessi
sarcofagi infatti potevano divenire modello per successive creazioni, come risulta evidente
nell'ambito del fenomeno delle copie locali di opere prodotte nelle officine attiche o urbane
e successivamente esportate nelle varie localit. Il sarcofago con battaglia alle navi, di cui ci
pervenuto un frammento conservato al museo di Torcello, p.es., fu verisimilmente
copiato da un artigiano aquileiese da un originale attico importato ad Aquileia, di cui pure,
significativamente, ci pervenuta una piccola porzione (Ghedini, 1989).
Anche l'esecutore del rilievo aquileiese con Admeto e Alcesti copi probabilmente i
personaggi da un sarcofago attico con la raffigurazione del riscatto del corpo di Ettore nella
redazione greco-orientale di cui s' parlato: le due figure affrontate appaiono infatti cos
strettamente esemplate sulla coppia Hermes-Teti, da costringerci a presupporre una
derivazione per copia diretta da un originale attico.
Analogamente il gruppo Priamo-Achille del sarcofago di Woburn Abbey (KossatzDeismann, 1981, . 706), che si stacca nettamente dalla tradizione consolidata e presenta
una soluzione figurativa chiaramente improntata al gruppo Ippolito-Nutrice del sarcofago
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
16/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
di Tiro (Linant de Bellefonds, 1990, n. 86 ss., passim), stato probabilmente realizzato
copiando e reinterpretando lo schema originale.
Sembra dunque che, proprio per la variet e la complessit delle raffigurazioni che si
dispiegavano sulla cassa e sul coperchio, tale classe di manufatti si offra anche come
osservatorio privilegiato per analizzare procedure di bottega altrimenti difficilmente
ricostruibili.
L'analisi dei manufatti d'uso o di lusso che, circolando entro e oltre i confini dell'impero,
consentivano la diffusione non solo dei soggetti ma anche degli schemi figurativi, potrebbe
continuare ricordando p.es. la produzione glittica in cui il fenomeno della esecuzione in serie
(per copia diretta: v. Dierichs, 1990, IV, 2, 3, 5) meglio documentato che in altre
categorie artigianali; nell'ambito di tale produzione emergono anche interessanti spunti di
riflessione in merito al problema della specificit del repertorio e dell'interscambio con altre
manifatture specializzate quali quelle toreutica e ceramica. Ma la moltiplicazione degli
esempi poco aiuta a chiarire la reale consistenza del fenomeno: infatti, se fuor di dubbio
che gli oggetti mobili trasmettessero cultura figurativa e rendessero note anche particolari
soluzioni iconografiche, meno agevole appare definire se e in che modo tali oggetti
potessero fiingere da modello al di fuori della propria classe artigianale. Poich sembra
improponibile che un maestro mosaicista si mettesse a copiare un vetro, o uno scalpellino
una gemma, per giustificare tangenze puntuali fra iconografie attestate in manufatti
appartenenti a classi artigianali diverse, necessario ipotizzare altri, pi specifici mezzi di
trasmissione, che potessero circolare non solo all'interno della bottega, ma anche fra
botteghe diverse.
Il confronto con la pratica dei modelli in gesso, attestata per la scultura a tutto tondo,
sembra decisamente orientare la ricerca consentendo di ipotizzare analoghe procedure
anche per le arti figurative bidimensionali.
4. Intermediar tecnici. - Modelli in gesso. - L'esistenza di calchi in gesso, riproducenti non
solo opere statuarie, ma anche composizioni a carattere narrativo, stata ampiamente
confermata dai ritrovamenti di Begrm e Memfi e dai pi recenti, ma non meno
significativi, di Sabratha (Reinsberg, 1980; Barone, 1994). Tali calchi in gesso, desunti per
lo pi da opere toreutiche, sono considerati intermediar tecnici privilegiati per la diffusione
di iconografie ispirate al repertorio epico-tragico (Van der Meer, 1975, p. 183; Froning,
1980 e 1981; Burkhalter, 1992, p. 334 ss.), decorativo e anche storico (Hackin, 1954;
Barone, 1994, tavv. LII s., CVII s.).
L'uso di tali calchi non doveva per essere limitato alle botteghe toreutiche, ma pu essere
plausibilmente esteso anche ad altre manifatture artigianali. Se, p.es., consideriamo la
singolare iconografia del Ganimede seduto che offre da bere all'aquila, riprodotta su uno dei
gessi di Begrm e la confrontiamo con quella attestata su alcune lucerne anatoliche e su
gemme di varia provenienza (Sichtermann, 1988, nn. 146, 167; v. anche il tondo in
terracotta da Heidelberg: ibid., n. 165), non si pu non rilevarne la puntuale identit, che
consente forse di ipotizzare che anche nelle officine ceramiche e glittiche potessero essere
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
17/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
usati modelli in gesso (si ricordi a tale proposito la perfetta identit iconografica che si
registra fra i gessi di Begrm con Diomede e Odisseo e le gemme con il medesimo
soggetto). Lo stesso schema ricompare anche sull'altare funerario di Stazio Asclepiade
(Sichtermann, 1988, n. 142), confermando la circolazione del modello anche nelle botteghe
di scultori.
D'altronde la Froning ha fornito una ricca ed esauriente casistica dell'uso dei medesimi
schemi figurativi negli argenti della prima et imperiale e nei sarcofagi di II e III sec. d.C.
In particolare sembrano coincidere, come gi s' detto, le raffigurazioni ispirate alle
tragedie: i gruppi di Fedra assistita dalla nutrice o di Medea che contempla i figli, negli
schemi documentati nei sarcofagi urbani e attici, trovano rispettivamente riscontro in uno
specchio da Pompei e nel klathos di Monaco, mentre il sacrificio dei prigionieri troiani
ripropone la redazione della coppa d'argento di Monaco (Froning, 1980).
Un'ulteriore conferma dell'uso dei calchi in gesso per la trasmissione delle iconografie viene
dai rilievi a carattere decorativo, dai vasi di marmo, dai candelabri, ecc. (Froning, 1981;
Cain, 1985).
Tali intermediar tecnici furono forse usati anche da pittori e mosaicisti: se infatti
raffrontiamo l'Europa natante accanto al toro del gesso di Memfi (Reinsberg, 1980, n. 56,
fig. 89) con alcuni affreschi pompeiani raffiguranti nello stesso schema Europa o Frisso o
una Nereide; Icard- Gianolio, Szabados, 1992, n. 54), difficilmente possiamo sfuggire alla
suggestione di ipotizzare che lo schema, che circolava nelle botteghe dei pittori, fosse stato
recepito proprio attraverso un calco in gesso simile a quello egiziano. Analoghe
considerazioni potrebbero essere fatte anche per giustificare l'assoluta identit che esiste
fra la Nereide su toro marino del mosaico di Aquileia e quella del medaglione di Abukir
(Ghedini, 1992 b, p. 307): i due monumenti cos lontani nel tempo e nello spazio ebbero
certamente un archetipo in comune, che pure potrebbe essere circolato proprio grazie a
matrici in gesso da opere toreutiche (si ricordi che il diametro del medaglione di quasi 6
cm).
Cartoni. - Fra i vettori di trasmissione delle iconografie i pi citati, ma anche i pi
discussi, sono certamente i cartoni (Skizzenbcher, Musterbcher, cahiers des
modles), invocati dagli studiosi, a torto o a ragione, ogniqualvolta si registrano precise
analogie iconografiche in opere rinvenute in localit lontane o in manufatti appartenenti a
diverse classi artigianali (a favore dell'esistenza dei cartoni si sono recentemente espressi,
fra gli altri: Froning, 1980, p. 324 s.; Besques, 1984, p. 71 ss.; Nowicka, 1984, p. 257;
Andersen, 1985; Balil, 1986; Brilliant, 1987, p. 42; Blanchard Leme, 1988, p. 380; Cantino
Wataghin, 1990, p. 279 ss.; Ling, 1991, p. 217 s.; e per l'et medievale: Vergnolle, 1984;
contra Bruneau, 1984; Balmelle, Darmon, 1986, p. 246; Bruneau, 1988, p. 71 s.;
Schmelzeisen, 1992, pp. 29 s., 175).
Anche i pi accaniti nemici dei cartoni (Bruneau, 1984; Balmelle, Darmon, 1986)
sembrano per sostanzialmente concordare sul presupposto che gli artigiani, prima della
esecuzione di un'opera complessa oppure tecnicamente difficile da realizzare (stoffe,
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
18/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
mosaici, argenti, ecc.), approntassero degli schizzi da sottoporre all'attenzione del
committente e da usare poi come traccia in corso d'opera.
Dell'esistenza di tali schizzi (paradigmata, exempla) abbiamo testimonianze significative:
basti pensare al papiro Cairo Zenone 59665, in cui si parla di un mosaico a disegno figurato
complesso (graphikn nthos) per l'esecuzione del quale si richiedeva il modello (Bruneau,
1980; Daszewski, 1985, p. 6 ss.); ancora un papiro (Cairo Zenone 59445) ci illumina
sull'uso dei paradigmata in pittura, dal momento che sottolinea come l'affresco del soffitto
voltato di Diotimo doveva essere conforme al modello (o o v ; Nowicka,
1984). L'uso del modello ben attestato anche nell'arte tessile: e non solo per le complesse
raffigurazioni che ornavano il peplo di Atena, per la cui scelta si indiceva addirittura un
concorso (cfr. Aristot., Ath. Pol., 49, 4), ma anche per pi modesti drappi, quali quello che
Diseris tess su modello di Praxidike (Anth. Pai., VI, 136). In tale prospettiva sembra porsi
anche la gi ricordata testimonianza di Simmaco che richiede che lexemplum gli venga
inviato vel in tabulis vel in tegulis (Ep., VIII, 42, 2).
La pratica del disegno preparatorio inoltre confermata da tutte quelle iscrizioni musive in
cui espressamente si sottolinea che l'esecutore materiale dell'opera persona diversa dal
suo ideatore (Bruneau, 1984, p. 264 s.; Donderer, 1989), implicitamente presupponendo
un modello da copiare.
Ci detto, sembra difficile seguire il Bruneau nell'ipotesi che tale materiale preparatorio
fosse immediatamente e sempre distrutto dopo l'uso e non potesse invece essere
riutilizzato dall'autore stesso, dalla sua bottega oppure anche dal committente che poteva
riservarsene il possesso. La distruzione dello schizzo preparatorio, oltre a essere una
pratica decisamente antieconomica, sembra anche contraddetta dal passo pliniano relativo
ai graphidis vestigia di Parrasio che, conservati in tabulis ac membranis, costituivano
oggetto di studio da parte degli artisti (ex quibus proficere dicuntur artifices: Plin., Nat.
hist., XXXV, 168). E che gli schizzi dei grandi pittori potessero addirittura essere oggetto di
esposizione lo conferma Petronio che nella pinacoteca visitata da Encolpio ricorda accanto a
opere di Zeusi anche rudimenta Protogenis (Sat., 83).
Se le opere preparatorie dei grandi artisti erano oggetto di tale interesse o se i quadri pi
rinomati venivano copiati da pittori di pi modeste qualit (Quint., Inst., X, 2, 6), non v'
motivo di dubitare che anche gli schizzi preparatori potessero venire conservati o
all'interno della bottega o, in taluni casi, anche all'esterno di essa, divenendo materia di
scambio o commercio. In tale prospettiva acquista spessore la testimonianza di Cassiodoro
(Inst. div., I, 20, 3), in cui l'autore afferma di aver raccolto in un codice diversi tipi di
composizione (multiplices facies facturarum), senza specificare se geometriche, floreali o
figurate, ma sottolineando la loro funzione di modello per successive opere. Ciascun
artigiano dunque e ciascuna bottega dovevano possedere un proprio patrimonio
iconografico, che poteva essere soggetto ad ampliamento o riduzione nel corso degli anni e
che verisimilmente comprendeva sia composizioni complesse riprodotte nei dettagli (si
veda p.es. la perfetta identit iconografica e compositiva che esiste fra i mosaici di Orfeo di
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
19/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
Henr Thina e Sqiyet ez-Ziz: Liepmann, 1974, pp. 28, n. 33, 29, n. 60) sia schemi
figurativi semplici (personaggio inginocchiato, figura femminile seduta), i quali grazie
all'aggiunta degli attributi potevano servire a raffigurare soggetti diversi (Andersen, 1985,
p. 122).
Scarse, ma non del tutto assenti, le testimonianze archeologiche: per la prima categoria
possiamo p.es. citare il papiro del Victoria and Albert Museum T 15.1946 (Settis, 1982, p.
183), in cui troviamo raffigurato, con una scansione spaziale tipica della produzione musiva
o tessile, Orfeo con gli animali entro un tondo inscritto in un quadrato (secondo taluni
anche la raffigurazione di Amore e Psyche e labductio di Briseide sono da annoverare in
tale categoria: v. supra tradizione letteraria: Illustrazioni da libri); per la seconda
possiamo invece ricordare gli schizzi del papiro Vindobonense G 30509 (Andersen, 1985,
p. 122).
Punzoni. - Fra i vettori di iconografie si possono annoverare anche i punzoni che
venivano utilizzati nelle officine ceramiche per decorare piatti, coppe, vasi con
raffigurazioni semplici o complesse. Tali punzoni che potevano, come le matrici, circolare o
essere oggetto di scambio o commercio fra le botteghe (Hofmann, 1971), consentivano
attraverso le diverse associazioni di creare composizioni variate, in analogia con quanto
ipotizzato per i cartoni con silhouettes semplici.
I punzoni svolsero certamente un'importante funzione nella diffusione del patrimonio
iconografico: in tal senso interessante appare il raffronto fra la Leda stante inseguita dal
cigno di alcune coppe africane e il medesimo soggetto reso con analoga soluzione
iconografica nel mosaico di Alcal de Henares (Salomonson, 1969; Linant de Bellefonds,
1992, p. 237, n. 62).
Lo status quaestionis relativo al problema della t. i. si presenta ancora scarsamente
definito e necessita di ulteriori approfondimenti: infatti, se la tradizione letteraria
apparsa determinante nella fase di formazione della cultura figurativa, se artigiani
itineranti, oggetti d'uso e di lusso, illustrazioni da libri sono sembrati sufficienti per
giustificare la larga circolazione non solo dei temi ma anche di determinate soluzioni
figurative, e se per spiegare identit puntuali stato necessario ricorrere all'ipotesi degli
intermediar tecnici (calchi in gesso, cartoni, punzoni), restano tuttavia ancora da chiarire
le modalit d'uso di tali vettori.
Per la soluzione di tale questione sembra necessario da un lato approfondire le
problematiche inerenti all'organizzazione del lavoro all'interno della bottega, dall'altro
verificare l'incidenza degli intermediar nei casi di trasmissione interna a una classe di
manufatti e nei casi di trasmissione fra classi artigianali differenti. A tale proposito, e in via
del tutto preliminare, si potrebbe proporre una distinzione fra officine specializzate nella
produzione in serie di manufatti trasportabili (p.es. sarcofagi, gemme, ecc.) e officine
produttrici di opere legate invece al supporto architettonico (p.es. mosaici, affreschi, ecc.).
Nel primo caso infatti, pur essendo gli intermediar plausibilmente ipotizzabili, le
iconografie si potevano trasmettere anche per copia diretta da un manufatto all'altro,
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
20/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
mentre nel secondo l'uso dell'intermediario appare indispensabile, non sembrando
plausibile l'ipotesi della riproduzione da oggetti mobili. Analoghe considerazioni possono
valere anche per manufatti appartenenti a classi artigianali diverse che presentano
iconografie identiche, sembrando anche in questo caso poco probabile la riproduzione da un
oggetto all'altro.
Bibl.: In generale: T. Hlscher, Rmische Bildsprache als semantisches System,
Heidelberg 1987 (trad. it. Torino 1993); S. Settis, Un'arte al plurale. L'Impero romano, i
Greci e i posteri, in Storia di Roma, IV, Torino 1989, pp. 827-878; G. Bejor, L'arte
romana: centro e periferia, arte colta e arti plebee, in S. Settis (ed.), Civilt dei Romani.
Un linguaggio comune, Milano 1993, pp. 235-246; S. De Maria, Botteghe d'artisti,
botteghe di copisti. Collezioni d'arte, ibid., pp. 219-234; C. Frugoni, Dall'iconografia
pagana all'iconografia cristiana, ibid., pp. 247-256; F. Ghedini, L'arte romana: generi e
gesti, ibid., pp. 161-178.
Produzione a tutto tondo: Ch. Landwehr, Die antiken Gipsabgsse aus Baiae. Griechische
Bronzestatuen in Abgssen rmischer Zeit, Berlino 1985; G. Barone, Gessi del Museo di
Sabratha, Roma 1994.
Rilievo, pittura, mosaico: Ph. Bruneau, Les mosastes antiques avaient-ils des cahiers des
modles?, in RA, 1984, pp. 241-271.
Tradizione letteraria: T. B. L. Webster, Monuments Illustrating Old and Middle Comedy,
Londra 1960; id., Monuments Illustrating New Comedy, Londra 1961; id., Monuments
Illustrating Tragedy and Satyr Play, Londra 1962; A. D. Trendall, T. b. L. Webster,
Illustrations of Greek Drama, Londra 1971; j. M. Moret,L'Ilioupersis dans la cramique
italiote, Roma 1975; H. Lavagne, Le combat de Dars et Enteile (Eneide, V, 362-482) sur
une mosaque de Villelaure (Vaucluse), in Caesarodunum, XIII bis, 1978, pp. 133-146; I.
Baldassarre, Piramo e Thisbe: dal mito all'immagine, in L'art dcoratif Ronfe la fin de
la rpublique et au dbut du principal Table ronde, Rome 1979, Roma 1981, pp. 337-347;
A. Kossatz- Deissmann, in LIMC, I, 1981, pp. 37-200, s.v. Achilleus, . Horsfall, The
Origins of the Illustrated Book, in Aegyptus, LXIII, 1983, pp. 199-216; F. Burkhalter, J.
Arce, La coupe de Mro. Une nouvelle tude iconographique et historique, in BCH,
CVIII, 1984, pp. 407-423; F. G. Andersen, Pompeian Painting. Some Practical Aspects of
Creation, in AnalRom, XIV, 1985, pp. 114-127; F. Gury, La forge du destin. A propos
d'une srie de peintures pompiennes du IVe style, in MEFRA, XCVIII, 1986, pp. 427489; J. A. Heffernan, Ekphrasis and Representation, in New Literary History, XXII, 1991,
pp. 297-316; R. Ling, Roman Painting, Cambridge 1991; F. Ghedini, Caccia e banchetto:
un rapporto difficile, in RdA, XVI, 1992, pp. 72-88; H. Lavagne, Aix-en-Provence: la
domus de la rue des Magnans et la mosaque de Dars et Enteile, in Gallia, LI, 1994, pp.
203-215; N. Bryson, Philostratus and the Imaginary Museum, in S. Goldhill, R. Osborne
(ed.), Art and Text in Ancient Greek Culture, Cambridge 1994, pp. 255-283; S. Goldhill,
Ekphrasis and the Culture of Viewing, ibid., pp. 197-223; F. I. Zeitlin, The Artful Eye:
Vision Ekphrasis and Spectacle in Euripidean Theatre, ibid., pp. 138-196. - Illustrazioni di
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
21/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
libri: S. Kharitonidis, L. Kahil, R. Ginouvs, Les mosaques de la Maison du Mnandre
Mytilne (AntK, Suppl. 6), Berna 1970; E. Kitzinger, Observations on the Samson Floor
at Mopsuestia, in DOP, XXVII, 1973, pp. 133-144; E. G. Turner, The Charioteers
fromAntinoe, in JHS, XCIII, 1973, pp. 192-195; K. Schefold, Bilderbcher als Vorlagen
rmischer Sarkophage, in MEFRA, LXXXVIII, 1976, pp. 759-797; V. Strocka, Die
Wandmalerei der Hanghuser in Ephesos (Forschungen in Ephesos, VIII, 1), Vienna 1977;
P. G. P. Meyboom, Some Observations on Narration in Greek Art, in MededRom, XL,
1978, pp. 55-82; U. Sinn, Die homerischen Becher (AM, Suppl. 7), Berlino 1979; G.
Frangini, M. L. Martinelli, Una scena della storia di Briseide: il pap. Monacense 128 e la
tradizione iconografica, in Prospettiva, 25, 1981, pp. 4-13; K. Weitzmann, An Enamelled
Glass Beaker with a Scene from New Comedy, in AntK, XXIV, 1981, pp. 39-49; A.
Daviault, J. Lancha, L. A. Lpez Palomo, Un mosaico con inscripciones, Puente Genii
(Crdoba), Madrid 1987; M. Donderer, Die Mosaizisten der Antike und ihre
wirtschaftliche und soziale Stellung. Eine Quellenstudie, Erlangen 1989; G. Cavallo, Libro
e cultura scritta, in Storia di Roma, IV, cit., pp. 693-734; id., Gli usi della cultura scritta
nel mondo romano, in AA.VV., Princeps urbium, Amilano 1991, pp. 171-253; L. Bacchielli,
Pittura funeraria antica in Cirenaica, in LibSt, XXIV, 1993, pp. 77-116; D. Fernandez
Galiano, The Villa of Maternus at Carranque, in Vth International Colloquium on Ancient
Mosaics, Bath 1994, pp. 200-210; . Ivanov, Rmische Mosaiken aus Colonia Ulpia Oescensium, in La mosaque grco-romaine, IV, Trves 1984, Parigi 1994, pp. 155-164.
Artigiani itineranti: H. Stem, Les mosaques de la Grande Mosque de Cordoue, Berlino
1976; K. M. D. Dunbabin, The Mosaics of Roman North Africa. Studies in Iconography
and Patronage, Oxford 1978; J. P. Sodini, L'artisanat urbain l'poque palochrtienne
(IV-VII s.), in Ktema, IV, 1979, pp. 71-119; J. P. Darmon, Les mosaques en Occident, in
ANRW, II, 12, 2, 1981, pp. 266-319; J. Lancha, Florilge viennoise, in Mosaque. Recueil
d'hommages H. Stern, Parigi 1983, pp. 245-251; C. Balmelle, J. P. Darmon, L'artisan
mosaste dans l'antiquit tardive, in Artistes, artisans et production artistique au Moyen
Age, Parigi 1986, pp.235-249; H. Eristov, Peinture romaine et textes antiques.
Informations et ambiguts. A propos du RecueilMilliet, in RA, 1987, pp. 109-123; Ph.
Bruneau, Philologie mosastique, nJSav, 1988, pp. 3-73; D. Joly, Mosaque africaine et
mosaque italienne. Quelques rflexions propos de certains ornements, in Hommenaje a
Garca y Bellido, V, Madrid 1988, pp. 169-211; M. Donderer, Die Mosaizisten der
Antike..., cit.; F. Queyrel, C. Ofellius Frus, in BCH, CXV, 1991, pp. 389-464.
Oggetti mobili. - Stoffe: H. Schmidt, in EUA, XIII, 1965, cc. 868-870, s.v. Tessuti-, L. Del
Francia, Un tessuto copto con nascita di Afrodite, in N. Bonacasa (ed.), Alessandria e il
mondo ellenistico-romano. Studi in onore di A. Adriani, II, Roma 1984, pp. 209-221; G.
Cantino Wataghin, La produzione musiva in Alto Adriatico e Mediterraneo, in Aquileia e
l'arco adriatico (Antichit altoadriatiche, XXXVI), Udine 1990, pp. 269-298; F. Ghedini,
Iconografie urbane e maestranze africane nel mosaico della Piccola Caccia di Piazza
Armerina, in RM, XCVIII, 1991, pp. 323-335; G. Calcani, L'antichit marginale.
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
22/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
Continuit dell'arte provinciale nel Rinascimento, Roma 1993; F. Ghedini, Il mosaico con
trionfo di Venere dalla c.d. domus dei Dioscuri a Ostia, in Atti del II Colloquio
AISCOM, Roma 1994, Bordighera 1995, pp. 301-310; S. Toso, Il Trionfo di Venere.
Una nuova proposta di classificazione iconografica, ibid., pp. 293-300; F. Ghedini,
Cultura figurativa e trasmissione dei modelli: le stoffe, in RdA, XIX, 1995. - Vetri: L.
Guimond, in LIMC, I, 1981, pp. 454-469, s.v. Aktaion-, D. B. Harden (ed.), Glass of the
Caesars, Milano 1987. - Manufatti toreutici: E. Simon, Nonnos und das Elfenbeinkstchen
aus Veroli, in Jdl, LXXVI, 1964, pp. 279-336; H. Froning, Die ikonographische Tradition
der kaiserzeitlichen mythologischen Sarkophagreliefs, ibid., XCV, 1980, pp. 322-341; V.
M. Strocka, Sepulkral-Allegorie auf dokimeischen Sarkophagen, in MarbWPr, 1984, pp.
197-241; J. Balty, Notes d'iconographie dionysiaque: la mosaque de Sarrin (Osrhone),
in MEFRA, CHI, 1991, pp. 19-33; F Baratte, Les ateliers d'argenterie dans l'antiquit
tardive. Donnes actuelles, in G. Sena Chiesa (ed.), Milano capitale dell'impero. Felix
Temporis Reparatio, Milano 1992, pp. 87-101; M. D'Abruzzo, Una pasta vitrea da Aitino
e il mito di Danae: osservazioni sull'iconografia, in RdA, XVII, 1993, pp. 18-31; . M.
Scarf, Le quattro basi figurate in Via 5 Giornate, in Novum Comum 2050, Como 1993,
pp. 151-162; H. Sichtermann, Bellerophon auf attischen Sarkophagen, in G. Koch (ed.),
Grabeskunst der rmischen Kaiserzeit, Magonza 1993, pp. 51-66. - Produzione ceramica:
E. Ettlinger, Arretina und augusteischer Silber, in Gestalt und Geschichte. Festschrift K.
Schefold, Berna 1967, pp. 115-119; M. Lawrence, The Birth of Venus in Roman Art, in
Essays in the History of Art Presented to R. Wittkower, Londra 1967, pp. 10-16; A. H.
Borbein, Campanareliefs. Typologische und Stilkritische Untersuchungen (RM, Suppl.
XIV), Heidelberg 1968; K. Schauenburg, in LIMC, I, 1981, pp. 774-790, s.v. Andromeda;
E. Di Filippo Balestrazzi, Lucerne del Museo di Aquileia, II, 2, Fiume Veneto 1988; A.
Dierichs, Leda-Schwan-Gruppen in der Glyptik und ihre monumentalen Vorbilder, in
Boreas, XIII, 1990, pp. 37-50; P. Linant de Bellefonds, in LIMC, VI, 1992, pp. 231-246,
s.v. Leda. - Emblmata: K. Parlasca, Hellenistische und rmische Mosaiken aus gypten,
in La mosaque grco-romaine, II, Parigi 1975, pp. 363- 369; A. Balil, Emblmata, in
Studia Archaeologica, XXXIX, 1976, pp. 3-27; S. F. Sear, Roman Wall and Vault Mosaics
(RM, Suppl. XXIII), Heidelberg 1977; M. Donderer, Ein verschollenes rmische Mosaik
und die Gattung der Wandemblemata, in Mosaque. Recueil d'hommage Stern, cit., pp.
123-128; O. Wattel de Croizant, L'enlvement d'Europe sur la pseudo pave de Cannes et
le problme des emblemata voyageurs, in Archaeonautica, VI, 1986, pp. 200-215; H.
Lavagne, Operosa antra. Recherches sur la grotte Rome, de Sylla Hadrien, Roma
1988; S. Angelucci e altri, Sepolture e riti nella necropoli di Ostia, in BA, 5-6, 1990 pp. 49113; Sarcofagi: H. Froning, Marmor-Schmuckreliefs mit griechischen Mythen, Magonza
1981; G. Koch, H. Sichtermann, Rmische Sarkophage, Monaco 1982; F. Ghedini, Un
frammento di sarcofago con battaglia alle navi nel Museo Provinciale di Torcello, in
AquilNost, LX, 1989, cc. 193-206; P. Linant de Bellefonds, in LIMC, V, 1990, pp. 445-464
s.v. Hippolytos I; M. Bonanno, Il mito di Ifigenia nei sarcofagi attici, in G. Koch (ed.),
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
23/24
17/08/13
Treccani, il portale del sapere
Grabeskunst der rmischen Kaiserzeit, cit., pp. 67-76.
Intermediari tecnici. - Modelli in gesso: C. Bernardi, I Niketeria, in Rivlt- Num, XVIII,
1970, pp. 79-90; L. B. van der Meer, Archetype. Transmitting Model. Prototype. Studies
of Etruscan Urns from Volterra, in BABesch, L, 1975, pp. 179-186; C. Reinsberg, Studien
zur hellenistischen Toreutik, Hildesheim 1980; F. Burkhalter, Moulages en pltre
antiques et toreutique alexandrine, in N. Bonacasa (ed.), Alessandria e il mondo
ellenistico-romano, II, cit., pp. 334-347; H.-U. Cain, Rmische Marmorkandelaber,
Magonza 1985; M. Donderer, Die Chronologie der rmischen Mosaiken in Venetien und
Histrien bis zur Zeit der Antonine, Berlino 1986; H. Sichtermann, in LIMC, IV, 1988, pp.
154-170, s.. Ganymedes; F. Ghedini, L'et romana, in Storia di Venezia, I. Origini. Et
ducale, Roma 1992, pp. 271-320; . Icard-Gianolio, . V. Szabados, in LIMC, VI, 1992, pp.
785-824, s.v. Nereides. - Cartoni: U. Liepmann, Ein Orpheusmosaik im Kestner Museum
zu Hannover, in Niederdeutsche Beitrge zur Kunstgeschichte, XIII, 1974, pp. 9-36; Ph.
Bruneau, Le devis de pose de mosaques: le papyrus Cairo Zen. 59665, .
. , Atene 1980, pp. 134-1435 S. Settis, Ineguaglianze e
continuit: un'immagine dell'arte romana, in O. J. Brendel (ed.), Introduzione all'arte
romana, Torino 1982, pp. 161- 200; S. Besques, Quelques problmes concernant les
transferts de thmes dans la coroplathie du monde mditerranen, in BAntFr, 1984, pp.
71-81; E. Vergnolle, Un carnet de modles de l'an mil originaire de Saint Benoit sur Loire,
in Arte medievale, II, 1984, pp. 23-52; M. Nowicka, Thophilos, peintre alexandrin et son
activit, in N. Bonacasa (ed.), Alessandria e il mondo ellenistico-romano,II, cit., pp. 256259; W. A. Daszewski, Corpus of Mosaics from Egypt, I. Hellenistic and Early Roman
Period, Magonza 1985; A. Balil, El oficio del musivario, in BVallad, LII, 1986, pp. 143-161;
R. Brilliant, Narrare per immagini, Firenze 1987; M. Blanchard Leme, A propos des
mosaques de Sidi Ghrib, in MEFRA, C, 1988, pp. 367-384; K. Schmelzeisen, Rmische
Mosaiken der Africa Procon- sularis, Francoforte 1992. - Punzoni: J. W. Salomonson,
Sptrmische rote Tonware mit Reliefverzierung aus nordafrikanischen Werksttten, in
BABesch, XLIV, 1969, pp. 4-109; . Hofmann, Les relations entre potiers, fabricants de
moules et artistes producteurs de poinons, in ReiCretRomFautActa, XIII, 1971,pp. 5-17.
(E. F. Ghedini)
www.treccani.it/enciclopedia/trasmissione-delle-iconografie_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/?stampa=1
24/24
Potrebbero piacerti anche
- Antichità - La civiltà romana - Arti visive: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 15Da EverandAntichità - La civiltà romana - Arti visive: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 15Nessuna valutazione finora
- Dottorato Di Ricerca 1Documento8 pagineDottorato Di Ricerca 1BixiWNessuna valutazione finora
- L'antica Roma - Le città, l’esercito e gli imperatoriDa EverandL'antica Roma - Le città, l’esercito e gli imperatoriValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Il Linguaggio Dell Arte Romana Di TonioDocumento30 pagineIl Linguaggio Dell Arte Romana Di TonioMic SNessuna valutazione finora
- Figura Arte Corpo UmanoDocumento33 pagineFigura Arte Corpo UmanoTinervia AlessioNessuna valutazione finora
- Il Cinquecento: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 48Da EverandIl Cinquecento: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 48Nessuna valutazione finora
- Maniera Le Vite De' Più Eccellenti Pittori, Scultori e ArchitettoriDocumento10 pagineManiera Le Vite De' Più Eccellenti Pittori, Scultori e ArchitettoriSilvia AntoniNessuna valutazione finora
- Pafumi NAC PDFDocumento56 paginePafumi NAC PDFStefania PafumiNessuna valutazione finora
- Cronologia Della Storia Dell' ArteDocumento42 pagineCronologia Della Storia Dell' ArteRosangelaNessuna valutazione finora
- Saverio Battente - Biografia e Ritratto. XVI e XVII SecoloDocumento5 pagineSaverio Battente - Biografia e Ritratto. XVI e XVII SecoloPietro GiocoliNessuna valutazione finora
- Letteratura e Arti FigurativeDocumento113 pagineLetteratura e Arti Figurativeanopticon100% (1)
- Arte Romana - M. PapiniDocumento6 pagineArte Romana - M. PapiniNicoNessuna valutazione finora
- Settis Futuro Del ClassicoDocumento5 pagineSettis Futuro Del Classicoiole0% (1)
- Storia Dell'Arte Moderna AppuntiDocumento243 pagineStoria Dell'Arte Moderna Appuntiale.guggiaNessuna valutazione finora
- Relazione de "Testimoni Oculari. Il Significato Storico Delle Immagini", Peter BurkeDocumento5 pagineRelazione de "Testimoni Oculari. Il Significato Storico Delle Immagini", Peter Burkegrazia coglianoNessuna valutazione finora
- Antichità - La civiltà greca - Musica: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 11Da EverandAntichità - La civiltà greca - Musica: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 11Nessuna valutazione finora
- 04 Iconografia e IconologiaDocumento8 pagine04 Iconografia e IconologiaGaia GiorgiNessuna valutazione finora
- Parol On Line - L - Archetipo Del Labirinto Nell - Arte Contemporanea - Di Manuela RoncoDocumento24 pagineParol On Line - L - Archetipo Del Labirinto Nell - Arte Contemporanea - Di Manuela RoncoFrancesco Maria FerraraNessuna valutazione finora
- Prima Parte: Le Immagini, I Testi, La Storia Dell'ArteDocumento76 paginePrima Parte: Le Immagini, I Testi, La Storia Dell'ArteFrancesca Di GiamberardinoNessuna valutazione finora
- Articoli Per L EsameDocumento79 pagineArticoli Per L EsameDomenico BenociNessuna valutazione finora
- Arte Romana. Papini.Documento111 pagineArte Romana. Papini.auro1230Nessuna valutazione finora
- Arte MedievaleDocumento12 pagineArte MedievaleMelissa WhiteNessuna valutazione finora
- PriniàsDocumento18 paginePriniàsEleonora PappalardoNessuna valutazione finora
- Antichità - La civiltà greca - Arti visive: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 8Da EverandAntichità - La civiltà greca - Arti visive: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 8Nessuna valutazione finora
- Il Medioevo (secoli V-X) - Arti visive (24): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 24Da EverandIl Medioevo (secoli V-X) - Arti visive (24): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 24Nessuna valutazione finora
- Federico Zeri - Rinascimento e Pseudo-Rinascimento (Storia Dell'arte Einaudi)Documento44 pagineFederico Zeri - Rinascimento e Pseudo-Rinascimento (Storia Dell'arte Einaudi)Luca MolteniNessuna valutazione finora
- Giordana Niv 3Documento12 pagineGiordana Niv 3PandexaNessuna valutazione finora
- Mithra PetrogenitoDocumento19 pagineMithra Petrogenitoabenati68Nessuna valutazione finora
- Elementi Di IconologiaDocumento17 pagineElementi Di IconologiaAndrea SimonettiNessuna valutazione finora
- SguardoDocumento382 pagineSguardonomeNessuna valutazione finora
- La Storia Dell'arteDocumento8 pagineLa Storia Dell'artecamillaNessuna valutazione finora
- Genesi e Caratteristiche Del Linguaggio Neoclassico EuropeoDocumento3 pagineGenesi e Caratteristiche Del Linguaggio Neoclassico EuropeoJaime Vigliano GirandoNessuna valutazione finora
- Daria Gigli Piccardi - Nonno e L'Egitto 1Documento22 pagineDaria Gigli Piccardi - Nonno e L'Egitto 1Said Carbajal ChamaNessuna valutazione finora
- Augusto e Il Potere Delle ImmaginiDocumento357 pagineAugusto e Il Potere Delle ImmaginiLaura de Angelis0% (1)
- Scrittura e Μουσική Nell' antica GreciaDocumento13 pagineScrittura e Μουσική Nell' antica GreciafcrevatinNessuna valutazione finora
- Arte Cretese MiceneaDocumento11 pagineArte Cretese MiceneaRiccardo Onestzky SimioniNessuna valutazione finora
- Antichità - Il Vicino Oriente - Arti visive / Archeologia: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 2Da EverandAntichità - Il Vicino Oriente - Arti visive / Archeologia: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 2Nessuna valutazione finora
- Stilul RenascentistDocumento89 pagineStilul RenascentistION GĂNGUȚNessuna valutazione finora
- Archeologia Pt.1Documento43 pagineArcheologia Pt.1Federica OlivieriNessuna valutazione finora
- La Pittura Di Icone in RussiaDocumento16 pagineLa Pittura Di Icone in RussiaȘtefan NuicăNessuna valutazione finora
- Il Novecento - Arti visive (71): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 72Da EverandIl Novecento - Arti visive (71): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 72Nessuna valutazione finora
- Neoclassicismo RomanticismoDocumento13 pagineNeoclassicismo RomanticismoMorenaNessuna valutazione finora
- Perché il romanico è l'unica vera arteDa EverandPerché il romanico è l'unica vera arteNessuna valutazione finora
- Il Seicento - Letteratura e teatro (54): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 55Da EverandIl Seicento - Letteratura e teatro (54): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 55Nessuna valutazione finora
- Slide 15: Emilio Paolo, Pidna 168 A.C. Vincitore Della 3° Guerra Macedonica, Che Nonostante La Critica Gli AbbiaDocumento6 pagineSlide 15: Emilio Paolo, Pidna 168 A.C. Vincitore Della 3° Guerra Macedonica, Che Nonostante La Critica Gli AbbiaRebecca MercuriNessuna valutazione finora
- Kitzinger Alle Origini Dellarte BizantinaDocumento15 pagineKitzinger Alle Origini Dellarte BizantinaGiuseppeNessuna valutazione finora
- Archeologia Classica 2021-2022Documento246 pagineArcheologia Classica 2021-2022ndhg962n4sNessuna valutazione finora
- Il Mondo del sacro: simboli - oggetti - struttureDa EverandIl Mondo del sacro: simboli - oggetti - struttureNessuna valutazione finora
- Echi del Carnevale di Venezia nella storia e nel mondoDa EverandEchi del Carnevale di Venezia nella storia e nel mondoNessuna valutazione finora
- 1 Arte Preistoria Vcino OrienteDocumento9 pagine1 Arte Preistoria Vcino OrienteDaniele DanieleNessuna valutazione finora
- La Maniera Moderna A VeneziaDocumento2 pagineLa Maniera Moderna A VeneziaMarco rossiNessuna valutazione finora
- Metodologia Della Storia Dell'arteDocumento32 pagineMetodologia Della Storia Dell'arteIrene FarinelliNessuna valutazione finora
- Astrattismo e Dadaismo: Poetiche dell'antiliricoDa EverandAstrattismo e Dadaismo: Poetiche dell'antiliricoNessuna valutazione finora
- RIASSUNTO La Storia Dell'arte. Dal Barocco All'art Nouveau, Vol.4Documento36 pagineRIASSUNTO La Storia Dell'arte. Dal Barocco All'art Nouveau, Vol.4Rebecca BattistiNessuna valutazione finora
- FOTOGRAFIA AppuntiDocumento4 pagineFOTOGRAFIA AppuntiVeronica FidanzatiNessuna valutazione finora
- LEZIONE 3 - ARTE GRECA I ParteDocumento11 pagineLEZIONE 3 - ARTE GRECA I Partenoidea666Nessuna valutazione finora