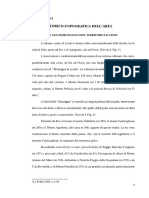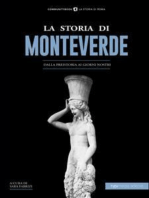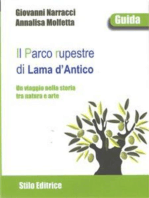Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Storia Geologica Della Zona Di Vigo Di Fassa
Caricato da
Igritan AlinTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Storia Geologica Della Zona Di Vigo Di Fassa
Caricato da
Igritan AlinCopyright:
Formati disponibili
STORIA GEOLOGICA DELLA ZONA DI VIGO DI FASSA
Le rocce pi antiche che affiorano sul territorio del Comune di Vigo appartengono alla
Formazione delle Arenarie di Val Gardena (ad esempio nelle immediate vicinanze degli abitati
di Larzonei e di Tamion e nella zona del Passo di Carezza). Si tratta di prevalenti areniti
rossastre (sabbie cementate), con materiali a grana pi fine e rare intercalazioni dolomitiche e
calcaree. Sono presenti, verso lalto stratigrafico e topografico, strati gessosi, che fanno da
preludio alla successiva formazione geologica.
I materiali a grana fine rappresentano un deposito di piana deltizia terminale, sviluppato in un
contesto climatico tendenzialmente arido con corsi dacqua sottili ed ampi, effimeri, pressoch
privi di alveo e con carico solido esclusivamente fine. Le alternanze gessose potrebbero
rappresentare la transizione ad un ambiente lagunare evaporitico. La consistente porzione
prevalentemente arenitica dellunit rappresenta invece la rapida progradazione di un apparato
fluviale.
1 - Claraia clarai, fossileguida del Triassico inferiore
In questa formazione, nel territorio del Comune di Vigo, sono a volte visibili resti vegetali
carboniosi di piante continentali.
Let attribuibile a questa formazione permiana media e, in parte, superiore. Ci troviamo verso
1/7
STORIA GEOLOGICA DELLA ZONA DI VIGO DI FASSA
la fine dellEra Primaria, il Paleozoico. Sembra che tale formazione geologica inizi a depositarsi
circa 260-255 milioni di anni fa.
A questa formazione succede, stratigraficamente, la Formazione a Bellerophon, ben visibile nei
canyon e nelle piccole incisioni vallive dallabitato di Vallonga verso il Passo Carezza. Si tratta
di prevalenti strati gessosi (di origine evaporitica), con subordinati dolomie e calcari.
Lunit attesta il progressivo instaurarsi, durante il Permiano superiore, di un ambiente marino
marginale che si era rapidamente sostituito alle pianure alluvionali e ai delta terminali della
precedente unit. I depositi calcarei testimoniano lavvento di un ambiente di mare ancora non
profondo ma aperto e distante dalla linea di riva.
2 - Sguardo sul canyondi Ciampede
Il Bellerophon, che ha dato il nome alla formazione, un gasteropode marino che tuttavia non
la caratterizza. Nel territorio comunale di Vigo non sono stati rinvenuti resti di tale chiocciola.
Let di questa formazione geologica va dal Permiano superiore a, grosso modo, il limite
Permo-Trias, limite importante da un punto di vista stratigrafico, poich rappresenta il passaggio
tra due ere geologiche, quella Primaria (Paleozoico) e quella Secondaria (Mesozoico). Da
ricordare che Paleozoico significa letteralmente era degli animali antichi e Mesozoico era
degli animali di mezzo: tra le due ere si avuta una importante estinzione di massa, che ha
portato alla scomparsa di pi del 90% delle specie allora viventi.
La successiva formazione geologica, come gi detto, rappresenta linizio di una nuova era: si
tratta della Formazione di Werfen, che inizia a depositarsi poco pi di 250 milioni di anni fa.
ben riconoscibile, ad esempio, nelle falde rocciose e negli affioramenti nei boschi sopra labitato
di Vigo (verso Vael e verso il Ciampede, compreso lo spettacolare canyon che va da Vigo
2/7
STORIA GEOLOGICA DELLA ZONA DI VIGO DI FASSA
verso la stazione a monte degli impianti funiviari di Ciampede), nonch sul versante della valle
opposto (zona Soraghe). Tale formazione risulta comunque subaffiorante o poco al di sotto del
piano di campagna, nei territori di Costa, Larzonei e Tamion. Si tratta di calcari, calcari marnosi,
calcari oolitici, areniti ed altri materiali depositatisi in bacini acquiferi.
3 - Strati della Formazionedi Werfen, affioranti nellazona di Vael
Lambiente di deposizione di tale formazione geologica comprende zone di piana di marea,
zone evaporitiche e zone di piattaforma carbonatica.
Numerosi sono i fossili presenti nella Formazione di Werfen: si tratta di brachiopodi (Lingula),
bivalvi (il pi famoso la
Claraia clarai, fossile guida del Triassico inferiore), microgasteropodi (Coelostylina, Holopella e
Natiria costata prevalenti), tracce di stelle marine (Asteriacites), ammonoidi (Tirolites cassianus)
e altri fossili in minore quantit, tra i quali alcuni di attribuzione incerta (Problematica), che si
rinvengono solo nel territorio comunale di Vigo e zone limitrofe. Abbastanza frequenti risultano
le strutture sedimentarie da carico e le increspature da onda (ripple marks), testimonianti il moto
ondoso in zone vicino ai limiti di antiche spiagge.
Let di questa formazione abbraccia tutto il Triassico inferiore (piani Induano e Olenekiano).
3/7
STORIA GEOLOGICA DELLA ZONA DI VIGO DI FASSA
Salendo stratigraficamente e, in via di massima, topograficamente, segue, come formazione
geologica, il Conglomerato di Richthofen, che rappresenta una testimonianza di erosione del
Triassico medio basale (piano Anisico). rappresentato prevalentemente da un conglomerato
(ghiaie cementate).
4 Problematicum sp., fossile di attribuzione incerta, che segna la ripresa della vita allinizio dellEra Me
Seguono la Dolomia del Serla e la Formazione di Contrin, caratterizzate da calcari di
piattaforma e da dolomie, affioranti, ad esempio, nelle zone del Ciampede, delle Cigolade e
delle Coronelle. Si tratta di depositi di mare limpido, derivanti dallaccumulo di fanghi e di alghe
calcaree e, subordinatamente, da accumulo organico di altri organismi (ammonoidi,
gasteropodi, bivalvi e altri ancora).
Le formazioni appartengono al Triassico medio, vale a dire, pi in dettaglio, al piano Anisico
inferiore e medio.
A queste formazioni segue la Formazione di Livinallongo, del Triassico medio (piano Ladinico
inferiore). Si tratta di depositi calcarei generalmente ben stratificati e di livelli di tufiti verdastre
(accumuli di ceneri vulcaniche, provenienti da zone lontane, forse da vulcani sepolti nelle
pianure venete), che indicano un mare pi profondo rispetto a quello dellepiattaforme
carbonatiche. In questa formazione, nella zona del Ciampede e delle Coronelle, sono stati
trovati, quali fossili, ammonoidi, nautiloidi e bivalvi.
4/7
STORIA GEOLOGICA DELLA ZONA DI VIGO DI FASSA
5 Increspature da interferenza di onde (= ripple marks), testimonianti ambienti litorali. Sulle increspa
Le cime dolomitiche pi importanti del territorio di Vigo di Fassa risultano costituite perlopi
dalla Dolomia dello Sciliar, rappresentante una importante piattaforma carbonatica, costituita da
calcari e dolomie, che caratterizza praticamente tutte le Dolomiti. Nei calcari e nei calcari
debolmente dolomitizzati si possono trovare resti di alghe calcaree, ammonoidi, bivalvi,
brachiopodi, gasteropodi e, con un po di fortuna, altri fossili molto rari, quali, ad esempio,
articoli di crinoidi e coralli.
In queste formazioni geologiche, a vari livelli, si trovano brecce di esplosione, depositi di
smantellamento di rocce eruttive e sedimentarie (brecce, arenarie ed altro), filoni magmatici,
colate laviche, lave a cuscini ed altre strutture vulcaniche e magmatiche. Si tratta dellevento
magmatico del triassico medio e superiore (di et ladino-carnica, circa 232 milioni di anni fa),
che ha permesso, tra laltro, la genesi di molte specie minerali, a volte anche rare.
6 Sguardo sul Catinaccio
Formazioni geologiche pi recenti non sono presenti sul territorio comunale di Vigo di Fassa,
5/7
STORIA GEOLOGICA DELLA ZONA DI VIGO DI FASSA
poich smantellate dagli agenti atmosferici, ad eccezione di depositi dellultima era geologica, il
Quaternario (chiamato anche Neozoico), che copre, qua e l, buona parte dellareale,
presentandosi sotto forma di depositi alluvionali terrazzati (verso il Torrente Avisio), depositi
morenici di vario tipo (magari rimaneggiati da fenomeni gravitativo-franosi), depositi di versante
(ai piedi delle falde rocciose), depositi di cono detritico-alluvionale (legati al trasporto operato
lungo canaloni, vallette o incisioni dovute a corsi dacqua), depositi cementati di probabile
origine glaciale (quali le brecce, visibili, ad esempio, a fianco del Pont da lInfern, lungo la
statale che porta a Soraga)ed altri ancora.
7 - Poligoni di fango (mud cracks): si tratta di fango calcareo-argilloso essiccato e conservato come st
Da ricordare che le antiche glaciazioni quaternarie (chiamate dai geologi, in ordine di tempo,
Biber, Donau, Gnz, Mindel, Riss e Wrm, questultima terminata circa 10.700 anni fa) hanno
modellato il nostro paesaggio in maniera significativa. Da vedere la splendida zona di accumulo
del ghiacciaio della conca del Ciampede; questo lembo glaciale, scomparso appunto circa
11.000 anni fa, alimentava lateralmente lantico ghiacciaio dellAvisio.
Un ultimo accenno va alle rocce dolomitiche, che rappresentano buona parte delle nostre pareti
rocciose e delle cime pi importanti. Le piattaforme carbonatiche, formatesi in mare con
accumulo di carbonato di calcioCaCO3 si sono (in tempi geologici) trasformate in dolomia, vale
a dire una roccia costituita da carbonato doppio di calcio e magnesio (Ca,Mg)(CaCO
3
. Tale trasformazione dovuta alcontatto con acque ricche in magnesio, provenienti dalla
terraferma e da alcuni vulcani sottomarini. Questo processo viene chiamato dolomitizzazione.
Il processo di dolomitizzazione un processo distruttivo, la roccia diventa omogenea e subisce
un aumentodi porosit, i fossili vengono amalgamati con la roccia e quindi non si vedono pi.
Dove lacqua ricca in magnesio non riuscita a toccare i calcari di piattaforma, vale a dire dove
le scogliere erano emerse dalle acque marine, si possono trovano invece fossili stupendi
6/7
STORIA GEOLOGICA DELLA ZONA DI VIGO DI FASSA
(ovviamente in calcari o, al massimo, in calcari debolmente dolomitizzati).
Fonti:
"I Monti Pallidi, viaggio tra storia e leggenda nell'area dolomitica". Ist. Geogr. de Agostini
Novara, 1989.
"La storia geologica delle Dolomiti", di Alfonso Bosellini. Edizioni Dolomiti, 1989.
"Geologia delle Dolomiti", di Alfonso Bosellini. Athesia, 1996.
7/7
Potrebbero piacerti anche
- Biasotti-Storia Geologica Della LiguriaDocumento8 pagineBiasotti-Storia Geologica Della LiguriaJuanNessuna valutazione finora
- Ciclos OrogenicosDocumento6 pagineCiclos Orogenicosシルバエイドリアン100% (2)
- Dolomiti Geologia e Paesaggio. Di Gabriele Pavan.Documento39 pagineDolomiti Geologia e Paesaggio. Di Gabriele Pavan.Francesco CastellaniNessuna valutazione finora
- Capitolo 4Documento6 pagineCapitolo 4Shelton MavaieieNessuna valutazione finora
- 2017 MarsureDocumento96 pagine2017 MarsureMorenoBaccichetNessuna valutazione finora
- Dalle Rocce Ai Palazzi-Genova RaccontaDocumento8 pagineDalle Rocce Ai Palazzi-Genova RaccontaClaudia Svaha RomanoNessuna valutazione finora
- StratigrafiDocumento8 pagineStratigrafiq1w2e3r4t5y6u7i8oNessuna valutazione finora
- Sinkhole Campania - SarnoDocumento5 pagineSinkhole Campania - SarnoPapa RuoloNessuna valutazione finora
- Rocce Sedim PDFDocumento2 pagineRocce Sedim PDFgrace10000Nessuna valutazione finora
- 7 - Lezione Rocce Sedimentarie (Ingegneria)Documento39 pagine7 - Lezione Rocce Sedimentarie (Ingegneria)Giovanni RossiNessuna valutazione finora
- La Terra DeformataDocumento40 pagineLa Terra DeformataAndrea ParizziNessuna valutazione finora
- 2011 Pannellini R06Documento1 pagina2011 Pannellini R06Philo SophemNessuna valutazione finora
- Rocce Lez01 2020Documento26 pagineRocce Lez01 2020Alessandro SpanuNessuna valutazione finora
- Basameno Magmatismo ItalianoDocumento4 pagineBasameno Magmatismo ItalianocarlodolciNessuna valutazione finora
- Appunti OfiolitiDocumento11 pagineAppunti OfiolitiDavide SchenoneNessuna valutazione finora
- SUBSIDENZADocumento1 paginaSUBSIDENZAGianfilippo SavinoNessuna valutazione finora
- Analisi Geologica e Geomorfologica Sulla Piana Costiera Del Fiume BifernoDocumento10 pagineAnalisi Geologica e Geomorfologica Sulla Piana Costiera Del Fiume BifernoGiuseppe Di CarloNessuna valutazione finora
- Geoloski RjecnikDocumento28 pagineGeoloski RjecnikVrijednostNessuna valutazione finora
- Note Storiche GioiaDocumento28 pagineNote Storiche GioiacriscuoloantoninoluNessuna valutazione finora
- Rosso Ammon I TicoDocumento4 pagineRosso Ammon I Ticopaolo paoliNessuna valutazione finora
- Storia Provincia Di ComoDocumento31 pagineStoria Provincia Di ComoGuido RomanoNessuna valutazione finora
- Glossario Di SpeleologiaDocumento48 pagineGlossario Di Speleologiafranco apponiNessuna valutazione finora
- 6 Bossio STRATIGRAFIA DEL NEOGENE E QUATERNARIO DEL SALENTODocumento31 pagine6 Bossio STRATIGRAFIA DEL NEOGENE E QUATERNARIO DEL SALENTOGianluca BoninsegniNessuna valutazione finora
- Blocco Sardo CorsoDocumento14 pagineBlocco Sardo CorsocarlodolciNessuna valutazione finora
- COLLEGAMENTI MATURITàDocumento34 pagineCOLLEGAMENTI MATURITàsiriaNessuna valutazione finora
- Geografia LazioDocumento39 pagineGeografia LazioGirolamo VetraniNessuna valutazione finora
- DelPrete Et Alii - ISPRA2008Documento70 pagineDelPrete Et Alii - ISPRA2008GiuseppeNessuna valutazione finora
- Elter - Descrizione Geologica Del Tratto Appenninico Tra Liguria Piemonte Ed Emilia R.Documento8 pagineElter - Descrizione Geologica Del Tratto Appenninico Tra Liguria Piemonte Ed Emilia R.irelorisNessuna valutazione finora
- Capo Rama AppuntiDocumento2 pagineCapo Rama AppuntiAnonymous Ywiq3wNessuna valutazione finora
- Tesi 5 - Caso Di StudioDocumento65 pagineTesi 5 - Caso Di StudioMatteo OliveriNessuna valutazione finora
- Storia Geologica Del'ItaliaDocumento2 pagineStoria Geologica Del'ItaliaChristopher LeeNessuna valutazione finora
- TESIDocumento111 pagineTESIFrancesco ParrottaNessuna valutazione finora
- La Storia di Monteverde: Dalla preistoria ai giorni nostriDa EverandLa Storia di Monteverde: Dalla preistoria ai giorni nostriNessuna valutazione finora
- Xyz - PECETTO Di VALENZA Nel MIOCENE Superiore - Word - PresentazioneDocumento2 pagineXyz - PECETTO Di VALENZA Nel MIOCENE Superiore - Word - PresentazionepronaturaalNessuna valutazione finora
- Le Gravine Di GrottaglieDocumento6 pagineLe Gravine Di GrottagliealiceadslNessuna valutazione finora
- 2011 Pannellini R08Documento1 pagina2011 Pannellini R08Philo SophemNessuna valutazione finora
- Ciclos OrogenicosDocumento2 pagineCiclos OrogenicosMiguelitititop BermeoNessuna valutazione finora
- Rocce Magmatiche o IgneeDocumento9 pagineRocce Magmatiche o Igneeludovicarizza2005Nessuna valutazione finora
- Il Territorio Delle Regioni Meridionali Italiane e Possibili ApplicazioniDocumento34 pagineIl Territorio Delle Regioni Meridionali Italiane e Possibili ApplicazioniADRIANO CAPITANINessuna valutazione finora
- Il Parco rupestre di Lama d’Antico: Un viaggio nella storia tra natura e arte - II edizioneDa EverandIl Parco rupestre di Lama d’Antico: Un viaggio nella storia tra natura e arte - II edizioneNessuna valutazione finora
- I Colli EuganiDocumento1 paginaI Colli EuganiFrancesco PalomboNessuna valutazione finora
- L'acqua Che ModellaDocumento11 pagineL'acqua Che Modelladaniela bruniniNessuna valutazione finora
- Il VulcanismoDocumento15 pagineIl Vulcanismodavidecauneac18Nessuna valutazione finora
- Riassunto Margini ConvergentiDocumento12 pagineRiassunto Margini ConvergentiDavide LazeteraNessuna valutazione finora
- Relazione Campagna RamponeDocumento24 pagineRelazione Campagna RamponeRuggero RamponeNessuna valutazione finora
- Caratteri Geologici Della PugliaDocumento1 paginaCaratteri Geologici Della PugliaGianfilippo SavinoNessuna valutazione finora
- Geologia NettunoDocumento15 pagineGeologia NettunoilamarcoNessuna valutazione finora
- Vecchi Ritrovamenti Di Elefanti Nani inDocumento5 pagineVecchi Ritrovamenti Di Elefanti Nani ingiovanni silvio cassarinoNessuna valutazione finora
- 1 PICCOLA STORIA DI RIOFREDDO Preistoria, Equi e Romani PDFDocumento9 pagine1 PICCOLA STORIA DI RIOFREDDO Preistoria, Equi e Romani PDFLuca VerzulliNessuna valutazione finora
- Le RocceDocumento4 pagineLe RocceGianfilippo SavinoNessuna valutazione finora
- Dispense GeografiaDocumento8 pagineDispense GeografiaSophie MiglioratiNessuna valutazione finora
- Le Rocce SedimentarieDocumento3 pagineLe Rocce SedimentarieRonnie JamesDioNessuna valutazione finora
- Contributo alla conoscenza della Malacofauna Marina della Riviera del Conero e dintorniDa EverandContributo alla conoscenza della Malacofauna Marina della Riviera del Conero e dintorniNessuna valutazione finora
- L'alba di una tragedia italiana: Il terremoto di Messina e Reggio-Calabria del 1908Da EverandL'alba di una tragedia italiana: Il terremoto di Messina e Reggio-Calabria del 1908Nessuna valutazione finora
- Monti Lessini Pasubio Piccole DolomitiDocumento82 pagineMonti Lessini Pasubio Piccole Dolomiticactusmtb100% (1)
- Geologia StoricaDocumento10 pagineGeologia StoricaMarta OreficiniNessuna valutazione finora
- Capitolo 4Documento5 pagineCapitolo 4Raffaele ZenobjNessuna valutazione finora
- PctoDocumento27 paginePctogaia.aloisio24Nessuna valutazione finora
- Sistemi Idraulici Ipogei Nell'area Di Santa Sabina A RomaDocumento12 pagineSistemi Idraulici Ipogei Nell'area Di Santa Sabina A RomavitcolNessuna valutazione finora