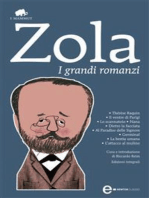Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
00 Letteratura1
Caricato da
Tommaso BaccanTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
00 Letteratura1
Caricato da
Tommaso BaccanCopyright:
Formati disponibili
Anna Bettoni
Da Flaubert ai giorni nostri
Testi e percorsi storico-letterari
SUPPORTO ANTOLOGICO PER IL PROGRAMMA DI LETTERATURA FRANCESE 1
Corso di laurea triennale in Lingue, Letterature e Mediazione culturale
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Studi linguistici e letterari
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 1
Il presente supporto antologico per il programma di Letteratura francese 1 costituisce base e premessa all’analisi
dei dieci testi, che qui sono riprodotti, provvisti ognuno di introduzione storico-critica. Tali testi saranno oggetto
di spiegazione e commento nel corso delle lezioni, a.a. 2023/24.
Ogni utilizzo commerciale del presente supporto antologico è vietato e perseguibile per Legge, trattandosi di
materiale didattico gratuito, riservato ad utenti @studenti.unipd.it
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Studi linguistici e letterari
foto di copertina:
cliché Anna Bettoni – Médiathèque Michel-Crépeau, La Rochelle, Charente Maritime, F
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 2
1857: Gustave FLAUBERT, Madame Bovary p. 5
1857(-1868): Charles BAUDELAIRE, Les Fleurs du Mal p. 8
1879: Edmond de GONCOURT, Les Frères Zemganno p. 11
1913: Marcel PROUST, Du côté de chez Swann p. 14
1931: Antoine de SAINT-EXUPÉRY, Vol de nuit p. 18
1935: Jean GIRAUDOUX, La Guerre de Troie n’aura pas lieu p. 22
1956: Albert CAMUS, La Chute p. 26
1958: Philippe JACCOTTET, L’Ignorant p. 29
1975: Romain GARY, La Vie devant soi p. 32
2001: Jean-Christophe RUFIN, Rouge Brésil p. 35
Bibliografia p. 39
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 3
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 4
1857
Madame Bovary
Gustave Flaubert
(1821-1880)
Maestro di realismo, Gustave Flaubert (1821-1880) ha legato il suo capolavoro, il romanzo Madame
Bovary, alla cancellazione di ogni interferenza d’autore: identico e totalmente sovrapposto alla sua
eroina, l’autore era scomparso dal testo, non c’era, non poteva dar giudizi. Non guardava la storia
dall’esterno, poiché l’aveva lasciata allo sguardo e all’intimo sentire dei suoi personaggi. Era diventato
Emma e, per spiegare quest’estrema adesione alla sola realtà di Emma, senza che potesse esistere né
fosse pertinente la realtà dell’uomo Gustave Flaubert, aveva detto «Madame Bovary c’est moi».
Frase celebre, quasi aforistica, capace di scioccare il lettore borghese dell’epoca, come persino di
suscitare le reazioni della censura che, dalla letteratura, credeva di poter aspettarsi sempre una posizione
morale chiara, un giudizio esplicito. Emma, che con i suoi sogni costruisce sempre di più, lungo tutto il
romanzo, una personale indipendenza dalla morale comune, semplicemente spezza – come ha scritto
Göran Blix – quel ruolo di secondo piano che la società le aveva attribuito: ruolo di devota moglie del
medico del paese. Apparentemente scagliato contro l’ordine borghese, il suo adulterio nasce da un
silenzioso ascolto delle passioni, dalla percezione del «mormorio dell’anima» – come leggiamo nel
brano qui riportato in forma antologica. Il romanzo non ne fa il centro della storia, non lo racconta per
elaborare sentenze. Ma, per l’oscurantismo del Secondo Impero, Emma non avrebbe potuto aver solo i
suoi occhi per tutte le pagine del romanzo, e solo il suo cuore, e solo le sue aspirazioni. Era un
personaggio che sfuggiva alla presa dei buoni costumi.
Giovane di campagna, educata dalle Orsoline, dotata di maniere raffinate e di buoni presupposti di
cultura, sposata a un medico più anziano di lei, rinchiusa nelle abitudini piccolo-borghesi di una cittadina
che, nella realtà topografica francese era Ry, nella Seine-Maritime, e che diventa Yonville nelle pagine
del romanzo, Emma pare ricalcare il percorso tragico di una tale Adèle-Delphine Couturier, moglie di
un ufficiale sanitario della regione, morta a soli 27 anni nel 1848, sommersa dai debiti e ripetutamente
‘macchiata’ da amori adulteri. Eppure tutto la allontana da questa figura di partenza, probabile fonte
ispiratrice di Flaubert: Emma è un personaggio perfettamente emblematico. Qualsiasi lettrice, qualsiasi
lettore poteva trovare in lei un tratto che gli era famigliare, una caratteristica comune, un sentimento che
le o gli apparteneva, perché Emma era una sintesi di molti tratti, estremamente realistici. La ‘somma’
che Emma rappresentava era frutto di fantasia letteraria, personaggio-tipo inesistente nella realtà: ma i
tratti che la componevano erano ad uno ad uno pescati, con attenzione minuziosa, nella società di
provincia, nel mondo che gravitava attorno alle professioni mediche nella Normandia degli anni ’40
dell’Ottocento, nelle letture di cui si nutriva il pubblico femminile dell’epoca. Era facile trovare elementi
di adesione al testo, leggendo. Per questo Madame Bovary fu oggetto di un procedimento giudiziario,
accusato di oltraggio ai buoni costumi, oltraggio alla morale religiosa e oltraggio alla morale pubblica
dal Tribunale correzionale di Parigi.
Uscì inizialmente a puntate nella Revue de Paris, in sei numeri, dal 1° ottobre al 15 dicembre 1856. Ma,
avendo constatato la soppressione di alcuni passi di testo, evidentemente ritenuti scabrosi dalla
redazione della rivista, Flaubert rinnegò il valore d’insieme della pubblicazione con una celebre lettera
del 15 dicembre 1856. Il 24 dicembre cedeva quindi i diritti di edizione integrale del romanzo a Michel
Lévy, che lo pubblicò nell’aprile 1857, dopo la chiusura del processo cui Madame Bovary fu sottoposto.
Flaubert, il suo romanzo e l’editore furono infatti assolti, e senza spese, il 7 febbraio 1857, dopo che il
Tribunale ebbe riconosciuto il lavoro letterario dell’autore come lavoro serio, anche se «impregnato di
un realismo volgare», e ammesso che l’arte, per quanto finalizzata al bene, può non essere sempre «casta
e pura nell’espressione».
Madame Bovary fu anche ripetutamente illustrato, per l’edizione a stampa, dal 1878 ad oggi. Venne più
volte adattato per il teatro, e per esempio dal belga Paul Emond per la regia di Sandrine Molaro e Gilles-
Vincent Kapps nel 2015. Fu di grande ispirazione per il cinema, con risultati spesso molto convincenti,
come il film di Sophie Barthes (2014), con Mia Wasikowska e Ezra Miller.
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 5
L’estratto che riportiamo qui fa parte del capitolo 3 della seconda parte del romanzo. Per collocarlo nella
trama, sarà utile sapere che, avendo da poco partorito ed avendo messo a balia la neonata, come in uso
all’epoca, per le prime settimane di allattamento, Emma si era recata a far visita alla bambina. Pur nella
debolezza del puerperio, aveva intrapreso la lunga strada che la portava all’estremità del paese, ai piedi
della collina. Prima di lasciare la strada maestra, aveva incontrato ‘il signor’ Léon, praticante in uno
studio notarile, già conosciuto nella stretta cerchia della borghesia di Yonville: a lui aveva chiesto di
accompagnarla. A conclusione della visita presso la balia, Emma e Léon ripercorrono la strada di ritorno,
fino a casa Bovary.
cfr. Jacques Suffel, «Préface», in Gustave Flaubert, Madame Bovary, Paris, Garnier Flammarion, 1979, pp. 13-27;
Revue Flaubert, n° 8, 2008, «Madame Bovary, encore»; Pierre-Louis Rey, «Questions de savoir-vivre», in Pierre-
Louis Rey et Gisèle Séginger (dir.), Madame Bovary et les savoirs, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2009, pp.
123-131; Göran Blix, «Le personnage et son milieu: réalisme et liberté dans Madame Bovary», ivi, pp. 243-256;
Bruno Gallice, «Rémanence de Madame Bovary dans l’édition illustrée», Flaubert. Revue critique et génétique,
12, 2014, doi.org/10.4000/flaubert.2356; Pierre-Louis Rey, «La beauté d’Emma», in Steve Murphy (dir.),
L’Aventure interprétative. Hommage à Georges Kliebenstein, Paris, Classiques Garnier, 2022, pp. 283-295; Régis
Jauffret, Dictionnaire amoureux de Flaubert, Paris, Plon, 2023.
Texte, d’après le chapitre II, 3
Ils [Emma et M. Léon] s’en revinrent à Yonville en suivant le bord de l’eau. Dans la saison chaude, la
berge plus élargie découvrait jusqu’à leur base les murs des jardins, qui avaient un escalier de quelques
marches descendant à la rivière. Elle coulait sans bruit, rapide et froide à l’œil ; de grandes herbes minces
s’y courbaient ensemble, selon le courant qui les poussait, et comme des chevelures vertes abandonnées
s’étalaient dans sa limpidité. Quelquefois, à la pointe des joncs ou sur la feuille des nénuphars, un insecte
à pattes fines marchait ou se posait. Le soleil traversait d’un rayon les petits globules bleus des ondes
qui se succédaient en se crevant ; les vieux saules ébranchés miraient dans l’eau leur écorce grise ; au-
delà, tout alentour, la prairie semblait vide. C’était l’heure du dîner dans les fermes, et la jeune femme
et son compagnon n’entendaient en marchant que la cadence de leurs pas sur la terre du sentier, les
paroles qu’ils se disaient, et le frôlement de la robe d’Emma qui bruissait tout autour d’elle.
Les murs des jardins, garnis à leur chaperon de morceaux de bouteilles, étaient chauds comme le vitrage
d’une serre. Dans les briques, des ravenelles avaient poussé, et, du bord de son ombrelle déployée,
Mme Bovary, tout en passant, faisait s’égrener en poussière jaune un peu de leurs fleurs flétries, ou bien
quelque branche des chèvrefeuilles et des clématites qui pendaient en dehors traînait un moment sur la
soie, en s’accrochant aux effilés.
Ils causaient d’une troupe de danseurs espagnols, que l’on attendait bientôt sur le théâtre de Rouen.
— Vous irez ? demanda-t-elle.
— Si je le peux, répondit-il.
N’avaient-ils rien autre chose à se dire ? Leurs yeux pourtant étaient pleins d’une causerie plus sérieuse ;
et, tandis qu’ils s’efforçaient à trouver des phrases banales, ils sentaient une même langueur les envahir
tous les deux ; c’était comme un murmure de l’âme, profond, continu, qui dominait celui des voix.
Surpris d’étonnement à cette suavité nouvelle, ils ne songeaient pas à s’en raconter la sensation ou à en
découvrir la cause. Les bonheurs futurs, comme les rivages des tropiques, projettent sur l’immensité qui
les précède leurs mollesses natales, une brise parfumée, et l’on s’assoupit dans cet enivrement, sans
même s’inquiéter de l’horizon que l’on n’aperçoit pas.
La terre, à un endroit, se trouvait effondrée par le pas des bestiaux ; il fallut marcher sur de grosses
pierres vertes, espacées dans la boue. Souvent, elle s’arrêtait une minute à regarder où poser sa bottine,
– et, chancelant sur le caillou qui tremblait, les coudes en l’air, la taille penchée, l’œil indécis, elle riait
alors, de peur de tomber dans les flaques d’eau.
Quand ils furent arrivés devant son jardin, Mme Bovary poussa la petite barrière, monta les marches en
courant et disparut.
Gustave Flaubert, Madame Bovary, préface par Jacques Suffel, Paris, Garnier Flammarion, 1979, pp. 127-129
Testo, tratto dal cap. 3 della Parte II
Rientrarono a Yonville seguendo la riva. Nella stagione calda l’argine, più largo, lasciava vedere fino
alla base i muri dei giardini con le loro corte scalette che scendevano al fiume. E il fiume scorreva
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 6
silenzioso, rapido e freddo allo sguardo; lunghi esili steli vi si curvavano tutti insieme, secondo
gl’impulsi della corrente, adagiandosi nella sua limpidezza come verdi chiome sparse. Talvolta, sulla
punta dei giunchi o sulle foglie delle ninfee, si muoveva o si posava un insetto dalle zampe filiformi. Il
sole trafiggeva con un raggio le bollicine azzurre delle onde che si rincorrevano rompendosi; vecchi
salici sfrondati specchiavano nell’acqua la scorza grigia; al di là, tutt’intorno, i prati sembravano vuoti.
Era l’ora della cena alle fattorie, e la giovane donna e il suo compagno non sentivano, camminando, che
la cadenza dei loro passi sulla terra del sentiero, le parole che si dicevano, e il frusciare leggero del
vestito intorno al corpo di Emma.
I muri dei giardini, irti sulla cima di cocci di bottiglia, erano caldi come la vetrata di una serra. Nelle
fessure dei mattoni erano cresciuti rafani selvatici; l’orlo dell’ombrellino aperto di madame Bovary ne
sfiorava la corolla appassita dissolvendola in una sfarinatura gialla, oppure qualche pendulo tralcio di
caprifoglio o di clematide scivolava lungo la seta impigliandosi nelle frange.
Parlavano di una compagnia di danzatori spagnoli di cui era imminente l’arrivo al teatro di Rouen.
«Ci andrete?» domandò lei.
«Se posso» lui rispose.
Non avevano nient’altro da dirsi? Eppure i loro occhi erano pieni di un discorso più serio; e mentre si
sforzavano di trovare qualche frase banale, si sentivano invadere insieme dal medesimo languore; era
come un mormorio dell’anima, profondo, continuo, che dominava quello delle voci. Colti dallo stupore
di quella soavità tutta nuova, non pensavano a comunicarsene la sensazione o a scoprirne la causa. Le
felicità future, come le rive dei tropici, proiettano sull’immensità che le precede le loro mollezze native,
una brezza profumata, e inebriati scivoliamo nel torpore senza nemmeno preoccuparci dell’orizzonte
che non si vede.
A un certo punto, per il continuo transito delle mandrie il terreno si affossava; fu necessario camminare
su certi pietroni verdi distanziati nella fanghiglia. Spesso lei si fermava un attimo, studiando dove fosse
meglio posare lo stivaletto e vacillando sul sasso instabile – gomiti allargati, busto curvo in avanti,
sguardo indeciso –, rideva per la paura di cadere nelle pozzanghere.
Arrivati che furono davanti al suo giardino, madame Bovary spinse il cancelletto, salì correndo gli
scalini e sparì.
trad. it.: Gustave Flaubert, Madame Bovary. Costumi di provincia, traduzione di Maria Luisa Spaziani,
introduzione di Antonia S. Byatt, Milano, Mondadori – “Oscar scuola”, 2014, pp. 106-108
illustrazione di Albert Fourié incisa per acquaforte da Eugène Abot, in Gustave Flaubert, Madame Bovary, mœurs de
province, avec 12 compositions par Albert Fourié gravées à l’eau-forte par Eugène Abot et Daniel Mordant, Paris, A.
Quantin, 1885, tavola f.t. fra p. 106 e p. 107, esemplare della Bibliothèque nationale de France, Réserve des livres rares,
RES P-Y2-1441, disponibile in https://gallica.bnf.fr
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 7
1857(-1868)
Les Fleurs du Mal
Charles Baudelaire
(1821-1867)
Nella storia della letteratura francese, Baudelaire viene definito come il padre della poesia moderna.
Con le parole di Erich Auerbach, potremmo precisare il suo ruolo come quello dell’artista che
costantemente ha lottato, passo dopo passo, nell’itinerario tracciato dalle sue Fleurs du Mal, per
qualcosa di assoluto. Coltivando il disprezzo della «realtà preformata dell’epoca in cui viveva»,
Baudelaire ha fatto della poesia l’emblema perfetto della ricerca, dell’aspirazione infinita verso questo
assoluto che, nei suoi versi, prende il nome di Ignoto, Nuovo, Altrove, Ideale, Abisso, Bene, Male:
«Inconnu», «nouveau», «Ailleurs», «Idéal», «abîme», «Bien», «Mal».
Per comporre le tappe della ricerca, Baudelaire ha dato forma a una raccolta poetica in termini
paradossalmente antologici. Le Fleurs del suo titolo sono un evidente accenno al greco ἄνϑη (ànthē),
fiori ‒ da cui ἀνϑολογία, scelta di fiori ‒ e presentano l’opera dunque come una scelta, operata a monte,
dall’autore: una scelta di poesie del Male, come fossero testi-campione, prelevati da tutto il Male
percepito dal poeta e fatto oggetto di elaborazione artistica. Inaugura, infatti, l’opera un significativo ex-
ergo di 6 versi, tratti dall’epopea cinquecentesca dei Tragiques di Agrippa d’Aubigné, il poeta-soldato
dell’epoca delle guerre di religione in Francia, che aveva conosciuto la violenza del Male: «On dit qu’il
faut couler les exécrables choses / Dans le puits de l’oubli et au sépulcre encloses, / Et que par les écrits
le mal ressuscité / Infectera les mœurs de la postérité; / Mais le vice n’a point pour mère la science, / Et
la vertu n’est pas fille de l’ignorance». Legittimando il Male come argomento di poesia, come oggetto
necessario all’uomo che vuole veramente vedere il percorso da compiere, Baudelaire rivendica con la
sua opera il potere di una verità artistica dura, violenta, esplicita nel disincanto. Questa verità, che solo
l’arte sa tenere in mano, crea nelle Fleurs du Mal un Uomo nuovo, a mille miglia di distanza dal
Romanticismo di inizio secolo: è il mezzo per dare a leggere, di fondo, molto di più di un percorso
esistenziale. Dà a leggere una metafisica.
Nell’edizione definitiva, sei sono le sezioni in cui è articolato il percorso, dopo la dedica Al Lettore,
letteralmente sedotto (condotto dentro al testo) come figura di ipocrita fratello del poeta, «Hypocrite
lecteur, ‒ mon semblable, ‒ mon frère!», che vorrebbe fingere di non conoscere la realtà opprimente e
preformata: non conoscere la Noia («l’Ennui!», «ce monstre délicat»). Le sezioni hanno titolo 1. «Spleen
et Idéal», 2. «Tableaux parisiens», 3. «Le vin», 4. «Fleurs du Mal», 5. «Révolte», 6. «La mort» e
costituiscono i sei momenti della ricerca dell’assoluto, come le sei tappe di un itinerario di cui l’io
poetante, emblema dell’Uomo, è protagonista. La ricerca inizia avendo come oggetto l’Ideale sulla terra,
in una lotta contro i vincoli concreti del Tempo, per poi fallire e cadere nell’avvilimento dello spleen,
‘coperchio’ metafisico, che opprime l’Uomo ed il suo anelito («Spleen et Idéal»). Viene tentata quindi
la via dell’immersione nella città («Tableaux parisiens»), in comunione con le persone che la abitano;
poi la via dell’artificio («Le vin»), quella delle depravazioni («Fleurs du Mal»), prima di arrivare alla
più amara rivolta («Révolte») e trovare via d’uscita solo nel viaggio verso l’Ignoto, scegliendo di
prendere la morte come unica fedele compagna («Mort») e soprattutto come capitano della nave che
attraverserà tutti i limiti, anche fino in fondo agli abissi, «Au fond de l’Inconnu, pour trouver du
nouveau».
La raccolta poetica delle Fleurs du Mal è dunque il luogo letterario (fatto di parole, suoni, strutture
stilistiche, trame lessicali, suggestioni di senso) in cui si svolge l’itinerario dell’Uomo alla ricerca
dell’assoluto. Il componimento che presentiamo qui, «Élévation», dà il senso di tutta l’ambiguità di tale
itinerario, sicuramente non assimilabile al sogno romantico di un viaggio verso cieli immaginari, mondi
eterei fatti di purissima libertà. Siamo all’inizio del percorso, «Élévation» è la terza poesia della raccolta.
Fa parte della sezione Spleen et Idéal. E, con le sue cinque quartine a rima incrociata, sembra indicare
la strada da seguire verso l’alto e come in volo, per giungere ‒ almeno in forma di auspicio, «Heureux
celui qui peut…» ‒ alla luce assoluta. In realtà, l’attenta lettura della poesia rivela come Baudelaire
componga con raffinata maestria canoni tradizionali antichissimi, per scardinare il sogno poetico del
volo verso luminose libertà. Riprende Lucrezio e i suoi «templa serena», spazi ritagliati nel cielo per il
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 8
solo poeta; riprende Petrarca e l’immagine delle ali dell’ingegno poetico («Mai non poria volar penna
d’ingegno, / […] ove Natura / volò»); e riprende il neoplatonismo del rinascimentale Joachim du Bellay
(«Et vous, mes vers, delivres et legers, / Pour mieulx atteindre aux celestes beautez / Courez par l'air
d’une aele inusitée»). Ma, come ha scritto Philippe Dufour, la strada ha tutte le caratteristiche di un
subdolo specchietto per allodole e conduce questo soggetto fortunato – beato, «heureux» – non a un
assoluto in cieli azzurri e romantici, ma alla comprensione di un linguaggio che per l’uomo comune è
solo muto, un linguaggio ‘altro’: il linguaggio di queste poesie, che sono il senso della vita su cui il
soggetto «plana». Per comprendere, il soggetto discende, invece di elevarsi e, con l’ambiguità, si fa
gioco dei luoghi comuni. Queste poesie sono «fiori», dalla lingua segreta: «Le langage des fleurs» è
quello che dobbiamo capire, per capire Baudelaire.
Les Fleurs du Mal uscirono in prima edizione il 25 giugno 1857 presso Auguste Poulet-Malassis e
Eugène de Broise: erano composte di 100 poesie. Furono oggetto di censura, in quella Francia di
Secondo Impero, e subirono un processo per oltraggio alla morale pubblica. Condannato a sopprimere
6 poesie, contenenti passi ritenuti osceni, grossolanamente realistici e moralmente offensivi, Baudelaire
lavorò ad una seconda edizione, uscita sempre per i tipi di Poulet-Malassis e De Broise nel 1861, senza
i testi censurati ma con 32 poesie in più, per un insieme di 126 componimenti. L’edizione postuma,
curata dagli amici e critici letterari Théodore de Banville e Charles Assélineau per l’editore Michel
Lévy, uscì con 151 poesie nel 1868, sempre senza i testi censurati. Mentre la riabilitazione completa
dell’opera, come della memoria dell’autore, avvenne con sentenza della Camera criminale della Corte
di Cassazione del 31 maggio 1949, che sancì, anche per le poesie a suo tempo condannate, il diritto di
espressione e «les libertés permises à l’artiste».
cfr. Erich Auerbach, «Les Fleurs du Mal e il sublime», in Baudelaire, I Fiori del Male, Les Fleurs du Mal, testo
it./fr. a fronte, trad. di L. De Nardis, con un saggio di E. Auerbach, Milano, Universale Economica Feltrinelli,
1977, pp. XV-XXXVI; Philippe Dufour, «Heureux qui comme Icare…», L’Information littéraire, vol. 55, 2003, 1,
pp. 53-60; Antoine Compagnon, Baudelaire, l’irréductible, Paris, Flammarion – Collection ‘Champs. Essais’,
20212 ; Jean-Marc Chatelain (dir.), Baudelaire, la modernité mélancolique, Paris, Bibliothèque nationale de France
– Catalogue de l’exposition, 2021
Texte: 3. Élévation
Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,
Par-delà le soleil, par-delà les éthers,
Par-delà les confins des sphères étoilées,
Mon esprit, tu te meus avec agilité, 5
Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l’onde,
Tu sillonnes gaiement l’immensité profonde
Avec une indicible et mâle volupté.
Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides;
Va te purifier dans l’air supérieur, 10
Et bois, comme une pure et divine liqueur,
Le feu clair qui remplit les espaces limpides.
Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leur poids l’existence brumeuse,
Heureux celui qui peut d’une aile vigoureuse 15
S’élancer vers les champs lumineux et sereins;
Celui dont les pensers, comme des alouettes,
Vers les cieux le matin prennent un libre essor,
– Qui plane sur la vie, et comprend sans effort
Le langage des fleurs et des choses muettes! 20
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 9
Charles Baudelaire, I Fiori del Male, Les Fleurs du Mal, testo italiano/francese a fronte, traduzione di Luigi De
Nardis, con un saggio di Erich Auerbach, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 1977, p. 16
Testo: 3. Elevazione
In alto, sugli stagni, sulle valli,
sopra i boschi, oltre i monti, sulle nubi
e sui mari, oltre il sole e oltre l’etere,
al di là dei confini delle sfere
stellate, tu, mio spirito, ti muovi
agilmente: dividi la profonda
immensità, come un buon nuotatore
che gode in mezzo alle onde, gaiamente,
con virile e indicibile piacere.
Fuggi lontano da questi miasmi
ammorbanti, e nell’aria superiore
vola a purificarti e bevi come
un liquido divino e puro il fuoco
che colma, chiaro, le regioni limpide.
Fortunato colui che può con ala
vigorosa slanciarsi verso campi
sereni e luminosi, abbandonando
i vasti affanni ed i dolori, peso
gravante sopra la nebbiosa vita;
colui che lascia andare i suoi pensieri
come le lodolette verso i cieli,
nel mattino; colui che sulla vita
plana e, sicuro, intende la segreta
lingua dei fiori e delle cose mute.
Charles Baudelaire, I Fiori del Male, Les Fleurs du Mal, testo italiano/francese a fronte, traduzione di Luigi De
Nardis, con un saggio di Erich Auerbach, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 1977, p. 17
frontespizio della prima edizione delle Fleurs du Mal, con l’ex-ergo di Agrippa d’Aubigné (Charles Baudelaire, Les Fleurs
du Mal, Paris, Auguste Poulet-Malassis et Eugène de Broise Libraires-Éditeurs, 4, rue de Buci, 1857) esemplare della
Bibliothèque nationale de France, Réserve des livres rares, RES SMITH LESOUEF R-7443, disponibile in
https://gallica.bnf.fr
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 10
1879
Les frères Zemganno
Edmond de Goncourt
(1822-1896)
Edmond de Goncourt aveva vissuto per lunghissimi anni una forma eccezionale di comunione artistica
con il fratello, Jules de Goncourt (1830-1870). Romanzieri a quattro mani, solidali in tutti gli aspetti
della creazione letteraria, portavano nelle loro storie la ferma convinzione che scrivere fosse
documentare. Il romanzo era per loro il frutto di un’indagine metodica, minuziosa e vasta al tempo
stesso, sulla realtà che li circondava. Convinti della necessità letteraria del Naturalismo, inteso come
studio scrupoloso e non convenzionale dell’oggetto del narrare, che fosse ripugnante degrado o
profumata bellezza, si definivano « raconteurs du présent », così come gli storici potevano definirsi
«raconteurs du passé». Un romanzo come Sœur Philomène (1861) riusciva, per esempio, a rendere arte
la vita perfettamente documentata di una suora, infermiera in ospedale, fra malattie, medicina e fede,
entro spazi spesso sgradevoli e situazioni tristi. Un romanzo come Manette Salomon (1867) riusciva a
perseguire sempre questa ‘scrittura artistica’ nella storia perfettamente documentata di un pittore di
talento, rovinato dall’amore per la sua bellissima modella, entro il bel mondo che animava le grandi
mostre, l’École des Beaux-Arts, le grandi e piccole sale d’esposizione della capitale. Il Naturalismo era
per loro rigore descrittivo: non era una scelta di campo, fra il brutto e il bello del mondo, fra il disagio e
il privilegio sociale. Lo intendevano come una rivoluzione culturale, che superasse per sempre il rifugio
nell’immaginazione, caratteristico del Romanticismo di inizio secolo.
Rimasto solo, dopo la morte di Jules, Edmond conservò intatto tale progetto narrativo, continuando ad
esser romanziere, oltre che generoso anfitrione, dedito all’accoglienza di letterati e artisti nel suo salotto
di Auteuil. Con uno dei romanzi più significativi dell’epoca, Les Frères Zemganno (1879), rese onore
al rapporto fraterno, alla sintonia nel vivere e nel sentire che intimamente lega tra loro i fratelli,
scegliendo come protagonisti due fratelli, clown e acrobati, entro quel mondo di purissima arte – distante
dalla vita comune – che è il circo. Emblema della fiducia reciproca, l’acrobata è colui che tesse con il
suo doppio, con colui che tende le mani dal trapezio sul lato opposto, con colui che raggiunge la
posizione di presa o di appoggio a terra, l’intesa più totale che si possa immaginare: la sincronia dei
corpi e della mente, fra vuoti, salti, distanze aeree da attraversare con volteggi che, senza intesa,
porterebbero alla rovina, e anche alla morte. Così legati e così fratelli, i due protagonisti, Gianni e Nello,
sono, nel romanzo, alla ricerca dell’impresa acrobatica straordinaria, mai vista prima: alla ricerca di una
creazione artistica completamente nuova, che finirà per dar loro un cognome nuovo, Zemganno, mai
avuto prima. Giungendo alla realizzazione di un numero circense di smisurata audacia – un salto di
Nello in verticale per 14 piedi di altezza, che finisca sulle spalle di Gianni, in piedi in equilibrio sul
bordo di una botte –, i fratelli che avevano infine scelto di chiamarsi Zemganno puntavano alla più alta
libertà: liberi dalle leggi di natura, liberi dalla forza di gravità, persino liberi dalle emozioni dell’essere
umano. Il nuovo cognome faceva di loro degli zigani, o tzigani, o zingari bohémiens, come bohémienne
e di origine nomade era stata la loro mamma, liberi di creare un’arte unica, svincolata da regole
precedenti. Metafora perfetta di qualsiasi creazione artistica, quindi anche della creazione letteraria, la
loro impresa aveva i colori del circo, il belletto ed il costume del pagliaccio, l’aura del saltimbanco.
Mostrava con perfetta evidenza che l’arte era elitaria e paradossale al tempo stesso: acquisita al caro
prezzo della fatica e della malinconia, dello sforzo fisico e dell’impossibilità di lasciar trasparire – mai!
– qualsiasi vena di tristezza, qualsiasi ripensamento, o il sentimento della propria diversità. È grazie a
questa sensibilità nella corrispondenza metaforica fra le arti, che il documento naturalista perde qui ogni
pesantezza: l’indagine di Edmond de Goncourt nel mondo circense era stata impeccabile, e minuziosa è
l’attenzione che, nel romanzo, viene dedicata ad ogni singolo elemento del circo, ai suoi attori, ai gesti,
alle abitudini, agli spazi, agli oggetti, agli animali. Ma, come ha scritto Jacques Noiray, Les Frères
Zemganno sono il romanzo che raggiunge la leggerezza – che è poi la leggerezza tragica del grande salto
nel vuoto dell’acrobata che, per un assurdo destino, non trova il punto d’appoggio finale – con l’eleganza
documentaria, con la fantasia circense scelta quale sublime documento per la creazione letteraria.
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 11
Il romanzo uscì nel 1879 a Parigi per i tipi di Georges Charpentier, fedele editore di Émile Zola e di Guy
de Maupassant, convinto sostenitore della scuola naturalista. Otto furono le edizioni che Charpentier
dovette ristampare in quello stesso anno. Più di un disegnatore e incisore, in seguito, si dedicò alle pagine
dei Frères Zemganno, per rendere con figure la magia dell’opera: nel 1891 uscì l’edizione illustrata dal
catalano Apeles Mestres, nel 1909 quella con le illustrazioni di Jacques Wély e nel 1921 la pregiata
edizione con le acqueforti di Auguste Brouet.
cfr. Jean Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque, Genève, Albert Skira, 1970 (trad. it.: Ritratto
dell’artista da saltimbanco, a cura di Corrado Bologna, Torino, Boringhieri, 1984); Jacques Noiray, «Tristesse de
l’acrobate. Création artistique et fraternité dans Les Frères Zemganno», Revue des Sciences Humaines, 259, juillet-
septembre 2000, pp. 91-110; Christian Galantaris, «L’illustration des romans d’Edmond et Jules de Goncourt»,
Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, 16, 2009, pp. 105-111; Catherine Dousteyssier, «Introduction», in Edmond
de Goncourt, Les frères Zemganno, éd. par C. Dousteyssier-Khoze, Paris, Honoré Champion, 2012, pp. 7-106.
Texte, d’après le chapitre XLII
Dans cette écurie, dans ces coulisses du Cirque, Nello éprouvait une sensation particulière.
Après qu’il s’était fait avec du blanc un visage de statue, dans lequel ne demeurait de vivant que
l’animation de l’œil entre des paupières rougies comme par la gelée, quand il était coiffé de sa perruque
pyramidale, quand il avait sur le dos ces costumes qu’il imaginait lui-même et sur la soie tendre desquels
il aimait à faire appliquer, avec des reliefs trompeurs, une colossale araignée, une chouette aux yeux
d’or, des volées de petites chauves-souris […] qui n’étaient sur l’étoffe qu’une ombre noire et une
silhouette macabre ; alors ‒ et pour peu que la grande glace de l’écurie eût renvoyé deux ou trois fois au
jeune homme son autre lui-même du soir ‒, alors une vie nouvelle, une vie différente de celle du matin,
une vie fantasque se mettait, pour ainsi dire, à couler dans ses veines. Oh ! cela n’allait pas pour le clown
à avoir le sentiment d’une métamorphose, d’une transformation en un homme-statue du pays sublunaire
dont il portait la livrée, non ! mais toutefois il se passait au-dedans de Nello de petits phénomènes
anormaux. Ainsi dans le clown enfariné et habillé de visions, il se faisait aussitôt dans son individu un
sérieux qui, même dans une de ses farces, s’il en faisait une, donnait à cette farce un caractère rêveur, et
qui était comme de la gaieté tout à coup suspendue, arrêtée par quelque chose d’inconnu. Sa voix n’avait
pas absolument le même son qu’elle avait dans la vie ordinaire ; elle était un rien timbrée de la note
grave qu’a, en un parler lent, la voix des émotions humaines. Enfin ses gestes, il y descendait, sans que
Nello le voulût, du funambulesque, et dans ces instants où il n’était pas en scène, et même pour les
actions les plus ordinaires, il sentait ses membres se contourner en des arabesques excentriques. Bien
plus, tout seul, il était poussé à des gestes de somnambule et d’halluciné ; et que les physiologistes
appellent des mouvements symboliques, gestes dont il n’avait pas l’absolue volonté. Il se surprenait à
faire jouer sur le mur, éclairé par un quinquet d’un corridor vide, l’ombre chinoise des doigts de sa main
contractée, s’amusant longtemps de leur danse crochue sur la muraille ; et cela sans but, pour se faire
plaisir à lui tout seul, et comme si son corps obéissait à l’impulsion de courants magnétiques biscornus
et de forces capricantes de la nature.
Puis, peu à peu, en un état à la fois vague et exalté, et comme au milieu d’un léger effacement autour de
lui de la réalité et d’une espèce d’endormement de sa pensée du jour, dans sa tête, semblable à cette tête
vide où l’on voit une cuiller retirer une à une les idées, le clown arrivait à n’avoir plus que le reflet de
sa blanche figure renvoyée par les glaces, les images des monstres que rencontraient ses yeux sur son
habit, et encore, le murmure resté dans ses oreilles de la musique diabolique de son violon.
Et cet état indéfinissable aux sensations fugaces et hétérogènes avait une grande douceur pour Nello,
qui, aux côtés de son frère, toujours la tête baissée et toujours tourmentant le sol d’un bout de bois,
restait, lui, les bras croisés, la tête au mur, les traits dans une sorte de dilatation extatique, avec un pâle
sourire de Pierrot sur sa blanche figure, et immobile, et semblant demander qu’on n’interrompît pas le
doux et riant et bizarre mensonge de son existence au Cirque.
Edmond de Goncourt, Les frères Zemganno, chap. XLII, éd. par Catherine Dousteyssier-Khoze, Paris, Honoré
Champion, 2012, pp. 209-210
Testo, dal capitolo XLII
In questa scuderia, fra le quinte del Circo, Nello provava una sensazione particolare.
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 12
Dopo essersi fatta con la biacca una faccia da statua, in cui, di vivo, rimaneva soltanto l’animazione
dell’occhio fra palpebre arrossate come dal gelo, dopo essersi messo in testa la sua parrucca piramidale,
e aver indossato uno di quei costumi che ideava egli stesso e sulla cui seta morbida amava far applicare,
con rilievi ingannatori, un ragno colossale, una civetta dagli occhi dorati, o sciami di piccoli pipistrelli
[…], che sulla stoffa figuravano soltanto come un’ombra nera ed un macabro contorno, allora (e bastava
che il grande specchio della scuderia gli avesse due o tre volte rimandata l’immagine di quel suo alter-
ego della sera), allora un vita nuova, diversa da quella del mattino, una vita bizzarra si metteva per così
dire a scorrere nelle sue vene. Oh, il clown non arrivava ad avere il sentimento d’una metamorfosi, d’una
trasformazione in uomo-statua dei paesi sublunari di cui egli portava la livrea, no, ma tuttavia nell’intimo
di Nello si verificavano piccoli fenomeni anormali. Così nel clown infarinato e vestito di visioni si
creava d’un tratto una serietà che perfino nelle farse, se egli ne faceva una, introduceva un carattere
trasognato, che era come un’allegria sospesa all’improvviso, fermata da qualcosa d’ignoto. La sua voce
non aveva assolutamente più lo stesso suono che aveva nella vita solita, assumeva un ché del timbro
grave che, in un lento parlare, ha la voce delle emozioni umane. E nei gesti, senza che Nello lo facesse
apposta, entrava qualcosa di funambolesco e, nei momenti in cui non era in scena, e perfino nelle azioni
più normali, egli sentiva le proprie membra atteggiarsi in arabeschi eccentrici. Non basta, anche da solo
egli era spinto a gesti da sonnambulo e da allucinato, di quelli che gli psicologi chiamano movimenti
simbolici, gesti a cui la sua volontà era del tutto estranea. Egli si sorprendeva a far muovere sulla parete
illuminata da una lanterna d’un corridoio vuoto l’ombra cinese delle dita d’una sua mano contratta,
divertendosi a lungo con la loro danza uncinata sul muro: e ciò senza uno scopo, solo per farsi piacere
da solo, e come se il suo corpo avesse obbedito all’impulso di correnti magnetiche cervellotiche e di
forze saltellanti della natura.
Poi, a poco a poco, in uno stato vago ed esaltato ad un tempo, e come in mezzo ad un leggero cancellarsi
della realtà attorno a sé e ad una specie di addormentarsi dei pensieri del giorno nella sua testa, simile a
quella testa vuota in cui si vede un cucchiaio che trae fuori, ad una ad una, le idee, il clown arrivava ad
avere soltanto più il riflesso della sua faccia bianca rimandato dallo specchio, le immagini dei mostri
che i suoi occhi scorgevano sul suo vestito, e poi il mormorio rimastogli negli orecchi della musica
diabolica del suo violino.
Questo stato indefinibile dalle sensazioni fugaci ed eterogenee aveva una grande dolcezza per Nello,
che a fianco del fratello, il quale stava sempre a testa bassa e tormentava il suolo con un pezzo di legno,
rimaneva a braccia conserte, la testa appoggiata al muro, i lineamenti estaticamente dilatati, con un
pallido sorriso da Pierrot sulla faccia bianca, e immobile pareva chiedere che non s’interrompesse la
dolce, ridente e bizzarra menzogna della sua esistenza al Circo.
trad. it.: Edmond de Goncourt, I fratelli Zemgannò, capitolo XLII, traduzione di Pino Bava, Milano, Rizzoli –
B.U.R., 1960, pp. 108-110
illustrazioni di Appeles Mestres, in Edmond de Goncourt, Les Frères Zemganno, illustrations de Apeles Mestres, Madrid-
Paris, La España Editorial-Georges Charpentier et Eugène Fasquelle, 1891, pp. 215, 285, esemplare della Bibliothèque
nationale de France, département Littérature et Art, 8-Y2-46985, disponibile in https://gallica.bnf.fr
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 13
1913
Du côté de chez Swann
Marcel Proust
(1871-1922)
Grande innovatore del genere romanzesco, Marcel Proust seppe creare con La Recherche du temps
perdu un vero e proprio sistema narrativo, gigantesco e perfettamente coerente, per il recupero del tempo
tramite la scrittura. Operatore del ‘sistema’ è la memoria, che può far sorgere immagini del passato in
modo del tutto involontario, come può essere l’effetto di uno sforzo mentale, per una ricostruzione
volontaria di pagine di vita vissuta. Nei due casi, involontaria e sicuramente più potente, o volontaria e
quindi razionale, la memoria opera per la narrazione, è all’origine della scrittura, permette di dare una
forma concreta al tempo che apparentemente scivola o è già scivolato via: la forma letteraria. Sette sono
i diversi romanzi che organizzano tale recupero di un tempo che prende forma: Du côté de chez Swann
(1913), À l’ombre des jeunes-filles en fleur (1919, premio Goncourt), Du côté des Guermantes (1920-
1921), Sodome et Gomorre (1922), ed i postumi La prisonnière (1923), Albertine disparue (1925) e Le
temps retrouvé (1927). Un solo “io” narrativo li anima: è la prima persona singolare di una sorta di alter-
ego dell’autore, che cerca un senso, lungo fasi di una storia non ordinata cronologicamente e
lontanissima dall’idea di autobiografia, lungo tappe di vita che sorgono nel testo per flash-back, per
immagini pescate dal presente, dal passato recente o dal passato antico, dall’età adulta, dalla giovinezza
o dall’infanzia. L’“io” narrante cerca con totale urgenza, pagina dopo pagina, un oggetto, che gli dia
senso. Pagina dopo pagina cerca la propria vita passata, la trova a tratti, la racconta, fino a giungere, nel
Temps retrouvé, alla scoperta di una volontà, che è di fondo una vocazione: la volontà di scrivere.
Scrivere lungamente, scrivere un libro immenso che sappia concretizzare il tempo, e che sappia collocare
nel tempo le vite raccontate. Così, alla domanda che pongono le ultime righe della Recherche – «Mais
était-il encore temps pour moi?», «Ma era ancora tempo per me?» – non è certo necessario che l’“io”
narrante risponda: poiché il tempo della vita è stato ben utilizzato e il libro immenso che il protagonista
scopre di voler scrivere per vivere la “vera vita” è il libro che, con quelle righe, si conclude, e che il
lettore ha dunque appena finito di leggere.
L’urgenza di scrivere è stata infatti la caratteristica più evidente dell’autore Marcel Proust, nato in un
contesto borghese e parigino nel 1871, toccato dalla malattia ‒ l’asma ‒ fin dai primissimi anni ’80, alla
fine della fanciullezza, iper-protetto dall’ambiente famigliare anche per questo, formatosi presso il
prestigioso Lycée Condorcet e poi frequentando negli anni ’90 l’École libre de sciences politiques, la
mondanità culturale della capitale, le conferenze del filosofo Henri Bergson, suo cugino acquisito. Già
autore di Matière et mémoire (1896), Bergson venne accolto al Collège de France il 6 dicembre 1901
proprio con una lezione inaugurale sul ‘pensare’ dell’uomo come possibilità di fissare il tempo.
Proust conobbe presto il lutto, per la perdita del padre e poi della madre, nel 1903 e nel 1905, fu autore
di articoli in riviste di ambito simbolista, ed avviò un romanzo autobiografico che resterà per sempre
incompiuto, Jean Santeuil. Cominciò a dar corpo al progetto della Recherche du temps perdu nel 1909,
mentre le crisi d’asma si facevano più frequenti, più gravi, ed il tempo a disposizione sembrava non
essere lunghissimo. I contatti preliminari per una pubblicazione del primo volume dell’opera, Du côté
de chez Swann, avvennero in quegli anni, con editori quali Fasquelle ed il grande Gaston Gallimard, che
rifiutarono entrambi l’edizione. Du côté de chez Swann uscì presso Bernard Grasset il 14 novembre
1913, con una grossa partecipazione di Proust stesso alle spese: partecipazione che non fu assolutamente
più necessaria in seguito, quando, dopo la conclusione della Prima guerra mondiale e la ripresa delle
attività culturali, l’editore Gallimard si rese conto dell’errore del suo rifiuto e prese in carico l’insieme
dell’opera dall’Ombre des jeunes-filles en fleur fino ai volumi postumi.
Il passo che proponiamo qui, sempre considerato come altamente rappresentativo del procedere
narrativo della Recherche e famosissimo ‒ è il passo ‘della petite madeleine’ ‒, dimostra come il ricordo
possa sorgere per via del tutto involontaria, grazie ad un abbandono dello sforzo razionale per ritrovarlo,
e, una volta identificato nel pozzo profondo del tempo perduto, funzioni da ‘esca’ e calamita del
movimento narrativo, come ha scritto Gérard Genette. Il ricordo diventa un punto, recuperato dal
passato, capace di dar vita a un’infinita reazione a catena, di altri ricordi che ad esso si associano, come
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 14
pezzi di ferro che si attacchino a una calamita appesa a una canna da pesca. Per il tramite dell’analogia,
ricordi adiacenti al primo, a lui simili, con lui legati e da lui ‘contagiati’ mnemonicamente, sorgono in
modo esponenziale e creano pagine di racconto, movimento del tempo e delle pagine che gli danno
forma: fanno nascere l’edificio immenso che il romanzo rappresenta.
cfr. Isabelle Serça (dir.), Proust et le temps. Un dictionnaire, Paris, Éditions Le Pommier, 2022; Annick
Bouillaguet et Brian G. Rogers (dir.), Dictionnaire Marcel Proust, Paris, Honoré Champion, 20142
Texte, d’après la Première partie, « Combray »
Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n’était pas le théâtre et le drame de mon
coucher n’existait plus pour moi, quand un jour d’hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant
que j’avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d’abord
et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites
Madeleines qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d’une coquille de Saint-Jacques. Et
bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d’un triste lendemain, je portai à
mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine. Mais à l’instant
même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se
passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il
m’avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté
illusoire, de la même façon qu’opère l’amour, en me remplissant d’une essence précieuse : ou plutôt
cette essence n’était pas en moi, elle était moi. J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel.
D’où avait pu me venir cette puissante joie ? Je sentais qu’elle était liée au goût du thé et du gâteau,
mais qu’elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D’où venait-elle ? Que signifiait-
elle ? Où l’appréhender ? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première,
une troisième qui m’apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m’arrête, la vertu du
breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n’est pas en lui, mais en moi. Il l’y a
éveillée, mais ne la connaît pas, et ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force,
ce même témoignage que je ne sais pas interpréter et que je veux au moins pouvoir lui redemander et
retrouver intact à ma disposition, tout à l’heure, pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse et me
tourne vers mon esprit. C’est à lui de trouver la vérité. Mais comment ? Grave incertitude, toutes les fois
que l’esprit se sent dépassé par lui-même ; quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où
il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher ? pas seulement : créer. Il est en face
de quelque chose qui n’est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière.
Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu, qui n’apportait aucune preuve
logique, mais l’évidence de sa félicité, de sa réalité devant laquelle les autres s’évanouissaient. Je veux
essayer de le faire réapparaître. Je rétrograde par la pensée au moment où je pris la première cuillerée
de thé. Je retrouve le même état, sans une clarté nouvelle. Je demande à mon esprit un effort de plus, de
ramener encore une fois la sensation qui s’enfuit. Et, pour que rien ne brise l’élan dont il va tâcher de la
ressaisir, j’écarte tout obstacle, toute idée étrangère, j’abrite mes oreilles et mon attention contre les
bruits de la chambre voisine. Mais sentant mon esprit qui se fatigue sans réussir, je le force au contraire
à prendre cette distraction que je lui refusais, à penser à autre chose, à se refaire avant une tentative
suprême. Puis une deuxième fois, je fais le vide devant lui, je remets en face de lui la saveur encore
récente de cette première gorgée et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, voudrait
s’élever, quelque chose qu’on aurait désancré, à une grande profondeur; je ne sais ce que c’est, mais
cela monte lentement ; j’éprouve la résistance et j’entends la rumeur des distances traversées. Certes, ce
qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l’image, le souvenir visuel, qui, lié à cette saveur, tente de
la suivre jusqu’à moi. Mais il se débat trop loin, trop confusément ; à peine si je perçois le reflet neutre
où se confond l’insaisissable tourbillon des couleurs remuées ; mais je ne puis distinguer la forme, lui
demander comme au seul interprète possible, de me traduire le témoignage de sa contemporaine, de son
inséparable compagne, la saveur, lui demander de m’apprendre de quelle circonstance particulière, de
quelle époque du passé il s’agit. Arrivera-t-il jusqu’à la surface de ma claire conscience, ce souvenir,
l’instant ancien que l’attraction d’un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever
tout au fond de moi ? Je ne sais. Maintenant je ne sens plus rien, il est arrêté, redescendu peut-être ; qui
sait s’il remontera jamais de sa nuit ? Dix fois il me faut recommencer, me pencher vers lui. Et chaque
fois la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, de toute œuvre importante, m’a conseillé de
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 15
laisser cela, de boire mon thé en pensant simplement à mes ennuis d’aujourd’hui, à mes désirs de demain
qui se laissent remâcher sans peine.
Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût, c’était celui du petit morceau de madeleine que le
dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l’heure de la messe), quand
j’allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m’offrait après l’avoir trempé dans son
infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m’avait rien rappelé avant que je n’y eusse
goûté ; peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des
pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d’autres plus récents ; peut-être
parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s’était
désagrégé ; les formes – et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son
plissage sévère et dévot – s’étaient abolies, ou, ensommeillées, avaient perdu la force d’expansion qui
leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort
des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus
persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler,
à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque
impalpable, l’édifice immense du souvenir.
Marcel Proust, Du côté de chez Swann, préface par Jean Milly, Paris, GF - Flammarion (À la recherche du temps
perdu, I), 1987, pp. 142-146
Testo tratto dalla Prima parte, “Combray”
Già da molti anni, di Combray tutto ciò che non era il teatro e il dramma del coricarmi non esisteva più
per me, quando in una giornata d’inverno, rientrando a casa, mia madre, vedendomi infreddolito, mi
propose di prendere, contrariamente alla mia abitudine, un po’ di tè. Rifiutai dapprima, e poi, non so
perché, mutai d’avviso. Ella mandò a prendere uno di quei biscotti pienotti e corti chiamati Petites
Madeleines, che paiono aver avuto come stampo la valva scanalata d’una conchiglia di san Giacomo.
Ed ecco, macchinalmente, oppresso dalla giornata grigia e dalla previsione di un triste domani, portai
alle labbra un cucchiaino di tè, in cui avevo inzuppato un pezzetto di madeleine. Ma, nel momento stesso
che quel sorso misto a briciole di biscotto toccò il mio palato, trasalii, attento a quanto avveniva in me
di straordinario. Un piacere delizioso m’aveva invaso, isolato, senza nozione della sua causa. M’aveva
subito reso indifferenti le vicissitudini della vita, le sue calamità inoffensive, la sua brevità illusoria, nel
modo stesso in cui agisce l’amore, colmandomi d’un’essenza preziosa: o meglio quest’essenza non era
in me, era me stesso. Avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale. Donde m’era potuta
venire quella gioia violenta? Sentivo ch’era legata al sapore del tè e del biscotto, ma lo sorpassava
incommensurabilmente, non doveva essere della stessa natura. Donde veniva? Che significava? Dove
afferrarla? Bevo un secondo sorso in cui non trovo nulla di più che nel primo, un terzo dal quale ricevo
meno che dal secondo. È tempo che io mi fermi, la virtù della bevanda sembra diminuire. È chiaro che
la verità che cerco non è in essa, ma in me. Essa l’ha risvegliata, ma non la conosce, e non può che
ripetere indefinitamente, con forza sempre minore, quella stessa testimonianza che io sono incapace di
interpretare e che voglio almeno poterle domandare di nuovo e ritrovare a mia disposizione intatta, fra
poco, per una spiegazione decisiva. Depongo la tazza e mi rivolgo al mio animo. Tocca a esso trovare
la verità. Ma come? Grave incertezza, ogni qualvolta l’animo nostro si sente sorpassato da sé medesimo;
quando lui, il ricercatore, è al tempo stesso anche il paese tenebroso dove deve cercare e dove tutto il
suo bagaglio non gli servirà a nulla. Cercare? Non soltanto: creare. Si trova di fronte a qualcosa che
ancora non è, e che esso solo può rendere reale, poi far entrare nella sua luce.
E ricomincio a domandarmi che mai potesse essere quello stato sconosciuto, che non portava con sé
alcuna prova logica, ma l’evidenza della sua felicità, della sua realtà, dinnanzi alla quale ogni altra
svaniva. Voglio provarmi a farlo riapparire. Indietreggio col pensiero al momento in cui ho bevuto il
primo sorso di tè. Ritrovo lo stesso stato, senza una nuova luce. Chiedo al mio animo ancora uno sforzo,
gli chiedo di ricondurmi di nuovo la sensazione che fugge. E perché niente spezzi l’impeto con cui
tenterà di riafferrarla, allontano ogni ostacolo, ogni pensiero estraneo, mi difendo l’udito e l’attenzione
dai rumori della stanza accanto. Ma, sentendo come l’animo mio si stanchi senza successo, lo costringo
a prendersi quella distrazione che gli rifiutavo, a pensare ad altro, a ripigliar vigore prima d’un tentativo
supremo. Poi, una seconda volta, gli faccio intorno il vuoto, di nuovo gli metto di fronte il sapore ancora
recente di quel primo sorso, e sento in me trasalire qualcosa che si sposta e che vorrebbe alzarsi, qualcosa
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 16
che si fosse come disancorata, a una grande profondità; non so che sia, ma sale adagio adagio; sento la
resistenza, e odo il rumore delle distanze traversate. Certo, ciò che palpita così in fondo a me dev’essere
l’immagine, il ricordo visivo che, legato a quel sapore, tenta di seguirlo fino a me. Ma si agita troppo
lontano, in modo troppo confuso; percepisco appena il riflesso neutro in cui si confonde l’inafferrabile
turbinio dei colori smossi; ma non so distinguere la forma, né chiederle, come al solo interprete possibile,
di tradurmi la testimonianza del suo contemporaneo, del suo inseparabile compagno, il sapore, chiederle
di rivelarmi di quale circostanza particolare, di quale epoca del passato si tratti. Toccherà mai la
superficie della mia piena coscienza quel ricordo, l’attimo antico che l’attrazione d’un attimo identico è
venuta così di lontano a richiamare, a commuovere, a sollevare nel più profondo di me stesso? Non so.
Adesso non sento più nulla, s’è fermato, è ridisceso forse; chi sa se risalirà mai dalle sue tenebre? Debbo
ricominciare, chinarmi su di lui dieci volte. E ogni volta la viltà, che ci distoglie da ogni compito
difficile, da ogni impresa importante, m’ha consigliato di lasciar stare, di bere il mio tè pensando
semplicemente ai miei fastidi di oggi, ai miei desiderii di domani, che si possono ripercorrere senza
fatica.
E ad un tratto il ricordo mi è apparso. Quel sapore era quello del pezzetto di madeleine che la domenica
mattina a Combray (giacché quel giorno non uscivo prima della messa), quando andavo a salutarla nella
sua camera, la zia Léonie mi offriva dopo averlo bagnato nel suo infuso di tè o di tiglio. La vista del
biscotto, prima d’assaggiarlo, non m’aveva ricordato niente; forse perché, avendone visti spesso, senza
mangiarli, sui vassoi dei pasticcieri, la loro immagine aveva lasciato quei giorni di Combray per unirsi
ad altri giorni più recenti; forse perché di quei ricordi così a lungo abbandonati fuori dalla memoria,
niente sopravviveva, tutto s’era disgregato; le forme – anche quella della conchiglietta di pasta, così
grassamente sensuale, sotto la sua veste a pieghe severa e devota – erano abolite, o, sonnacchiose,
avevano perduto la forza d’espansione che avrebbe loro permesso di raggiungere la coscienza. Ma,
quando niente sussiste d’un passato antico, dopo la morte degli esseri, dopo la distruzione delle cose,
soli, più tenui ma più vividi, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l’odore e il sapore, lungo tempo
ancora perdurano, come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, sopra la rovina di tutto il resto,
portando sulla loro stilla quasi impalpabile, senza vacillare, l’immenso edificio del ricordo.
trad. it.: Marcel Proust, La strada di Swann, traduzione di Natalia Ginzburg, con un saggio di Giovanni Macchia,
Torino, Einaudi, 1990, pp. 49-52
fotografia attuale (2022) della “Maison de tante Léonie” a Illiers-Combray, 19, rue de Chartres,
sede delle collezioni museali della Société des Amis de Marcel Proust
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 17
1931
Vol de nuit
Antoine de Saint-Exupéry
(1900-1944)
L’opera celeberrima di Saint-Exupéry, Le Petit Prince, uscì per la prima volta durante la Seconda guerra
mondiale, il 6 aprile 1943, negli Stati Uniti, a New York, dove l’autore era stato inviato con funzioni
diplomatiche. Nel suo ruolo di aviatore, pilota militare, rappresentante delle forze dell’Armée de l’Air
contro l’occupazione nazista, Antoine de Saint-Exupéry collaborava all’organizzazione della missione
Béthouart, destinata a prevedere l’aiuto americano, il riarmo dell’esercito francese e soprattutto
l’auspicato sbarco degli Alleati in Provenza. Ma a quell’epoca l’aviatore e diplomatico già chiamato da
tutti “Saint-Ex” (come lo sarà nel film del 1996 con Bruno Ganz) era già uno scrittore di prestigio, con
al suo attivo romanzi di altissimo spessore morale, di seduttiva e raffinata narrazione. Le Petit Prince,
tradotto, ad oggi, in 553 lingue e dialetti nel mondo e venduto in milioni e milioni di copie, presente
ormai in una sorta di immaginario collettivo, quale simbolo del fanciullo che opera con la sua saggia
meraviglia entro l’animo di ogni uomo, era in quel 1943 un semplice tassello di un già ricco percorso
d’autore. Prima di esso, L’Aviateur (1926), Courrier Sud (1929), Vol de nuit (1931), il grande puzzle di
riflessioni e avventure in sintonia con un pianeta da rispettare e proteggere, Terre des hommes (1939),
e poi Pilote de guerre (1942) avevano già creato il mito del pilota-scrittore, dell’animo gentile
dell’aristocratico Saint-Exupéry, votato alla difesa del mondo e degli uomini dall’alto dei cieli che
attraversava in mille occasioni, per incarichi di guerra e incarichi di pace, e dal ‘basso’ di una fantasia
letteraria, fecondissima e pacata al tempo stesso.
Vol de nuit fa parte di questo percorso d’autore e di questo mito, biografico e letterario. È il romanzo
sorprendentemente documentario dell’esorcizzazione della paura grazie alla meraviglia. Racconta
l’azione reale, documentata dall’esperienza concretamente vissuta dai piloti di voli aeropostali, agli
albori dell’aviazione, al servizio di compagnie come la Latécoère, che era stata fondata col nome di
Aeroposta Argentina e fu attiva in Sud America, Marocco e Francia fra il 1926 e il 1931. Ma il romanzo
racconta l’azione quale eroismo, come il normale eroismo di chi ha scelto il rischio per lavoro: volare
in cieli notturni con biplani dalla strumentazione ancora primordiale, per trasportare materiale postale.
E la racconta come il grande, seppur normale eroismo, vissuto da un animo sensibile, capace di cogliere
la poesia del mondo, e affrontato dal coraggio di un pilota rimasto bambino. Come Peter Pan, che certo
non ha paura di volare ed è il fedele compagno delle stelle, il protagonista di Vol de nuit, assoluto doppio
del suo autore, vive fino in fondo l’azione che è suo dovere compiere, assume tutta la responsabilità del
volo, della vita del co-pilota e sua, non smette un solo istante di mettere a frutto la sua profonda
competenza professionale e resta fedele al sogno che lo abita, al fanciullo che è dentro di lui: le immagini
dell’ombra dell’uragano che avvolge l’aereo, l’oscurità della terra o del mare sotto di lui, la minaccia
apparente della morte sanno essere esorcizzate dalla fantasia fatata dell’infanzia, per lui. Ed esorcizzate,
per il lettore, dalla più elevata – in senso di nobiltà letteraria – immaginazione poetica, contro ogni paura.
Premiato con il Prix Femina il 4 dicembre 1931, Vol de nuit ebbe e continua ad avere un successo
enorme, fu tradotto in inglese fin dal 1932 con il titolo di Night Flight. Nel 1933 la Metro Goldwyn
Meyer ne acquistò i diritti per il film che fu in sala nel 1934, con Clark Gable: un successo di pubblico
ugualmente enorme. E tutto questo, senza che Antoine de Saint-Exupéry si facesse mai un vanto, né
della celebrità, né del ruolo che poteva avere all’epoca nel panorama letterario come negli impegni civili
o militari nell’aviazione. Era conte, appartenente ad una delle più antiche casate nobiliari francesi, e
figlio della contessa Marie Boyer de Fonscolombe, artista fervida e indipendente. Aveva avuto
un’infanzia spumeggiante, seppur orfano di padre dall’età di quattro anni, con fratelli e sorelle, fra il
decadente castello di Saint-Maurice de Rémens ed il palazzo di famiglia a Lione. E poi una vita intensa,
fatta di insuccessi, successi e continue sfide, di grandi relazioni di amicizia e impegno in tutti i sensi,
sempre al limite di personali e famigliari ristrettezze economiche (di cui in realtà non si curava),
attraversando l’Europa, l’Africa e l’America, fino all’ultima missione di ricognizione aerea, partita il 31
luglio 1944 dalla base dell’Armée de l’Air di Alto, in Corsica, teoricamente diretta verso Grenoble-
Ambérieu-Annecy e conclusasi con la menzione a registro aeronautico di: «pilota non rientrato”». Il suo
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 18
P38 – modello F-5G da ricognizione –, abbattuto da un caccia tedesco, aveva deviato verso il mare,
verso Marsiglia: ma questo lo si saprà più di mezzo secolo più tardi. Nel frattempo, nella famiglia e nei
suoi discendenti (e nel nipote François d’Agay in primis, il figlio di Gabrielle de Saint-Exupéry, sorella
dell’autore), nasceva l’idea di una Fondazione, che destinasse capitali ed impegno a progetti per
l’infanzia e la gioventù, e fosse basata sul rispetto dell’uomo nella totale diversità delle culture, sulla
responsabilità individuale e sulla solidarietà. Prese forma così, nel 2008, la Fondation Antoine de Saint-
Exupéry pour la Jeunesse (FASEJ), il cui celebre motto, tratto dal romanzo postumo Citadelle, è:
«L’avenir, tu n’as point à le prévoir, mais à le permettre».
cfr. Monique Gosselin-Noat, «Introduction», in Saint-Exupéry, Vol de nuit, édition critique par M. Gosselin-Noat,
Genève, Droz, 2017, pp. V-XCVIII
Texte, d’après les chapitres XV et XVII du roman
CHAP. XV […]
Il lui parut que la matière aussi se révoltait. Le moteur, à chaque plongée, vibrait si fort que toute la
masse de l’avion était prise d’un tremblement comme de colère. Fabien usait ses forces à dominer
l’avion, la tête enfoncée dans la carlingue, face à l’horizon gyroscopique, car, au dehors, il ne distinguait
plus la masse du ciel de celle de la terre, perdu dans une ombre où tout se mêlait, une ombre d’origine
des mondes. Mais les aiguilles des indicateurs de position oscillaient de plus en plus vite, devenaient
difficiles à suivre. Déjà le pilote, qu’elles trompaient, se débattait mal, perdait son altitude, s’enlisait
peu à peu dans cette ombre. Il lut sa hauteur : « Cinq cents mètres ». C’était le niveau des collines. Il les
sentit rouler vers lui leurs vagues vertigineuses. Il comprenait aussi que toutes les masses du sol, dont
la moindre l’eût écrasé, étaient comme arrachées de leur support, déboulonnées, et commençaient à
tourner, ivres autour de lui. Et commençaient, autour de lui, une sorte de danse profonde et qui le serrait
de plus en plus.
Il en prit son parti. Au risque d’emboutir, il atterrirait n’importe où. Et, pour éviter au moins les collines,
il lâcha son unique fusée éclairante. La fusée s’enflamma, tournoya, illumina une plaine et s’y éteignit :
c’était la mer.
Il pensa très vite : « Perdu. Quarante degrés de correction, j’ai dérivé quand même. C’est un vrai cyclone.
Où est la terre ? » Il virait plein Ouest. Il pensa : « Sans fusée maintenant, je me tue ». Cela devait arriver
un jour. […] Il aurait pu lutter encore, tenter sa chance : il n’y a pas de fatalité extérieure. Mais il y a
une fatalité intérieure : vient une minute où l’on se découvre vulnérable ; alors les fautes vous attirent
comme un vertige.
Et c’est à cette minute que luirent sur sa tête, dans une déchirure de la tempête, comme un appât mortel
au fond d’une nasse, quelques étoiles.
Il jugea bien que c’était un piège : on voit trois étoiles dans un trou, on monte vers elles, ensuite on ne
peut plus descendre, on reste là à mordre les étoiles…
Mais sa faim de lumière était telle qu’il monta.
CHAP. XVI
Il montait lentement en corrigeant mieux les remous, grâce aux repères qu’offraient les étoiles. Leur
aimant pâle l’attirait. Il avait peiné si longtemps, à la poursuite d’une lumière, qu’il n’aurait plus lâché
la plus confuse. Riche d’une lueur d’auberge, il aurait tourné jusqu’à la mort, autour de ce signe dont il
avait faim. Et voici qu’il montait vers des champs de lumière.
Il s’élevait peu à peu, en spirale, dans le puits qui s’était ouvert, et se refermait au-dessous de lui. Et les
nuages perdaient, à mesure qu’il montait, leur boue d’ombre, ils passaient contre lui, comme des vagues
de plus en plus pures et blanches. Fabien émergea.
Sa surprise fut extrême : la clarté était telle qu’elle l’éblouissait. Il dut, quelques secondes, fermer les
yeux. Il n’aurait jamais cru que les nuages, la nuit, pussent éblouir. Mais la pleine lune et toutes les
constellations leur versaient une neige rayonnante.
L’avion avait gagné d’un seul coup, à la seconde même où il émergeait, un calme qui semblait
extraordinaire. Pas une houle ne l’inclinait. Comme une barque qui passe la digue, il entrait dans les
eaux réservées. Il était pris dans une part de ciel inconnue et cachée comme la baie des îles
bienheureuses. La tempête, au-dessous de lui, formait un autre monde de trois mille mètres d’épaisseur,
parcouru de rafales, de trombes d’eau, d’éclairs, mais elle tournait vers les astres une face de cristal et
de neige.
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 19
Fabien pensait avoir gagné des limbes étranges, car tout devenait lumineux, ses mains, ses vêtements,
ses ailes. Car la lumière ne descendait pas des astres, mais elle se dégageait, au-dessous de lui, autour
de lui, de ces provisions blanches. […]
Pourtant, mille bras obscurs l’avaient lâché. On avait dénoué ses liens, comme ceux d’un prisonnier
qu’on laisse marcher seul, un temps, parmi les fleurs, mais ce jardin était de ceux dont il était interdit de
revenir.
« Trop beau », pensait Fabien. Il errait parmi des étoiles accumulées avec la densité d’un trésor, dans un
monde où rien d’autre, absolument rien d’autre que lui, Fabien, et son camarade, n’était vivant. Pareils
à ces voleurs des villes fabuleuses, murés dans la chambre aux trésors dont ils ne sauront plus sortir.
Parmi des pierreries glacées, ils errent, infiniment riches, mais condamnés.
Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit, édition critique par Monique Gosselin-Noat, Genève, Droz, 2017, pp. 91-
97
Testo tratto dai capitoli XV e XVI del romanzo
CAP. XV […]
Gli parve che anche la materia si ribellasse. A ogni tuffo, il motore vibrava più forte, così forte che tutta
la massa dell’aeroplano era presa da un tremito come di collera. Fabien stancava le sue forze a dominare
l’aeroplano, con la testa nascosta nella carlinga, volto all’orizzonte giroscopico, poiché, fuori, non
distingueva più la massa del cielo da quella della terra, perduto in un’ombra nella quale tutto si mischiava
e si confondeva, un’ombra originaria, simile a quella donde erano usciti i mondi. Ma le sfere degli
indicatori di posizione oscillavano sempre più rapide e diventava difficile seguirle, e già il pilota, ch’esse
ingannavano, si dibatteva male, perdeva quota, affondava a poco a poco in quell’ombra. Lesse la quota:
“Cinquecento metri”. Era il livello delle colline. Le sentiva spingere verso di lui le loro ondate
vertiginose. Capiva inoltre che tutte le masse del suolo, la più piccola delle quali l’avrebbe sfracellato,
erano come strappate dai loro sostegni, schiodate, e cominciavano a girare, libere intorno a lui,
cominciavano, intorno a lui, una specie di danza profonda che lo stringeva sempre di più.
Si decise. Decise di atterrare ovunque, a rischio di sfracellarsi. E, per evitare almeno le colline, lanciò
l’unico razzo illuminante che aveva a bordo. Il razzo s’infiammò, girò, illuminò una pianura e vi si
spense: era il mare.
Egli pensò rapidamente: “Perduto. Quaranta gradi di correzione, e sono ugualmente andato alla deriva.
È un ciclone. Dov’è la terra?” Virò verso ovest, completamente. Pensò: “Ora, senza razzi illuminanti,
non posso che uccidermi”. Doveva finire così, una volta o l’altra […] Egli avrebbe potuto lottare ancora,
tentare tutte le probabilità: la fatalità esteriore non esiste. Ma c’è una fatalità interiore: arriva un minuto
nel quale ci si sente vulnerabili, e, allora, gli errori attirano come una vertigine.
Ed è in questo preciso minuto che sulla sua testa, attraverso una lacerazione della tempesta, come un
richiamo mortale in fondo a una rete, brillarono alcune stelle.
Capì che era un tranello: si vedono tre stelle in un buco, si sale verso di loro; ma poi non si può più
discendere, e si rimane lassù, a mordere le stelle…
Ma la sua fame di luce era tale ch’egli salì.
CAP. XVI
Saliva, correggendo meglio che poteva i risucchi, grazie ai punti di riferimento che offrivano le stelle.
La loro calamita pallida lo attirava. Aveva tanto e così lungamente sofferto alla ricerca d’una luce, che,
trovatala, non avrebbe abbandonato neppure la più confusa. Ricco d’un chiarore d’albergo, avrebbe
girato sino alla morte, attorno a quel segno di cui aveva fame. Ed ecco che saliva verso il campo di luce.
Saliva a poco a poco, a spirale, nel pozzo che s’era aperto e che si richiudeva sotto di lui. E, a misura
ch’egli saliva, le nuvole perdevano il loro fango d’ombra, passavano contro di lui, simili a onde sempre
più bianche. Fabien emerse.
La sua sorpresa fu estrema: la luce era tale che abbagliava. Per qualche secondo fu costretto a chiudere
gli occhi. Non avrebbe mai creduto che, di notte, le nubi potessero abbagliare. Ma la luna piena e tutte
le costellazioni versavano su di loro come un manto di neve, raggiante.
L’aeroplano era improvvisamente sboccato, nello stesso attimo in cui era emerso, in una calma che
pareva straordinaria. Non un’onda che lo facesse inclinare. Come una barca quando passa la diga, esso
entrava in acque riservate. Era preso in una parte sconosciuta del cielo, nascosta come la rada delle isole
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 20
felici. Sotto di lui, la tempesta formava un altro mondo di tremila metri di spessore, percorso da raffiche,
da trombe d’acqua, da lampi; ma essa volgeva agli astri una faccia di neve e di cristallo.
Fabien s’immaginava d’avere raggiunto uno strano limbo, perché tutto si faceva luminoso; le sue mani,
le sue vesti, le sue ali. La luce non scendeva dagli astri, ma si sprigionava, sotto di lui, intorno a lui, da
quei depositi bianchi […].
Nondimeno mille braccia oscure l’avevano abbandonato. I suoi lacci erano stati slegati, come quelli
d’un prigioniero lasciato libero di camminare, per un po’, tra i fiori, anche se entro un giardino da cui
era poi proibito uscire, tornando indietro.
“Troppo bello”, pensò Fabien. Errava tra le stelle accumulate con la densità di un tesoro, in un mondo
nel quale nulla, all’infuori di lui, Fabien, e del suo compagno, era vivo. Simili a quei ladri delle città
favolose, murati entro la stanza del tesoro dalla quale non potranno più uscire. Ed errano, in mezzo a
gelide pietre preziose, infinitamente ricchi, ma condannati.
trad. it.: Antoine de Saint-Exupéry, Volo di notte, traduzione di Cesare Giardini, Milano, Bompiani – Grandi
tascabili, 2020, pp. 80-85
celebre scatto di Roger Viollet (1° gennaio 1929), per Getty Images (©gettyimages):
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), a sinistra, con Henri Guillaumet (1902-1940), all’epoca collega nell’Aeropostale
Latécoère, poi anch’egli pilota di ricognizione agli inizi della Seconda guerra mondiale
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 21
1935
La Guerre de Troie n’aura pas lieu
Jean Giraudoux
(1882-1944)
Originario della piccola cittadina di Bellac, nella Haute-Vienne, non lontano da Limoges, Jean
Giraudoux fu studente liceale a Sceaux e poi universitario a Parigi, dove, nel 1903, venne ammesso
all’École Normale Supérieure. La sua disciplina di predilezione fu la letteratura tedesca e, dopo la
Laurea, visse un lungo periodo in Germania, prima di intraprendere la carriera diplomatica ed entrare al
Ministero degli esteri dal 1910. Chiamato alle armi nel 1914 e ferito nel corso della Prima guerra
mondiale, fu incaricato dal Ministero di importanti missioni in Portogallo e negli Stati Uniti, quale alto
funzionario di Stato, particolarmente stimato per capacità di relazione, competenza e saggezza.
All’inizio della Seconda guerra mondiale, nel 1939, era presidente del Conseil supérieur de
l’Information, istituzione creata per informare e documentare gli organi di Stato ed assistere il Ministro
degli esteri. Dopo aver seguito il governo a Bordeaux nel giugno 1940 ed essersi poi trasferito a casa
della madre a Vichy, visse in modo apparentemente contrastante gli anni dell’Occupazione nazista.
Condannò subito il procedere del Maresciallo Pétain, ma fu tra i pochissimi a conservare la passione per
la cultura tedesca, con la quale vedeva perduto ogni contatto per il permanere della guerra e delle sue
atrocità. E non poté vedere la fine, di quella guerra, né dunque la Liberazione, poiché morì il 31 gennaio
1944, a Parigi, per malattia. Per noi, che leggiamo le sue opere, la sua biografia disegna innanzitutto una
figura profondamente impegnata: scrittore di romanzi, di saggi e soprattutto di testi teatrali, Giraudoux
rappresenta il genio artistico che opera in parallelo ad un credo sociale, al servizio di un mondo migliore,
se non semplicemente al servizio delle Nazioni, per scambi fra politiche e Stati diversi, per una
condivisione di prospettive (anche grazie alla conoscenza delle lingue straniere), sempre contro ogni
tipo di disumanità. Autore originale fin dal suo primo libro, Les provinciales (1909), pubblicò numerose
opere narrative: delicati studi di psicologia femminile (L’école des indifférents, 1911; Simon le
pathétique, 1918; Adorable Clio, 1929; Suzanne et le Pacifique, 1921; Églantine, 1927) e romanzi di
argomento politico (Siegfried et le Limousin, 1922; Bella, 1926). Ma è nel teatro che trasparì ai massimi
livelli la sua genialità: la genialità dell’intellettuale che assume tutta la responsabilità della sua parola e
sa mettere su una scena teatrale i ‘grandi ignobili’, i cosiddetti ‘fabbricanti di tragedie’. Sul palco, a
teatro, l’agire dei fabbricanti di tragedie mostra in modo esplicito come l’atrocità, la guerra, la tragedia
non esisterebbero affatto se predominasse la semplice buona volontà degli uomini. Alla base del
pensiero di Giraudoux e della sua creazione teatrale c’è questa convinzione che possiamo definire
‘minima’: la buona volontà, così come Giraudoux poteva leggerla nella filosofia del Rinascimento e
soprattutto negli Essais di Michel de Montaigne (1533-1592). Egli fa sua la formula secondo cui «Il
n’est rien si beau et légitime que de faire bien l’homme et dûment» (Montaigne, Les Essais, III, 13:
«Non c’è nulla di tanto bello e legittimo, quanto fare l’uomo, bene e debitamente»). Il suo teatro
rappresenta tutti gli ostacoli ‒ spesso stupidamente banali ‒ che si intromettono contro la buona volontà
o che la offuscano: per citare qualche esempio, il dramma Siegfried (1928) pone il problema franco-
tedesco in termini di valore permanente; Judith (1932) traspone in una scena modernissima l’assedio di
Betulia e l’impresa di Giuditta contro il generale assiro, Oloferne; La guerre de Troie n’aura pas lieu
(1935) rende esplicita la volontà completamente malsana di chi sobilla una nazione affinché entri in
guerra, contro il buon senso e la disperata voglia di pace di grandi personaggi come Ettore, da un lato,
o Ulisse, da parte avversa; Pleins pouvoirs (1939) sarà un lucido e poetico bilancio della Francia alla
vigilia della catastrofe nella Seconda guerra mondiale.
Del dramma più celebre, La guerre de Troie n’aura pas lieu, scegliamo qui un passo tratto dal secondo
Atto. È la scena in cui, obbligato a celebrare con un discorso i soldati morti in una guerra appena
conclusa e fermo nella sua intenzione di non intraprendere mai più altre guerre, Ettore ‒ che è un
condottiero ed è figlio del re di Troia ‒ costruisce con profonda ironia la condanna di qualsiasi tipo di
conflitto sanguinario: guerre, battaglie, uccisioni… Il suo pacifismo è potente e la sua posizione, nella
gerarchia monarchica e militare di Troia, gli avrebbe conferito tutti gli elementi per sventare la nuova
guerra che si profilava all’orizzonte: quella con i Greci, che accusavano Troia (e Paride, in primis) di
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 22
aver rapito la bella Elena. Eppure, nonostante gli sforzi del ‘suo’ Ettore, il dramma messo in scena da
Giraudoux non può avere lieto fine, poiché la storia è storia, il poema epico ‒ l’Iliade ‒ è già stato scritto,
la guerra di Troia c’è stata. Per il teatro, sul palco animato dai personaggi della Guerre de Troie n’aura
pas lieu, la responsabilità della conclusione tragica è tutta in carico a figure secondarie, numerose e
banali, capaci di fomentare frenesie di guerra con il loro disordinato parlottìo, con false dicerie e una
gran dose di pregiudizi. Con l’eleganza che la tristezza di Ettore regala allo spettatore, con la pacata
rassegnazione di chi si trova nella trappola di un futuro tragico già esistito, Giraudoux crea, scena dopo
scena, la rappresentazione più alta ‒ anche stilisticamente ‒ della logica umanissima della pace.
cfr. André Job, Giraudoux: l’humanisme républicain à l’épreuve, Paris, Michalon éditeur, 2019
Texte, d’après l’Acte II, scène 5 – personnages : le Géomètre, Hector, Priam, Demokos, la Petite
Polyxène, Hécube, le Garde
[…] LE GEOMETRE
Prononce en tout cas le discours aux morts, Hector. Cela te fera réfléchir...
HECTOR
Il n’y aura pas de discours aux morts.
PRIAM
La cérémonie le comporte. Le général victorieux doit rendre hommage aux morts quand les portes se
ferment.
HECTOR
Un discours aux morts de la guerre, c’est un plaidoyer hypocrite pour les vivants, une demande
d’acquittement. C’est la spécialité des avocats. Je ne suis pas assez sûr de mon innocence...
DEMOKOS
Le commandement est irresponsable.
HECTOR
Hélas, tout le monde l’est, les dieux aussi ! D’ailleurs, je l’ai fait déjà, mon discours aux morts. Je le
leur ai fait à leur dernière minute de vie, alors qu’adossés un peu de biais aux oliviers du champ de
bataille, ils disposaient d’un reste d’ouïe et de regard. Et je peux vous répéter ce que je leur ai dit. Et à
l’éventré, dont les prunelles tournaient déjà, j’ai dit : « Eh bien, mon vieux, ça ne va pas si mal que
ça... » Et à celui dont la massue avait ouvert en deux le crâne : « Ce que tu peux être laid avec ce nez
fendu ! » Et à mon petit écuyer, dont le bras gauche pendait et dont fuyait le dernier sang : « Tu as de la
chance de t’en tirer avec le bras gauche... » Et je suis heureux de leur avoir fait boire à chacun une
suprême goutte à la gourde de la vie. C’était tout ce qu’ils réclamaient, ils sont morts en la suçant... Et
je n’ajouterai pas un mot. Fermez les portes.
LA PETITE POLYXENE
Il est mort aussi, le petit écuyer ?
HECTOR
Oui, mon chat. Il est mort. Il a soulevé la main droite. Quelqu’un que je ne voyais pas le prenait par sa
main valide. Et il est mort.
DEMOKOS
Notre général semble confondre paroles aux mourants et discours aux morts.
PRIAM
Ne t’obstine pas, Hector.
HECTOR
Très bien, très bien, je leur parle... (Il se place au pied des portes). Ô vous qui ne nous entendez pas, qui
ne nous voyez pas, écoutez ces paroles, voyez ce cortège. Nous sommes les vainqueurs. Cela vous est
bien égal, n’est-ce pas ? Vous aussi vous l’êtes. Mais, nous, nous sommes les vainqueurs vivants. C’est
ici que commence la différence. C’est ici que j’ai honte. Je ne sais si dans la foule des morts on distingue
les morts vainqueurs par une cocarde. Les vivants, vainqueurs ou non, ont la vraie cocarde, la double
cocarde. Ce sont leurs yeux. Nous, nous avons deux yeux, mes pauvres amis. Nous voyons le soleil.
Nous faisons tout ce qui se fait dans le soleil. Nous mangeons. Nous buvons... Et dans le clair de lune !
... Nous couchons avec nos femmes... Avec les vôtres aussi...
DEMOKOS
Tu insultes les morts, maintenant ?
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 23
HECTOR
Vraiment, tu crois ?
DEMOKOS
Ou les morts, ou les vivants.
HECTOR
Il y a une distinction...
PRIAM
Achève, Hector... Les Grecs débarquent...
HECTOR
J’achève... Ô vous qui ne sentez pas, qui ne touchez pas, respirez cet encens, touchez ces offrandes.
Puisqu’enfin c’est un général sincère qui vous parle, apprenez que je n’ai pas une tendresse égale, un
respect égal pour vous tous. Tout morts que vous êtes, il y a chez vous la même proportion de braves et
de peureux que chez nous qui avons survécu et vous ne me ferez pas confondre, à la faveur d’une
cérémonie, les morts que j’admire avec les morts que je n’admire pas. Mais ce que j’ai à vous dire
aujourd’hui, c’est que la guerre me semble la recette la plus sordide et la plus hypocrite pour égaliser
les humains et que je n’admets pas plus la mort comme châtiment ou comme expiation au lâche que
comme récompense aux vivants. Aussi qui que vous soyez, vous absents, vous inexistants, vous oubliés,
vous sans occupation, sans repos, sans être, je comprends en effet qu’il faille en fermant ces portes
excuser près de vous ces déserteurs que sont les survivants, et ressentir comme un privilège et un vol
ces deux biens qui s’appellent, de deux noms dont j’espère que la résonance ne vous atteint jamais, la
chaleur et le ciel.
LA PETITE POLYXENE
Les portes se ferment, maman !
HECUBE
Oui, chérie.
[…] HECTOR
C’est fait ? Elles sont fermées ?
LE GARDE
Un coffre-fort...
HECTOR
Nous sommes en paix, père, nous sommes en paix.
Jean Giraudoux, La Guerre de Troie n’aura pas lieu, édition par J. Body, Paris, Gallimard – Folio Théâtre, 2015,
pp. 154-158
Testo tratto dall’Atto II, scena 5 – personaggi: il Geometra, Ettore, Priamo, Demokos, la piccola
Polissena, Ecuba, la Guardia
[…] IL GEOMETRA: Pronuncia comunque il tuo discorso ai morti Ettore, ti farà riflettere…
ETTORE: Non ci sarà nessun discorso ai morti.
PRIAMO: Lo richiede il cerimoniale. Quando si chiudono le porte, il generale vittorioso deve rendere
omaggio ai morti.
ETTORE: Un discorso ai morti della guerra è un’arringa difensiva per i vivi, una domanda d’assoluzione.
Una specialità degli avvocati. Io non sono così sicuro della mia innocenza…
DEMOKOS: Il comando è irresponsabile.
ETTORE: Ahimé, tutti sono irresponsabili, anche gli dei! D’altronde l’ho già fatto il mio discorso ai
morti. Gliel’ho fatto nel loro ultimo minuto di vita, quando appoggiati un po’ di sbieco agli ulivi del
campo di battaglia, disponevano ancora d’un rimasuglio di udito e di vista. Posso ripetervi quello che
ho detto loro. A uno squartato i cui occhi già si socchiudevano ho detto: “E allora vecchio mio, non ti
va poi così male…” E a quello cui la mazza aveva spaccato il cranio: ”Non ti dona affatto il naso rotto!
Sei bruttissimo!” E al piccolo scudiero cui pendeva solo il braccio sinistro, mentre perdeva l’ultimo
sangue: “T’è andata bene di cavartela col sinistro…” E sono felice di aver fatto bere loro, a ciascuno, la
suprema ultima goccia dalla borraccia della vita. Era tutto quello che volevano, e sono morti
sorseggiandosela. Non aggiungerò una parola. Chiudete le porte.
LA PICCOLA POLISSENA
È morto anche lui, il piccolo scudiero?
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 24
ETTORE
Sì, piccola mia. È morto. Ha alzato la mano destra. E qualcuno che io non vedevo lo ha preso per mano,
per la mano buona, e lui è morto.
DEMOKOS: Il nostro generale sembra confondere le parole ai morenti con il discorso ai morti.
PRIAMO: Non ostinarti, Ettore.
ETTORE: D’accordo, d’accordo, gli parlo…(Si mette ai piedi delle porte) O voi che non sentite più, che
non vedete più, ascoltate queste parole, guardate questo corteo. Noi siamo i vincitori. Per voi fa lo stesso,
vero? Anche voi lo siete. Ma noi, noi siamo i vincitori vivi. E questo fa la differenza. E questo mi fa
vergogna. Non so se nella folla dei morti si distinguono i morti vincitori con una coccarda. I vivi,
vincitori o no, hanno la vera coccarda, doppia. Sono gli occhi. Noi abbiamo due occhi, miei poveri
amici. Vediamo il sole. Facciamo tutto quello che si fa sotto il sole. Mangiamo. Beviamo. E sotto il
chiaro di luna… Giaciamo con le nostre donne… e anche con le vostre…
DEMOKOS: Ora insulti i morti?
ETTORE: Lo credi davvero?
DEMOKOS: O i morti, oppure i vivi.
ETTORE: C’è una bella differenza…
PRIAMO: Ettore, prosegui…I Greci stanno sbarcando.
ETTORE: Proseguo… O voi che non annusate più, che non tastate più, respirate questo incenso, toccate
queste offerte. Sappiate infine che è un generale sincero quello che vi parla, non ho una tenerezza uguale
e un rispetto uguale per tutti voi. Tutti siete ugualmente morti, da voi c’è la stessa proporzione di
coraggiosi e di codardi che da noi sopravvissuti e non mi farete confondere, per via della cerimonia, i
morti che ammiro con quelli che non ammiro. Ma quello che voglio dirvi oggi, è che la guerra mi sembra
la ricetta più sordida e più ipocrita per rendere uguali gli umani, e che non ammetto la morte né come
castigo o come espiazione per il vigliacco, né, dall’altro lato, come ricompensa per gli eroi. Inoltre,
chiunque voi siate, voi assenti, voi inesistenti, voi dimenticati, senza occupazioni, senza riposo, senza
essere, capisco in effetti che bisognerebbe, chiudendo queste porte, chiedere scusa a voi per questi
disertori che sono i sopravvissuti, e sentire come un privilegio e come un furto questi due beni che si
chiamano, con due nomi il cui suono spero non vi affligga mai, il calore e il cielo.
LA PICCOLA POLISSENA
Le porte si chiudono, mamma!
ECUBA
Sì, piccola mia.
[…] ETTORE
Fatto? Le porte sono chiuse?
LA GUARDIA
Come una cassaforte...
ETTORE
Siamo in pace, padre, siamo in pace.
trad. it.: Jean Giraudoux, La guerra di Troia non si farà, a cura di Stefano Serri, Torino, Robin Edizioni –
Biblioteca del Vascello, 2020, pp. 142-143
La guerre de Troie n’aura pas lieu, regia teatrale e direzione artistica di Raymond Gérôme, fotografie di Daniel Cande,
Paris, Comédie-Française, 9 gennaio 1988, disponibile in gallica.bnf.fr
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 25
1956
La Chute
Albert Camus
(1913-1960)
La Chute, romanzo uscito nel 1956 nella prestigiosa Collana della Nouvelle Revue Française (nrf) di
Gallimard, è la confessione di tutta un’esistenza. Viene presentata dalla trama narrativa nella sua durata
di cinque giorni e nel contesto, prima, di un bar del porto di Amsterdam, poi dei suoi dintorni, ed anche
a bordo di un battello che solca le acque dello Zuiderzee, il mare interno della capitale olandese. A
parlare, confessandosi, è un ex-avvocato parigino, ritiratosi nelle nebbie del Nord, nella città dei canali
e fra la gente del porto, a sèguito di un evento traumatico accaduto molti anni prima, a Parigi. Ad
ascoltarlo è un interlocutore silenzioso, di cui non abbiamo altre notizie se non quelle che lo stesso
protagonista fornisce, parlandogli: si scopre, pagina dopo pagina, che si tratta di un suo connazionale,
francese e parigino, di professione avvocato, di passaggio ad Amsterdam per i cinque giorni della
narrazione. Ma questi non prende mai la parola. Stilisticamente, il romanzo è costruito senza il minimo
intervento dialogico: è la storia di un percorso esistenziale, raccontata in prima persona (alla prima
persona singolare: «je», «io») a un «vous» (in italiano: a un «Lei») di cui si registrano le reazioni e le
curiosità, senza che questo secondo personaggio del racconto assuma alcuna figura. Il protagonista,
invece, nel corso della sua lunga confessione, assume con sempre maggiore precisione la figura
dell’uomo che ha scoperto di non amare la sua vita: ha avuto l’esperienza traumatica della propria
vigliaccheria, testimone inerte del suicidio di una giovane donna gettatasi nella Senna, e da allora vive,
in piena consapevolezza, la vergogna di se stesso. Si racconta dalla sua posizione di uomo molto, troppo
maturo, come colui che ritiene di aver perso la luce, l’innocenza, il respiro del mattino, e pian piano
trova nel suo interlocutore quella forma di solidarietà che gli permette, alla fine del romanzo, di usare
la prima persona plurale, un «nous» anziché un «je» («Oui, nous avons perdu la lumière, les matins, la
sainte innocence de celui qui se pardonne lui-même»).
Nascendo da riflessioni profondamente radicate nella filosofia dell’Esistenzialismo – corrente di
pensiero di cui Camus fu uno dei massimi esponenti, insieme a Jean-Paul Sartre –, La Chute crea dunque
una finzione narrativa dell’ignominia, caratteristica dell’uomo e ugualmente possibile nell’azione come
nell’inerzia: l’assurdo dell’esistenza risiede qui nella volontà disperata del protagonista, che vorrebbe
dimenticare e dimenticarsi, e verifica quotidianamente di non poterlo fare.
Premio Nobel per la Letteratura nel 1957, morto in un incidente stradale, sull’auto guidata da Michel
Gallimard, di ritorno dal Capodanno del 1960, Albert Camus era nato in Algeria, a Mondovi, nel 1913.
In Francia, negli anni ’30 e poi durante la Seconda Guerra mondiale, fu antifascista e membro al partito
comunista, partecipò alla Resistenza e fu giornalista e direttore della rivista Combat (1944-48). Opere
famosissime come L’Étranger (1942), La Peste (1947) ed il saggio sull’assurdo Le mythe de Sisyphe
(1944) mettono in luce il destino dell’uomo entro una realtà ineluttabile, in cui possono esistere il delitto
involontario o la beffa dell’equivoco. La reazione dell’individuo, nel pensiero di Camus, sfocia quasi
ottimisticamente nella rivolta, intesa come vera e propria morale: l’uomo che si rivolta è colui che,
rifiutando ogni conformismo, riesce, nella solidarietà con i suoi simili, a salvare i grandi ideali di libertà,
giustizia, verità, bellezza.
Il passo della Chute che riportiamo qui, centrale nel romanzo, racconta l’evento traumatico che è
all’origine della svolta esistenziale del protagonista. Molto celebre, è la perfetta rappresentazione
narrativa dello scarto che può verificarsi fra il pensiero e l’azione: racconta la tragedia dell’incongruenza
– possibile in ogni momento della vita di un uomo – fra la volontà (intellettuale) ed il gesto che dovrebbe
derivarne. Racconta la situazione non capita, l’intenzione non còlta, e poi il gesto ineluttabilmente non
compiuto: vista la giovane donna in procinto di gettarsi nella Senna, il protagonista era passato oltre,
senza provare ad avere un contatto con lei, distratto o vigliacco o incapace di comprendere. E, una volta
udito il tonfo del corpo caduto nel fiume, non si era voltato, non era tornato indietro, non si era tuffato
nelle acque della Senna improvvisandosi soccorritore, non aveva nemmeno avvertito nessuno, poi. Tutta
una serie di negativi, e una serie quindi di inerzie che, sul momento, poterono essere in contraddizione
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 26
con il pensiero logico della volontà: aiutare gli altri. Ma che segnarono poi per sempre il procedere di
un’esistenza senza più innocenza.
cfr. Jacqueline Lévi-Valensi, ‘La Chute’ d’Albert Camus, Paris, Gallimard, 1996; Pierre-Louis Rey, «Aspects du
temps dans La Chute d’Albert Camus», in Les formes du temps: rythme, histoire, temporalité, Strasbourg, Presses
Universitaires de Strasbourg, 2007, pp. 379-384; Nadia Jamal, «Amsterdam dans l’imaginaire de Camus : La
Chute», Bulletin de l’Association européenne François Mauriac, 35, 2016, pp. 18-20
Texte, d’après le milieu du roman
Tiens, la pluie a cessé! Ayez la bonté de me raccompagner chez moi. Je suis fatigué, étrangement, non
d’avoir parlé, mais à la seule idée de ce qu’il me faut encore dire. Allons! Quelques mots suffiront pour
retracer ma découverte essentielle. Pourquoi en dire plus, d’ailleurs? Pour que la statue soit nue, les
beaux discours doivent s’envoler. Voici. Cette nuit-là, en novembre, deux ou trois ans avant le soir où
je crus entendre rire dans mon dos, je regagnais la rive gauche, et mon domicile, par le pont Royal. Il
était une heure après minuit, une petite pluie tombait, une bruine plutôt, qui dispersait les rares passants.
Je venais de quitter une amie qui, sûrement, dormait déjà. J’étais heureux de cette marche, un peu
engourdi, le corps calmé, irrigué par un sang doux comme la pluie qui tombait. Sur le pont, je passai
derrière une forme penchée sur le parapet, et qui semblait regarder le fleuve. De plus près, je distinguai
une mince jeune femme, habillée de noir. Entre les cheveux sombres et le col du manteau, on voyait
seulement une nuque, fraîche et mouillée, à laquelle je fus sensible. Mais je poursuivis ma route, après
une hésitation. Au bout du pont, je pris les quais en direction de Saint-Michel, où je demeurais. J’avais
déjà parcouru une cinquantaine de mètres à peu près, lorsque j’entendis le bruit, qui, malgré la distance,
me parut formidable dans le silence nocturne, d’un corps qui s’abat sur l’eau. Je m’arrêtai net, mais sans
me retourner. Presque aussitôt, j’entendis un cri, plusieurs fois répété, qui descendait lui aussi le fleuve,
puis s’éteignit brusquement. Le silence qui suivit, dans la nuit soudain figée, me parut interminable. Je
voulus courir et je ne bougeai pas. Je tremblais, je crois, de froid et de saisissement. Je me disais qu’il
fallait faire vite et je sentais une faiblesse irrésistible envahir mon corps. J’ai oublié ce que j’ai pensé
alors. «Trop tard, trop loin...» ou quelque chose de ce genre. J’écoutais toujours, immobile. Puis, à petits
pas, sous la pluie, je m’éloignai. Je ne prévins personne.
Mais nous sommes arrivés, voici ma maison, mon abri! Demain? Oui, comme vous voudrez. Je vous
mènerai volontiers à l’île de Marken, vous verrez le Zuyderzee. Rendez-vous à onze heures à Mexico-
City. Quoi? Cette femme? Ah! je ne sais pas vraiment, je ne sais pas. Ni le lendemain, ni les jours qui
suivirent, je n’ai lu les journaux.
Albert Camus, La Chute, Paris, Gallimard – Folio, 1984, pp. 74-75
Testo tratto dalle pagine centrali del romanzo
Guardi! Ha smesso di piovere. Abbia la bontà di riaccompagnarmi a casa. Sono stanco, stranamente, ma
non di aver parlato, ma alla sola idea di quello che devo ancora dirle. Allora su, basterà qualche parola
per delineare la scoperta essenziale della mia vita. Perché usarne di più, del resto? Affinché la statua sia
nuda, bisogna che si svesta di ogni bel discorso e che questo voli via. Ecco qui, dunque. Una notte, in
novembre, due o tre anni prima della sera in cui mi era sembrato di sentir ridere alle mie spalle, stavo
raggiungendo la riva sinistra della Senna, casa mia, attraversando il Pont Royal. Era l’una di notte,
pioveva una pioggia fine che aveva il potere di disperdere i vari passanti. Avevo appena lasciato la casa
di un’amica che probabilmente in quel momento stava già dormendo, ero felice di quel mio camminare,
un po’ intorpidito, con il corpo che sentivo calmato, irrigato di un sangue dolce come la pioggia che
cadeva. Sul ponte passai dietro a una forma che si sporgeva sul parapetto e sembrava guardare il fiume.
Quando fui vicino, distinsi una giovane donna, sottile, vestita di nero. Tra i capelli scuri e il collo del
cappotto si vedeva solo una nuca fredda e bagnata, alla quale fui molto sensibile. Ma continuai per la
mia strada dopo una leggera esitazione. Giunto in fondo al ponte, presi il lungo-Senna in direzione di
Saint-Michel, dove abitavo. Avevo già percorso una cinquantina di metri quando sentii il rumore che,
malgrado la distanza, mi sembrò tremendo nel silenzio notturno, di un corpo che sbatte sulla superficie
dell’acqua. Mi fermai di colpo, ma senza girarmi. Quasi subito sentii un grido ripetuto più volte, che
scendeva anche esso lungo il fiume. Poi si spense bruscamente. Il silenzio che seguì nella notte mi
sembrò interminabile. Volli correre e non mi mossi. Tremavo, credo, di freddo e di sgomento. Mi dicevo
che bisognava fare in fretta e sentivo una debolezza irresistibile invadermi il corpo. Ho dimenticato
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 27
quello che ho pensato in quel momento, “troppo tardi, troppo lontano”, o qualcosa del genere. Ascoltavo
sempre immobile. Poi a piccoli passi sotto la pioggia mi allontanai. Non avvisai nessuno.
Ah, ma eccoci arrivati. Eccoci a casa mia, al mio rifugio. Domani? Sì, come vuole. La porterò volentieri
all’isola di Marken, vedrà lo Zuiderzee. Allora appuntamento alle 11 a Mexico City. Cosa? Quella
donna? Mah, non so esattamente, non so. Non ho letto i giornali, né il giorno dopo, né i giorni seguenti.
trad. it.: Albert Camus, La caduta, traduzione di Yasmina Melaouah, Milano, Bompiani – Tascabili narrativa,
2019, pp. 52-53
Albert Camus, La Chute, Paris, nrf Gallimard, 1956, edizione originale, esemplare venduto da Artcurial,
7, rond-point des Champs-Élysées Marcel Dassault, Paris VIIIe, nel 2018, lotto n. 93
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 28
1958
L’Ignorant
Philippe Jaccottet
(1925-2021)
Dando lettura delle motivazioni che avevano portato all’attribuzione a Philippe Jaccottet del Premio
internazionale Cino del Duca, il 30 maggio 2018, la segretaria dell’Académie française, N.D. Hélène
Carrère d’Encausse, fornì in pochi minuti di parola la più chiara presentazione del poeta premiato e della
sua opera. Con un discorso semplice e profondo, Carrère d’Encausse identificava una sorta di ‘motto’,
valido a titolo omnicomprensivo per il mondo di Jaccottet, nel primo verso dell’ultima quatrina di «Que
la fin nous illumine» (L’Ignorant, pp. 50-51): «L’effacement soit ma façon de resplendir», ‘la
cancellazione sia il mio modo di risplendere’. L’umiltà di un passo sempre indietro è il gesto-chiave di
questo poeta, un grandissimo della nostra epoca, capace sempre di fondere nella parola poetica
l’accoglienza, con il suo sguardo, del mondo circostante. Accoglienza è sempre stata per lui sinonimo
di verginità nel sentire, ignoranza nell’apprendere, innocenza nel capire: lontano dalle certezze, incapace
di pregiudizi, il poeta pone sicuramente un quesito sul mondo, perché questo è il ruolo dell’intellettuale.
Ma nulla è più lontano da Jaccottet dalla pretesa di ottenere risposte, e tanto meno risposte certe. La
poesia non cerca mai – come ha detto Hélène Carrère d’Encausse – il tratto meraviglioso, abbagliante,
straordinario, il grande stile («l’éclatant, le clinquant, le grand style»), ma fa in modo che a brillare sia
sempre e solo la semplicità dell’evidenza, l’istante di una piccola verità umana, accettata con tutte le sue
– anche e serenamente incomprensibili – zone d’ombra. Quale meditazione sui limiti della parola, quale
ricerca scrupolosa della precisione formale, nella consapevolezza che i significati del mondo vengono
compresi solo in piccola parte, la poesia di Jaccottet è profondamente «leale», come ha scritto Jean
Starobinski. Non rende la realtà né magnifica, né miserabile. Crede invece che possa esistere un patto
fra il vero e la parola poetica. È, di fondo, una poesia etica.
Nato nel 1925 a Moudon, nel cantone di Vaud, nella Svizzera francofona, e stabilitosi nel 1953 a
Grignan, nella Drôme, nel sud della Francia, Philippe Jaccottet aveva una formazione universitaria in
filosofia, in filologia greca e filologia tedesca. La sua laurea, all’Università di Losanna, è del 1946.
Aveva tessuto legami intellettuali molto forti con poeti quali Gustave Roud e Charles Ferdinand Ramuz,
nella sua Svizzera natale, mentre a Parigi, dove soggiornò come collaboratore dell’editore Henry-Louis
Mermod, si legò in particolare a Francis Ponge. Fu un celebre e raffinato traduttore, in particolare
dell’Odissea, e poi di Thomas Mann, di Rilke, di Friedrich Hölderlin, di Robert Musil, di Leopardi ed
Ungaretti. Scrisse racconti, diari, saggi critici, e soprattutto poesia: qui studiamo un componimento tratto
da L’Ignorant (1958), ma ricordiamo almeno Airs (1967), Leçons (1969), Après beaucoup d’années
(1994), Cahier de verdure (2003), oltre all’insieme della sua opera poetica, uscita nella prestigiosa
collana della Pléiade di Gallimard nel 2014.
«Le travail du poète» (L’Ignorant, p. 37-38), che presentiamo qui, è una poesia in tre tempi, a strofe
libere (tipograficamente strutturata in due), dotata di un forte impatto narrativo, che viene sostenuto
dalla ricchezza degli enjambements e dall’irregolarità degli alessandrini. Il primo tempo (vv. 1-4) si
sofferma sul lavoro del poeta, pastore attento che ha il còmpito di vegliare. Il secondo tempo (vv. 5-19)
introduce il lungo ed incerto lavoro della memoria, nel tentativo di disegnare la figura di un’anziana
signora morta da poco, ben conosciuta dall’io poetante ed evidentemente a lui cara. Il terzo tempo (vv.
20-27) torna ciclicamente sul lavoro del poeta, soggetto definito con un verbo di divenire, nel campo
lessicale della povertà: non tanto il ‘povero’, ma colui che si è impoverito, l’«appauvri» (v. 25). Il suo
compito, qui conclusivo, è simile a quello d’apertura, importantissimo nella sua piccolezza: tener acceso
un fuoco, che rischia ad ogni istante di spegnersi, per il vento, come per la poca legna di cui egli dispone.
È, questo, un testo altamente rappresentativo della precisione costante che il poeta dedica al mondo che
lo circonda e che scorre accanto a lui, come se dovesse fondervisi per non perderne le tracce, cancellarsi
per essere più attento all’oggetto del suo sguardo e del suo sentire. Lontano dall’immagine heideggeriana
del ‘pastore dell’essere’, questo pastore («un berger», v. 3) dei versi di Jaccottet vigila sì, ma in tutta
umiltà, affidandosi, come ha scritto Charles-Olivier Stiker-Métral, alla fragilità della sua osservazione
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 29
e della sua parola, e quasi consapevole della minaccia che può venire da due grandi ‘mostri’ distruttivi:
l’approssimazione e l’esagerazione.
cfr. Jean Starobinski, «Parler avec la voix du jour », préface à Philippe Jaccottet, Poésie, 1946-1967, Paris,
Gallimard, 1971, coll. ‘Poésie’, pp. 7-22 (trad. it. a cura di Daniela Vianello, « Parlare con la voce della luce », in
Idra, Cagiallo, Genova, n° 1, 1990, pp. 230-242, riedita in Philippe Jaccottet, Il barbagianni. L’ignorante, con un
saggio di Jean Starobinski, a cura di Fabio Pusterla, Torino, Einaudi, 1992,pp. 171-180); Gérard Farasse (dir.),
Jaccottet en filigrane, Revue des Sciences Humaines, n° 255, juillet/septembre 1999, 236pp.; Renée Ventresque
(dir.), Philippe Jaccottet. La mémoire et la faille, Publications de l’Université Paul-Valéry, Montpellier 3, 2002;
Charles-Olivier Stiker-Métral, «Philippe Jaccottet, la poésie de l’effacement», Esprit, n. 414, mai 2015, pp. 99-
108
Texte, «Le travail du poète»
L’ouvrage d’un regard d’heure en heure affaibli
n’est pas plus de rêver que de former des pleurs,
mais de veiller comme un berger et d’appeler
tout ce qui risque de se perdre s’il s’endort.
*
Ainsi, contre le mur éclairé par l’été 5
(mais ne serait-ce pas plutôt par sa mémoire),
dans la tranquillité du jour je vous regarde,
vous qui vous éloignez toujours plus, qui fuyez,
je vous appelle, qui brillez dans l’herbe obscure
comme autrefois dans le jardin, voix ou lueurs 10
(nul ne le sait) liant les défunts à l’enfance...
(Est-elle morte, telle dame sous le buis,
sa lampe éteinte, son bagage dispersé ?
Ou bien va-t-elle revenir de sous la terre
et moi j’irais au-devant d’elle et je dirais : 15
«Qu’avez-vous fait de tout ce temps qu’on n’entendait
ni votre rire ni vos pas dans la ruelle ?
Fallait-il s’absenter sans personne avertir ?
Ô dame! revenez maintenant parmi nous...»)
Dans l’ombre et l’heure d’aujourd'hui se tient cachée, 20
ne disant mot, cette ombre d’hier. Tel est le monde.
Nous ne le voyons pas très longtemps : juste assez
pour en garder ce qui scintille et va s’éteindre,
pour appeler encore et encore, et trembler
de ne plus voir. Ainsi s’applique l’appauvri, 25
comme un homme à genoux qu’on verrait s’efforcer
contre le vent de rassembler son maigre feu...
Philippe Jaccottet, L’Ignorant. Poèmes 1952-1956, Paris, Gallimard, 1958, pp. 37-38
Testo, «Il lavoro del poeta»
Compito dello sguardo che s’offusca
non è sognare o piangere, è vegliare
come un pastore il gregge, e richiamare
ciò che rischia di perdersi nel sonno.
*
Così, sul muro acceso dall’estate
(ma non sarà piuttosto dal ricordo)
vi guardo dentro la pace del giorno,
voi che andate lontano, che fuggite,
vi chiamo, luminosi dentro l’erba
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 30
più scura, come un tempo nel giardino, voci o luci
(chi sa) che legano i defunti con l’infanzia…
(È morta, la signora sotto il bosso,
spento il suo lume, al vento il suo corredo?
O un giorno tornerà da sotto terra
e potrò dirle, io, andandole incontro: «Che ne è stato
di tutto questo tempo, in cui tacevano
il riso e i vostri passi per la via? E non si poteva
che andarsene così, senza avvisare?
O signora, tornate ora fra noi…»)
Nell’ombra ed ora d’oggi sta in silenzio,
nascosta, l’ombra di ieri. E questo è il mondo.
Non lo vediamo a lungo, quel che basta
a trattenerne quello che scintilla, e a poco a poco
si spegne, a chiamare ancora e poi ancora, e a tremare
di non vedere più. Così si sforza
il misero, come chi, inginocchiato, contro vento,
tenta di adunare un magro fuoco…
trad. it.: Philippe Jaccottet, Il barbagianni. L’ignorante, con un saggio di Jean Starobinski, a cura di Fabio Pusterla,
Torino, Einaudi, 1992, p. 105
Philippe Jaccottet sul terrazzo della sua casa a Grignan. Fotografia di Erling Mandelmann, 1991 © R. & B. Mandelmann,
Collezioni del Musée historique de Lausanne – Dizionario Storico della Svizzera DSS / SAGW / ASSH
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 31
1975
La Vie devant soi
Romain Gary
(1914-1980)
La Vie devant soi è il romanzo che semplicemente conferma, come ha scritto Jean-François Hangouët,
la premonizione di Mina (o Nina) Owczyńska Kacew, madre di Romain Gary, convinta che il figlio
sarebbe diventato «un titan de la littérature». Uscito con lo pseudonimo di Émile Ajar nel 1975 presso
il Mercure de France, La Vie devant soi fu insignito del prestigioso Premio Goncourt, che Romain Gary
aveva già ricevuto nel 1956 per Les Racines du ciel e che, per normativa del Premio, non avrebbe in
nessun modo potuto ricevere una seconda volta. Firmandosi con lo pseudonimo e senza specificare
motivi, egli fece infatti arrivare al presidente dell’Accademia Goncourt un cortese rifiuto, che
semplicemente non fu accolto, poiché il Premio veniva attribuito a un libro, non a un autore che potesse
poi decidere se accettare o meno il riconoscimento. Il velo che copriva l’identità di Ajar restò
impenetrabile e così rimase fino a dopo la morte di Gary. Solo una scrittrice di origine ungherese,
Christine Arnothy, anch’essa esule e naturalizzata francese, ebbe l’intuizione di una somiglianza
assoluta fra la scrittura di Émile Ajar e quella di una specie di «Gogol de la rive gauche, le Pouchkine
des ténèbres de Paris» (D. Bona, p. 361). Pur rimanendo quasi del tutto inosservata, la sua intuizione si
fondava su quel misto di umorismo ebraico, tristezza est-europea, sorridente disincanto e rispetto per
l’umanità, che costituiscono lo spirito di fondo della Vie devant soi e che Christine Arnothy rilevava già
nel 1974, nel primo romanzo firmato da Gary con lo pseudonimo di Ajar, Gros-Câlin.
Il sogno di poter dar vita a un ‘romanzo totale’ si realizzava per Gary con La Vie devant soi: c’è un
romanzo del personaggio letterario e un romanzo, dunque, dell’autore che lo crea.
Il personaggio, qui, è il giovane Momo, adolescente clandestino di origine magrebina, orfano di una
prostituta, con la sua alterità rispetto alla Parigi borghese, la sua vita nel condominio di periferia insieme
agli altri figli di prostitute che Madame Rosa, ebrea, sopravvissuta ad Auschwitz, accoglie e cresce in
casa sua, dietro una piccola remunerazione. L’autore sarebbe stato in origine – nell’idea di Gary – un
vagabondo, medico ma mezzo criminale, esule senza radici, troppo facilmente sospettabile come un
prestanome: divenne quindi un personaggio in carne ed ossa, quando, per completare la totalità
romanzesca, Gary architettò la messa in scena di una attribuzione dell’opera al nipote Paul Pavlowitch,
figlio di una cugina. Mentre La Vie devant soi veniva accolto come il romanzo della modernità assoluta
e Pavlowitch riconosciuto come uno strampalato genio, per qualche anno si vide in Romain Gary il
romanziere di un’epoca conclusa, il grande autore di Éducation européenne (1945), che aveva saputo
tessere la trama narrativa meravigliosa di una solidarietà fra popoli, contro qualsiasi tipo di stato
sovrano, di razzismo, di oppressione: ma che, alla fine degli anni ’70, ormai aveva poco da dire. Anche
per questo, quando con la pubblicazione postuma della Vie et mort d’Émile Ajar (1981) si seppe che
Émile Ajar era Gary, una luce completamente nuova illuminò la sua figura, la sua arte, il suo genio
assoluto.
Con La Vie devant soi, Gary aveva completamente rivoluzionato la prospettiva di lettura: nelle pagine
del romanzo, ci si trova condotti per mano dalla voce in prima persona del narratore Momo,
costantemente presente in primo piano nella trama e responsabile di una visione del mondo autentica e
paradossale al tempo stesso. Quello che Momo vede, la Francia che è al di là di un confine invisibile,
oltre il quartiere popolare di Belleville in cui risiedono lui e gli altri personaggi di una multietnica realtà
anni ’70, le abitudini di una varia umanità segnata dall’emarginazione sono il filo solidissimo di una
narrazione comica, patetica, troppo reale, e reale soprattutto per i suoi occhi. La costituiscono ‒ lungo il
percorso di una crescita individuale che fa del ragazzino delle prime pagine un quindicenne di
sorprendente saggezza ‒ ingenuità linguistiche, trasgressioni sintattiche, improprietà lessicali, che sono
il mezzo perfetto per denunciare.
Denuncia delicata e commovente, la voce di Momo ci porta dentro a una logica incontestabile, come
nella ribellione, per esempio, contro le leggi di Natura, che causano sofferenza all’anziana e amatissima
Madame Rosa, dato che le persone anziane «sont attaquées par la nature, qui peut être une belle salope
et qui les fait crever à petit feu». Oppure nella ribellione contro l’attaccamento alla vita, se ai suoi occhi
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 32
«les gens tiennent à la vie plus qu’à n’importe quoi, c’est même marrant quand on pense à toutes les
belles choses qu’il y a dans le monde». O ancora nella ribellione contro una religione estrema:
«Monsieur Hamil dit que l’humanité n’est qu’une virgule dans le grand Livre de la vie et quand un
homme dit une connerie pareille, je ne vois pas ce que je peux y ajouter». E alla ribellione si
accompagna, come fosse la sua evidente causa, all’origine di tutto il percorso di Momo, l’onnipresente
bisogno di amore, come leggiamo nel testo che qui viene presentato in forma antologica.
Di origine russo-lituana, nato come Roman Kacew e poi naturalizzatosi francese con il nuovo nome,
Romain Gary era cresciuto a Nizza e poi a Parigi, era stato studente di Giurisprudenza negli anni ’30,
ma dedito alla letteratura da sempre, si era arruolato nell’esercito francese prima della Seconda Guerra
mondiale, e si era quindi unito alla Resistenza come pilota, nella compagnia Lorraine della France Libre.
Croce al merito della Liberazione nel 1944, diplomatico al servizio della nazione in diverse sedi, fra cui
l’ONU ed il consolato di Los Angeles negli anni della crisi algerina, romanziere, drammaturgo, cineasta,
Gary si suicidò con la pistola avuta in dotazione come console, il 2 dicembre 1980, nella sua bella casa
del VIe arrondissement a Parigi, dopo aver inviato al suo editore la ‘rivelazione’ della Vie et mort
d’Émile Ajar. Qui scriveva il senso della sua esistenza, in termini di congedo, con la celebre conclusione:
«Je me suis bien amusé. Au revoir et merci».
cfr. Dominique Bona, Romain Gary, Paris, Mercure de France – Folio, 1987; Jean-François Hangouët, Romain
Gary. À la traversée des frontières, Paris, Gallimard, «Découvertes Gallimard», 2007; Valérie Mirarchi, Gary-
Ajar: un génie à double face, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2020; Yves Baudelle, Julien Roumette (dir.),
Romain Gary ou le roman total, Paris, Classiques Garnier – «La Revue des Lettres modernes», 2023
Texte, au début du roman
Madame Rosa a bien vu que j’étais triste et elle m’a expliqué que la famille ça ne veut rien dire et qu’il
y en a même qui partent en vacances en abandonnant leurs chiens attachés à des arbres et que chaque
année il y a trois mille chiens qui meurent ainsi privés de l’affection des siens. Elle m’a pris sur ses
genoux et elle m’a juré que j’étais ce qu’elle avait de plus cher au monde mais j’ai tout de suite pensé
au mandat et je suis parti en pleurant.
Je suis descendu au café de Monsieur Driss en bas et je m’assis en face de Monsieur Hamil qui était
marchand de tapis ambulant en France et qui a tout vu. Monsieur Hamil a de beaux yeux qui font du
bien autour de lui. Il était déjà très vieux quand je l’ai connu et depuis il n’a fait que vieillir.
‒ Monsieur Hamil, pourquoi vous avez toujours le sourire ?
‒ Je remercie ainsi Dieu chaque jour pour ma bonne mémoire, mon petit Momo.
Je m’appelle Mohammed mais tout le monde m’appelle Momo pour faire plus petit.
‒ Il y a soixante ans, quand j’étais jeune, j’ai rencontré une jeune femme qui m’a aimé et que j’ai aimé
aussi. Ça a duré huit mois, après, elle a changé de maison, et je m’en souviens encore, soixante ans
après. Je lui disais : je ne t’oublierai pas. Les années passaient, je ne l’oubliais pas. J’avais parfois peur
car j’avais encore beaucoup de vie devant moi et quelle parole pouvais-je donner à moi-même, moi,
pauvre homme, alors que c’est Dieu qui tient la gomme à effacer ? Mais maintenant, je suis tranquille.
Je ne vais pas oublier Djamila. Il me reste très peu de temps, je vais mourir avant.
J’ai pensé à Madame Rosa, j’ai hésité un peu et puis j’ai demandé :
‒ Monsieur, Hamil, est-ce qu’on peut vivre sans amour ?
Il n’a pas répondu. Il but un peu de thé de menthe qui est bon pour la santé. Monsieur Hamil portait
toujours une jellaba grise, depuis quelque temps, pour ne pas être surpris en veston s’il était appelé. Il
m’a regardé et a observé le silence. Il devait penser que j’étais encore interdit aux mineurs et qu’il y
avait des choses que je ne devais pas savoir. En ce moment je devais avoir sept ans ou peut-être huit, je
ne peux pas vous dire juste parce que je n’ai pas été daté, comme vous allez voir quand on se connaîtra
mieux, si vous trouvez que ça vaut la peine.
‒ Monsieur Hamil, pourquoi ne me répondez-vous pas ?
‒ Tu es bien jeune et quand on est très jeune, il y a des choses qu’il vaut mieux ne pas savoir.
‒ Monsieur Hamil, est-ce qu’on peut vivre sans amour ?
‒ Oui, dit-il, et il baissa la tête comme s’il avait honte.
Romain Gary, La Vie devant soi, Paris, Gallimard – Folio, série Tirages limités sous étui, 2007, pp. 10-12
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 33
Testo, tratto dalle prime pagine del romanzo
Madame Rosa si è accorta che ero triste e mi ha spiegato che la famiglia non significa niente e che ci
sono perfino di quelli che vanno in vacanza abbandonando il loro cane legato a un albero e che ogni
anno ci sono tremila cani che muoiono così senza l’affetto dei loro cari. Mi ha preso sulle ginocchia e
mi ha giurato che io ero la cosa più cara che aveva al mondo, ma io ho pensato subito al vaglia e sono
scappato via piangendo.
Sono sceso di sotto nel caffè del signor Driss e mi sono seduto di fronte al signor Hamil, che ha fatto il
venditore ambulante di tappeti per tutta la Francia e ne ha viste di cotte e di crude. Il signor Hamil ha
dei begli occhi che dispensano del bene tutto intorno. Era già molto vecchio quando l’ho conosciuto e
dopo ha sempre continuato a invecchiare.
«Signor Hamil, perché sorridete sempre?»
«In questo modo ringrazio ogni giorno Dio per la mia buona memoria, piccolo Momò».
Io mi chiamo Mohammed, ma mi chiamano tutti Momò per far prima.
«Sessant’anni fa, quand’ero giovane, ho incontrato una ragazza che mi ha amato e che ho amato anch’io.
È andata avanti per otto mesi, poi lei ha cambiato casa, e io me ne ricordo ancora sessant’anni dopo. Le
dicevo: “Non ti dimenticherò”. Passavano gli anni e io non la dimenticavo. Certe volte avevo paura
perché avevo ancora molta vita davanti a me, e che promessa potevo mai fare a me stesso, io, povero
uomo, se è Dio che tiene in mano la gomma da cancellare? Adesso però sono tranquillo. Non
dimenticherò Djamila. Mi resta poco tempo, morirò prima».
Ho pensato a Madame Rosa, ho esitato un po’ e poi ho domandato:
«Signor Hamil, si può vivere senza amore?»
Non ha risposto. Ha bevuto un po’ di tè alla menta che fa bene alla salute. Da un po’ di tempo il signor
Hamil portava sempre una jellaba grigia, per non farsi trovare in giacchetta al momento della chiamata.
Mi ha guardato ed è rimasto in silenzio. Doveva pensare che ero ancora vietato ai minori e che c’erano
delle cose che non dovevo sapere. A quel tempo dovevo avere sette anni o forse otto, non ve lo posso
dire con precisione perché non sono stato datato, come saprete quando ci conosceremo meglio, se trovate
che ne vale la pena.
«Signor Hamil, perché non mi rispondete?»
«Sei molto giovane, e quando si è molto giovani ci sono delle cose che è meglio non sapere».
«Signor Hamil, si può vivere senza amore?»
«Sì», ha detto, e ha abbassato la testa come se si vergognasse.
trad. it.: Romain Gary, La vita davanti a sé, traduzione di Giovanni Bogliolo, Vicenza, Neri Pozza, 2009 10, pp.
8-9
L’attore Gabriel Jabbour (1922-1987) nel ruolo di Monsieur Hamil, in Madame Rosa, film di Moshé Mizrahi, 1977, Oscar
for best foreign-language film, 1978
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 34
2001
Rouge Brésil
Jean-Christophe Rufin
(1952-)
Jean-Christophe Rufin, scrittore nostro contemporaneo, è membro dell’Académie française dal 19
giugno 2008, quando vi è stato eletto al posto («au fauteuil 28») del grande storico di origine armena
Henri Troyat, da poco scomparso. Tale posto che Rufin occupa è il perfetto riconoscimento di una
genialità d’autore che, lungo tutta la sua carriera, ha operato di pari passo con l’impegno: impegno
sociale, umanitario, sanitario, diplomatico, ambientalista, pedagogico. Medico di professione,
ambasciatore francese in Africa, responsabile di missioni per Médecins sans frontières e per Action
contre le faim, docente nelle discipline delle Relazioni internazionali, Rufin è l’emblema dello scrittore
che apre la letteratura al mondo che ci circonda. I suoi romanzi, che, tutti, si leggono d’un fiato, dalla
prima pagina all’ultima, entro una suspense narrativa che attrae il lettore con estrema forza, sono ‘storie
del mondo’, potenti riflessioni, pur restando sempre collocate entro un immaginario affascinante e
splendidamente strutturato.
Dire che siano romanzi storici è una semplificazione che non rende giustizia all’opera di Rufin. Sono
romanzi basati sulla storia, ma in cui gli avvenimenti, storicamente documentati, costituiscono soltanto
un punto di partenza: punto di partenza per l’intrigo narrativo, per la finzione letteraria, per le azioni, i
pensieri, i caratteri dei loro protagonisti e per tutto quell’insieme – come ha detto Rufin stesso – di aria,
di spazio, d’ignoto che crea l’emozione. La storia – e nel caso di Rouge Brésil (2001, premio Goncourt)
la storia del tentativo francese di conquista e colonizzazione di un lembo del Brasile nel 1555 – è fonte
tematica per il romanzo solo se raccontata nel modo personalissimo che Rufin sente come suo. È posta
entro quella cassa di risonanza che sono le idee dell’autore, la sua vita, le sue esperienze, i suoi sogni e
soprattutto è costantemente collegata al presente in cui viviamo. L’incontro fra civiltà ne è qui, in Rouge
Brésil, l’oggetto. Non diciamo lo scontro, anche se così parrebbe, perché la storia risale assolutamente
ad un’epoca di origini, in cui gli indigeni delle foreste vergini dell’attuale Brasile non erano in nessun
modo ‘pronti a combattere’, quindi a ‘scontrarsi’. L’ammiraglio ugonotto (e scienziato, e cavaliere di
Malta, e esploratore…) Nicolas Durand de Villegagnon sbarcò nella baia di Guanabara (oggi Rio de
Janeiro) il 10 novembre 1555, con due navi e 600 coloni, per attuare un progetto tutto francese, ispirato
direttamente dal re, Enrico II, mirante alla costituzione di una ‘Francia antartica’, oltre-oceano, ma non
lungo il consueto 45° parallelo che aveva già portato i francesi, mai scesi verso Sud, in quella ‘Nouvelle
France’ che era, all’epoca, il Canada.
Il mondo indigeno che fu trovato in questo oltre-oceano molto più distante e inaspettato era
profondamente arcaico, fragilissimo rispetto all’elaborata civiltà europea: ed era un mondo di comunità
disperse, in mezzo ai vuoti vergini di quelle terre, nuove per Villegagnon ed i suoi. Di fronte a loro,
l’isolamento dei francesi sull’altura in mezzo alla baia, la costruzione smisurata del forte, detto Fort
Coligny, le difficoltà climatiche, le frange di disobbedienza, le dispute religiose fra coloni che portano
Villegagnon ad abbandonare la fede riformata e tornare al Cattolicesimo, l’incomprensione della
diffidenza infinita degli indigeni, le pratiche violente, le razzie, il sangue, tutto contribuisce al carattere
invasivo dell’operazione francese. E il fallimento dell’impresa di Villegagnon, sancito storicamente
dall’intervento portoghese del 1558 contro questi ‘nuovi’ e ‘illegittimi’ conquistatori, ha portato, nella
storia di Francia, ad un vero e proprio rifiuto mnemonico: non se ne è voluta coltivare la memoria,
almeno fino ad anni relativamente recenti, quando il grande storiografo protestante Jean de Léry è stato
finalmente oggetto di attente letture e appassionate ricerche. Testimone diretto, Léry aveva fatto parte
della spedizione nella baia di Guanabara. La sua lucidissima Histoire d’un voyage fait en la terre du
Brésil, autrement dite Amérique, scritta nel rispetto degli usi e costumi degli indigeni, detti ‘selvaggi’,
era stato – a posteriori, a vent’anni di distanza dal viaggio americano – uno dei libri più rivoluzionari
dell’epoca, fondato su un moderno relativismo nella visione di umanità diverse, ugualmente provviste
di dignità. Uscita a Ginevra nel 1578 ed oggi molto studiata, ha potuto suggerire a Jean-Christophe Rufin
il nucleo portante del romanzo, e per una ragione precisa. Con perfetta percezione dell’alterità del Nuovo
mondo, Léry portava la testimonianza delle necessità linguistiche, di cui la spedizione era del tutto
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 35
consapevole, ai fini di un incontro, o di un contatto, o anche di uno scontro fra coloni ed indigeni. Nella
sua Histoire, riferiva che Villegagnon aveva con sé, sulle navi, sei ragazzini, presi in adozione dagli
orfanatrofi francesi per accompagnare i coloni e servire da interpreti: perché – si sa, e lo si sapeva nel
XVI secolo – una lingua straniera viene assimilata in giovanissima età, non da adulti. È da bambini, o
da ragazzi, che si entra in sintonia senza fatica e senza ostacoli con nuovi suoni, nuovi modi linguistici,
nuove forme di lessico: e si capisce lo straniero. I due ragazzini del romanzo di Rufin, maschio e
femmina, Just e Colombe, sono ‘nati’ da questa testimonianza storica. Ma la loro avventura, tutto il loro
mondo in mezzo a quel Brasile, rosso nei frutti, rosso nel legno delle foreste e rosso del sangue versato,
sono l’emozione narrativa più dirompente che la scrittura romanzesca abbia potuto offrire ai lettori in
questi ultimi decenni. È con gli occhi e con il sentire di Just e di Colombe, in mezzo ad adulti intrisi di
guerra, di politica, di dispute teologiche, di fanatismi e di traffici loschi, che scopriamo la distanza
assurda fra le due civiltà: la civiltà europea, da un lato, che si presenta come missionaria e benefattrice
ma che, pagina dopo pagina, si rivela sopraffattrice e assassina; gli indigeni, dall’altro, sensuali, crudeli
nella loro adesione a semplici e spietate leggi di natura, in armonia con un senso spontaneo del sacro,
capaci di felicità.
Il passo che qui viene proposto, tratto dalla prima parte del libro, racconta l’avvicinarsi delle navi di
Villegagnon al continente americano, dopo tre mesi e mezzo di navigazione sull’Atlantico. Contiene già
tutto il senso di meraviglia e la sorpresa della differenza totale fra i due mondi, che sono la caratteristica
primaria del romanzo.
cfr. Frank Lestringant, Le huguenot et le sauvage. L’Amérique et la controverse coloniale, en France, au temps
des Guerres de Religion (1555-1589), Paris, Aux Amateurs de Livres, 1990; Jean-Christophe Rufin, «À propos
des sources de Rouge Brésil», in Id., Rouge Brésil, Paris, Gallimard – Folio, 20143, pp. 597-602; Isabelle Trivisani-
Moreau, Aude-Nuscia Taïbi, Camille Noûs, «Voyage des plantes, voyages des hommes, mutations des livres:
l’exemple du bois-brésil », L’Esprit créateur, 60 (4), 2020, pp. 9-21 ; William de Lima Maia, «L'approche de la
culture améridienne dans Rouge Brésil de Jean-Christophe Rufin», in Leonor Lourenço de Abreu et Ana
Maria Bicalho (dir.), Reconstructions du Brésil dans les imaginaires littéraires français et francophones,
Bruxelles, PIE Peter Lang - Archives & musée de la littérature, 2018, pp. 133-155
Texte, d’après le chapitre I, 11
Pendant tous ces débats, l’heure avait tourné. Le sillage du vaisseau se colorait de mauve et d’indigo
tandis que s’allumait dans le ciel d’orient une étoile immobile. En cette heure ultime du jour, les vents
marquaient souvent une pause, les voiles s’affaissaient et le navire, baigné de silence, semblait se
recueillir pour une invisible vêpre. Or, tout au contraire, ce fut le moment où parvint dans le carré,
assourdi par les tapisseries, un grand tumulte venu de l’avant.
Villegagnon se précipita au-dehors et les autres à sa suite. Tout l’équipage et nombre de passagers se
tenaient à la proue le nez en l’air. D’autres arrivaient encore en courant, montant de l’entrepont et des
cales. Villegagnon se fraya un chemin jusqu’au beaupré. L’horizon devant eux était rouge à l’endroit où
le soleil finissait de disparaître. On ne voyait aucune terre ni, quand le ciel s’assombrit, aucun feu. Les
vigies, d’ailleurs, n’avaient pas crié. À vrai dire, rien n’était perceptible sauf une odeur étrange, tout à
la fois faible et immense. Faible parce qu’il fallait concentrer toute son attention pour en discerner la
pointe dans l’air tiède ; immense parce qu’elle envahissait toutes les directions, entourait le bateau et
paraissait s’étendre sur toute la surface de la mer.
Pourtant, elle ne lui appartenait pas. Le nez, de science aussi certaine que la vue ou l’ouïe, affirmait que
c’était bien une senteur de terre.
Il est des terres qui exhalent l’herbe, le bétail, la pourriture, les labours. Cette odeur-là n’évoquait rien
de tel. Elle était acidulée, juteuse, turgescente, printanière. En fermant les yeux, on avait envie de dire
qu’elle était colorée, rouge, peut-être orangée.
Soudain quelqu’un découvrit le mot juste et cria que cela sentait le fruit.
En effet, c’était bien une essence subtile de pulpe qui se répandait en vapeur sur toute l’étendue de la
mer, une immense odeur de fruit mûr. Une île se voit mais elle n’a pas ce parfum lointain et puissant.
Seul un continent peut jeter aussi loin sur la mer ses fragrances végétales, tout comme l’océan envoie
dans la profondeur du littoral ses embruns salés et ses senteurs de varech.
Villegagnon pleurait de joie dans son poing fermé et tous, autour de lui, s’embrassaient.
Il leur fallut encore naviguer deux jours pour être en vue de la côte.
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 36
Trois mois et demi s’étaient écoulés depuis leur départ du Havre.
Jean-Christophe Rufin, Rouge Brésil, Paris, Gallimard – Folio, 20143, pp. 151-153
Testo, tratto dal cap. 11 della Parte I
Durante tutti questi discorsi, l’ora era cambiata. La scia del vascello si colorava di malva e di indaco
mentre nel cielo d’oriente si accendeva una stella immobile. In quell’ultima ora del giorno, i venti
facevano spesso una pausa, le vele si afflosciavano e la nave, bagnata di silenzio, pareva raccogliersi
per un’invisibile preghiera della sera. Quello, al contrario, fu il momento in cui giunse nella sala interna,
avvolto e attutito dalle tappezzerie, un gran tumulto, proveniente da prua.
Villegagnon si precipitò all’esterno e gli altri dietro di lui. Tutto l’equipaggio, e molti dei passeggeri,
erano là, a prua, col naso per aria. Altri continuavano ad arrivare, salendo dagli interponti e dalle stive.
Villegagnon si aprì un cammino fino al bompresso. L’orizzonte davanti a loro era rosso lungo la linea
dove il sole stava terminando di scomparire. Non si vedeva nessuna terra né, quando in cielo fu notte,
alcun fuoco. Le vedette, d’altronde, non avevano gridato. A dire il vero, non si percepiva nulla di diverso
dal solito, salvo uno strano odore, al tempo stesso debole ed immenso. Debole, perché bisognava
metterci tutta l’attenzione possibile per discernerne le tracce nell’aria tiepida; immenso, perché invadeva
tutte le direzioni, circondava la nave e sembrava che si stendesse sull’intera superficie del mare.
Tuttavia, era un odore che non apparteneva all’oceano. Il naso, scienza esatta come la vista e l’udito,
affermava che era certamente un’essenza di terra.
Ci sono terre da cui provengono esalazioni d’erba, di bestiame, di marciume, di zolle dissodate. Ma
quell’odore non evocava nulla di tutto ciò. Era acidulo, succoso, turgido, primaverile. Chiudendo gli
occhi, veniva voglia di dire che era colorato, rosso, forse arancione.
All’improvviso, qualcuno scoprì la parola giusta e gridò che quell’odore sapeva di frutta.
In effetti, era proprio una sottile essenza di polpa che si propagava, in vapore, su tutta la distesa del
mare, un immenso odore di frutta matura. Un’isola, la si vede, ma non ha questo profumo lontano e
potente. Soltanto un continente può inviare a tale distanza, così al largo, le fragranze vegetali, così come
l’oceano diffonde fin nel profondo interno del litorale aromi salati e profumi d’alghe.
Nella sua rigidità, Villegagnon piangeva di gioia e tutti, attorno a lui, si abbracciavano.
Dovettero navigare ancora due giorni per arrivare in vista della costa.
Erano passati tre mesi e mezzo dal giorno della loro partenza da Le Havre.
trad. it.: Jean-Christophe Rufin, Rosso Brasile, traduzione di Antonio Panella, Torino, Robin Edizioni – Biblioteca
del Vascello, 2004, pp. 117-118
Jean de Léry, Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite Amérique, [Genève], Antoine Chuppin, 1578, p.
[121] e p. [121, particolare], esemplare della Bibliothèque nationale de France, département de l’Arsenal, rue Sully, 8-H-
1573, disponibile in https://gallica.bnf.fr
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 37
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 38
Bibliografia
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 39
1857, Madame Bovary :
● Gustave Flaubert, Madame Bovary, préface par Jacques Suffel, Paris, Garnier Flammarion, 1979
● trad. it.: Gustave Flaubert, Madame Bovary. Costumi di provincia, traduzione di Maria Luisa Spaziani,
introduzione di Antonia S. Byatt, Milano, Mondadori – “Oscar scuola”, 2014
● riferimenti critici: Jacques Suffel, «Préface», in Gustave Flaubert, Madame Bovary, Paris, Garnier Flammarion, 1979,
pp. 13-27; Revue Flaubert, n° 8, 2008, «Madame Bovary, encore»; Pierre-Louis Rey, «Questions de savoir-vivre»,
in Pierre-Louis Rey et Gisèle Séginger (dir.), Madame Bovary et les savoirs, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2009,
pp. 123-131; Göran Blix, «Le personnage et son milieu: réalisme et liberté dans Madame Bovary», ivi, pp. 243-256;
Bruno Gallice, «Rémanence de Madame Bovary dans l’édition illustrée», Flaubert. Revue critique et génétique, 12,
2014, doi.org/10.4000/flaubert.2356; Pierre-Louis Rey, «La beauté d’Emma», in Steve Murphy (dir.), L’Aventure
interprétative. Hommage à Georges Kliebenstein, Paris, Classiques Garnier, 2022, pp. 283-295; Régis Jauffret,
Dictionnaire amoureux de Flaubert, Paris, Plon, 2023.
1857(-1868), Les Fleurs du Mal
● Charles Baudelaire, I Fiori del Male, Les Fleurs du Mal, testo italiano/francese a fronte, traduzione di
Luigi De Nardis, con un saggio di Erich Auerbach, Milano, Universale Economica Feltrinelli, 1977
● riferimenti critici: Erich Auerbach, «Les Fleurs du Mal e il sublime», in Baudelaire, I Fiori del Male, Les Fleurs du
Mal, testo it./fr. a fronte, trad. di L. De Nardis, con un saggio di E. Auerbach, Milano, Universale Economica
Feltrinelli, 1977, pp. XV-XXXVI; Philippe Dufour, «Heureux qui comme Icare…», L’Information littéraire, vol. 55,
2003, 1, pp. 53-60; Antoine Compagnon, Baudelaire, l’irréductible, Paris, Flammarion – Collection ‘Champs.
Essais’, 20212 ; Jean-Marc Chatelain (dir.), Baudelaire, la modernité mélancolique, Paris, Bibliothèque nationale de
France – Catalogue de l’exposition, 2021
1879, Les Frères Zemganno
● Edmond de Goncourt, Les Frères Zemganno, éd. par Catherine Dousteyssier-Khoze, Paris, Honoré
Champion, 2012
● trad. it.:Edmond de Goncourt, I fratelli Zemgannò, traduzione di Pino Bava, Milano, Rizzoli – B.U.R.,
1960
● riferimenti critici: Jean Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque, Genève, Albert Skira, 1970 (trad. it.:
Ritratto dell’artista da saltimbanco, a cura di Corrado Bologna, Torino, Boringhieri, 1984); Jacques Noiray,
«Tristesse de l’acrobate. Création artistique et fraternité dans Les Frères Zemganno», Revue des Sciences Humaines,
259, juillet-septembre 2000, pp. 91-110; Christian Galantaris, «L’illustration des romans d’Edmond et Jules de
Goncourt», Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, 16, 2009, pp. 105-111; Catherine Dousteyssier, «Introduction»,
in Edmond de Goncourt, Les frères Zemganno, éd. par C. Dousteyssier-Khoze, Paris, Honoré Champion, 2012, pp.
7-106.
1913, Du côté de chez Swann
● Marcel Proust, Du côté de chez Swann, préface par Jean Milly, Paris, GF - Flammarion (À la recherche
du temps perdu, I), 1987
● trad. it.: Marcel Proust, La strada di Swann, traduzione di Natalia Ginzburg, con un saggio di Giovanni
Macchia, Torino, Einaudi, 1990
● riferimenti critici: Isabelle Serça (dir.), Proust et le temps. Un dictionnaire, Paris, Éditions Le Pommier, 2022; Annick
Bouillaguet et Brian G. Rogers (dir.), Dictionnaire Marcel Proust, Paris, Honoré Champion, 20142
1931, Vol de nuit
● Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit, édition critique par Monique Gosselin-Noat, Genève, Droz, 2017
● trad. it.: Antoine de Saint-Exupéry, Volo di notte, traduzione di Cesare Giardini, Milano, Bompiani –
Grandi tascabili, 2020
● riferimenti critici: Monique Gosselin-Noat, «Introduction», in Saint-Exupéry, Vol de nuit, édition critique par M.
Gosselin-Noat, Genève, Droz, 2017, pp. V-XCVIII
1935, La Guerre de Troie n’aura pas lieu
● Jean Giraudoux, La Guerre de Troie n’aura pas lieu, édition par J. Body, Paris, Gallimard – Folio Théâtre,
2015
● trad. it.: Jean Giraudoux, La guerra di Troia non si farà, a cura di Stefano Serri, Torino, Robin Edizioni
– Biblioteca del Vascello, 2020
● riferimenti critici: André Job, Giraudoux: l’humanisme républicain à l’épreuve, Paris, Michalon éditeur, 2019
1956, La Chute
● Albert Camus, La Chute, Paris, Gallimard – Folio, 1984
● trad. it.: Albert Camus, La caduta, traduzione di Yasmina Melaouah, Milano, Bompiani – Tascabili
narrativa, 2019
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 40
● riferimenti critici: Jacqueline Lévi-Valensi, ‘La Chute’ d’Albert Camus, Paris, Gallimard, 1996; Pierre-Louis Rey,
«Aspects du temps dans La Chute d’Albert Camus», in Les formes du temps: rythme, histoire, temporalité,
Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2007, pp. 379-384; Nadia Jamal, «Amsterdam dans l’imaginaire
de Camus : La Chute», Bulletin de l’Association européenne François Mauriac, 35, 2016, pp. 18-20
1958, L’Ignorant
● Philippe Jaccottet, L’Ignorant. Poèmes 1952-1956, Paris, Gallimard, 1958
● trad. it.: Philippe Jaccottet, Il barbagianni. L’ignorante, con un saggio di Jean Starobinski, a cura di Fabio
Pusterla, Torino, Einaudi, 1992
● riferimenti critici: Jean Starobinski, «Parler avec la voix du jour », préface à Philippe Jaccottet, Poésie, 1946-1967,
Paris, Gallimard, 1971, coll. ‘Poésie’, pp. 7-22 (trad. it. a cura di Daniela Vianello, «Parlare con la voce della luce»,
in Idra, Cagiallo, Genova, n° 1, 1990, pp. 230-242, riedita in Philippe Jaccottet, Il barbagianni. L’ignorante, con un
saggio di Jean Starobinski, a cura di Fabio Pusterla, Torino, Einaudi, 1992, pp. 171-180); Gérard Farasse (dir.),
Jaccottet en filigrane, Revue des Sciences Humaines, n° 255, juillet/septembre 1999, 236pp.; Renée Ventresque (dir.),
Philippe Jaccottet. La mémoire et la faille, Publications de l’Université Paul-Valéry, Montpellier 3, 2002; Charles-
Olivier Stiker-Métral, «Philippe Jaccottet, la poésie de l’effacement», Esprit, n. 414, mai 2015, pp. 99-108
1975, La Vie devant soi
● Romain Gary, La Vie devant soi, Paris, Gallimard – Folio, série Tirages limités sous étui, 2007
● trad. it.: Romain Gary, La vita davanti a sé, traduzione di Giovanni Bogliolo, Vicenza, Neri Pozza, 200910
● riferimenti critici: Dominique Bona, Romain Gary, Paris, Mercure de France – Folio, 1987; Jean-François Hangouët,
Romain Gary. À la traversée des frontières, Paris, Gallimard, «Découvertes Gallimard», 2007; Valérie Mirarchi,
Gary-Ajar: un génie à double face, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2020; Yves Baudelle, Julien Roumette
(dir.), Romain Gary ou le roman total, Paris, Classiques Garnier – «La Revue des Lettres modernes», 2023
2001, Rouge Brésil
● Jean-Christophe Rufin, Rouge Brésil, Paris, Gallimard – Folio, 20143
● trad. it.: Jean-Christophe Rufin, Rosso Brasile, traduzione di Antonio Panella, Torino, Robin Edizioni –
Biblioteca del Vascello, 2004
● riferimenti critici: Frank Lestringant, Le huguenot et le sauvage. L’Amérique et la controverse coloniale, en France,
au temps des Guerres de Religion (1555-1589), Paris, Aux Amateurs de Livres, 1990; Jean-Christophe Rufin, «À
propos des sources de Rouge Brésil», in Id., Rouge Brésil, Paris, Gallimard – Folio, 20143, pp. 597-602; Isabelle
Trivisani-Moreau, Aude-Nuscia Taïbi, Camille Noûs, «Voyage des plantes, voyages des hommes, mutations des
livres: l’exemple du bois-brésil », L’Esprit créateur, 60 (4), 2020, pp. 9-21 ; William de Lima Maia, «L'approche de
la culture améridienne dans Rouge Brésil de Jean-Christophe Rufin», in Leonor Lourenço de Abreu et Ana
Maria Bicalho (dir.), Reconstructions du Brésil dans les imaginaires littéraires français et francophones, Bruxelles,
PIE Peter Lang - Archives & musée de la littérature, 2018, pp. 133-155
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 41
materiale didattico riservato ad utenti @studenti.unipd.it – p. 42
Potrebbero piacerti anche
- PROUSTDocumento14 paginePROUSTKariNessuna valutazione finora
- Michel ButorDocumento2 pagineMichel Butorannachiara masieroNessuna valutazione finora
- (Il Caffè Dei Filosofi) Stefano Cristante - Corto Maltese e La Poetica Dello Straniero. L'atelier Carismatico Di Hugo Pratt-MimesisDocumento154 pagine(Il Caffè Dei Filosofi) Stefano Cristante - Corto Maltese e La Poetica Dello Straniero. L'atelier Carismatico Di Hugo Pratt-MimesisDavid García-Ramos GallegoNessuna valutazione finora
- ProustDocumento2 pagineProustdavis2aNessuna valutazione finora
- Tommaso LandolfiDocumento9 pagineTommaso LandolfivitazzoNessuna valutazione finora
- ModernismoDocumento9 pagineModernismocivisbeatsNessuna valutazione finora
- Riassunto I MiserabiliDocumento141 pagineRiassunto I MiserabiliIMPUTATO IoaccusoNessuna valutazione finora
- Cezanne ZolaDocumento8 pagineCezanne ZolaRobertoNessuna valutazione finora
- Il Romanzo Francese Del 900Documento6 pagineIl Romanzo Francese Del 900Francesca AmatoNessuna valutazione finora
- Tutti i racconti originali di Maupassant (tradotto)Da EverandTutti i racconti originali di Maupassant (tradotto)Nessuna valutazione finora
- @d'annunzio SintesiDocumento3 pagine@d'annunzio SintesismataloneNessuna valutazione finora
- ItalianoDocumento10 pagineItaliano4vvxy6xsfxNessuna valutazione finora
- 2.2. Naturalismo e VerismoDocumento3 pagine2.2. Naturalismo e VerismoFedericaNessuna valutazione finora
- Il tempo ritrovato di Marcel Proust (Analisi del libro): Analisi completa e sintesi dettagliata del lavoroDa EverandIl tempo ritrovato di Marcel Proust (Analisi del libro): Analisi completa e sintesi dettagliata del lavoroNessuna valutazione finora
- M. Proust, Dalla Parte Di SwannDocumento15 pagineM. Proust, Dalla Parte Di SwannMary BiondiNessuna valutazione finora
- 02 Gustave FlaubertDocumento6 pagine02 Gustave FlaubertCristina CappellaNessuna valutazione finora
- Jules Verne - Robur Il Conquistatore 1886Documento143 pagineJules Verne - Robur Il Conquistatore 1886salvy1963100% (1)
- All'insegna Del Bizarre - La Scuola Belga Del FantasticoDocumento2 pagineAll'insegna Del Bizarre - La Scuola Belga Del FantasticostridulumNessuna valutazione finora
- Albert Camus - L'Uomo in RivoltaDocumento14 pagineAlbert Camus - L'Uomo in Rivoltaalex050993Nessuna valutazione finora
- IonescoDocumento2 pagineIonescoirelorisNessuna valutazione finora
- Marino MorettiDocumento8 pagineMarino MorettiApetrei Andreea AlexandraNessuna valutazione finora
- Copia Di ItalianoDocumento6 pagineCopia Di ItalianoFrancesco CaramazzaNessuna valutazione finora
- Eugène Ionesco. La Cantatrice Calva - RinoceronteDocumento194 pagineEugène Ionesco. La Cantatrice Calva - RinoceronteRicardo Calixto100% (1)
- André Breton - Antologia Dello Humor NeroDocumento368 pagineAndré Breton - Antologia Dello Humor Nerofaneyro100% (2)
- L'ammazzatoioDocumento6 pagineL'ammazzatoioAndrea CardoneNessuna valutazione finora
- Gabriele D'AnnunzioDocumento7 pagineGabriele D'Annunzio85xsc25yfbNessuna valutazione finora
- Gabriele D'annunzio RiassuntoDocumento7 pagineGabriele D'annunzio RiassuntoPaolo CasellaNessuna valutazione finora
- FlaubertDocumento13 pagineFlaubertMirelaNessuna valutazione finora
- LoplopDocumento20 pagineLoplopPopinga100% (1)
- Aldo Busi Su Verlaine e Rimbaud, Amanti Dolenti e Vagabondi - La Repubblica 08.06.2013Documento1 paginaAldo Busi Su Verlaine e Rimbaud, Amanti Dolenti e Vagabondi - La Repubblica 08.06.2013glisfogliati100% (1)
- Tesi Andi Begaj - Doc - 1 (2014 - 06 - 07 16 - 25 - 26 UTC)Documento24 pagineTesi Andi Begaj - Doc - 1 (2014 - 06 - 07 16 - 25 - 26 UTC)jurgenkurzNessuna valutazione finora
- La città vampira: o la sventura di scrivere romanzi goticiDa EverandLa città vampira: o la sventura di scrivere romanzi goticiNessuna valutazione finora
- Boito MefistofeleDocumento59 pagineBoito MefistofeleEdoardo UrbaniNessuna valutazione finora
- Komparativna Analiza Tozzi KozaracDocumento22 pagineKomparativna Analiza Tozzi KozaracFranka PolićNessuna valutazione finora
- UntitledDocumento636 pagineUntitledRené Morales ZepedaNessuna valutazione finora
- Il Decadentismo 5Documento14 pagineIl Decadentismo 5Arianna PetraliNessuna valutazione finora
- MONTALEDocumento2 pagineMONTALEreal xcsNessuna valutazione finora
- Donne e LetteraturaDocumento3 pagineDonne e LetteraturahaccaNessuna valutazione finora
- Lupin contro Holmes: La parodia che si fece beffe dell'originaleDa EverandLupin contro Holmes: La parodia che si fece beffe dell'originaleNessuna valutazione finora
- UntitledDocumento2 pagineUntitledGioNessuna valutazione finora
- La Fiaba e La FavolaDocumento31 pagineLa Fiaba e La FavolaGiovanna CobinoNessuna valutazione finora
- Canzone 1Documento5 pagineCanzone 1JovanaNessuna valutazione finora
- Anteprima Luglio 2021 WEBDocumento13 pagineAnteprima Luglio 2021 WEBSilvia Onpu RossiNessuna valutazione finora
- Dvorak - Msku Na Nebi Hlubokm Rusalka - Song To The MoonDocumento9 pagineDvorak - Msku Na Nebi Hlubokm Rusalka - Song To The MoonGrisel Lara100% (2)
- GIOVANNI PASCOLI SchemaDocumento6 pagineGIOVANNI PASCOLI SchemaMariachiara ContiNessuna valutazione finora
- Letteratura Italiana Moderna e ContemporaneaDocumento53 pagineLetteratura Italiana Moderna e ContemporaneaBenedetta CastagnaNessuna valutazione finora
- Https WWW - Dmc.com Media DMC Com Patterns PDF 7367 INTDocumento12 pagineHttps WWW - Dmc.com Media DMC Com Patterns PDF 7367 INTMariel EscamillaNessuna valutazione finora
- Commento L'assiuoloDocumento2 pagineCommento L'assiuoloMarco FicanoNessuna valutazione finora
- Umanesimo Eta' MediceaDocumento2 pagineUmanesimo Eta' MediceaNunzio BrancaccioNessuna valutazione finora