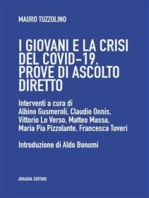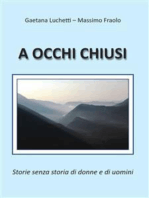Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Riassunto Oltre La Pena
Caricato da
CLAUDIA AMBROSONITitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Riassunto Oltre La Pena
Caricato da
CLAUDIA AMBROSONICopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|11436358
Riassunto Oltre LA PENA
Pedagogia del conflitto della marginalità e della devianza (Università degli Studi di
Bergamo)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
RIASSUNTO OLTRE LA PENA- L’INCONTRO OLTRE L’OFFESA-
LIZZOLA
In pena si trova chi ha vissuto la rottura, nella sua vita, della fiducia originaria, dell’attesa che dai primi
momenti ha segnato i giorni di ognuno.
La pena segna la perdita dell’innocenza, eppure uomini e donne non innocenti sono capaci di riscattarsi, di
rigenerare legami, di iniziare di nuovo. Sanno assumere una domanda di giustizia e rispondervi, anche
superando una logica restitutiva e camminando verso un orizzonte riparativo.
Lo fanno attraverso tessiture personali ed esistenziali, attraverso difficili passaggi nell’esecuzione penale,
nella sofferenza e nella cura. Aprendo esperienze nuove di legame e di vita comune.
Chi è in pena sente di non appartenersi più, e anche di non essere più di qualcuno. Chi la pena la soffre vive
il continuo sentire la sua vulnerabilità, chi la pena l’ha causata è fissato in qualche modo da quella scelta, da
quel gesto, nell’impossibilità di divincolarsene.
Uomini e donne si scoprono nell’evidenza che per abitare la propria fragilità devono confidare, partecipare a
trame di reciprocità, vivere nel legame e tornare a corrispondere. La pena è passaggio importante e doloroso
per mantenere questa coscienza e per rinnovare le pratiche che la sorreggono e la esprimono.
PARTE PRIMA: UOMINI E DONNE INNOCENTI
La durezza del tempo d’esodo
Martin Buber parla di età della casa ed età senza casa. Nell’età della casa le convivenze umane abitano
mondo ordinati, nei quali sono definiti il senso del tempo e della storia, si usano parole il cui significato è
generalmente condiviso. Nell’età senza casa, invece, prevalgono l’incertezza e l’ansia. Nelle età senza casa si
vive la consumazione di un tempo. Come nell’esodo: tempo grande e fecondo ma anche ricco di fratture
sociali, culturali ed esistenziali. Nell’esodo viene alla luce la traccia violenta dell’umano ma si evidenzia
anche la resistenza delle speranze e delle cure reciproche. Vivere il tempo dell’esodo è ciò a cui forse siamo
chiamati perché il mondo non ci sfugga e non prevalga la seduzione della violenza e dell’indifferenza.
Certamente il nostro esodo è anche un tempo di durezza e rancore. La reattività immediata brucia lo spazio
della riflessione e impedisce di cogliere il valore delle persone. Si forma così una logica prepotente e
violenta. Uno scritto del 1940 di Maria Zambrano intitolato “L’agonia dell’Europa” sostiene che “ogni
disastro consente alla gente di manifestarsi nella sua cruda realtà. Quando crolla ciò che era rimasto saldo, il
rancore si scatena”. Il rancore è reso terribile dal fatto che si ritorce sempre contro ciò che potrebbe salvarlo.
Distrugge principi e valori. Questo testo sembra parli di noi, della nostra società attuale nella quale
assistiamo alla erosione dei vincoli della vita comune, della coscienza morale.
Riemergono paure nuove e antiche. È quindi tempo di una lucidità al fine di vedere e curare ciò che nasce.
Zambrano parla dell’uomo come di una creatura a cui non basa nascere una sola volta e che ha bisogno di
venire riconcepita. Inoltre, oltre a paura e violenza, gli uomini e le donne mostrano anche speranza tendendo
a dare la vita per la giustizia, a stare presso le vittime e a perdonare. Per far fronte a questa violenza che
nasce bisogna avere lucidità, cura e attenzione che sono condizione e frutto di una relazione tesa a sostenere
l’umano e la fraternità.
1
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
Nelle nostre città il benessere e la sofferenza sono sempre più privatizzati e confinati agli ambienti privati e
familiari. Molta vulnerabilità ed emarginazione hanno natura esistenziale: sono legate a dimensioni
personali. Ma nel nostro a tempo, a questa violenza fredda e privata, si vede anche una violenza calda che è
invece molto visibile. Siamo in un tempo segnato da un incremento della distruttività, tempo di guerra. Già
dall’11 settembre 2001 la guerra ha subito pesanti metamorfosi. La guerra è diventata una malattia della
civiltà. Riuscire ad essere miti in tempi di guerra risulta difficile, eppure rappresenta un punto necessario di
resistenza.
La vulnerabilità è presente nell’essere umano, il quale è sempre attraversato dalla violenza calda che pare
metterlo alla prova. Ciò porta anche ad una chiusura verso l’altro che genera privatizzazione che porta le
persone a chiudersi in micro-comunità viste come più rassicuranti. Queste ultime (le micro-comunità)
continuano però, per vivere, a creare e produrre esclusione e disprezzo verso gli altri. In tempo d’esodo, il
contatto con la violenza fredda blocca il “sentire l’altro”. L’indifferenza blocca le relazioni. Questo porta le
persone a idealizzare una figura da disprezzare.
Molti utilizzano il disprezzo per collocarsi nelle dinamiche sociali. Alla base del disprezzo c’è l’incapacità di
incontrare la propria vulnerabilità e l’evidenza di essere nati dalla cura.
Il riconoscimento, che è il contrario del disprezzo, è necessario alla costruzione dell’identità e alla
convivenza. Il disprezzo, invece, esprime un intento distruttivo e di odio.
Le strategie del disprezzo negano l’identità dell’altro e vanno dal disprezzo fisico alle pratiche di esclusione
sociale fino ad arrivare al disprezzo simbolico che identifica l’altro come negativo e/o inferiore. Anche l’aver
cura di sé non è un’acquisizione immediata. Quando si subisce o si utilizza il disprezzo, il mancato
riconoscimento lascia segni profondi. Il disprezzo genera paralisi e rende difficile riconquistare la cura di sé.
Ci vogliono percorsi che riportano a fare i conti con quella che Minkowski chiama “morte transitiva” ovvero
un saper lasciare parti di sé. Riconquistare la morte immanente è una fatica dura. La chiusura all’altro e la
chiusura in micro-comunità è illusoriamente rassicurante.
Nelle fratture delle vite
La vita che cerca vita ha bisogno di incontrare altra vita che cerca vita. Quando ci neghiamo il tempo gli uni
agli altri chiudiamo il futuro. Tempo negato è anche quello di chi vive il bisogno di una relazione educativa e
non la trova.
Il mondo dei padri sembra privo di coraggio, come se non volesse misurarsi o esporsi con le sue narrazioni e
sembra preferire un incontro con chi cresce che cerca di produrre un attaccamento segnato dalla paura.
Questo processo porta ad un furto della coscienza e un furto del tempo. Si ruba agli adolescenti quell’alterità
rappresentata da adulti portatori di storie che è necessaria per favorire l’attraversamento verso una nuova
nascita.
Nella nostra società ci sono molti spazi di libertà e di scelta ma quando diventa meno forte il legame tra le
persone, questa libertà diventa opprimente e viene svuotata dall’interno.
Occorre una mediazione che permetta di generare contatti e incontri. In questo modo, di persona in persona,
di generazione in generazione, passano i racconti. Grazie ai racconti noi siamo capaci di abitare mondi a noi
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
stranieri. Grazie ai racconti siamo capaci di identificarci nelle persone all’interno degli stessi e questo
comporta una provocazione ad essere e agire altrimenti che può far maturare un uomo e una donna.
Occorre dare spazio anche alla debolezza e scoprire il confine tra possibilità e limite lavorando anche su una
nuova costruzione dell’intenzionalità. Ognuno cresce indagando la propria capacità intenzionale, la propria
modalità di darsi senso. In alcuni casi l’intenzionalità fa i conti con un blocco e ci si sente schiacciati da una
presenza eccessiva nel mondo che può portare ad una fissazione sulla propria insufficienza. Altre volte
l’intenzionalità viene distorta da un “troppo di io” e riduce l’altro e il mondo a strumento della
rappresentazione di sé. Ciò porta ad una incapacità di camminare con l’altro e alla chiusura in comportamenti
spesso antisociali.
L’incontro con la vulnerabilità può riaprire il respiro della coscienza intenzionale delle donne e degli uomini
nel riconoscimento del legame che li precede e li origina. Le esperienze nella frattura e nella cura possono
essere instauratrici di una nuova intenzionalità. La coscienza intenzionale oscilla tra un senso di impotenza e
il delirio di onnipotenza.
La forza del gesto di offesa
Quando le forze delle norme vengono meno, le solidarietà tendono a scomparire e gli altri diventano utili
oppure ostacoli, oggetti di cui disporre o nemici da negare. Bisogna quindi tornare a ciò che origina l’uomo.
In esodo si cammina e si assapora il senso del futuro, la costruzione di equilibri e legami. Ciò ci ricorda che
l’etica si trova all’aperto. “All’aperto” vuol dire esposta a movimenti dei “fondi oscuri£ che ogni uomo e
donna porta con sé e che altri movimenti di gruppi possono far scatenare. Ma “all’aperto” indica anche
uomini e donne buoni e giusti. Si deve riscoprire il senso del vivere insieme, della cura reciproca.
Nei momenti di transizione assume importanza ciò che avviene nei luoghi in cui si giudicano i gesti, si
richiamano le norme e si definisce ciò che è reato, ingiustizia e distruzione del legame. In questi luoghi di
opera una chiarificazione di cosa ricostruire nella convivenza.
Come si costruisce il processo dei gesti e delle intenzioni che rompono il legame e vanno contro le leggi?
Come si ricrea quel processo in cui si evidenziano le conseguenze dei gesti verso persone rese vittime?
Bisogna cercare di costruire nuovi sentieri della vita comune e provare a riparare legami e permettere alle
persone di rigenerarsi.
La violenza calda è quella agita verso l’altro, sé stesso e contro le cose. È una violenza che “fa rumore” e
toglie l’attenzione da domande fondamentali. Noi diventiamo quello che agiamo, quello che scegliamo. Ma
come liberarci da questa costituzione quando diventa distruttiva e crea separazione? Il reato è sicuramente
un fatto sociale ma il ricondurre a psicopatie i comportamenti criminali e violenti, pensando di concentrare
l’intervento sulla terapia, mostra scarsa attenzione ai processi interattivi e simbolici entro i quali la persona
ha condotto il suo percorso. Un conto è la rilevanza clinica dei disturbi, altro è la loro influenza sui
comportamenti violenti. Bisogna tenere in considerazione anche i contesti e le cornici relazionali. Non si
tratta di rimuovere le cause che hanno portato alla violenza. Bisogna avere a che fare con operatori e
attrattori che hanno
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
costituito il percorso verso il crimine e l’esercizio della violenza. È l’assunzione di un comportamento
deviante a riorganizzare l’identità personale e produrre le motivazioni devianti. Gaetano De Leo parla del
“processo della devianza” nel quale si possono identificare tre fasi.
La prima fase è quella di “antecedenti storici della devianza” cioè le condizioni e le problematicità della
persona che sono rilevanti ma che da sole sono incapaci di determinare le scelte devianti.
La seconda fase è segnata dall’emergere di una “crisi” nella storia del soggetto. Si crea così un vortice
all’interno del quale il gesto violento diventa fuoco d’interesse esplicativo.
La terza fase è quella della “stabilizzazione del percorso deviante”. Vene usata la devianza
anche per produrre interazioni e la stabilizzazione avviene quando il gruppo e il contesto rinforzano
l’immagine di sé valorizzando le competenze acquisite nella devianza.
Le persone poi usano strategie per svincolarsi delle norme e dalle responsabilità. Gaetano del Leo ne
individua alcune:
1) La prima è la “giustificazione morale dei gesti”, legata al richiamo della difesa della dignità
personale.
2) La seconda è “l’etichettamento eufemistico dei gesti” ovvero l’utilizzo di un linguaggio “attenuato”
al fine di rendere i gesti più accettabili.
3) La terza strategia è il “confronto vantaggioso” in cui si paragona il proprio gesto con altri ritenuti
peggiori.
Esiste anche il “dislocamento delle responsabilità” su altri, oppure la “diffusione della responsabilità”
all’intera società, o, ancora, la “distorsione delle conseguenze” con la quale si riducono gli effetti delle
azioni, l’“attribuzione della colpa” di ciò che è successo al contesto sociale o alla vittima stessa.
Interrompere carriere criminali è un processo complesso.
RENDERE GIUSTIZIA
Una rottura instauratrice
Nei reati va sempre letto un messaggio. C’è sempre un senso di inadeguatezza personale, un senso di
precarietà esistenziale e anche una pretesa al controllo delle persone piuttosto che un profondo
individualismo. Dietro a queste azioni spesso c’è scarsa progettualità, una vita senza speranza e autostima.
Manca il gusto del vivere e spesso il gesto violento non viene percepito come tale da chi lo compie.
Ci sono luoghi nei quali l’incontro con la violenza mette a dura prova un’intenzionalità educativa. È difficile
far fronte a quanto la violenza ha provocato in una persona. L’educazione non deve contrastare la violenza in
modo diretto ma deve ricostruire, elaborare lutti e riaprire nuovi percorsi. In questi soggetti l’agito d’offesa
ha instaurato una relazione con l’altro non segnata dalla pietà o dal rispetto, il quale è spesso visto come
forma dii debolezza e assoggettamento all’altro. Ritrovare sé stessi e la pietà in una relazione, assumere
significati e conseguenze, riprendere una possibilità di scelta, è il difficilissimo cammino che provano a
sostenere educatori, psicologi.
In condizione di detenzione e nelle forme non detentive della pena, si incontra l’uomo del reato e l’uomo
della pena. Lì si coglie che la sola affiliazione della pena può non avere la forza di rompere le
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
cristallizzazioni create dal reato, le quali non di rado impediscono l’esperienza della colpa e
l’attraversamento del pentimento. Quello educativo è un altro sguardo che è legato al mantenimento di una
fiducia di base alla convinzione dell’educabilità. L’agire educativo non può pretendere di vincere la violenza
ma può rendere capaci di leggere le proprie possibilità di violenza e aiutare la strutturazione di altre forme di
coscienza intenzionale e morale. Può orientare un percorso di
riscatto personale.
Al cuore dello sguardo pedagogico che guida un lavoro di ristrutturazione della attività intenzionale di una
persona ci sono quattro caratteri:
• Attenzione ri-compositiva → che considera la persona nella totalità dei suoi aspetti. Un lavoro
rieducativo deve confrontarsi con resistenze forti e inconsce che non perdono efficacia nonostante
il comportamento negativo. Si tratta di trovare elementi “positivi” all’interno della vita del soggetto
che ha compiuto azioni violente.
• Orientamento al futuro, al possibile → Ci si concentra sulle capacità di giocare il proprio sé
responsabilmente.
• Orientamento pratico → in cui si promuovono spazi di vita concreta in cui ritrovare nuove capacità di
azione e relazione. Sonno pratiche che permetto di decostruire il passato e prenderne le distanze in vista di un
futuro migliore. Per disfare lo sguardo sul mondo è necessario rifare le pratiche e gli incontri.
• Insistere sulla dimensione sociale, sulla vita comune.
Serve quindi una rottura: la risposta al reato va cercata nell’instaurazione di altri cammini sui quali
ritrovarsi, in luoghi educativi. Possiamo evidenziare alcuni caratteri di queste rotture. È importante
incontrare situazioni di debolezza e fragilità ma anche di cura e difesa dei diritti. Anche il confronto con
esperienze e storie di vita di diversi contesti sociali può fare scoprire l’appartenenza a una “comune
umanità”. Un’altra possibilità di “rottura” può essere rappresentata dalla necessità di rideclinare le relazioni
con i propri mondi familiari in condizione di separazione. Si può parlare anche di “rottura instauratrice”
dell’incontro con la mitezza che è, insieme, non violenza e richiamo di verità. La mitezza può portare fuori
da dinamiche di negoziazione e di calcolo di convenienza. La prospettiva riabilitativa propria del trattamento
penitenziario non basta. È utile perché chiama in gioco la persona ed è tesa sul cambiamento. Ma se non si
apre anche una dimensione riparativa non si cura la ferita.
Attivare le persone a stabilire relazione richiede l’intervento di più soggetti, chiede contesti con più presenze.
Si può dire che nella relazione educativa si diventa attivi e vivi solo dopo che è avvenuta una rottura (rottura
instauratrice), dopo che, per un certo momento, ci si è sentiti persi.
Il carcere, la pena, il riscatto
La pena vissuta nella condizione di detenzione è un’esperienza che a volte lascia celata la verità del reato.
Questo aspetto punitivo spesso lascia poco spazio alle dimensioni del riscatto personale e della
riconciliazione nei confronti delle vittime. Uno spazio pedagogico penitenziario chiederebbe la stipulazione
di un patto trattamentale con le persone detenute teso ad aprire un processo che le porti a farsi carico di un
lavoro su di sé nel quale possano diventare testimoni del proprio cambiamento. Ai colpevoli si deve chiedere
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
di attivarsi e di fare. Tutto ciò si scontra con la forza delle costrizioni che a volte è al limite dell’umiliazione.
Queste condizioni possono confermare i caratteri delle persone. Le forme della pena sono elementi decisivi
per la possibilità di maturare nuove responsabilità. Anche nella detenzione sono presenti degli incontri con
guardie di sicurezza, educatori ma anche con gli altri detenuti attraverso incontri caratterizzati dalla presenza
di regole e condivisioni. A volte ci sono anche gli incontri con le vittime e si tratta di incontri molto
importanti perché possono rendere possibile un attraversamento educativo delle memorie.
Nel carcere ci sono anche soggetti definiti come deboli o marginali che sono reclusi per reati
specifici e non per comportamenti o condizioni ma sono l’evidenza del fallimento delle politiche sociali.
Nel carcere c’è un grande percentuale di sofferenza e violenza.
In un carcere così connotato come costruire uno spazio pedagogico che permetta di rielaborare le
difficoltà? Come orientare la persona verso la costruzione
e la relazione? Occorre lavorare su prospettive disciplinari diverse. Il carcere è insieme un luogo e un non
luogo: a volte è disumano ma allo stesso tempo infestato di senso perché l’umano vi si mette in scena. Allo
stesso tempo è un luogo in cui essere accolti senza condizioni e paure. In carcere si incontrano alcune
resistenze specifiche. La prima resistenza con la quale si fanno i conti è la resistenza dell’istituzione stessa.
La pena, il tempo di detenzione, quello definito nel dispositivo della sentenza, finisce spesso per sostituire la
colpa. Lo scontare la pena sostituisce spesso anche il ripensamento personale e la ricerca di un riscatto.
La parola “riscatto” si collega al termine di Maria Zambrano “rescatar” che indica il movimento del tornare a
prendere parti di sé nel proprio passato. Dentro le mura delle carceri riesce a volte a mutare l’interrogazione
su ciò che vale. Si può sostituire al disumano subire un nuovo darsi da fare nella riparazione delle
conseguenze del reato, nell’assunzione libera di impegni a favore della vittima. Serve una filosofia politico-
criminale che con il dischiudersi di “possibilità riparative” consenta all’autore del reato dii giocare ancora “la
carta mobilitante delle proprie capacità, conoscenze e competenze”: sollecitando a “mettere di nuovo in
campo quelle risorse personali che la pena detentiva finisce per rinchiudere”. Nella pena, la vita cambia sia
che si sia vittime sia che si sia colpevoli. Riportare il senso di colpa nella propria storia personale è farne una
premessa per nuovi inizi. Servono relazioni tra donne e uomini che non dimenticano il male fatto e subiti e
che cercano percorsi nei quali alla fine si “rimettono le colpe”. Uomini e donne curano la
possibilità di nuovi inizi. Un’altra forte resistenza che si incontra in carcere è sulla “soglia del pentimento”,
sul confine di una trasformazione personale. È una resistenza che impedisce la conquista di una apertura.
Non è semplice rendersi conto di ciò che vivono gli altri, le vittime. A volte lo stesso pentimento mina la
fiducia. Di chi si pente non ci si fida. Anche chi si pente fatica a fidarsi del suo pentimento, ad accettarlo. C’è
bisogno che anche altri ci credano con lui altrimenti del pentimento non ci si fida. Non aiuta l’isolamento nel
quale ci si trova. La progettazione “rieducativa” nel quadro dell’attività trattamentale dell’adulto detenuto
avviene in modo discontinuo e coinvolge un terzo o poco più delle persone detenute. L’indirizzo è in
coordinamento di un piano personalizzato non è nella realtà effettivamente assunto e curato da una figura
educativa ma pare risultare piuttosto da una “composizione” di interventi di figure diverse. Così trova
ostacoli una presa in carico globale del soggetto.
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
Il contesto detentivo rende molto difficile la valorizzazione della persona come protagonista attiva nella
costruzione di un nuovo modello. Il suo reinserimento viene pensato spesso in modo meccanico.
L’esperienza di detenzione non può essere vissuta come una parentesi che “riporta in parità i conti”. Occorre
pensare a occasioni precise e impegnative per progettare il percorso
riabilitativo insieme a chi è in esecuzione penale, con il coinvolgimento di tutte le aree e i soggetti coinvolti.
Occorre che da una condizione segregativa possa maturare una esperienza di avvicinamento, di
vulnerabilità. La cura è dare tempo alla formazione dell’uomo, sostenere che nell’avventura umana il male
non è originario. Le ferite possono divenire esperienze conoscitive e di approfondimento del sentire, a patto
che non venga rubato il tempo, come spesso avviene per chi è carcerato.
Rigenerare legami e persone
“La vera pena è la colpa” così scriveva Carlo Maria Martini.
Il carcere è lo spazio su cui si proiettano molte rappresentazioni sociali e attese di giustizia segnate per lo più
dalla logica del contrappasso: al delitto si risponde con la pena, con la sanzione. La pena deve agire come
monito per i malvagi. Il carcere rappresenta lo spazio simbolico e reale della risposta sociale, della
“restituzione” di una punizione al male commesso.
È possibile il riscatto di chi ha compiuto il male? Carlo Maria Martini scriveva “la risposta al male secondo
l’intelligenza di una elaborazione conforme al bene”.
Ricostruire il tessuto lacerato chiede dei passaggi obbligati: quello della riparazione e prima ancora quello
della maturazione dell’ammissione di colpa. È un doloroso riconoscimento. Il dolore di chi ha recato offesa
non vale come risarcimento, piuttosto può valere come forza per un percorso nuovo, un riscatto. Anche
l’umanità di chi si è reso colpevole di un reato deve stare a cuore. Bisogna praticare una reazione al male che
stacchi dal male e che non produca altra violenza. Se nella colpa è già insita la pena, la colpa comporta una
nuova responsabilità verso il riguadagnarsi la vita. Proprio per questo la colpa non cancella la dignità di un
uomo o di una donna: resta aperto il cammino verso una nuova nascita.
La logica del contraccambio vede la detenzione come la scelta da privilegiare per dar forma alla giustizia
perché rappresenterebbe un chiaro “analogo negativo” del reato capace di segnalarne la negatività. Ma questa
logica non muove energie capaci di riavviare e rinforzare il legame sociale leso. Rischia di lasciare fermi i
posizionamenti interiori delle persone, delle relazioni. Sanzionando e punendo tende a intimidire e
neutralizzare più che a far maturare scelte. Riaffermare la positività della legge e ritessere i legami di
convivenza chiede di dare vita nella esecuzione della pena a esperienze, incontri e prove di sé nelle quali
rielaborare criticamente le scelte fatte, compiere atti riparatori, vivere rapporti dinamici. Difficile che
avvenga in un carcere.
Nella restrizione le donne e gli uomini si trovano soggetti passivi alla loro esperienza piuttosto che attori
della loro esperienza. Ma solo se nell’esperienza si aprono spazi di costruzione si possono produrre effetti di
decostruzione di quando appreso e praticato sotto il segno del reato. Ma ciò può avvenire solo se quello
detentivo diventa un luogo da abitare, un luogo di relazioni. Allora il confronto e il rapporto con la
convivenza sociale possono essere tessuti.
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
Roberta De Monticelli disse che la giustizia è fatta non solo a condizione che ci sia riparazione ma anche
quando “tutti sanno”. L’abitare un’esperienza è da vigilare con cura.
Si parla anche di solitudine della scelta, di ripresa di fiducia in sé. In fondo a quella solitudine con sé stessi
c’è il dire “sì alla vita”. Dobbiamo passare attraverso la “notte scura”: in essa possono celarsi gli elementi
più belli del nostro disporci agli altri, ma anche le tentazioni più forti della violenza da esercitare su altri o su
noi stessi. Sicuramente questa esposizione alla notte scure obbliga gli educatori a una certa raffinatezza
nell’usare i loro saperi e le loro pratiche. Possiamo educarci reciprocamente a diventare uomini e donne
miti, tenendo ben presente che dentro di noi abbiamo anche delle forze distruttive. In noi prendiamo
contatto con tutto questo tutte le volte che accettiamo di passare nella “notte oscura” per poi, grazie
all’altro, uscire all’aperto.
PENA ARRECATA PENA SUBITA
La colpa e il debito
La relazione educativa ha sempre una dimensione “drammatica”, di confronto tra resistenze. È lo sforzo per
rompere insieme della resistenza, per poi insieme costruire: tutti e due i movimenti la costituiscono.
Nel carcere si vive un attraversamento importante dell’avventura umana segnata dalla colpa. L’azione
educativa cerca di “allestire” condizioni che permettano di ricostruire persone. Un “riscatto” che renda
possibile raccogliere il peso della colpa. Riscatto che impedisca di essere ridotti sempre alla colpa soltanto.
È una società, la nostra, che dopo il giudizio non sa volgersi verso il volto del condannato.
La società della colpa e del merito lascia pochissimo spazio al legame e alla responsabilità, all’assunzione
personale della colpa. Fa “uscire” dalla colpa soltanto con “riequilibrio”, restituendo, pagando. Ma lo
squilibrio resta. La vita cambia, sia per la vittima che per il reo. Occorre maturare che la prepotenza è
ingiusta, così come è ingiusto violare, recidere legami, ingannare. Ma per incontrarsi sulla “soglia del
pentimento” occorre rompere il contagio tra la violenza del delitto e la violenza della punizione.
Se il detenuto deve diventare protagonista della sua situazione, e della sua strategia di riscatto, occorre
anzitutto contrastare la “cultura della branda”, quella rassegnata abulia, quell’atrofia del sentire che porta
proprio a eludere il confronto con la colpa, il rapporto tra sé e il reato.
Nelle strategie “trattamentali”, di “rieducazione e reinserimento”, ogni operatore deve ben aver presente che
si rivolge a uomini e donne autori di reati con un portato di esperienze e di distorsioni relazionali e nella
struttura di personalità che li condiziona a vivere una debole possibilità di immaginare altri tipi di vita
possibile. Gli operatori stessi sono ben consapevoli di questo rischio di rigidità. Educare si svela sempre
come un ritrovarsi in narrazioni che ci precedono. Dentro queste narrazioni occorre provare a toccare
insieme la propria impotenza e la propria forza attiva davanti a un sentire particolare: la colpa.
Questo sentire è il riflesso della sofferenza. Ora ritrovarsi chiederà di fare spazio a una rottura instauratrice
che operi una sorta di perdono. È quando le donne e gli uomini si trovano nella colpa che vivono
l’esperienza. La condizione della “vittima” e quella del “colpevole” appaiono accomunate da questa
impossibilità di iniziativa intesa alla trasformazione di sé.
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
La vita comune si vede segnata da un debito nei confronti della vittima. La vita comune viene toccata dalla
colpa e dal debito verso la vittima. È certo la vita comune ha pure ospitato il colpevole, il suo tradimento
delle norme di convivenza e la lesione inferta all’altro. Ferita che tocca anche quella “fiducia di base” che
dovrebbe permettere di segnare una buona distanza dall’istintiva guerra di tutti contro tutti per il possesso.
Fiducia che è l’attesa e l’anima della convivenza.
La lesione è totalmente addebitata al tradimento del colpevole, e la convivenza reagisce rinchiudendolo
nell’ombra dell’istituzione di una pena. Il tempo sociale pare inaridirsi attorno al “colpevole” e alla
“vittima”: li riduce ai margini o fuori dai luoghi della vita. I luoghi in cui le donne e gli uomini ritrovano e
rinnovano sé stessi nella loro individualità, nell’identità di genere, sono luoghi impediti ai colpevoli. Fuori da
questi luoghi chi è autore di reato può semplicemente cercare di negare le parti oscure di sé in cui non si vuol
riconoscere.
Per evitare questo vicolo cieco occorrono due condizioni: che si guardi in faccia ciò che si è compiuto ed
espresso di sé; che si colga su di sé una attesa di novità. Non è un semplice “lasciare andare” le colpe, chiede
piuttosto di riprendere autonomia, di entrare nella dinamica del riscatto. Rimesse le colpe c’è l’impegno
definito come debito che è al di là del risarcimento. La colpa non è cancellata ma è una via per andare al
fondo di sé stessi. Il senso di colpa stabilisce un’asimmetria.
Nell’asimmetria stabilita dalla colpa, dal debito, non si cerca reciprocità: la si spera, magari, ma non la si
chiede come condizione. Non possiamo sostituirci all’altro, alla sua responsabilità: al più possiamo
avvicinarci e sentire in noi il suo dolore, renderci conto di ciò che vive. Le scienze umane e psicologiche
hanno colto i meccanismi che generano i sensi di colpa. I sensi di colpa nascono dall’evidenza del limite,
sono legati alla vergogna. La propensione a prendere su di sé la colpa dell’altro può avere la funzione di
proteggere la convivenza da quelle colpe, di preservare le relazioni. Del senso di colpa Giovanni Jervis
sottolinea prevalentemente le dimensioni negative. Mette in luce il nesso tra il senso di colpa e
l’irrazionalità. Jervis sostiene che mentre e molto facile sentirsi in colpa, è molto difficile sentirsi in colpa in
modo sano. I sensi di colpa, a suo giudizio, sono paralizzanti. La ricerca di vie d’uscita da questo tormento
può portare su percorsi pericolosi. Sentire la colpa per nulla è espressione di stati di depressione. Il senso di
colpa è dunque scivoloso, va superato. Alla colpa-sentimento deve sostituirsi la maturazione di
responsabilità ben definite. Il senso di responsabilità a differenza di quello di colpa è un senso sereno,
costruttivo. Il senso di colpa che si fa dilagante e non viene elaboro può sicuramente indirizzare verso chine
pericolose. Un’azione che non vogliamo accettare come nata da noi rischia di essere ripetuta. Solo se
accolta come nostra, come colpa specifica, può divenire un “terreno di lavoro” ricompositivo.
Ciò è importante specie quando gli effetti delle azioni sono irreparabili. Sentire la colpa è scoprire e abitare
l’ambivalenza e la complessità. Il legame tra colpa e perdono. Colpa e perdono sono compresenti, maturano
l’una grazie all’altro. La colpa non avvelena proprio grazie al perdono: si attenua, diviene fonte di libertà e
di nuovo inizio. Il perdono è trovato e provato grazie al senso di colpa che impedisce il giudizio sommario.
Nessuno si libera da solo dalla colpa. Occorre che vegliamo e ci richiamiamo oltre reciprocamente,
sostenendo una presa di distanza dal male compiuto e subito. Presa di distanza e ricomposizione che non si
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
risolvono nella condanna e nella pena. Come definire il grado di colpevolezza di un comportamento?
Lo sguardo di uomini e donne in pena
Offrire del tempo, stare insieme nel ristagno del tempo con l’altro, può farci recuperare la luce della
affidabilità, provare a togliere le ragioni alla violenza, di provare ad attenuare il legame con la violenza.
Il dono del tempo è un dono di ospitalità. Si accolgono esperienze ed eventi della vita di donne e di uomini
perché ci si possa ritrovare affidati. Nel tempo può svolgersi l’esperienza della ricapitolazione: l’esperienza
del riprendere tempi e passaggi della vita e ritessere i fili in un gioco di riprese, di tagli per aprire nuovi
legami.
Ricapitolazione necessaria per non vivere nel rancore e nel risentimento perenne. Quando la
ricapitolazione avviene siamo resi forse ancora capaci di dare e offrire. Quello che mettiamo in atto nei
confronti di storie di fragilità e di dolore è sempre una sorta di invasione. Che fa ancora male. La prossimità,
anche la sola prossimità alle vittime, a volte, fa male. È naturale che si crei una resistenza da parte di chi
vive un dolore molto forte, quando è riportato a sé stesso e al suo corpo, e non riesce ad accettare che
qualcun altro lo conduca proprio lì. È importantissimo riconoscere la resistenza di chi non si lascia aiutare,
di chi ha paura di aprirsi alla relazione. A volte poi la resistenza crollano improvvisamente e si arriva alla
delega totale e ciò non è un bene: l’invasione non può dirsi riuscita e buona solo perché l’occupato ha
delegato tutto all’occupante. Vi sono persone che vivono come ultima strategia di resistenza il restare nel
dolore, quasi fosse l’ultimo contatto che hanno con sé.
Lo sguardo della vittima chiede tutto dal suo svuotamento. Questi sguardi sono fatti lontani, chiedono tutto,
invasi dall’ombra e fissati sulla luce.
Quell’ombra nella quale l’incontro con l’altro è sempre sospeso, e quella nella quale il tradimento le ha
precipitate. Quella luce della traccia profonda dell’amore e della promessa che si è fatta nostalgia vuota. La
vittima mostra come una donna, un uomo possano essere resi inermi. L’inerme non ha armi, non può
ferire: è in balia del potere dell’altro. Lo sguardo della vittima disfa il nostro sguardo che viene disfatto
anzitutto perché si trova nella incapacità di costruire la realtà, la condizione della vittima. Lo sguardo della
vittima disfa il movimento del nostro conoscere ma anche quella della nostra intenzionalità che progetta e
ripara. Lo disfa per provare a indirizzarlo verso un agire in ascolto e pensoso, un fare nel debito. Il nostro è
anche il tempo in cui emerge e si diffonde una particolarissima preoccupazione per le vittime. Lo sguardo
della vittima svela l’impossibile assunzione del male: la vittima lo ha riconosciuto.
Non bisogna pretendere di assumere e vincere il male, non ci si può appropriare del bene né del tutto
liberarsi e liberare del male.
Non è la mancanza di sapere che rende debole la nostra responsabilità di fronte alle vittime. Spesso è
proprio il possesso dei saperi a occultare. Le vittime non sono da comprendere, tanto meno da studiare.
Avvicinandoci ad esse, possiamo disegnare la compatibilità che accoglie e collega i distinti. E la nostra
capacità di essere figure terze come un’altra forma possibile di vicinanza. È una vicinanza che si esprime
come mantenimento di una promessa. A questa presenza si possono confidare intenzioni, timori, paure. È
importante tenere un velo di distanza. Cosa c’è nei volti di chi ha l’anima ferita dalla sofferenza? Restano a
10
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
volte solo gesti che sostituiscono un colloquio. Le vittime non di rado si ritraggono da un sentir-sé e si
ripiegano. Non possono sentire senza sentirsi minacciate e ferite. Gli occhi delle vittime della violenza e del
dolore sono svuotati, non riescono a vedere. Cosa mi resta? Solo sperare di sperare, di poter essere ancora
colto dalla luce cui alzare lo sguardo. L’incontro tra donne e uomini mostra la sua intimità originaria al
sacrificio e alla cura amorosa.
La grande questione diventa quella di apprendere a scendere nell’inferno del vivente per poi essere tratti
fuori a respirare, compiendo ancora la nascita.
Ciò che va ricercato presso la vittima non è l’innocenza ma la ricostruzione del patto, di una nuova
affidabilità originaria. La vittima non va sacralizzata. Da richiamare non è la sacralità delle vittime ma la loro
umanità, la loro dignità di nuovo ricostruibile. Il legame da stabilire di nuovo tra la vittima e chi le si fa
prossimo è quello alle loro spalle, il legame d’origine. Il volto della vittima è l’illustrazione più forte del
volto come lo intende Lévinas. Il volto dell’altro è originalità, è il volto dell’altro che mi chiama, mi elegge e
mi ordina di rispettarlo e non ferirlo. È ancora l’incontro con l’altro che può rompere e ridisegnare il tempo
personale, una qualche nuova partecipazione al tempo del vivere insieme.
PARTE SECONDA – ESISTENZA SENZA ATTESA?
PADRI E DETENUTI
Paternità nella frattura
Quella della paternità e quella della pena sono esperienze nelle quali ci si ritrova ma nelle quali un uomo
incrocia il passaggio della scelta. Entrambe le esperienze rappresentano un passaggio. Per sempre resterà il
segno di una paternità così come per sempre si sarà segnati da un passaggio nella restrizione in un istituto
di pena. C’è un prima e un dopo la paternità. C’è un uomo che è chiamato a scegliere. Ci sono fratture e
inizi.
La paternità è sempre una paternità in relazione ai figli. Non è un semplice esercizio di ruolo. La
paternità è una dimensione cui dare ospitalità. È c’è un reato, ci sono vittime, dirette e indirette. Ci sono
legami nuovi e legami spezzati. Il futuro non può che disegnarsi come tempo del riscatto e non tanto di un
riscatto personale quanto di riscatto di un tempo del figlio, della figlia perché possa essere un tempo, un
futuro libero e promettente. Riscatto del futuro, a cura della vita e della giustizia dei figli. Tra le generazioni,
tra padri e figli, è necessario anche lasciarsi progressivamente o in passaggi netti. Quando si è in grado di
raccontare a un bambino il passato familiare, lo si libera, quando non è in grado di raccontarlo lo si
incatena. Il passato se non è contenuto in una narrazione può ritornare in maniera ripetuta e violenta. Per
divenire adulto responsabile ogni bambino ha il diritto e il bisogno di conoscere la sua vera storia. La
paternità sfida il tempo della pena, la sua spaccatura, apre una breccia del senso e dell’inizio verso una
ripresa della biografia personale come progetto. Per alcuni si tratta di lavorare sulla nostalgia. La nostalgia
che viene dal passato può rappresentare qualcosa che si torna a prendere, è che può riuscire a fronteggiare
ciò che del passato è ombra. Può permettere l’attraversamento e la ricerca di nuova vita. Molti e diversi
sono i percorsi e gli incroci tra le esperienze di carcerazione e l’esperienza di paternità, molto diverse sono
le elaborazioni, le rappresentazioni disegnate dentro di sé. Per molti padri detenuti la nostalgia si mescola
11
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
alla ricapitolazione, al riesame della propria storia di vita, dei propri percorsi, di cosa ne resta e di cosa può
restare aperto.
Una ricapitolazione di fronte ai figli, alle domande che i padri temono portino dentro. A un
certo punto questa ricapitolazione, che la pena induce, non riguarda più solo la salvaguardia della propria
narrazione, porta piuttosto a chiedersi: a cosa invito i miei figli? La carcerazione rappresenta una barriera
nello sviluppo di molti percorsi sui quali proprio la rivisitazione della paternità potrebbe portare a
ripensamenti della propria adultità nel rapporto con gli altri.
Lo sviluppo del rapporto tra padri e figli potrebbe aiutare a disegnare una nuova forma delle relazioni
familiari. Per il padre ristretto che vive l’esperienza di un carcere che spersonalizza è importante ritrovarsi
come soggetto. Il riconoscimento del ruolo genitoriale è richiesta di riconoscimento di sé. Il vissuto di
inadeguatezza è diffuso. Il senso di insicurezza e la crisi dell’autostima colpisce anche persone che pur
essendo detenute non sono cattivi genitori. La continuità nel rapporto con i padri e le madri è una necessità
prioritaria per lo sviluppo dei figli.
Mantenere la relazione può proteggere da conseguenze pesanti, può permettere al figlio di crescere nella
consapevolezza della propria storia senza rinunciar al proprio genitore. È prezioso potere parlare con altri in
una certa fiducia e intimità non in situazioni obbligate, in esteriorità. Diverso è parlare in esteriorità ovvero
dentro mascheramenti costruiti dalle scadenze giudiziarie. Scoprirsi in una possibile comunicazione in
interiorità con altre persone ristrette può lasciare spazio alla commozione, al desiderio.
Essere chiamati padri
La ricerca del padre è la ricerca di una guida. Cercare padri per sentirsi figli non rinchiusi nell’universo della
perfezione e della colpevolizzazione, del fallimento. Quella del padre è l’esperienza di chi ti consegna il tuo
essere figlio dell’uomo. Per ogni padre la chiamata che giunge dai figli molto piccolo è vivere l’esperienza di
essere attesi. Questa attesa dei figli piccioli per ogni padre, per i diversi padri che si ritrovano in esecuzione
penale, è una sorta di remissione dai debiti, è uno sguardo oltre la colpa un po’ sconvolgente per alcuni.
Quasi un invito a costruire un altrimenti. Poi le figlie e i figli crescono, giudicano, chiedono ragione.
L’attesa cambia, occorre riconquistarla e lasciare che lavori nella nuova distanza. I padri toccano anche la
delusione e il rancore che li incontrano. Sentirsi ancora attesi è decisivo per chi vive l’esperienza della colpa
e della pena. Un’attesa può essere vissuta con
riconoscenza, può spingere a cercare un nuovo riconoscimento. Esso può essere accolto come impegno
verso una nuova offerta di sé, una nuova responsabilità. Essere attesi chiede un movimento: verso la
ritessitura di relazioni e la rigenerazione dei legami. Anche tra padri e figli esiste sempre un problema di
giustizia. Una giustizia da fare rispetto alla promessa di vita buona. Figli e padri possono rincontrarsi
sull’orizzonte di una giustizia da fare. La nuova ospitalità è sofferta perché chiede di farsi carico della
sofferenza arrecata e di non farsi avvelenare da quella subita. In carcere troviamo feritori feriti. Incontriamo
uomini e donne in difficoltà a risollevarsi. A vegliare a volte sono i figli, altre i genitori. Questo non è letto
dai padri come l’essere ancora giudicati bensì come il venire letti come persone, come storie uniche e
aperte, segnate da errori. C’è una credibilità che può resistere anche passando dall’errore. Una credibilità
12
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
che rinasce, va ricostruita. È prezioso dire ai propri figli cosa un padre detenuto sta facendo per altri.
L’incontro è sempre un rischio, un’esposizione reciproca.
L’incontro con i figli è anche quello più temuto. Si teme di sentire il rifiuto, l’allontanamento. È il figlio che
permette al padre di pensare al passato come esperienza di una vita nella quale è possibile tornare a cercare e
riuscire a cogliere i semi di una consegna. Una vita da vivere e da lasciare. Si tratta di accettare e
comprendere il proprio figlio e ritrovare una nuova alleanza in parole di verità circa lo stato di detenzione e
le scelte che lo hanno determinato. Questo significa sostenere il genitore detenuto a ritrovare dentro di sé la
propria storia. I figli hanno bisogno del racconto dei padri e viceversa. È un incrocio di racconti da tempi
diversi.
È importante che separazione e lontananza non diventino rottura e allontanamento. Incontrare i figli è
indicare che c’è una promessa buona da seguire nonostante il buio. Servono percorsi condivisi in cui vivere il
periodo di distanza sul piano di realtà. Allora la relazione padre e figli si sviluppa modificando sé e l’altro. E
i padri detenuti riescono a ritrovare autorità e apprezzamento. Il dolore si combatte insieme senza
assecondare tutte le richieste che in forza di dolore vengono avanzate ma attraverso impegni reciproci, in
trasparenza.
Farsi uomini e adulti nella pena
L’universo carcerario è un universo maschile nel quale di riversano e confrontano i riti e i miti della
maschilità. Non di rado i miti della virilità. L’esercizio della forza e della violenza è un tratto evidente.
Spesso si riproducono codici e culture degli ambienti di provenienza di molte persone detenute. Ambienti
della violenza, senza regole. In generale, i modelli maschili e d’adulto incontrati e assunti nel proprio
cammino sono quelli di ambienti difficili. In tali ambienti i maschi spesso sono contro o incapaci di vita di
relazione. Eppure, proprio la paternità può rompere le cristallizzazioni delle culture e delle pratiche dei
percorsi d’origine. Sfidati dal nuovo ruolo di responsabilità, riconquista dell’adultità, del ruolo paterno,
chiedono di rimettere a fuoco un proprio credibile profilo di uomo adulto. Profilo di un uomo capace di
segnare ancora una via, ma senza possedere e dominare. La crisi della paternità fa sì che un uomo chiamato
ad essere padre possa ritrovare sé stesso nella percezione lucida della sua fragilità. Nel carcere la forzata
convivenza tra maschi adulti che si sentono in mani d’altri, in condizioni di impotenza, segna la vita
quotidiana. Maschi, adulti, pressati nella quotidianità, così segnati da differenze ed estraneità. Nel tempo
presi da ostilità ma anche da fraternità impreviste, da veglie reciproche. Avere figli, essere padri è uno dei
tratti comuni sui quali ci si ritrova in questa alterità. Lo spazio del suo racconto, della sua nostalgia, apre la
maschilità oltre il virilismo e la forza. È spazio di ammissione di fragilità, di dolore e colpa.
Fare gli uomini è divenire capaci di riconoscere, di farsi responsabili magari a partire dai figli. Adulti, fatti
uomini, capaci di lasciare e di dedicare. Adulti che scoprono una maturità che è incontro con la vita.
L’adultità aperta dalla paternità è nuova esperienza della propria vulnerabilità. In carcere la vulnerabilità non
ha facile ospitalità. Eppure, un uomo adulto dalla sua vulnerabilità può curare, dare forza a chi è incerto.
Aprire momenti di scambio riflessivo tra persone detenute è molto importante.
L’incontro e lo scambio con altri padri è un importante confronto con altre esperienze. L’incontro tra
13
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
genitori in carcere è anche incontro tra persone detenute e operatori genitori. Adulti al lavoro con e per
adulti. Genitori che incontrano altri genitori portatori di gesti e scelte che hanno rotto fiducia e legami.
Sostenere la ripresa di capacità di esercizio di responsabilità e cura va di pari passo con la ridefinizione del
ruolo paterno e genitoriale. L’esperienza scolastica è uno dei luoghi più rilevanti nel quale raccogliere i
vissuti e le storie di paternità. I gruppi di discussione o di riflessione rappresentano altre occasioni preziose
di lavoro su di sé e sulla propria paternità. Nei gruppi può aprirsi un momento di domanda e
interpretazione. Quando i gruppi sono piccoli e composti da persone ristrette allora l’esperienza che può
svilupparsi nel tempo assume tratti significativi. Sono esperienze di incontro personale favorito anche
dall’uso di alcuni strumenti culturali e di metodologie della co-formazione grazie a figure di mediazione e
facilitazione. Alcuni dei cammini che si tracciano in un istituto di pena sono veri e propri camini di
formazione della coscienza. C’è un legame tra sentire la colpa e sentire la paternità. Lavorando nel tempo
sul senso di colpa i padri possono sentire rimesse le loro colpe e sostenibile la paternità. Questo lavoro
porta a poter vivere in un nuovo tempo. Rientrare nella paternità può essere anche un rischio a causa dei
cammini che i padri devono compiere che possono contenere numerosi passaggi e nuove misure.
UNA SCUOLA PRIGIONIERA
Ciò che conta è chi diventiamo
La scuola può cambiare il carcere, l’esperienza di detenzione. Il carcere cambia la scuola: la scuola si scopre
centrata sugli studenti, aiuta la costruzione di relazioni. La scuola in carcere assume i caratteri di una
esperienza di soglia, ridisegna l’educazione. Frequentare la scuola rappresenta una forte scossa in
condizione di esecuzione penale. Viene offerta l’occasione di studiare. Chi incontrano in carcere gli
insegnanti? Incontrano uomini e donne del reato e della pena. A volte sono uomini e donne persi da lavorio
della colpa. Nella scuola in carcere queste persone incontrano la società che li punisce e la società che li
cura. La prima chiede loro capacità di adattamento al regime di detenzione, la seconda chiede che si
attivino nella partecipazione al loro cambiamento e alla cura di sé stessi. La scuola richiama ad agire e a
reagire. Insegnanti e formatori rappresentano figure particolari per chi è ristretto. Potremmo definirle
figure terze, figure che chiedono una seria ed esigente cura. Sentire sé più a fondo per far emergere un
sentire l’altro. Riprendere narrazioni e costruire immaginazioni abitabili di futuro non è facile. Chiede
maturazione e tenuta di atteggiamenti adulti. Assumere una propria domanda di formazione è da adulti.
Nell’attività scolastica e formativa tra adulti la fragilità della mente, la fatica nel capire metodo e strumenti,
portano a un confronto con la propria biografia. In un istituto di pena insegnare è anche sapere che si farà
un po’ male e non solo perché contenuti ed elaborazioni possono essere duri e difficili ma perché sempre
tali contenuti aprono a un gioco di verità, di sincerità verso le scelte, le relazioni delle persone. E
richiamano le dimensioni etiche. L’esperienza scolastica a volte avvia un serio e delicato lavoro
ermeneutico, un approfondimento delle simboliche; può avviare un lavoro su di sé, sulla propria
formazione, sulle proprie esperienze. Chi insegna è chiamato ad essere capace di attestazione, a mostrare
ciò in cui si crede (attenzione all’altro, senso della giustizia).
14
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
Nell’esperienza scolastica in carcere ciò che riesce a volte ad apparire è un particolare legame tra alcuni
percorsi di apprendimento, formazione del carattere. Le proposte non chiedono solo adeguamento, chiedono
responsabilità e continuità. In ogni istituto di pena è il contesto stesso che definisce dove può trovare
appoggio l’esperienza educativa. In carcere serve una scuola che faccia incontrare persone intere e non le
funzioni.
Uno spazio di crescita personale e di vita comune, nel quale non è tanto importante ciò che si impara ma chi
si diventa.
Quello che si dovrebbe creare, in un gruppo classe, tra adulti autori di reato e in esecuzione penale e
insegnanti, è un’esperienza sempre unica di cammino e di legame. Studiare è un’offerta ma è sempre anche
una responsabilità: non si studia mai da soli. Il lavoro scolastico può attivare un lavoro di ripensamento e di
riposizionamento. Per formare ogni studente come soggetto autonomamente responsabile occorre
considerarlo tale.
Un luogo da abitare
La scuola in carcere può diventare un luogo. Un luogo abitabile, un luogo nel quale le persone assumono un
volto, e si costituisce un universo di riconoscimento nel quale ci si incontra.
L’esperienza scolastica può essere esperienza nella quale si prova la dimensione del legame e della vita
comune.
A scuola non ci si sceglie, non ci si può evitare, eppure non c’è solo scambio. C’è dell’altro, ci può essere
riconoscimento, cura condivisa. A scuola gradualmente ci si espone e si viene apprezzati. Serve
un’esperienza che appoggi la costituzione dell’esercizio della libertà, della partecipazione alla costruzione
della propria esistenza, della propria personalità. La scuola diviene allora un luogo sentito come proprio
quando accoglie e permette di raccogliersi. Non puoi che ritornare alle tue responsabilità, alla necessità di
trovare percorsi e pratiche riparative di ciò che si è rotto o è restato ferito per causa tua. Questo puoi
maturare in un luogo che sia universo di riconoscimento come può essere un’attività scolastica.
La scuola in carcere a volte può permettere di sperimentare la verità del dire di Simone Weil per la quale il
futuro entra in noi prima che avvenga. La possibilità che una persona cambi è legata al suo vedere maturare
in sé possibilità e rappresentazioni e forme del pensiero nuove. Non può solo rappresentare un puro
addestramento dei migliori. La scuola, la relazione educativa chiedono verità, disponibilità all’esposizione
trasparente di sé. La verità ha a che fare con la scuola e con la vita. Questa attenzione alla verità trova terreno
decisivo di coltivazione nella ricerca pratica di valori e di principi, di un posizionamento personale nel
mondo che sia giusto. La scuola può aiutare un poco a pulire il futuro dal peso di azioni compiute. Può
aiutare molto e può anche non bastare. Servono attorno a lei percorsi in esecuzione penale che prevedano
contesti di incontro, di messa alla prova. È allora molto importante a scuola rispondere a bisogni ma
alimentare a dare buoni profili, ai desideri può essere ancora più importante.
Anche in carcere, a scuola, ci si può impegnare a pulire il futuro. Il futuro può presentare un cammino un
poco più aperto di quanto temuto nel quale avviarsi dotati di qualche capacità di lettura della realtà.
15
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
Insegnanti in una esperienza di soglia
Gli insegnanti in carcere devono leggere e leggersi continuamente dentro le relazioni e il loro ristabilirsi,
ridefinirsi nel gruppo. Fanno un lavoro continuo di adattamento dei curricola che tenga conto delle teorie
implicite degli allievi e dello loro idee preesistenti. Allestiscono contesti e proposte di apprendimento
personalizzato, progettano percorsi per fare raccogliere e fare interagire diverse fonti di informazione e
conoscenza. L’aula è uno strumento di socializzazione che si apre perché regola e richiama responsabilità.
Allo stesso tempo collega e distanzia dalla realtà della pena. In aula si portano i propri corpi, carichi della
propria esperienza. Ma in aula si vive anche una presa di distanza da memorie, presa di distanza riflessiva,
di nuove immaginazioni.
In un recente e impegnativo percorso di ricerca e formazione realizzato nella Casa circondariale di Bergamo,
sono emersi sei percorsi di lavoro e riflessione.
Anzitutto la questione dell’incontro con le storie di detenzione e con le storie di reato.
In secondo luogo, la questione dell’intenzionalità educativa, legata a un mandato sociale complesso. Educare
e formare, fare scuola e fare giustizia nell’esperienza della scuola in carcere si legano e si interrogano
continuamente e reciprocamente.
In terzo luogo, la domanda di senso rivolta alle materie. La necessità di riscoprire le materie come avventure
dell’umano.
In quarto luogo, la questione dell’incontro con il dolore e la sofferenza. Gli insegnanti sono chiamati a sapere
lasciare andare il dolore.
In quinto luogo la questione della motivazione e della rimotivazione, che interessa sia i detenuti-studenti che
gli insegnanti. È una questione delicata della relazione tra adulti che si incontrano in co-educazione e co-
formazione e che devono affrontare il rapporto con male, violenza, fiducia e giudizio.
In sesto luogo, la questione del lavoro con altri, del bisogno di cooperare e sostenersi a vicenda. Ma gli
insegnanti possono partire anche dalla convinzione che la giustizia sia necessaria ma non basti. Perché non
esaurisce le responsabilità di una convivenza sociale. Resta da rendere giustizia partendo dal periodo di
esecuzione penale. Rendere giustizia a chi non è stato difeso da sé stesso. Resta da rendere giustizia a
persone che hanno giocato irresponsabilmente della loro libertà, che sono condannati in quanto responsabili
di qualcosa o per qualcosa ma che vanno accompagnati ad essere responsabili verso qualcuno, verso altri.
Bisogna riportare la giustizia nelle relazioni.
Infine, gli insegnanti possono partire da una collocazione laterale, si potrebbe forse dire da una posizione di
veglia: sulle possibilità e sulle direzioni nella quali fare reincontrare altro di sé, le capacità di conoscere e di
reinterpretare.
La sofferenza e la parola
Il tempo della pena fa i conti con un tempo perduto e distorto. Questo dà pena ma può permettere una
diversa lettura di ciò che nel tempo può essere recuperato. Si può passare da un tempo di pena chiuso e
vuoto a un tempo nel quale può valere la pena? Il percorso penale potrebbe sviluppare queste direzioni se
aprisse a condizioni diverse di prova di sé. La scuola è anche un luogo in cui la sofferenza può emergere con
16
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
più evidenza. La sofferenza non può che emergere nel gioco di verità e di domanda che si coltiva a scuola.
Qui la sofferenza non è obbligata a sfogarsi o a reprimersi, come in sezione. È importante riuscire ad
appoggiare la sofferenza nelle parole e nelle narrazioni. La parola offerta dalla scuola per gli “scartati” ha da
essere un cammino per accogliere la realtà dell’umanità che cerca la liberazione dalla oppressione. La
parola deve essere parola libera per poter aprire alla verità e alla storia personale. La mancanza di parola
avvelena. Nella vita dei detenuti quando la parola riesce a entrare svela l’essenzialità di quel che è
esperienza della vita. La parola serve per ascoltare sé e dentro di sé e apre alla possibilità di parlare con
altri. La parola viva opera fratture e cuciture. A scuola si può non fare solo l’esperienza del comunicare,
dell’insegnare e dell’apprendere. Si può non fare solo la fatica del concetto. Ci si può anche fare carico gli
uni degli altri. Servono insegnanti che abbiamo cura di sé e amino i loro allievi.
UN’ESPERIENZA DI MALATTIA E DI PENA
La malattia parla della pena
È una particolare esperienza di malattia quella che si vive in carcere. Esperienza complessa che tiene
intrecciate direzioni diverse del vivere, delle relazioni con altri e chiede di far fronte al giudizio, alla colpa e
alla pena. Questa particolare esperienza chiama ad andare con la riflessione più a fondo di quanto si può
attingere nel dibattito contro lo stigma per la tutela della dignità delle persone. La riflessione si muove
attorno alle questioni psicologiche ed esistenziali proprie dell’esperienza della malattia. Specie di quelle
malattie legate alle relazioni. Come è oggi di molte esperienze di malattia. Queste questioni non sono
“sanitarizzabili”. In carcere si incontra il doppio volto della finitezza: la vulnerabilità ontologica e il limite,
da un lato, e la fattibilità morale e la ferita, dall’altro lato. L’esperienza della malattia e della cura di uomini e
donne detenuti chiede attento ascolto della vita. L’esperienza del corpo è esperienza delicatissima. Il corpo
detenuto è stato spesso attore di offesa, di presa sull’altro. Il corpo malato, ora offeso, è di nuovo
inaffidabile. Il corpo malato è il corpo del reato. Se soffre forse lo merita, ne porta la pena. Il corpo fragile
che io sono, che ha ospitato responsabilità morale, nel quale ora si esprime la malattia quale condizione
esistenziale di vulnerabilità, è il corpo dove l’esperienza di limite e di ferita si toccano, in un riverbero. La
malattia rivela la nostra vulnerabilità e ci rivela consegnati alla cura. Ma la ricerca di significare la propria
malattia rende l’esperienza della malattia un importante passaggio per la reinterpretazione del senso e
delle relazioni. Fuori dall’autosufficienza si vive l’esposizione al vincolo, dell’aiutare e dell’essere aiutato.
Ritrovarsi con il proprio limite e la propria fragilità fisica o psichica è vedere ridisegnato il proprio rapporto
ad altri. È una forte scossa, in condizione di esecuzione penale. Si viene curati senza merito e al di là del
merito. Chi incontrano gli operatori della salute negli ambulatori, nelle infermerie del carcere? Incontrano
uomini e donne del reato e della pena. Altre volte sono uomini e donne presi dal lavorio della colpa.
L’esperienza di malattia si intreccia a questi vissuti, diviene evidenza di ingiustizia o percorso di espiazione
del male. Essere figure terze non vuol dire essere figure di consolazione o di comoda complicità. Invitare a
una seria ed esigente cura di sé vuol dire chiedere molto. Chiede un nuovo rapporto di sé a sé, fatto di
accettazione dei limiti. Sentire sé più a fondo può fare emergere un sentire l’altro. La cura della salute non
può essere disgiunta dalla pratica di scelte. Nell’esperienza di malattia in carcere le persone muovono e
17
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
chiedono e affidano all’altro la propria figura ferita. L’esperienza del dolore non è risarcimento per le
conseguenze del reato, non pareggia il conto. Può indirizzare a nuove attenzioni e consapevolezze. Ci sono
una malattia e un disagio ben visibili in carcere. Ma ci sono anche una malattia e una sofferenza celati e
nascosti. Gli operatori della cura devono vegliare sulla propria intenzionalità che in questo contesto è
esperienza di una coscienza che dà senso al reale. Al paziente si chiede sempre di attivare risorse morali ed
esistenziali per vivere la malattia, non si suggeriscono solo pratiche.
Un conflitto tra prospettive
In carcere si incontra una umanità che fuori non si vede facilmente. Segnata da pesanti svantaggi e
incapacità di relazioni. Questo conduce gli educatori ad assumere una sorta di fiducia vulnerabile e una
capacità di agire con continuità e lucidità senza la certezza del risultato. La domanda di cura delle persone
detenute fatica a prendere forma. Quando riesce non incontra il loro riconoscimento come soggetti di
domanda, mentre altre volte trova risposte che non considerano i pazienti detenuti come soggetti cui
rivolgere domande impegnative. Non è scontato farsi curare, non è facile né immediato aver cura di sé. È
ancor meno scontato vivere modalità di relazione aperta in carcere. Vivere il limite avendo vissuto la ferita
e l’offesa, la frattura, colora diversamente la sofferenza. Pena e sofferenza si mescolano. La sofferenza
subita può celare il senso di colpa. Risulta difficile tenere distinti la finitezza che si vive originata dalla
malattia e dalla fragilità esistenziale e i momenti della coscienza morale.
L’esperienza del paziente in carcere è segnata da una doppia solitudine: la prima è di ordine personale, la
seconda è legata alla cultura medicalizzante che può lasciare la sofferenza in spazi anonimi. Accompagnare
nella cura è sapere che si fa un po’ male: e non solo perché le terapie possono essere dolorose ma perché
sempre si apre un gioco di verità, di sincerità verso le relazioni delle persone.
Il contesto penale può ospitare percorsi nei quali le persone assumono il compito della cultura di sé e del
proprio cambiamento. Accettare un percorso terapeutico è sentirne una vicinanza. In carcere, da malato,
incontro la società che mi punisce e la società che mi cura. La prima mi chiede capacità di adattamento al
regime di detenzione, la seconda chiede che mi attivi nella partecipazione alla cura di me stesso. Su entrambi
i fronti incontro la sofferenza e il bisogno di contenerla. Sulla scena della cura ci si aiuta a posizionarsi negli
eventi della vita, nei cambiamenti di prospettiva. Non è semplice lavorare in presenza di una comunicazione
non chiara con i pazienti detenuti. Il ripararsi dietro atteggiamenti difensivi condiziona la relazione. Da
evitare è il rimbalzo continuo tra un approccio contrattualista e un approccio paternalistico: in entrambi i casi
si va perdendo il senso profondo dell’alleanza terapeutica che è attenzione e non compiacenza, è competenza
e accompagnamento. Ciò che prevale in carcere è un paradigma utilitarista, e l’assunzione di un’ottica
premiale-punitiva.
Il rapporto intersoggettivo, che si era paralizzato nel legame strumentale e nelle conseguenze della sofferenza
arrecata, ora viene ritrovato e riscoperto come luogo di attenzione e di cura, di prossimità fiduciosa.
Ristabilire l’equilibrio originario della relazione è la via da aprire per vivere e sostenere la malattia. Ma
proprio questo, in carcere, in molti casi destabilizza la relazione costruita dell’io con sé stesso.
18
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
La relazione, tra operatori di aree diverse, non è sempre agevole. La questione della comunicazione delle
informazioni rappresenta un punto critico. La postura dell’operatore deve essere responsiva nei confronti di
chi incontra e delle condizioni nella quali lavora e incontra.
La relazione con il futuro e con l’altro
Riconquistare pratiche di libertà dal carcere non si rivela facile. Occorre che chi cura si ponga oltre
l’orizzonte dei diritti sostenendo percorsi di riconoscimento. Uomini e donne della colpa e della pena
possono non avere mai sperimentato pienamente l’autonomia relazionale. Per ritrovare queste dimensioni
occorre attraversare una zona grigia. Osare un tempo a venire e un cambiamento personale. La malattia è
un tempo per volere. Tempo in cui è necessario scegliere. Nel quale ricomprendere sé stessi come persone
vulnerabili. Ma il tempo di malattia può essere incontrato anche come esperienza di affidamento.
L’esperienza di malattia va tessuta, costruita come relazione con il futuro e con l’altro. Anche l’emergenza
legata ai comportamenti autolesionistici, o alla necessità di un TSO, chiede attenzioni reciproche tra
operatori e persone detenute. Non basta il necessario impegno nell’educazione alla salute sviluppato in
diversi istituti. Occorre un impegno continuo per promuovere e sostenere la presenza responsabile delle
persone detenute. Le logiche organizzative e di controllo oggi prevalenti in carcere spingono alla passività.
Riportare dentro un paradigma relazionale la cura e la costruzione dell’esperienza di malattia è possibile.
Divengono preziose le figure di integrazione. Il confine tradizionale tra salute e malattia in carcere sfuma e
quasi resta in dissolvenza: per la forza della diagnosi certo, ma anche per la scoperta di una vulnerabilità
profonda che ci è propria. Questa esperienza a volte è brusca scoperta di una condizione di esposizione a
qualcosa di silenzioso che invade e contamina. Ci si scopre malati e presenti ad altri. È una conoscenza della
malattia, la propria, che va condivisa. C’è, a volte, una certa fatica a leggere le proprie condizioni di
debolezza. Ci sono molte storie di detenuti resi vulnerabili e fragili che mostrano come non sia spontaneo
né scontato entrare in un nuovo gioco di fiducia con le figure dell’assistenza e della cura. Costruire nuove
trame di fiducia è un sottile e delicato gioco che si sviluppa nella possibilità di costruire insieme una storia
prospettica di cura, per il tempo prossimo futuro. La stagione della malattia detenuta apre a una nuova
pagina di vita che chiede una necessaria ricapitolazione. Obbliga a narrazioni delle relazioni. La malattia
porta lontano ma crea anche uno spazio di risonanza e fraternità, di incontro della comune umanità. Vivere
fuori dal potere, vivere e desiderare indebolendo e diminuendo, vivendone la libertà e riscoprendo il valore
simbolico dei gesti e delle scelte quotidiane. È ciò a cui ci spinge la malattia. Quasi impossibile in carcere.
Portare responsabilmente la propria malattia nel tempo, nella biografia personale e nella rete vitale è
provare il rapporto con una rinascita. Ma il carcere non è propriamente un campo di facile coltivazione.
Portare responsabilmente la malattia è possibile in un quadro di relazioni che non facciano spazio a
vittimizzazioni. Scoperta una malattia, occorre cercare la vita di nuovo. Soprattutto in ambienti di
costrizione si può non reggere l’esposizione a sé. Il potere di far perdurare il nascondimento della malattia
può far reggere un “quasi oblio” che permette di vivere irresponsabili continuità negli stili di vita. Mentre si
lavora la malattia e mentre la vita ci lavora, mentre la malattia lavora nei giorni, spesso ci si trova là dove
non ci si aspettava di trovarsi. In un incontro con sé stessi e con altri, con la possibilità di trascendere e di
19
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
iniziare. Le fragilità vissute possono portare le persone a una riorganizzazione del sistema di vita, a
riconfigurare in qualche modo la vita quotidiana. Ma è pur vero che dentro il carcere e fuori di esso, si
assiste a una deriva verso un progressivo impoverimento del senso, del desiderio e della capacità di aver
cura di sé. Lì, dove le persone fragilissime rischiano l’annullamento di ogni possibilità narrativa, proprio lì si
possono tessere trame di veglia e ricerche concrete che possono portare a dire “credo di potere, posso
provare a potere”.
Forse solo nella passività del corpo che non regge, dell’umano che tocca il suo finire, è
possibile re-imparare le parole e il silenzio, la veglia e l’attesa.
PARTE TERZA – RIGENERARE LEGAMI
DONNE CON PROLE
Maternità e reato
Come è possibile vivere insieme l’esperienza della pena e quella della maternità? Maternità e pena sono
due esperienze che inseriscono una forte discontinuità in una biografia. Sono esperienze che chiedono
capacità di ricapitolazione. Certamente i vincoli pesano e sono vincoli chiari quelli dell’esecuzione penale in
atto. Tutto ciò è complesso e difficile, certamente: c’è il peso del reato e delle sue conseguenze, spesso ci
sono altri figli e legami faticosi con i mariti e i compagni, spesso le madri detenute possono contare su
scarse risorse personali. Dopo il reato non si appartiene più come prima ai propri contesti di relazione, alle
proprie famiglie. Rese madri dalla nascita di figli e figlie non si appartiene più solo a sé stesse, si appartiene
anche a loro. Le libertà sono sospese e da ridisegnare. Non è facile reggere la fatica del confronto con le
proprie condizioni. Forse ciò può divenire possibile se si costruisce con altri una pratia di futuro possibile.
Entrare nei progetti offerti alle donne con prole chiede una scelta. L’allontanamento dai contesti sociali e
familiari di provenienza sono faticosi, i mariti a volte condizionano pesantemente, ci sono donne che devono
chiedere il permesso. Scegliere per alcune è provare a vedere se c’è altro nel proprio destino. La presenza
dei bambini può rinforzare anche i percorsi del disimpegno morale ma può anche condurre su sentieri della
rimessa in gioco. Sarà possibile, a una madre non innocente, di scegliere, le sarà possibile avviarsi ad essere
capace di prendere una certa distanza rispetto alle sue origini. La normativa pone al centro la tutela e la
promozione dell’infanzia dei figli. È grazie a loro e per loro che alle donne viene proposta una esecuzione
penale esterna agli istituti di pena. All’origine dei progetti vi è l’attenzione allo sviluppo del minore. Nel
periodo della pena la speranza è che la relazione con figli piccoli possa aiutare la madre autrice di reato a
lavorare su sé stessa. In alcuni casi l’assunzione della maternità è difficile. L’esperienza nelle comunità non
rappresenta solo un’opportunità utile e di alleggerimento della pena, ma assume i tratti dell’impegno verso
i figli. L’obbiettivo della tutela e della promozione della crescita di bambini e delle bambine viene
interpretato in modo diverso da alcune madri e dagli operatori delle comunità. Creando anche tensioni e
passaggi difficili. La maturazione di capacità di cura dei figli, si presenta come obbiettivo da assumere nel
corso del tempo per le madri autrici di reato. Si cerca di lavorare in due direzioni: si esercitano attenzioni
conoscenze a abilità di base circa l’alimentazione l’igiene; si richiama poi l’attenzione sugli atteggiamenti
inadeguati. L’orientamento che gli operatori devono dare al loro intervento è quello di proporre attenzioni
20
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
e percorsi compatibili con le realtà di vita dove si tornerà a fine pena oppure attraversare stili e
comportamenti decisamente alternativi e differenti? Occorre pensare di avviare occasioni di coprogettazione,
di confronto e di monitoraggio delle diverse esperienze e dei tragitti delle persone coinvolte.
È importante la condivisione di obbiettivi, di strumenti di verifica. Permette dia valorizzazioni che
ripensamenti e correzioni di rotta. Un certo numero di donne con prole vive in solitudine o con problemi di
integrazione sociale e questo si aggiunge alle fatiche nell’acquisizione di competenze genitoriali. Tutte sono
obbligate alla condizione di ripensare all’origine propria, ai propri valori. La diaspora è condizione che porta
sul limitare tra dispersione e ritrovamento e avvio di un cammino nuovo nel quale rideclinare le origini e i
lasciti ricevuti. La diaspora è esperienza di separazione, eppure, è anche esperienza di nuove compagnie, di
legame con i propri e gli altri.
La forza della vita quotidiana
La forza della vita quotidiana con i bambini sostiene un tempo dove si inseriscono evoluzioni. Muove in
direzioni diverse rispetto all’esperienza di destinazione. La scoperta di possibilità genitoriali, pur in una
storia personale segnata dal reato, si può dare se si offre l’incontro e la scoperta di contesti di vita e di
relazioni sociali. Il fatto di essere accolte può portare a un ripensamento e un riorientamento circa le
responsabilità educative verso i figli. La trama di vita e di legami in cui le madri sono coinvolte può
provocare qualche distanza critica rispetto alle scelte e alle relazioni fino ad allora sperimentate. Relazioni
non di rado portatrici di distorsioni. Il tempo quotidiano accoglie un lavoro su di sé silenzioso e lento: lavoro
sui propri limiti e fragilità. La cura dei figli e della relazione con i figli si dà in una trama di cura e di racconti
e diviene attenzione a sé. La comunità, la casa-famiglia, a un tempo collegano e distanziano. La comunità è
protezione e prova. È la concreta densità della vita quotidiana che può aiutare progressivamente le madri a
disporsi e farsi accompagnare in un contesto di reciprocità. La possibilità di godere di spazi di autonomia
pur con cadenze della comunità e insieme ai supporti di operatori. Le relazioni con altre madri, con altre
donne operatrici e madri, può contenere il timore di essere giudicate come inadeguate e colpevoli anche
della sofferenza dei figli. Permette di giocare ancora coni figli, con altre madri e altri figli, e di sollecitarli,
correggerli e osservarli. Anche le problematicità psicologiche o psichiatriche si configurano meglio e con più
chiarezza in questo clima relazionale. Trasformare un’esecuzione penale in un progetto condiviso non è un
processo semplice. È un processo che va cercato con la necessaria competenza, costruendo le condizioni
per un impatto favorevole. È un passaggio culturale ed esistenziale: dal saldare un debito con la società per
un comportamento illegale all’assumere un debito verso le persone offese, verso i figli piccoli da
accompagnare nella vita. Si tratta di veri e propri esercizi di libertà condotti per un periodo di tempo
conosciuto in una zona di limitazioni che è, allo stesso tempo, una zona franca, di passaggio. Nella zona
franca c’è sostegno alla genitorialità, costruzione di rapporti collaborativi e un lavoro culturale e psicologico
sulle rappresentazioni di maternità e infanzia. La qualità degli incontri accompagna il primo crescere delle
figlie e figli. Si può disegnare una nuova prospettiva per la libertà personale. In molte esperienze di madri
autrici di reato si sono dati momenti di verità, difficili e preziosi passaggi critici. Passaggi nei quali si
ripresenta la tentazione delle maschere, del riparo nelle conferme e nelle giustificazioni. La formazione, il
21
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
coinvolgimento in pratiche di servizio e di volontariato non rappresentano esperienze facili, di cui le donne
coinvolte colgono subito il valore. Quella che si può incontrare è anche una convivenza che si fa attenta e
solidale, che si fa riparativa quando i conflitti e le separazioni si aprono. Nei tratti di esclusione penale
esterna è come se la convivenza ti venisse a cercare. La convivenza offre un tempo nella quale provare a
ricollocarsi in una nuova verità e in riscatto e riparazione nei confronti del passato. Le gravidanze in
condizioni di esecuzione penale possono aprire a storie nuove. Corsi per mamme, assistenza medica. Il
lavoro su di sé p un obbiettivo da conquistare non un prerequisito. Mentre per le madri occorre curare una
esperienza di prova e di contenimento, per i bambini occorre garantire il più possibile una vita quotidiana,
una partecipazione agli spazi e alle relazioni normali, proprie delle infanzie del territorio.
Tessiture resistenti e fragili
Gli operatori sono concentrati sui minori da tutelare. Occorre una buona contaminazione tra attenzioni
specialistiche e attenzioni concrete a organizzare la vita della casa, le cose e i tempi feriali. Occorre
accompagnare già dal carcere a costruire una domanda di aiuto, a definire le prime linee di un patto con le
persone. In carcere la vita e prevalentemente irretita di vincoli e dipendenze che continuamente si
ripropongono. I problemi delle persone detenute sono colti prevalentemente per approcci specialistici. In
comunità e nelle case-famiglia, invece, si prova una presa in carico della globalità e complessità dell’essere
persone. L’esperienza in comunità ha caratteri di eccezionalità. Tutto questo chiede competenze educative
tanto quanto l’apertura verso movimenti riflessivi. Le madri fanno continuamente i conti con i vissuti
profondi. A volte anche con forme di ricatto e assoggettamento. Risulta molto importante il primo periodo
di accoglienza e osservazione reciproca tra le madri accolte, gli operatori di sorveglianza, la magistratura e
gli altri ospiti. In moltissimi percorsi l’obbiettivo è quello di rendere le madri protagoniste della loro
domanda di cambiamento. Le comunità e le case-famiglia sono realtà che nelle loro esperienze di
convivenza contengono le spinte distruttive e le fragilità personali e allo stesso tempo accolgono le persone
che ne sono portatrici. Rileggono vissuti e incontri passati, osservano e promuovono relazioni nuove e
sviluppi inediti, prestano attenzione al singolo caso, alla coppia mamma-bambino. Tre sono i punti di
criticità e di attenzione: il passaggio dal carcere alla comunità, il rapporto con i servizi e le istituzioni del
territorio e il rapporto con la magistratura di sorveglianza. Il rapporto con la rete di servizi territoriali è
importante e complesso. La condivisione con i magistrati è molto importante e chiede di promuovere una
conoscenza reciproca e diretta tra comunità e magistrati. I percorsi e le transizioni vissute in esecuzione
penale esterna con i propri figli aprono ad altre prospettive, a conoscenze nuove. In molte donne la
riflessione sul reato è difficile. Non è raro che la condizione di debolezza non permetta di leggersi
responsabili dei propri gesti. L’interesse del minore è che la mamma non torni a comportamenti illegali.
L’elaborazione del reato si presenta molto difficile se manca la visualizzazione dei danni arrecati. Ma si
possono incontrare anche forti vissuti persecutori che rendono difficile un confronto con il reato. Il reato
attiva nelle donne con figli una reattività emotiva. Alcune iniziano un ripensamento del reato, si rendono
contro e cercano riscatto.
22
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
INCONTRI SULLA SOGLIA
Presenze e gesti volontari
Molte delle figure che si incontrano durante l’esecuzione penale si dedicano per ruolo ad applicare le
prescrizioni della giustizia penale. Alcune delle figure che accompagnano i percorsi della pena, invece,
agiscono e invitano ad agire per fare giustizia, per rifare relazioni. Sono in moltissimo casi dei volontari che
erano in carcere e realizzano dialoghi e sostegni. A volte agiscono in indirizzo e a supporto di
riconciliazione.
L’orizzonte su cui si va a collocare la riflessione e la pratica del volontariato penitenziario organizzato si può
tratteggiare attorno a due caratteri.
Anzitutto c’è la considerazione delle persone detenute incontrate come soggetti responsabili. In secondo
luogo, tra i volontari di gran parte delle associazioni è maturata la assunzione di una funzione non solo di
supporto e sostegno alle condizioni di restrizione ma anche di accompagnamento all’acquisizione di
possibilità di reincontrare sé.
Sono volontari di generazioni diverse e con storie complesse. Sono donne e uomini non innocenti che
cercano di tenere e ritessere relazioni giuste.
Sono molto sensibili al tema della fatica della libertà. Le diverse attività delle diverse figure di volontari
vanno assumendo i caratteri di pratiche di libertà. È una caratterizzazione dell’impegno volontario il
rispetto dei diritti delle persone detenute e anche quello dei diritti delle vittime. Vogliono superare un
modo di occuparsi di carcere sono “contro”: pregiudizi, violenze. Ci si vuole dedicare anche a promuovere
una dinamica originata dal riconoscimento e dalla dignità. I volontari provano a tenere intenzione e
relazione e a costruire un tempo a venire. Questi volontari ricordano un “utile” che è anzitutto nella
presenza, nell’offerta reciproca. I volontari si vanno disegnando come figure terze. Sono presenti per
promuovere, aprire e tenere aperti percorsi evolutivi di speranza. Alcune associazioni di volontari invitano a
manifestare bisogni e necessità al di là di quanto intercettabile dai funzionamenti giuridici e organizzativi
del sistema penale. Un primo confine, una prima soglia tra giustizia e misericordia si definisce tra ciò che
effettivamente si è determinato con il reato nelle storie personali e che non va negato e omesso e le
dimensioni del riscatto possibile. L’impegno dei volontari è quello di offrire tempo. Un altro confine per
quei volontari che un po’ assumono i tratti dei “passatori” si traccia tra le logiche e le pratiche della
sorveglianza. Una logica fuori dai calcoli e della punizione. Una terza soglia si cui si configura la presenza di
volontari è quella tra la verità giudiziaria centrata sull’evento reato e l’ascolto, l’assunzione della realtà del
vissuto, della verità delle vittime. Aprendo una ricerca sulle effettive possibilità di ricostruzione di relazioni.
Il quarto limitare dell’azione di molti volontari collega gli istituti di pena con la convivenza, riporta l’offesa e
il reato dentro le realtà in cui maturano, o non riescono ad essere contrastati. In carcere, nelle comunità e
nelle realtà della messa alla prova, si concentrano pesanti svantaggi, sofferenze non elaborate. Questo
incontro chiede un lavoro delicato di ricomposizione. L’esecuzione penale riscoperta come cammino per
maturare un nuovo incontro con la verità si colora di un senso e una finalità più piena.
23
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
Certamente perché possa caratterizzarsi così serve un cambiamento culturale, cui dedicarsi con
determinazione.
In primo luogo, l’esperienza aperta da volontari può aprire e trasformare. In secondo luogo, in questa
iniziativa si può fare esperienza. Incontrare uomini e donne che scelgono volontariamente la prossimità da
parte di uomini e donne nella pena è incontrare l’affermazione di una comune umanità. Certamente ognuno
diventa quel che sceglie, ma non vi resta fissato per forza e per sempre: nelle esperienze si viene chiamati o
condotti ad altro, ci si può ritrovare in altro, grazie ad altri. La pena può essere riconquistata come un diritto.
Ci sono uomini che hanno tradito la fiducia, che hanno offeso, eppure c’è chi vuole incontrarli: e quegli
uomini si trovano ad essere ancora attesi. Chiede di ascoltare il dolore dell’altro, i valori violati. Ci si può
tornare a legare, a fidarsi anche da non innocenti.
Mediazione, memoria, riparazione
Recentemente si è sviluppata, da parte di volontari, un’esperienza tesa a proporre e verificare la possibilità
di avviare percorsi di restorative justice e di riconciliazione tra autori di reato e vittime.
Si propone di cercare insieme la giustizia già durante il percorso della pena. Per provare a lavorare sul dolore
provocato e subito, provando a rompere meccanismi del rancore e della tenuta a distanza. È un lavoro
volontario tra dentro e fuori per cercare condizioni per la maturazione di un incontro. Non bisogna essere
ambigui o finti, occorre raccontare le storie da adulti. E non si racconta per spiegare le scelte e i gesti ma si
racconta per tornare a guardare, rischiando di sentirsi altri, anche se fa male. Va maturato il bisogno
dell’incontro con ciò che manca.
È un incontro difficile, forse di rigenerazione di possibilità e legami.
È importante riconoscere quel negativo nelle sue parti, vederne altre parti separate da quelle. È possibile un
altro passaggio nel quale ridare destinazione all’irreparabile, si può riconoscere e rivedere, riconoscersi e
assumere impegni di futuro. Ora il destino è riparare e rigenerare. È un’esperienza di verità, per dare
direzione diversa agli effetti dell’offesa, della violenza. Restare separati può continuare a originare violenza
a distanza, occorre apprendere a camminare verso l’altro.
Gruppi per riparare legami
Negli ultimi decenni si sono moltiplicate le iniziative di incontro tra detenuti e cittadini provenienti da
diversi percorsi ed esperienze sociali.
Hanno preso vita percorsi condivisi tra persone detenute e persone
libere. Anche i luoghi della formazione e dell’università sono spesso coinvolti o si fanno promotori di
esperienze.
Una di queste esperienze ha avuto sviluppo in Lombardia negli ultimi 15 anni ed ha seguito una
strategia particolare: la proposta di gruppi di incontro formati da persone detenute e giovani uomini e
donne dei corsi universitari.
La prospettiva nella quale si è collocato questo lavoro è quella di una giustizia
non solo riabilitativa ma anche riparativa e riconciliativa. Verso un’assunzione delle conseguenze dei propri
gesti da parte degli autori del reato. Orizzonte d’una giustizia delle relazioni tesa a mettere a fuoco percorsi
24
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
sui quali ricostruire il legame di convivenza leso e avviarsi verso percorsi riparativi e riconciliativi con le
vittime. I gruppi di incontro hanno segnato percorsi nei quali si è proposto di entrare in circuiti comunicativi
ed esperienziali esigenti e definiti. In essi si sono costruite scene e proposti incontri nei quali i vissuti dei
partecipanti risuonassero gli uni negli altri. Hanno così preso forma sequenze di incontri tra coetanei,
giovani figli e adulti padri, giovani adulti e adolescenti. La condizione degli studenti comportava di proporre
domande che chiedevano di ampliare il respiro del ricordare. È stato come consegnare una zona franca, un
luogo nel quale esporsi ed essere protetti. È complesso passaggio quello che conduce a diventare testimoni
di sé stessi, del proprio cambiamento. Si entra nelle storie e nelle vite gli uni degli altri, ma fino ad un certo
punto e sotto il segno dell’ospitalità e dell’attenzione. Si possono tratteggiare alcuni caratteri di
un’esperienza che ha preso e sta prendendo la forma di una soglia, di un’esperienza di passaggio molto
significativa per i tragitti personali segnati dalla colpa. Sono tre i tratti molto curati in questi percorsi sul
limitare per aiutare l’incontro e anche per fare appoggiare le differenze. Il primo è la loro caratterizzazione
come zone franche di pausa e di sosta, fuori dai contesti relazionali abituali del carcere nei quali si vive
sotto pressione. Nelle zone franche del rispetto non bisogna per forza dimostrare qualcosa o affermare e
difendere ragioni. Il secondo tratto è quello della salvaguardia di zone della parola nelle quali si possano
vivere le esperienze discorsive e le conversazioni inedite che vengono proposte.
Per aprire i gruppi all’esperienza dell’incontro si è messa al centro una particolare esperienza della parola e
della sua cura. Le parole usate possono agire su di noi; se non dette in uno spazio comune agiscono su chi le
dice e chi le ascolta.
Parole e pensiero si legano: per trovare le parole dell’incontro occorre che nei gruppi cresca l’esperienza di
un pensare aperto che sente e si avvicina alla realtà. Il terzo tratto dei percorsi dei gruppi è stato il
prefigurarli come momenti impegnativi ma di passaggio, di transizione. Il carattere dei gruppi ha
aperto dinamiche particolari. Il gruppo e l’incontro sono considerati preziosi strumenti di esperienza
trasformativa personale e interpersonale. Poiché consentono una intenzione diretta. Nei gruppi si trova una
nuova forma di relazione non violenta. Ritrovare la libertà di dire e l’apertura al confronto aiuta il percorso
di conoscenza e fa avvicinare o toccare zone di difficoltà e sofferenza che normalmente non vengono
indagate. Il gruppo nelle sue fasi si presenta come garanzia di equilibri relazionali. Uno stereotipo corrente
presenta il gruppo come una realtà che garantirebbe di per sé una produzione più efficace dei risultati. Lo è
a volte, a condizione che vi sia passione per un progetto condiviso. In gruppo tutti sono responsabili. Nei
gruppi non si danno contributi senza che questo abbia riverbero sul pensare e sulla vita. Il rapporto con la
verità è importante. Nel gruppo si permette silenzio ma si chiede verità.
Nel gruppo si curano tre dimensioni: quella della disposizione, della decisione e della differenza. Tracciate
insieme percorsi implica anzitutto disposizione cioè apertura. È una dimensione esistenziale, non
intellettuale. La disposizione si dà come disponibilità ad ascoltare.
La seconda dimensione è quella della decisione. Scegliere è sempre scegliere una relazione, scegliere
qualcuno o per qualcuno. Scegliere è definire un patto. Per essere portatori di una differenza, di una
specificità, ci vuole fierezza e umiltà. Ci vuole la forza di essere differenti.
25
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
lOMoARcPSD|11436358
La differenza chiede relazione.
Nei gruppi si svolge un’esperienza di potere, di esercizio del potere: nel gioco di responsabilità, di presa di
parola. La possibilità di essere diversi e che si possa cambiare restano aperte. Il gruppo è anche luogo nel
quale la sofferenza può emergere ma non è obbligata a sfogarsi.
Occorre ridare voce ai silenzi delle persone e decostruire le ambiguità. Si può provare assicurando zone di
riguardo e di rispetto, offrendo luoghi dialogali aperti. Nei gruppi un tratto comune è stato quello della
scoperta del bisogno di incontrare la verità di storie buone, di narrazioni umane che parlino di noi. Non
tutte le storie sono buone, ci sono narrazioni che distruggono e fanno male. Ma negli scambi di gruppi
hanno vita breve. Nei gruppi è come se la convivenza ponesse un luogo sociale.
Il carcere li ospita come un avamporto di una comunità riparativa. In genere i gruppi ospitano alcune persone
in crescita. Giovani uomini e donne vanno iniziando responsabilità e scelte adulte, uomini e donne che dopo
la pena e l’offesa non potranno che vivere inizi e riprese. Pur se il movimento iniziale dell’incontro poteva
essere solo quello di trovare appoggi, poi nel tempo il legame ha attinto a una diversa qualità d’esperienza.
26
Downloaded by CLAUDIA AMBROSONI (c.ambrosoni1@studenti.unibg.it)
Potrebbero piacerti anche
- Riassunto La Pedagogia Degli OppressiDocumento19 pagineRiassunto La Pedagogia Degli OppressiHorace Basile100% (2)
- L'educazione Nell'ombra - RiassuntoDocumento29 pagineL'educazione Nell'ombra - Riassuntodangerousstar100% (1)
- #Estratti Dalla Comunità TerribileDocumento3 pagine#Estratti Dalla Comunità TerribileFrancesco TabarriniNessuna valutazione finora
- Zygmunt Bauman, Paura LiquidaDocumento5 pagineZygmunt Bauman, Paura LiquidaAlice Biscotto LenziNessuna valutazione finora
- Di Generazione in GenerazioneDocumento7 pagineDi Generazione in GenerazioneFrancesca PeroniNessuna valutazione finora
- L'uomo Moderno Ha Le Stesse Incertezze Dell'uomo Del Primo Novecento?Documento2 pagineL'uomo Moderno Ha Le Stesse Incertezze Dell'uomo Del Primo Novecento?Diego Deplano100% (1)
- Riflessione Sul Film L'Onda'Documento3 pagineRiflessione Sul Film L'Onda'Annalucia ViscoloNessuna valutazione finora
- L'educazione Nell'ombra - Ivo Lizzola: Cap 1 - Una Cura Educativa Senza DimoraDocumento8 pagineL'educazione Nell'ombra - Ivo Lizzola: Cap 1 - Una Cura Educativa Senza DimoraCLAUDIA AMBROSONINessuna valutazione finora
- FUSARO Soggettività e Mondo Reale...Documento7 pagineFUSARO Soggettività e Mondo Reale...MargaraGodinNessuna valutazione finora
- Con l'altro e per l'altro: Una filosofia del dono e della condivisioneDa EverandCon l'altro e per l'altro: Una filosofia del dono e della condivisioneNessuna valutazione finora
- Carcere: luci e ombre: Le forme della mediazioneDa EverandCarcere: luci e ombre: Le forme della mediazioneNessuna valutazione finora
- Aver Cura Della Vita Riassunto Del Libro Per Lesame Di PedagogiaDocumento11 pagineAver Cura Della Vita Riassunto Del Libro Per Lesame Di PedagogiaCLAUDIA AMBROSONINessuna valutazione finora
- APPARTENERSI (Riassunto)Documento31 pagineAPPARTENERSI (Riassunto)edoardo tostiNessuna valutazione finora
- Monadologia Della SolitudineDocumento4 pagineMonadologia Della SolitudinePino AlessandriNessuna valutazione finora
- Fuori Dal SilenzioDocumento24 pagineFuori Dal SilenzioEmma13Nessuna valutazione finora
- Libro Riassunto BreveDocumento4 pagineLibro Riassunto Brevenqyaya3euehNessuna valutazione finora
- Il Loro Sguardo Buca Le Nostre OmbreDocumento5 pagineIl Loro Sguardo Buca Le Nostre OmbreAlly MoserNessuna valutazione finora
- Sognare la Terra - Il troll nell'AntropoceneDa EverandSognare la Terra - Il troll nell'AntropoceneNessuna valutazione finora
- La Blancheur o Il Desiderio Di Farsi Da Parte. Intervista A David Le BretonDocumento12 pagineLa Blancheur o Il Desiderio Di Farsi Da Parte. Intervista A David Le BretonAntonello ColimbertiNessuna valutazione finora
- Il Carattere Necessario e Riduttivo Delle Identità. Un'Intervista A Franco CrespiDocumento8 pagineIl Carattere Necessario e Riduttivo Delle Identità. Un'Intervista A Franco CrespiGiovanni FileroNessuna valutazione finora
- La civiltà della paura: Breve trattato su uomo e societàDa EverandLa civiltà della paura: Breve trattato su uomo e societàNessuna valutazione finora
- Appello Del Comitato InvisibileDocumento52 pagineAppello Del Comitato InvisibiledoguibatNessuna valutazione finora
- Riassunto Pedagogia Socio-CulturaleDocumento16 pagineRiassunto Pedagogia Socio-CulturaleNicoleNessuna valutazione finora
- GiornataMemoria Il-Messaggio-Di-Liliana-SegreDocumento2 pagineGiornataMemoria Il-Messaggio-Di-Liliana-SegreFlaminia BonfiglioNessuna valutazione finora
- In altre parole: Dizionario minimo di diversitàDa EverandIn altre parole: Dizionario minimo di diversitàNessuna valutazione finora
- Modernita Liquida BaumanDocumento12 pagineModernita Liquida BaumanjaNessuna valutazione finora
- Psicologia Dell'Invecchiamento: Corso Aging PsychologyDocumento119 paginePsicologia Dell'Invecchiamento: Corso Aging PsychologyAlberto BoniventoNessuna valutazione finora
- I Soggetti NarraliDocumento1 paginaI Soggetti NarraliMarco DiBNessuna valutazione finora
- Fratelli Migranti Contro Le BarbarieDocumento6 pagineFratelli Migranti Contro Le BarbarieMATTEO GUIDO VISCARDINessuna valutazione finora
- WrightMills Cap1Documento12 pagineWrightMills Cap1Gianpiero VincenzoNessuna valutazione finora
- Vivere InsiemeDocumento19 pagineVivere Insiememartina.novaselichNessuna valutazione finora
- I giovani e la crisi del covid-19: Prove di ascolto direttoDa EverandI giovani e la crisi del covid-19: Prove di ascolto direttoNessuna valutazione finora
- Parrello SCENE DAL-FUTURODocumento8 pagineParrello SCENE DAL-FUTUROSalvatore CascellaNessuna valutazione finora
- Alle radici della disuguaglianza: Manuale di pari opportunitàDa EverandAlle radici della disuguaglianza: Manuale di pari opportunitàNessuna valutazione finora
- Laltro RiassuntoDocumento5 pagineLaltro RiassuntoVinci LisaiNessuna valutazione finora
- Violenza sulle donne: 7 storie incisive per riflettere e trovare soluzioni pratiche con l'aiuto di psicologi e psicoterapeutiDa EverandViolenza sulle donne: 7 storie incisive per riflettere e trovare soluzioni pratiche con l'aiuto di psicologi e psicoterapeutiValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (7)
- Tristezza: Dalla rassegnazione alla creatività fragileDa EverandTristezza: Dalla rassegnazione alla creatività fragileNessuna valutazione finora
- Un cubano alla ricerca della sua identità - II edizioneDa EverandUn cubano alla ricerca della sua identità - II edizioneNessuna valutazione finora
- La ConsegnaDocumento29 pagineLa ConsegnaSilvia SolazzoNessuna valutazione finora
- La potente voce della Dea: Cinque dialoghi teatrali sul femminile integratoDa EverandLa potente voce della Dea: Cinque dialoghi teatrali sul femminile integratoNessuna valutazione finora
- Luatti - Ed - Citt.interculturaleDocumento7 pagineLuatti - Ed - Citt.interculturaleGa_VNessuna valutazione finora
- Arti Marziali e ViolenzaDocumento3 pagineArti Marziali e ViolenzakyrieNessuna valutazione finora
- Lossessione Identitaria RemottiDocumento12 pagineLossessione Identitaria RemottiPaolo SeriNessuna valutazione finora
- Reflexiones Fratelli TuttiDocumento46 pagineReflexiones Fratelli TuttiCatequesis Diocesana TacnaNessuna valutazione finora
- CanevaDocumento13 pagineCanevaaliceNessuna valutazione finora
- Gestazione per altri: Pensieri che aiutano a trovare il proprio pensieroDa EverandGestazione per altri: Pensieri che aiutano a trovare il proprio pensieroMorena PiccoliNessuna valutazione finora
- 06 La Vita Nelle Nostre Mani Padre Maurizio FaggioniDocumento19 pagine06 La Vita Nelle Nostre Mani Padre Maurizio FaggioniFrancisNessuna valutazione finora
- Corpo e Potere nell’ideologia ’ndranghetista Un’analisi pedagogica. II EdizioneDa EverandCorpo e Potere nell’ideologia ’ndranghetista Un’analisi pedagogica. II EdizioneNessuna valutazione finora
- Gli Inizi Dell'industrializzazioneDocumento6 pagineGli Inizi Dell'industrializzazioneCLAUDIA AMBROSONINessuna valutazione finora
- Aver Cura Della Vita Riassunto Del Libro Per Lesame Di PedagogiaDocumento11 pagineAver Cura Della Vita Riassunto Del Libro Per Lesame Di PedagogiaCLAUDIA AMBROSONINessuna valutazione finora
- U33Documento9 pagineU33CLAUDIA AMBROSONINessuna valutazione finora
- Seconda Prova Intermedia - Antropologia Culturale 2A2Documento1 paginaSeconda Prova Intermedia - Antropologia Culturale 2A2CLAUDIA AMBROSONINessuna valutazione finora
- Letteratura Giapponese IIDocumento66 pagineLetteratura Giapponese IICLAUDIA AMBROSONINessuna valutazione finora
- Prima Prova Intermedia - Antropologia Culturale 2A2Documento1 paginaPrima Prova Intermedia - Antropologia Culturale 2A2CLAUDIA AMBROSONINessuna valutazione finora
- Docsity Ragazzi Difficili Pedagogia Interpretativa e Linee Di InterventoDocumento21 pagineDocsity Ragazzi Difficili Pedagogia Interpretativa e Linee Di InterventoCLAUDIA AMBROSONINessuna valutazione finora
- Ambrosoni Claudia Matricola 1074694Documento3 pagineAmbrosoni Claudia Matricola 1074694CLAUDIA AMBROSONINessuna valutazione finora
- Antropologia Prova 2 AntropoceneDocumento1 paginaAntropologia Prova 2 AntropoceneCLAUDIA AMBROSONINessuna valutazione finora
- IPA VocaliDocumento1 paginaIPA VocaliCLAUDIA AMBROSONINessuna valutazione finora
- Lingua e Letterature Ispano-AmericaneDocumento116 pagineLingua e Letterature Ispano-AmericaneCLAUDIA AMBROSONINessuna valutazione finora
- Frasi Da Tradurre Dallitaliano in Giapponese. Unità 41-45Documento1 paginaFrasi Da Tradurre Dallitaliano in Giapponese. Unità 41-45CLAUDIA AMBROSONINessuna valutazione finora