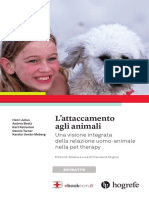Il 0% ha trovato utile questo documento (1 voto)
298 visualizzazioni28 pagineStoria Sarda Per Bambini
Il documento descrive la storia preistorica della Sardegna, dall'arrivo dell'uomo di Neanderthal 450.000 anni fa fino alla comparsa dei primi nuraghi intorno al 1600 a.C. Vengono introdotti i principali periodi preistorici e descritti i progressi dell'uomo dall'Homo erectus all'Homo sapiens sapiens, inclusa la transizione dalla vita nomade a quella sedentaria nei villaggi.
Caricato da
patriziaCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Il 0% ha trovato utile questo documento (1 voto)
298 visualizzazioni28 pagineStoria Sarda Per Bambini
Il documento descrive la storia preistorica della Sardegna, dall'arrivo dell'uomo di Neanderthal 450.000 anni fa fino alla comparsa dei primi nuraghi intorno al 1600 a.C. Vengono introdotti i principali periodi preistorici e descritti i progressi dell'uomo dall'Homo erectus all'Homo sapiens sapiens, inclusa la transizione dalla vita nomade a quella sedentaria nei villaggi.
Caricato da
patriziaCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd