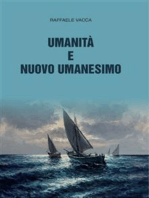Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Cusano
Caricato da
vitazzoCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Cusano
Caricato da
vitazzoCopyright:
Formati disponibili
1.
Umanesimo, Rinascimento e platonismo
LUmanesimo nasce in Italia intorno alla fine del Trecento e da qui, in seguito, si diffonde nellintera Europa cristiana. C un rinnovato interesse verso l uomo e verso ci che a lui collegato: la citt, la libert, i temi etici e politici; viene celebrata la vita activa (limpegno civile, il lavoro umano, esaltati in particolare da Coluccio Salutati e, soprattutto, da Leon Battista Alberti, 1404-72), in contrasto con la vita contemplativa e leccessivo peso della metafisica. Successivamente, durante il Rinascimento (allincirca dal Cinquecento in poi) lattenzione si sposter sulla natura, riconsiderata positivamente (a differenza del periodo medievale) come manifestazione di Dio. Tra i filosofi pi interessati alla natura, vista come organismo vivente, vanno ricordati Bernardino Telesio (1509-88, che arriva a parlare di natura senziente) e Giordano Bruno. Con lUmanesimo si ha una vera e propria riscoperta di Platone, che prende corpo nel cosiddetto platonismo rinascimentale. A cominciare dal Petrarca, i motivi per cui si apprezza nuovamente Platone, eleggendolo a Maestro del nuovo pensiero, sono molteplici. Ad esempio si vede in lui il pi artista tra i filosofi e la figura pi affascinante della classicit. Oppure lo si stilizza come l'ideale antagonista di Aristotele e dell'ormai aborrita filosofia scolastica, come il pensatore che grazie al suo filosofare aperto e problematico, antitetico al filosofare chiuso di Aristotele e di Tommaso, appare il pi adatto ad esprimere l'inquietudine dell'uomo e la complessit dinamica del reale. Ma soprattutto si considera Platone - non ancora separato da Plotino, solo nell'Ottocento che si comincer a distinguerli nettamente - come il filosofo pi vicino allo spirito religioso del Cristianesimo e come il pi consono ad esprimere il rapporto fra Dio e mondo in termini di circolarit e di amore, secondo il doppio processo della derivazione del mondo da Dio e del ritorno del mondo a Dio tramite un atto di amore. Contemporanee circostanze storiche, che contribuiscono ulteriormente ad avvicinare gli spiriti a Platone, sono il Concilio di Ferrara e di Firenze (1438-1439), per l'unione della Chiesa greca e di quella orientale, e la caduta di Costantinopoli in mano ai Turchi (1453); elementi che facilitano l'afflusso, in Italia, di una moltitudine di dotti orientali, esperti di lingua e cultura greca. Questo fervore di interessi per Platone si concretizza nella traduzione completa delle opere da parte di Marsilio Ficino (1433-1499). Egli celebre come fondatore della Accademia platonica, nei pressi di Firenze. In particolare, rielabora la tradizione neoplatonica considerando il principio primo (lantico Uno) Dio Padre, che crea volontariamente, grazie allamore, il mondo intero. Ficino anche uomo del suo tempo; considera infatti la magia (intesa in modo simile alla chimica) come uno strumento essenziale per governare la natura, un potenziamento della medicina. Il platonismo rinascimentale da considerarsi, dunque, un insieme complesso e multiforme di elementi disparati: platonici, neoplatonici, orfici, pitagorici, ermetici (legati cio alla mitica figura primordiale di Ermete Trismegisto legato allantica sapienza egizia e considerato autore di una serie di opere rivelatisi poi false) e cristiani. Di conseguenza, questo platonismo va interpretato, in primo luogo, come una forma
rielaborata di neoplatonismo cristianeggiante. Va infine ricordato che, nello stesso tempo, si ha un rinato interesse per Aristotele, innescando anche una disputa tra platonici e aristotelici. Se il centro dei platonici era Firenze, Aristotele era studiato principalmente a Padova, in primo luogo grazie a Pietro Pomponazzi (1462-1524). Un certo successo lo ebbero anche le filosofie ellenistiche ( Lorenzo Valla, 1407-1457, recuper ad esempio lepicureismo).
2. Nicola Cusano
Nikolaus Krebs (1401-61) nacque a Cusa presso Treviri (Renania) in Germania nel 1401. Legato alla mistica tedesca, studi ad Heidelberg, poi a Padova. Si era indirizzato agli studi giuridici, ma divenne poi sacerdote nel 1430. Nel 1432 partecip al concilio di Basilea (che doveva fra l'altro decidere l'unione tra la Chiesa latina e la Chiesa greca) e poi fu mandato in Grecia, donde ritorn in Italia con i pensatori e i teologi greci pi significativi del tempo. Nominato cardinale (1448) e vescovo di Bressanone (1450), entr in conflitto col duca del Tirolo, dal quale fu tenuto in carcere per parecchi anni. Mor lontano dalla sua diocesi, a Todi in Umbria. La sua opera principale Docta ignorantia (1440), alla quale seguirono numerosi altri scritti, tra cui De pace fidei (1453) e De visione Dei (1453). Il punto di partenza della riflessione di Cusano teologico. Dio in quanto ens perfectissimum, privo di ogni limitazione e creatore dell'intera realt, infinito in atto o infinito negativo: tutte le sue propriet sono perfettamente realizzate al culmine delle loro potenzialit. Rifacendosi ad Anselmo e alla sua definizione di Dio (quo maius cogitari nequit), Cusano parla di Dio come del massimo assoluto rispetto al quale nulla vi di pi grande. Ma, accanto alla tradizione scolastica razionalistica, Cusano si rifa anche e soprattutto a quella mistica e alla teologia negativa. In questo caso l'infinit di Dio significa la sua assoluta trascendenza: Dio non n Padre, n Figlio, n Spirito Santo, ma soltanto infinito. In quanto tale, Dio resta sempre trascendente e si sottrae a ogni sforzo conoscitivo dell'uomo: un Deus absconditus che resiste a ogni tentativo della ragione di svelarne l'essenza, resta inaccessibile e si mostra, anzi, come un vero e proprio "paradosso". Il carattere paradossale dell'infinit divina espresso da Cusano attraverso la nozione della coincidentia oppositorum. la quale oltrepassa ogni nostra capacit di comprensione razionale, fondata sul principio di non contraddizione. Egli utilizza prevalentemente simboli matematici per esprimere questa paradossale coincidenza: la linea retta e la linea curva sono distinte e addirittura opposte tra loro, ma una circonferenza "massima", ossia di diametro infinito, risulterebbe identica a una linea retta, ossia a una linea la cui curvatura sia "minima". La retta e il circolo, il minimo e il massimo, trovano nell'infinito la loro coincidenza. Sulla scia di Platone e della tradizione neoplatonica, Cusano distingue due elementi. La ratio, la ragione, che alla base della conoscenza razionale; essa sempre parziale e imperfetta per la sua natura discorsiva. Lintellectus, lintelletto, permette di andare oltre la ragione grazie
allintuizione; esso in grado di sollevarsi oltre il principio di non contraddizione, fino a intravedere la paradossale coincidentia oppositorum dell'infinito. Tuttavia, non si tratta di una vera e propria conoscenza, destinata a soppiantare quella razionale: lintelletto offre solo una conoscenza negativa che, se oltrepassa la limitatezza della ratio, non pu per sfociare in un sapere positivo. L'intelletto ha, piuttosto, il compito di farci intravedere i limiti della ragione e si presenta come un socratico "sapere di non sapere, una docta ignorantia.
3. La conoscenza umana congetturale per Cusano
Questa consapevolezza del limite della conoscenza razionale si traduce nella definizione della nostra conoscenza come solo congetturale, ipotetica. Nessuna conoscenza pu mai essere definitiva, perch essa pu approssimarsi sempre di pi al suo oggetto, ma fra i due destinata a restare sempre una differenza mai del tutto colmabile. Per esprimere lo scarto che segna ineliminabilmente le nostre congetture, Cusano ricorre a un'ennesima metafora matematica: il rapporto tra la verit e la conoscenza viene paragonato a quello tra una circonferenza e il poligono inscritto . Quest'ultimo si approssimer tanto pi alla circonferenza quanti pi angoli presenter, pur non potendo mai, in quanto poligono, identificarsi pienamente con essa. Ma proprio da questa insuperabile differenza tra conoscenza e verit, da questo carattere ineliminabilmente congetturale del nostro conoscere, Cusano trae motivo per celebrare l'inesauribile creativit della mente umana. Quest'ultima, origine delle infinite congetture, risulta in qualche modo partecipe della stessa infinit creativa di Dio. Il carattere congetturale della conoscenza umana non riferito solo allinfinit divina, ma allintero universo che, essendo infinito come il suo creatore, non consente alla ragione di giungere a una sua completa conoscenza. L'universo, afferma Cusano, esplicazione e dispiegamento di Dio (principio unitario) nella molteplicit e nel tempo. Se tale il rapporto tra Dio e il mondo, ne consegue che quest'ultimo, manifestazione ed esplicazione di Dio, non potr essere finito, ma dovr essere anchesso infinito, per poter esprimere degnamente l'infinit divina. Dio e mondo non sono allora due entit distinte e contrapposte ma l'unit e la molteplicit, la coincidentia oppositorum e gli opposti, in diverse modalit di attuazione. La concezione del rapporto tra Dio e l'universo in termini di complicazione ed esplicazione e la distinzione tra l'infinit negativa di Dio e quella privativa dell'universo portano Cusano a rifiutare la cosmologia aristotelico-tolemaica, anticipando alcune dette pi innovative teorie della successiva rivoluzione astronomica. Egli nega l'esistenza di un centro immobile e di una circonferenza assoluta dell'universo, la perfetta immobilit della Terra, la sua posizione centrale nelluniverso, la distinzione tra un sopra divino e un sotto terreno. Ogni corpo, nellordine cosmico, in rapporto immediato con Dio.
A queste innovative tesi cosmologiche corrispondono le concezioni filosofico-religiose espresse negli scritti De pace fidei e De visione Dei, entrambi del 1453. La prima opera, scritta sotto l'impressione della caduta di Costantinopoli per mano dei turchi, uno significativo invito al dialogo e alla tolleranza religiosa. Rispetto allunico Dio, le fedi si presentano come conjecturae che manifestano il Deus absconditus in forme sempre diverse; la molteplicit e la differenza delle fedi sono considerate come manifestazione infinitamente ricca della verit. Analogamente, nel secondo breve scritto Cusano sviluppa alcune suggestive riflessioni sulla teologia mistica. Il titolo dell'opera, De visione Dei, va inteso come un genitivo oggettivo e soggettivo a un tempo: la visione che noi possiamo avere di Dio , contemporaneamente, la visione che Dio ha di noi e viceversa. Ci comporta che Dio si mostra a ciascuno con un volto e un aspetto differenti, dipendenti da ci che ognuno (L'uomo non pu non giudicare umanamente), e che il possesso autentico di Dio dipende dalla nostra libera decisione di possedere noi stessi. Ci che Cusano aveva prima affermato con riferimento alla cosmologia e alla pluralit dei corpi celesti e poi in relazione alle varie fedi storiche viene adesso riferito alla fede colta nella dimensione interiore propria dell'individuo.
5. Giovanni Pico della Mirandola
Nato a Mirandola nel 1463, considerato un grande intellettuale ed erudito gi durante la sua vita, entra a far parte dellAccademia platonica di Ficino e si propone come punto di contatto di tradizioni filosofiche differenti: scolastica araba e cristiana, aristotelismo, platonismo. Per le sue tesi innovative subisce anche accuse di eresia. Muore a Firenze nel 1494. Nella sua Orazione sulla dignit delluomo ( De homini dignitate, 1486) emerge lidea delluomo come partner privilegiato di Dio nel comprendere e portare a termine il lavoro della creazione. Luomo, al centro delluniverso, creato a immagine e somiglianza di Dio, raccogliendo in se stesso tutti gli elementi di tutte le cose (ricollegandosi alle filosofie di Anassagora e di Agostino). Perci, luomo pu essere interpretato come microcosmo: riprende in piccolo le caratteristiche del mondo e, viceversa, il mondo rappresenta in grande le propriet delluomo. Luomo, come Dio, pu liberamente scegliere come realizzarsi: in questo risiede la sua dignit. Pu perci sollevarsi alle pi alte vette dello spirito come abbassarsi alla degradazione morale per effetto delle sue scelte, a differenza delle altre creature che sono vincolate a un modo di essere specifico. Luomo, tuttavia, ha principalmente desiderio di Dio e mira ad ascendere progressivamente a Lui. Negli ultimi anni della sua vita contesta la scienza dell astrologia, considerata distruttrice delle libert umane perch fa dipendere la vita del singolo dagli astri.
Da: Ciuffi, Luppi, Vigorelli, Zanette, Bianchi, De Pasquale, OBrien, I filosofi e le idee, vol. 2, Paravia Bruno Mondadori, Milano, 2006, pagg. 38-42; De Luise, Farinetti, Lezioni si storia della filosofia , vol. B, Zanichelli, Bologna, 2010, p. 9; Da Abbagnano, Fornero, Protagonisti e Testi della Filosofia, vol. B, Paravia, Torino, 2000, pagg. 27-32. Con modifiche.
4. Tolleranza e individualit nella religione per Cusano 2
Potrebbero piacerti anche
- Manuali - Elaborazione Motociclismo - Elaborazione Delle CentralineDocumento9 pagineManuali - Elaborazione Motociclismo - Elaborazione Delle CentralinenikolaxxxteslaNessuna valutazione finora
- Chiarini Espres Con Cit Contini PDFDocumento24 pagineChiarini Espres Con Cit Contini PDFAndrea LombardiNessuna valutazione finora
- Catabasi Di EneaDocumento16 pagineCatabasi Di Eneaanton59Nessuna valutazione finora
- Lycan - Filosofia Del Linguaggio RiassuntoDocumento11 pagineLycan - Filosofia Del Linguaggio RiassuntoLorenzo PasqualeNessuna valutazione finora
- Giorgio Colli, Alessandro Fersen - La Dimensione Perduta (Integrale)Documento9 pagineGiorgio Colli, Alessandro Fersen - La Dimensione Perduta (Integrale)dolan36Nessuna valutazione finora
- Breve Manuale Di Geografia Umana, Minca C., Colombino A.Documento47 pagineBreve Manuale Di Geografia Umana, Minca C., Colombino A.Denis ScottNessuna valutazione finora
- Naturales QuaestionesDocumento3 pagineNaturales QuaestionesFrancesco MirabellaNessuna valutazione finora
- Estetica CroceDocumento26 pagineEstetica CrocePaolo EmilioNessuna valutazione finora
- Mel-Frequency Cepstral CoefficentsDocumento5 pagineMel-Frequency Cepstral CoefficentsFibro_Nessuna valutazione finora
- Archicad ManualeDocumento293 pagineArchicad ManualeMario FriscoNessuna valutazione finora
- Giordano Bruno vs Aristotele. La critica di Giordano Bruno al pensiero di Aristotele.Da EverandGiordano Bruno vs Aristotele. La critica di Giordano Bruno al pensiero di Aristotele.Nessuna valutazione finora
- L'Estasi Iniziatica. Da Giordano Bruno ad Arturo ReghiniDa EverandL'Estasi Iniziatica. Da Giordano Bruno ad Arturo ReghiniNessuna valutazione finora
- Trucheck - It - Positivismo, Realismo, Naturalismo, VerismoDocumento5 pagineTrucheck - It - Positivismo, Realismo, Naturalismo, VerismoValentino Masi100% (1)
- Analisi Del TestoDocumento3 pagineAnalisi Del TestoelionanaqoNessuna valutazione finora
- Antigone (Figlia Di Edipo)Documento2 pagineAntigone (Figlia Di Edipo)FrankNessuna valutazione finora
- Machiavelli Dialogo Intorno Alla Nostra PDFDocumento15 pagineMachiavelli Dialogo Intorno Alla Nostra PDFsebatorres7Nessuna valutazione finora
- 1-Canfora - SLGA. La Biblioteca e Il MuseoDocumento14 pagine1-Canfora - SLGA. La Biblioteca e Il MuseoFederico Gelsi100% (2)
- Donato Loscalzo - La Catarsi TragicaDocumento19 pagineDonato Loscalzo - La Catarsi TragicaCosti TorreNessuna valutazione finora
- Immaginazione in Kant I PDFDocumento16 pagineImmaginazione in Kant I PDFCarlo MunariNessuna valutazione finora
- Senso, Denotazione, Verità (Frege) PDFDocumento41 pagineSenso, Denotazione, Verità (Frege) PDFMarisa La BarberaNessuna valutazione finora
- Wilson Filologia Greca A BisanzioDocumento15 pagineWilson Filologia Greca A BisanzioPallino61Nessuna valutazione finora
- Berardi, La Medea Di Apollonio Rodio. Pitture Di Un'Anima 2012Documento13 pagineBerardi, La Medea Di Apollonio Rodio. Pitture Di Un'Anima 2012pinoNessuna valutazione finora
- Profilo Di Storia Della Letteratura Latina2Documento28 pagineProfilo Di Storia Della Letteratura Latina2Lmpus AnnaNessuna valutazione finora
- Vitellaro Il Secondo Heidegger PDFDocumento20 pagineVitellaro Il Secondo Heidegger PDFCarla NatoliNessuna valutazione finora
- Massimo FERRARI, Cassirer, Natorp e L'immagine Di PlatoneDocumento29 pagineMassimo FERRARI, Cassirer, Natorp e L'immagine Di PlatoneargentazzuNessuna valutazione finora
- Landi, Carlo (Ed.) - Demogòrgone (Microform) - Con Saggio Di Nuova Edizione Delle Genologie Deorum Gentilium Del Boccaccio e Silloge Dei Frammenti Di TeodonzioDocumento130 pagineLandi, Carlo (Ed.) - Demogòrgone (Microform) - Con Saggio Di Nuova Edizione Delle Genologie Deorum Gentilium Del Boccaccio e Silloge Dei Frammenti Di TeodonzioVerónica Díaz PereyroNessuna valutazione finora
- Mito e Poesia Nel PROMETEO INCATENATO Di EschiloDocumento9 pagineMito e Poesia Nel PROMETEO INCATENATO Di EschiloDavo Lo SchiavoNessuna valutazione finora
- Aristeo PDFDocumento15 pagineAristeo PDFrabidusutventusNessuna valutazione finora
- Eschine Di Sfetto Alcune Nuove TestimoniDocumento30 pagineEschine Di Sfetto Alcune Nuove TestimoniΑλέξανδρος ΣταύρουNessuna valutazione finora
- CREVATIN y TEDESCHI 2005 - Studi Di Antichità in Onore Di Segio DarisDocumento335 pagineCREVATIN y TEDESCHI 2005 - Studi Di Antichità in Onore Di Segio DarisLóstregos de BrestNessuna valutazione finora
- Masnovo - Ancora Alberto Magno e L'averroismo Latino PDFDocumento10 pagineMasnovo - Ancora Alberto Magno e L'averroismo Latino PDFAlberti Magni Studiosus100% (1)
- Spengler - FaustismoDocumento17 pagineSpengler - FaustismoMichele CalcagnoNessuna valutazione finora
- La Cetra e Il CantoDocumento268 pagineLa Cetra e Il CantoLorenzoZambernardi100% (1)
- (Note) Giorgio Colli - Parmenide PDFDocumento10 pagine(Note) Giorgio Colli - Parmenide PDFCarmen RomeroNessuna valutazione finora
- Mario Negri-Erika Notti - Leonardo Magini - Omero Il Cielo e Il Mare - Intro - Chap. 1Documento51 pagineMario Negri-Erika Notti - Leonardo Magini - Omero Il Cielo e Il Mare - Intro - Chap. 1Luciano DuòNessuna valutazione finora
- Monografia La Doppia Ascia A Creta Claudio MDocumento47 pagineMonografia La Doppia Ascia A Creta Claudio Misabel_carrilho_1100% (2)
- G. Pasquali, 1920. Orazio LiricoDocumento810 pagineG. Pasquali, 1920. Orazio LiricoTaratantaraDixitNessuna valutazione finora
- Marzillo - Porfirio Antro NinfeDocumento40 pagineMarzillo - Porfirio Antro NinfeΑλέξανδρος ΣταύρουNessuna valutazione finora
- PREUMANESIMODocumento42 paginePREUMANESIMOsilviaNessuna valutazione finora
- Dorato, Mauro - Istituzioni Di Filosofia Della ScienzaDocumento70 pagineDorato, Mauro - Istituzioni Di Filosofia Della ScienzaRenato Degli EspostiNessuna valutazione finora
- EspositoDocumento24 pagineEspositolvanzago100% (1)
- Omero e La Storia P.carlierDocumento59 pagineOmero e La Storia P.carlierGildaNessuna valutazione finora
- 18 FirpoDocumento38 pagine18 FirposirfrogNessuna valutazione finora
- Cristianesimo Primitivo e Paideia GrecaDocumento11 pagineCristianesimo Primitivo e Paideia GrecaGabriel FawkesNessuna valutazione finora
- Cartesio MeditazioniDocumento2 pagineCartesio MeditazioniPaolo EmilioNessuna valutazione finora
- Stalingrado. Il polittico di Vasilij Grossman.: Memorie plurali e memoria di StatoDa EverandStalingrado. Il polittico di Vasilij Grossman.: Memorie plurali e memoria di StatoNessuna valutazione finora
- Spartaco PDFDocumento8 pagineSpartaco PDFIpssar Beltrame EventiNessuna valutazione finora
- Parmenide: Sulla Natura - Dario ZucchelloDocumento617 pagineParmenide: Sulla Natura - Dario ZucchellorumorumoNessuna valutazione finora
- Fowler PlatoneDocumento135 pagineFowler PlatoneSandro Themel100% (2)
- Intellettuali Nel MedioevoDocumento31 pagineIntellettuali Nel MedioevoandreaNessuna valutazione finora
- Lezioni Sulla Fenomenologia Della Temporalità Di HusserlDocumento204 pagineLezioni Sulla Fenomenologia Della Temporalità Di HusserlLibricusNessuna valutazione finora
- AuerbachDocumento28 pagineAuerbachrobertoslNessuna valutazione finora
- Porfirio La Philosophia Ex Oraculis Per Una Nuova Edizione Dei FrammentiDocumento455 paginePorfirio La Philosophia Ex Oraculis Per Una Nuova Edizione Dei FrammentikyomarikoNessuna valutazione finora
- Alberi-Auber - La Linea Meridiana Di AugustoDocumento15 pagineAlberi-Auber - La Linea Meridiana Di Augustoberix100% (1)
- Copisti e FilologiDocumento52 pagineCopisti e FilologiIoana Caloian0% (1)
- Epitteto - Diatribe e FrammentiDocumento245 pagineEpitteto - Diatribe e Frammentijuanmatus2011Nessuna valutazione finora
- Democrazia AteneDocumento31 pagineDemocrazia AteneFrancesco OrtaleNessuna valutazione finora
- La Vicenda Umana Di IpaziaDocumento24 pagineLa Vicenda Umana Di IpaziaEla RodriguezNessuna valutazione finora
- Del Mar Più Che Del Ciel Amante . Bruno e CusanoDocumento292 pagineDel Mar Più Che Del Ciel Amante . Bruno e CusanoJosé Manuel OsorioNessuna valutazione finora
- Ezio Albrile, Smarrirsi Nell'adeDocumento9 pagineEzio Albrile, Smarrirsi Nell'adealessandro cosciaNessuna valutazione finora
- Plotino e Ficino - L'autorelazione Del PensieroDocumento33 paginePlotino e Ficino - L'autorelazione Del PensieroErnesto Fuentes Padgett100% (1)
- La Filosofia Si Sporca Le ManiDocumento7 pagineLa Filosofia Si Sporca Le ManivitazzoNessuna valutazione finora
- NāgārjunaDocumento25 pagineNāgārjunavitazzoNessuna valutazione finora
- La Neuropatia Del Soprascapolare Negli AtletiDocumento2 pagineLa Neuropatia Del Soprascapolare Negli AtletivitazzoNessuna valutazione finora
- Dharma Kirti 2Documento32 pagineDharma Kirti 2vitazzoNessuna valutazione finora
- Bombieri - L'InfinitoDocumento38 pagineBombieri - L'InfinitoGiovanni GrassoNessuna valutazione finora
- Geometria Non Euclidea PDFDocumento9 pagineGeometria Non Euclidea PDFvitazzoNessuna valutazione finora
- De Waal F, Naturalmente Buoni, GarzantiDocumento3 pagineDe Waal F, Naturalmente Buoni, GarzantivitazzoNessuna valutazione finora
- 200910Documento19 pagine200910vitazzoNessuna valutazione finora
- Geometria PDFDocumento11 pagineGeometria PDFvitazzoNessuna valutazione finora
- Crisi Dei Fondamenti Della Matematica PDFDocumento6 pagineCrisi Dei Fondamenti Della Matematica PDFvitazzoNessuna valutazione finora
- 06 MecacciDocumento10 pagine06 MecaccivitazzoNessuna valutazione finora
- 02 Hoelderlin PatmosDocumento8 pagine02 Hoelderlin PatmosvitazzoNessuna valutazione finora
- 200912Documento15 pagine200912vitazzoNessuna valutazione finora
- Misure Spazio e Figure 2 - SoluzioniDocumento6 pagineMisure Spazio e Figure 2 - Soluzionisinghjaswanttony67Nessuna valutazione finora
- Lavorazioni PlasticheDocumento7 pagineLavorazioni PlasticheEnricoPietraNessuna valutazione finora
- ElettromagnetismoDocumento29 pagineElettromagnetismoghàloàpbwn1NàLòQF èèpùè hgHFNHNessuna valutazione finora
- Mat5ab7 12-13Documento2 pagineMat5ab7 12-13savaziNessuna valutazione finora
- 02 Integrali ImpropriDocumento9 pagine02 Integrali ImpropriCarlMuserNessuna valutazione finora