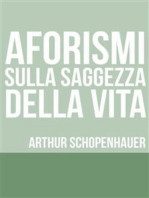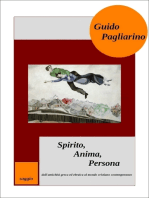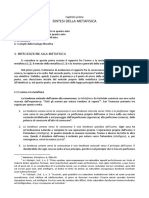Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Appunti Sul Libro Di Sandro Nannini "L'anima e Il Corpo".
Caricato da
Leonardo SimoniTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Appunti Sul Libro Di Sandro Nannini "L'anima e Il Corpo".
Caricato da
Leonardo SimoniCopyright:
Formati disponibili
Appunti sul libro di Sandro Nannini
Lanima e il corpo - parte I
Unintroduzione storica alla filosofia della mente
Cap. 1
La filosofia antica e medievale
1.1 Mente, anima e spirito
La mente rinvia allanima e allo spirito, vediamo le ragioni etimologiche di questo legame: o La parola mente deriva dal latino mens per indicare lanima razionale di Aristotele. o Anima (il termine latino), la traduzione latina del greco psych. o Mente legata a spirito, dal latino spiritus, che traduceva il termine filosofico greco pnuma). o Psych e pnuma in greco sono legati in quanto hanno un significato simile: soffio, respiro, alito e, per estensione, vita. I concetti di anima e spirito, dai quali deriva quello di mente, sono frutto di una lunga storia: o In Platone (ed embrionalmente in alcuni pre-socratici) troviamo per la prima volta il termine psych usato con significato di anima individuale (costituisce lunit{ della persona, pensa e guida il corpo, costituisce un soggetto morale); o Prima del V secolo a.C. anima e spirito significano soffio, forza vitale inteso in due accezioni: Cosmologico, come ci che infonde vita e ordine al cosmo; Individuale (o psicologico), come forza vitale in un singolo individuo. o Esempi di questo duplice significato si trovano in Omero: le anime dirette allAde si riferiscono a singoli individui; nel Timeo di Platone, daltro canto, il demiurgo pone al centro del cosmo unanima che d{ movimento ai cieli, vita e intelligenza al tutto (concetto di anima mundi); o Nello pnuma degli stoici ancor pi forte il significato cosmologico: esso era fuoco creatore, soffio vitale materiale; o Nel Cristianesimo laccezione cosmologica del termine rinvenibile nello Spirito Santo; o Nella filosofia pi recente, in Hegel lo spirito cosmico laicizzato e diventa spirito oggettivo e assoluto o Alla fine del XIX, nelle scienze dello spirito di Dilthey lo spirito assume il significato di dimensione sopraindividuale, storicamente tramandata, del mondo umano, cio cultura in senso antropologico.
1.2 Lanima da Omero a Platone
In Omero, secondo gli studi di B. Snell, il concetto di anima individuale non esiste ancora: lanima solo lombra, limmagine (idolon) del defunto. con Platone (427-347 a. C.) che la psych assume il significato che ancor oggi, tramite il Cristianesimo, gli associamo, cio centro della vita morale e spirituale dellindividuo. La psych platonica emerge nellApologia, nel Critone, ma soprattutto nelle pagine finali del Fedone; essa ancora non autocoscienza nel senso moderno e cartesiano del termine, ma vi gi una netta distinzione tra anima e corpo (dualismo nella filosofia contemporanea):
In Platone, inoltre, lanima sopravvive alla mortalit{ del corpo (immortalit{ dellanima) e ci avr{ eccezionale fortuna nella concezione cristiana. In Platone tuttavia non abbiamo ancora una scienza unitaria dellanima per due motivi: o Egli scrisse dialoghi, non trattati; la sua filosofia non vuole essere un insieme di conoscenze dogmatiche, ma formazione morale delle persone attraverso la libera discussione (larte di educar lanima) o Non v in Platone una distinzione tra metafisica, teoria della conoscenza, etica, estetica e filosofia poltica (distinzioni introdotte poi da Aristotele). La concezione platonica dellanima deve esser vista quindi come cura alla corruzione morale di Atene provocata dai democratici e dalla filosofia dei sofisti (cura dellanima come ritorno alla virt, riscatto morale e politico della citt di Atene) e quindi collegata a un programma di rigenerazione morale, politica e religiosa.
1.3 Aristotele
Aristotele, diversamente da Platone, parla dellanima con un intento scientifico: egli elabora per la prima volta una dottrina fisica e metafisica dellanima. In Aristotele si pu gi parlare, quindi, di una psicologia, ma sarebbe pi esatto intenderla come bio-fisio-psicologia, in quanto il filosofo non distinse tra biologia e fisica (lanima fa parte della fisica). A differenza del dualismo di Platone anima/corpo, la concezione di Aristotele anti-dualista; anima come forma del corpo, secondo lapplicazione della pi generale dottrina aristotelica dellilomorfismo (hyle = materia, morph = forma). Le opere pi importanti dove viene esposta la dottrina aristotelica dellanima sono: o De anima o Parva naturalia Nel De anima, dopo aver ribadito il significato originario di anima come principio degli esseri viventi, si ricerca la sua natura (physis) mediante unindagine fisica. Nellindagine Aristotele esamina la natura della collera ed evidenzia due errori: o Errore del dialettico (Platone), per cui lanima separabile dal corpo e identifica interamente la collera con il desiderio di vendetta. Nello spiegare la collera, cio, si considera solo la forma, lintenzione dellagire, la nozione (logos), appunto il desiderio di vendetta, dimenticando che tale forma non pu esistere se non si realizza in una determinata materia. Il dialettico, quindi, tiene conto della razionalit teleologica insita nelle cose ma non riesce a spiegare come questa sia legata al corpo, appunto perch intende lanima separata dal corpo. o Errore del naturalista-presocratico: la collera causata dal ribollire del sangue intorno al cuore. Daltro canto il naturalista compie lerrore opposto: vede la collera come un meccanismo cieco, dando una spiegazione solamente fisica della collera, senza collegarla allessenza, alla forma di cui funzione. Per Aristotele invece bisogna tener conto della forma e della materia insieme. I fenomeni organici, nella sua dottrina, trovano una spiegazione di tipo psicologico e teleologico (cio finalistico, che tende a uno scopo): il desiderio di vendetta (che fa parte dellanima) spiega il sangue che ribolle (fenomeno fisico); quindi per Aristotele la psicologia il fondamento della biologia. Inoltre, per Aristotele, lessenza dellanima deve essere ricercata tenendo conto che essa intrinsecamente legata a un corpo: essa la forma di una determinata materia.
Concetti su cui si basa la definizione dellanima in Aristotele: o Forma e materia (formulati nella Fisica e nella Metafisica): tutti gli oggetti sono un composto (synolon = sinolo, tuttuno) di una materia particolare e di una forma universale. o Le forme, al contrario di Platone, non sono separate dagli oggetti sensibili (non sono trascendenti ma immanenti). o Luomo un sinolo di materia e forma, corpo e anima. o La forma la sostanza, ci in cui consiste un oggetto (anche luomo) e lo fa essere quello che . o Lilomorfismo (ogni cosa tranne Dio un sinolo di materia e forma) una dottrina metafisica generale che riguarda esseri animati e inanimati. o Nelluomo lanima la forma e il corpo la materia. o Lanima, in quanto forma, anche entelechia, cio atto, realizzazione pienamente compiuta, il corpo potenza, possibilit{. o Anche la coppia potenza-atto si applica a qualsiasi cosa (il bronzo potenza, possibilit{ di assumere forma sferica. La sfera di bronzo diverr{ atto quando larte imporr{ la forma sferica al bronzo). o Lanima atto, entelechia del corpo, in quanto d{ vita, sensibilit{, ecc. a un corpo. la realizzazione, cio, delle potenzialit proprie del corpo. o Si distingue lentelechia prima dallentelechia seconda: la prima quella che realizza le potenzialit del corpo dandogli vita, sensibilit, ecc., e la seconda quella che realizza leffettivo vivere, sentire, ecc.. o Lanima sta al corpo come latto della visione sta allorgano visivo: la realizzazione della capacit che propria di un corpo organico. o Come ogni strumento ha una sua funzione, che latto o attivit{ dello strumento (come funzione della scure di tagliare), cos lorganismo in quanto strumento ha la funzione di vivere e di pensare; e latto di questa funzione lanima. o Tripartizione dellanima. Lanima consta di tre funzioni, di cui le superiori riassorbono le inferiori: Facolt{ nutritiva (vivere e riprodursi, propria delle piante); Facolt sensitiva e appetitiva (propria degli animali); Intelletto (propria delluomo). La teoria aristotelica cos intesa antiplatonica: una forma non pu esistere se non nella sua realizzazione materiale. Lanima, quindi non pu esistere fuori dal corpo. In realt{ lantiplatonismo pu essere attenuato considerando i passi del De anima che parlano di un genere di anima diverso, che pu essere separato dal corpo (intelletto agente). Il concetto di intelletto agente, in Aristotele, contrasta con la sua visione di anima inseparabile dal corpo: esso separabile dal corpo ed immortale ed eterno. Questo concetto stato molto discusso fino al Rinascimento, soprattutto dai pensatori cristiani interessati alla questione dellimmortalit{ dellanima. Quattro modi con cui il concetto dellintelletto agente pu essere conciliato con il resto della dottrina ilomorfica dellanima: o Il passo parzialmente o interamente spurio oppure pu essere interpretato acrobaticamente in modo tale da renderlo coerente; o Lintelletto agente di carattere divino e non ha nulla a che vedere con quello umano;
Esistono in Aristotele quattro tipi di anime: Anima nutritiva (delle piante) Anima sensitiva (di animali e uomini) Intelletto umano (in potenza e agente) Intelligenze che muovono i cieli Lilomorfismo si applica solo alle prime due forme e forse allintelletto in potenza, mentre quello agente immateriale e immortale come le intelligenze celesti. Lintelletto agente un elemento divino presente nelluomo e determina la sua felicit{ attraverso la vita contemplativa (ricongiunzione con la divinit).
Nel De anima (ricostruito da Andronico di Rodi), confluiscono teorie platoniche e antiplatoniche ricollegabili a periodi diversi della vita di Aristotele.
Al di l{ dellimpossibilit{ di riscostruire con certezza la presenza o meno di elementi dualistici in Aristotele, rimane il fatto che la sua teoria dellanima ha avuto un peso immenso sulla storia della nostra civilt.
1.4 Latomismo e lo stoicismo
Accanto al dualismo di Platone e allilomorfismo di Aristotele abbiamo nellantichit{ anche concezioni materialistiche: o Latomismo di Democrito (V-IV sec. A.C.), Epicuro (341-270 a.C.) e Lucrezio (99-55 a.C.): Per gli atomisti sono meccanicisti (meccanicismo: spiegazione filosofica del mondo che si serve esclusivamente del movimento dei corpi, inteso nel senso ristretto di movimento spaziale). Per gli atomisti esistono solo gli atomi (indivisibili e corporei) e il vuoto (inerte, non produce effetti); ogni fenomeno riconducibile a movimenti e urti fra atomi. Lanima quindi corporea (composta di atomi sottili e veloci), perch se non lo fosse non produrrebbe effetti. Essa tiene in vita il corpo (fatto di atomi pi pesanti) e lo muove. Il rapporto tra anima e corpo di fusione totale, anche se esplicabile in termini di urti e movimenti tra gli atomi diversi che li compongono. Nel De rerum natura di Lucrezio sono sostenuti argomenti a favore dellidentit{ dellanima con il cervello; svalutata la concezione spirituale dellanima, che deriva dal desiderio umano di non morire. Atteggiamento areligioso degli atomisti: per Epicuro (rovesciando largomento platonico del Fedone), non bisogna temere la morte perch lanima mortale. Bene e male corrispondono edonisticamente con il piacere e il dolore, cio con la sensazione. Allorquando interviene la morte, cessa la sensazione di dolore, quindi stolto temerla: finch viviamo la morte non c, mentre quando questa sopraggiunge noi non ci saremo pi. o Lo stoicismo di Zenone di Cizio (333-263 a. C.) e Cleante (304-232 a.C.), per quanto riguarda lambiente greco; Seneca (4 a.C.-65 d.C.), Epitteto (50-138 d.C.) e Marco Aurelio (121-180 d.C.) per lambiente romano: Il materialismo stoico non meccanicistico e areligioso come latomismo. Esso vitalistico; prevede la presenza del divino nel mondo. La concezione dellesistenza di unanima del mondo ripresa dal Timeo di Platone ed fusa con lilozoismo presocratico, secondo cui tutta la materia vivente.
Lanima del mondo pnuma, cio soffio vitale, fuoco creatore e, nello stesso tempo, razionalit interna ad ogni cosa, presenza divina. Lo spirito dunque intrinseco alla materia e questultima, a sua volta, portatrice di un ordine razionale e divino. Le anime umane ed animali sono punti di tensione dello pnuma universale. Nellanima umana la tensione raggiunge il suo culmine, manifestandosi come hegemonikn, cui confluiscono le informazioni dei sensi e da cui partono i comandi per i movimenti del corpo (conoscenza da parte degli stoici del funzionamento del sistema nervoso grazie alle scoperte della medicina ellenistica.) Le funzioni, strettamente legate, dellhegemonikn sono: Percezione Pensiero La riduzione a unit di percezione pensiero e la loro separazione dalle funzioni vitali avvicina la concezione della mente degli stoici a quella moderna del Self (autocoscienza). La concezione stoica dellanima interessante perch, pur essendo materialistica, non esclude la presenza del senso del divino, riunendo psicologia ed etica; e poi per la centralit{ conferita allio individuale (anticipazione del pensiero moderno).
1.5 La tarda antichit e il medioevo
Il neo-platonismo lultima grande filosofia dellantichit{. o Lepoca tardo antica, in cui il neo-platonismo rientra, si distingue dallEllenismo per la presenza di dellaffermarsi di movimenti religiosi e filosofie misticheggianti e per il trionfo del cristianesimo. o Plotino (205-270 d.C.) liniziatore del neo-platonismo. Il quarto libro delle sue Enneadi quello dove tratta il tema dellanima. Caratteristiche dellanima in Plotino: intermediaria tra mondo sensibile e mondo intellegibili. immortale e incorporea. Le anime individuali fanno parte dellAnima universale (anima mundi del Timeo platonico) con elementi dello pnuma degli stoici. Possibilit{ di ricongiungimento con lAnima e con lIntelletto divino (dove risiedono le forme, idee, archetipi di tutti le cose sensibili) delle anime tramite la ricerca di verit e altre forme di purificazione. Le anime possono fondersi con lUno (Dio), in fugaci momenti di estasi. o Novit di Plotino rispetto a Platone: Rispetto al dualismo platonico (mondo sensibile e mondo intellegibile sono due distinti piani di realt), in Plotino si ha un primo esempio di monismo immaterialistico (anticipatore dellidealismo moderno), i cui punti fondamentali sono: LUno lorigine unica di ogni realt{. Tutto in Dio e tutto promana direttamente o indirettamente da lui. Concetto di ipostasi, termine con cui sono indicate le tre sostanze del mondo intellegibile: Uno, Intelligenza e Anima. Tutte le cose derivano dallipostasi. Il corpo deriva dallanima. Maturazione del motto socratico Conosci te stesso: lanima giunge alla conoscenza distaccandosi dal mondo esterno e prendendo coscienza di se stessa (concetto di coscienza e di interiorit come base della conoscenza).
Aurelio Agostino (354-430 d.C.), visse tra i due momenti storici della fine dellantichit{ e linizio del medioevo. Egli il grande elaboratore e della teologia cristiana in cui confluiscono i pensieri di Platone e Plotino (come ad esempio lincorporeit{ dellanima che sar un elemento definitivamente acquisito dalla dottrina cristiana). Natura dellanima in Agostino, punti di straordinaria importanza per la filosofia moderna della mente: Il libero arbitrio. Libert{ di scelta delluomo tra il bene e il male tramite un atto di volont{; ci comporta lassunzione di responsabilit{ da parte delluomo. Autocoscienza. Dio pu essere trovato solo dentro di noi. Metafora della mente come spazio interno accessibile solo a se stessi. Dio pu essere ritrovato nella propria interiorit solo attraverso una presa di coscienza di s e della propria natura spirituale. In questo processo Dio stesso ci guida attraverso la sua grazia. La vera conoscenza possibile solo tramite questa illuminazione interiore e non tramite lesperienza sensibile. Caratteri dellanima in Agostino: Lanima umana una sostanza spirituale caratterizzata dalla consapevolezza di s. Anticipando Cartesio, Agostino afferma che lautocoscienza rende lanima certa della sua esistenza. Lanima unita al corpo tramite un imperscrutabile atto di Dio, ma si distingue perch immateriale e immortale. Il dualismo di Agostino pu essere considerato come il ponte tra quello antico di stampo platonico e quello moderno cartesiano. Tommaso dAquino (1225-1274). uno dei grandi interpreti di Aristotele, di cui cerca di conciliare alcuni aspetti della sua filosofia con i dogmi cristiani. Tommaso risolve alcuni problemi riguardo lanima a cui erano andati incontro i commentari arabi di Aristotele durante il medioevo: Se lanima la forma del corpo, come pu essere essa immortale? Soluzione: secondo linterpretazione di tomistica lintelletto (ossia lanima umana) distaccato dal corpo in quanto non ha bisogno di alcun organo corporeo particolare per esplicare la sua attivit (Tommaso sottovaluta, come Aristotele, la funzione del cervello). Conseguenza: poich lintelletto (ossia lanima umana) agisce per proprio conto senza bisogno del corpo, esso pu esistere indipendentemente dal corpo stesso. Per Tommaso, quindi, lanima una forma sussistente senza alcun supporto materiale (interpretazione spiritualistica dellilomorfismo). Per Tommaso esiste tuttavia un legame essenziale tra anima e corpo, dovuto allindividualit{ di ogni anima cui Dio associa un corpo particolare. Lintelletto umano, infatti, pu solo operare sulla base delle immagini fornite dai sensi (legati al corpo). Senza questo legame lanima non pu realizzare la conoscenza, che la sua finalit. In definitiva Tommaso cerca di tenere insieme due punti di vista: Limmortalit dellanima (possibilit{ dellanima di esistere senza il corpo) Lilomorfismo (legame tra forma e materia).
Questi due punti di vista permettono: Unantropologia e unepistemologia di tipo naturalistico: la mente deve essere studiata in rapporto al corpo (antropologia); la conoscenza, a differenza di Agostino, non deriva dallinteriorit{ ma dallesperienza (lato epistemologia). Una giustificazione della filosofia aristotelica di fronte al dogma cristiano della resurrezione della carne nel giorno del Giudizio Universale (laristotelismo si concilia con il cristianesimo meglio del dualismo platonico-agostiniano in quanto lanima deve ricongiungersi poi con il corpo). La teoria tomistica dellanima, forma del corpo ma autosussistente e immortale, rappresenta un compromesso tra il pensiero aristotelico (riscoperto nel secolo XIII) e laderenza ai dogmi della Chiesa.
Potrebbero piacerti anche
- L'ultimo PlatoneDocumento9 pagineL'ultimo Platoneclaudiastocchino100% (1)
- Etica Nicomachea - Aristotele - Libro Da 6 A 10Documento7 pagineEtica Nicomachea - Aristotele - Libro Da 6 A 10Mared'inverno AnimebluNessuna valutazione finora
- Fede e RagioneDocumento3 pagineFede e RagionegiuseppeNessuna valutazione finora
- Cronologia Dei FilosofiDocumento5 pagineCronologia Dei Filosofirossi_g_19706076Nessuna valutazione finora
- La Dottrina Delle IdeeDocumento5 pagineLa Dottrina Delle IdeeBris3iDe100% (2)
- Spirito, Anima, Persona dall'antichità greca ed ebraica al mondo cristiano contemporaneoDa EverandSpirito, Anima, Persona dall'antichità greca ed ebraica al mondo cristiano contemporaneoNessuna valutazione finora
- Enrico Berti Cristianesimo e Filosofia GrecaDocumento2 pagineEnrico Berti Cristianesimo e Filosofia GrecaraimpoNessuna valutazione finora
- Giusnaturalismo e Giuspositivismo Di N. BobbioDocumento12 pagineGiusnaturalismo e Giuspositivismo Di N. Bobbiobabe_mc100% (1)
- Filippo Bartolone / Cristianesimo e Filosofia in F.B.Documento4 pagineFilippo Bartolone / Cristianesimo e Filosofia in F.B.Enzo CiceroNessuna valutazione finora
- AristoteleDocumento53 pagineAristoteleAlessandro PasseraNessuna valutazione finora
- Un Profilo Dell'utilitarismo ClassicoDocumento140 pagineUn Profilo Dell'utilitarismo ClassicoGiuseppe BarrecaNessuna valutazione finora
- Del Mar Più Che Del Ciel Amante . Bruno e CusanoDocumento292 pagineDel Mar Più Che Del Ciel Amante . Bruno e CusanoJosé Manuel OsorioNessuna valutazione finora
- Alessandro Biral 1942 96 Corso 1990-91Documento42 pagineAlessandro Biral 1942 96 Corso 1990-91vitfilosNessuna valutazione finora
- Ordinamento GiuridicoDocumento3 pagineOrdinamento GiuridicoEla Rodriguez100% (1)
- Augusto Del Noce e Rene DescartesDocumento34 pagineAugusto Del Noce e Rene DescartesCarlos Daniel LasaNessuna valutazione finora
- SINTESI Di PLATONEDocumento17 pagineSINTESI Di PLATONEmattiasNessuna valutazione finora
- Costituzione Maurizio FioravantiDocumento26 pagineCostituzione Maurizio FioravantiAlessandroFinottoNessuna valutazione finora
- Riflessioni Su "Una Teoria Della Giustizia" Di John RawlsDocumento19 pagineRiflessioni Su "Una Teoria Della Giustizia" Di John RawlsBenessere ItaliaNessuna valutazione finora
- Sant'Agostino - Lo Spirito e La Lettera (ITA)Documento78 pagineSant'Agostino - Lo Spirito e La Lettera (ITA)PapeSatanAleppe100% (1)
- Dialoghi PlatoniciDocumento2 pagineDialoghi Platonicifreelancer861Nessuna valutazione finora
- SocrateDocumento1 paginaSocrateMariano De LucaNessuna valutazione finora
- Piero-Coda-Il Cristo Della Fede in Hegel PDFDocumento9 paginePiero-Coda-Il Cristo Della Fede in Hegel PDFbruno_mor33Nessuna valutazione finora
- Etica Di Aristotele PDFDocumento2 pagineEtica Di Aristotele PDFArunkumarNessuna valutazione finora
- Platone e La PoesiaDocumento5 paginePlatone e La PoesiaLoredana FinocchiaroNessuna valutazione finora
- Parmenide e Lorigine Della Nozione Di NullaDocumento35 pagineParmenide e Lorigine Della Nozione Di Nullamarvas100% (1)
- Manifesto Del LiberalsocialismoDocumento3 pagineManifesto Del LiberalsocialismocingomaxNessuna valutazione finora
- La Critica Di Hegel Al Cosmopolitismo Kantiano PDFDocumento12 pagineLa Critica Di Hegel Al Cosmopolitismo Kantiano PDFdiscepolo_7Nessuna valutazione finora
- Dorato, Mauro - Istituzioni Di Filosofia Della ScienzaDocumento70 pagineDorato, Mauro - Istituzioni Di Filosofia Della ScienzaRenato Degli EspostiNessuna valutazione finora
- Orfismo Misteri EleusiniDocumento15 pagineOrfismo Misteri EleusiniCiro IacominoNessuna valutazione finora
- Storia Della FilosofiaDocumento27 pagineStoria Della FilosofianirgunaNessuna valutazione finora
- Il Cristianesimo e La FilosofiaDocumento3 pagineIl Cristianesimo e La FilosofiaSonia PitNessuna valutazione finora
- Parmenide - Pasqualotto PDFDocumento30 pagineParmenide - Pasqualotto PDFAlessio Tovaglia100% (1)
- Massimo FERRARI, Cassirer, Natorp e L'immagine Di PlatoneDocumento29 pagineMassimo FERRARI, Cassirer, Natorp e L'immagine Di PlatoneargentazzuNessuna valutazione finora
- Potenza e AttoDocumento3 paginePotenza e Atto678tyughjNessuna valutazione finora
- Aristotele Intro All'etica Nicomachea Parte 2Documento28 pagineAristotele Intro All'etica Nicomachea Parte 2Alessandro PasseraNessuna valutazione finora
- Sintesi Metafisica - Mitchell PDFDocumento95 pagineSintesi Metafisica - Mitchell PDFAlessandro ReiNessuna valutazione finora
- Salvatore Giammusso - Antropologia Filosofica e Natura UmanaDocumento10 pagineSalvatore Giammusso - Antropologia Filosofica e Natura Umanaalfredo89Nessuna valutazione finora
- CAMPIONI, G. Eraclito Nella Filosofia Di NietzscheDocumento229 pagineCAMPIONI, G. Eraclito Nella Filosofia Di NietzscheuhogyrdsytkkfyuNessuna valutazione finora
- Platone, Il Rapporto Con Socrate e I Metodi Di ScritturaDocumento2 paginePlatone, Il Rapporto Con Socrate e I Metodi Di Scritturafrancyna93Nessuna valutazione finora
- Il Concetto Di Causa Nella Filosofia AnticaDocumento28 pagineIl Concetto Di Causa Nella Filosofia AnticaAlessandro PasseraNessuna valutazione finora
- I Filosofi Antichi Nel Pensiero Di Simone Weil e Hannah Arendt - Wanda TommasiDocumento9 pagineI Filosofi Antichi Nel Pensiero Di Simone Weil e Hannah Arendt - Wanda TommasiAndrea MontoyaNessuna valutazione finora
- Gesu Storico 0 PDFDocumento12 pagineGesu Storico 0 PDFGuidoneNessuna valutazione finora
- La Politia AristotelicaDocumento33 pagineLa Politia Aristotelicaargentazzu100% (1)
- Prezzolini - Amici, Vallecchi, Firenze 1922Documento166 paginePrezzolini - Amici, Vallecchi, Firenze 1922Fabio CiracìNessuna valutazione finora
- Sant'AgostinoDocumento3 pagineSant'AgostinoDavide LeonardiNessuna valutazione finora
- Storia Della Filosofia MedievaleDocumento21 pagineStoria Della Filosofia MedievaleGiulia Valentina RiccioniNessuna valutazione finora
- Giordano BrunoDocumento1 paginaGiordano Brunofedeg94Nessuna valutazione finora
- Severino AppuntiDocumento6 pagineSeverino AppuntiFrancesco NunziataNessuna valutazione finora
- Aristotele PsicologiaDocumento7 pagineAristotele PsicologiasuperciuchinoNessuna valutazione finora
- Enrico Berti I Miti in PlatoneDocumento2 pagineEnrico Berti I Miti in PlatoneraimpoNessuna valutazione finora
- L'arte Della Persuasione - PpsDocumento66 pagineL'arte Della Persuasione - PpslanaNessuna valutazione finora
- Corso Di Filosofia Della Religione PDFDocumento18 pagineCorso Di Filosofia Della Religione PDFcuba esquivel amadeoNessuna valutazione finora
- Bobbio KelsenDocumento25 pagineBobbio KelsenAnonymous 4L7zuPcaLNessuna valutazione finora
- Paganesimo e CristianesimoDocumento5 paginePaganesimo e Cristianesimobruno_mor33Nessuna valutazione finora
- Due Passaggi Sul Paradiso Di Dante - A.K. CoomaraswamyDocumento11 pagineDue Passaggi Sul Paradiso Di Dante - A.K. CoomaraswamyzucchettaNessuna valutazione finora
- (Libro) Attilio Mordini - La Via Del VerboDocumento8 pagine(Libro) Attilio Mordini - La Via Del VerboAnonymous JIc7R6Nessuna valutazione finora
- Dibattito - Addio Al Postmoderno - Micromega ApprofondimentoDocumento99 pagineDibattito - Addio Al Postmoderno - Micromega ApprofondimentoEmmanuele Jonathan PiliaNessuna valutazione finora
- Vitellaro Il Secondo Heidegger PDFDocumento20 pagineVitellaro Il Secondo Heidegger PDFCarla NatoliNessuna valutazione finora
- 20 Lezioni Di A - Piergiorgio OdifreddiDocumento618 pagine20 Lezioni Di A - Piergiorgio OdifreddiFilosofia Filosofare100% (1)
- Notiziario Dell'ecomuseo Della Tuscia - Nr. 3Documento4 pagineNotiziario Dell'ecomuseo Della Tuscia - Nr. 3Flavio FrezzaNessuna valutazione finora
- Venita Al Banchetto (Dio Ha Tanto Amato Il Mondo)Documento9 pagineVenita Al Banchetto (Dio Ha Tanto Amato Il Mondo)Max L.Nessuna valutazione finora
- Gen RossoDocumento32 pagineGen RossoGiovanni INessuna valutazione finora
- 109 NumerologiaDocumento1 pagina109 NumerologiaIerofanteNessuna valutazione finora