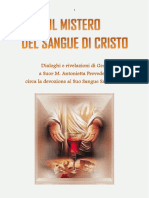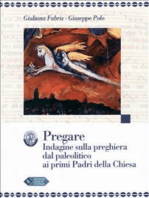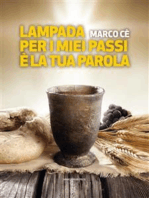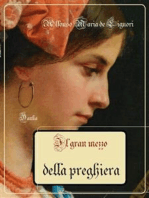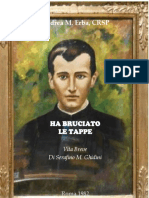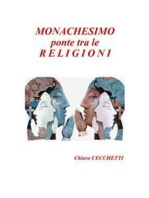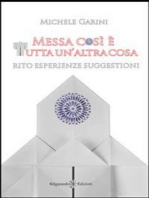Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
TISO - Desideri
TISO - Desideri
Caricato da
Marco PassavantiCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
TISO - Desideri
TISO - Desideri
Caricato da
Marco PassavantiCopyright:
Formati disponibili
Francis V. Tiso, Ph.D.
Ippolito Desideri e il dialogo interreligioso con il buddhismo vajrayana Forte dei Marmi, sera del 23 luglio 2009
1. Paragone del resoconto del Desideri sulla tolleranza, la piet, la curiosit dei tibetani, con la mia esperienza nel Dolpo, nel Kham, e nel Tibet centrale. I. DESIDERI, Relazione (MITN VI, DR.2, pp.80-81): Non solamente per lor genio affabile, cortese e domestico, ma oltre di ci per la politica, tanto i Thibetani quanto i Tartari (non per i Tartari di Giongr) son amanti de forestieri, co quali usano e riverenza e amorevolezza. [] Non per communemente permesso a forestieri laver casa propria (specialmente in Lhas), ma solamente labitare nelle case a nolo. Contuttoci il primo ministro e il re Cinghes Khang mi avevano conceduto, come a missionario europeo, licenza di comprar una casa grande e posta in un buon sito, quasi su la piazza di Lhas e nella strada principale detta del Khor. Cos ancora dopo la mia partenza [] i P.P. Cappuccini hanno ottenuto, comessi affermano, facolt di comperare un pezzo di terreno e di fabbricare in esso un lor ospizio. Permettono di pi a missionarj daver nelle loro case le cappelle e di celebrare in esse il Santo Sacrifizio della Messa. Anzi dimandano con somma instanza di potervi assistere. M succeduto molte volte, nel dar loro a intendere che cosa rappresentasse limmagine del Crocifisso, di vederli, prostrati a terra, non solamente far adorazione al Divin Salvatore, ma battersi divotamente il petto, e domandando daver la Sacra Immagine nelle mani, con molto affetto baciarla e tutta bagnarla di lacrime, per un gran sentimento eccitatone loro cuori dalludire che Nostro Signor Gies Cristo, che rappresentato in quella, ha tanto patito e sofferto per la redenzione delle loro anime. Spessissimo ancora ero costretto dalle efficacissime instanze che mi facevano a permetter loro dintervenire alla Santa Messa, ed era cosa che compungeva il vederli tutto quel tempo stare inginocchiati in terra con le mani giunte e con molta attenzione. Talvolta alcuni di essi portavano profumi, pregando che si facessero ardere sopra laltare. N solamente mi permettevano luso della cappella dentro la mia casa di Lhas ma ancora quando abitavo nel loro Gran convento e universit di Ser, avevo quivi la mia cappella, dove concorrevano e facevano tutto il qui 1
esposto molti religiosi, anche dottori e qualificati e di grande autorit fra di loro. A tutto ci conferisce molto la stima che hanno concepito de Missionarij Europei, considerandoli e riconoscendoli per Lama, cio non solamente per Religiosi che hanno rinunziato al mondo e come dottori che hanno acquistato le scienze, ma come maestri e direttori spirituali, che spontaneamente si son dedicati a questo ministero e a tutti i travagli ad esso annessi per il motivo di ritirar glaltri daglerrori e dal male e di guidargli e condurgli al bene e alleterna felicit. Questi tre sono appresso i Thibettani le constituzioni essenziali dun vero Lama. F. TISO, Just This Side of Tibet (1999), 23 maggio 1997, a Samten Ling, gompa di Tarakot, nel Dolpo inferiore. Qui tutti sono "lama" e fanno la pj, sia uomini che donne. Ho celebrato la S. Messa stamattina in ringraziamento a Sant'Antonio per l'aiuto nel ritrovare la tenda perduta lungo la pista qualche giorno fa, e per l'alacrit del Nabin Gurung in quelle circostanze di grande pericolo. Era forse la prima S. Messa cattolica mai celebrata nel Dolpo. Dal momento che tutta la gente qui prega spesso e molto, e si affida in ogni momento ai riti, non ci sorprende che gli abitanti del gompa (sul tetto del quale abbiamo messo il nostro accampamento), fossero affascinati dalla mia S. Messa. Guardavano dal cortile, felicissimi. Ho spiegato che stavo pregando per una benedizione sull'intera casa e i suoi abitanti, per i vivi e per i morti. In modo particolare, apprezzavano il canto: ho usato i canti liturgici in latino con le melodie gregoriane, cose facili che potevo cantare a memoria. "E' un lama come noi" hanno detto. S, qui abbiamo l' Issu Lama, il Lama di Ges (perch conoscono qualcosa del cristianesimo). Ho capito pi tardi che, per loro, la maggior parte degli europei sono "barbari" senza religione, senza spiritualit, materialisti e spesso (anche i giovani "trekkers", purtroppo) sfruttatori. Trovare un lama occidentale era un vero sollievo per questo popolo portato piuttosto a pensare bene degli altri: "Ah, anche loro hanno una cultura, una religione, anche il canto sacro meno male, non sono del tutto ignoranti e sfortunati come abbiamo temuto". Un episodio simile accadeva vicino un grande ponte dove ubicato un grande chorten (= stpa) consacrato a Padmasabhava (Guru Rinpoche). Stavo celebrando la S. Messa all'aperto, seduto in postura di loto davanti a un piccolo altare costruito sul posto con delle pietre. Mentre pregavo, passavano alcuni dei Lama locali portando sulle spalle i famosi tamburini a doppia testa per il rito del chd, che di solito qui si usa in suffragio dei morti. Bastava un sorriso di comprensione scambievole accompagnato da un saluto caloroso con la mano destra, e continuavano il cammino con cuori liberi e gioiosi e volti irraggianti. Nella spedizione del 2000, sempre nel Dolpo, c'era un rito al bodhisattva Vajrasattva il trentesimo giorno dopo la morte di un bambino, figlio di uno dei lama. Tutti i lama della vallata Tarap, compreso il 2
sottoscritto, furono invitati alla cerimonia, recitata interamente dagli antichi libri scritti in maiuscole tibetane. Dopo questo rito, sono salito sul tetto con un compagno (uno studente cattolico dall'Universit statale Humboldt, in California) per celebrare l'Eucaristia. Compiuto il rito della S. Messa, successo uno di quei segni e meraviglie da cui parla il Nuovo Testamento. Nel cielo, visibile per tutta la vallata, ci furono due arcobaleni accompagnati da poche nuvole segno evidente a tutti che i due riti furono ugualmente efficaci; la natura stessa ha comunicato il messaggio del divino gradimento. Il mio gruppo di ricerca (in quell'anno stavamo raccogliendo dati sulle thangka dei sette gompa della Tarap Valley) mi riferiva la gioia sulle labbra di tutti gli abitanti all'altro lato della vallata, perch erano tutti informati sui due riti. Sulla base di queste esperienze sono tuttora in buoni rapporti con gli abitanti del Tarap-Dho; ho mandato qualche sostegno al progetto di una clinica di medicina tradizionale al Ri-'bum Gompa e rimaniamo in contatto per posta elettronica quando Lama Namgyal si trova a Kathmandu. 2. Il contenuto del dialogo interreligioso; il valore delle idee e della comprensione scambievole come fondamento indispensabile per eventuali collaborazioni. L'importanza del dialogo come fonte dell'amicizia, o almeno di reciproco conoscenza. Importanza che i leader delle comunit religiose si conoscano attraverso gli anni, se fosse possibile, dal periodo della formazione accademica. Un cenno sul mio itinerario personale: ho incominciato con un primo discorso [sull'evoluzione biologica in prospettiva teologica cristiana] alla scuola catechetica dei luterani del mio paese all'et di sedici anni. Poi alla Cornell University, facevo parte del gruppo di ospitalit per i predicatori di ogni religione invitati alla cappella universitaria nel periodo 1968-1972. A Cornell ho avuto modo di conoscere parecchie persone di altre religioni e per fare lunghi dibattiti con loro in quei tempi di grande fermento politico e culturale. Alla Cornell University, ho conosciuto il mio padre spirituale, dom David Steindl-Rast, benedettino, uno dei grandi pionieri del dialogo con il buddhismo zen; ho passato molti giorni di ritiro nel suo monastero non lontano dall'universit. Gi nei primi mesi del seminario, ho scritto sulle questioni riguardanti il dialogo interreligioso. Lasciando il seminario cattolico (dove non ero particolarmente "gradito" a certi dei miei superiori! ironicamente, ora sono gradito e ci sono andato spesso per vari incontri ecumenici o semplicemente per amicizia), ho compiuto la laurea in teologia alla Harvard University, ove ho studiato gli aspetti teorici del dialogo inter-religioso con il professore George Rupp e con l'inimitabile professore Harvey Cox, il quale tuttora rimane un caro amico e fonte di tante idee utili sia per l'ecumenismo che per il dialogo inter-religioso. Per due anni dopo la laurea, cercavo di approfondire lo studio con la pratica della vita monastica presso la Grangia benedettina con padre John Giuliano e dom David Steindl-Rast. In quel periodo, abbiamo fatto diversi incontri soprattutto con i buddhisti zen e i sufi. Compiuta la formazione, ho trovato un posto di lavoro presso la casa editrice 3
teologica "Seabury Press" a Manhattan, a due passi dall'ONU. Seabury era un centro del dialogo inter-religioso ed ecumenico all'epoca e ho potuto conoscervi tantissime persone sia nell'ambito accademico che nel mondo delle ONG. Oggi va di modo per i giovani a fare gli "internships" (tirocinio non rimunerato) presso queste ONG, per rinforzare il proprio curriculum vitae. Non potrei sottolineare mai abbastanza l'importanza di queste esperienze per i giovani che aspirano al "leadership" in qualsiasi professione, perch viviamo in un mondo multi-culturale dove le interfacce sono numerose e gli incontri tra persone esigono sempre pi una conoscenza degli altri e delle loro idee. Dopo l'esperienza di Seabury, ove ho fatto pubblicare le edizioni americane delle opere di Marco Pallis, del padre Yves Congar, del canonico Alan Jones, dei gesuiti Barry e Connolly (ora quel libro sulla direzione spirituale si trova dappertutto tra quelli che fanno questo ministero), e di vari altri, ho vinto una borsa di studio per completare il dottorato di ricerca alla Columbia University sotto l'indimenticabile Alex Wayman, traduttore delle opere di Je Tsong Kha pa e figura di perenne controversie. Ho scritto la dissertazione sulle pi antiche versioni della biografia di Milarepa, grande figura di santit nel buddhismo vajrayna, ispiratore di una cultura poetica e yoghica nel Tibet, e uno dei fondatori dell'ordine dei kagyupa. Ho tradotto due antiche agiografie del "Mila rnam thar" mai conosciute e completamente trascurate dagli studiosi; ora grazie a Carla Gianotti, l"UTET ha pubblicato una nuova traduzione italiana della biografia di Milarepa scritta dal grande "Yoghi Matto" gTsang smyon Heruka attorno a 1500; nella sua introduzione al testo, la Gianotti fa generosi riferimenti al mio lavoro, che finora non ho potuto pubblicare in italiano (lei ha usato un testo inedito nella biblioteca del Centro Milarepa a Torino). Per riassumere lattivit degli anni '90, sono stato in Italia come sacerdote della diocesi di Isernia-Venafro, collaborando fuori diocesi con i PP. PIME, i PP. benedettini, e il PCID per promuovere una conoscenza sana e teologicamente salda delle altre religioni e del dialogo. Sono stato a Taiwan nel 1995 con S. Eminenza cardinale Francis Arinze per l'incontro con le varie scuole del buddhismo; con i benedettini in India nel 1992; in sabbatico in Nepal nel 1997; la spedizione sui thangha nel 2000 e sempre nel 2000 in Tibet orientale per ricercare un caso del corpo di arcobaleno (Khenpo A-chs). Nel 1998, tornai negli USA per un periodo di aggiornamento pastorale mentre si completavano i lavori anti-sismici all'eremo dei SS. Cosma e Damiano a Isernia. Una cosa port a un'altra, e inizialmente fui invitato dall'arcivescovo di San Francisco mons. William Levada (attualmente cardinale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede della Santa sede) ad aiutare in una parrocchia gravemente polarizzata e poi incaricato di riorganizzare l'associazione degli studenti cattolici alla San Francisco State University. Come sempre sviluppai moltissimi contatti con i partner ecumenici ed inter-religiosi nel mondo multi-culturale della California e fui nominato alla commissione per il dialogo con le comunit 4
zen e ch'an. Dopo un anno, fui nominato Direttore associato del Segretariato per l'ecumenismo e il dialogo inter-religioso della Conferenza episcopale dei vescovi cattolici degli USA (USCCB) a Washington, DC, incarico che ho coperto per cinque anni. Il nostro lavoro abbracciava sia il dialogo con gli altri cristiani (in modo particolare per me, i Riformati, cio i Calvinisti) sia con le altre religioni: con i buddhisti, gli ind, i sikh, gli ebrei, e i musulmani. Convocavo riunioni, scrissi documenti, pubblicavo articoli, valutavo la teologia dei colleghi professori, svolgevo consulenze per i vescovi, guidavo la formazione dei delegati diocesani per il dialogo, e mantenevo una vasta corrispondenza tramite posta elettronica. Il nostro segretariato si occupava molto delle problematiche del dialogo con un approccio sia critico dal punto di visto teologico, sia in una prospettiva pragmatica. Per esempio, c' il problema del "dialogo" gestito da persone che non sono rappresentanti di una consistente comunit religiosa o culturale, oppure da persone che hanno poco conoscenza delle religioni (anche di quella propria!), oppure da quelli che hanno lo scopo del proselitismo, oppure da quelli che vedono tutto il bello dell'altro e niente di bello nel suo ecc. Perci, nel mio lavoro alla Conferenza episcopale, ho dato molta importanza all' approccio di "antropologia culturale" nel metodo scientifico delle mie ricerche nellAsia meridionale e in Estremo Oriente, ovviamente temperato con la critica strettamente teologica. Potrei commentare in modo assai esteso sul collegamento tra la teologia dei documenti del Concilio Vaticano II e la pratica attuale del dialogo inter-religioso sia nella Chiesa cattolica che negli altri ambienti, ma preferisco fornirvi alcune osservazioni dalla ricerca nel Dolpo, regione al nord della montagna Dhaulagiri, sui confini con il Tibet occidentale: 27 maggio 1997. Vallata del Fiume Tarap. La religione del Dolpo, sia il vajrayna buddhista (chs pa)
sia il vajrayna bn po, consiste dei seguenti elementi: - esperienza mistica personale e auto-conoscenza coltivate in lunghi ritiri attraverso l'intero percorso della vita delle persone; - culto di varie divinit, ognuna delle quali ha un suo ruolo pratico per la gente comune, quel che qualcuno forse chiamerebbe 'superstizione' ha per anche la capacit di affrettare il raggiungimento della piena illuminazione, cio della buddhit; - il virtuoso religioso per eccellenza il Lama, il quale non soltanto uno specialista per i riti e per gli insegnamenti, ma ha anche acquistato il potere spirituale attraverso la pratica assidua del culto tantrico degli di, facendo i loro rispettivi yoga durante i lunghi periodi di ritiro; in tal modo, i suoi riti sono non soltanto belli, ma efficaci; - cura medica nella tradizione tibetana del menzikhang (centro per la medicina e per l'astrologia); - cultura "folcloristica" dell'arte, della musica, dell'astrologia, del calendario, dei miti, ecc.; - pratica regolare della divinazione soprattutto attraverso il "mo" - cio l'uso del mala come fonte di 5
numerologia, ma anche attraverso i sogni ed altri "segni" (il volo degli uccelli, ecc.); - esorcismo e eliminazione degli ostacoli (cio togliere le fatture, le maledizioni, ecc.): il ngag pa (sanscrito: mantrika, praticante dei mantra) sempre una specie di mago o santone professionista; - cura dei luoghi sacri, ad esempio i templi curati dalle famiglie che fanno da generazione a generazione i lama ereditari. Importante ricordare che i laici diventano lama oppure ngag pa attraverso l'intensa pratica del ritiro. Nel Dolpo inferiore non ci sono monasteri dei gelong classici del buddhismo tibetano (ci sono nel Dolpo superiore) e sono pochi quelli che scelgono il celibato (tra pa). Il gompa di solito un affare di famiglia, un focolare nel senso vero della parola. Troviamo quindi analogia alla cultura dei guaritori e dei santoni che caratterizzano altri luoghi, ma apparentemente senza le polemiche e i contrasti con il clero monastico, i sacerdoti, i ministri e i rappresentanti del governo. L'autorit si basa sul lignaggio della trasmissione da maestro a discepolo, l'efficacia sentita dei riti celebrati dal singolo lama, e la pratica del ritiro (ad esempio, in cicli di tre anni, tre mesi e tre giorni, spesso ripetuti; il primo ritiro di solito si compie in adolescenza, chiudendosi in una stanza superiore della casa, che funge sempre come tempio; altri ritiri si possono fare in grotte locali oppure in centri di ritiro appositi). 3. Il nostro Segretariato ha dato molto rilievo all'ideale del servizio alle comunit religiose: scopo del dialogo; servizio all'umanit: scopo inscindibile del dialogo tra comunit. Esempio: assistenza alle vittime di eventi catastrofici, collaborazione nelle opere di misericordia. Per, il motivo per questo tipo di servizio diverso tra una religione e un'altra, e i motivi vanno rispettati, altrimenti facciamo troppo in fretta una "traduzione" dell'altro in termini nostri, senza rispettare la soteriologia ed altre caratteristiche dell'altro negandogli la sua vera identit e dignit. Esempio: si presume che il buddhismo sia una religione "ecologica" e lo , come sottoprodotto, ma non come scopo principale. Confondere il rapporto tra l'uomo e la natura nel sistema buddhista dimostra una mancanza di rispetto per elementi fondamentali di quella dottrina; significa non "ascoltare" il partner nel dialogo. Altro esempio diffusissimo, al quale sono stato messo in guardia dal mio grande direttore di tesi del dottorato, Alex Wayman, la tendenza di tradurre le parole chiave del buddhismo in maniera falsificante. Dappertutto si parla delle "Quattro nobili verit" ma in realt la parola sanscrita "caturaryasatya" viene spiegato come "le quattro verit che appartengono agli rya" cio, riferisce alle quattro verit al cuore della dottrina buddhista le quali sono riconosciute, raggiunte, intese e spiegate solo da chi le ha realizzate attraverso la pratica della meditazione e l'esperienza dell'illuminazione cio dagli rya, i santi, gli illuminati; per la gente comune, queste verit non sono particolarmente chiare, conosciute, apprezzate ed abbracciate! Ma forse per un falso rispetto per la democrazia e l'uguaglianza sociale, sembra pi proficuo parlare di quattro verit che sono 6
apparentemente "sublimi" e non distinguere tra vari tipi di persone. Ma in realt, tutto il buddhismo si fondato sull'idea che ci sono due tipi di persone, quelli che hanno raggiunto lo scopo dell'esistenza umana, e quelli che sono ancora nella confusione mentale. 4. Tra il buddhismo e il cattolicesimo: contrasto tra le due escatologie e quindi tra le due soteriologie. Cosa significa escatologia? Quel che si propone come scopo della vita umana in vista dello stato eterno della persona umana. Cosa significa la soteriologia: la dottrina della salvezza, (soteria, in greco), sia sotto l'aspetto del fine ultimo, sia sotto l'aspetto del cammino per raggiungerlo. Molto interessante rilevare, per, che dalla mia esperienza in Himalaya, sia nel 1997 sia nel 2000, risulta come l'ambiente stesso abbia un effetto sul cambiamento, sulla trasformazione, spirituale/interiore; cominciamo cos a capire come sia possibile sfruttare alcuni metodi per riscoprire elementi quasi scomparsi della nostra tradizione contemplativa cattolica. Un estratto dal mio diario di viaggio:
F. V. TISO, Just This Side of Tibet (1999, inedito): 16 maggio 1997, in campeggio a 2500 metri, sulla pianura "Phagorne". Dopo una breve seduta di preghiera, aumentava la velocit del vento e alle 7 e 52 prendevamo la strada accompagnati da un cavallo di nome "Thur-ri" portando 50 kg con noi. Fa bel tempo per il trekking: fresco, ventilato, e parzialmente nuvoloso. Sempre con un panorama splendido, ruscelli freddi e sorgenti purissime. Una grande quantit di rododendri e una specie di lilla di colore pi rosa che lavanda e meno profumata di quella coltivata da noi. Ho raccolto anche una quantit di achillea per uso medicinale. Iniziava subito l'ascesa verso un passo oltre 4500 metri sul livello del mare. Ero davvero incapace di farcela col mio zaino, e quindi come un vero guerriero gurkha, il bravissimo Nabin Gurung ha messo la mia roba in testa ed ha ripreso il cammino. Con l'aiuto di Jamphel, ho raggiunto il passo dopo due ore di salita dolorosissima. Poi, altre due ore per arrivare al meraviglioso luogo di campeggio. Lungo la pista, ho avuto forti esperienze interiori: intuiti, lacrime, riflessioni esistenziali sul mistero della Santissima Trinit (ad esempio: il paradosso tra movimento e stasi dentro le processioni delle Persone Divine), comprensione del significato dell'ascetismo e della rinuncia per motivi spirituali, e una bellissima visualizzazione della lettera A dentro una goccia luminosa (A-tigl) dei colori dell'arcobaleno, ed altre ancora. Le lacrime scaturivano quando ho meditato in gratitudine per i miei genitori; ho capito anche la gentilezza e la severit attraverso gli anni di formazione ai piedi del mio maestro dom Davide il benedettino ho avuto un fortissimo desiderio di vederlo di nuovo nella sua vecchiaia. Il vero guru, archetipo del monaco e maestro padre-e-madre nelle visualizzazioni tantriche. Mi ricordo molto forte il 7
momento di realizzazione diretta della piena e libera consapevolezza mentre lo vedevo, nel 1979, tagliare la legna con la sega in mano: la sua focalizzazione intensa come fu dura la legna. Non molto tempo dopo, ho avuto anch'io la stessa esperienza di assorbimento contemplativo mentre segava la legna, perdendomi nel ritmo del lavoro manuale. La "A-tigl" visualizzata mi ha aiutato molte volte durante la salita del passo. Una volta ho sentito la sensazione dell'infuocare del calore yoghico, cio del famoso gtummo che il grande Milarepa usava per stare bene nelle grotte del Tibet durante i suoi lunghi ritiri invernali. Ho avuto anche scintille di luce in forma delle sfere colorate come i cinque elementi (indaco, verde, bianco, rosso e giallo). In queste altezze ovviamente molto pi facile fare le visualizzazioni del genere, e anche i canti vengono direttamente dal cuore. Davanti ai rododendri, ho cantato l'inno alla Madonna di Lourdes: "The cause of joy to men below" con grande emozione; pi tardi, un inno anglicano con parecchie Alleluia per le processioni pasquali. Al chorten "la-tse" (pinnacolo della montagna), ho cantato il Regina Coeli mentre la guida Norbu vi metteva un khatak, urlando estaticamente. Per quanto riguarda la Santissima Trinit, ho visto in un attimo la profondit della perichoresi la danza circolare ed eterna delle Tre Persone, come Dante nel XXXIII canto del Paradiso. E' una quiete eterna che stranamente "danza" insieme con la gnosi e l'agape; l'ordine infinito che si esprime nella spontaneit del formarsi degli elementi dell'universo. Mi tornava in mente la mia meditazione di qualche settimana prima presso il fiume Kaligandaki mentre l'amico Song-la riposava in un campo di cannabis e io, con l'apparecchio fotografico, prendevo le immagini delle pietre del fiume, impregnate di granato rosso, di micascisto, e di quarzo in forme spesso spiraleggianti, ognuna con il suo riflesso del momento primordiale della creazione, ognuna con l'evidenza della pi recente limatura nella sabbia del grande fiume. I granati sono distribuiti con una stranissima regolarit, come avessero un messaggio da comunicare, chiss perch? Grandi piegature, e larghe strisce, in cui interagiscono insieme casualit ed ordine. Si pu spiegare per mezzo della geologia, della fisica e della chimica, ma anche quella spiegazione sarebbe una rivelazione, come lo pure la storia scientifica della formazione dell'universo, come la conosciamo oggi per la prima volta nella storia umana. Ma io, come il filosofo francescano San Bonaventura, sono interessato al messaggio che si svela dentro le cose create una specie dell'Itinerarium mentis ad Deum e altrove. Mi riporta alla memoria l'idea del mistico Jacob Bhme e la "siglatura di ogni cosa" che ha cos affascinato mio professore Alex Wayman alla Columbia University. E' nella sua semplicit il messaggio dello yin e dello yang, del calore e del freddo, della struttura energetica nascosta nei fenomeni naturali (come per esempio la sezione aurea): quelle cose che suggeriscono in "macro" quel che succedeva all'inizio in "micro" quando l'intero universo era incredibilmente caldo e denso. Tutto ci 8
lo vedevo nelle pietre e ora lo vedo nella mia memoria, e mi vengono delle intuizioni sulla danza circolare della Trinit, cos' e cosa significa. Perch ho l'idea che se la Sindone di Torino una "foto" della Resurrezione, cos queste pietre e queste montagne sono delle foto del momento primordiale della Creazione stessa. Il Nome Divino si trova scritto e sigillato dappertutto. E' una danza, la Gnosi! Nel Vangelo di Giovanni, troviamo questa parola greca molte volte e si tratta di come il Padre e il Figlio stanno prodigandosi affinch queste "scimmie" (noi cosiddetti Homo sapiens ...) scelte per diventare i sacerdoti di tutto il creato partecipino a questa grande celebrazione dell'Essere. Attraverso l'agape, raggiungiamo la gnosis, e dalla gnosis saliamo verso la koinonia! La rinuncia si incarna in questo pesantissimo trekking! Assomiglia alle antiche pratiche ascetiche dei santi, cose che ho sempre pensato di essere al di l della mia capacit. Forse ora avr la purificazione desiderata e necessaria: camminando e salendo, completo la pratica preliminare antecedente all'accesso ai tantra pi esigenti e sublimi. Il digiuno si fa facilmente con quest'orrendo dhal bhat, denso e disgustoso come la colla. La veglia si fa con questa intensissima attenzione mentre si cammina, e anche durante le notti in cui non si riesce a prendere sonno, sdraiato nel sacco a pelo sul pavimento roccioso di una grotta. L'Himalaya ci impone e insegna lezioni dure. Un passo sbagliato e si entra nel "bardo" subito! Quelli che bisticciano su roba da niente sulle isole, sulla pianura, sulle costiere, non trovano posto qui in alto. Qui si trova un'economia delle parole, dei sentimenti, della stessa verit. Ogni tanto, per, mi scappa qualche lunga lezione magistrale, e la assorbe tutta il caro compagno americano, Bob. Maggiormente, per, tutta questa va al di l di Ngrjuna, oltre il vuoto del vuoto. L'altezza ci mette in uno stato alterato della consapevolezza, e finalmente le cose vengono viste come sono, con chiarezza esistenziale, e non come nella bassa pianura, o nei conventi accoglienti e comodi. Il pensiero libero, selvaggio, proibito qui ha senso, e diventa chiaro, puro, limpido come il cielo. 5. Cosa possiamo imparare dal buddhismo vajrayna, e dall'esperienza storica del Tibet? Il viaggio del missionario-esploratore Ippolito Desideri ci ha lasciato qualche lezione ancora rilevante? A mio avviso, si possono elencare alcune cose di grande valore che sono state approfondite dal buddhismo. Esempi: a) l'unit del corpo e della mente nell'esperienza dell'illuminazione, comprendente anche il concetto dei cakra, i canali energetici, e il flusso dell'energia vitale nel corpo (cosiddetto pra, per convenientemente distinto dalla "pranoterapia"); b) l'importanza dell'armonia tra la ricerca filosofica e la ricerca per la liberazione spirituale: l'una sostiene l'altra; c) il ritiro, anche prolungato, come mezzo indispensabile per raggiungere lo scopo della vita spirituale; 9
d) il ruolo indispensabile del maestro spirituale, il direttore spirituale, e lo stile di un vero maestro della vita spirituale; e) lopportunit di entrare nel cammino spirituale anche da molto giovani; la vita spirituale come vera e propria professione, un'arte da imparare con ogni fibra delle forze umane. Quindi, hanno ancora valore i seminari minori, anche se questo non va pi di moda ...; f) la possibilit di fare la vita spirituale come famiglia e in famiglia, trasmettendo l'arte di generazione in generazione, in armonia (anzich in contrasto) con il monachesimo e il celibato sacerdotale. g) lapprendimento dal dialogo stesso che ogni scoperta umana vive in reciprocit con altre scoperte, comprese anche quelle spirituali; quindi l'esclusione delle verit altrui modo sicuro per indebolire la verit propria, cio del proprio sistema soteriologico, come diceva l'Imperatore Aoka nel terzo secolo avanti Cristo. Penso che quel che ha scoperto padre Desideri rimane un fondamento ancora molto utile e rilevante per un dialogo fecondo tra cristiani e buddhisti. Inoltre, direi, tale dialogo perch oggi soprattutto in Occidente spesso accade tra persone della stessa formazione accademica diventa fonte di metodologie e scoperte che rendono pi efficaci i dialoghi con altre religioni, che in certi casi sono prevalentemente presenti nelle comunit di formazione straniera (ad esempio quelle musulmane). Si formulano le problematiche in modo compatibile, cos agevolando la comprensione scambievole. Si va al profondo, soprattutto nel parlare dell'esperienza interiore del credente. Si d la giusta misura di importanza all'ascolto, alla conoscenza scambievole, al rispetto per l'integrit del sistema filosofico-soteriologico altrui. Spero che molto presto possiamo condividere il cammino spirituale!
10
Potrebbero piacerti anche
- Marco Frisina - RaccoltaDocumento46 pagineMarco Frisina - RaccoltaFamigliaRusso75% (4)
- Stein Edith - La Mistica Della Croce. Scritti Spirituali Sul Senso Della VitaDocumento66 pagineStein Edith - La Mistica Della Croce. Scritti Spirituali Sul Senso Della Vitamel martigan100% (1)
- Comunicazione e Propaganda. Il Ruolo Dei Media Nella Formazione Dell'Opinione PubblicaDocumento218 pagineComunicazione e Propaganda. Il Ruolo Dei Media Nella Formazione Dell'Opinione PubblicaMassimo Ragnedda100% (2)
- La Gnosi Cristiana: Le verità nascoste dei Vangeli, dei Mistici e del Cristo-LogosDa EverandLa Gnosi Cristiana: Le verità nascoste dei Vangeli, dei Mistici e del Cristo-LogosNessuna valutazione finora
- [La Bibbia Commentata Dai Padri] Thomas C. Oden, Angelo Di Berardino, Sever J. Voicu - La Bibbia Commentata Dai Padri. Antico Testamento_ Tobia. Sapienza. Siracide. Baruc. Aggiunte a Daniele Vol. 5(2016, Città Nuova)Documento632 pagine[La Bibbia Commentata Dai Padri] Thomas C. Oden, Angelo Di Berardino, Sever J. Voicu - La Bibbia Commentata Dai Padri. Antico Testamento_ Tobia. Sapienza. Siracide. Baruc. Aggiunte a Daniele Vol. 5(2016, Città Nuova)TipoTipo100% (4)
- La Preghiera InterioreDocumento36 pagineLa Preghiera InterioreCalogero CusumanoNessuna valutazione finora
- Talmud EbraicoDocumento47 pagineTalmud EbraicoRaffaella0% (1)
- Breviario Redentorista 2006Documento200 pagineBreviario Redentorista 2006Rodhrigo LinsNessuna valutazione finora
- Storia di un' anima: Edizione critica a cura di Alessandro e Ilario MessinaDa EverandStoria di un' anima: Edizione critica a cura di Alessandro e Ilario MessinaNessuna valutazione finora
- Gallo Don A. - Il Vangelo Di Un UtopistaDocumento20 pagineGallo Don A. - Il Vangelo Di Un Utopistababe_mcNessuna valutazione finora
- 0600 Von Balthasar - Abbattere I Bastioni 2021-12-06 18 - 10 - 24Documento117 pagine0600 Von Balthasar - Abbattere I Bastioni 2021-12-06 18 - 10 - 24DanielNessuna valutazione finora
- Hugo Rahner - Mater EcclesiaDocumento78 pagineHugo Rahner - Mater EcclesiaGabriele Galleri100% (1)
- Il Mistero Del Sangue Di CristoDocumento643 pagineIl Mistero Del Sangue Di CristoCatyNessuna valutazione finora
- PREGARE Indagine sulla preghiera dal paleolitico ai primi Padri della ChiesaDa EverandPREGARE Indagine sulla preghiera dal paleolitico ai primi Padri della ChiesaNessuna valutazione finora
- Bartolucci - Alleluia Euntes in MundumDocumento6 pagineBartolucci - Alleluia Euntes in MundumGuido MenestrinaNessuna valutazione finora
- Dalla Mia Vita Pietro Archiati PDFDocumento36 pagineDalla Mia Vita Pietro Archiati PDFAnonymous xIi1uNlBJNessuna valutazione finora
- Agostino D'ipponaDocumento23 pagineAgostino D'ipponaGian Clau100% (2)
- Gnoli Ricordo Di TucciDocumento20 pagineGnoli Ricordo Di TucciMarco PassavantiNessuna valutazione finora
- La Madonna Della CornabusaDocumento45 pagineLa Madonna Della CornabusaMaatStarchildNessuna valutazione finora
- Fraternità Padri Del Deserto StincheDocumento27 pagineFraternità Padri Del Deserto StincheChiaraNessuna valutazione finora
- Il pensiero antropologico ed etico rosminiano negli scritti di Pietro AddanteDa EverandIl pensiero antropologico ed etico rosminiano negli scritti di Pietro AddanteNessuna valutazione finora
- Quando Il Maestro Parla Al CuoreDocumento77 pagineQuando Il Maestro Parla Al Cuoreapi-254303213Nessuna valutazione finora
- G. TOMASELLI BiografiaDocumento52 pagineG. TOMASELLI Biografiavincenzo,castelliNessuna valutazione finora
- Voce Amica2013 6Documento24 pagineVoce Amica2013 6ladydaladyNessuna valutazione finora
- Il Servo Di Dio Mons. Raffaele Dimiccoli Promotore Dei Laici ApostolatoDocumento26 pagineIl Servo Di Dio Mons. Raffaele Dimiccoli Promotore Dei Laici ApostolatopianetainpreghieraNessuna valutazione finora
- Il Vangelo Di Don BoscoDocumento14 pagineIl Vangelo Di Don BoscoAnte PeharNessuna valutazione finora
- Sorella Angela MusolesiDocumento4 pagineSorella Angela MusolesiGamp GampNessuna valutazione finora
- Rionfo Del Uore: PDF - Famiglia Di Maria Gennaio - Febbraio 2017 N 41Documento21 pagineRionfo Del Uore: PDF - Famiglia Di Maria Gennaio - Febbraio 2017 N 41Fr. DLMNessuna valutazione finora
- Intervista Con Angelo MontonatiDocumento8 pagineIntervista Con Angelo MontonatiAngelic Sisters of St. PaulNessuna valutazione finora
- Santa Teresa Benedetta Della CroceDocumento3 pagineSanta Teresa Benedetta Della Croceemmedi1979Nessuna valutazione finora
- Dossetti e Le Querce Di Monte Sole Di Luciano Gherardi, 1997Documento6 pagineDossetti e Le Querce Di Monte Sole Di Luciano Gherardi, 1997lupocanutoNessuna valutazione finora
- Ha Bruciato Le Tappe: Vita Breve Di Serafino GhidiniDocumento35 pagineHa Bruciato Le Tappe: Vita Breve Di Serafino GhidiniBarnabite PublicationsNessuna valutazione finora
- Frédéric Manns - Gesù Figlio Di Davide. Il Vangelo Nel Suo Contesto Giudaico-Ancora (1998)Documento248 pagineFrédéric Manns - Gesù Figlio Di Davide. Il Vangelo Nel Suo Contesto Giudaico-Ancora (1998)Veronica GoianNessuna valutazione finora
- Cristianesimo Mistico: Gli insegnamenti interiori del MaestroDa EverandCristianesimo Mistico: Gli insegnamenti interiori del MaestroNessuna valutazione finora
- Revixit Spiritus Meus: Appunti di un missionario in CinaDa EverandRevixit Spiritus Meus: Appunti di un missionario in CinaNessuna valutazione finora
- Van Thuan - Il Coaggio Della SperanzaDocumento40 pagineVan Thuan - Il Coaggio Della SperanzastefanoNessuna valutazione finora
- Aprirsi A DioDocumento65 pagineAprirsi A DioAntonio MucciNessuna valutazione finora
- Gli Esseni e La CabalaDocumento1 paginaGli Esseni e La Cabalaandrea.pellegrino83Nessuna valutazione finora
- Novena Al Beato J. ScalabriniDocumento5 pagineNovena Al Beato J. ScalabriniOur Lady of All Souls R.C. ChurchNessuna valutazione finora
- Ogni Ginocchio Si Pieghi! - Riflessioni Su Un Gesto Fondante Del Cristianesimo (Nuova Evangelizzazione Vol. 2) (Italian Edition)Documento53 pagineOgni Ginocchio Si Pieghi! - Riflessioni Su Un Gesto Fondante Del Cristianesimo (Nuova Evangelizzazione Vol. 2) (Italian Edition)Lucas de BritoNessuna valutazione finora
- Pellegrino Di RomaDocumento380 paginePellegrino Di RomaAnonymous inBELEBkm100% (1)
- Baracche ZaccheoDocumento1 paginaBaracche ZaccheoVittorio RitelliNessuna valutazione finora
- Sobre A Regra de São Basílio PDFDocumento171 pagineSobre A Regra de São Basílio PDFrenan larentiNessuna valutazione finora
- Gda1958 1963Documento41 pagineGda1958 1963PevuNessuna valutazione finora
- Messa così è tutta un'altra cosa: Rito, esperienze, suggestioniDa EverandMessa così è tutta un'altra cosa: Rito, esperienze, suggestioniNessuna valutazione finora
- 05-A-Principi e Modelli Dell'Inculturazione Liturgica - 16 - 17Documento5 pagine05-A-Principi e Modelli Dell'Inculturazione Liturgica - 16 - 17jesuscolado2Nessuna valutazione finora
- MARTINI - Educare I Giovani All'Ascolto Della Parola Di DioDocumento7 pagineMARTINI - Educare I Giovani All'Ascolto Della Parola Di DioFluerSNessuna valutazione finora
- La Sorgente Primordiale Dell OccultismoDocumento136 pagineLa Sorgente Primordiale Dell OccultismoAlina StoianNessuna valutazione finora
- Tornare Alla MissioneDocumento3 pagineTornare Alla MissioneJuan Quinto RegazzoniNessuna valutazione finora
- Vita Della Santa Vergine MariaDocumento216 pagineVita Della Santa Vergine MariaVincenzo Panepinto BoanergesNessuna valutazione finora
- MARIENFRIED BARBEL RUESS La Rivelazione Dell'Amore DivinoDocumento151 pagineMARIENFRIED BARBEL RUESS La Rivelazione Dell'Amore DivinoÓscar GorrizNessuna valutazione finora
- Dialnet STeresaMargheritaFraLeConsorelle 5363487Documento38 pagineDialnet STeresaMargheritaFraLeConsorelle 5363487Victor Hugo BorgesNessuna valutazione finora
- QuadConc08 SRivaDocumento38 pagineQuadConc08 SRivaDavid JassoNessuna valutazione finora
- Nell'Adorazione Eucaristica Trovò La Sua Vocazione. Don Ruggero Caputo Alla Luce Dei Suoi Nsegnamenti.Documento27 pagineNell'Adorazione Eucaristica Trovò La Sua Vocazione. Don Ruggero Caputo Alla Luce Dei Suoi Nsegnamenti.pianetainpreghieraNessuna valutazione finora
- L Esercizio Della Buona Morte Nell EsperDocumento29 pagineL Esercizio Della Buona Morte Nell EsperJefferson WilesNessuna valutazione finora
- Ancilla Domini - 03 - 10 - 2013Documento12 pagineAncilla Domini - 03 - 10 - 2013ffbetaniaNessuna valutazione finora
- Rgveda X 129Documento2 pagineRgveda X 129Marco Passavanti0% (1)
- Roberto de NobiliDocumento6 pagineRoberto de NobiliMarco PassavantiNessuna valutazione finora
- BARGIACCHI - DesideriDocumento19 pagineBARGIACCHI - DesideriMarco PassavantiNessuna valutazione finora
- BARGIACCHI - Ippolito Desideri, Un Ponte Tra Due CultureDocumento49 pagineBARGIACCHI - Ippolito Desideri, Un Ponte Tra Due CultureMarco PassavantiNessuna valutazione finora
- Guido KellerDocumento7 pagineGuido KellerMarco PassavantiNessuna valutazione finora
- Prajnaparamita SamcayagathaDocumento102 paginePrajnaparamita SamcayagathaFedra Fox CubedduNessuna valutazione finora
- PDF Musica CoraleDocumento9 paginePDF Musica CoraleAndrea AdamoNessuna valutazione finora
- Carlo MagnoDocumento6 pagineCarlo MagnoNicolò VerdeNessuna valutazione finora
- I - I Cavalieri Templari NellAlto Monferrato e Nel Ponzonese ShortDocumento9 pagineI - I Cavalieri Templari NellAlto Monferrato e Nel Ponzonese ShortEnrico IvaldiNessuna valutazione finora
- 30 Ottobre San Germano Di Capua VescovoDocumento4 pagine30 Ottobre San Germano Di Capua Vescovoapi-237067085Nessuna valutazione finora
- Giornale Storico Della Letteratura Italiana Vol. 16Documento190 pagineGiornale Storico Della Letteratura Italiana Vol. 16Tarquinia MolzaNessuna valutazione finora
- Villa Madama: CollocazioneDocumento3 pagineVilla Madama: CollocazioneLidia Tamara KushykNessuna valutazione finora
- Il Tornado 645Documento36 pagineIl Tornado 645liberfreeNessuna valutazione finora
- Sofonisba PDFDocumento272 pagineSofonisba PDFDouglas Pereira NazárioNessuna valutazione finora
- Fazio Degli Uberti A Milano Con Una Nota PDFDocumento20 pagineFazio Degli Uberti A Milano Con Una Nota PDFStefano CampagnoloNessuna valutazione finora
- Sull'Archivio Come Universitas RerumDocumento4 pagineSull'Archivio Come Universitas RerumKatarinə FischerNessuna valutazione finora
- AnselmoDocumento35 pagineAnselmoFedericaSchiavonNessuna valutazione finora
- Prot. 154418 Del 07102020 - Scuola II Grado - Comunicazioni Ammessi Prova ScrittaDocumento27 pagineProt. 154418 Del 07102020 - Scuola II Grado - Comunicazioni Ammessi Prova Scrittaangels1968Nessuna valutazione finora
- Divina Liturgia San Giovanni CrisostomoDocumento20 pagineDivina Liturgia San Giovanni CrisostomoMario BamonteNessuna valutazione finora
- La Consacrazione Al Cuore Immacolato Di Maria (Mini Book)Documento12 pagineLa Consacrazione Al Cuore Immacolato Di Maria (Mini Book)Gesù all'umanita - Italia (gruppo di preghiera)100% (1)
- Moroni. Dizionario Di Erudizione Storico-Ecclesiastica Da S. Pietro Sino Ai Nostri Giorni. 1840. Volume 15.Documento326 pagineMoroni. Dizionario Di Erudizione Storico-Ecclesiastica Da S. Pietro Sino Ai Nostri Giorni. 1840. Volume 15.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNessuna valutazione finora
- Presentazione Don Bosco PDFDocumento13 paginePresentazione Don Bosco PDFSilvia ArosioNessuna valutazione finora
- Tre ViteDocumento188 pagineTre ViteRoberto PesceNessuna valutazione finora
- 2017 06 30 ItaliaOggiDocumento71 pagine2017 06 30 ItaliaOggiluigiNessuna valutazione finora
- LO SPECCHIO NELL'ARTE - TRA VANITAS E PRUDENTIA - MilanoPlatinum PDFDocumento17 pagineLO SPECCHIO NELL'ARTE - TRA VANITAS E PRUDENTIA - MilanoPlatinum PDFLuciana SousaNessuna valutazione finora
- Dizionariostoric 03 CrolDocumento364 pagineDizionariostoric 03 CrolRenan CardenutoNessuna valutazione finora
- L'esagono. Storia e Tradizioni Del Baianese PDFDocumento151 pagineL'esagono. Storia e Tradizioni Del Baianese PDFKUNGALEGPANessuna valutazione finora
- Beatitudini VissuteDocumento27 pagineBeatitudini VissutestringheNessuna valutazione finora
- Memorie e Documenti 2 Per La Storia Dell'Universita Di PaviaDocumento89 pagineMemorie e Documenti 2 Per La Storia Dell'Universita Di Paviaj.ramminger618Nessuna valutazione finora
- Kel12 Magazine - Settembre 2016Documento51 pagineKel12 Magazine - Settembre 2016kel 12Nessuna valutazione finora
- Papiri Greci E Latini Volume 3Documento204 paginePapiri Greci E Latini Volume 3Fiat luxNessuna valutazione finora




![[La Bibbia Commentata Dai Padri] Thomas C. Oden, Angelo Di Berardino, Sever J. Voicu - La Bibbia Commentata Dai Padri. Antico Testamento_ Tobia. Sapienza. Siracide. Baruc. Aggiunte a Daniele Vol. 5(2016, Città Nuova)](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/548532936/149x198/cb63b95cf2/1711839446?v=1)