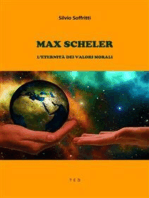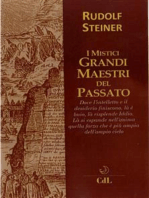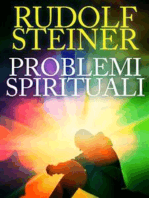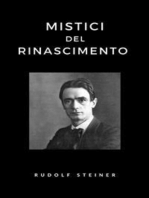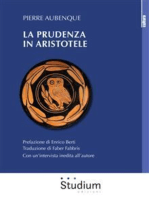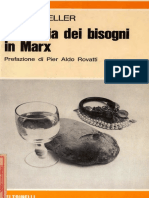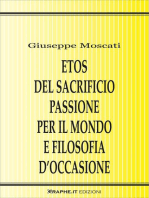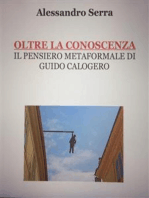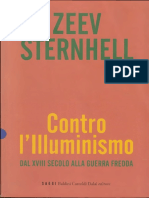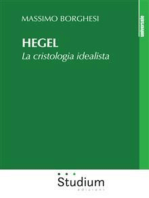Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Il Problema Dell'uomo Nel Pensiero Di Max Scheler PDF
Il Problema Dell'uomo Nel Pensiero Di Max Scheler PDF
Caricato da
Claudio GodoyTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Il Problema Dell'uomo Nel Pensiero Di Max Scheler PDF
Il Problema Dell'uomo Nel Pensiero Di Max Scheler PDF
Caricato da
Claudio GodoyCopyright:
Formati disponibili
IlproblemadelluomonelpensierodiMaxScheler
StefanoLiccioli
liccioli@interfree.it Abstract In this article the following questions have been addressed: does a unifying point exist in Schelers philosophy? Who is Man? The author argues that Scheler defines man as person. A person is a unifying centre of actions: he interacts with other people and with God. Also God is person and man has a constitutive relation with Him. Keywords: Max Scheler, man, person, community, God. Premessa ScriveHansGeorgGadamer:
Pu sembrare incredibile, eppure se oggi si interroga un giovane o anche un anziano, interessato alla filosofia, si scopre che non sa chi sia Max Scheler. Vi potr dire molto vagamente che egli era un pensatore cattolico, autore di unimportante etica materiale dei valori, e apparteneva al movimento fenomenologico che aveva in Husserl il suo fondatore e in Heidegger, right or wrong, il suo continuatore. In ogni caso, la coscienza filosofica contemporanea non riserva a Scheler una presenza paragonabile a quella di Husserl o Heidegger.Comemai?ChierarealmenteMaxScheler1?
Personalmente ritengo che lanalisi di Gadamer sia appropriata: indubbio infatti che tra i filosofi la conoscenza di Max Scheler sia piuttosto approssimativa. Invece, leggendo i suoi scritti, ci si rende conto che questa scarsa fama di cui gode immeritata. Il pensiero di Scheler offre oggi come allora delle intuizioni originali, che a volte rimangono in nuce, non vengono sviluppate in modo adeguato, ma sono ugualmente importanti per chi vuol comprendere a pienoilquadrodellafilosofiatedescaedeuropeaalliniziodelNovecento. AnchelacriticapiuttostoconcordenelriconoscerelagrandezzaintellettualediScheler.Basta pensare ad Arnold Gehlen che considera fondamentale per la storia dellantropologia filosofica lopera scheleriana Die Stellung des Menschen im Kosmos: Tutti gli scritti contemporanei e posteriori nellantropologia filosofica che abbiano in un qualche modo un valore, sono dipesi nei loro punti principali da questo scritto, e cos rimarranno le cose2. Se davvero cos, come mai i filosofi sembrano non aver riservato molta attenzione per Scheler? A mio parere, la ragione principale il modo con cui il filosofo espone le proprie idee: il suo stile di filosofare
Hans Georg Gadamer, Philosophische Lehrjahre: eine Rckschau, Frankfurt am Main, Klostermann, 1977 [tr. it. Maestriecompagninelcamminodelpensiero.Unosguardoretrospettivo,Brescia,Queriniana,1980,p.56]. 2 Arnold Gehlen, Philosophische Anthropologie und Handlungslehre (= Gesamtausgabe 4), Frankfurt am Main, Klostermann,1983[tr.it.Antropologiafilosoficaeteoriadell'azione,Napoli,Guida,1990,p.309].
1
79
Humana.MenteIssue7October2008
non molto sistematico, a momenti appare arruffato e irrituale, ma sempre partecipe e appassionato3. A tal proposito mi sembra piuttosto adeguata la descrizione che Nicolai Hartmann fa di Scheler nel necrologio in suo onore: Egli non era un costruttore di sistemi, anche se tutto ci che egli affrontava prendeva, sotto le sue mani, forma sistematica. Non avevanessunasimpatiapercolorochepartendodaunatesi,siapurebenfondata,netraggono comodamenteleconseguenzesenzarivederneessistessicontinuamenteifondamenti.Egliera fondamentalmente un pensatore di problemi4. Anche Bobbio pi o meno dello stesso parereedaffermache Scheler non mai uno scrittore sistematico, anche quando, come nellEtica e nei Problemi della Religione,
tenta il sistema; caratteristico che tutte le sue opere tranne lEtica e qualche altra secondaria, siano raccolte di saggi messi insieme con intenzioni giustificative talvolta assai deboli. Ma anche lEtica opera tuttaltro che organica; gi nel titolo e nel sottotitolo [Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik.NeuerVersuchderGrundlegungeinesethischenPersonalismus],rivelaleduepartidiversedicui costituita,eche,essendocomposteintempidiversiecondiversioggetti,appaiono,riuniteinunsolvolume, pi accostate che fuse []. Egli essenzialmente un ricercatore, la cui ricerca mossa da un profondo interesseperiproblemimorali5.
C anche un altro motivo che impedisce a Scheler di avere una giusta considerazione: nel corso della sua vita egli ha cambiato frequentemente idea su alcuni grandi temi come luomo, Dio, la societ. Questa mutevolezza non ha certo favorito linteresse verso di lui, perch chi lo affronta sa di trovarsi su un terreno insidioso; infatti bisogna stare attenti a fare affermazioni netteedefinitivesullevarieteoriediSchelerperchpotrebberoesseresmentitedaalcunisuoi successiviripensamenti. Il cammino filosofico di Scheler si pu suddividere in tre momenti. Il primo quello formativo in cui egli entra in contatto con vari pensatori (Eucken e Husserl, per citarne due) che poi lo influenzeranno nellelaborazione delle sue concezioni filosofiche. Il secondo periodo definito cattolico,teisticoepersonalisticoedcompresotrail1915circaeil1922,ancheselannuncio ufficiale dellabbandono del teismo fu dato nella conferenza del 17 gennaio 1925 presso la LessingHochschule di Berlino. La terza e ultima fase, chiamata panenteistica, viene fatta coincidere con gli anni che vanno dal 1922 circa allanno della morte del filosofo (1928). Come tutte le suddivisioni cronologiche, anche questa non pretende di essere rigorosa e definitiva in maniera assoluta: solo un modo per indicare che in alcuni anni la riflessione scheleriana ha determinati contenuti che, in altri momenti, vengono ripensati e modificati, a volte anche
Bruno Accarino, Tra libert e decisione: alle origini dellantropologia filosofica, in AA. VV, Ratio imaginis: uomo e mondonell'antropologiafilosofica,acuradiBrunoAccarino,Firenze,PontealleGrazie,1991,p.7. 4 Nicolai Hartmann, Max Scheler, in Kantstuiden, XXXIII (1928) 1/2, p. XV. Cfr. anche Giovanni Ferretti, Scheler (Introduzione bibliografica e antologica), in AA. VV., Questioni di storiografia filosofica, a cura di A. Bausola, 4/1, Brescia,LaScuola,1978,pp.93120. 5 Norberto Bobbio, La personalit di Max Scheler, in Rivista di filosofia XXIX (1938) 2, p. 98. La mancanza di sistematicit nel pensiero di Scheler dipende anche dalla sua idea di filosofia: La filosofia qualcosa come il tirare dei burattini con i fili (H. G. Gadamer, Maestri e compagni nel cammino del pensiero. Uno sguardo retrospettivo, cit. p. 58). In questa ottica la filosofia sembra consistere nel dare degli stimoli, degli impulsi come quando si tirano dei fili: non c un metodo preciso e sistematico. Su questo tema Cesare Luporini osserva che lunit dellopera di Scheler soprattutto ununit di temperamento, in cui emergono soprattutto gli interessi vitali del moralista e la preoccupazione religiosa e nellappariscente variet e tumultuosit dei problemi da lui toccati [] facile riscontrare una direttiva costante segnata da questa doppia esigenza (Cesare Luporini, Filosofi vecchi e nuovi: Scheler,Hegel,Kant,Fichte,Leopardi,I,Firenze,G.C.Sansoni,1947,p.4).
3
80
StefanoLiccioliIlproblemadelluomonelpensierodiMaxScheler
radicalmente. Daltra parte importante non chiudere Scheler in gabbie cronologiche6, non considerare il suo pensiero come diviso in contenitori che non comunicano fra di loro. Infatti sia nella seconda che nella terza fase del pensiero scheleriano ci sono alcuni motivi speculativi che rimangono costanti. Ad esempio al di l delle loro differenze, il teismo e il panenteismo condividono questa identica condizione di base: la realt suprema lo spirito, caratterizzato da efficacia causale e produttiva; inoltre in questi suoi due periodi Scheler sostiene che la persona, grazie allo spirito che la anima, non possa essere n oggettivata n conosciuta oggettivamente. Un altro esempio ci offerto dalla riflessione del filosofo sullamore: amare Dio significa partecipare al suo stesso atto di amore per tutte le creature, ci comporta amare in lui tutte le creature; questa tematica dello amare mundum in Deo presentata allincirca negli stessi termini sia nello scritto Liebe und Erkenntnis del 1915 sia in quello intitolato Die Stellung des Menschen im Kosmos del 1928. Lultimo e, a mio parere, pi importante tema che rimane costantenel corsodellafilosofiaschelerianalariflessionesulluomo.Inquestoultimo caso non tanto il contenuto della riflessione a restare identico (che anzi, cambia notevolmente), quanto il fatto che il filosofo durante tutta la sua vita si sempre preoccupato dichecosafosseluomo.InquestosensomisembraesemplarecichescriveSchelernel1928:
Fin dal primo destarsi della mia coscienza filosofica domande come Che cos luomo? e Qual la sua posizione nellessere? mi hanno coinvolto pi intensamente e ampiamente di qualsiasi altra questione filosofica. I lunghi anni di lavoro, dedicati a considerare questo problema sotto ogni punto di vista, si sono concretizzati in unopera dedicata a questo argomento, ed con gioia crescente che ho potuto constatare 7 comeinessavenisseroaconvergerelamaggiorpartedeiproblemifilosoficicheavevotrattato .
Anche se non esplicitamente detto, mi sembra chiaro che capire quale sia la posizione delluomonellessere,vuoldireanchecapirequalesiailrapportodellindividuoconlessere. In questa sede cercher proprio di mettere in luce la visione delluomo secondo Scheler, ritenendolo un tema fondamentale in quanto unifica tutte le riflessioni del filosofo: Alla base, ci che guid tutta la vita per i suoi intricati sentieri fu un unico problema: il problema delluomo. Psicologia e metafisica, gnoseologia e sociologia, etica e ontologia, tutto lo fece convergereinununicooggetto,ilpilontanoealtempostessoilpivicino8. Nellaffrontare questo argomento mi limiter alla fase teistica sia per dovere di sintesi sia perch dovendo prendere in considerazione questo uomo aperto costitutivamente allessere (che in questo periodo possiamo chiamare Dio), mi sembra pi sensato concentrarmi in un momento in cui i due poli della relazione sono ben distinti e dove piuttosto chiaro anche il nessofraquestidueelementi.Daltrapartenellultimafase,quandoDiointutto,comefarea distinguere dove finisce luomo e dove invece inizia il divino? Il nostro filosofo, per risolvere
Roberto Racinaro, Il futuro della memoria: filosofia e mondo storico tra Hegel e Scheler, Napoli, Guida, 1985, p. 246. 7 Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, IX, Spte Schriften, Bern, Francke, 1976 [Tr. it. La posizione delluomo nel cosmo, Milano, Franco Angeli, 2000], p. 9 [73]. Nel corsodiquestolavoro,le citazionitrattedatutteleoperediScheler,sonoindicateconlepaginedelleGesammelte Werkee,traparentesiquadra,conquellecorrispondentiallatraduzioneitalianasegnalata(ovepresente). 8 Hartmann,MaxScheler,p.XVI.
81
Humana.MenteIssue7October2008
questi problemi, ha dato alcune indicazioni, ma, a mio avviso, sono incomplete, anche perch lasuamortehainterrottoulteriorisviluppiedelaborazioni. Max Scheler viene considerato un grande moralista, ma, grazie a queste sue riflessioni sulluomo, su Dio e sulla loro relazione, ha dato il proprio contributo anche allo sviluppo della filosofia della religione. Sebbene sia interessante, non questo il luogo per valutare lentit di taleapportonquantopossaaverinfluenzatolecorrentiteologichealuicontemporanee. Scheler,comnelsuostile,nonaffrontainmanierasistematicailproblemadellafilosofiadella religione,mafavariaccenni,piomenoampi,indiversisuoiscritti. Alcune indicazioni esplicite sono gi rintracciabili nella sua monumentale opera Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik in cui, ad esempio, vengono teorizzati alcuni temi che offrono spunti di filosofia della religione: lassiologia con al vertice i valori religiosi, lantropologia che vede la natura specifica delluomo alla luce dellidea di Dio, il personalismo metafisico che considera lidea di Dio come fondamento di ogni persona sia individuale che comunitaria. In Vom Ewigen im Menschen, dove gli spunti di filosofia della religione sono pi sistematici, Scheler sostiene che la disciplina filosofica fondamentale circa la religione, la fenomenologia essenziale (Wesensphnomenologie). Questo metodo, a suo parere, permette di cogliere, attraverso lintuizione eidetica9, i significati essenziali delle esperienze umane concrete. In sostanza il nostro filosofo ci vuol dire che, cercando il posto dellareligionenellastrutturadellaragioneumana,lafilosofiadevemostrareilfondamento,ma anche il presupposto della religione nello spirito umano, cio quella originaria tensione amorosaversolassolutochecostituiscemetafisicamenteognipersona. Uno degli aspetti pi importanti del pensiero di Scheler proprio questa idea secondo cui il rapporto Uomo Dio non fra due entit qualsiasi, ma fra due persone. Per questo incontro conlarealtdivinapuavveniresoltantograzieaquegliattireligiosispecificiconcuisiaccoglie la rivelazione di Dio, da parte sua la filosofia si ferma prima. Infatti studiando da un punto di vista essenziale la natura degli atti religiosi, la fenomenologia non pu sostituirli nel cogliere la realt delloggetto religioso: la filosofia pu solo indicare la natura della via con cui si giunge alla partecipazione allassoluto, ma non pu mai giungervi autonomamente. In conclusione la soluzione di Scheler permette di costruire una filosofia della religione che salvaguarda la peculiarit e lindipendenza del fenomeno religioso, ma allo stesso tempo capace di affrontareilproblemadellasuafondazione. Con il presente lavoro non ho certo la pretesa di rendere giustizia a Scheler: mi preme per mettere in luce la grande pregnanza di alcune sue tesi filosofiche, come quelle elaborate sul problema delluomo. Daltra parte, come si pu trascurare lacutezza di certe sue osservazioni che difficilmente si appiattiscono su luoghi comuni, su affermazioni gi fatte? Ritengo che troppospessoletormentatevicendebiografichediSchelereilsuocaratterevolubile,ilqualesi riflesso anche nel suo modo di filosofare, abbiano in parte oscurato la sua grandezza intellettuale, impedendogli di essere considerato meritatamente uno dei pi grandi pensatori delNovecento.
9
questo un tema in cui Scheler debitore alla fenomenologia di Husserl: il primo considera lintuizione eidetica, unastrazioneideante,unmodounicoperaccedereallessenzacostitutivadelmondo.
82
StefanoLiccioliIlproblemadelluomonelpensierodiMaxScheler
1.SULLIDEADELLUOMO
In un certo senso tutti i problemi fondamentali della filosofia si possono ricondurre alla domanda che cosa sia luomo e quale posto e posizione metafisica egli occupi entro la totalit dellessere, del mondo, di Dio10. Come testimoniano queste parole tratte dal saggio Zur Idee des Menschen, Scheler, gi nel 1915, afferma che nella filosofia il problema delluomo e del posto che occupa nel mondo ha un ruolo centrale. In questo stesso anno il filosofo si era convertito per la seconda volta al cattolicesimo, ma limportanza che egli attribuisce al tema delluomo va al di l della sua credenza religiosa; infatti il passo con cui ho chiuso il capitolo precedente e che rivendica anchesso limportanza del problema delluomo, del 1927, quandoormaiSchelerhaabbandonatodatempolafedecristiana.Sedunquevogliamotrovare leprovediunacertasistematicitnel pensieroscheleriano,lariflessionesulluomopuessere una: essa una costante nel corso degli scritti del nostro autore. Come sostiene Nicolai Hartmann11,ilcentrounificatoredellafilosofiaschelerianailproblemadelluomo. Prendendo in considerazione attentamente Zur Idee des Menschen possiamo evincere quale sia per Scheler la vera costituzione dellessere umano: esso ripiegato in se stesso oppure apertoadunadimensionetrascendente,adunOltre?ladomandaacuidobbiamorispondere percapireseilrapportoconDiounrapportoessenziale,costitutivoperluomooppureuna relazione qualsiasi, non necessaria. Prima di risolvere questo problema, ritengo doveroso illustrare le principali questioni toccate da Scheler nel suo saggio. Prima di tutto egli afferma che le definizioni delluomo che sono state date nel corso dei secoli, sono parziali ed insoddisfacenti. Infatti, a suo avviso, non esauriente dire, secondo la teoria classica greca, che luomo un animale razionale, valutando esclusivamente la sua capacit contemplativa e trascurando la struttura corporea specifica che fonda il suo comportamento pratico; ma altrettanto insoddisfacente sottolineare esclusivamente lelemento corporeo, definendo luomo solo in base a ci che sa fare, come homo faber. Positivisti e pragmatisti sono gli esponenti di questa posizione. Scheler non specifica a chi si riferisca in particolare, quindi lecito pensare che abbia in mente il positivismo ed il pragmatismo in generale e non qualche corrente precisa. Queste teorie filosofiche sostengono che luomo non pi lanimale contraddistinto dalla ragione, ma lanimale che sa parlare e fabbricare strumenti. Per Scheler, questa continuit tra animali e uomini che i positivisti ed i pragmatisti sostengono, si basa sul fraintendimentodellanaturadellaparolaedellostrumento. Infatti,perquantoriguardalaparolaeillinguaggio,ilfilosofopensacheglianimaliesprimano, attraverso suoni e gesti, unesperienza vissuta, un sentimento (es. il dolore, la paura). Non si pu pensare per che la parola ed il linguaggio umano sorgano per semplice evoluzione di questi sistemi di espressione delle bestie, dato che fra i primi ed i secondi esiste una profonda differenza qualitativa. La voce, o meglio il suono espressivo degli animali, ben diverso da un
Max Scheler, Zur Idee des Menschen, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, III, Vom Umsturz der Werte, Bern, Francke, 1955; tr. it. Sullidea delluomo in La posizione delluomo nel cosmo ed altri saggi, Fabbri, Milano, 1970,p.176[100]. 11 Hartmann,MaxScheler,p.XV.
10
83
Humana.MenteIssue7October2008
mero rumore, esprime il sentimento che lanimale prova, il suo vissuto; la parola invece ci rimanda, di per se stessa, ad un oggetto del mondo. Essa indica qualcosa, che non sidentifica n con lelemento corporeo del suo suono, n con lesperienza vissuta di un sentimento che il soggetto potrebbe manifestare con unesclamazione. La parola pu intendere il vissuto interiore di chi parla, ma lo fa in modo diverso da una semplice espressione; infatti un conto gridareahi,altrodireiosentoundolore. Lintenzionalit propria della parola distingue sostanzialmente la comunicazione umana dal semplice contagio psichico dei sentimenti, che pu aver luogo anche fra gli animali quando ad esempioun caneabbaiaedanchealtri canivicini comincianoadabbaiare.Scheleraffermache comprendere ci che uno dice con parole equivale ad intuire ci che tali parole intendono, ad esempio il fatto che oggi il sole splende12. Questa concezione della parola, che vede nellintenzionalitlasuanaturaspecifica,servealfilosofopernoncaderenelnominalismoche erra nellidentificare la parola con il nome, e il nome con un semplice segno convenzionale di una o pi cose. Lessenza, il nucleo della parola sono per lappunto costituiti da quel passaggio, che si verifica nellErlebnis, da suono a significato, e questi fungono esclusivamente da punto di partenza e di arrivo per un movimento intenzionale dello spirito13. Senza la parola, sarebbe impossibile costituire le convenzioni che stanno alla base degli altri segni e dei nomi. In questa ottica non ha senso indagare sullorigine storica della parola, come non vale la penaricorrereallacapacitanatomicaefisiologicadiformaresuoniarticolatiperspiegarela capacit umana di parlare, perch la parola un fenomeno originario, nato con luomo stesso. Per sintetizzare la sua posizione, Scheler usa unespressione di W. Von Humboldt che recita cos: Luomo esiste solo in virt del linguaggio; nondimeno, per inventare il linguaggio egli doveva gi esser uomo14. Grazie al concetto dintenzionalit, proprio di tutto il movimento fenomenologico, Scheler analizza la specificit della parola umana, che il naturalismo dei positivisti e dei pragmatisti, aveva completamente perso, fraintendendo in tal modoradicalmenteanchelanaturastessadelluomo15. Laltrofraintendimentoimputatoaipositivistiedipragmatisti,riguardalainterpretazionedello strumento. significativo rilevare che anche in questo caso Scheler usa il concetto dintenzionalit per analizzare fenomenologicamente lo strumento. A suo parere, una cosa resa strumento non dalluso che se ne fa per conseguire un certo scopo, come possono fare anche gli animali usando occasionalmente degli oggetti esterni come mezzi per soddisfare meglio certe necessit biologiche; bens lutensile tale in base al significato unitario imposto ad una data materia dallazione delluomo. importante osservare che questo significato
Per completezza espositiva aggiungo che nellottica scheleriana comprendere ci che uno dice con parole equivale ad intuire ci che tali parole intendono, ad esempio il fatto che oggi il sole splende; non si tratta di un giudizio dato per contagio psichico, ma non vuol dire neanche cogliere che X dice che oggi bel tempo, riferendosi cos solamente allatto del soggetto che esprime il giudizio. Intendersi fra persone, comprendere una persona, non vuol dire farla oggetto della mia conoscenza, ma capire, appunto, ci che essa dice. Cfr. M. Scheler, ZurIdeedesMenschen,cit.,p.180[103]. 13 interessante notare come contro il nominalismo Scheler sostenga che, mentre nel segno la percezione dellelemento sensibile materiale separata dalla comprensione del significato, che il segno solo per convenzione indica, nella parola invece si presenta a noi una realt significante semplice, unitaria, in cui solo una analisi riflessa pudividerelelementoacusticodaquellosignificante.Cfr.M.Scheler,ZurIdeedesMenschen,cit.,p.180[103]. 14 M.Scheler,ZurIdeedesMenschen,cit.p.182[106]. 15 G.Ferretti,Fenomenologiaeantropologiapersonalistica,inMaxScheler,I,Milano,VitaePensiero,1972,p.107.
12
84
StefanoLiccioliIlproblemadelluomonelpensierodiMaxScheler
trascende ogni uso occasionale dello strumento cos che esso si colloca quasi sul piano di unopera darte che ha senso in se stessa, indipendentemente da ogni finalit biologica. Per chiarire questa idea Scheler usa questo esempio: Se io uso una chiave come battente di porta, la chiave rimane chiave, e non diventa battente di porta16. Inoltre, lintenzionare i significati oggettivi unitari, che sono cos indipendenti dalla contingenza delle esigenze vitali, ci che caratterizza lo spirito. Esso dunque si rivela in atto nelluomo, gi nel fabbricare strumenti,comequalcosachelodistingueessenzialmentedallanimale. Laltra obiezione importante che il nostro filosofo rivolge alla teoria dei positivisti riguarda lo strumento considerato dal mero punto di vista della sua funzionalit biologica: in esso vedono una tappa propria dellevolversi progressivo della vita, che arriverebbe nello homo faber a formarsi, con gli strumenti, quasi dei nuovi organi per lazione. Scheler invece pensa che se lo strumento considerato esclusivamente dal punto di vista biologico, esso non il frutto di un progresso, bens di una deficienza vitale, della mancanza di organi adatti alla vita17. Perci lintelletto, considerato come capacit di fabbricare, non il culmine dellevoluzione vitale, bens un segno di ristagno della vita, un surrogato dellistinto che venuto a mancare, il quale capacedirisolvereiproblemivitaliinmodopiimmediatochenonlintelletto18;ovviamente anche lintelletto pu sbagliare, ma solo in casi rarissimi e per lo pi in seguito a un intervento volutodalluomo. In questa visione mi sembra sia evidente linflusso della lezione di Nietzsche, anche se questi, secondoScheler,hasbagliatoadaccettareilpresuppostopositivisticocheconsideralintelletto comelacaratteristicaspecificadelluomo,invecediritenerelindividuodotatodiintellettoedi strumenti,comeunanimalecostituzionalmentemalato,nelqualelavitahafattounfauxpas echesismarritoinunvicolocieco19. Hovolutofareunabreverassegnadiquesteconcezionidellessereumano,permettereinluce loriginalitdellaposizioneschelerianariguardoilproblemadellindividuo,posizionechenon assolutamente appiattita su altre teorie antropologiche. Scheler afferma che dal punto di vista
Inquestaotticaemergeconevidenza,amioparere,chesolosecondariamentelostrumentotaleinrelazioneal fine biologico contingente per cui usato. Quando viene costruito lo strumento si deve vedere allopera quella stessa forza spirituale che agisce nella costruzione della cultura spirituale, con una differenza per: nella formazione di strumenti tale forza spirituale si pone liberamente al servizio del soddisfacimento di necessit biologiche, mentre nella formazione delle opere culturali, se ne mantiene totalmente libera. Cfr. M. Scheler, Zur IdeedesMenschen,cit.,p.182[106]. 17 Questa idea di Scheler richiama in un certo senso quella di Kant secondo cui la natura ha lasciato un vuoto nelluomo, la natura ha voluto che luomo traesse interamente da se stesso tutto ci che va oltre la costituzione meccanica della sua esistenza animale e che non partecipasse ad altra felicit o perfezione se non a quella che egli stesso, libero da istinti si crea con la propria ragione (Immanuel Kant, Idee zu einer allgemeinem Geschichte in weltbrgerlicherAbsicht,1784;tr.it.Ideadiunastoriauniversaledalpuntodivistacosmopolitico,inScrittipoliticie di filosofia della storia e del diritto, Torino, UTET, 1965, p. 126). La visione di Scheler si oppone anche a quella di Marxilqualevedelaproduzionedeglistrumenticomeunprogressodelluomo(KarlMarx,DieDeutscheIdeologie, FrankfurtamMainMoskau,1932;L'ideologiatedesca,Roma,EditoriRiuniti,1967,p.8). 18 Ferretti sostiene che Scheler fin da questo saggio, fa propria la concezione bergsoniana dellintelletto come facolt dellhomo faber, distinguendolo nettamente sia dallo spirito che dallistinto. Mentre per in questo saggio lattivit spirituale delluomo appare nellesercizio stesso delle attivit biologiche, e listinto visto perfino come una forma dello spirito, in seguito Scheler, soprattutto nellultimo periodo della sua filosofia, distinguer e contrapporr pi nettamente spirito da un lato e intelletto e istinto, biologicamente condizionati, dallaltro (G. Ferretti,Fenomenologiaeantropologiapersonalistica,inMaxScheler,cit.,p.115). 19 M.Scheler,ZurIdeedesMenschen,cit.,p.185[109].
16
85
Humana.MenteIssue7October2008
biologico, non si pu definire luomo in modo specifico e neppure individuarlo come specie animale unitaria; in accordo con la teoria evoluzionistica lanimale e luomo formano un continuo, per cui una distinzione tra luno e laltro, che si fonda sulle qualit naturali, rappresentauntaglioarbitrariooperatodanoi20. Il nostro filosofo contrappone alla concezione naturalistica delluomo, a cui anche Nietzsche era rimasto legato, una visione decisamente spiritualista e personalista. La peculiare natura delluomo non nellambito del vitale, ma nel suo trascendere il vitale. Lanimale malato, lanimale intelligente e capace di costruirsi degli utensili diviene subito magnifico, grande e nobile, quando si consideri la sua possibilit di trasformarsi in un essere che trascende ogni formadivita21.Luomolessereche,purattraversoattivitbiologicamentefinalizzate,come lafabbricazionedistrumenti,trascendeogniformadivita22esestessoinquantosemplicevita. Perchiarirequestoconcetto,sonoilluminantileparolediScheler:
Luomo [] lintenzione e il gesto della trascendenza stessa, lessere che prega e cerca Dio. Anzi luomo non prega, egli la preghiera che la vita eleva al di sopra di se stessa; non cerca Dio, egli quello X vivente, che Dio cerca! E tutto ci, esattamente nella misura in cui il suo intelletto, i suoi utensili e le sue macchine sono in grado di garantirgli un ozio libero per contemplare e amare Dio. Dunque ci che pu giustificare il suo intelletto e lopera di questo, la civilizzazione, solo il fatto che essi rendano sempre pi permeabile il suo essere a quello spirito e a quello amore che, in tutti i loro moti e in tutti i loro atti, si orientano come i segmenti di un unico arco verso qualcosa che si chiama Dio. Dio il mare, essi sono i fiumi: e fin dalla loro 23 sorgenteifiumipresentonoilmareversocuicorrono .
Inoltre Scheler sostiene che sia impossibile trovare per luomo una fissa stazione fra la vita e Dio, per definirlo in se stesso. Allessenza delluomo appartiene lindefinibilit: Questi solo un infra, una frontiera, un passaggio, un apparire di Dio nel corso della vita, e una eterna trascendenza della vita oltre se stessa24. Il passaggio appunto tra il regno inferiore a lui e quello a lui superiore, il regno di Dio25: lesistenza delluomo proprio questo trapasso dalluno allaltro regno, un ponte, un movimento tra di essi; e luomo non pu come intu Pascal sottrarsi allalternativa di far parte delluno o dellaltro. Perch persino la non decisione si configura come decisione di essere un animale, e, come tale un animale degenerato. Il fuoco, la passione di trascendersi si chiami la meta, superuomo o Dio costituiscelunicasuaveraumanit26. Condivido la lettura di chi pensa che questa descrizione fatta da Scheler ha chiari accenti nietzscheani27. Ma al superuomo, scopo intenzionale della trascendenza nietzschiana
Ivi,p.193[118]. Ivi,p.185[109]. 22 Anche in Der Formalismus, Scheler sostiene che lautentica definizione essenziale delluomo : egli una cosa che trascende se stessa e la propria vita ed ogni vita (Max Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, II, Bern, Francke, 1954; tr. it. Il formalismo nelletica e leticamaterialedeivalori,Torino,EdizioniSanPaolo,1996,cit.,p.293[357]). 23 Ivi,p.186[110]. 24 Ibidem(Corsivimiei). 25 Cfr. M. Scheler, Der Formalismus, cit., p. 293 [357]. Anche qui Scheler afferma che luomo la tendenza, il punto dipassaggioversolambitodeldivino. 26 M.Scheler,ZurIdeedesMenschen,cit.,p.195[120](Corsivimiei). 27 In Fenomenologia e antropologia personalistica (in Max Scheler, cit., p. 117) Ferretti mette a confronto questa descrizionediSchelerconquellafattadaNietzschein,AlsosprachZarathustra:einBuchfrAlleundKein,Chemnitz, Schmeitzner, 1883 sgg. [tr. it. Cos parl Zarathustra, Milano, Adelphi, 1991, p. 8]: Luomo un cavo teso tra la
21 20
86
StefanoLiccioliIlproblemadelluomonelpensierodiMaxScheler
delluomo sulla vita, Scheler sostituisce Dio, la persona infinitamente perfetta. proprio la tensioneaquestaPersonachecaratterizzaogniculturaspirituale,tantochesipuconsiderare Dio come la radice di ogni cultura nelluomo e, dunque, di tutti quegli atti spirituali intenzionali che una considerazione meramente naturalistica delluomo non pu spiegare e che,invece,costituisconoluomocomepersona. Degna di nota questa affermazione di Scheler: Pertanto, tra le convinzioni pi sciocche dei pensatori moderni c quella che lidea di Dio sia antropomorfica. Cosa che appare tanto pi falsa, quanto pi si riflette sul fatto che lunica idea delluomo che abbia senso precisamente quella teomorfica di un X che sia immagine finita e vivente di Dio, una sua analogia, una delle sue innumerevoli ombre sul grande sfondo dellessere28. Quindi: Lidea di persona applicata a Dio non dunque lespressione di un antropomorfismo! Dio piuttosto lunica persona perfetta e pura, mentre quel quid che pu chiamarsi col nome di uomo solamente una persona imperfetta e analogicamente intesa29. Solo in virt di questo Fondamento, di questa persona perfetta, luomo acquista una sua unit, relativa al pensiero, alla coscienza e al sentimento, nonostante i dati delle scienze naturali, non dimostrino alcuna unit specifica nelluomo.PerSchelerquestofattocostituiscelaprovarigorosachelanostraideadiunitnon si fonda affatto sulla struttura naturale delluomo, inteso come un tutto unico, ma che il fondamentoultimodiquestaunitriposa,asuavolta,suqualcosadicompletamentediverso. A questo punto ci sono tutti gli elementi per rispondere alla domanda con cui ho iniziato il paragrafoecio:PerluomoilrapportoconDioessenzialeecostitutivo?Larispostas:in questo saggio emerge la caratterizzazione specifica delluomo come apertura e tensione allInfinito ed anche come trascendenza sulla vita. Questo slancio verso lInfinto, eleva luomo dalla sua naturalit: L ove il desiderio di Dio chiama prepotentemente alla riscossa tutto lessere e tutto lo spirito contro ci che solo mondo, ecco lhomo bestia naturalis trasformarsi in un homo. [] Colui che cerca Dio, rientra con i suoi attributi sostanziali in una nuova classe eidetica oggettiva30. Lerrore del positivismo, per Scheler, sta proprio nellaver negato che la tendenza metafisica delluomo sia un suo costitutivo essenziale, considerandola invece unabitudine, un effetto storico accidentale, che successivamente potremo abbandonare. Ma, se definiamo luomo senza riferimento a Dio e dunque senza lo spirito, la cultura, la religione, il risultato un uomo privato di ogni dinamismo: non pi un ricercatore di Dio, bens un individuo pago di s31. Inoltre interessante rilevare che questa essenziale
bestia e il superuomo, un cavo al di sopra dellabisso. Un passaggio periglioso, un periglioso essere in cammino, un periglioso guardarsi indietro e un periglioso rabbrividire e fermarsi. La grandezza delluomo di essere un ponte e non uno scopo: ci che si pu amare nelluomo che egli sia una transizione e un tramonto. Oltre limmagine del ponte, delluomo come passaggio dalla bestia a qualcosa di trascendente, anche limmagine del fiume e del mare presa da Nietzsche: Davvero un fiume immondo luomo. Bisogna essere un mare per accogliere un fiume immondo,senzadiventareimpuri.Eccoioviinsegnoilsuperuomo:egliquestomare,nelqualesipuinabissareil vostrograndedisprezzo(Ivi,p.7). 28 M.Scheler,ZurIdeedesMenschen,cit.,p.188[111].(Corsivimiei).Cfr.DerFormalismus,cit.,p.293[357]. 29 Ivi,p.190[114].SultemadiDiocomepersonavediilparagrafosuccessivo. 30 Ivi, p. 190 [115] (Corsivi miei). Scheler arriva a dire che luomo che cerca Dio rientra in una nuova classe di essenze. C dunque unaforte discontinuit, anche dal punto divista essenziale, tra luomo ripiegato su se stesso e luomoprotesoversoildivino. 31 Ferrettiscrivecheunuomopagodis,ciononprotesoversoDio,coscomevuoleilpositivismo,perScheleril ritratto del borghese (G. Ferretti, Fenomenologia e antropologia personalistica, in Max Scheler, cit., p. 119). Credo
87
Humana.MenteIssue7October2008
tendenza metafisica delluomo, la sua apertura alla sfera dellAssoluto, ritenuta da Scheler unacondizionenecessariaperlapossibilitdellareligione,sebbene,comevedremoinseguito, lareligionenonsiametafisica. Sorge dunque un altro problema non meno facile: Come pu essere soddisfatta questa apertura delluomo a Dio? Con una conoscenza dellessere e del bene reale assoluto che non derivadaunarivelazione?Secosluomoappagatonellasuatendenzametafisicaenonha pi bisogno della religione. In caso contrario, questa apertura pu essere soddisfatta solo con unautocomunicazione di Dio alluomo: una rivelazione appunto. Successivamente spiegher tutti questi termini, ma prima di fare questo e sopratutto prima di mostrare la soluzione al problema appena menzionato, ritengo doveroso approfondire brevemente lanalisi delluomo e della persona, dal momento che questa fase del pensiero di Scheler che sto trattando anche quella della sua filosofia personalistica. per questo che nel paragrafo successivo metter in luce, in maniera piuttosto schematica e riassuntiva, i punti principali del personalismoscheleriano.
2.LAPERSONA
Per impostare il suo studio delluomo Scheler comincia dal concetto di spirito e di persona. ComesplicitamenteaffermatoinDerFormalismus:
Quanto emerge nelluomo come nuovo elemento in una determinata fase della sua evoluzione propriamente, da un punto di vista biologico, una certa ridondanza dattivit spirituale: come se in lui e nella sua storia si fosse aperta una fessura da cui appaia, sovrapposto ad ogni forma di vita un ordine di atti e di contenuti (valori). Tutto ci si manifesta in concomitanza ad una nuova configurazione unitaria di tale ordine, analoga a quella che abitualmente cogliamo come unit della persona (a differenza cio dellio, dellorganismoecc.):lasuainteriorearticolazionecostituitadallamoreedallapuragiustiziachesudiesso sifonda32.
In questo passo Scheler accenna anche al rapporto che intercorre tra spirito e persona. Se lo spirito la sfera di tutto quanto presenti lessenza di atto, dintenzionalit e di pienezza di senso, la persona la forma unitaria in cui questa sfera pu solamente concretizzarsi: Persona invero quella unit che sussiste in funzione del compimento di atti sempre diversi in ragione della propria essenza e nella misura in cui tali atti vengono pensati come compiuti33. In termini metafisici la persona si costituisce grazie allo spirito dal momento che questo ultimo viene visto come principio in antitesi ad ogni forma di vita, anche a quella umana, colte nel loro aspetto naturale34, allo stesso tempo per ogni spirito personale per necessit di natura eidetica e lidea duno spirito impersonale un controsenso35. Nella prefazione alla seconda edizione di Der Formalismus, Scheler afferma coerentemente che
cheFerrettiabbiaragione,infatticomeosservaacutamenteNorbertoBobbio,ilconcettodiborghesiafunzionaper Scheler come una specie di scatola a sorpresa in cui sia racchiuso tutto il male del mondo (Bobbio,LapersonalitdiMaxScheler,p.109). 32 M.Scheler,DerFormalismus,cit.,p.293[356]. 33 Ivi,p.382[473]. 34 CondividopienamentequestainterpretazionediGiancarloCaronello(Pref.aIlformalismo,cit.,p.80). 35 M.Scheler,DerFormalismus,cit.,p.388[481].
88
StefanoLiccioliIlproblemadelluomonelpensierodiMaxScheler
anche un fondamento spirituale del mondo (quale ne sia la natura) pu essere definito in se stessocomeDiosolonellamisuraincuisiapersonale36. interessante rilevare il motivo per cui Scheler, per indicare il principio transbiologico caratterizzanteluomo,preferiscailterminespiritoaquellodiragione.Infattiquestultima sempre stata usata per indicare il pensiero logico, che si articola per idee e concetti. Alla base di tale uso, fatto proprio anche da Kant, sta la convinzione che solo il pensiero logico apra luomo al mondo transbiologico, daltra parte tutto ci che nelluomo non razionale viene relegato nel campo della sensibilit. Invece Scheler, usando il termine spirito per tutta la sfera degli atti, pensa che la trascendenza sul mondo biologico, e dunque lapertura a dati assoluti, riguardi ogni tipo di conoscenza intuitiva, cio tutti gli atti emozionali e volitivi, diretti a contenuti essenziali. Per spirito dunque il filosofo intende la completa sfera di atti, di natura intenzionale, emozionali, teoretici, volitivi, che trascendono il dato empirico per rivolgersi ad essenzevalideapriori37. Come abbiamo visto la critica di Scheler al pensiero morale di Kant si estende anche alla sua concezione della persona. Infatti, da una parte i due filosofi concordano nel riconoscere alla persona la dignit pi alta e nel riaffermare limperativo per cui la persona non debba mai essere considerata esclusivamente come mezzo; in questo senso Kant avrebbe ragione nel far vedere come ogni etica dei beni e dei fini sminuisca la dignit della persona, subordinandola a qualcosadestraneodasestessa.DaltraparteSchelercontestalidentificazionekantianadella personaconilsoggettodiattirazionaliconformiallaleggemorale.Cosfacendo,perScheler,si attua unautentica spersonalizzazione, una neutralizzazione della persona individuale e concreta; dunque Kant sbaglierebbe nel concepire la persona unicamente come ragione, escludendo la vita emozionale: corretto pensare che la persona non pu in alcun modo venir pensata come una cosa o una sostanza che disponga di determinate facolt o capacit tra cui quella facolt o quella capacit che appunto la ragione38. Infatti la ragione, separata dalla concretezza dellindividualit, del suo carattere, della sua vita emozionale e anche delle sue inclinazioni sensibili, resta solo una pura universalit astratta e non pu presentarsi come unaveraepropriaindividualitspirituale.PerSchelerse,comevuoleKant,laragioneciche ci connota ed anche in un modo pi universale e generico, noi siamo veramente persone, quantomenosiamoindividui,ciosoggettisingoliconcaratteristichediversedatuttiglialtri:si crea cos unincompatibilit tra individualit e personalit. Inoltre Scheler critica in termini piuttostoprecisiancheladefinizionekantianadelluomoattraversolanozionedinoumeno:
Kantidentifica,infatti,questaXconluomonoumeno,cioconluomoqualecosains,contrapponendopoi questo ultimo allo homo phainomenon. Ora, lhomo noumenon [] il concetto della (comunque inconoscibile) cosa in s come costante ontologica, applicato per alluomo. La medesima costante
Ivi,p.16[10]. evidente che Scheler voglia tutelare la funzione dello spirito nella costituzione della persona e lo fa in maniera decisa a tal punto che si pu legittimamente affermare che Scheler si arrocca a difesa dello spirito (B. Accarino, Tra libert e decisione: alle origini dellantropologia filosofica, in AA. VV, Ratio imaginis: uomo e mondo nell'antropologiafilosofica,cit.,p.25). 38 Ivi,p.371[458].
37
36
89
Humana.MenteIssue7October2008 inconoscibile vale per, senza differenziazione, anche per ogni pianta e minerale. Come potrebbe essa quindigarantirealluomounadignitdiversadaquellaminerale?39.
LintentodiSchelerdicogliere(checosa?)inunmodochesalvaguardicontemporaneamente sia la spiritualit sia lindividualit della persona. Per fare ci egli innanzitutto sgombra il campo dalla teoria della metafisica razionalistica che fa corrispondere la persona allanima. Anchequestaentitinfattideltuttoindeterminata daun punto divistaindividuale.Daparte sua la tesi metafisica tradizionale, di tipo scolastico, vede lindividualit come il risultato della materializzazionedellentitspirituale(lanimaappunto)permezzodiunacorporeit.Ciper contrasta, secondo Scheler, con il forte senso dunit psicofisica in cui la persona avverte se stessa:essanonsipercepiscecomecostituitadaduesostanzediverse.Inoltrecomepotrebbe lanima essere ci che percepisce esternamente, mentre essa stessa o il suo fondamento intuitivopossonodarsisolonellaformaspecificadellapercezioneinterna?40. Dunque Scheler vuole mostrare come la sua tesi dellindividualit della persona, non sia riconducibile a nessun fondamento ontologico, come lanima appunto. Anche in questo caso desidero mettere in luce che Scheler, dovendo definire filosoficamente la persona, non sibasa su presupposti ontologici, come ha gi fatto, a mio parere, nella costruzione del sistema dei valori,nonancorandolalorosussistenzaelaloroautonomiaallEssere. Ilfilosofosostiene chelapersonaindicaunessereumanoconsideratonellaricchezzadellasua vita emotiva, non il soggetto incolore, animato da una mera attivit di pensiero: un soggetto capacedipensareechesiaautocosciente,nonancoraunapersona.Atalpropositoilfilosofo confuta un vecchio pregiudizio di stampo illuministico secondo cui le persone sono tanto pi simili quanto pi sono attive nellesercizio delle facolt razionali, mentre sono tanto pi diverse quanto pi vivono nelle necessit biologiche; Scheler sostiene proprio il contrario: le persone raggiungono la loro completa individualit, quando esercitano le facolt superiori dello spirito, invece diventano tanto pi simili, quanto pi la loro esistenza ridotta al campo dellefunzionivitali. 2.1PERSONAEATTI Machecosalloralapersona?InDerFormalismusSchelerdefiniscelapersonacomelunit diessere concreta e in se stessa essenziale di atti di diversa natura, tale da darsi in s prima dogni essenziale differenza datto e, in particolare, prima della differenza tra percezione interna ed esterna, tra volont interna ed esterna, tra sentire, amare, odiare nella propria interiorit o nella sfera dellalterit ecc. Lessere della persona fonda tutti gli atti essenzialmente diversi41. Quindi la persona precede e fonda i diversi tipi di atti. Occorre
39 40
Ivi,p.373[461]. Ivi,p.376[465]. 41 Ivi,p.382[473].QuestaconcezionestatapiomenoripresaancheinambitocristianodaKarolWojtyla.Questi sostienecheluomopersonaperchcompieatti.Lattoildatofondamentaleperlanalisidelsoggettocosciente, giacch in esso si manifesta nel modo pi chiaro il suo essere personale. Luomo, nellatto, sperimenta se stesso come causa efficiente del suo agire, vale a dire come qualcuno che liberamente determina se stesso nellazione. (Karol Wojtyla, Osoba i czyn ora zinne studia antropologiczne, Lublino, KUL, 1969, 19942; tr. it Persona e atto, SantarcangelodiRomagna,Rusconilibri,1999).
90
StefanoLiccioliIlproblemadelluomonelpensierodiMaxScheler
ricordare che per atti, Scheler intende i moti della persona nel suo aprirsi al mondo: essi, pur rimanendo distinti dal piano dello Io e del mondo, non nascono dalla sfera psichica, ma direttamente dalla persona e rivelano lintenzionalit con cui essa si rapporta al mondo e agli altri. Ad esempio latto dascoltare una musica si serve delludito, ma si tratta dun ascoltare che ha unintenzionalit che invece assente nella funzione sensibile delludire, ed in cui dato qualcosa che prima rimaneva invisibile. Altri atti del genere sono quelli che ho descritto nelcapitoloprecedente:amare,odiare,ricordare,preferire,posporre.Inoltre,siagliattichela persona, afferma Scheler, sono psicofisicamente indifferenti, nel senso che sono dati precedentemente al senso interno ed esterno a cui corrispondono la sfera psichica e fisica. Latto,dunque,haunasuaprecisanaturaenondeveessereidentificatoconlafunzione42:essa regola il rapporto fra il corpo vivente e il mondoambiente. Cos il gustare un cibo, lodorare, lusare il tatto sono funzioni che servono a raccogliere informazioni importanti sul mondo circostante. Inoltre esse possono essere oggetto della percezione interiore, possono essere studiate e osservate, dati i concomitanti organici propriocorporali da cui sono accompagnate43,mentrenoncospergliattiperchmaiunattoancheunoggetto,ciogli attipossonooggettivarelefunzioni,manonsestessi:
Un atto non per mai anche un oggetto; alla natura dessere degli atti perviene invero di venir intuitivamente esperiti nel loro stesso compimento e desser dati solo nella riflessione. Un atto non pu quindiinalcunmododivenireunoggettograzieadunsecondoattochesia,inuncertosenso,retrospettivo. Lastessariflessionechepurenderconsapevolelattoaldildelproprio(ingenuo)compimentononfamai 44 dellattounoggetto:ilsapereriflessivoaccompagnalatto,manonloggettualizza.
Soprattutto le funzioni formano la sfera che regola lattivit dellIo psichico e si svolgono, a differenza dagli atti, nella sfera psichica: grazie ad esse luomo riesce ad avere una visione oggettiva del mondo. Vi possono essere relazioni fra atti e funzioni, nel senso che i primi possono intendere le seconde, usarle per arrivare a cogliere il proprio oggetto, ma in nessun modoattiefunzionipossonoessereconfusi:danotarecometalifunzioninonabbianonulla incomunecongliatti45. Inoltre significativo osservare che la persona non si riduce allo psichico. La psiche manca della partecipazione agli atti che vengono compiuti perch essa non ha il senso della reciprocit interpersonale che caratterizza una dimensione propria dello spirito. Infatti lanimale esercita funzioni perch dotato di psiche, ma luomo compie funzioni solo quando la partecipazione con la sua vita personale viene vissuta parzialmente. Ma anche in tal caso il suo esserpersona non viene mai meno. Scheler sostiene che anche la pi grave delle alienazioni mentali, che non rende luomo pi imputabile per delle sue azioni, non annulla il suoesserpersona,maneimpediscesoloilmanifestarsiindeterminateazioni.Coslamalattia
42
Pusembrardifficiledistinguereconcretamenteattiefunzioni,maperSchelerladifferenzabendefinita.Infatti, egli in Der Formalismus, critica Stumpf, reo, a suo parere, daver identificato atti e funzioni, affidandone lo studio allapsicologia.(Cfr.DerFormalismus,cit.,p.387[479]). 43 G.Ferretti,Fenomenologiaeantropologiapersonalistica,inMaxScheler,cit.p.155. 44 Ibi,p.374[462]. 45 M.Scheler,DerFormalismus,cit.,p.387[479](Corsivimiei).SuquestotemasivedalariflessionediAndreaZhok, IntersoggettivitefondamentoinMaxScheler,Firenze,LaNuovaItalia,1997,p.9.
91
Humana.MenteIssue7October2008
e la salute non possono affatto porsi come eventuali predicati della persona, ma delluomo, dellanima.Visonomalattiedellanima,manonmalattiedellapersona46. Unaltroaspettoimportantedarilevare che quandoScheleraffermachelapersonafondagli atti,eglidiceche:
La persona non un vuoto punto di cominciamento di atti, bens lessere concreto senza il quale ogni discorso circa gli atti non potrebbe mai far riferimento allessenza completamente adeguata di un atto qualsiasi, ma solo ad unessenza astratta; solo in quanto inerenti allessenza di questa o quella persona individuale, gli atti si concretizzano trasformandosi da essenze astratte in essenze concrete. Per tal ragione non mai possibile cogliere in maniera adeguata ed esaustiva un atto concreto senza una precedente 47 conoscenzaintenzionaledellessenzadellapersonastessa.
Laconcretezzadellapersonadata,perScheler,nondalriferimentoadunagenteingenerale, formale e vuoto, ma dal riferimento allessenza di questa o quella persona individuale. Il filosofovedelapersonacomeunitdegliattispirituali,basandosisullesperienzacheluomofa del riferimento complessivo alla stessa persona individuale di vari atti spirituali di stampo diverso: questo riferimento talmente essenziale che gli atti non possono esistere che come atti di una certa persona. Daltra parte ritengo che questa ultima affermazione sarebbe quantomeno fuorviante, se Scheler non precisasse che non dobbiamo commettere lerrore di pensarelapersonacomeunacosaounasostanzacapacedicondurreacompimentodiattinel senso duna causalit sostanziale. Ci non vuol dire che la persona sia inconsistente, ma solo che non un substrato: essa non pu essere concepita come un punto fermo su cui si appoggiano i suoi atti, o, un ente oggettivato che si pone al di sopra del processo di compimento dellatto stesso48. Infatti, come sottolinea Scheler, la persona esiste e si esperisceinmanieravissutasolocomeessenzacheportaacompimentoatti,comepurcerto che non esiste, in alcun senso, al di sotto o al di sopra di questi atti o addirittura come un qualcosa che, analogamente ad un punto fermo, sussista al di sopra del processo di compimento e scorrimento dei propri atti49. Dunque la persona non fonda latto dallesterno, ma vive nellatto stesso: vivendo in ogni suo atto che la persona lo caratterizza con il suo peculiaremododessere. 2.2LINOGETTIVABILITDELLAPERSONA La gi citata differenza tra atti e funzioni ci porta ad affrontare unaltra distinzione fatta da Scheler: quella tra persona ed io, dal momento che la loro differenza fondamentale: Una persona possiede, rispetto allio, il carattere di una totalit che sufficiente a se stessa. Una persona, ad esempio, agisce, va a passeggio o simili; un io, al contrario, non ha la possibilit di farlo.Gliiononagiscono,nvannoapasseggio50.Dunque gliiononfannonulla,nonvivono
46 47
Ivi,p.479[596]. Ivi,p.383[474]. 48 G.Cusinato,Scheler.Dioindivenire,cit.,p.31. 49 M.Scheler,DerFormalismus,cit.,p.384[475]. 50 Ivi,p.389[482].
92
StefanoLiccioliIlproblemadelluomonelpensierodiMaxScheler
in una dimensione fondamentale di reciprocit. Cosa che invece fanno le persone. Confondere la persona con l io significa oggettivarla, farne un oggetto di studio e di ricerca. Infatti l io il luogo di funzioni che si possono studiare in modo oggettivo, mentre la persona partecipa degli atti che essa stessa compie e latto di una persona non mai qualcosa di neutralmente oggettivochesipuosservarecomeuneventonaturaleopsichico. ParticolarmentesignificativoilfattocheSchelercritichiognioggettivazionedellapersonache non ne preservi lessenziale soggettivit spirituale. Per quanto detto precedentemente, si pu affermare che per Scheler la persona inoggettivabile, dal momento che essa lunitdi essere concreta e in se stessa essenziale di atti di diversa natura e gli atti sono inoggettivabili. Linoggettivabilit della persona si manifesta nel fatto che appartiene alla sua essenza il lasciarsi conoscere o meno. Una pietra non pu compiere questa scelta, solo una persona pu decidere quando e con chi confidarsi, se nascondersi o no. La persona si distingue da un oggetto in quanto supera le coordinate spaziotemporali: cos facendo libera di cambiare, sfuggendoalleleggidellacausalitmeccanica. Appurato che persona ed atti sono inoggettivabili, Scheler afferma che possibile, grazie alla riflessione che pu sempre accompagnare gli atti intenzionali, conoscere la loro qualit specifica cio le loro proprie leggi essenziali. Vale la pena osservare che oggettivare la qualit di un atto, non vuol dire oggettivare latto stesso. Quando io ricordo di aver compiuto un atto determinato, ad esempio che ho ricordato una cosa, il mio ricordo non ha per oggetto latto precedente del ricordo, ormai compiuto, ma solo la qualit di quello atto come ricordo51. Dunque se gli atti non sono oggettivabili, ma conoscibili unicamente grazie alla riflessione che li accompagna, allora essi possono essere conosciuti, solo attraverso il loro compimento effettivo; da ci segue che un vero studio delluomo si fonda sullesperienza vissuta pi vasta delluomo. Ritengo che questa tesi rechi con s una conseguenza con dei risvolti importanti: la personapuconosceresestessasolocompiendoipropristessiattiegrazieallariflessioneche li accompagna. Ci comporta che anche Dio, essendo persona, non pu essere conosciuto come un oggetto, ma solo nel partecipare alla sua stessa vita e cio nel cogitare, velle et amareinDeo52. 2.3PERSONAEMONDO Linoggettivabilit della persona connessa al problema della sua apertura al mondo: Come correlato effettivo della persona in genere noi abbiamo posto il mondo53. Infatti, come loggetto il correlato dellatto, cos il mondo il correlato oggettivo della persona: non il mondo biologico inteso come linsieme degli oggetti empirici reali, che si presentano alluomo nellatteggiamento naturale e costituiscono il suo mondoambiente (Umwelt), ma un sistema pi vasto, che non neanche assimilabile al mondo kantianamente inteso come unidea.
G.Ferretti,Fenomenologiaeantropologiapersonalistica,inMaxSchelercit.,p.154. Vedi M. Scheler, Wesen und Formen der Simpatie, in Gesammelte Werke, a cura di Manfred Frings, VII, Bern, Francke,1973[tr.it.Essenzaeformedellasimpatia,Roma,CittNuovaEditrice,1980],p.220[320]. 53 M.Scheler,DerFormalismus,cit.,p.392[486].
52 51
93
Humana.MenteIssue7October2008
Questo sistema pi ampio, di cui l Umwelt solo una parte, formato dallinsieme dei dati oggettivi in cui lessere si manifesta cos com in se stesso. interessante rilevare che se ad ogni persona corrisponde un mondo, ad ogni mondo corrisponde una persona54: la persona non mai parte del mondo in cui vive, ma il suo correlato. Da parte sua ogni mondo individuale deve certamente avere le caratteristiche essenziali generali a priori proprie di ogni mondo possibile, allo steso tempo esso pu essere correlato alla persona solo se presenta le peculiaritessenzialichecorrispondonoallaconcretezzaindividualedellapersona.Datuttoci conseguechenonabbiamoununicomondougualepertuttelesingolepersone,maunmondo checoncretoeindividuale,anchesedatoinsestessoedassoluto. Scheler tratta questa idea dei mondi individuali personali e della loro unificazione, in una sezione55 di Der Formalismus. La questione importante perch potremmo arrivare ad una sintesi dei vari mondi personali: essi potrebbero essere visti come microcosmi, aspetti di un unico superiore macrocosmo. Il filosofo, a mio avviso, non d una risposta precisa, per sostiene che lidea di un unico mondo identico e reale richiama necessariamente lidea duna personaspiritualeinfintaeperfetta,ciolideadiDio:Sequindinoiponessimocomerealeun solo mondo concreto, risulterebbe essere privo di senso [] il fatto di non porre contemporaneamente anche lidea di uno spirito concreto56. Analogamente ogni comunit di persone individuali non si fonda su una qualche astratta idea della ragione, ma sulla comunit di queste persone con la persona delle persone, cio con Dio. bene ricordare che qui non si fa riferimento alla posizione di realt dellessenza di Dio57 perch, come vedremo, la concreta personalitdivinasidsoloinambitoreligioso. 2.4LIDENTITDELLAPERSONA Unaltroaspettoimportantequellodellidentitpersonale:lidentitdellapersonanonuna relazionediuguaglianzacomeA=A,nonunoggettochesimantienestabilenelsuccedersidel tempo; anzi, lidentit della persona come uno stile peculiare cha fa riconoscere subito un individuo dallapparire dei suoi atti. Essi infatti si concretizzano ed hanno un significato in quanto ineriscono allessenza della persona. Questultima, dunque, si configura come unidentit nel cambiamento, dal momento che un centro dinamico in movimento che regola gli atti dun individuo. Tale cambiamento deve essere inteso come un mutamento dellidentit personale, non sul piano oggettivabile, ma su quello della libert, intesa come possibilitcheunapersonahadimutareunordinamentodiatti. Infatti la persona, nel suo poter divenire altro, cambia la sua identit, si muove, contrariamente al soggetto che rimane immutabile58. Perci lidentit della persona pu cambiare, anche in maniera profonda ad esempio attraverso latto del pentimento59 o del
54 55
Ivi,p.394[489]. MikroundMakrokosmosundGottesidee[Tr.it.MicrocosmoemacrocosmoelideadiDio],cit.,p.395[489]. 56 Ivi,p.395[490]. 57 Ivi,nota(31)p.396[490]. 58 Perladifferenzatrapersonaesoggettovedisopra. 59 Vedi il saggio di Scheler, Reue und Wiedergeburt, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, V, Vom Ewigen imMenschen,Bern,Francke,1954[tr.it.Pentimentoerinascita,inLeternonelluomo,Milano,Fabbri,1972].
94
StefanoLiccioliIlproblemadelluomonelpensierodiMaxScheler
perdono: il risultato una fisionomia particolare che, pur essendo in mutamento, presenta unacoerenzadisviluppo.Precedentementeabbiamovistocheinogniattoconcretolapersona si esprime nella sua interezza, senza per esaurirsi in essa; cos nel compimento di ogni atto la persona sperimenta una variazione, diventa altro. proprio grazie a questo atto del divenire, del trascendersi (la cui pi alta espressione lamare), che la persona tale. Il centro dellidentit personale dinamico in quanto si trasforma nella misura in cui fa sviluppare la persona. 2.5PERSONAECOMUNIT Prima di concludere non possono non fare un breve riferimento alla dimensione comunitaria della persona. Far un rapido accenno allo scritto Wesen und Formen der Simpatie, tralasciandoperdiapprofondireivaritemiespuntioffertidaquestaopera. GiinDerFormalismusSchelersostienechenelcompimentodiognisuoattolapersonahadi se stessa un vissuto tale da sapersi membro duna comunit personale collettiva dun determinato tipo in cui la simultaneit e la successione (delle generazioni) sono ancora indifferenziate60. Ma soprattutto in Wesen und Formen der Simpatie, che Scheler sviluppa questa tesi delloriginaria comunitariet delle persone umane, aperte alla sfera di un tu in generale, gi prima di ogni esperienza dei tu empirici concreti altrui. Per spiegare meglio questa posizione, in questa opera61 il filosofo riprende un esempio gi fatto in Der Formalismus:
Robinson era un uomo che mai aveva percepito lessenza dei suoi simili n qualsivoglia genere di segni e tracce dei medesimi, e dellesistenza di tali esseri non aveva mai fatto esperienza alcuna. Ebbene [] io posi laquestioneseuntaleRobinsonpotesseavereonounaqualcheconoscenzacircalesistenzadellacomunit edisoggettipsicospiritualisimilialui;esepotessesaperecheegliappartenevaadunatalecomunit.[]Io risposi affermativamente ad entrambe le domande. [] Levidenza che il Robinson ha dellesistenza dun qualche tu in generale e della sua appartenenza ad una comunit ha un determinato fondamento intuitivo. Questofondamentointuitivo,ciodatodallacoscienza,determinataebencircoscrittadelvuoto.62
Per coscienza del vuoto Scheler intende quel vissuto che si crea quando a determinati atti sociali (lamare, il comandare, lobbedire, il lodare, il promettere) non corrisponde latto sociale di risposta che loro proprio: al comando lobbedienza, allamore lamore di contraccambio questo vuoto, cos aperto da tali atti, che forma questa idea del tu, questa ideadellacomunitingenerale,acuimancherebbesoloildarsidiesemplariconcreti. Scheler precisa che la persona non si costituisce solo di atti sociali, ma anche di atti singolarizzanti: la coscienza di s, lamore di s, la stima di s. Cos il correlato degli atti singolarizzanti forma il mondo del singolo, il correlato degli atti sociali costituisce il mondo comunitario. Questo per non la mera somma di mondi singoli, n la persona comune la
60 61
M.Scheler,DerFormalismus,cit.,p.509[633]. FaccioriferimentoallasecondaedizionediWesenundFormenderSimpatie(1923). 62 M.Scheler,WesenundFormenderSimpatie, cit.,p.229230[332333].LesempiodiRobinsonCrusoeuntopos pi volte sfruttato in filosofia. In questo caso Scheler lo usa per indicare un uomo che, pur essendo stato sempre completamenteisolatodalmondoedagliuomini,puaverelevidenzadellesistenzadiqualchetuingenerale.
95
Humana.MenteIssue7October2008
somma di persone singole. Esse sono una realt vissuta in ogni possibile persona finita concreta. Daltra parte la persona singola non pu essere considerata una parte della persona comune. Esse infatti si rapportano a vicenda63, senza che luna sia il fondamento dellaltra: LIo non solo un membro del Noi, ma anche il Noi un membro necessario dellIo64. In questa ottica ogni persona altrettanto originariamente persona singola e comune, dal momento che entrambe sono subordinate allidea di quella persona infinta in cui viene a mancareognidistinzionetrapersonasingolaepersonacollettiva,essenzialeinvecepertuttele personefinite65. importante anche la suddivisione, operata da Scheler, sui vari tipi fondamentali dunit sociali. Cos la massa, che negli animali rappresentata dal gregge, si forma solo in base al contagio affettivo; la comunit di vita nasce dal condividere i medesimi contenuti intenzionali,caratterizzatadallamancanzadiogni distinzionetrailvissutomiootuoeforma ununit corporeovitale, rivolta ai valori vitali; la societ invece ununit artificiale di singoli, basata su convenzioni e contratti: Le diversit reali e di valore si manifestano nella societ e tra i suoi membri solo grazie ai diversi valori di prestazione dei singoli, cio rispetto allorientamento della societ versi i valori del piacevole e dellutile66. Al grado pi elevato si colloca la persona comune che sorge dallunione di persone singole, autonome, spirituali, individuali articolatesi in una persona collettiva, autonoma, spirituale, individuale67, fino ad arrivare alla piena comunit di ogni persona con Dio, persona delle persone; questa forma di unione caratterizzata dal principio di solidariet insostituibile: la persona singola corresponsabile di tutte le altre persone singole, non solo allinterno della persona collettiva e come suo membro per il fatto di rappresentare una funzione [], ma lo pure in quanto individuo personale, unico e dotato di una coscienza morale individuale68; tutto dipende da quali valori vengono accentuati: abbiamo la nazione, se hanno particolare rilievo i valori spirituali della cultura, invece abbiamo la chiesa, se sono in primo piano i valori religiosi. Nellottica di Scheler, questa appartenenza della persona a vari gruppi sociali non esaurisce tuttoilsuoesserepersonaperchessa,oltreadunasferasocialecostituitadaquellinsiemedi esperienze che pu condividere con gli altri, ha anche una sfera intima fatta di esperienze che fa solo lei e non pu comunicare. Questa sfera caratterizzata, nellambito delle persone finite,dallasolitudineassolutachecessasoloneiconfrontidellarelazionecomunitariaconDio, che non n persona singola, n persona comune: cos che davanti a Dio la persona si apre pertuttociche,conlaconsapevolezzadiesserealcontempogiudicataeprotetta. Ai fini delle mie indagini sul rapporto tra uomo e Dio, occorre sottolineare ci che Scheler scrive: Lunit delle persone collettive tra di loro, nonch della persona singola o della persona collettiva possibile peraltro solo in Dio69; risulta chiaro che, per il filosofo, ogni rapporto comunitario fra gli uomini, dipende dalla nostra relazione con Dio. Anche in Wesen
Condivido pienamente questa interpretazione di Ferretti (G. Ferretti, Fenomenologia e antropologia personalistica,inMaxScheler,cit.,p.225). 64 M.Scheler,WesenundFormenderSimpatie,cit.,p.225[327]. 65 M.Scheler,DerFormalismus,cit.,p.514[640]. 66 Ivi,p.519[645]. 67 Ivi,p.522[649]. 68 Ivi,p.523[650]. 69 Ivi,p.527[656].
63
96
StefanoLiccioliIlproblemadelluomonelpensierodiMaxScheler
und Formen der Simpatie, il filosofo offre degli spunti interessanti di filosofia della religione o meglio, in questo caso, di sociologia della religione. Cos egli pensa che il personalismo da lui sostenuto sia comprensibile solo mettendolo in corrispondenza con il teismo: La persona e il tutto esistono in modo indipendente e luna per laltro, ma mai esclusivamente luna per laltro, ma luna e laltro esistono al contempo per Dio come persona, e solo in Dio esistono anche luna per laltro70. Laltro spunto riguarda il tu altrui e i diversi gruppi sociali: secondo Scheler, infatti, lapertura alla sfera del tu altrui segue lapertura delluomo alla sfera dellassoluto,eprecedelarelazioneallasferadelmondoesternonaturale. Trattando del problema delluomo, ho scelto daprire questa lunga parentesi sul tema della persona perch, secondo Scheler, luomo essenzialmente persona. Essa , per il filosofo, un percorso: il divenirpersona contraddistinto dallatto dellamore, con cui luomo va oltre se stesso, in direzione del valore del sacro. Questo processo del divenirpersona non pu essere concepito come un atto autonomo e autosufficiente delluomo, come il moto di una sostanza separata dal divino: nel divenirpersona si esprime una continuazione dellatto creativo divino e tale divenire risulta possibile solo grazie alla presenza salvifica del divino71. Non dobbiamo dimenticare che anche Dio, nella concezione scheleriana, persona: Un fondamentospiritualedelmondo(qualenesialanatura)puesseredefinitoinsestessocome Diosolonellamisuraincuisiapersonale72.Dunque,ilrapportotrauomoeDio,nonfradue entitqualsiasi,mafraduepersone. 2.5UOMOEDIO:UNRAPPORTOFRADUEPERSONE Per Scheler la persona umana pu raggiungere alcune evidenze ultime riguardo lEssere Assoluto (Dio), mediante la conoscenza filosofica. Essa si configura come animata da quello slancio morale, con cui il nocciolo della persona cerca di raggiungere la partecipazione allessenzialittramitela conoscenza73;cicheognunopu conosceredipendedalgradodello slancio.Laprimaevidenzaacuigiungelafilosofiachequalcosaesisteedunqueilnullanon ; questa affermazione, apparentemente scontata, per Scheler fondamentale: Certamente chi non ha guardato nellabisso del nulla assoluto non saccorger delleminente positivit del contenuto dellintuizione, che in genere qualcosa esista anzich nulla74. La ragione dellesistenza di qualche cosa dipende da unentit assoluta, unentit tramite cui ogni altro ente nonassoluto riceve lessere che gli compete: questa intuizione la seconda evidenza. Tale entit assoluta , come la chiama Scheler, lEns a se, che ha nella sua essenza la ragione
M.Scheler,WesenundFormenderSimpatie,cit.,p.227[329]. G.Cusinato,Scheler.Dioindivenire,cit.,p.33.QuestaaffermazionediCusinato,amioparereforsetropponetta, poneperbeneinrisaltoillegametralapersonaDioelapersonauomo. 72 M.Scheler,DerFormalismus,cit.,p.16[10]. 73 Max Scheler, Vom Wesen der Philosophie und den moralischen Bedingungen des philosophischen Erkennens, in GesammelteWerke,acuradiMariaScheler,V,VomEwigenimMenschen,Bern,Francke,1954[tr.it.Lessenzadella filosofiaecondizionemoraledellaconoscenzafilosofica,inLeternonelluomo,Fabbri,Milano,1972],p.83[196]. Si notilevidenterichiamoallimmagineplatonicadelfilosofoprotesoversoilmondodellessenzialit. 74 Ivi, p. 93 [207]. Su questo punto si veda laffinit di pensiero tra Scheler e M. Heidegger che in Einfhrung in die Metaphysik, scrive: Perch vi , in generale, lessente e non il nulla? (Martin Heidegger, Einfhrung in die Metaphysik,Tbingen,MaxNiemeyer,1966;tr.it.Introduzioneallametafisica,Milano,Mursia,1968,p.13).
71 70
97
Humana.MenteIssue7October2008
delsuoessere;essaancheSommobene,qualebenedistintodaglialtribenirelativi.Larealt dell Ens a se evidente e non il frutto duninferenza razionale: Lilluminante luce di questa verit non anzitutto dipendente da precisione logica75; nonostante ci sempre difficilenoncaderenellerroredidentificarelEssereassolutoconunodeitantientirelativiche possiamo esperire. La terza evidenza che ogni ente finito ha unessenza ed unesistenza distinte, mentre solo nellEssere assoluto esse si identificano; perci la filosofia, prescindendo dallinduzione, unintuizione a priori dellessere e coglie le essenzialit e le loro interdipendenze,primadiqualsiasiosservazioneempirica. Perci la filosofia, per spiegarsi come mai esistano enti che potrebbero anche non essere, stabilisce che c l Ens a se e che esso causa del mondo; queste due proposizioni sono le sole affermazioni evidenti che la filosofia pu fare intorno a Dio. Se si vuol andare avanti si entra nella metafisica applicata al reale e dunque nel campo delle ipotesi perch levidenza si ha solo nellintuizione eidetica dei rapporti fra essenze; se la metafisica vuole essere una scienza del reale essa deve dunque applicare quei principi che nascono dai rapporti fra le essenze, a realt esistenti, e giudizi sulla realt possono esserci forniti solo dalle scienze particolari, che sono basate sullinduzione e perci raggiungono solo la probabilit e non levidenza76. InProblemederReligionScheleraffermachiaramenteche:
unintera serie di questioni fondamentali [] possono con laiuto della metafisica anche filosoficamente essereprovate.Tradiessepongo(soloaguisadesempio)lesistenzadiunessere,chehalesistenzasoloper la sua stessa essenza; lesistenza di questo Ens a se come prima causa di tutto lessere contingente [], la spiritualit e la razionalit di questo Ens a se e la sua natura come summum bonum e meta finale di tutte le attivit del mondo; la sua infinit. Ma in nessun caso vi annovero la sua effettiva personalit (neretto nostro)77.
Ivi,p.94[209]. Sofia Vanni Rovighi, Filosofia e religione nel pensiero di Max Scheler, in Religione e filosofia (Relazioni e comunicazioni allXI Congresso Nazionale di filosofia), Milano, 1968, p. 151. Con questa interpretazione Sofia Vanni Rovighi mette in luce unapparente incongruenza che emergerebbe nella concezione scheleriana della metafisica; infatti ella sostiene che strano che Scheler applichi da una parte il metodo husserliano della riduzione fenomenologica, della messa fra parentesi dellesistenza, dallaltra invece sostenga che la prima evidenza filosofica sia che qualcosa esiste. Per Vanni Rovighi questa difficolt concettuale teoreticamente inspiegabile, mentre si pu spiegare storicamente, se si vede nel pensiero di Max Scheler un momento di transizione fra la fenomenologia di Husserl e la filosofia esistenziale di Heidegger. Personalmente ritengo che lobiezione della Vanni Rovighi sia importante, ma non pienamente condivisibile. Infatti Scheler nelletica, pur parlando di Dio, mette tra parentesi la sua esistenza. Come si concilia ci, secondo Vanni Rovighi, con la netta affermazione filosofica che qualcosa esiste? Penso che la soluzione stia nel tener presente che mettere tra parentesi ad esempio la realt di Dio, non vuole dire cancellarla, ma solo non considerarla. Dunque, a mio parere, Scheler pu affermare che la filosofia arrivi ad intuire lesistenza di un Ens a se, senza per entrare in contraddizione quando opera la riduzione fenomenologica. Infatti nelletica mettere tra parentesi la realt di Dio, non vuol dire negare la sua esistenza, bens significa che leticapufareamenodellasuaesistenzaconcreta(nonperdellasuapresenzacomevaloreultimo,valorediuno spiritopersonaleinfinitochefondaglialtrivalori). 77 Max Scheler Probleme der Religion, in Gesammelte Werke, acura di Maria Scheler, V, Vom Ewigen im Menschen, Bern,Francke,1954[tr.it.Problemidireligione,inLeternonelluomo,Fabbri,Milano,1972],p.141[257](Grassetto mio). Non concordo con Ubaldo Pellegrino che traduce il verbo erweisen con dimostrare. Infatti parlando della filosofia preferisco dire che essa pu provare, ma non dimostrare questioni fondamentali che anche la religione pone come vere. Il dimostrare infatti rimanda a dei procedimenti logici, a delle conclusioni inferenziali, che sono estraneealmodoincuiluomoriesceapossederecerteevidenzefilosofiche.AdesempiolesistenzadiquestoEnsa se, come prima causa di tutto lessere contingente, frutto di unintuizione, non di una dimostrazione. La filosofia dunquepuprovarealcunequestionifondamentalicheanchelareligioneponecomevere.
76
75
98
StefanoLiccioliIlproblemadelluomonelpensierodiMaxScheler
Mi interessa sottolineare il fatto che per Scheler impossibile una dimostrazione metafisica dellesistenza di Dio come Persona, partendo dalla realt esistente nel mondo, proprio perch il mondo nei suoi valori colto nellessenza e non nellesistenza; la realt esistente invece conosciuta solo induttivamente e quindi ipoteticamente. Inoltre laffermazione che luomo, conlametafisica,puraggiungeresoloilconcettodiDiocomeEnsase,comecausadituttoil contingente, ma non come persona , a mio avviso, gravida di conseguenze; infatti, nel paragrafo precedente ho illustrato come la personalit sia una caratteristica essenziale per luomo, ma anche per Dio (un fondamento spirituale del mondo pu essere definito in se stesso come Dio solo nella misura in cui sia personale)78: dunque non cogliere Dio come Persona,ciocomeamore,vuoldirenonconquistareilsuointimonucleo. A mio avviso si pu concludere che uomo capace di giungere a Dio come Persona solo attraverso lareligione: essa ha per oggetto il Sacro, per mezzo la fede, per fine la salvezza, per modello il santo. Unicamente nellambito dellesperienza religiosa luomo riesce a raggiungere pienamente lAssoluto che si rivela come Principio Primo degli enti, vivo, reale e personale, e noncomeilDiodellametafisica,freddoevuoto. Ritengo che nella concezione scheleriana la filosofia sembri fermarsi sulla soglia della piena conoscenza di Dio: per andare oltre, per arrivare ad una partecipazione perfetta allAssoluto ci vuole la religione. Che ne dunque della filosofia? qualcosa di inutile da superare? Su tale questione sono daccordo con Vanni Rovighi che afferma che il riconoscimento dellinsufficienza della filosofia sempre una conclusione filosofica perch la stessa limitazione della filosofia non avrebbe diritto di essere affermata se non come autolimitazione. Questo tipo di conoscenza resta dunque necessario, ma come una fase preparatoria, introduttiva alla religione, anche se non fondativa della religione. in questo senso, secondo Scheler, che deve essere interpretata lespressione philosophia ancilla theologiae: la filosofia, mostrando limpossibilit di una metafisica come conoscenza della realt dellassoluto, non solo libera la coscienza dai miti della metafisica, ma aiuta lo spirito a riceverelalucedellarivelazione,efapostocosallafedenellambitodellospiritoumano. Nelsaggiodel1915AbsolutsphreundRealsetzungderGottesidee,Schelerafferma:
Poichlideaessenzialeaprioridelladivinitcostituitadallideadiunapersonainfinitamentesanta,viun solo modo decisivo in cui sia pensabile, per persone finite, la possibilit dellesperienza della realt di un soggetto che corrisponda al contenuto di questa idea: che lidea della divinit si ripresenti nel senso pi stretto del termine alle persone finite in una persona reale, la quale in qualche modo ne medi la conoscenza []. Ci deve intendersi nel senso che un soggetto reale, corrispondente a questa essenza, giunge ad esperienza solo tramite il conesperire e postesperire lesperienza vissuta di Dio che ha questa persona. Lessenza e lidea di una possibile persona reale, presso la quale e nella quale possa aver luogo un possibile afferrare la realt della divinit, io la chiamo lidea del santo originario []. Ci che noi espressamente contestiamo ogni dottrina che ritenga possibile, da parte di persone finite, una comprensione della realt della divinit anche per qualche altra via che non sia lautorivelazione della 79 divinitdiunsantooriginario.
78 79
M.Scheler,DerFormalismus,cit.,p.16[10]. Max Scheler, Absolutsphre und Realsetzung der Gottesidee, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, X, Schriften aus dem Nachlass I, Bern, Francke, 1957, p. 181. In questo brano Scheler sostiene che Buddha, Mos, Cristo,Maomettosonoesempidisantioriginari.
99
Humana.MenteIssue7October2008
Gi in questo scritto, in cui c un primo abbozzo della filosofia della religione di Scheler, emergelideachelarealtdellapersonadivinanonpuessereconosciutaconilragionamento di una persona finita, ma esclusivamente attraverso la sua autorivelazione cio la rivelazione che Dio stesso compie. I motivi a sostegno di questa tesi sono tre. Il primo riguarda la concezione scheleriana della persona: come ho mostrato nel paragrafo precedente, essa pu essere conosciuta in se stessa solo se volontariamente si lascia capire, sapre allaltro; in caso contrario possiamo cogliere il corpo della persona umana, ma non il suo nucleo pi intimo. Anche Dio persona, ma, dal momento che incorporeo, invisibile, perfetto, infinito e assolutamente libero, se non si manifestasse sarebbe impossibile coglierlo: chiaro che la sua stessa natura non esclude che essa nasconda non soltanto il contenuto del suo spirito, ma anche la sua stessa esistenza. Egli chiama questa argomentazione, prova dellindimostrabilit di Dio come persona, sottolineando che per quanto una visione razionale senza luce di rivelazione possa riconoscere lesistenza di un Dio nel senso delle definizioni: Ens a se, res infinita, summum bonum, e possa anche stabilire teoreticamente che il carattere di persona proprio dellessenza del sommo bene, tuttavia laffermazione: il Dio esistente persona superioreadogniconoscenzarazionale80. La seconda ragione a sostegno della tesi sullautorivelazione di Dio, riguarda proprio la sua naturachecaratterizzatadaamoreebontuniversali.propriograzieallamorecheDionon pu tacere e nascondersi alluomo perch lamore porta questa persona infinita a manifestare la propria realt in modo spontaneo, ad aprirsi alluomo: Quindi nellessenza di un Dio personale, il fatto che la conoscenza della sua esistenza pu essere possibile soltanto in forza di questo atto fondamentale dellaprire se stessi, del lasciarsi illuminare dal tutto del significato del mondo, che imperniato su Dio e che viene a nostra conoscenza attraverso il suo amore universale e la rivelazione fondata su di esso81. importante notare che luomo conserva la libert daccettare o meno questa rivelazione: la sua colpa infatti consiste nel non accoglierequestaluce,rimanendolegatiallafinitezzadeglioggetti. Il terzo ed ultimo motivo riguarda il fatto che il divino un valore ed un essere infinito, la cui essenza implica che non possa essere colta partendo da realt finite. Su questo punto mi pare significativo che Scheler condivida la critica che Kant compie di tutte le possibili prove (cosmologiche, ontologiche) che pretendono di cogliere lesistenza di Dio, partendo da realt finite. In particolare Kant sottolinea che tali prove sono insufficienti perch esse al massimo ci portano ad una realt pi grande, una causa finita del mondo, ma mai ad un essere e valore infinito. Ritengo che Scheler riprenda questa argomentazione quando afferma che tali prove non soltanto non ci conducono alla personalit, alla santit di Dio, ma neanche ad un creatore del mondo dal momento che il concetto di creazione richiede, per Scheler, lattribuzione a Dio dellaliberavolontpersonale. Sempre nel saggio Absolutsphre und Realsetzung der Gottesidee, il filosofo critica un altro tipodiprova,quellateoreticoassiologica;infattilinsoddisfazionecheluomoprovaperibeni e i valori finiti e la sua ricerca di un valore assoluto, di per s non sono una prova per
80 81
MaxScheler,ProblemederReligion,inVomEwigenimMenschen,cit.,p.332[466].(Corsivimiei). Ivi,p.333[467].
100
StefanoLiccioliIlproblemadelluomonelpensierodiMaxScheler
dimostrare lesistenza di Dio. Alla base di questa esigenza umana darrivare a Dio c la costituzionale tendenza metafisica delluomo. Lapertura della persona allAssoluto, lungi dallessere il frutto di un mero effetto storico contingente, un tratto essenziale della natura umana. Abbiamo visto che tale tendenza non pu essere appagata da una metafisica cio da una conoscenza dellessere e del bene reale assoluto che nasce dalluomo. Ci che questi pu fare solo una metafisica relativa, che riguarda alcuni campi particolari dellessere, come lanima, la natura. Essa costruita collegando i dati scientifici sulla realt con i dati essenziali della filosofia. I suoi risultati sono per solo ipotetici e probabili, non potendo avere che il grado di certezza proprio delle premesse pi deboli, in questo caso le premesse scientifiche82. In questa ottica appare che lunica via per giungere a Dio quella tracciata dalla religione: proprionellafedechecivienedatoquelveroDioconosciutotramitelarivelazione. StefanoLiccioli
Bibliografia
A) TESTIDISCHELER 1. Scheler M., Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler e Manfred Frings, Bern, Francke, 1954sgg.,(voll.IIIIIVVIIIXX). 2. Scheler M., Absolutsphre und Realsetzung der Gottesidee, in Gesammelte Werke, a cura diMariaScheler,X,SchriftenausdemNachlassI,Bern,Francke,1957. 3. Scheler M., Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, II, Bern, Francke, 1954; tr. it. Il formalismo nelletica e leticamaterialedeivalori,Torino,EdizioniSanPaolo,1996. 4. Scheler M., Die Stellung des Menschen im Kosmos, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, IX, Spte Schriften, Bern, Francke, 1976; tr. it. La posizione delluomo nel cosmo, Milano,FrancoAngeli,2000. 5. Scheler M., Probleme der Religion, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, V, Vom Ewigen im Menschen, Bern, Francke, 1954; tr. it. Problemi di religione, in Leterno nelluomo,Milano,Fabbri,1972. 6. Scheler M., Reue und Wiedergeburt, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, V, Vom Ewigen im Menschen, Bern, Francke, 1954; tr. it. Pentimento e rinascita, in Leterno nelluomo,Milano,Fabbri,1972.
Cfr. Giovanni Ferretti, Filosofia della religione, in Max Scheler, II, Milano, Vita e pensiero, 1972, p. 58. Condivido questocommentodiFerrettisoprattuttopercheglifariferimentoaduntemainteressante:lapportodellascienza alla metafisica. Scheler critica la cosiddetta metafisica scientifica, perch il metodo scientifico mira a costruire deduttivamente una serie di proposizioni, anche se solo verosimili, che servono per dominare il mondo. Questo metodo non considera il problema dellintuizione delle essenze n il valore degli oggetti, mancanze che impedisconoaquestametafisicascientificadiarrivareadunaconoscenzacertaedesaustivadellAssolutoequindia soddisfarelapropensionemetafisicadelluomo.
82
101
Humana.MenteIssue7October2008
7. Scheler M, Vom Wesen der Philosophie und den moralischen Bedingungen des philosophischen Erkennens, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, V, Vom Ewigen imMenschen,Bern,Francke,1954;tr.it.Lessenzadellafilosofia econdizione morale della conoscenzafilosofica,inLeternonelluomo,Milano,Fabbri,1972. 8. Scheler M, Wesen und Formen der Sympathie, in Gesammelte Werke, a cura di Manfred Frings, VII, Bern, Francke, 1973; tr. it. Essenza e forme della simpatia, Roma, Citt Nuova Editrice,1980. 9. Scheler M., Zur Idee des Menschen, in Gesammelte Werke, a cura di Maria Scheler, III, Vom Umsturz der Werte, Bern, Francke, 1955; tr. it. Sullidea delluomo in La posizione delluomonelcosmoedaltrisaggi,Milano,Fabbri,1970. B) TESTIDIALTRIAUTORI 10. Bobbio N., La personalit di Max Scheler, in Rivista di Filosofia, XXIX (1938) 2, pp. 97 126. 11. Gadamer H. G., Philosophische Lehrjahre: eine Rckschau, Frankfurt am Main, Klostermann, 1977; tr. it. Maestri e compagni nel cammino del pensiero. Uno sguardo retrospettivo,Brescia,Queriniana,1980. 12. Gehelen A., Philosophische Anthropologie und Handlungslehre (= Gesamtausgabe 4), Frankfurt am Main, Klostermann, 1983; tr. it Antropologia filosofica e teoria dell'azione, Napoli,Guida,1990. 13. HartmannN.,MaxScheler,inKantstuiden,XXXIII(1928)1/2,pp.IXXVI. 14. Heidegger M., Einfhrung in die Metaphysik, Tbingen, Max Niemeyer, 1966; tr. it. Introduzioneallametafisica,Milano,Mursia,1968. 15. Kant I., Idee zu einer allgemeinem Geschichte in weltbrgerlicher Absicht, 1784; tr. it. Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Scritti politici e di filosofia della storiaedeldiritto,Torino,UTET,1965. 16. Marx K., Die Deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen Philosophie in ihren Re prsentanten Feuerbach, B. Bauer und Stirner, un des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenenPropheten,inMEGA,V,FrankfurtamMainMoskau,1932;tr.it.L'ideologia tedesca: critica della pi recente filosofia tedesca nei suoi rappresentanti Feuerbach, B. BauereStirner,edelsocialismotedesconeisuoivariprofeti,Roma,EditoriRiuniti,1967. 17. Nietzsche F., Also sprach Zarathustra: ein Buch fr Alle und Kein, Chemnitz, Schmeitzner, 1883sgg.;tr.it.CosparlZarathustra,Milano,Adelphi,1991. 18. Wojtila K., Osoba i czyn ora zinne studia antropologiczne, Lublino, KUL, 1969, 19943; tr. it Personaeatto,SantarcangelodiRomagna,Rusconilibri,1999. C) LETTERATURACRITICA
102
StefanoLiccioliIlproblemadelluomonelpensierodiMaxScheler
19. AccarinoB.,Tralibertedecisione:alleoriginidellantropologiafilosofica,inAA.VV.,Ratio imaginis: uomo e mondo nell'antropologia filosofica, a cura di Bruno Accarino, Firenze, PontealleGrazie,1991,pp.763. 20. BosioF.,InvitoalpensierodiMaxScheler,Milano,Mursia,1995. 21. Bosio F., Religione e filosofia in Max Scheler: scritti in onore di Ubaldo Pellegrino, in AA. VV.,Azioneecontemplazione,Milano,IPL,1992. 22. BosioF.,SchelerinterpretediNietzsche,inCriterioV(1987)3,pp.192209. 23. Caronello G., Saggio introduttivo a Max Scheler, Il formalismo nelletica e letica materiale deivalori,Torino,EdizioniSanPaolo,1996. 24. CusinatoG.,Scheler.Dioindivenire,Padova,EdizioniMessaggero,2002. 25. Ferretti G., Fenomenologia e antropologia personalistica, in Max Scheler, I, Milano, Vita e pensiero,1972. 26. FerrettiG.,Filosofiadellareligione,inMaxScheler,II,Milano,Vitaepensiero,1972. 27. Ferretti G., Scheler (Introduzione bibliografica e antologica), in AA. VV., Questioni di storiografia filosofica, Il pensiero contemporaneo, a cura di A.Bausola, 4/1, Brescia, La Scuola,1978,pp.93120. 28. Luporini C., Filosofi vecchi e nuovi: Scheler, Hegel, Kant, Fichte, Leopardi, I, Firenze, G. C. Sansoni,1947. 29. MaderW.,MaxScheler,ReinbekbeiHamburg,Rowolht,1995. 30. Pellegrino U., Religione e metafisica in Max Scheler, in AA. VV., Studi di filosofia e di storia dellafilosofiainonorediF.Olgiati,Milano,Vitaepensiero,1962. 31. Racinaro R., Il futuro della memoria: filosofia e mondo storico tra Hegel e Scheler, Napoli, Guida,1985. 32. Riconda G., Introduzione al pensiero di Max Scheler, Torino, Giappichelli Editore, 1985, 2 voll. 33. Spielberg H., The phenomenological movement: a historical introduction, The Hague, Nijhoff,1982. 34. Staude J. R., Max Scheler: 18741928: an intellectual portrait, New York, The Free Press; London,CollierMcMillan,1967. 35. Vanni Rovighi S., Filosofia e religione nel pensiero di Max Scheler, in Religione e filosofia (Relazioni e comunicazioni allXI Congresso Nazionale di filosofia), Milano, 1968, pp. 147 158. 36. ZhokAndrea,IntersoggettivitefondamentoinMaxScheler,Firenze,LanuovaItalia,1997.
103
Humana.MenteIssue7October2008
104
Potrebbero piacerti anche
- SARTRE - L'Esistenzialismo È Un UmanismoDocumento63 pagineSARTRE - L'Esistenzialismo È Un UmanismoGiuseppe100% (1)
- Lessere e Lessenza Etienne Gilson 1416Documento291 pagineLessere e Lessenza Etienne Gilson 1416Javier Valdivia100% (2)
- Bernhard Welte, L'Ateismo Di Nietzsche e Il Cristianesimo. Note Di LetturaDocumento2 pagineBernhard Welte, L'Ateismo Di Nietzsche e Il Cristianesimo. Note Di LetturaLeitmotivPeriodicoNessuna valutazione finora
- Ernst Cassirer. Filosofia Delle Forme Simboliche Vol I. Il LinguaggioDocumento234 pagineErnst Cassirer. Filosofia Delle Forme Simboliche Vol I. Il LinguaggioIulianButnaruNessuna valutazione finora
- Martin HeideggerDocumento11 pagineMartin HeideggerLuca CanegratiNessuna valutazione finora
- Bobbio Max SchelerDocumento23 pagineBobbio Max SchelerAnonymous 4L7zuPcaLNessuna valutazione finora
- Dialnet HomoReligiosusIndagineSullaReligiosita 5363639Documento8 pagineDialnet HomoReligiosusIndagineSullaReligiosita 5363639Liborio Martinez PolloNessuna valutazione finora
- Preve - LukacsDocumento80 paginePreve - Lukacsgyorgy85100% (1)
- Hegel e CristoDocumento12 pagineHegel e Cristobruno_mor33Nessuna valutazione finora
- Appunti Filosofia Morale PDFDocumento110 pagineAppunti Filosofia Morale PDFdaniloNessuna valutazione finora
- Appunti Su AlthusserDocumento11 pagineAppunti Su AlthusserRichi MassaNessuna valutazione finora
- EspositoDocumento24 pagineEspositolvanzago100% (1)
- Contat Confronto Con Heidegger Nel Tomismo ContemporaneoDocumento72 pagineContat Confronto Con Heidegger Nel Tomismo ContemporaneoEleutherosNessuna valutazione finora
- Martin HeideggerDocumento16 pagineMartin HeideggerilguerrierodellaluceNessuna valutazione finora
- Edith Stein e Max Scheler Sull'empatiaDocumento15 pagineEdith Stein e Max Scheler Sull'empatiaLibricusNessuna valutazione finora
- Slide CDocumento28 pagineSlide CFrancesco BonsignoreNessuna valutazione finora
- Costanzo Preve - Ventitreesimo Capitolo Di "Una Nuova Storia Alternativa Della Filosofia"Documento16 pagineCostanzo Preve - Ventitreesimo Capitolo Di "Una Nuova Storia Alternativa Della Filosofia"NaΘjusNessuna valutazione finora
- Tracce di germanicità: Julius Langbehn e la nascita del paradigma indiziarioDa EverandTracce di germanicità: Julius Langbehn e la nascita del paradigma indiziarioNessuna valutazione finora
- Lezioni Hegeliane - U.normale PisaDocumento21 pagineLezioni Hegeliane - U.normale Pisabruno_mor33Nessuna valutazione finora
- Andrea Benino, Ontologia Politica e Soggettivazione. Su Alcune Aporie Dello SpinozismoDocumento21 pagineAndrea Benino, Ontologia Politica e Soggettivazione. Su Alcune Aporie Dello SpinozismoGuillermosibiliaNessuna valutazione finora
- Nichilismo Ab 10Documento5 pagineNichilismo Ab 10francesco venieriNessuna valutazione finora
- Ágnes Heller - La Teoria Dei Bisogni in Marx (1978, Feltrinelli)Documento165 pagineÁgnes Heller - La Teoria Dei Bisogni in Marx (1978, Feltrinelli)Manolo SanchezNessuna valutazione finora
- LA POLITICa Della FilosofiaDocumento28 pagineLA POLITICa Della FilosofiaFrancesco BonsignoreNessuna valutazione finora
- Etos del sacrificio passione per il mondo e filosofia d’occasione: La critica della violenza in Karl Jaspers, Hannah Arendt e Günther AndersDa EverandEtos del sacrificio passione per il mondo e filosofia d’occasione: La critica della violenza in Karl Jaspers, Hannah Arendt e Günther AndersNessuna valutazione finora
- Bruner Psicologo Oltre Ogni Confine - 2017 PDFDocumento17 pagineBruner Psicologo Oltre Ogni Confine - 2017 PDFGaby GhiuzanNessuna valutazione finora
- CUSINATODocumento21 pagineCUSINATOElenaBottani100% (1)
- Scheler PDFDocumento2 pagineScheler PDFÓscar Quevedo VeraNessuna valutazione finora
- EsistenzialismoDocumento16 pagineEsistenzialismoFabio DellisNessuna valutazione finora
- Augusto Del Noce e Rene DescartesDocumento34 pagineAugusto Del Noce e Rene DescartesCarlos Daniel LasaNessuna valutazione finora
- 10.rivelazione Fra Teologia e Filosofia. Rosmini - SchellingDocumento16 pagine10.rivelazione Fra Teologia e Filosofia. Rosmini - SchellingbrunomorabitoNessuna valutazione finora
- Istituto Italiano PER GLI Studi: Filosofici Saggi 37Documento293 pagineIstituto Italiano PER GLI Studi: Filosofici Saggi 37Myriam PanicoNessuna valutazione finora
- L'Epoca del Nichilismo: Appunti per una analisi del nostro tempoDa EverandL'Epoca del Nichilismo: Appunti per una analisi del nostro tempoNessuna valutazione finora
- Lorizio - Quale MetafisicaDocumento44 pagineLorizio - Quale Metafisicabruno_mor33Nessuna valutazione finora
- Agnes HellerDocumento28 pagineAgnes Hellergyorgy85Nessuna valutazione finora
- BLONDELDocumento6 pagineBLONDELkidmarcoNessuna valutazione finora
- Il Concetto Di TempoDocumento77 pagineIl Concetto Di TempoAndixNessuna valutazione finora
- Filosofia e Religione Nel Pensiero Di Mussolini by Armando CarliniDocumento77 pagineFilosofia e Religione Nel Pensiero Di Mussolini by Armando CarliniBob IsAwesomeNessuna valutazione finora
- Vploi Heidegger - RTF 0Documento40 pagineVploi Heidegger - RTF 0Maurizio FalconeNessuna valutazione finora
- Filosofia MoraleDocumento52 pagineFilosofia MoraleMenaEspositoNessuna valutazione finora
- Oltre la conoscenza. Il pensiero metaformale di Guido CalogeroDa EverandOltre la conoscenza. Il pensiero metaformale di Guido CalogeroNessuna valutazione finora
- Cornelio Fabro - Un Grande Filosofo Cattolico Del Novecento - Roberto de MatteiDocumento2 pagineCornelio Fabro - Un Grande Filosofo Cattolico Del Novecento - Roberto de MatteiBrunodeSouzaNessuna valutazione finora
- Alessandro Volpone, Dall'epistemologia Della Pratica Alla Filosofia in Quanto PraticaDocumento32 pagineAlessandro Volpone, Dall'epistemologia Della Pratica Alla Filosofia in Quanto PraticasaffarooNessuna valutazione finora
- La Vita Di NietzscheDocumento11 pagineLa Vita Di Nietzschesarita AviNessuna valutazione finora
- Hegel la dialettica: Introduzione al pensiero hegeliano. Nuova edizione rivista e accresciutaDa EverandHegel la dialettica: Introduzione al pensiero hegeliano. Nuova edizione rivista e accresciutaNessuna valutazione finora
- Jurino (1949) La Filosofia Di Louis LavelleDocumento30 pagineJurino (1949) La Filosofia Di Louis LavelleIma BageNessuna valutazione finora
- Fonnesu - Il Ritorno Dell'autonomiaDocumento37 pagineFonnesu - Il Ritorno Dell'autonomiaArmando ManchisiNessuna valutazione finora
- Teologia Negativa Secondo BalthasarDocumento27 pagineTeologia Negativa Secondo BalthasarJuan F. SardiNessuna valutazione finora
- Zeev Sternhell - Contro L'illuminismo. Dal XVIII Secolo Alla Guerra Fredda-Dalai Editore (2007)Documento581 pagineZeev Sternhell - Contro L'illuminismo. Dal XVIII Secolo Alla Guerra Fredda-Dalai Editore (2007)Marco CagolNessuna valutazione finora
- Lezioni Sulla Fenomenologia Della Temporalità Di HusserlDocumento204 pagineLezioni Sulla Fenomenologia Della Temporalità Di HusserlLibricusNessuna valutazione finora
- Il Tao Della Fisica - RecensioneDocumento5 pagineIl Tao Della Fisica - RecensioneGiuseppe LiniNessuna valutazione finora
- Il Problema Del Cominciamento FilosoficoDocumento30 pagineIl Problema Del Cominciamento FilosoficoLory PirasNessuna valutazione finora
- Marx AlienazioneDocumento2 pagineMarx AlienazioneElettra RizzottiNessuna valutazione finora
- Il Valore Magico de La Palabra FlorenskyDocumento52 pagineIl Valore Magico de La Palabra FlorenskyAlessandra FrancescaNessuna valutazione finora
- Il Platone Di Enzo MelandriDocumento18 pagineIl Platone Di Enzo Melandrilorenzen62Nessuna valutazione finora
- La Filosofia Di AristoteleDocumento5 pagineLa Filosofia Di AristoteleMichela MaroniNessuna valutazione finora
- Guardini L Essenza Del CristianesimoDocumento3 pagineGuardini L Essenza Del Cristianesimomid3naNessuna valutazione finora
- HeideggerDocumento8 pagineHeideggerRenzo CandidiNessuna valutazione finora
- Cosmologia Occulta - Bruce LyonDocumento390 pagineCosmologia Occulta - Bruce LyonMax Vietri100% (1)