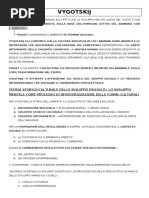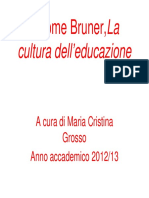Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
788 visualizzazioni5 pagineJerome Bruner
Jerome Bruner, padre della psicologia culturale, sostiene che la cultura permette di superare i limiti biologici e che l'intersoggettività è fondamentale per la condivisione delle esperienze umane. Il suo lavoro si concentra sul pensiero narrativo e sul costruttivismo, evidenziando l'importanza delle interazioni sociali e del linguaggio nello sviluppo cognitivo. Bruner critica l'approccio computazionale della psicologia, proponendo invece una ricerca del significato come elemento centrale nella comprensione delle esperienze umane.
Caricato da
MiriamCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
788 visualizzazioni5 pagineJerome Bruner
Jerome Bruner, padre della psicologia culturale, sostiene che la cultura permette di superare i limiti biologici e che l'intersoggettività è fondamentale per la condivisione delle esperienze umane. Il suo lavoro si concentra sul pensiero narrativo e sul costruttivismo, evidenziando l'importanza delle interazioni sociali e del linguaggio nello sviluppo cognitivo. Bruner critica l'approccio computazionale della psicologia, proponendo invece una ricerca del significato come elemento centrale nella comprensione delle esperienze umane.
Caricato da
MiriamCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd