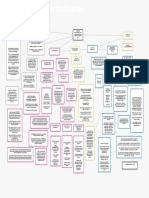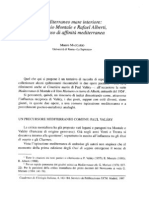Poesia Dante in Borges
Caricato da
Anna BoccutiPoesia Dante in Borges
Caricato da
Anna BoccutiLA POESIA DI DANTE SECONDO JORGE LUIS BORGES
Author(s): Nicola Longo
Source: Dante: Rivista internazionale di studi su Dante Alighieri , Vol. 4 (2007), pp. 89-114
Published by: Fabrizio Serra Editore
Stable URL: [Link]
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@[Link].
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
[Link]
Fabrizio Serra Editore is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Dante:
Rivista internazionale di studi su Dante Alighieri
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
LA POESIA DI DANTE
SECONDO JORGE LUIS BORGES*
Nicola Longo
Sulla poetica
L ’i dea di poesia che ha animato l’intera opera di Jorge Luis Borges si
trova disseminata nei due volumi delle opere disponibili in italiano
per lo più con il testo originale a fronte, ma io la trarrò, prevalentemente,
dalla traduzione italiana di un libretto stampato a Madrid nel 982 2 che
raccoglie i suoi studi danteschi e che l’autore, a suo tempo, ha giudicato
« una collezione di refusi ». 3
Qui egli pone al centro della propria riflessione un giudizio di Robert
Luis Stevenson secondo cui « i personaggi di un libro sono filze di paro-
le ». 4 Sembra, dunque, evidente che per Borges la letteratura ha una giu-
risdizione extraterritoriale rispetto alla realtà (è un’altra, antica e magica
second life di cui parlano le attuali cronache internettiane). Un mondo
parallelo in cui non valgono le categorie separate di spazio e di tempo
e tanto meno, come vedremo, la logica aristotelica del principio di non
contraddizione, se è vero come è vero, che ogni segno linguistico può
contenere contemporaneamente un significato ma anche altri significati.
Questa idea di poetica è espressa bene in una pagina del racconto L’attesa,
contenuto in Aleph, in cui del misterioso protagonista si dice che « l’idea di
una coincidenza fra l’arte e la realtà gli è estranea ». 5
La letteratura, del resto, per Borges è anche l’esito di una lunghissima
sequenza di testi, prima orali e poi scritti, che l’hanno preceduta. In ter-
mini banali, si può affermare che ogni opera letteraria rappresenti il punto
d’arrivo, la summa di tutte quelle che sono state scritte prima 6 e, nello stes-
* Questo studio deriva da una relazione svolta in occasione di un Seminario di Studi in
onore di Jorge Luis Borges, tenuto presso l’Auditorium di Palazzo Sora a Roma, il 6 giu-
gno 2007, per iniziativa di Saverio Avveduto e di Lina Lo Giudice Sergi, rispettivamente,
Presidente e Vicepresidente dell'Università di Castel Sant’Angelo.
Jorge Luis Borges, Tutte le opere, a cura di Domenico Porzio, i, Milano, Mondadori,
984 ; ii, ivi, 985. In seguito indicato come Opere.
2
Jorge Luis Borges, Nueve ensayos dantescos, introducción de Marcos Ricardo Barna-
tán, presentación por Joaquin Arce, Selecciones austral, Madrid, Espansa-Calpe, 982, pp.
62 ; trad. it. Nove saggi danteschi, a cura di Tommaso Scarano, Milano, Adelphi, 200. In
seguito indicato come Borges. Da questa edizione ricavo le date delle composizioni, in
assenza di una Nota al testo, nell’edizione mondadoriana.
3 4 5
Borges, p. 42. Ivi, p. 39. Opere, i, p. 876.
6
Scrive acutamente Scarano, nel saggio Finzioni dantesche, collocato come Postfazione
«dante» · iv, 2007
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
90 nicola longo
so tempo, si pone entro quel medesimo filone della tradizione che prepara
le opere che verranno.
A conferma di ciò, Borges sostiene che nella letteratura si dà ciò che
non è possibile nella realtà (e che, almeno in parte, rinvia a quanto la
retorica definisce adynata o impossibilia), cioè che due eventualità con-
trapposte possano coincidere e coesistere, proprio in grazia di quella spe-
ciale funzione del linguaggio letterario dai linguisti chiamata poetica, che
manifesta, entro il medesimo segno, quei valori semantici connotativi che
ne costituiscono la ricchezza. Da questo punto di vista, come vedremo,
Borges, sia pure indirettamente, ci fa sospettare che il fenomeno letterario
sia per lui assai prossimo all’universo del sogno.
C’è un altro spunto di riflessione che non si può trascurare prima di
entrare in alcuni luoghi essenziali per il tema che ho accettato di svolgere.
Si tratta della centralità della poesia nella vita dell’umanità. Partendo da
una citazione dall’Odissea : « gli dei tessono disavventure per gli uomini
affinché le generazioni future abbiano qualcosa da cantare » e da una di
Mallarmé : « tutto sfocia in un libro », Borges arriva alla conclusione che
siamo fatti per l’arte, che siamo fatti, per la memoria, per la poesia o forse per
l’oblio. Ma qualcosa resta e questo qualcosa è la storia o la poesia, che non sono
essenzialmente diverse. 2
Mi sembra chiaro, dunque, che il contenuto dell’arte sia giudicato essere
un’esperienza prevalentemente dolorosa. La quale può essere cantata, può
diventare poesia, solo a partire dalla capacità di riviverla attraverso la media-
zione del ricordo, cioè attraverso l’opera di Mnemosine, madre di Calliope e
di Clio, come dire progenitrice della poesia e della storia, trovando le parole
per rendere bella l’espressione di quel sentimento che solo così trova un’eco
in chi riceve poi quel messaggio. Perciò il compito di conservare i segni delle
esperienze passate è affidato alla poesia e alla storia. In questa prospettiva
il libro è l’oggetto, insieme reale e simbolico, che rappresenta, contiene e
tramanda quell’esperienza nelle forme che sono proprie dell’arte.
Borges e la Commedia
Tuttavia vorrei parlare del Dante di Borges, campo assolutamente privile-
giato per mettere alla prova queste scarne idee che ho saputo trarre dalla
riflessione, assai più complessa quanto straordinariamente ricca, di Borges.
al citato volume : « […] Borges avanza la teoria della creazione letteraria come infinita e
anonima confluenza di creazioni preesistenti » (Borges, p. 75).
Cfr. infra p. 0, nota .
2
Borges, pp. 3-4. Con queste stesse citazioni dall’Odissea e di Mallarmé comincia
anche il saggio Del culto dei libri, stampato in Altre inquisizioni, Feltrinelli, Milano 963
(Opere, i, p. 00) ; questa informazione si trova in Domenico Porzio, Introduzione a
Opere, i, p. xxii.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
la poesia di dante secondo jorge luis borges 91
Per avviare il discorso comincerò, nell’attraversamento dei suoi studi, da
una convinzione che è alla base del modo con cui ha percepito la Divina
Commedia. Egli afferma di ritenere con certezza che Dante « abbia edificato
la triplice architettura del suo poema per introdurvi » il suo incontro con
Beatrice, al fine di mitigare la tristezza prodotta dalla sua morte. Sicché il
Poema Sacro è, insieme, la realizzazione di una promessa formulata fin dalla
conclusione della scrittura della Vita nuova, e un atto d’amore compiuto
per elaborare e sublimare la sofferenza di una separazione, di un allonta-
namento definitivo, di un lutto. Questo è dunque il senso profondo e vero
dell’opera dantesca e da questo senso primitivo e fondante, discendono
anche alcune interpretazioni certamente deformanti che, come vedremo,
Borges propone con la sua analisi, altrettanto certamente, geniale.
Del resto, in proposito scrive Paoli, offrendoci una chiave interpretativa
straordinaria quanto affascinante e utile per penetrare nell’universo lette-
rario di Borges, « Serpeggia per tutta l’opera il pensiero che la letteratura
sia spesso, forse sempre, il mesto risarcimento di uno scacco di fronte agli
altri, al mondo esterno ; il surrogato di una vita che non si è concessa ». 2
Egli è stato un lettore attento e costante della Divina Commedia ed anche
dei commenti che ne hanno accompagnato la fortuna. 3 Il primo rapporto
totale con quest’opera è narrato in una pagina memorabile che mi sem-
bra indispensabile citare per intero :
Quando ho letto per la prima volta la Commedia mi sono lasciato trasportare dalla
lettura. L’ho letta come ho letto altri libri meno famosi. Voglio confessarvi […] la
storia del mio commercio personale con la Commedia.
Tutto ebbe inizio poco prima della dittatura. 4 Ero impiegato in una biblioteca
del quartiere Almagro. Abitavo in calle Las Heras angolo Pueyrredón, dovevo
percorrere in lenti e solitari tranvai il lungo tratto che da quel quartiere del nord
Borges, p. 94.
2
Roberto Paoli, Borges e Dante, in Idem, Borges e gli scrittori italiani, Napoli, Liguori,
997, pp. 87-07: p. 02. In seguito indicato con Paoli. Questo saggio, fondamentale intro-
duzione alla comprensione dell’opera borgesiana e che in queste pagine viene proficua-
mente utilizzato, appare la prima volta, con lo stesso titolo, in « Studi danteschi », 56, 984,
pp. 89-22.
3
Un elenco, probabilmente del tutto completo dei commenti antichi e moderni alla
Commedia, conosciuti e citati da Borges, si trova in Lore Terracini, Dante e Borges, « Lettu-
re Classensi », 4, 985, pp. 2-36: p. 28. In seguito indicata con Terracini. Ai commenti
danteschi in Borges fa riferimento Paoli per sostenere, giustamente, come la passione di
Borges per Dante « non è viscerale » perché egli « ama la pedanteria dei chiosatori » (pp. 92-
93: p. 93). Per alcuni rinvii ai commentatori, vd. Borges, p. 2. Inoltre, uno dei tanti segni
del rapporto speciale di Borges con Dante è testimoniato dalla pagina in cui Domenico
Porzio, riferendo di un suo incontro con Borges, ricorda le modalità di una amicale e do-
mestica lettura della Commedia che mantiene, ancora nel giugno dell’’85, la freschezza dei
primi approcci al poema (Opere, ii, pp. xiii-xv).
4
Il riferimento è all’elezione del 946, che vide la vittoria alla Presidenza dell’Argentina
di Juan Domingo Perón il quale presto instaurò una sorta di dittatura populista.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
92 nicola longo
va fino ad Almagro Sud, a una biblioteca situata in avenida La Plata all’altezza
di Carlos Calvo. Il caso […] mi fece imbattere in tre piccoli volumi nella libreria
Mictchel, oggi scomparsa, e che mi evoca tanti ricordi. Quei tre volumi (avrei
dovuto portarne uno come talismano oggi) erano l’Inferno, il Purgatorio, e il Para-
diso, tradotti in inglese da Carlyle, non Thomas Carlyle, di cui parlerò più tardi.
Erano libri molto maneggevoli, editi da Dent. Mi stavano in tasca. In una pagina
c’era il testo italiano e nell’altra la traduzione inglese, letterale. Escogitai questo
modus operandi : leggevo prima un brano, una terzina, in prosa inglese ; poi legge-
vo lo stesso brano, la stessa terzina, in italiano ; continuavo così fino alla fine del
canto. Quindi leggevo l’intero canto in inglese, e poi in italiano. A questa prima
lettura capii che le traduzioni non possono sostituire il testo originale ; anche se
possono essere un mezzo e uno stimolo per avvicinare il lettore all’originale,
soprattutto nel caso dello spagnolo.
Non è forse questa liturgia dell’approccio al testo dantesco, un segno di
quanto stretto sarà in seguito il legame dello scrittore con Dante ? Egli
continua dicendo, non senza una punta di civetteria, di non conoscere
altro italiano se non la lingua di Dante e non è forse questa, prima di Pe-
trarca e Boccaccio, la lingua fondante della nostra tradizione letteraria ?
Anche intorno a questa citazione, mi sembrano importanti le osser-
vazioni che Terracini svolge, richiamando due elementi fondamentali
della formazione di Borges : da un lato la presenza forte della ‘sua’ città
– quartieri, edifici, case, palazzi, strade, negozi – e dall’altra il richiamo
(che, del resto, risulta anche negli studi di Paoli) alla cultura inglese, attra-
verso cui egli è giunto alle letterature europee e in particolare alla poesia
di Dante. 2
Prima di entrare nel merito dei ragionamenti e delle osservazioni che
il poeta argentino svolge intorno alla Commedia, va precisato che il suo
modo di leggere il testo non prevede mai l’analisi integrale di un canto.
Piuttosto egli coglie, nei suoi studi, il nucleo essenziale di un episodio,
attento alla centralità dei singoli personaggi intorno a cui ruota la rifles-
sione dantesca e da cui emerge la sua grande poesia. Dobbiamo dire che è
questo, probabilmente, un residuo di cultura romantica che nelle grandi
individualità, nei grandi personaggi, ha sempre concentrato il dato poe-
tico delle opere letterarie. Si pensi come prova di questa affermazione,
alla lettura desanctisiana del poema, ugualmente incentrata sulle figure
dominanti di Francesca, di Farinata, di Ugolino.
Per concludere questo discorso introduttivo, è indispensabile ricordare
come per Borges la Commedia sia
l’apice della letteratura e delle letterature […] è un libro che tutti dobbiamo
Borges, pp. 0-. Il brano è tratto dalla conferenza del giugno del ’77 che, come
tutte le conferenze, non si trova raccolta nelle Opere e che qui è pubblicata in Appendice,
2
col titolo La Divina Commedia (Borges, pp. 05-38). Terracini, p. 25.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
la poesia di dante secondo jorge luis borges 93
leggere. Non farlo significa privarci del dono più grande che la letteratura può
offrirci.
E ancora, aggiunge :
dobbiamo leggere il poema di Dante con la fede di un bambino, abbandonarci ad
esso ; ed esso ci accompagnerà per tutta la vita. Sono tanti anni che la Commedia
mi accompagna, e so che se la leggerò domani vi troverò cose che finora non ho
visto. 2
In questa valutazione superlativa dell’opera dantesca sta la garanzia dei
giudizi formulati da Borges. I quali, anche se talvolta non possono essere
assunti come valutazioni esegetiche utili alla comprensione del testo,
restano comunque a testimonianza di una straordinaria capacità di rea-
zione emotiva, di compartecipazione sentimentale all’universo poetico di
Dante, così quei giudizi finiscono con l’essere l’indispensabile chiave per
penetrare nell’universo fantastico di Borges scrittore.
Proprio di questo nesso fra l’attività creativa di Borges e la sua lettura
“critica”, fortemente intinta di istanze provenienti da quella attività, si
occupa il ricco saggio, già citato, di Terracini. In particolare la studiosa
si sofferma intorno all’ampia serie di autori di tutte le letterature cono-
sciute, che Borges invoca costantemente quando parla/scrive di Dante.
Sicché, ella afferma, lo scrittore stabilisce continui « rapporti fra un testo e
l’altro ». 3 Del resto è difficile non concordare con queste osservazioni che
vedono il Dante di Borges come un personaggio scaturito dalla fantasia
creatrice dello scrittore fino a considerare che « Dante diventa personaggio
di un testo narrativo di Borges », 4 evidenziando, poi, con grande acume,
come in « questa filologia fantastica […] le fonti gareggiano col testo deri-
vato e la competizione si svolge a ritroso nel tempo ». 5
Ugolino
Il volumetto è composto da nove saggi con un’Appendice, di cui s’è già
detto, 6 ed un Prologo. Quest’ultimo deriva, in parte, come annota il cura-
tore, 7 dall’Introduzione ad un’edizione argentina della Commedia, allestita
nel 949 e in cui confluirono anche tre brani già apparsi l’anno prima
sul quotidiano «La Nación» e dedicati ad Ugolino, a Ulisse e a Beatrice.
Proprio questi tre interventi, ritornati ad essere indipendenti in questa
2
Borges, p. 3. Ivi, p. 38.
3 4
Terracini, p. 29. Ivi, p. 32.
5
Ivi, p. 36. La medesima idea del nesso irrazionale fra l’autore e la sua fonte si trova
sviluppata a conclusione del saggio di Paoli (pp. 06-07) che ricorda quanto scriveva Bor-
ges circa la possibilità di percepire lo stesso sapore nei racconti di Hawthorne e di Kaf ka :
« un grande scrittore crea i suoi precursori » (Opere, i, p. 964).
6 7
Cfr. supra, p. 92, nota . Borges, pp. 43-44
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
94 nicola longo
nuova collocazione, sembrano particolarmente importanti, in quanto
esprimono alcune delle idee forti e dei contributi più originali della lettura
borgesiana di Dante. Inoltre, anche sfogliando le pagine degli altri scritti,
si potrà ricostruire, sia pure attraverso alcuni discorsi frammentari, la sua
interpretazione dei due personaggi principali del canto v dell’Inferno.
Il secondo saggio della raccolta, intitolato Il falso problema di Ugolino,
affronta quasi ex abrupto la questione centrale del canto xxxiii dell’Infer-
no :
Ho l’impressione che [i commenti] nel caso del famoso verso 75 del penultimo
canto dell’Inferno [« poscia più che ’l dolor, poté ’l digiuno »], abbiano creato un
problema che nasce da una confusione tra arte e realtà.
Insomma Ugolino si macchia anche del delitto di antropofagia o no ? Nes-
suno s’è mai posto il problema del fatto che ove questo peccato bestiale
fosse stato compiuto, esso non avrebbe trovato alcuna corrispondenza
nella condizione dell’anima di Ugolino così come ci appare moralmente
determinato nell’aldilà dantesco. La risposta di Borges a quella domanda,
invece, che dipende – come precisa Scarano 2 – « in buona parte da una
nota di Luigi Pietrobono », risulta del tutto coerente con la sua idea di
letteratura. Egli richiama i luoghi del canto in cui Dante dissemina l’im-
pressionante immagine del mangiare carne umana, e non sono pochi, a
cominciare dal « fiero pasto » a cui l’anima del traditore era dedita con con-
sapevole voluttà di vendetta, fino all’atto del tornare a rodere (è il verbo
borgesiano) il capo dell’arcivescovo Ruggieri, passando per l’immagine
del sogno delle cagne magre che azzannano il lupo e i lupacchiotti ; e poi
al moto quasi inconsapevole che porta Ugolino a mordersi entrambe le
mani e al conseguente gesto dei figli che gli offrono le proprie carni per-
ché egli sopperisca ai morsi della fame. Tutto ciò s’inscrive perfettamente
entro il campo semantico dell’antropofagia. La questione di partenza,
tuttavia, è risolta da Borges lasciando per intero alla grande poeticità del-
l’espressione dantesca l’enigmaticità che gli appartiene e che certamente
non è casuale. Se Dante avesse voluto, sarebbe stato chiaro come solo lui
sa essere. In questo caso egli ha voluto lasciare al lettore la doppia possi-
bilità di interpretazione.
Per dirla con Borges, la soluzione è la seguente : « Ugolino divora e non
divora gli amati cadaveri, e questa oscillante imprecisione, questa incer-
Per l’espressione di questa identica idea cfr. supra, p. 89, nota 5.
2
Borges, p. 46. Qui è citato un ampio brano del commento di Pietrobono nella
edizione torinese del 923-926. Nell’edizione che ho consultato io, la bolognese del 954
(pp. 303-304), lo studioso esclude con sicurezza l’interpretazione di Ugolino antropofago
perché nel suo progetto di accrescere la colpa dell’arcivescovo, Ugolino avrebbe ottenuto
di oscurarla di fronte all’orrore del suo gesto bestiale.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
la poesia di dante secondo jorge luis borges 95
tezza è la strana materia di cui è fatto ». Del resto è privilegio del linguag-
gio poetico contraddire, se così mi è permesso esprimermi, il principio
di non contraddizione della logica aristotelica secondo cui è impossibile
che, per la medesima considerazione, la stessa cosa sia e non sia, perché
è sua (del linguaggio poetico) qualità specifica la plurisemanticità (deter-
minata dal valore connotativo del segno che lo costituisce), nonché la
funzione prevalentemente poetica che consiste nell’attenzione orientata
verso l’organizzazione formale del messaggio piuttosto che verso la sua
nuda proprietà. Sono questi principi che dominano l’intera opera creativa
di Borges e che, quindi, inevitabilmente, segnano anche la sua lettura dei
poeti e di Dante in particolare.
Non si deve trascurare, tuttavia, come il fastidio verso certe forme estre-
me di ricercatezze barocche (il concettismo di Gongóra, ad esempio) porti
Borges a segnalarne la presenza persino nel verso dantesco che dice « tu ne
vestisti queste misere carni, e tu le spoglia », 2 da lui avvertito come « una
delle rare falsità presenti nella Commedia ». 3
Entro questo scambio continuo e fruttuoso, fra Borges scrittore e Bor-
ges lettore di Dante, ancora a proposito di Ugolino, si deve ricordare la
citazione che del personaggio fa Borges nei seguenti versi dedicati a La
fame, nella poesia omonima :
In Pisa, nella torre dove languì Ugolino
vanti il tuo monumento e nella strofe breve
in cui scorgiamo appena i suoi ultimi giorni
come nell’ombra che si addensa le agonie. 4
Qui, rimane intatta l’idea dell’ambiguità del messaggio ; al poeta lettore non
resta che esaltare quel grande « monumento » alla fame che, negli ultimi
giorni, lascia solo intravedere nell’ombra le ultime agonie e nulla di più.
Nel racconto L’attesa, citato prima, il personaggio del tutto misterioso,
ma che pure si comprende sopravviva nell’attendere di essere ucciso,
concede al lettore il dubbio di dover morire per una falsa accusa di tradi-
mento. L’indizio è favorito dalla presenza di una edizione della Commedia
nella camera-cella che ha preso a pigione, ed egli « non pensò che Dante
l’avrebbe condannato all’ultimo girone, dove i denti di Ugolino rodono
senza fine la nuca di Ruggieri ». 5 Se non fosse stato che per seminare que-
sto indizio che senso avrebbe avuto il dotto richiamo ?
Ivi, p. 40
2
Inf. xxxiii, 62-63. Paoli (p. 00) sottolinea la contrapposizione fra Dante e Gongóra
che è riconducibile a quella fra Borges e la letteratura che si identifica nel nome di Gon-
3
góra. Borges, p. 37.
4
Opere, ii, p. 43. Il componimento, del 966, è nella raccolta dal titolo L’altro e lo stesso.
5
Opere, i, p. 878. Come s’è già detto (cfr. supra, p. 89, nota 5) il racconto è intitolato
L’attesa (950) e si trova in Aleph.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
96 nicola longo
Ulisse
Nella Nota al testo dei Nove saggi, Scarano cita un’affermazione contenuta in
La sfida (che fa parte della Storia del tango ), in cui, richiamandosi all’espe-
rienza dell’Ulisse dantesco, si afferma « l’oscura e tragica convinzione che
l’uomo è sempre l’artefice della propria sventura ». 2 Mi pare che come
introduzione alla lettura borgesiana dell’Ulisse di Dante questa citazione
presenti una chiave essenziale per comprendere l’esperienza narrata nel
canto xxvi dell’Inferno. Si tratta del riuso di un fortunato topos della latinità
che, fra le varie formulazioni, si legge con queste parole : « faber est suae
quisque fortunae », attribuite dallo Pseudo-Sallustio ad Appio Claudio
Cieco, 3 dove ‘fortuna’ ha evidentemente un significato anceps, dovendosi
intendere sia buona che cattiva sorte.
Nella prima delle sette conferenze tenute a Buenos Aires, quella del giu-
gno del 977, pubblicata, come s’è detto, in Appendice al volume dantesco,
affrontando il tema del personaggio di Ulisse, Borges sottolinea, come
del resto la critica più accorta ha fatto di frequente, la sua vicinanza, fino
alla sovrapponibilità, con il personaggio storico di Dante. 4 In maniera più
precisa, Borges pensa che tale somiglianza consista nell’aver Dante osato
anticipare o comunque conoscere l’imperscrutabile giudizio finale di Dio.
Questo peccato di orgoglio, secondo lo scrittore, è simile a quello di chi ha
voluto superare le colonne d’Ercole per conoscere ciò che all’uomo non
è dato conoscere in vita. 5
Ma il contributo originale della lettura borgesiana del mito dantesco di
Ulisse, consiste nel richiamo, sia pure assai fugace, alla figura di Simbad de
Capitolo aggiunto nel 955, a Evaristo Carriego (Opere, i pp. 263-280. La citazione si
trova a p. 279 e, in questa nuova versione, suona con parole appena diverse : « […] oscura
e tragica convinzione che l’uomo è sempre l’artefice delle proprie sventure, come l’Ulisse
2
del canto xxvi dell’Inferno »). Borges, p. 48.
3
Epistola ad Caesarem senem de repubblica, ,,2.
4
« Dante sentì che Ulisse, in qualche modo, era lui stesso » (Borges, p. 37). « Dante,
novello Ulisse » (Ivi, p. 45). Del resto molti sono i segnali contenuti nella Commedia di que-
sta affinità speciale che accomuna il poeta e il suo personaggio. Paoli, dopo essere giunto
al punto di tentare di identificare l’Ulisse dantesco e quello omerico con Borges, scrive,
conclusivamente : « L’episodio dell’Inferno deve, a giudizio di Borges, la sua tremenda forza
al fatto che Ulisse è lo specchio di Dante » (Paoli, p. 05).
5
Per correttezza, devo dire che nella mia lettura del canto di Ulisse (L’Ulisse di Dante,
di prossima pubblicazione in « Studi petrarcheschi ») ho accolto, semplificandola, l’ampia
e ricca interpretazione di Fubini (Ulisse, in Enciclopedia dantesca, v, Roma, Istituto dell’En-
ciclopedia Italiana, 976, pp. 803-809) che, stando alla lettera del testo, non ritiene che la
morte, che Dio stesso commina ad Ulisse e ai suoi compagni, sia interpretabile come la
punizione di un peccato di superbia ma che essa sia piuttosto la naturale conseguenza di
una vita umana che ha voluto conoscere la morte prima della propria morte, il che, in
seguito al peccato di Adamo, non è concesso al genere umano.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
la poesia di dante secondo jorge luis borges 97
Le mille e una notte e soprattutto alla straordinaria creazione del capitano
Ahab di Melville, la cui sorte finale è vista come identica a quella narrata
da Ulisse nella bolgia dei consiglieri di frode. Quest’ultimo ritiene di dover
giustificare e nobilitare il proprio gesto con la virtù dell’intelligenza che
vuole conoscere l’ignoto e naufraga, per mano di Dio stesso, in un oceano
sconosciuto agli umani, mentre il mare si richiude sopra di lui. Ahab, dal
canto suo, spinto da spirito di vendetta, percorre i sette mari finché, uccisa
la balena bianca, suo mortale nemico, affonda con la nave, scomparendo
nello stesso modo e quasi con le stesse parole dell’Ulisse cantato nell’In-
ferno : « […] poi tutto ricadde, e il gran sudario del mare tornò a stendersi
come si stendeva cinquemila anni fa ». 2
Nel terzo saggio della raccolta, Borges esamina i luoghi della Commedia
in cui tornano le parole più importanti del canto di Ulisse (« folle volo »
di Inf. xxvi, 25 ; « varco folle » di Par. xxvii, 82-83 ; « venuta folle » di Inf.
ii, 35 ; « com’altrui piacque » di Inf. xxvi, 4 e di Purg. i, 33) per trarne la
conclusione delle affinità e delle differenze 3 che ci sono fra Dante e Ulisse.
Quindi lo scrittore-lettore sottolinea la distanza esistente fra l’avventura
di Ulisse, che consiste nella scelta di intraprendere un viaggio impossibile,
e quella di Dante che non sta, come si potrebbe superficialmente pensare,
nell’esperienza dell’attraversamento dei tre regni ultraterreni, ma nella
straordinaria impresa della scrittura del libro. Ciò, tuttavia, non basta a
segnare la lontananza fra le due vicende, perché Ulisse supera la consape-
volezza della follia del suo volo con l’intraprenderlo senza esitazioni, men-
tre Dante, prima di mettersi nell’alto passo, espone a Virgilio, come più
tardi farà con Cacciaguida, i dubbi della propria coscienza religiosa, circa
l’opportunità di argomentare il giudizio sui morti e sui vivi. La medesima
angoscia, di ordine religioso, il poeta manifesta, secondo Borges, nell’in-
venzione eccezionale della nuovissima leggenda di Ulisse, attraverso la cui
disavventura si intravede la possibile condanna che merita chi presuma di
rivelare il misterioso giudizio di Dio.
Francesca
Non c’è uno studio preciso dedicato al personaggio di Francesca da Ri-
mini. Tuttavia molti sono i riferimenti che in questi Nove saggi danteschi
Molti sono gli interventi borgesiani su quest’opera. Fra questi non si dimentichino :
la sezione dedicata a I traduttori delle « Mille e una notte » in Storia dell’eternità (Opere, i, pp.
584-608) ; la poesia dal titolo Metafore delle Mille e una notte, compresa in Storia della notte, in
cui si legge : « I viaggi di Simbad, quell’Odisseo / sospinto dalla sete di avventura, / e non
dal castigo di un dio » (Opere, ii, pp. 038-043: p. 039).
2
Queste sono le parole con cui Cesare Pavese traduce l’explicit del grande romanzo di
Melville e che meriterebbero una loro interpretazione a parte.
3
« Questa azione [la visione del viaggio di Dante] sembra il rovescio di quella [l’impresa
di Ulisse] » (Borges, p. 46).
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
98 nicola longo
riguardano la poeticissima protagonista del canto quinto dell’Inferno. La
costante della lettura che Borges offre delle parole con cui il poeta deli-
nea la figura di Francesca da Rimini, consiste in una gamma variegata di
sentimenti che quelle parole suscitano sia nel personaggio-poeta che le
esprime, quanto nel lettore che le fruisce.
Come s’è accennato all’inizio, tutta la Commedia, secondo Borges, è
organizzata per trovare consolazione alla scomparsa di Beatrice. Quando
il lettore sentimentale del Poema Sacro si incontra con l’infinito amore di
Dante per la sua donna, pensa che lei non corrispose a quell’immenso
sentimento e insieme non può non andare con la mente alle parole di
Francesca (« questi che mai da me non fia diviso » ), immaginando come
Dante, « con un amore spaventoso, con angoscia, con ammirazione, con
invidia, deve aver forgiato questo verso ». 2 Mi sembra evidente quanto
questo punto di vista sia assai lontano dalla cultura, dalla mentalità, dal
sentimento religioso che sono alla base del pensiero e, prima, dell’animo
di Dante perché sono la cultura, la mentalità e il sentimento religioso
del tempo a cui egli appartiene. Pensare che colui che ha immaginato
la ‘visione’ della Commedia con il preciso intento di rappresentare agli
uomini l’universo che li attende dopo la morte, in funzione del loro
comportamento in vita, per convertirli ; ipotizzare che colui che ha inteso
anticipare o esprimere il giudizio definitivo (‘il giudizio di Dio’) su uomi-
ni che hanno avuto in loro potere i destini del mondo, possa avvertire il
sentimento dell’invidia verso chi si trova sotto la pena eterna della « bufera
infernal, che mai non resta », 3 sia pure unito per l’eternità con l’oggetto
della propria passione amorosa, significa trascurare quell’elemento reli-
gioso che accompagna e determina costantemente l’intera visione del
mondo del Medioevo e di Dante e che rende viva e vera la sua poesia ;
significa mettere in sottordine la legge dell’Amore di Dio e verso Dio che,
come è detto in maniera esplicita in Purg. xvii, è l’unico Amore che deve
illuminare e guidare l’umanità nel cammino terreno verso l’unica meta
che è l’Amore assoluto del Creatore.
Eppure quest’idea dell’invidia prevale nettamente nella lettura bor-
gesiana delle straordinarie parole con cui Dante racconta la storia della
passione dei due cognati.
Cosa coglie dell’intero episodio Borges ? Intanto il fatto che l’avvio del
discorso di Francesca, dopo l’invito del personaggio Dante ad avvicinarsi
e parlare, è organizzato sul piano dello stile patetico (« se fosse amico il re
dell’universo, / noi pregheremmo lui de la tua pace » 4). Poi che Francesca
racconta due volte la storia d’amore, insistendo sul fatto che « continua ad
amare Paolo […] fedele al suo peccato ». 5 Quindi, di fronte alla domanda
2 3
Inf. v, 35. Borges, p. 96. Inf. v, 3.
4 5
Inf. v, 9-92. Borges, p. 25
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
la poesia di dante secondo jorge luis borges 99
di Dante che desidera conoscere come s’accorsero di essere innamorati,
Borges afferma che essi non sospettavano di esserlo e qui inserisce di
nuovo il tema straniante dell’invidia :
C’è qualcosa che Dante non dice, ma che si avverte per tutto l’episodio e forse
gli conferisce la forza che ha. Con infinita pietà, Dante ci racconta il destino dei
due amanti e sentiamo che prova invidia per quel destino. Paolo e Francesca sono
nell’Inferno e Dante si salverà ma loro si sono amati, mentre lui non ha ottenuto
l’amore della donna che ama, di Beatrice. […] Dante è separato per sempre da
Beatrice. Invece quei due reprobi stanno insieme. […] condividono l’Inferno, e
questo a Dante dev’essere sembrato una specie di Paradiso.
Questo significa interpretare un testo in maniera personale, da poeta e
non da critico, in maniera soggettiva e non storica, proiettando in esso
i nostri sentimenti dominanti cioè i nostri desideri e non scandagliando
il senso che le parole hanno all’interno di un preciso codice culturale di
riferimento.
La civiltà medievale, nel corso dei mille anni che da Costantino arrivano
a Dante, ha elaborato una filosofia, una teologia, un protocollo di com-
portamento sociale, una precisa gerarchia di valori, tutte cose che hanno
il proprio fondamento nella visione trascendente del mondo : il cosid-
detto legame dell’umanità con Dio mediante il filo della trascendenza.
Naturalmente semplifico per necessità di esposizione. Ebbene la ‘visione’
dantesca (nell’accezione di genere letterario, preciso e comparabile a
tante altre opere coeve che Borges conosce assai bene 2) non si può leg-
gere collocandola sul piano dei valori cosiddetti orizzontali perché essa è,
strutturalmente, un’opera escatologica e in questo senso essa si spiega e si
comprende tanto nel suo insieme quanto in ciascuna sua singola articola-
zione, dal verso alla terzina, all’unità narrativa, al canto, alla cantica. Pen-
sare che Francesca sia felice perché vive per l’eternità accanto al suo Paolo
significa lasciarsi sfuggire il senso profondo dell’Inferno dantesco che,
prima di ogni pena, consiste nell’assenza di Dio e nella consapevolezza di
quell’assenza. Altrimenti arriveremmo a confondere il beati del Paradiso
con i sapienti del Limbo e tante altre simili confusioni ci impedirebbero di
capire il valore autentico (‘sacro’) che proprio Dante per primo attribuisce
al suo poema, « al quale [non a caso] ha posto mano e cielo e terra ». 3
In realtà sia Francesca che Paolo, proprio perché continuano a provare
amore l’uno per l’altro, si trovano nella condizione di avere una punizio-
ne ben superiore (doppia) rispetto a quella degli altri spiriti del secondo
cerchio.
Borges, p. 28.
2
Si veda almeno il saggio del 957, intitolato Dante e i visionari anglosassoni, in Borges,
3
pp. 59-69. Par. xxv, 2
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
100 nicola longo
C’è un ulteriore interessante richiamo al canto di Francesca e consiste in
una breve notazione – starei per dire – sonora, dell’ultimo verso :
E caddi come corpo morto cade.
Scrive Borges : « Perché la caduta rimbomba ? Rimbomba per la ripetizione
del verbo cadere ». 2 A tale ovvia conclusione si può giungere solo quando
non si sia perduto di vista il semplice ed evidente fenomeno che vuole
che ‘quella’ caduta sia fatta di parole e il suono a cui esse rinviano possa
essere amplificato solo da una ripetizione. Mi pare una grande lezione, per
esegeti approssimativi che leggono credendo di trovare nelle parole della
letteratura la stessa sostanza dolorosa della vita.
A proposito di questo canto, si deve ricordare come, col titolo Inferno
v 129, 3 nella raccolta La cifra, si legga una poesia. Questo è il testo che si
trascrive per la necessità della breve analisi :
Lascian cadere il libro, ormai già sanno
che sono i personaggi del libro.
(lo sanno di un altro, l’eccelso,
ma ciò ad essi non importa.)
Adesso sono Paolo e Francesca,
non due amici che dividono
il sapore di una favola.
Si guardano con incredulo stupore.
Le mani non si toccano.
Hanno scoperto l’unico tesoro ;
hanno incontrato l’altro.
Non tradiscono Malatesta
perché il tradimento richiede un terzo
ed esistono solo loro due al mondo.
Sono Paolo e Francesca
ma anche la regina e il suo amante
e tutti gli amanti esistiti
dal tempo di Adamo e la sua Eva
nel prato del Paradiso.
Un libro, un sogno li avverte
che sono forme di un sogno già sognato
nelle terre di Bretagna.
Altro libro farà che gli uomini,
sogni essi pure, li sognino. 4
Il gioco di questa costruzione sta tutto nella sovrapposizione fra il libro
2
Inf. v, 42. Borges, p. 6.
3 4
Si tratta del verso « soli eravamo e senza alcun sospetto ». Opere, ii, p. 223.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
la poesia di dante secondo jorge luis borges 101
galeotto, quello che i due protagonisti lasciano cadere fin dal primo verso,
e l’altro libro, quello « eccelso » del quale essi, con la storia del loro amore,
sono parte fondamentale. La loro breve avventura si colloca in uno spazio
letterario, fatto di parole, che conduce dallo stupore incredulo, dimostrato
dalle mani che non si toccano, alla grande scoperta dell’amore dell’altro. E
la scena del mondo si fa deserta, nessuno, nemmeno Malatesta, la occupa
più, all’infuori di loro due innamorati.
Così Francesca e Paolo finiscono nell’identificarsi con Ginevra, la regi-
na, e il suo amante, Lancillotto, ma anche con tutti gli amanti di sempre.
Sicché essi sono consapevoli di essere un sogno già sognato tante volte
dagli uomini che, ricordando Calderon, pure essi sono un sogno, cioè un
semplice esito della letteratura.
Beatrice
Il saggio L’incontro in un sogno, pubblicato nel ’48, e quello intitolato L’ul-
timo sorriso di Beatrice, che deve risalire, secondo Scarano, allo stesso giro
d’anni, 2 sono due interventi che illustrano la visione borgesiana del perso-
naggio di Beatrice nella Commedia.
Nel primo di questi scritti Borges spiega, con la solita chiarezza, effi-
cacemente didascalica, il contesto in cui finalmente, dopo tanta doloro-
sa attesa, il poeta pellegrino incontra di nuovo Beatrice. Nel Paradiso
terrestre, fermata la processione, Dante personaggio avverte, nel suo
corpo, la vicinanza della donna per la quale, secondo Borges, egli aveva
« professato una religione idolatrica » ; 3 la quale donna, sempre secondo
lo scrittore, « si era burlata di lui e l’aveva respinto », 4 in quella situazione
sentimentale, di chi avverte in sé uno stato d’animo che lo riporta ad
un’altra epoca, ad un altro mondo, egli si gira e non trova più accanto
a sé Virgilio, 5 a cui poter dire quel verso bellissimo tradotto dall’Eneide :
« conosco i segni dell’antica fiamma ». 6 Invece è Beatrice che, in questa
circostanza di ulteriore abbandono, lo invita a piangere non per la rin-
Del rapporto fra sogno e letteratura Borges scrive, oltre che in tanti altri luoghi, anche
nella conferenza su Hawthorne, che si apre con un discorso sulla metafora del teatro
come sogno. Collocati in epigrafe, si trovano dei versi di Gongóra, quindi lo scrittore cita
Jung che « paragona le invenzioni letterarie alle invenzioni oniriche, la letteratura ai sogni »
2
(Opere, i p. 953). Borges, pp. 54-55.
3
Borges, p. 94. A tale idolatria Borges è forse condotto, come sospetta Paoli (p. 0, n.
59 ; il capitolo indicato da lui è, erroneamente, il xxxii), dalla lettura di Giovanni Papini,
Dante vivo, cap. xxxiii, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 933, pp. 288-296.
4
Ibidem.
5
Anche in questo caso s’innesca un procedimento di compianto funebre per l’abban-
dono : « ma Virgilio n’avea lasciati scemi / di sé, Virgilio dolcissimo patre, / Virgilio a cui
6
per mia salute die’mi » (Purg. xxx, 49-5). Purg. xxx, 48.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
102 nicola longo
novata solitudine, ma per i suoi peccati (« ché pianger ti conven per altra
spada »).
Così l’incontro, che forse tante volte era stato oggetto di straordinarie fan-
tasticherie, prodotte da un sentimento assoluto, da un « pensiero dominante »
durato tutta la vita, un incontro con la creatura amata come nessun’altra e
chissà quante volte sognato ad occhi aperti, si rivela essere quello con un giu-
dice « implacabile » 2 che elenca i peccati di Dante obbligandolo a confessarli
pubblicamente. Ebbene, di tutta questa scena, Borges coglie da un lato, rapi-
damente, la delusione dell’amante che ritrova dopo tanto tempo la donna
desiderata, e dall’altra si sofferma a spiegare, sulla scorta dei commentatori, i
sensi allegorici della processione a cui Dante aveva appena assistito :
- I ventiquattro anziani sono i libri dell’antico Testamento.
- I quattro animali sono i Vangeli o i quattro Evangelisti.
- Le sei ali ai loro fianchi sono le leggi o la diffusione della dottrina nelle sei dire-
zioni dello spazio.
- Il carro trainato da un grifone è la Chiesa universale.
- Le due ruote del carro sono l’antico e il nuovo Testamento o la vita attiva e
quella contemplativa o S. Domenico e S. Francesco o la Giustizia e la Pietà.
- Il grifone è Gesù Cristo o il papa.
- Le tre donne che ballano alla destra del carro sono le Virtù teologali.
- Le quattro donne vestiste di porpora, alla sinistra del carro, sono le Virtù car-
dinali ; quella di loro con tre occhi è la Prudenza che vede il passato il presente
e il futuro.
- La donna che appare quando il carro si ferma, che ha il capo coperto da un velo
e il vestito di fiamma viva, è finalmente Beatrice.
Con tutto ciò, proprio in questo studio, Borges afferma quanto s’è già
osservato, essere questo incontro il fulcro poetico dell’intera Commedia
costruita per poter narrare l’avvenimento straordinario della realizzazione
di un sogno durato tutta la vita, quello di poter rivedere Beatrice.
Nel saggio L’ultimo sorriso di Beatrice, Borges esamina i canti xxx e xxxi
del Paradiso, in cui le parole esprimono una sofferenza che non fu di
Dante personaggio della Commedia ma solo attraversò e percosse l’anima
di Dante poeta. Si tratta della situazione in cui il pellegrino ha raggiunto
l’Empireo, il cielo di sola luce che contiene un fiume di luce fra due rive
fiorite, e poi il fiume si fa lago e i fiori si rivelano essere gli angeli e le faville
i beati. E la luce si fa forma circolare e poi specchio in cui si riflettono i
beati disposti in più di mille gradini che si aprono verso l’alto in forma di
immensa candida rosa. Qui ad un certo punto Dante « improvvisamente,
avverte che Beatrice l’ha lasciato » : l’endecasillabo dice il passaggio da una
guida all’altra, con tutto il tremore di chi di nuovo soffre il sentimento
dell’abbandono :
2
Purg. xxx, 57. Borges, p. 9.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
la poesia di dante secondo jorge luis borges 103
credea veder Beatrice e vide un sene.
Bernardo gli suggerisce di alzare gli occhi :
e vidi lei che si facea corona
riflettendo da sé li etterni rai. 2
Dopo averle rivolto una preghiera di ringraziamento per il suo intervento
salvifico, ecco la risposta di lei :
Così orai ; e quella, sì lontana
come parea, sorrise e riguardommi ;
poi si tornò a l’etterna fontana. 3
Su questo sorriso si ferma Borges. Dall’idea che il miglior libro della let-
teratura sia stato determinato dal bisogno di creare degli incontri « con
l’irrecuperabile Beatrice », 4 deriva di conseguenza l’idea che « un sorriso e
una voce, che lui sa perduti, sono il fatto fondamentale » 5 della Commedia
dantesca.
In una delle pagine più suggestive di questi saggi, lo scrittore, attraver-
so una struttura anaforica che, con forte effetto emotivo, ripete il nome
di lei – proprio alla maniera in cui Dante saluta Virgilio quando cede
il posto a Beatrice 6 – e ne elenca le straordinarie virtù. 7 Lo stesso mec-
canismo dell’anafora si ritrova nel racconto che dà il titolo alla raccolta
Aleph (dove il nome del personaggio principale è Beatriz). Qui si legge
il seguente passo la cui ispirazione formale ha sicuramente la medesima
matrice : « Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz amata,
Beatriz perduta per sempre, son io, sono Borges ». 8 Sui significati dei tre
nomi di questo personaggio, offre una precisa interpretazione Ruggero
Stefanini, ricordando come il primo nome rinvia alla Commedia e quindi
alla civiltà cristiana ; il secondo a Omero ed alla civiltà pagana; il terzo
(cognome) identifica il personaggio « come gringa e come ebrea, anzi
conversa ». 9
Ebbene, proprio questo calco stilistico svolge la funzione di far ricor-
dare con forza che l’intera situazione, il sorriso come lo sguardo di lei, è
esistita solo nella realtà della letteratura. Scrive Borges :
2 3
Par. xxxi, 59. Par. xxxi, 7-72. Par. xxxi, 9-93.
4 5 6
Borges, p. 0. Ibidem. Cfr. supra, p. 0, nota 5.
7
« Lì, aureolata, c’è Beatrice, c’è Beatrice ; Beatrice il cui sguardo soleva colmarlo d’in-
tollerabile beatitudine, Beatrice ch’era solita vestirsi di rosso, Beatrice alla quale pensava
tanto […], Beatrice che una volta gli aveva negato il saluto, Beatrice che era morta a
ventiquattro anni, Beatrice di Folco Portinari che era andata sposa a Bardi ». (Borges, pp.
8
02-03). Opere, i, p. 895. Cfr. infra, p. 2, nota 6.
9
Rugger0 Stefanini, Dante in Borges : l’Aleph, Beatriz e il sud, « Italica », 57, 980, , pp.
53-65: pp. 56-57.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
104 nicola longo
Ricordiamo un fatto incontrovertibile, un solo umilissimo fatto : la scena è stata
immaginata da Dante
Di qui discende una connotazione del tutto originale di quel sorriso e di
quella infinita lontananza 2 : « nelle parole [di Dante] traspare l’orrore ». 3
Ecco il modo di procedere nella comprensione del testo. Al di là di ogni
ovvietà, Borges, con la sensibilità che solo un grande scrittore può avere e
che gli deriva da una straordinaria conoscenza del genere umano, con, in
più degli altri scrittori ciò che gli è proprio, cioè una forte consapevolezza
della costante distanza che esiste fra realtà e letteratura, fra le parole e le
cose, egli sa scorgere nei versi dell’ultimo saluto di Dante a Beatrice e di
Beatrice a Dante (nella preghiera di ringraziamento dell’uno e nel sorriso
enormemente lontano dell’altra) il segno reale della disperazione.
Mai la critica dantesca è andata così lontano e così in profondità. Né,
in questo caso, è importante stabilire quanto Borges abbia compreso più
degli altri. Ciò che conta è che ha saputo farci intravedere qualcosa in più
che non avevamo sospettato esistesse nei versi e nel cuore di Dante.
La coscienza del poeta di aver potuto trovare solo nel Poema Sacro le
parole per fingere un sogno, per dire un desiderio impossibile, per canta-
re, l’ultima volta, un amore straordinario, vissuto esclusivamente nel suo
cuore e nella sua scrittura, sentimento che è stato perciò sofferenza (d’un
amore non corrisposto, d’un amore per una donna morta, d’un amore
abbandonato) e che solo nella Commedia è stato disperata consolazione
(molto di più che nei versi della Vita nuova e in quelli delle Rime), che è
stato celebrazione e ricerca infinita di un’assente.
Dolce color d’orïental zaffiro
Questo verso del primo canto del Purgatorio non è, come invece è stato
recepito da certi lettori romantici, una pennellata di colore per quanto
straordinaria, ottenuta in grazia di una musicalissima combinazione di
suoni (compresa la dieresi, indispensabile per il ritmo lento dell’endeca-
sillabo). In esso appare concentrato, anche, il significato dell’intera atmo-
sfera di umile ricerca di purificazione dell’anima peccatrice, che domina
tutta la Cantica. 4
Borges, pp. 03-04.
2
Aveva scritto poco prima : « Come un uomo che alzi lo sguardo dall’abisso del mare
alla regione del tuono, da tale distanza la venera e la implora » (Ivi, p. 00).
3
Ivi, p. 04.
4
Per un discorso più analitico relativo a questo verso, all’interno dell’intera poesia del
canto purgatoriale, mi sia permesso rinviare al mio articolo intitolato Il canto d’apertura
del Purgatorio : dalla morte dell’anima alla luce della speranza, di prossima pubblicazione in
« Studi petrarcheschi ».
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
la poesia di dante secondo jorge luis borges 105
Il colore azzurro intenso dello zaffìro (quello orientale è il più puro e
quindi il più pregiato) richiama una certa tonalità del cielo d’Oriente che
si prepara ad accogliere la luce del primo sole, ma qui esso corrisponde
anche ad un preciso elemento della cultura medievale : la scelta di questa
pietra rinvia al suo valore simbolico registrato dai relativi trattati.
Sul « curioso meccanismo di questo verso » si sofferma Borges, speciale
lettore di Dante, rilevando come esso contenga
un gioco di specchi, poiché l’Oriente viene indicato attraverso il colore dello zaf-
firo e questo zaffiro è uno “zaffiro orientale”. Vale a dire uno zaffiro carico della
ricchezza della parola “orientale” ; pieno, per così dire, delle Mille e una notte che
Dante non conobbe, ma che tuttavia sono lì.
Borges è affascinato dalla ricchezza della parola con cui si indica sì una pie-
tra dura dal particolare colore che è possibile accostare alla tinta d’un’alba
primaverile a patto però di non perdere l’altra sua forza di significato
che rimanda proprio a quel mondo d’Oriente (felicemente richiamato
nel nome delle Mille e una notte), a quell’Oriente da cui sale la prima luce
mattutina d’un giorno d’aprile speciale, quando l’anima è appena uscita
dall’aria morta (buia ma anche dei morti) a rivedere le stelle e a comincia-
re a sperare di vedere la Luce.
Come ci ricorda anche Paoli, 2 nel capitolo La metafora della Storia del-
l’eternità (936), si legge uno dei primi riferimenti a Dante :
il curioso verso in cui Dante (Purgatorio, i, 3), per definire il cielo orientale invoca
una pietra orientale, una pietra limpida nel cui nome si trova, per un caso for-
tunato, l’Oriente : « Dolce color d’orïental zaffiro » è, al di là di qualsiasi dubbio,
ammirevole. 3
Si noti che nella Bibbia esiste già un collegamento simile fra il colore della
pietra dello zaffiro e quello del cielo sereno : « E videro Iddio d’Israele ;
sotto i suoi piedi vi era come una lastra lavorata di zaffiro simile in chia-
rezza al cielo stesso ». 4
A tutto ciò si deve però aggiungere che il Medioevo attribuiva allo
zaffìro il potere di liberare le persone dagli incubi. Qui, esso ha, perciò,
la funzione di indicare come Dante si ritrovi, finalmente, con uno stato
d’animo rasserenato, nella condizione di libertà dalle paure che l’hanno
attraversato durante il cammino infernale. Esiste, come si vede, una
precisa corrispondenza fra tali qualità speciali attribuite alla pietra dalla
sapienza dell’epoca e il mondo morale del Purgatorio : liberazione dal car-
cere del peccato, disposizione dell’anima a rivolgersi a Dio, controllo delle
2
Borges, p. 6. Paoli, p. 89.
3
Opere, i, p. 567. Un precedente rapido richiamo alla Commedia, sempre segnalato da
Paoli nello stesso luogo, si trova in La durata dell’Inferno, del 932, testo raccolto in Discus-
sione (Ivi, pp. 366-37).
4
Esodo, 24, 0. Si vd. pure il riferimento in Terracini, p. 26.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
106 nicola longo
passioni. E, ancora, perfetta coincidenza con il rito della lavanda del viso
a cui, poco dopo, Dante si sottoporrà.
Poesia congetturale
Nelle pagine del secondo dei due volumi delle Opere, si legge la poesia dal
titolo Poesia congetturale, che Borges ha scritto nel 943 e che fa parte della
raccolta L’altro, lo stesso. Qui il poeta racconta la storia della tragica fine
di un suo avo materno, Francisco Narciso Laprida, 2 morto nel 829 nella
guerra civile contro i gauchos ribelli. Ecco un brano del testo in cui, oltre
ad una citazione esplicita dal canto v del Purgatorio, si manifesta un chiaro
riuso dei materiali di quel medesimo canto.
Come quel capitano in Purgatorio
fuggendo a piedi e insanguinando il piano 3
fu accecato e abbattuto dalla morte
dove un oscuro fiume perde il nome, 4
così dovrò cadere. Oggi è la fine.
La notte laterale dei pantani
m’insidia e m’imprigiona. 5 Odo gli zoccoli
della mia calda morte che mi cerca
con cavalieri, con musi e con lance.
Io che sognai d’essere un altro, un uomo
di sentenze, di libri, di verdetti,
a ciel sereno giacerò tra il fango ;
ma mi delizia il cuore, inesplicabile
un giubilo segreto. 6
Forse anche sulla scorta di Raimondi (Ezio Raimondi, Rito e storia nel i canto del Purgato-
rio, Lectura Dantis Scaligera, Firenze, Le Monnier, 967, pp. -42; ora in Idem, Metafora e storia.
Studi su Dante e Petrarca, Torino, Einaudi, 9772, pp. 65-94: p. 70), Chiavacci Leonardi, molto
opportunamente, cita un brano del De lapidibus (P. L. 7, 757-780) del vescovo di Rennes,
Marbodo (xi-xii sec.), in cui si riferiscono le virtù attribuite allo zaffiro : « hic lapis […] educit
carcere victos […] vincula tacta resolvit, placatumque Deum reddit […] ardorem refrigerat
interiorem […] tollit et ex oculis sordes » (cito da Marbode, De lapidibus preciosis enchiridion,
excudebat Christianus Wechelus, Parisiis, 53, pp. 92-93) ; [« libera i prigionieri dal carcere […]
al suo tocco scioglie i legami e placa l’ira di Dio […] raffredda gli ardori interni […] leva dagli
occhi ogni sporcizia »] (trad. it in Anna Maria Chiavacci Leonardi, commento al v. 3).
2
Per il quale vd. Opere, i, p. xxvii.
3
« Como aquel capitán del Purgatorio / que, huyendo a pie y ensangrentando el llano,
/ […] ». Il secondo, di questi due versi, ricalca perfettamente il testo dantesco che dice :
« fuggendo a piede e sanguinando il piano » (Purg. v, 99).
4
« Donde un oscuro río pierde el nombre » : anche in questo caso il richiamo dantesco è
quasi letterale. Dante, per indicare il punto in cui il fiume Archiano si immette nell’Arno, lì
dove Buonconte, ferito a morte, spira, dice : « Là ’ve ’l vocabol suo diventa vano » (Purg. v, 97).
5
« La noche lateral de los pantanos / me acecha y me demora », verso che corrisponde
ai seguenti versi danteschi : « Corsi al palude, e le cannucce e ’l braco / m’impigliar sì ch’i’
caddi » (Purg. v, 82-83).
6
Opere, ii, pp. 26-27. A questo componimento è dedicata un’ampia analisi di Paoli (Gli
spunti danteschi del « Poema conjetural » di Borges, in Paoli, pp. 09-8).
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
la poesia di dante secondo jorge luis borges 107
Mi sembra evidente come qui siano presenti entrambi i modelli di morte
violenta, sia quello di Buonconte da Montefeltro, dal cui episodio è rica-
vata la citazione quasi letterale, come s’è visto, che quello di Jacopo del
Cassero, come sostiene Roberto Paoli, citato da Calvino.
Intorno a questo testo, infatti, si sofferma Calvino nel suo intervento
romano su Borges. 2 Queste le parole da lui dedicate alla composizione
borgesiana :
Borges dantescamente immagina i pensieri d’un suo antenato […] ferito dopo la
battaglia, braccato dai gauchos del tiranno Roses, e riconosce il proprio destino
nella morte di Buonconte da Montefeltro così come la ricorda Dante nel v del
Purgatorio. Ha osservato Roberto Paoli, che attinge più ancora che all’episodio di
Buonconte esplicitamente citato, a un episodio contiguo dello stesso canto v del
Purgatorio, quello di Jacopo del Cassero. L’osmosi fra fatti scritti e fatti reali non
potrebbe avere una migliore esemplificazione : il modello ideale non è un model-
lo mitico anteriore all’espressione verbale, bensì il testo come tessuto di parole e
immagini e significati, composizione di motivi che si rispondono, spazio musicale
in cui un tema sviluppa le sue variazioni. 3
Mi sembra importante notare come anche Calvino colga la relazione fra
realtà e scrittura come uno dei segnali forti della visione borgesiana della
letteratura. Sicché anche la citazione dotta, ricavata dai versi danteschi,
s’inserisce in tale relazione e serve ad esaltare epicamente l’episodio che si
riferisce alla morte reale e familiare dell’eroe, situandola nella dimensione
dell’assoluto e del mito.
A partire da questa esperienza, Calvino è portato a spiegare con ulterio-
re determinazione il valore attribuito da Borges alla scrittura letteraria :
il potere della parola scritta si collega dunque al vissuto come origine perché
diventa l’equivalente d’un avvenimento che altrimenti sarebbe come non avve-
nuto ; come fine perché per Borges la parola scritta che conta è quella che ha un
forte impatto sull’immaginazione, come figura emblematica o concettuale fatta
per essere ricordata e riconosciuta in qualsiasi sua apparizione passata o futura. 4
Non solo essa ha il compito di garantire l’esistenza ed assicurare la soprav-
vivenza di ciò che è esistito realmente e che la dimenticanza rischia di can-
cellare dalla realtà, ma è in grado di produrre, per mezzo dell’invenzione
Paoli, p. 95.
2
Nel 984, in occasione della pubblicazione del primo dei due volumi dei «Meridiani»
dedicati alle sue Opere, Borges è stato ospite del Ministero della Pubblica Istruzione. Nello
stesso anno Borges è ospite dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana (cfr. Vincenzo Cappel-
letti, Borges il 15 ottobre 1984 a Palazzo Mattei, Roma, Il Veltro, 985). Calvino viene invitato
e svolgere « una memorabile allocuzione » (Paoli, p. 9).
3
Italo Calvino, Borges, in Idem, Perché leggere i classici, Milano, Mondadori, 99; ora in
Idem, Saggi 1945-1985, i, a cura di Mario Barenghi, Milano, Mondadori, 995, pp. 292-30: p.
4
296. Italo Calvino, Borges, cit., p. 297.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
108 nicola longo
espressiva («immaginazione, figura emblematica o concettuale»), la sua
memoria e la sua riconoscibilità.
Ancora una volta, come accade nella scrittura borgesiana, la vicenda di
un’esistenza si condensa in poche parole che ne colgono assolutamente il
significato e le attribuiscono, con la forza di una forma programmatica-
mente esente da ridondanze barocche (virtù che la qualifica lontana da
stilemi iberico-europei), una esemplarità straordinaria. A questo punto è
necessario svolgere in maniera più articolata queste due argomentazioni.
La prima si riferisce alla capacità borgesiana di concentrare la storia di
un’esistenza in un atto preciso che la riassume e la individua perfettamen-
te. Ebbene, Paoli, a questo proposito, ha coniato l’espressione « biografie
compendiose », attribuendo questa particolare virtù dell’arte scrittoria
del maestro argentino « alla suggestione della lettura della Commedia ». 2
La seconda osservazione riguarda la differenza che si avverte nell’intera
opera di Borges circa le influenze e le profonde diffidenze che essa manife-
sta rispetto ad alcune letterature europee, cioè la sua naturale sfiducia nei
confronti del concettismo barocco, di cui s’è detto a proposito di un verso
del canto di Ugolino. 3 Questa differenza Borges la registra esplicitamente
nel citato saggio su Hawthorne, quando, tornando a ricordare il nesso
junghiano fra letteratura e mondo onirico, scrive :
questa dottrina non sembra applicabile alle letterature che usano l’idioma spa-
gnolo, clienti del dizionario e della retorica, non della fantasia. Essa è invece
adatta alle lettere dell’America del Nord. Queste (come quelle d’Inghilterra o di
Germania) sono più capaci d’inventare che di trascrivere, di creare che di osser-
vare. 4
L’aver sottolineato questa difformità di fondo fra due tradizioni letterarie
entrambe molto importanti per lo scrittore Borges, non si può trascurare
dal momento che egli così ci aiuta a comprendere quanto la scrittura lette-
raria di matrice classica venga da una tradizione di riflessioni sulla poetica
e sulla retorica che ha fatto prevalere una ricerca stilistica compiuta tutta
“in punta di penna”, mentre quella di matrice anglosassone è più incline
ad una scrittura vicina al gusto dell’affabulare, del raccontare, dell’affa-
scinare attraverso l’invenzione e l’organizzazione dell’intreccio. Inoltre
attraverso quella distinzione egli esalta ancora una volta la composizione
della Divina Commedia, ascrivendola all’universo della letteratura fanta-
Dante in Borges : Le biografie compendiose è il titolo di un capitolo contenuto nel volume di
Roberto Paoli, Borges. Percorsi di significato, Firenze-Messina, D’Anna, 977, pp. 0-07.
2
Paoli, p. 96. Lo stesso Borges ha riconosciuto questa influenza solo dopo un incontro
con Paoli che esponeva questa sua tesi, impossibile da contestare, presso l’Istituto Italo-
3
Latino Americano di Roma nel maggio del 977. Cfr. supra, p. 95, nota 3.
4
Opere, i, p. 973. « La letteratura spagnola è così noiosa » è una battuta attribuita a
Patricio Gannon, personaggio minore di L’altra morte (Opere, i, p. 825).
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
la poesia di dante secondo jorge luis borges 109
stica, sciogliendola da qualunque possibile confusione con la letteratura
retorica, con la letteratura di scuola. Non a caso, proprio per questo giu-
dizio, il lettore è autorizzato a considerare Dante un precursore dell’opera
altrettanto fantastica di Borges.
L’ Aleph
Di questa raccolta, il cui titolo rinvia a quello di uno dei suoi racconti, qui,
per i possibili o evidenti richiami all’opera dantesca, ci interessano i se-
guenti brani : L’altra morte, Lo Zahir, La scrittura del Dio, L’attesa, L’Aleph.
Nel primo di questi, L’altra morte, scritto nel 949, si trova l’idea che la
letteratura sia uno straordinario gioco arbitrario in cui è possibile ogni
cosa e il suo contrario. Per sostenere l’assurdità della doppia morte del
suo personaggio, lo scrittore ricorda i versi controversi 2 del canto xxi del
Paradiso (2-23) che, secondo alcuni critici, nasconderebbero l’identità di
due Pietro (Pier Damiani e Pietro Peccatore) :
In quel loco fu’ io Pietro Damiano,
e Pietro Peccator fu’ ne la casa
di Nostra Donna in sul lito adriano.
Ormai la critica sembra abbastanza concorde nel ritenere che qui Dante
si riferisca sempre allo stesso Pier Damiani. Proprio quel teologo nelle cui
parole il narratore trova una possibile spiegazione della misteriosa esi-
stenza e morte di Pedro Damián. Il personaggio del racconto borgesiano
(« ultrapirandelliano », lo definisce Paoli 3) che si chiama pour cause Pedro
Damián, e chi lo narra dichiara di averlo conosciuto nel 942, 4 è il risul-
tato di un vero e proprio sdoppiamento che solo la letteratura è in grado
di operare. In una prima ipotesi, infatti, lo scrittore sostiene che esistano
due Damián, il vile che morì ad Entre Ríos intorno al 946 e il coraggio-
so che morì nella battaglia di Masoller nel 904. Ma se è vero, appunto,
quanto sostiene Pier Damiani, in contrasto con Aristotele e con Tommaso
d’Aquino, che Dio può, nella sua onnipotenza, modificare il passato (« fare
Da questo punto di vista e ricordando che secondo Borges, come s’è già avuto occa-
sione di notare, « ogni grande scrittore crea i suoi precursori » (cfr. supra, p. 93, nota 5), ha
perfettamente ragione Paoli quando afferma che « se Borges s’è nutrito di Dante, anche
Dante, dopo Borges, è più ricco, più vicino a una sensibilità moderna, più rispondente alle
esigenze di un lettore attuale » (Paoli, p. 07).
2
Versi controversi è il titolo del seminario dantesco che si è svolto presso l’Università di
Foggia nel corso dell’Anno Accademico 2005-2006, i cui atti sono in corso di stampa.
3
Paoli, p. 94.
4
È una caratteristica della scrittura borgesiana il rinvio a tempi precisi della storia che
narra, quanto più essa ha contenuti fantastici e del tutto inverosimili. La precisione del
tempo ne avvalorerebbe l’autenticità letteraria. Sulla dimensione speciale che il tempo
assume nell’universo elaborato dallo scrittore – se sia rettilineo o circolare o abbia altra
forma imprecisata o variabile – si è a lungo soffermata la critica.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
110 nicola longo
sì che non sia stato ciò che è stato » ), si dà una seconda ipotesi. Damián si
comportò da vile, nel 904 a Masoller. Visse per quarant’anni in attesa di
poter riscattare la sua vergogna e in punto di morte, sotto forma di delirio,
rivisse la “sua” battaglia agendo coraggiosamente, sicché, « in grazia di un
lungo patimento », poté morire da eroe nel 946 nella disfatta di Masoller,
« avvenuta tra l’inverno e la primavera del 904 ». 2
Come si vede è questo uno dei tanti luoghi borgesiani in cui la dimen-
sione temporale supera gli schemi della logica e dell’esperienza umana
per assumere il valore esclusivamente letterario cioè altro da quello
esistenziale e ‘reale’, identificabile solamente con la vita che si svolge
entro l’universo onirico (per di più prefreudiano) : « già i greci sapevano
che siamo i sogni d’un’ombra ». 3 Il richiamo a Dante, dunque, e al suo
Pier Damiani, è solo un magnifico pretesto per trovare una fantastica via
d’uscita ad un intreccio altrimenti insolubile, o potrebbe essere anche
l’invenzione di un racconto ispirato proprio dalla difficoltà di interpretare
l’ambiguità dei versi danteschi.
Il secondo dei racconti di Aleph indicati, comincia con una semplice
spiegazione della parola del titolo : « A Buenos Aires lo Zahir è una moneta
comune ». 4 Il che serve a mettere il lettore sull’avviso che ben altra strada
prenderà la vicenda, inseguendo questa moneta così comune.
Infatti la parola Zahir – secondo quanto scrive lo stesso Borges – in
lingua araba significa « notorio, visibile ; in questo senso, è uno dei novan-
tanove nomi di Dio » 5 e, in senso più generale, significa ‘il pensiero domi-
nante’, ciò che si impadronisce della nostra mente e non l’abbandona più,
portandola fino alla follia.
Il racconto si svolge con assoluta precisione nella cadenza delle sue
date, fra il 6 giugno e il 3 novembre, d’un anno imprecisato, ed ha inizio
con la morte di Teodelina Villar, di cui lo scrittore narratore era stato inu-
tilmente innamorato. Certamente assai vicino a questo ritratto di donna è
la Beatriz che introduce la storia narrata in Aleph. In questa grande passio-
ne amorosa, appena accennata, si ritrova il tentativo di identificazione di
Borges con Dante : Teodelina è stata adorata da lui in vita, tanto quanto lo
è stata Beatrice, sicché, lei morta, egli può ora celebrarne le straordinarie
virtù, fisiche e spirituali. Ma è anche evidente che ci troviamo di fronte ad
una parodia di Beatrice : nel fornire i dati del suo carattere, dei suoi com-
portamenti, dei suoi tic, fra la passione e il suo oggetto, s’interpone l’arte
retorica dell’ironia che, esaltando i difetti di lei (« l’impeccabile correttezza
d’ogni atto, […] le norme del suo credo non erano eterne, ma si piegava-
2
Opere, i, p. 827. Ibidem.
3
Ibidem. Per l’analisi di questo racconto si veda quanto scrive Paoli, p. 89. Per il rappor-
to fra letteratura e sogni, cfr. supra, p. 0, nota .
4 5
Opere, i, p. 847. Ivi, i, p. 853.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
la poesia di dante secondo jorge luis borges 111
no al capriccio di Parigi […], gli atteggiamenti provinciali, […] la sua vita
esemplare, […] le continue metamorfosi ») la riduce ad un essere umano
che, con tutta la sua ricerca di perfezione, la sua bellezza, la sua ricchezza,
« commise l’errore di morire in pieno Quartiere Sud ».
Si consideri che, come accade per la Beatriz di Aleph, questo è solo l’an-
tefatto, che avrà poca incidenza nella vera vicenda narrata intorno allo
Zahir, che qui diventa l’ossessione del narratore.
Nel racconto La scrittura del Dio il protagonista principale, che è anche
l’io narrante, Tzinacàn, sacerdote del dio Qaholom, prigioniero di Pedro
de Alvarado, 2 si trova nella condizione simile a quella d’un’anima del-
l’inferno dantesco. La sua cella è quasi circolare come una bolgia dell’ot-
tavo cerchio, accanto a lui, in forma di contrappasso, è prigioniero uno
giaguaro, animale sacro, uno degli attributi del dio. Egli, giunto ormai
alla fine della sua esistenza, cerca la sentenza magica con cui il creatore,
all’inizio dei tempi, ha offerto di liberare gli uomini dalle sventure e dalle
rovine della fine dei tempi. In questa sua del tutto folle ricerca, « avvenne
l’unione con la divinità », esperienza – dice il narratore, richiamando il
tema dell’ineffabilità che percorre gli ultimi canti del Paradiso 3 – « che non
posso dimenticare né comunicare ». E subito dopo ricorda implicitamente
la visione dantesca di Dio, scrivendo : « c’è chi ha visto Dio in una luce […]
o nei cerchi di una rosa ». Tzinacàn arriva alla contemplazione di tutte
le cose in una ruota altissima, comprende tutto, senza fine, vede « il dio
senza volto che sta dietro gli dei », 4 capisce la scrittura affidata dal dio « alla
pelle viva dei giaguari », 5 ma, insieme, comprende che, dopo l’esperienza
dell’estasi non ha più senso né la liberazione dal carcere né vendicarsi di
Alvarado.
Della citazione esplicita della Commedia contenuta nel racconto L’attesa,
con riferimento alla figura dell’Ugolino dantesco, s’è già avuto modo di
discorrere precedentemente. 6
Nel racconto Aleph, del 945, (« la più geniale parodia della Divina Com-
media », secondo Stefanini 7) uno dei rinvii possibili al Paradiso dantesco,
consiste nel riferimento al verso 94 dell’ultimo canto, lì dove ci si trova di
fronte alla difficoltà di spiegare il rapporto fra il termine « punto », inteso
come entità geometrica priva di dimensioni, e l’immagine che contiene in
Ivi, i, p. 848, per tutte le citazioni precedenti.
2
Personaggio storico che, nel 59, accompagnò in America Centrale Cortés come
uomo di fiducia. In una notte ricordata come la “notte triste”, egli ordinò lo sterminio di
tutti gli Aztechi che erano impegnati in una cerimonia religiosa.
3
Per lo svolgimento di questo tema entro l’ultimo canto della Commedia, mi permetto
di rinviare al mio La scala al Fattore : “Paradiso”xxxiii, in corso di pubblicazione nel prossi-
4
mo numero di « L’Alighieri ». Le tre citazioni sono in Opere, i, p. 86.
5 6
Ivi, p. 859. Cfr. supra, p. 89 e p. 95.
7
Ruggero Stefanini, Dante in Borges, cit., p. 57.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
112 nicola longo
sé, di un tempo infinito, di una durata senza fine, perciò tanto superiore al
tempo intercorso fra l’episodio più lontano della storia umana, l’impresa
degli Argonauti, e il presente. Ebbene Borges, definisce l’Aleph « uno dei
punti dello spazio che contengono tutti i punti », « il luogo dove si trovano
tutti i luoghi della terra visti da tutti gli angoli », che è un trasferimento
entro la dimensione spaziale di ciò che in Dante aveva la dimensione
temporale.
Il racconto ha inizio con la morte di Beatriz Viterbo, appassionatamente
amata da colui che narra e, anche per questo motivo, assai vicina a Teode-
lina Vilar de Lo Zahir. Il giorno della morte di Beatriz è segnato – in manie-
ra del tutto straniante – dal cambiamento del manifesto pubblicitario in
Plaza Constitución, come dire che, mentre ancora il cadavere è caldo,
nonostante l’illustre dipartita, nonostante il lutto dei parenti, nonostante
il dolore di chi aveva avuto per lei una vera adorazione e scrive della sua
scomparsa, la vita, cinicamente, continua.
Molti sono i segni che la critica ha individuato (si vedano le puntuali
osservazioni di Stefanini, al riguardo), sparsi lungo la trama di questa scrit-
tura borgesiana, precisamente riferibili alla Beatrice dantesca (dal nome,
alla numerologia che caratterizza le date con cui si scandisce il procedere
della storia, subito dopo la morte della donna). Di lei, nelle sole due pagi-
ne iniziali del racconto, si ha una serie di immagini fotografiche, esposte
nel vestibolo della casa, e questa unica rappresentazione diretta, espressa
al passato :
Beatriz era alta, fragile, lievemente inclinata ; c’era nel suo portamento (se l’ossi-
moro è tollerabile) come una gentile goffaggine, un principio d’estasi. 2
Dopo questo troveremo solo un rinvio alle mani della donna ; 3 alla sua ir-
recuperabile voce ; 4 alle sue « negligenze, distrazioni, disdegni, vere crudel-
tà, che forse richiedevano una spiegazione patologica » ; 5 quindi l’anaforica
invocazione davanti al ritratto dipinto di lei. 6 Poi più nulla. In primo piano
appare la figura del cugino di lei, Carlo, che, nella sua follia, introdurrà il
tema di Aleph.
Stefanini stesso s’è soffermato a lungo sul significato del termine
« punto », proprio in relazione all’Aleph, individuando altri luoghi testuali
di contatto con la terza cantica della Commedia. Il primo di questi consiste
nella questione del ritenere e ridire, cioè nell’indicibilità dell’esperienza
dell’infinito, 7 che rinvia a Par. i, 7-2 e xxxiii, 56 sgg. ; 73 sgg. Il secondo sta
2 3
Opere, i, p. 894. Ivi, i, p. 887. Ibidem.
4
Ivi, p. 893. Si ricordi « l’irrecuperabile Beatrice » (cfr. supra, p. 03, nota 4).
5 6
Opere, i, p. 895. Cfr. supra p. 03, nota 8.
7
« Comincia, qui, la mia disperazione di scrittore […] come trasmettere agli altri l’infi-
nito di Aleph che la mia timorosa memoria a stento abbraccia ? » Opere, i, p. 895.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
la poesia di dante secondo jorge luis borges 113
nella dimensione stessa dell’Aleph che nei due o tre centimetri di diame-
tro della sua sfera contiene l’intero cosmo, come nel « punto » dantesco
si trova l’immagine di Dio (Par. xxvii, 6-20), « rettore e organizzatore
dell’universo » (Par. xxvii, 40-42). Il terzo di questi luoghi coincide con
quello in cui lo scrittore, posto di fronte all’indicibile infinito di Aleph,
deve trovare le parole per spiegare che « milioni di atti » costituenti « un
insieme infinito », occupano « lo stesso punto », sicché « quel che videro i
suoi occhi fu simultaneo : ciò che trascriverà successivo ». I rinvii sono
a Par. xxxi, 9-24 e Par. xxx, 8-23 in cui s’esprime lo stesso « annullarsi
della lontananza con le riduzioni e limitazioni ad essa connesse [...] che
ha contribuito all’ottica dell’Aleph in cui panorami cosmici e particolari
di natura morta si succedono con la stessa evidenza, senza problemi di
proporzione o di scala ». 2
Per concludere, richiamo due brani della raccolta L’artefice, del 960, in
cui gli stessi titoli delle composizioni contengono un ricordo dantesco.
La prima di queste, Paradiso xxxi, 108, si riferisce al verso che dice : « or
fu sì fatta la sembianza vostra ? ». È il luogo della candida rosa in cui Ber-
nardo autorizza Dante a contemplare tutto il giardino in cui si trovano,
per abituare il suo sguardo all’intensità della luce che troverà più avanti.
Così Dante paragona la propria condizione a quella del pellegrino che,
venuto dalla Croazia fino a Roma, contemplando la Veronica, 3 è certo di
riconoscervi l’impronta del volto di Cristo. Borges applica questa situazio-
ne a quanti abbiano smarrito dalla loro memoria il volto di una persona
cara e vorrebbero perciò trovarsi nelle medesime condizioni di grazia del
pellegrino, « sognato nell’empireo sotto la Rosa », 4 che dopo aver affron-
tato l’impervia avventura del viaggio alla tomba di Pietro e Paolo, per il
dono della grazia della sua fede, è certo di avere davanti a sé la miracolosa
immagine di Cristo.
La seconda prosa, intitolata Inferno i , 32, si riferisce al verso che dice :
« una lonza leggera e presta molto ». Si tratta di un brano dal sapore meta-
Opere, i, p. 897.
2
Ruggero Stefanini, Dante in Borges, cit., p. 54. Molti altri sono i riferimenti che in
questo ricco e utile saggio (nato come recensione al volume di Paoli Percorsi di significato,
Firenze-Messina, D’Anna, 977) vengono individuati fra la scrittura borgesiana di Aleph e
la Commedia.
3
Si tratta di una leggenda di epoca tarda, secondo la quale una emoroissa asciugò il
volto sanguinante di Gesù con un lino su cui rimase l’impronta del sacro volto. Il nome
della donna, Veronica, si estese al panno conservato nella Basilica Vaticana (Nicola
Longo, Roma i papi e Dante. L’idea e le immagini di Roma nella Commedia dantesca, Roma,
Bulzoni, 2004, pp. 88 e 90n).
4
Opere, i, p. 53. Noto che il termine « rosa » qui è scritto con la maiuscola mentre a
p. 86 (luogo già citato : cfr. supra, p. ) è scritto con la minuscola. Questa affermazione
di Borges è un’ulteriore prova della sua concezione della letteratura come sogno, spesso
applicata proprio alla grande poesia fantastica della Commedia.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]
114 nicola longo
fisico, in cui dapprima si narra del sogno di un leopardo, nel quale Dio, appa-
rendo alla fiera, l’esorta alla rassegnazione nel suo destino di prigioniero,
perché – gli dice – da esso deriverà la possibilità che un uomo possa usare in
futuro « la tua figura e il tuo simbolo in un poema, che ha il suo posto preci-
so nella trama dell’universo ». In parallelo, segue la narrazione di un sogno
in cui Dio appare a Dante, rivelandogli il senso nascosto e misterioso della
sua esistenza, sicché il poeta per un momento « seppe chi era e che cosa era
e benedisse le sue amarezze », 2 anche se, al risveglio, al poeta rimane solo
l’impressione di ciò che aveva conseguito e poi aveva perduto per sempre.
Si può dire, forse, che, in queste poche righe, l’intento dello scrittore era
di collocare il Poema Sacro entro un più ampio e imperscrutabile progetto
divino, quasi a collocarlo in una dimensione dell’eterno in cui solo il mira-
colo della letteratura può trovare la sua dimensione.
Si fa esplicito, così, il legame fra Borges lettore della Commedia e Borges
scrittore fantastico. Mi sembra impossibile separare queste due sue attivi-
tà, anzi credo che dalla loro interazione derivi la ricchezza dell’interpre-
tazione borgesiana di Dante ed anche, almeno in parte, il fascino speciale
della scrittura del maestro argentino.
2
Opere, i, p. 67. Ibidem.
This content downloaded from
[Link] on Fri, 30 Apr 2021 [Link] UTC
All use subject to [Link]