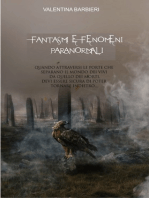Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Nuove Frontiere Vol. I
Caricato da
Sofia VenturoliCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Nuove Frontiere Vol. I
Caricato da
Sofia VenturoliCopyright:
Formati disponibili
Nuove frontiere
per la storia di genere
COLLANA SCIENTIFICA DELLUNIVERSIT DI SALERNO
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 1 03/05/2013 11:10:53
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 2 03/05/2013 11:11:08
Nuove frontiere
per la storia di genere
Volume I Genere e politica
a cura di
Laura Guidi e Maria Rosaria Pelizzari
realizzato da
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 3 03/05/2013 11:11:08
Propriet letteraria riservata
Universit degli Studi di Salerno
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di
adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microflm e le copie
fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.
Nessuna parte di questa pubblicazione pu essere riprodotta, distribuita o trasmessa
in qualsivoglia forma senza l autorizzazione scritta dell Editore, a eccezione di brevi
citazioni incorporate in recensioni o per altri usi non commerciali permessi dalla
legge sul copyright. Per richieste di permessi contattare in forma scritta l Editore al
seguente indirizzo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ISBN: 978-88-XXXXXXX
Prima edizione: XXXXX 2013
realizzato da
Webster srl, Libreriauniversitaria.it
www.libreriauniversitaria.it
redazione@libreriauniversitaria.it
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 4 03/05/2013 11:11:08
Sommario
Volume I Genere e politica
La Societ Italiana delle Storiche, il futuro della storia delle donne e di genere,
le generazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Elisabetta Vezzosi
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Laura Guidi Maria Rosaria Pelizzari
Le nuove frontiere della Storia di genere dallAntichit allEt contemporanea . 49
Pauline Schmitt Pantel e Franoise Tbaud
Madame la Terre, Monsieur le Capital: quale il genere del progresso nel XIX
secolo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Marta Petrusewicz
CAPITOLO 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos . 77
a cura di Claudia Montepaone e Gabriella Pironti
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Claudia Montepaone e Gabriella Pironti
1. La hybris di Medea e il nomos degli altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Ida Brancaccio
2. Le Hybristika di Argo: un caso di travestimento intersessuale . . . . . . 91
Anna Chiaiese
3. Disonore, disobbedienza e disordine civile: la hybris di Lisistrata . . . . . 97
Marcella Maresca
4. Parthenoi e controllo sociale nella prospettiva di genere: il caso delle Spartane . 103
Maria Luisa Napolitano
5. La separazione tra oikos e polis in una prospettiva di genere . . . . . . . . 109
Maria Letizia Pelosi
6. Alle soglie dellOlimpo: prospettiva di genere e analisi del politeismo greco 115
Gabriella Pironti
7. Discorsi di genere nelle Storie dAmore attribuite a Plutarco . . . . . . . . 121
Pauline Schmitt Pantel
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 5 03/05/2013 11:11:08
6
Nuove frontiere per la storia di genere Volume I
CAPITOLO 2. Gender and Politics in Early Modern Europe . . . . . . . 127
edited by Linda Jauch
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Linda Jauch
1. Marriage and Rule in Jean Bodins Political Tought . . . . . . . . . . . 135
Anna Becker
2. Te Female Consort in Italy: Giovanna of Austria and her Sisters . . . . . 141
Sarah Bercusson
3. Mary Habsburg and her Hungarian dower lands . . . . . . . . . . . . . 149
Andrea Frhlich
4. Eleonora dAragona and the discourse surrounding female political power
in Quattrocento Northern Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Linda Jauch
CAPITOLO 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica
del lungo Ottocento lombardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
a cura di Maria Luisa Betri
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Maria Luisa Betri
1. Fra protezione e autonomia: le colombe dellospedale maggiore di Milano
(XVII-XIX secolo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Flores Reggiani
2. Spose, vedove, avventuriere. Profli di donne francesi nella Milano
di Napoleone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Natalia Tatulli
3. Cristina di Belgiojoso, Marie dAgoult e la fgura dellaristocratica dclasse . 181
Antonietta Angelica Zucconi
4. Laura Solera Mantegazza tra militanza politica e impegno sociale . . . . . 189
Alessandra Porati
5. Mazzinianesimo e radicalismo nei carteggi della Romussi-Lazzati
nella seconda met dellOttocento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Altea Villa
CAPITOLO 4. Che genere di nazione? . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
a cura di Rafaella Bianchi
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Rafaella Bianchi
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 6 03/05/2013 11:11:08
7
Sommario
1. Laltra nazione: cantanti (e) castrati italiani nella Londra del diciottesimo
secolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Serena Guarracino
2. Leroina romantica tra passione e martirio. Storia di una rivoluzione vocale 217
Simonetta Chiappini
3.Per la generazione che verr. Limpegno politico femminile nel 1848
negli Stati italiani e tedeschi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Giulia Frontoni
4. Donne in armi e Risorgimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Benedetta Gennaro
CAPITOLO 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione
dellItalia unita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
a cura di Laura Guidi
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Laura Guidi
1. Risorgimento italiano. Naturali protagonismi di donne . . . . . . . . . 243
Franca Bellucci
2. Militanza, identit e memoria in una famiglia napoletana di patrioti . . . 253
Marcella Varriale
3. Il Mezzogiorno e la Questione meridionale negli scritti di Cristina Trivulzio
di Belgiojoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Karoline Rrig
4. Sport e ginnastica nella costruzione degli italiani, tra modelli di estetica
femminile e di educazione fsica maschile. . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Francesco Muollo
5. Maria Sofa di Borbone: da regina-soldato ad amica di briganti e anarchici . 275
Ugo della Monica
CAPITOLO 6. Lampiezza di un margine. Genere, cittadinanza e politica
nellItalia repubblicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
a cura di Valentina Greco
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Valentina Greco
1. Genere e forme di partecipazione politica tra fascismo e Repubblica:
il caso di Olga Arcuno (1902-1977) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Luca Grauso
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 7 03/05/2013 11:11:08
8
Nuove frontiere per la storia di genere Volume I
2. Fondatrici, sostenitrici, utenti del Movimento Italiano Femminile:
elementi di una biografa collettiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
M. Eleonora Landini
3. La violenza femminile singolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Stefania Voli
CAPITOLO 7. Il fare politica e il fare societ delle donne negli anni Settanta:
voci, esperienze, lotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
a cura di Beatrice Pisa
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Beatrice Pisa
1. Il nesso liberazione / emancipazione: lesperienza del Movimento Liberazione
della Donna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Beatrice Pisa
2. Le democristiane negli anni Settanta fra tradizione, modernizzazione,
secolarizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Stefania Boscato
3. Lo Statuto dei Lavoratori e delle Lavoratrici: un compleanno da ricordare . 335
Rossella Del Prete
4. Una storia degli anni Settanta: donne a scuola tra vecchie e nuove culture . 343
Anna Balzarro
CAPITOLO 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del
Novecento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
a cura di Maria Rosaria Stabili
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Maria Rosaria Stabili
1. Biografe femminili a confronto nel Messico post-rivoluzionario: Frida Kahlo
e Tina Modotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Benedetta Calandra
2. Mara Rosa Oliver: unargentina liberal-oligarchico-comunista . . . . . . 363
Camilla Cattarulla
3. Loyola Guzmn Lara, i diritti umani e la politica in Bolivia . . . . . . . . 371
Gabriella Citroni
4. La partecipazione femminile nelle barriadas di Lima . . . . . . . . . . . 377
Stefania Pastorelli
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 8 03/05/2013 11:11:08
9
Sommario
5. Percorsi di apprendimento allazione politica in una comunit delle Ande
Peruviane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Sofa Venturoli
6. Diritto Rovesciato e lotte silenziose. El Salvador e Marianela Garcia Villas . 391
Chiara Forneis
7. Donne, diritti e potere: le Madres e le Abuelas di Plaza de Mayo . . . . . 397
Marzia Rosti
8. Beatriz Sarlo e la critica periferica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Amanda Salvioni
9. Patricia Verdugo (1947-2008). Alla ricerca della verit nel Cile di Pinochet . 409
Claudia Borri
10. Somos todas Presidentas. Il potere politico al femminile: Michelle
Bachelet, Presidente del Cile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Maria Rosaria Stabili
CAPITOLO 9. Le sde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente:
gender, dinamiche socio-culturali, processi di trasformazione politica
ed economica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
a cura di Anna Maria Di Tolla ed Ersilia Francesca
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Anna Maria Di Tolla ed Ersilia Francesca
1. Donne del Nord Africa: discorso, pratiche e rappresentazioni . . . . . . . 433
Tassadit Yacine
2. Nuovi movimenti socio-politici e processi di emancipazione femminile
in Nord Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Anna Maria Di Tolla
3. Il femminismo islamico e il caso delle murshida
-
t in Marocco . . . . . . . 445
Sara Borrillo
4. Le algerine e la guerra di liberazione nazionale: lingresso delle donne
nello spazio pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Valeria Guasco
5. Rifessioni sul femminismo islamico in Iran: voci, temi, strategie e fnalit. . 459
Leila Karami Nogurani
6. Formale o informale? Dinamiche delloccupazione femminile nellarea
MENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
Ersilia Francesca
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 9 03/05/2013 11:11:09
10
Nuove frontiere per la storia di genere Volume I
7. Gender e riforme economiche in Giordania . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Claudia Corsi
8. Economia delloccupazione in Palestina: genere, lavori informali e
Income Generating Projects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Valentina Venditti
9. Mani da manicure preparano bobine elettriche: la partecipazione femminile
alla migrazione turca in Germania Occidentale . . . . . . . . . . . . . . . 487
Lea Nocera
CAPITOLO 10. Impegno e militanza femminile tra le due rive del
Mediterraneo:il caso della Tunisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
a cura di Lucia Valenzi
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
Lucia Valenzi
1. Per una politica al femminile nella Tunisia tra le due guerre . . . . . . . 501
Leila El Houssi
2. Nello spazio pubblico per vocazione. Suore bianche nella Tunisia coloniale . 509
Daniela Melfa
CAPITOLO 11. Donne israeliane e palestinesi fra critica, protesta e
rappresentazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
a cura di Maura Palazzi
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
Maura Palazzi
1. La coesistenza possibile tra palestinesi e israeliani? Una lettura di genere . 527
Giulia Daniele
2. Le donne di Machsom Watch tra normalizzazione e sfda al mito
della sicurezza nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
Laura Aletti
3. Le donne nei manuali delle scuole pubbliche palestinesi . . . . . . . . . . 539
Eleonora Lotti
4. Israele: rappresentazioni dellidentit di genere tra militarismo e societ civile . 549
Raya Cohen
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 10 03/05/2013 11:11:09
11
Sommario
CAPITOLO 12. La rappresentazione del femminile nei piani e programmi
dazione europei per le pari opportunit e la non discriminazione . . 555
a cura di Silvia Niccolai
Introduzione. Tra strumentalizzazione e imprevisto: la politica delle donne nella
stagione dei piani e programmi dazione europei in materia di pari opportunit
e non discriminazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
Silvia Niccolai
1. Lavoro e occupazione: legislazione e politiche dellUnione europea per la
parit tra uomini e donne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Mariagrazia Rossilli
2. Il tempo delle donne nelle politiche di conciliazione: verso una
rilegittimazione di un modello sociale familistico? . . . . . . . . . . . . . 571
Alessandra Vincenti
3. Lincontro tra il pensiero femminista e i programmi europei: attraversamenti
e interpretazioni. Unesperienza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Simonetta De Fazi
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 11 03/05/2013 11:11:09
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 12 03/05/2013 11:11:09
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 13 03/05/2013 11:11:09
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 14 03/05/2013 11:11:09
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 15 03/05/2013 11:11:09
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 16 03/05/2013 11:11:09
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 17 03/05/2013 11:11:09
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 18 03/05/2013 11:11:09
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 19 03/05/2013 11:11:09
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 20 03/05/2013 11:11:09
La Societ Italiana delle Storiche, il futuro della
storia delle donne e di genere, le generazioni
Elisabetta Vezzosi
Quasi dieci anni fa veniva pubblicato un piccolo libro di grande signifcato per la
storiografa italiana, A che punto la storia delle donne in Italia
1
. Le parole della cura-
trice, Anna Rossi Doria, nella sua introduzione, rimangono in gran parte vere oggi:
da un lato, la fase della legittimazione e autolegittimazione scientifca della storia
delle donne ampiamente conclusa [] dallaltro lato, tuttaltro che raggiunto
il consenso della comunit accademica nei riguardi della storia delle donne e
quindi lintegrazione di questultima nel corpus della storiografa italiana
2
.
Dei processi che hanno accompagnato la nascita e levoluzione della storia
delle donne e di genere in Italia la Societ Italiana delle Storiche stata ed pro-
tagonista. Il ricchissimo V Congresso della Societ, che si tenuto a Napoli nel
gennaio 2010, ne prova.
Ero al mio primo anno di presidenza della SIS e calarmi nei panel, ascoltare
tante giovani e meno giovani studiose stato stimolante e grande motivo di fe-
rezza: la Societ esprimeva il meglio di s mostrando la crescita e la maturazione
scientifca di un campo di studi mai pienamente valorizzato dal punto di vista
accademico. Da quel momento alla fne della mia presidenza sono trascorsi ancora
due anni e mezzo, un tempo in cui sono state pensate, elaborate, organizzate, tante
1 Rossi Doria, A. (a cura di) A che punto la storia delle donne in Italia, Roma, Viella, 2003.
2 Ivi, p. 10. Della stessa autrice si veda anche Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne,
Roma, Viella, 2007, cap. Didattica e ricerca nella storia e delle donne.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 21 03/05/2013 11:11:09
22
La Societ Italiana delle Storiche, il futuro della storia delle donne e di genere, le generazioni
iniziative, un tempo che stato anche di rifessione sul futuro della disciplina e sul
ruolo che la SIS potr rivestire nei prossimi anni.
In Italia, a circa quarantanni dal suo avvio, sconfortante constatare quanto
sia dif cile inserire la storia delle donne per non parlare di quella di genere
nella trama della narrazione storica complessiva
3
. Sebbene sia da tempo fuoriuscita
dalla sua nicchia, sebbene sia impensabile per molti/e studiosi/e trascurare com-
pletamente questa dimensione, il suo spazio appare spesso ancora interstiziale.
Il suo successo futuro si fonda sulla capacit di esportare il proprio patrimonio
intellettuale al di fuori degli studi specialistici e di intavolare un vero confronto
tra generazioni. Le giovani storiche mostrano legami pi febili con la politica
istituzionale, ma manifestano grande attenzione per il lintreccio corpo/sessualit/
politica/potere e per nuove discussioni teoriche
4
, un aspetto che la storiografa
italiana delle donne e di genere ha prevalentemente trascurato, preferendo dibat-
titi su categorie di importazione allelaborazione di originali strategie discorsive.
Si tratta dunque di continuare a cercar di risolvere lapparente opposizione
tra storia delle donne e storia di genere, tra oppressione e agency, tra esperienza
e discorso. Lagenda futura densa di impegni: insegnamento e ricerca che col-
leghino locale e globale; riconoscimento non solo delle diferenze tra donne ma
dellintersezionalit di genere, razza, etnia, classe, orientamento sessuale e nazione;
ridefnizioni teoriche; dialogo inter-generazionale.
Le energie, per raforzare una rifessione sul metodo, esistono gi: luoghi di
incontro, buone riviste tra cui la nostra rivista, Genesis una produzione scien-
tifca di rilievo. Si tratta di mettere in campo quelle energie con forza e decisione.
Sul piano accademico, le recenti riforme universitarie hanno reso irrealistico
un ampliamento degli insegnamenti di Womens and Gender History, che si sono
difusi (e che in alcune sedi ancora esistono) negli anni Novanta. Le famigerate
tabelle delle classi di laurea, unite al limite posto al numero degli esami hanno reso
sempre pi esile questi insegnamenti segnando una tendenza credo irreversibile.
anche vero, del resto che, se la storia delle donne e di genere acquisisse infne
pieno diritto di cittadinanza, il problema potrebbe autorisolversi perch non ci
sarebbe pi bisogno di insegnamenti specifci, compensatori, e defnizione che
le storiche, italiane e non, hanno sempre rifutato aggiuntivi.
3 Vedi, in tal senso, i risultati del convegno Una nuova storia politica? Il genere nella ricerca, Roma,
12-13 novembre 2009, organizzato da Dipartimento di Studi Internazionali dellUniversit di
Roma Tre, Societ Italiana delle Storiche, Societ Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea,
Giunta Centrale per gli Studi Storici.
4 Per un contributo alla discussione attuale sulla categoria di genere vedi Salvatici, S. (a cura di) Il
genere: unutile categoria di analisi per la storia delle donne?, in Contemporanea, XIII, 2, 2010, pp.
303-342.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 22 03/05/2013 11:11:09
23
Elisabetta Vezzosi
Abbiamo sbagliato in Italia, negli anni Ottanta, a non creare dipartimenti di
Womens Studies, rifutando il separatismo disciplinare? Dif cile fornire una risposta
che non tenga conto degli accesi dibattiti allora avvenuti su questo tema. Oggi for-
se la creazione di Centri Studi di genere, Osservatori di genere, etc., lattenzione al
terzo livello della formazione, che pu compensare e recuperare sul piano didattico
(lezioni, cicli di seminari e conferenze, gruppi tematici) le carenze presenti? Lattivit
pu essere intensifcata nel settore della scuola, dei curricula allinterno dei dottorati
di ricerca, della formazione long-life learning. Certo la difusissima condizione di
precariet tra le giovani storiche, a oggi quasi del tutto assente nelle ricognizioni e
ricerche disponibili
5
, non aiuta un rilancio della disciplina in ambito accademico
segnando un rilevante gap tra quantit e qualit della ricerca e legittimazione.
E il ruolo della SIS quale pu essere nellambito di questa rifessione sul fu-
turo? stato il seminario interno del giugno 2009, La SIS compie ventanni:
rifessioni sul passato, prospettive per il futuro
6
, a fornire le prime risposte, che il
Consiglio direttivo e le socie tutte avrebbero poi elaborato nel corso di assemblee
e incontri tematici. Dal seminario uscirono parole nuove, parole che aprono,
come disse Dianella Gagliardi. Che aprono a nuove occasioni, nuovi temi, nuove
azioni, nuovi confronti, nuovi comportamenti. Le riassumemmo cos:
raforzamento del legame tra ricerca e operare politico. Necessit di una rein-
venzione del linguaggio della politica;
identit della SIS, caratterizzata dallessere tra: tra ricerca e lavoro, tra appar-
tenenza disciplinare e politica, tra generazioni. Una pluralit di presenze che
ne fanno una societ professionale sfaccettata e un possibile nuovo laboratorio
di costruzione e condivisione;
valore e senso di appartenenza. La Societ come impegno intellettuale vissuto
collettivamente e non in solitudine;
intensifcazione della presenza pubblica scegliendo di volta in volta sui vari
temi gli interlocutori;
riconoscimento accademico-istituzionale e professionale;
individuazione di percorsi di ricerca mirati e raforzamento delle reti;
costruzione di opportunit per le nuove generazioni di studiose: di ricerca, di
insegnamento anche nellambito del long-life learning;
necessit di puntare sullinternazionalizzazione come leva di rilancio e sullau-
toimprenditorialit;
5 Vedi in questo senso le ricerche, i saggi e gli interventi a convegni di Schettini, L.Diversamente
storiche: una rifessione sulla condizione delle storiche nellet del precariato, in Genesis, X, 2, 2011,
pp. 179-197; relazione dal titolo Precariet, potere, appartenenza di genere, al Seminario annuale 2001
della Societ Italiana delle Storiche, Generazioni, Precariet, Leadership, Firenze, 17 giugno 2011.
6 Il seminario, tenutosi il 19-20 giugno 2009 a Firenze, era dedicato ad Annarita Buttafuoco.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 23 03/05/2013 11:11:09
24
La Societ Italiana delle Storiche, il futuro della storia delle donne e di genere, le generazioni
interdisciplinariet e capacit di dialogo in modo da coinvolgere in maniera
attiva, su temi signifcativi, altre associazioni di donne;
ripensare la storia delle donne e di genere nella scuola, nei curricula universi-
tari e nellambito delle scuole dottorali;
desiderio di autonomia e responsabilit da parte delle nuove generazioni ri-
spetto alla SIS. Intreccio di linguaggi nuovi e antichi (e a volte abusati).
Ascolto delle percezioni di futuro delle giovani studiose. Non trasmissione
tra generazioni ma circolazione di idee, prospettive, pensieri: donne-studiose
di generazioni diverse che posso essere compagne di pensiero, come ha scrit-
to Enrica Asquer.
Gli importanti seminari successivi hanno ampliato quelle parole, quelle idee:
Sguardi incrociati sul genere (giugno 2010), Generazioni/precariet/leadership (giu-
gno 2011).
Oggi la Societ Italiana delle Storiche in buona salute e piena di attivit. Su
quali aspetti dobbiamo, dunque, lavorare per superare alcune criticit: sulla re-
sponsabilizzazione delle socie, anche giovani, nellassumersi posizioni di leadership
di gruppi e progetti; sulla creazioni di reti fnanziate di ricerca che possano soste-
nere le giovani socie impedendo loro di allontanarsi dalla ricerca; sullinternazio-
nalizzazione; sullintensifcazione della nostra attivit nel settore della scuola, dei
dottorati di ricerca, della formazione long life learning, su una presenza pubblica
visibile su temi di volta in volta scelti.
Sono certa che riusciremo, la pubblicazione di questi volumi ringrazio Lau-
ra Guidi e Maria Rosaria Pelizzari per questo un forte segno di determinazione
a proseguire con energia il nostro lavoro.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 24 03/05/2013 11:11:09
Introduzione
Laura Guidi, Maria Rosaria Pelizzari
Il V Congresso della Societ Italiana delle Storiche (SIS), svoltosi a Napoli nel gen-
naio 2010, ha riconfermato il carattere di appuntamento internazionale a scadenza
triennale, ampio e inclusivo, con cui la SIS, a partire dal 1995, ha inteso ofrire
unoccasione di visibilit a chi svolge ricerche nel campo degli studi storici di genere.
Giovani ricercatrici e ricercatori sono stati, infatti, inseriti nel programma accanto a
nomi di consolidato prestigio internazionale grazie alla formula di una molteplicit
di panel tematici af ancati dalle lezioni storiografche e metodologiche di alcune
protagoniste della Gender history nonch da una tavola rotonda su un tema indivi-
duato dalle organizzatrici come particolarmente signifcativo e attuale.
La formula che ha ispirato lorganizzazione del Congresso viene in parte ri-
prodotta dai volumi che presentiamo, bench questi non ne costituiscano una
pura riproduzione ma piuttosto una rielaborazione di gran parte dei lavori pre-
sentati nelle giornate napoletane. In continuit con le esperienze precedenti, il
Comitato scientifco, pur avendo, infatti, scelto e sollecitato la partecipazione di
studiose/i ritenuti di particolare signifcato per la Gender history, ha riconfermato
al tempo stesso una modalit organizzativa dal basso, che partiva dalle proposte
dei gruppi e delle/dei singoli che avevano risposto al call for panels. Dalle proposte
pervenute era emersa, infatti, una variegata ricchezza di temi e approcci scientifci,
che il Comitato scientifco, pur esercitando il suo compito di selezione e coordina-
mento, ha cercato quanto pi possibile di preservare. Il tema stesso del Congresso,
nella sua formulazione volutamente ampia e inclusiva, si limitava a indicare alcune
parole chiave che potessero agevolare comparazioni e proposte innovative, pur
nella grande diversit dei temi presentati. Quella delle frontiere del resto una
categoria ricorrente e, si potrebbe dire, fondativa nella Storia di genere, che si
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 25 03/05/2013 11:11:09
26
Introduzione
caratterizzata dal suo nascere per il continuo attraversamento e la decostruzione
di confni: quelli tra discipline, grazie alle fertili contaminazioni tra storia, scienze
socio-antropologiche, letteratura, scienze della salute, storia delle arti, psicoanalisi,
e cos via, nonch per le barriere e le opposizioni binarie codifcate nel linguaggio
e nelle categorie di analisi (tra pubblico e privato, natura e storia, Occidente e
societ altre, fno alla rappresentazione binaria delle stesse identit di genere,
o alla separazione dualistica tra soggetto e oggetto della ricerca). Nel riferirci alle
nuove frontiere intendevamo, quindi, aprire una serie di interrogativi e rifessioni
allinterno della nostra area di studi, ormai ricca di oltre trentanni di esperienze:
chiederci quali dei percorsi di ricerca delineati nelle prime fasi vengano oggi prose-
guiti e consolidati, quali siano gli elementi di pi singolare innovazione introdotti
negli ultimi anni, quali gli aspetti peculiari di questultimo congresso. Raccogliere
il contributo di nuove fonti e nuove chiavi interpretative su temi gi esplorati in
passato, e ofrire spazio a suggestioni, temi, prospettive pi radicalmente inediti.
Tra le frontiere valicate dagli studi qui presentati, si impone con chiarezza il supe-
ramento di una visione centrata sullOccidente, limite che appariva dif cilmente
superabile appena ventanni fa, come sottolineava nel 1991 la Storia delle donne
curata da Georges Duby e Michelle Perrot. Aree extra-occidentali come il Nor-
dafrica, il Medio Oriente e lAmerica Latina (cui si aggiungeva, al Congresso, il
panel, di grande interesse, sulla Cina, che purtroppo non stato possibile pubbli-
care) vengono indagate nella loro peculiarit ma anche nella molteplicit dei loro
legami con il mondo occidentale. Analogamente, lo studio dei fenomeni migratori
e delle minoranze ci restituisce una molteplicit di soggetti e la complessit delle
loro relazioni, e delle stesse societ occidentali.
Della categoria di genere il Congresso e questi volumi testimonia un pi
profondo radicamento negli studi storici rispetto alla fase precedente, per altro
indispensabile e fertile, della Storia delle donne (intesa come lemergere e il
divenire visibile di unattiva presenza femminile nella Storia e, al tempo stesso,
come rifessione sulla sua cancellazione o stereotipizzazione). Alcuni dei contri-
buti presentati in questi volumi adottano anche lapproccio della Mens History;
altri indagano la storia dellomosessualit e della transessualit, decostruendo una
visione binaria dellidentit di genere e sottolineandone il carattere di complessa
costruzione culturale e storica. Numerosi interventi esprimono laspirazione a una
rilettura/riscrittura della Storia, in cui la nuova visibilit di una presenza femmi-
nile, prima rimossa, costituisca solo il passaggio necessario verso una ricostruzione
complessiva della storia di donne e uomini, negli aspetti sociali e culturali come in
quelli economici e politici.
Nel pubblicare questi volumi abbiamo inteso, sulla scia del Congresso, of-
frire una visione panoramica e inclusiva di un grande cantiere di lavori, creare
unopportunit di contatto tra studiose/i e gruppi di ricerca, e in particolare tra
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 26 03/05/2013 11:11:09
27
Laura Guidi, Maria Rosaria Pelizzari
le nuove leve della Storia di genere, ofrendo un potenziale punto di partenza
per ulteriori iniziative che, mettendo a fuoco temi specifci, possano rispondere
a esigenze di approfondimento degli stessi. Lopera, infatti, per la natura stessa di
questa iniziativa, non ha potuto accogliere lesposizione analitica delle singole ri-
cerche, limitandosi a ofrire rapide sintesi e suggestioni, da cui ci si augura possano
nascere interessi, curiosit, aggregazioni tra ricercatori. E che questi volumi siano
in grado di trasmettere la stessa energia che circolava a Napoli durante i tre giorni
del Congresso, fertili di idee, scoperte, proposte, contatti
7
.
La stessa, densa ricchezza di quelle giornate ci ha costrette a operare dei tagli
nel passaggio dal Congresso alla pubblicazione. In particolare, non stato possibi-
le pubblicare in questa sede gli interventi della tavola rotonda su La storia di genere
nel dialogo tra generazioni, che stata ricca di spunti di discussione e ha visto la
partecipazione al dibattito di molte giovani ricercatrici e studentesse. La relazione
introduttiva di Pauline Schmitt Pantel e Franoise Tbaud viene invece ripropo-
sta in una forma rielaborata e tradotta in italiano grazie alla preziosa collabora-
zione di Michle Benaiteau, che ringraziamo. Lanalisi delle interpretazioni e del
dibattito intorno alla categoria di genere in ambito storiografco viene proposta
da due studiose di alto proflo, unantichista e una contemporaneista, attraverso la
comparazione di studi francesi e angloamericani tra gli anni Novanta e il tempo
presente. La loro rifessione storiografca ben si presta ad aprire questa pubblica-
zione e a introdurne alcuni punti chiave sul piano metodologico e interpretativo.
Il testo di Marta Petrusewicz (elaborato a partire dalla lezione introduttiva
al secondo giorno), sul dibattito ottocentesco che sottoline lantagonismo tra
i tempi lenti e ciclici di Madame la Terre e laccelerazione spesso predatoria, di-
struttiva di equilibri sociali e contesti ambientali, impressa da Monsieur le Capital,
introduce una lettura di genere su temi quali la sostenibilit dello sviluppo e le
trasformazioni dellambiente, di evidente interesse attuale.
1. Genere e politica
I contributi riuniti in questa prima parte dellopera esprimono complessivamente
laspirazione a una rilettura dellintera storia politica alla luce del genere. Modelli,
identit, norme, confitti politici non sono ritenuti analizzabili e interpretabili
7 Questi Atti vedono la luce con un ritardo, dovuto al completamento di un lungo iter burocratico,
richiesto dalla valutazione e dallapprovazione dei materiali da parte di due commissioni scientifche
dellUniversit degli Studi di Salerno, che, essendo stata tra i fnanziatori del V Congresso SIS, si
assunta lonere, non indiferente, della pubblicazione nella sua Collana scientifca. Tra la consegna
del materiale alluf cio stampa, nel giugno 2011, e la pubblicazione, quindi passato oltre un anno,
per cui in alcuni casi la bibliografa potrebbe non comprendere opere uscite in questo periodo.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 27 03/05/2013 11:11:09
28
Introduzione
ef cacemente se si prescinde dal ruolo svoltovi dalle donne come soggetti attivi,
da un lato; dal ruolo simbolico svolto dal genere nel disegnare rappresentazioni e
teorie politiche, dallaltro.
il caso delle rappresentazioni della polis nella Grecia antica, destinate a con-
dizionare tutto il pensiero politico successivo. Miti potenti e indimenticabili come
quello della barbara Medea, infatti, pongono le fondamenta di coppie oppositi-
ve basilari per la confgurazione della polis: inclusione-esclusione, ordine-disordine,
cittadino-barbaro. Escluse dalla cittadinanza, le donne possono, paradossalmente,
divenirne il fattore di continuit: ad esempio, attraverso i matrimoni misti che se-
gnano le fasi di riconciliazione e rifondazione civile. Ma, avvertono le curatrici della
sezione (Claudia Montepaone e Gabriella Pironti), nel contesto della Grecia classica
il genere, inteso come la maniera in cui una societ costruisce i rapporti tra i sessi,
indissociabile dagli altri due sistemi di classifcazione propri della polis: quello che
distingue le diverse classi di et e quello che separa i cittadini dai non cittadini.
La dicotomia tra oikos e polis viene analizzata e decostruita anche nella sezione
coordinata da Linda Jauch, che sottolinea come solo considerando la continuit
tra relazioni familiari-dinastiche e sfera politica sia possibile cogliere la complessit
delle dinamiche tra dinastie, e degli sviluppi nelle relazioni interne alla coppia
reale, che disegnano la storia politica dellet moderna. Matrimoni, nascite, tra-
smissione di patrimoni rappresentano infatti momenti cruciali per la storia po-
litica del tempo. Nel pensiero politico dellepoca, daltra parte, famiglia e Stato
sono dimensioni entrambe basilari: per Bodin, in particolare, lanalisi della sfera
politica si sviluppa a partire da unattenta analisi delle relazioni di potere in ambito
familiare (the power of the husband over the woman is the source and origin of any
human society). Nel ribadire la continuit e linterdipendenza tra le due sfere, Bodin
consolida altres il principio della naturale e necessaria soggezione femminile, che dalla
sua opera risulta essere il pilastro su cui si regge lintero sistema sociale e politico.
Un folto gruppo di contributi riguarda i processi di costruzione nazionale
nellOttocento. Il flo rosso, che lega gli interventi della sezione coordinata da
Maria Luisa Betri, il tema degli spazi ottocenteschi di autonomia femminile,
insieme con laspirazione delle donne a coniugare diferenza e inclusione nella
comunit nazionale. NellOttocento le donne sono protagoniste di una sfera di
socialit e di opinione pubblica, distinta sia dalla dimensione domestica sia dalla
vera e propria sfera politica. Alla pedagogia nazionale prevalente dopo il 1860,
che confna le donne nel ruolo domestico, fa riscontro una cultura di dissenso dai
valori tradizionali, difusa in area repubblicana e garibaldina, e, nello stesso tem-
po, un modello di patria come collettivit eterogenea in cui anche la componente
femminile elemento basilare di una nuova vita democratica nazionale.
Anche i contributi della sezione coordinata da Rafaella Bianchi sottolineano
come tra il 1840 e il 1870 la produzione poetica, melodrammatica e pittorica ofra
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 28 03/05/2013 11:11:09
29
Laura Guidi, Maria Rosaria Pelizzari
esempi di donne che non si limitano a incoraggiare uomini intimoriti o codardi,
ma li af ancano, o addirittura li superano in ardimento, dimostrando altrettanto
coraggio ed eroismo. Su queste presenze del patriottismo romantico, distanti dal-
la pedagogia nazional-patriottica dominante, prevarranno tuttavia fgure di donne
ricondotte entro i limiti di una femminilit pi convenzionale. Particolarmente sti-
molanti, su questo tema, le osservazioni di Simonetta Chiappini sulluso e i signif-
cati delle voci maschili e femminili nel teatro lirico del tempo, tempio del patriot-
tismo italiano, nellambito di una codifcazione nazionale delle identit di genere.
Il ruolo delle donne del Sud dItalia nella costruzione della nazione, lopinio-
ne femminile sulla nascente questione meridionale, una memorialistica femminile
del Risorgimento meridionale che al tempo steso storia privata e familiare e sto-
ria politica, sono al centro della sezione coordinata da Laura Guidi. Dalle ricerche
presentate emerge un patriottismo femminile di respiro cosmopolita, che si nutre
di letture, scritture, viaggi, conversazioni, corrispondenze. Il 1848 rappresenta il
momento di passaggio dalla dimensione del salotto, della conversazione colta, dei
dibattiti epistolari sulla vita ideale e la necessit di rinnovamento sociale, al pia-
no pi esplicitamente politico e militante, del quale le donne saranno protagoniste
al fanco degli uomini.
La sezione coordinata da Valentina Greco su genere, cittadinanza e politica
nellItalia contemporanea ripropone lipotesi che gli spazi di confne siano parti-
colarmente fertili per lanalisi della partecipazione politica femminile. Esperienze
al margine o del tutto escluse dalla narrazione pubblica, ma non per questo
irrilevanti. il caso della battaglia civile e democratica condotta da Olga Arcuno,
docente di Storia e Filosofa ed educatrice dei giovani a valori civili e democratici,
fondatrice di associazioni e riviste, tra fascismo e dopoguerra.
Su un versante culturalmente e politicamente opposto, la vicenda del MIF
apre squarci inediti sul ruolo attivo delle donne di destra nelle vicende del fasci-
smo italiano, nel periodo di transizione alla Repubblica e alla democrazia.
Le testimonianze autobiografche delle militanti di Lotta Continua rivelano
le dif colt e le contraddizioni nelle relazioni di genere allinterno del gruppo e
fanno luce sul controverso rapporto delle militanti con la violenza politica degli
anni Settanta.
Le fonti biografche si rivelano, in questa come in altre sezioni, preziose nella
trasmissione della memoria femminile, testimone in questo caso dellampliamen-
to dello spazio politico e della messa in discussione di quello privato che contrad-
distinsero i movimenti sociali politici e culturali di quegli anni. Emerge il nodo
problematico della violenza politica agita o comunque condivisa dalle donne, che nelle
loro testimonianze tendono a spostare il discorso dalla violenza agita a quella subi-
ta, culturalmente pi accettabile: la violenza agita dalle donne rappresenta tuttora
osserva la curatrice un nodo irrisolto della memoria collettiva.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 29 03/05/2013 11:11:09
30
Introduzione
LItalia degli anni Settanta del Novecento torna nella sezione coordinata da
Beatrice Pisa, da cui emerge limmagine di una fase storica che, nonostante i suoi
aspetti pi bui, si caratterizz per unintensa attivazione di energie positive, dando
vita a una fase di conquiste sociali, culturali e legislative che cambiarono il volto
della nostra societ.
Il femminismo perme gran parte di questi mutamenti: il caso delle inse-
gnanti che videro nella loro professione uno strumento per cambiare la societ
nella direzione di un empowerment femminile, cos come della svolta operata, a
partire dallo Statuto dei Lavoratori, nei diritti delle lavoratrici. Dal femminismo
nacque il radicale e libertario MLD, che svolse un ruolo rilevante nel dar voce e
respiro nazionale alle istanze femministe, ma che viene generalmente rimosso dalle
ricostruzioni storiografche. Il femminismo ebbe ripercussioni profonde anche sul
partito considerato baluardo della tradizionale defnizione dei rapporti di genere:
il movimento femminile della Democrazia Cristiana, infatti, fn dagli anni Ses-
santa esercit un ruolo di sollecitazione progressista su temi quali i rapporti con
la sinistra, la parit fra i coniugi, il divorzio. Le democristiane denunciarono la
scarsit di candidature femminili nelle liste del partito e limpossibilit delle donne
di accedere a posizioni di responsabilit al suo interno.
NellAmerica Latina del Novecento, su cui indaga la sezione coordinata da Maria
Rosaria Stabili, le donne sono veicoli di modernit e laicit, in contrasto con lo stere-
otipo nazionalista che identifca la donna con la funzione materna, luomo con quella
militare, in un contesto segnato dal patriarcato e da un maschilismo che produce
violenze eferate nei confronti delle donne. Eppure la presenza attiva e riconosciuta
delle donne in molti ambiti della vita pubblica rappresenta uno degli elementi pi
signifcativi di rinnovamento in quellarea nellultimo scorcio del secolo scorso e nei
primi anni dellattuale. La seconda ondata del femminismo, negli anni Settanta, si
sviluppa in America Latina contemporaneamente al movimento per i diritti umani,
la cui leadership quasi tutta femminile. Giovani donne dalla formazione cosmopo-
lita, tornate dallestero nei Paesi di provenienza, cominciano a nominare questioni
quali la sessualit, gli abusi sessuali, la violenza domestica, lautonomia del corpo fem-
minile, la femminilizzazione della povert, indicandole come questioni nodali della
costruzione democratica dei loro Paesi. Nascono movimenti politici femminili che
utilizzano abilit e competenze proprie della sfera femminile, in particolare nelle mo-
dalit di socializzazione. Le Madri di Piazza di Maggio, in Argentina, sono un chiaro
esempio di come ruoli squisitamente femminili possano acquisire un nuovo signif-
cato politico e sociale. Negli ultimi anni molte donne ricoprono la carica di sindaco
nelle capitali e in importanti citt dellarea; cinque sono state elette presidenti della
Repubblica. Si sono imposte, nella maggior parte dei casi, grazie al loro radicamento
nella societ e non per designazioni avvenute dalle segreterie dei partiti, contribuendo
anche sotto questo aspetto a un signifcativo rinnovamento della politica.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 30 03/05/2013 11:11:09
31
Laura Guidi, Maria Rosaria Pelizzari
Larea MENA (Middle East and North Africa) oggetto degli interventi co-
ordinati da Anna Maria Di Tolla ed Ersilia Francesca, che illustrano le dinamiche
di genere nellambito delle trasformazioni economiche e politiche degli ultimi
decenni sul piano delle relazioni familiari, dellinfuenza del fondamentalismo
islamico, delle politiche governative, del lavoro, delle migrazioni. Il mondo fem-
minile islamico elabora, di fronte alle sfde della globalizzazione, risposte che lo
pongono oltre una semplice condizione di subordinazione. Se, da un lato, luso
strumentale dellIslam e della tradizione patriarcale tende a perpetuare un ordine
sociale discriminatorio, le tradizioni berbere, cos come il femminismo islamico,
suggeriscono esiti diversi. Senza dubbio, poi, modernizzazione e globalizzazio-
ne infuenzano le dinamiche di genere in area MENA, determinando da un lato
una concezione pi avanzata dei diritti politici, sociali ed economici delle donne,
dallaltro producendo nuove e pi sottili discriminazioni. Occorre dunque andare
oltre le categorie di tradizione e modernizzazione per analizzare la complessit
dei fenomeni di mutamento in atto.
La sezione coordinata da Lucia Valenzi presenta alcuni casi di iniziativa socia-
le e politica femminile nella Tunisia tra le due guerre. Il caso delle Suore Bianche,
attive nel Paese sin dallinizio del XX secolo, si presta alla rifessione sulluso stru-
mentale di temi di genere da parte dei colonizzatori: gli stessi funzionari coloniali
che cercano di accreditare unimmagine di s come liberatori delle donne dei
paesi coloniali, infatti, sono oppressori delle donne appartenenti alla propria
cultura. Cos lazione emancipatrice svolta dalle Suore Bianche nei confronti delle
tunisine viene contraddetta dalla loro condizione di subordinazione rispetto alla
branca maschile della congregazione.
Gli altri casi analizzati riguardano donne attive in quel laboratorio politico che
nella Tunisia degli anni Trenta e Quaranta prese forma dalliniziativa di antifascisti e
anticolonialisti di diverse nazionalit: donne e uomini francesi, italiani, arabi.
Nel piccolo ma agguerrito partito comunista le donne non sono moltissime,
ma svolgono un ruolo signifcativo. Alcune di esse, di origine italiana, raggiunge-
ranno altra riva del Mediterraneo nel dopoguerra, portandovi la forza del loro
spirito combattivo, dellironia e dellottimismo grazie al quale avevano superato le
prove del carcere, della clandestinit e della guerra.
Il complesso rapporto fra identit di genere e identit nazionale nello scenario
del confitto israelo-palestinese il nodo con cui si confrontano le studiose che par-
tecipano alla sezione coordinata da Maura Palazzi. Due sono i temi principali. Il pri-
mo riguarda lattivit delle donne in associazioni femminili/femministe per la pace:
la possibilit di interazione positiva fra lesperienza dei gruppi misti di israeliane e
palestinesi, come il Jerusalem Link; la prospettiva One State di soluzione del confit-
to, riproposta dopo il fallimento degli accordi di Oslo; la storia di Machsom Watch,
fondata da israeliane per il monitoraggio dei check point installati in Cisgiordania.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 31 03/05/2013 11:11:09
32
Introduzione
Il secondo tema riguarda le rappresentazioni delle donne palestinesi e israelia-
ne proposte allinterno delle comunit nazionali di appartenenza. Sui manuali sco-
lastici di Cisgiordania e Gaza, pubblicati a cura dellautorit palestinese, il coin-
volgimento delle donne nella sfera pubblica provocato dalloccupazione , seppur
valorizzato, interpretato come estensione di ruoli tradizionali; mentre, in merito
alle opere di letterati e cineasti israeliani come David Grossman e Avi Mograbi,
Raya Cohen osserva che, anche quando rappresentano madri o mogli che critica-
no i loro uomini per la partecipazione a crimini di guerra, gli autori (maschi) non
riescono a immaginarle impegnate nella creazione di spazi politici alternativi.
La sezione curata da Silvia Niccolai esplora i rapporti tra i movimenti e la
cultura femministi e le politiche europee per le pari opportunit uomo-donna.
Tali politiche hanno prodotto lacquisizione di competenze europee verso materie
non direttamente riconducibili al mercato (come lambiente, la salute, la ricerca).
Sono state cos promosse iniziative europee contro la violenza di genere e per la
salute delle donne. Gli interventi di questa sezione si interrogano sullinfuenza
che la cultura femminista, a partire dagli anni Sessanta e Settanta, ha esercitato sui
contenuti, sul linguaggio e sulle modalit di intervento delle istituzioni europee.
La presa in carico istituzionale di temi risalenti al movimento femminista ha, a sua
volta, inciso sui percorsi del femminismo in Europa. Viene sottolineata, infne, la
perdita di ef cacia delle iniziative quando queste hanno stemperato le azioni per le
donne nel pi ampio quadro di una politica sociale europea, troppo spesso rivolta
prioritariamente a salvaguardare gli interessi del sistema economico.
2. Spazi, ruoli, poteri
In questa parte dellopera, pur nella variegata diversit dei contesti indagati,
possibile individuare alcuni elementi ricorrenti che ofrono spunti di rifessione e
comparazione. Innanzitutto colpisce la fuidit delle relazioni sociali concrete e dei
percorsi individuali, il loro dinamismo nei diversi contesti analizzati, rispetto alla
rigidit delle norme astratte nel defnire spazi, ruoli, modelli identitari di genere.
Gli spazi delle donne analizzati sono fsici e simbolici a un tempo, marcati dal
potere e dal prestigio femminile: il caso delle sepolture agli albori dellet storica,
che attraverso la disposizione spaziale e i corredi testimoniano prestigio e ruoli di
donne, uomini, bambini; quello del controllo di territori politicamente strategici
da parte delle regine medioevali; quello degli spazi domestici contrassegnati da
oggetti densi di signifcato; quello dei salotti ebraici berlinesi, luoghi peculiari di
integrazione tra culture. Gli spazi fsici, culturali, sociali vengono attraversati e
riattraversati nelle complesse strategie delle donne migranti. Gli spazi fsici e sim-
bolici costituiscono mappe di relazioni tra i gruppi maggioritari e le minoranze
di un determinato contesto, defnendo rapporti nei quali il genere costituisce un
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 32 03/05/2013 11:11:09
33
Laura Guidi, Maria Rosaria Pelizzari
elemento di ulteriore diferenziazione nellambito delle diferenze tra gruppi etnici
o religiosi.
Sugli spazi fsici e metaforici si costruiscono ruoli e poteri, si defnisce lac-
cesso a risorse materiali o simboliche: dai patrimoni, al lavoro, ai diritti sociali.
Lanalisi degli spazi e dei ruoli occupati dalle donne nei diversi contesti criminali
italiani, infne, vede la rigidit degli antichi codici donore cedere il passo a forme
diverse di adattamento alla modernit globalizzata e a peculiari forme di eman-
cipazione femminile.
La prospettiva archeologica si rivela preziosa per lo studio delle origini e dei
primi sviluppi delle diseguaglianze sociali, obiettivo per il quale le categorie di
genere, et ed etnia devono essere incrociate con quelle riferite alla diseguaglianza
nellacceso alle risorse, defnibile, fn dal nascere di societ complesse, in termini
di rango o classe. Esempio del signifcativo contributo che, in tempi recenti,
larcheologia italiana ha iniziato a dare agli studi di genere, la sezione coordinata
da Mariassunta Cuozzo e Alessandro Guidi indaga sulle diferenze di genere, et e
appartenenza etnica desumibili dallo studio dei contesti funerari dellarea tirreni-
ca, tra la fne dellet del bronzo e linizio dellet storica.
Tra il nono e il decimo secolo, in Nord-Italia e in Germania, complessi appa-
rati normativi defniscono la qualit dei beni dotali delle regine e la loro disponibi-
lit libera o vincolata. I contributi coordinati da Lazzari illustrano come detenere
parti del patrimonio pubblico includesse inevitabilmente la regina anche nella
gestione in prima persona del potere politico e fanno emergere il valore strategico
di questi beni ai fni del controllo di ampie porzioni delle risorse dei regni, il cui
signifcato va ben oltre quello di un semplice valore privato e familiare.
Gli spazi delle donne allinterno di alcune minoranze vengono analizzati
nella sezione coordinata da Alessandra Veronese, che sottolinea linadeguata atten-
zione storiografca su questo tema. Le minoranze indagate dai diversi contributi
sono religiose, razziali, etniche, domestiche: ebrei, zingari, stranieri, schiavi. Viene
analizzata la posizione delle schiave che vivono a Genova tra Medio Evo e Rinasci-
mento: intimate stranger il cui corpo viene sfruttato e mercifcato. Sono indagati
rapporti e socialit nella composita popolazione di straniere esistente a Roma tra
XV e VI secolo. Viene analizzata la condizione delle zingare nel Sud dItalia e
quella delle ebree convertite a Firenze nella prima et moderna e infne la vita delle
ebree di Trieste tra XIX e XX secolo.
Le domande che scaturiscono dallinsieme di questa sezione riguardano il for-
marsi dellidentit di queste donne, le implicazioni dellappartenenza a religioni di-
verse da quella cattolica, la loro infuenza nellambito dei gruppi di appartenenza, il
loro rapporto sia col mondo maschile che con le donne dei gruppi dominanti.
Alcuni di questi temi ritornano nella sezione di Paola Ferruta, Anna Dorothea
Ludewig e Hannah Lotte Lund che esplora immagini e concetti di marranismo
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 33 03/05/2013 11:11:09
34
Introduzione
nei secoli XIX e XX: si intende con questo termine unassimilazione a un sistema
religioso che continua a coesistere con leredit culturale ebraica senza eclissarla;
un fenomeno di sconfnamento, di trasgressione di confni morali e materiali. Alle
donne ebree consentito ci che quasi impossibile per gli uomini: collocarsi al
confne tra due mondi, vivere una condizione di travestimento metaforico, sacri-
fcare la propria stessa identit a vantaggio della propria comunit. La Bibbia stessa
ofre loro larchetipo di Ester, intermediaria tra il mondo ebraico e i non-ebrei.
Il tema del lavoro femminile, riferito soprattutto allItalia del Novecento,
al centro della sezione coordinata da Gloria Chianese. NellItalia contemporanea
esso caratterizzato da una discontinuit occupazionale e da una mancanza di
tutele che sono propri e della societ postindustriale. Pertanto le culture e le pra-
tiche lavorative delle donne vanno scandagliate in profondit, attraverso percorsi
di ricerca specifci, che ne evidenzino le relazioni con lambito familiare cos come
il rapporto con la dimensione pubblica. Ridare voce alle lavoratrici del passato
soggetto collettivo sommerso superando rimozioni e censure il progetto
ambizioso di questo gruppo di ricercatrici.
Si sottolinea il contributo cospicuo alla costruzione della cittadinanza decli-
nata in primo luogo come acquisizione dei diritti sociali prodotto dalle organiz-
zazioni femminili interne al mondo sindacale. Negli anni Cinquanta incomincia-
va a emergere il tema della doppia fatica delle donne e la necessit di difendere
la vita della lavoratrice nei due aspetti della fabbrica e della casa, messa in luce
soprattutto dallUDI: da qui le prime rivendicazioni di servizi sociali atti ad alle-
viare le fatiche imposte dalla sfera riproduttiva.
Al tema del lavoro si collega fortemente quello delle migrazioni femminili nel
XX secolo. I contributi coordinati da Maria Rosaria De Rosa sottolineano come la
migrazione vada analizzata nella maggior parte dei casi non come decisione defnitiva,
ma come segmento entro percorsi complessi, che vedono ritorni e relazioni forti con i
contesti di origine. Flessibile e imprevedibile, il ruolo delle migranti non pu essere ri-
dotto a un fenomeno gregario e mette in atto una molteplicit di strategie individuali
nel creare relazioni sia interne che esterne al gruppo etnico nei luoghi di approdo. Re-
lazioni con il vicinato nei luoghi di immigrazione, uso del denaro, progetti di ritorno
e clandestinit tracciano alcuni dei percorsi di ricerca di questa sezione.
Oggetti quotidiani come espressione di pratiche culturali individuali e fami-
liari, cose che impersonano valori, signifcati, emozioni, memorie, tradizioni
familiari: questo il tema della sezione tra storia, sociologia e antropologia co-
ordinata da Laura Savelli, che fa degli oggetti domestici un punto di osservazione
sulla societ italiana del dopoguerra e i suoi cambiamenti. Attraverso gli oggetti,
individui e famiglie defniscono spazi di lavoro e domesticit, memorie e identit.
Sul piano della distribuzione, del consumo, delle pratiche di dono, gli oggetti svol-
gono un ruolo signifcativo nelle strategie di distinzione sociale, diferenziandosi
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 34 03/05/2013 11:11:09
35
Laura Guidi, Maria Rosaria Pelizzari
in relazione al genere, alla classe di et, allo status socio-culturale. I cambiamenti
nelle pratiche di acquisizione e uso degli oggetti ofrono pertanto numerosi spunti
per lo studio dei mutamenti socio-antropologici nella societ contemporanea.
Nella sezione coordinata da Gabriella Gribaudi e Marcella Marmo la prospet-
tiva di genere viene applicata allo studio delle organizzazioni criminali. Il tema
delle donne al loro interno si misura con nodi cruciali quali il rapporto fra genere
e violenza, fra tradizione e modernit, la gerarchia interna alle organizzazioni e la
sopravvivenza, o il mutare, di antichi codici donore. Attraverso storie di donne
appartenenti a Mafa, Camorra, Ndrangheta e Sacra Corona Unita, tra il XIX
secolo e i nostri giorni, si analizzano le relazioni tra singole donne e gruppi di
appartenenza, le trasformazioni di pratiche antiche e le forme di adattamento alla
societ globale. I ruoli di potere e talora di comando ricoperti dalle donne, in par-
ticolare negli ultimi decenni, richiedono chiavi interpretative distinte da quella di
emancipazione propria della storia del femminismo borghese, che fa riferimento
allindividuazione della persona a fronte di ruoli cogenti, e alladesione a valori di
liberazione.
Nelle storie di vita analizzate, al contrario, lacquisizione di potere non cor-
risponde a una conquista di indipendenza individuale: la dimensione degli afetti
si sovrappone e si confonde con quella degli afari in una ragnatela inestricabi-
le, mentre a donne e uomini richiesta una solidariet tendenzialmente assoluta
allinterno del gruppo, cui deve corrispondere laggressivit analogamente assoluta
allesterno.
3. Immaginari e linguaggi
Nella terza e quarta parte delle Nuove frontiere il discorso si soferma, con un oc-
chio accentuatamente interdisciplinare, su alcuni aspetti che completano il quadro
fn qui delineato. Aspetti che si sviluppano allinterno di due sezioni tematiche,
strettamente legate tra di loro, con ampio spazio dedicato alle scritture biograf-
che e alla narrazione: Immaginari e linguaggi e Il corpo: discorsi e pratiche.
Creativit, soggettivit, ricerca di libert ma anche percorsi di adattamento alle
culture dominanti emergono da questa parte del volume, in cui, in modo partico-
lare, le arti della scena (danza, teatro, cinema) sono indagate attraverso un angolo
visuale che parte dal basso esplorando il ruolo delle spettatrici nellinfuenzare,
condizionare o promuovere determinate arti sceniche. Limmaginario o meglio
gli immaginari il plurale dobbligo in un discorso che segue s linee verticali e
orizzontali ma spesso attraversato diagonalmente da vicende e fenomeni sociali
e culturali sono analizzati a partire da unindagine di tipo semiotico che mira a
chiarire e decodifcare i segni con i quali essi si manifestano, sia nel campo della
formazione e dei sentimenti, che in quello legato al corpo e al suo lessico. Se
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 35 03/05/2013 11:11:09
36
Introduzione
oggi, di fronte a un mondo sempre pi multiculturale, si discute, con rinnova-
to interesse, sul concetto di cultura, analogamente, laspetto culturale assume
un particolare interesse nellanalisi di altri contesti ed epoche storiche. proprio
quanto emerge dai saggi del gruppo, coordinato da Monica Ferrari, sulleduca-
zione delllite femminile tra tardo Medioevo e prima et moderna, che prova a
declinare al femminile il tema della cultura per e di un dato gruppo di soggetti del
sociale che non sempre ha trovato spazio di espressione e memoria. La rifessione
si concentra soprattutto sulle peculiarit delleducazione al femminile nelle corti
europee per rifettere, non solo sui luoghi e sui tempi, ma anche sui segnidi une-
ducazione dlite che si confronta con stereotipi e con immagini di s, nel gioco
dei rimandi con le immagini degli altri. Linteresse si focalizza sui discorsi teorici
e sulle realizzazioni di modelli di formazione e processi educativi volti a plasmare
e collocare, in modo particolare, la principessa o la nobildonna nel ruolo a essa
spettante nella societ.
Emergono pertanto dal silenzio voci di donne che hanno scritto o, pi silen-
ziosamente, hanno lavorato per educare le fglie (e i fgli) dei Grandi. E proprio
sulleducazione dei Grandi, molti sono gli interrogativi ancora aperti data la molte-
plicit di fonti, di diferente tipologia, di cui si pu disporre: dalliconografa, alla
precettistica, alla memorialistica. Leducazione delle principesse e delle nobildonne
si rivela pertanto un tema suscettibile di diferenti approcci, in cui la proposta cultu-
rale e pedagogica si intreccia, nello stesso milieu, per confronti e comparazioni, con
quella riservata ad altre fgure sociali. Attualmente, negli studi, sempre pi forenti,
almeno a partire dalla fne degli anni Ottanta del secolo scorso, sulla formazione
delle principesse e sul loro ruolo culturale nelle corti europee, si sta ormai superando
progressivamente una storia fatta di medaglioni di donne illustri e di biografe esem-
plari, tipica della prima met del Novecento sulla scorta dellantica tradizione delle
clare donne e delle femmes forte. Si nota, in primo luogo, un attento uso delle fonti,
al fne di cogliere, oltre che la specifcit della cultura per le donne, anche la proposta
culturale al femminile nelle corti europee, intrecciando alle questioni famigliari, di-
nastiche e politiche pi vaste, anche la prospettiva della storia di genere. Si sta, infat-
ti, arricchendo, sempre di pi, una produzione storiografca e una letteratura che ha
assegnato per molto tempo centralit soprattutto ai maschi della casata, occupandosi
solo marginalmente delle loro fglie, mogli, madri e sorelle nellambito di romanzi o
di biografe che sapessero dare rilievo alla vita delle corti.
Sul flo dei sentimenti, con particolare riferimento allambito famigliare, si
dipana la sezione dedicata alla memoria sovversiva, in cui si analizzano tracce e
trame di vita afettiva: dal legame di sangue tra genitori e fgli, alle dinamiche
afettive e relazionali nei ruoli coniugali e genitoriali, ai confitti, i silenzi, le morti-
fcazioni, le inadeguatezze, le illusioni amorose, nel rapporto tra passione e pacato
amore coniugale. Un discorso che viene inserito nel quadro della storia delledu-
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 36 03/05/2013 11:11:09
37
Laura Guidi, Maria Rosaria Pelizzari
cazione, cos come si venuta confgurando a partire dagli anni Sessanta del secolo
scorso, in cui si afermata una maggiore laicizzazione del pensiero pedagogico,
con gli innesti, in primo luogo, di altre discipline umanistico-scientifche, e grazie
ai nuovi scenari della storia sociale. Lutilizzo della categoria di genere, nonch la
disamina di fonti di diversa tipologia, con un attento studio flologico delle fonti
letterarie, ha fatto s che, come rileva Maria Cristina Leuzzi, proprio in quegli
anni fosse dato respiro alla storia delleducazione tanto da rendere possibile il di-
svelamento di questambito privato a vantaggio di un rapporto il pi possibile
bilanciato tra natura e cultura. Attraverso lanalisi delle scritture dellio si deli-
nea, in realt, la trasformazione delle relazioni famigliari: dal modello gerarchico-
autoritario a quello intimo-afettivo. Rispetto ai vissuti sentimentali, come rileva
Francesca Borruso, lobiettivo quello di sottrarre alloscurit dei silenzi sociali
le tracce di vita relative allimpalpabile soglia del privato, le quali possono confer-
mare o meno il modello educativo dominante che in Occidente, fra Sette e Otto-
cento, ha determinato leducazione sentimentale di uomini e donne. In proposito,
si rivela particolarmente interessante la disamina di quegli scritti che testimoniano
lo strappo esistente tra la cultura imposta e i desideri individuali.
Tra realt storica e rappresentazione letteraria si muovono i Ritratti fem-
minili della sezione curata da Annamaria Laserra che si propone di indagare il
ruolo di alcune Signore di Signori che hanno animato la scena storica in diverse
epoche, luoghi e circostanze. Si tratta di protagoniste, che in genere hanno eser-
citato il potere allombra di Grandi uomini. I loro profli sono contraddistinti
dalleterogeneit spazio-temporale delle coordinate delle loro esistenze (svoltesi
tra Europa, Africa e Americhe tra la fne del XV e la prima met del XX secolo),
a cui si aggiunge la variet dello stato sociale, del ruolo da esse svolto nelle loro
rispettive epoche, e, principalmente, delle loro personalit. Il flo che le unisce
uno: per nascita o per acquisizione, esse hanno condiviso la sorte di vivere accanto
a riconosciuti Grandi della Storia e di partecipare alla loro vicenda personale e
politica esprimendo, ciascuna a suo modo, la propria personalit. La problematica
identitaria trova in genere una delle sue pi profonde espressioni se interrogata
a partire dallimmaginario simbolico: perci le studiose e gli studiosi del gruppo
hanno cercato di interrogare queste protagoniste a partire dalla scrittura epistolare
e da scritti a sfondo autobiografco dei loro Signori (epistolario coniugale di Abi-
gail Adams, poema dedicato da Garibaldi ad Anita e da Lopold Senghor a sua
moglie Colette), ma anche dal loro modo di vivere e interpretare la cultura del
tempo (letteratura forita intorno a Germaine de Foix, documentazioni intorno
alle nuove forme teatrali studiate dalla regina Anna). Emergono nel complesso
vivaci ritratti che si muovono tra strategie diplomatiche, passioni e sentimenti
individuali, le cui vicende esistenziali ci introducono alla sezione seguente, quella
curata da Luisa Tasca, incentrata su Individui e sentimenti, che focalizza latten-
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 37 03/05/2013 11:11:10
38
Introduzione
zione sulla centralit dellindividuo emotivo e narratore invece che sullindividuo
razionale, attraverso alcuni case study a cavallo tra Otto-e Novecento.
Sentimenti, relazioni afettive, emozioni, analizzate attraverso tipologie di-
verse di scritture dellio (epistolari, diari, autobiografe, biografe), pongono in
primo piano limportanza dellindividuo, con la sua vita, le sue relazioni famigliari
e sociali, il suo mondo afettivo privato: ne derivano alcune questioni importanti
di tipo metodologico e storiografco in senso ampio, sulle quali si interrogano in
modi diversi gli interventi della sezione. Nel corso di gran parte del Novecento,
come sottolinea Luisa Tasca, la storiografa ha messo al centro del proprio interesse
i gruppi sociali (la borghesia, la classe operaia, laristocrazia), immaginandoli
come unit coerenti nel modo di sentire, pensare e agire, in cui lindividuo si ri-
specchiava in toto. Ponendo, pertanto, lattenzione ai tempi lunghi, non biograf-
ci, gli storici hanno perlopi oltrepassato la vita individuale, ritenendola superfua
e ininfuente rispetto ai fenomeni macroscopici della storia sociale ed economica,
che si giocavano sul lungo periodo. Negli ultimi decenni, invece, la storiografa ha
riscoperto un metodo di studio del passato che valorizza la dimensione individuale
e biografca. Lattenzione degli storici si quindi spostata, grazie agli apporti della
storia orale, della storia delle donne e degli studi sulla cultura popolare, anche sulle
biografe e le testimonianze individuali, mettendo al centro gli individui nellin-
treccio delle loro relazioni pubbliche e private. Di questo interesse testimoniano
i saggi della sezione, che spaziano dalle scritture conservate nellarchivio Cala-
mandrei-Regard, agli scritti di Angelo de Gubernatis (autobiografa, epistolario e
diario), alla corrispondenza tra Adelaide Dore Pintor alla famiglia, fno alle rela-
zioni afettive tra sorelle, indagate attraverso la biografa di Vanessa Bell e Virgina
Woolf, e quella delle sorelle Bront.
Dallindagine sui sentimenti individuali, in particolare allinterno delle rela-
zioni famigliari, lette attingendo a diferenti scritture dellio, oltre che alla rappre-
sentazione letteraria, linteresse si sposta, con le sezioni curate da Annamaria Cec-
coni, Susanne Franco e Monica DallAsta, alle arti della scena con cui si chiude la
parte dedicata, nello specifco, agli immaginari e ai loro linguaggi. Il tema dei sen-
timenti tuttavia non si esaurisce, ritorna infatti nella sezione sul Genere del pub-
blico: gli studi di caso presentati si sofermano, in un arco temporale dal XVIII
al XX secolo, su temi che spaziano dalla funzione di modello di una grammatica
dei sentimenti, che il palcoscenico ha proposto, alla formazione di un pubblico
femminile dellopera lirica, dallintenzionalit delle grandi attrici del XIX secolo
nel costruire le loro spettatrici al rapporto tra teatro delle donne e pubblico nel
neofemminismo. I saggi propongono anche una selezione di varie tipologie di
fonti documentarie, (giornali, recensioni, lettere, atti processuali), guidata dallo
sforzo di suggerire strumenti per una nuova area di ricerca. Lobiettivo dichiarato
, tra gli altri, una prima ricognizione delle questioni di carattere teorico e meto-
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 38 03/05/2013 11:11:10
39
Laura Guidi, Maria Rosaria Pelizzari
dologico. Largomento si presenta degno di rilievo per pi settori disciplinari. La
storia culturale ha, in realt, rivolto il suo interesse alla presenza femminile negli
spazi pubblici e della cultura, mentre le storie del teatro e dellopera hanno ulte-
riormente indagato il doppio legame comunicativo tra palcoscenico e pubblico.
Le studiose femministe del teatro, della danza, dellopera lirica hanno fnora
lavorato, come sottolinea Cecconi, su questo legame prevalentemente dal punto
di vista dellemittente verso la platea. Al contrario, le ricerche di Mariani, Masca-
ri e Plebani, puntano il loro sguardo nella direzione opposta: dalla platea verso
la scena. La sezione si rivela pertanto originale anche se la dif colt maggiore
dellimpresa rappresentata, in fondo, dal rischio di considerare il pubblico fem-
minile unentit omogenea, sia sul piano sociologico, culturale e dei diversi gradi
di competenza teatrale, che su quello soggettivo delle emozioni, e quindi della
risposta individuale a quanto il palcoscenico difonde.
Rimanendo nellambito delle arti della scena, il gruppo di studio, coordinato
da Susanne Franco, rifette, come si accennato, sugli immaginari corporei e le
rappresentazioni di genere tra danza, scrittura e societ, sofermandosi, sia sugli
stereotipi di genere che sulla suddivisione dei ruoli nella danza. I saggi presentati
sono il prodotto di ricerche condotte da studiose di danza attive tra Italia e Francia
e appartenenti a diverse generazioni. Afrontando in particolare gli immaginari
corporei e le rappresentazioni di genere, esse propongono lanalisi di casi appar-
tenenti a epoche e contesti culturali eterogenei, che proprio per questa estensione
temporale e geografca danno la misura della potenzialit di nuovi sguardi per lo
studio della danza. Agli occhi dello storico, dunque, la danza si rivela, come sotto-
linea Franco, un osservatorio particolarmente stimolante per comprendere aspetti
meno noti degli immaginari sociali che con le loro utopie e le loro angosce, come
la paura della disintegrazione dellordine morale, sessuale o sanitario, hanno nutri-
to le nostre idee su come si , si diventa o si percepiti in quanto uomini e donne.
Dal pubblico del teatro alle pioniere del cinema muto: nei saggi del gruppo
coordinato da Monica DallAsta si apprende, non senza una certa sorpresa, la no-
tizia di centinaia di cineaste nella fase artigianale del cinema, tra gli anni Trenta e
Quaranta, in una dimensione transnazionale. Eppure, solo recentemente la storia
del cinema ha iniziato a incrociare i suoi percorsi con la storia delle donne. Si pensi
che, ancora oggi, i pi autorevoli repertori biografci riservano di solito un po di
spazio alle donne, ma solo in quanto attrici, mentre appena una piccola quantit di
nomi femminili spunta quasi casualmente nei volumi dedicati ai registi. In genere,
la storia del cinema ha considerato la creativit e liniziativa femminile quali variabili
senza importanza per il destino artistico, economico e industriale del cinema. Ci
ha prodotto una visione del cinema mutilata, come costruzione tutta maschile, dove
il femminile ha spazio solo nella misura in cui si presta a farsi oggetto di sguardo
sullo schermo. La ricerca sulle pioniere, in linea con la storiografa cinematografca
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 39 03/05/2013 11:11:10
40
Introduzione
post-Brighton, si inoltre allontanata dalla celebrazione dei cosiddetti grandi flm
di maggior valore estetico e commerciale, adottata dalla storiografa tradizionale,
e ha ottenuto un vero superamento della concezione omosociale dei luoghi della
produzione. Non solo le registe, sottolinea DallAsta, ma tutte le donne che abbiano
fatto qualcosa per il cinema, in una parola le cineaste, sono diventate in questi saggi
loggetto di un discorso teso a illuminare il contributo di fgure normalmente trascu-
rate, ma non certo ininfuenti per i processi produttivi. Si noti, inoltre, che, bench
lindagine abbia escluso in prima battuta le attrici, questa visione del cinema come
sfera pubblica abitata da donne, oltre che da uomini, promuove una nuova valoriz-
zazione anche di tali fgure. Infatti, non solo la ricerca ha rivelato che molte donne,
considerate a lungo solo attrici, furono invece anche registe, produttrici, sceneggia-
trici e, in alcuni casi, perfno montatrici dei loro flm, ma ha mostrato anche che la
considerazione del processo produttivo come spazio relazionale e di negoziazione tra
soggettivit diferenti pu fruttare unidea pi complessa dello stesso ruolo attoriale,
interrogando i margini della sua possibile partecipazione nelle scelte di regia.
Limpostazione seriale della ricerca facilita, inoltre, il confronto tra casi indivi-
duali con lobbiettivo di indagare, non solo la vita delle donne studiate in relazio-
ne al loro rapporto con il cinema delle origini, ma piuttosto la stessa condizione
femminile nei diversi contesti territoriali, locali e nazionali di riferimento, cos da
fornire la base per una comparazione sul piano globale. In questo senso, le autrici
presentano i loro saggi come tasselli di un mosaico pi ampio, tuttora in feri,
che intende restituire unimmagine complessa dellesperienza femminile nei primi
decenni del secolo scorso. Lambizione del lavoro del gruppo di ricerca, attivo dal
2007, , dunque, quello di fornire un primo, parziale contributo della storia del
cinema alla storia delle donne nel nostro Paese.
4. Il corpo: discorsi e pratiche
Trascurato sino a tempi recenti, il tema del corpo e delle sue rappresentazioni
diviene oggi un ef cace strumento metodologico per la comprensione di societ
e di culture. Diventa pertanto una singolare fonte per completare e arricchire
le analisi di storia sociale. Non un caso che proprio a tale tema sia dedicata
lultima sezione delle Nuove frontiere, in cui si parte dalla proposta di una lettura
della storia sociale e culturale del rapporto corpo/gender, e si arriva a considerare
la relazione tra cura e salute. Due i percorsi principali: da un lato, la violenza e i
suoi linguaggi, i comportamenti sessuali e il controllo pubblico a loro riservato,
gli orientamenti sessuali e la visione politica a loro legata; dallaltro, la medicina
delle donne e per le donne. Questultima si muove, nel lungo periodo, tra i vari
aspetti che sono alla base della medicina di genere (idee scientifche e pratiche),
per sofermarsi sulla medicalizzazione della maternit, non senza afrontare le pi
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 40 03/05/2013 11:11:10
41
Laura Guidi, Maria Rosaria Pelizzari
attuali questioni di etica, bioetica e diritto. Il corpo viene pertanto visto, come
si gi accennato, quale punto di osservazione per esplorare, in primo luogo, i
signifcati culturali e sociali di determinati periodi storici, individuando in esso e
nella sua percezione uno dei testi pi signifcativi della cultura contemporanea.
In questo quadro, si delinea uno studio interdisciplinare che intreccia, agli studi
storici e flosofci, la storia dellarte e la sociologia, lantropologia, il diritto e
la psicologia, sia per indagare come, negli ultimi tre secoli, il corpo umano, in
primo luogo quello femminile, sia stato percepito, immaginato e rappresentato,
che per inserire la Body history nella storia sociale, politica ed economica delle-
t contemporanea. In diversi saggi riservata unattenzione particolare al corpo
e ai linguaggi che su di esso si inscrivono: con lapproccio multi-disciplinare si
cerca, infatti, di operare un processo di decostruzione di tutti i codici che su di
esso si sono iscritti. Si avvia una sorta di operazione archeologica, alla ricerca dei
vari saperi e delle ideologie che sul corpo si sono stratifcati. La rappresentazione
dei corpi non mai neutra, dal momento che viene ispirata dalla politica, dalla
comunicazione pubblica, dal prodotto artistico e culturale in genere, nonch dai
sentimenti e dai dialoghi privati.
Non a caso, quindi, la parte dedicata al corpo inizia con la sezione coordinata
da Patrizia Dogliani, che nel rapporto corpo/gender propone, esplicitamente, una
nuova lettura della storia sociale e culturale. Da qui linserimento in essa di ricerche
abbastanza diverse tra loro, sia per la variet di aree geografche e di periodi storici
esaminati (principalmente il contemporaneo, ma con incursioni nel moderno) sia
per i diferenti settori disciplinari (storia politica e sociale, storia dellarte e storia
culturale) sia per lampio impiego delle fonti (da quelle letterarie alle visive, quali
pittura e fotografa). Nonostante la diversit, almeno apparente, di impostazioni,
obiettivi e conclusioni, i contributi risultano, tuttavia, uniti dallattenzione alla
lettura di genere nellanalizzare le rappresentazioni dei corpi. Il discorso acquista,
poi, particolare interesse quando nella rappresentazione si individua il simbolico e
nei corpi rappresentati si legge unepoca: ovvero, come specifca Dogliani, quanto
ritrae di se stessa, risultato di mentalit e di classi sociali. In tali rappresentazioni
la femminilit molto spesso sottoposta a poteri sociali e di genere, estetizzata, o
ancora nazionalizzata; mentre la mascolinit diventa perlopi virilit dominante.
Ponendo, dunque, al centro dellanalisi la categoria di genere, i corpi, cultural-
mente costruiti, rivelano, da un lato, il valore conferito alla corporalit, gli stereo-
tipi di mascolinit e di femminilit, dallaltro, le culture che defniscono modelli
di comportamento corporeo, i valori e i caratteri psicofsici attribuiti a un corpo
identifcato con il suo genere e il proprio ruolo sociale. Prendono pertanto forma
sociale il corpo del militare, il corpo dello sportivo, il corpo del colonizzatore.
Nel rapporto tra corpo e gender un ruolo signifcativo assunto dal lessico
della violenza: violenza fsica, culturale, sociale. I linguaggi e le rappresentazioni
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 41 03/05/2013 11:11:10
42
Introduzione
della violenza di genere sono pertanto esaminati in unapposita sezione, coordina-
ta da Maria Rosaria Pelizzari, in cui il tema afrontato, ancora una volta, con un
intreccio di specifci contesti e di diferenti ottiche disciplinari, che dialogano, in
primo luogo, sui linguaggi con cui la violenza si presenta in alcuni contesti storici,
attraverso le strutture famigliari, i ruoli sessuati e i comportamenti criminali. Allo
stesso modo, si analizzano le modalit con cui essa si manifesta in recenti contesti
urbani di migrazione nonch le forme con cui nella letteratura e nelle arti fgurati-
ve stato strutturato il racconto della violenza, violenza del corpo e della parola. Il
quadro generale quindi, costruito basandosi su precise indagini microanalitiche:
lidea di stupro nellet longobarda, la tragica condizione di prostitute e donne
sole nei sobborghi marsigliesi tra Seicento e Settecento, la condizione di miseria
delle operaie parigine di fne Ottocento, soprusi e coercizioni in ambito familiare
e domestico a cavallo tra Otto e Novecento, abusi fsici e psicologici sui minori
nel primo Novecento. Si attinge inoltre a varie questioni teoriche inerenti luso e
il disciplinamento di talune forme di violenza domestica, scrutando tra pratiche
e divieti, in et moderna e contemporanea. I vari contributi, pur muovendosi co-
erentemente allinterno dello specifco di ciascuna disciplina, sono tuttavia uniti,
come nella precedente sezione, da una lettura culturale e sociale del fenomeno
analizzato, che consente in alcuni casi di rintracciare elementi di continuit oltre i
confni temporali e le identit culturali.
Il discorso sul rapporto tra corpo e controllo pubblico si sviluppa in modo
particolare nella sezione curata da Margherita Sabrina Perra che lo legge allinter-
no delle societ contemporanee e nellottica del pensiero femminista, che trova
proprio in questo rapporto uno spazio di confronto. Il punto di partenza una
rifessione sullattuale condizione delle donne in Italia, a pi di trentanni dal fem-
minismo e in relazione agli ultimi interventi legislativi sulla procreazione assistita,
al dibattito sullintroduzione della pillola RU486, nonch alle questioni legate alla
revisione della legge sullinterruzione volontaria di gravidanza. I toni e i contenuti
del dibattito hanno fatto emergere una situazione preoccupante per lItalia, in
cui si assiste a una rinnovata tendenza al controllo dei corpi femminili e, a parti-
re da questo, a una riproposizione dellidentit femminile che sembra annullare
completamente le molte conquiste ottenute negli ultimi trentanni. Si procede da
unanalisi della legge 40/2004 in cui si presentano alcune importanti rifessioni
sia sulle rappresentazioni del corpo che essa ha prodotto, sia sul modo con cui
essa ha cercato di defnire le funzioni riproduttive supportate medicalmente. Il
corpo femminile, fortemente disciplinato, viene rappresentato nella sua funzione
riproduttiva, funzione di cui le donne hanno perso completamente il controllo: la
costruzione giuridica dei sessi, dei generi e della sessualit uno degli strumenti
attraverso il quale si esprime il sodalizio tra diritto e potere, nonch il controllo sul
corpo delle donne. Alle considerazioni sugli aspetti legislativi inerenti il rapporto
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 42 03/05/2013 11:11:10
43
Laura Guidi, Maria Rosaria Pelizzari
tra corpo e controllo pubblico si inseriscono anche le rifessioni derivanti dalla-
nalisi di alcune storie di vita e narrazioni individuali, in particolare quelle legate
al controllo del proprio corpo nel rapporto tra anoressia e bulimia. I racconti di
giovani donne sono anche al centro di contributi che analizzano diferenti scelte di
fecondit, in particolare allinterno di complicati percorsi, stretti tra aspettative so-
ciali sulla maternit e negoziazione con il partner. Lanalisi sul controllo del corpo
femminile non pu non prendere in considerazione il rapporto con lesperienza
del parto: questa emerge dai racconti raccolti ai corsi di preparazione al parto:
in essi si legge, non senza una certa sorpresa, la resistenza alla medicalizzazione
del parto e la volont delle donne come partorienti e come professioniste di
riprendersi il controllo di questo momento della propria vita.
Chiude la sezione lindagine sulle rappresentazioni del corpo femminile in
relazione alla cura, indagata attraverso i racconti delle giovani generazioni (un
campione di aspiranti a professioni legate alla cura), che non hanno vissuto le-
sperienza del femminismo. Si delinea un quadro in cui non mancano ragioni di
preoccupazione. Si riconosce la rinnovata tendenza alla naturalizzazione delle dif-
ferenze costruita sullidea dellessenza biologica degli individui; nonch la fatica
delle donne a esprimere la propria soggettivit, costretta tra norme giuridiche e
sociali. A ci si aggiunge la considerazione che nelle narrazioni dei pi giovani,
sia maschi che femmine, venuta meno la consapevolezza dellidentit di genere
come costruzione sociale
Il corpo sessuato, con particolare riferimento alla sessualit nellItalia unita
(dallUnit al Secondo dopoguerra), al centro della sezione curata da Martina
Salvante: i contributi si sofermano su come i rapporti sessuali fossero direttamen-
te vissuti e percepiti, sulle modalit con cui sono stati raccontati e giudicati, su
come la sessualit sia stata controllata e regolamentata dai singoli, sia uomini che
donne, oltre che dai poteri pubblici. Il rapporto tra genere e sessualit costituisce,
in realt, come sottolinea Salvante, uno degli argomenti rimasti ancora ai margini
o addirittura, in un certo senso, paradossalmente inesplorati. Anche se molte sono
state le indagini su argomenti correlati alla vita sessuale delle donne eterosessua-
li nei secoli (matrimoni, violenze sessuali, contraccezione, prostituzione), ancora
stentano, invece, ad afermarsi in Italia studi che facciano emergere lesbiche e
gay come soggetti storici mettendo in luce desideri, pratiche e identit sessuali
di singoli e singole. Solo in anni molto recenti si possono annoverare rilevanti
eccezioni grazie a giovani storiche e storici che, anche attraverso limpegno econo-
mico e militante dellattivismo LGBT, hanno contribuito a elaborare e divulgare
rifessioni storiografche e non solo su esperienze individuali e collettive di
sessualit altre, oltre a ricostruire le vicende del movimento stesso. Negli inter-
venti pubblicati in questa sessione, si afronta, dunque, in vario modo, il tema
dellomosessualit. Le fonti utilizzate come, in realt, si registra un po in tutte
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 43 03/05/2013 11:11:10
44
Introduzione
le sezioni delle Nuove frontiere sono di vario tipo, cos come la metodologia uti-
lizzata. I tre contributi di questa sezione fanno riferimento perlopi al tema della
prostituzione e/o del corpo come oggetto di scambio, e nel complesso esortano
tutti a discutere pi estesamente i temi della sessualit nel pi ampio contesto della
storia nazionale ma anche transnazionale dando, cos, un signifcativo apporto
alla storia sociale e culturale tout court. Essi spronano pure a interrogarci in modo
pi profondo su concetti-chiave (identit, desiderio, ruolo, amore, ecc.) facendo
altres attenzione alluso e al metodo con cui certe categorie analitiche fra cui
genere, classe, etnia sono impiegate nellindagine storiografca. Pi che risposte
immediate, vengono forniti spunti utili alle ricerche e alle discussioni future. Tra
questi, la distinzione tra pratiche, comportamenti e identit sessuali. In questo
ambito si inserisce, ad esempio, lattenzione rivolta al sesso che coinvolge o pra-
ticato da minori; come pure della prostituzione, esercitata da uomini o da donne.
Quali pratiche socio-sessuali, al di l dei comportamenti proibiti dalla legge, sor-
sero proprio in conseguenza di certe sanzioni? Quale il ruolo ricoperto dal denaro
nella legittimazione di certi comportamenti? Quali rappresentazioni identitarie
accompagnarono tali prassi? Come mutarono queste nel tempo? Quale davvero il
legame tra identit sessuale e scelta delloggetto del desiderio?
Continuando il percorso indicato da simili ricerche, insistendo e ampliando
questi interrogativi storiografci, la storia delle sessualit, in dialogo con la storia
di genere, potrebbe in modo profcuo ampliare gli orizzonti delle nostre conoscen-
ze. Un percorso, in realt, gi tracciato dal compianto Bruno P.F. Wanrooij che,
con la sua Storia del pudore, gi dal 1990 ha aperto nuovi orizzonti storiografci,
esortando il mondo accademico italiano a interessarsi alla storia gay e lesbica e allo
studio delle mascolinit.
Linteresse per la storia della sessualit prosegue anche nella sezione curata da
Maria Cristina Gramolini, che si addentra in modo specifco in un aspetto par-
ticolare, che, per la sua originalit, calza perfettamente con il tema delle Nuove
frontiere della storia di genere: il movimento delle lesbiche in Italia. I contributi
trattano di alcune esperienze collettive di donne che hanno fatto della loro omo-
sessualit un motivo di associazione, di rifessione culturale e di azione politica.
Lomosessualit femminile, come noto, stata a lungo negata o vagliata come
disturbo mentale, almeno sino alla rottura degli equilibri socio-sessuali verifcatasi
tra la fne degli anni Sessanta e linizio dei Settanta, in concomitanza (anche se
non come conseguenza diretta) del femminismo e del movimento gay. In questi
contesti emersa la soggettivit lesbica: il femminismo lha resa possibile con li-
stanza della liberazione delle donne, il movimento gay con la legittimazione del
desiderio tra persone dello stesso sesso. Anche se entrambi non hanno mai fornito
un appoggio esplicito. Il primo non ha, infatti, autorizzato pienamente lesplici-
tazione del lesbismo, nel timore che la dimensione del desiderio tra donne creasse
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 44 03/05/2013 11:11:10
45
Laura Guidi, Maria Rosaria Pelizzari
ostacoli al progetto di un movimento unitario di tutte le donne. Il secondo, a sua
volta, ha promosso una rappresentazione del lesbismo come immagine speculare
dellomosessualit maschile, una assimilazione che discende, come sottolinea Gra-
molini, da uno scarso interesse per la realt concreta delle donne, bench queste
siano spesso evocate dai gay come ispiratrici. Tuttavia, le donne omosessuali degli
anni Settanta hanno trovato gli elementi utili allemersione del proprio vissuto at-
tingendo sia al repertorio femminista e alla pratica dellautocoscienza sia al coming
out maschile. Questo processo tormentato e confittuale tuttora in atto.
Come nella sezione precedente, riguardanti i comportamenti sessuali, anche
in questa sui movimenti delle lesbiche in Italia, le curatrici auspicano che le ri-
cerche accolte possano soprattutto spingere a nuovi approfondimenti, aprire a
nuovi possibili focus. Negli ambienti delle intellettuali lesbiche forte il rifuto
dellimmagine di s come danneggiate, immagine a cui invece ricorrono pi di
frequente quanti si mobilitano per una politica dei diritti. Ancora oggi conclude
Gramolini non sempre facile rispecchiarsi nella fatica di vivere da lesbiche e nei
suoi insuccessi o compromessi, ma questi sembrano pi lievi se riguardati alla luce
della raggiunta capacit di autoemancipazione delle lesbiche.
Il discorso sul corpo non si esaurisce, ovviamente, con linteresse sugli orien-
tamenti e i comportamenti sessuali. Una parte importante, che in tempi recenti
ha visto sempre di pi le storiche lavorare, fanco a fanco, con sociologhe, antro-
pologhe, studiose/i di diritto, nonch professioniste e professionisti della salute,
quella inerente la relazione salute/cura, che si intreccia sempre pi spesso con
le correnti questioni di etica, bioetica, diritto, legate allinizio e alla fne della vita
umana. Non un caso che negli ultimi tempi si parli con una certa frequenza della
medicina di genere che applica alla medicina generale il concetto di diversit tra
generi per garantire a tutti, uomini o donne, il migliore trattamento auspicabile
in funzione delle specifcit di genere. E nellambito della giurisprudenza, si fa
anche strada lidea di una lettura del diritto nellottica di genere, in cui viene indi-
viduata lesistenza di un rapporto stretto tra limmaginario comune sul ruolo della
donna e la disciplina del suo corpo, dei suoi diritti, della sua libert. Nel quadro
che si delineato, abbiamo pertanto inteso completare la parte dedicata al corpo
con saggi che hanno, in linea generale, afrontato la relazione corpo/salute/cura,
muovendosi tra circolazione delle idee, giurisprudenza e pratiche. Si tratta delle
ultime quattro sezioni, che chiudono anche tutto il nostro discorso sulle Nuove
frontiere, ovvero, quelle curate da: Claudia Pancino (medicina delle donne e per
le donne); Gabriella Botti e Giovanna Vicarelli (idee scientifche e pratiche); Ma-
ria Conforti (medicalizzazione della maternit); Emilia DAntuono (questioni di
etica, bioetica e diritto).
La sezione di Pancino apre, come si accennato, la rifessione su corpo/salute/
cura, indagando, in un arco di tempo che va dallet moderna allOttocento, la
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 45 03/05/2013 11:11:10
46
Introduzione
relazione tra medicina e donne, sia nelle diverse forme di elaborazione del pensiero
medico-flosofco sia nelle pratiche di cura del corpo femminile. Lattenzione rivol-
ta, in primo luogo, allesercizio dei mestieri terapeutici, delle professioni sanitarie, sia
nella loro specializzazione e organizzazione che nellespressione delle terapie e delle
cure quotidiane e famigliari. Emerge con chiarezza che raramente si verifcata una
sintonia dialettica fra quanto i medici pensavano, e scrivevano, e i diversi modi di
curare le donne. Si pensi, in modo particolare, al rapporto tra medico e ostetrica,
soprattutto nel momento in cui, a cavallo tra Otto e Novecento, il parto veniva me-
dicalizzato. Lessere donna della levatrice, fno alle recentissime riforme del percorso
formativo universitario ha continuato, come sottolinea Pancino, a rappresentare un
segno di continuit unico nella storia delle professioni. Lappartenenza di genere,
infatti, si prefgurata per i secoli XVIII, XIX e XX, quale memoria storica di forme
di conoscenza e cura che la storia della medicina occidentale e delle professioni sani-
tarie avevano in buona parte cancellato. Proprio sulla professione di ostetrica, ofre
unimportante rifessione il caso di studio, indagato dalla compianta Maria Luia
Mott, che ricostruisce e descrive il percorso migratorio e professionale di ostetriche
italiane in Brasile fra 1870 e 1920. Il caso, secondo Pancino, appare esemplifcativo
della storia della formazione e dellautonomia raggiunta da una fgura professionale
femminile, estremamente moderna, con radici molto antiche.
La cura al femminile anche oggetto della sezione curata da Gabriella Botti
e Giovanna Vicarelli, che la inquadrano, nel periodo compreso tra XIX e XX seco-
lo, inserendola tra pubblico e privato, sia nelle idee scientifche che nelle pratiche.
Solo nel corso dellOttocento si istituzionalizza progressivamente la separazione tra
il prendersi cura e la cura come terapia e guarigione. Botti e Vicarelli dichiarano
di aver voluto esaminare proprio questo passaggio, ripercorrendone brevemente le
tappe. Vicarelli si sofermata, in modo particolare, sulle professioni nel corso del
Novecento, soprattutto sulla femminilizzazione della professione medica, che ha
favorito la possibilit di sviluppare studi mirati sulla salute della donna. In realt,
durante tutto lOttocento persiste lintreccio tra cura e cure, testimoniato in modo
esemplare dal lavoro di cura svolto da varie congregazioni di religiose. Pertanto, se
nellOttocento si istituzionalizza, come si accennato, la separazione tra il pren-
dersi cura e la cura come terapia e guarigione, ci non signifca lo sottolineano
le curatrici della sezione che efettivamente, nel primo Novecento, la medicina
uf ciale fosse in grado di intervenire in modo risolutivo sulle malattie della popo-
lazione. Ci si verifcher soltanto negli anni Trenta e Quaranta con la rivoluzione
scientifca, legata alla scoperta e alla difusione degli antibiotici, quando il medico
da curante sarebbe diventato in efetti un terapeuta. Non a caso, tutti i tentativi di
professionalizzazione della medicina, che si svilupparono nel secondo Ottocento
e che culminarono nel 1910 con listituzione degli ordini professionali, poggiano
su una concezione dellintervento sanitario pi a carattere preventivo e sociale
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 46 03/05/2013 11:11:10
47
Laura Guidi, Maria Rosaria Pelizzari
(ligiene e la sanit pubblica) che curativo e individuale. Questultima modalit
prevarr nel Secondo dopoguerra quando la medicina specialistica e diagnostica
prender il sopravvento rendendo efettivamente pi ampio il solco tra la cura e
le cure sanitarie.
Prosegue il tema della medicina femminile, con la sezione curata da Maria Con-
forti, che si soferma, in modo particolare, sulla medicalizzazione della maternit,
frutto del lavoro di ricerca di un gruppo, costituitosi allinterno della SIS su Donne
salute e cura. Lo scopo dichiarato quello di leggere la medicalizzazione della ma-
ternit in una prospettiva storica di lunga durata, per comprendere, in primo luogo,
come emerge e come viene concettualizzata, nella storia della medicina ma anche in
quella pi ampia della cultura, la nozione del carattere patologico di alcuni fenome-
ni legati a episodi-chiave della vita corporea delle donne, e in particolare della ma-
ternit. Altro interrogativo a cui gli studi di caso hanno inteso rispondere, riguarda il
modo con cui si confgura e si modifca, nella storia della medicina occidentale, una
specifca medicina delle donne, nella quale diventa centrale la categorizzazione del
patologico. Lintenzione di partenza era quella di individuare e analizzare, attraverso
la lettura di storie, di casi clinici, nonch la narrazione e la scrittura di argomento
medico, alcuni snodi signifcativi, nei quali un fenomeno o caso medico viene in-
terpretato come fatto che rientra nella norma, come fatto preternaturale oppure
come fatto che ne esula in quanto contro natura o patologico.
Rilevare e ricostruire lo sguardo dei medici e della medicina teorica e pratica
riguardo a malattie femminili, gravidanza e parto non esaurisce, come sottolinea
Conforti, la questione della medicalizzazione e della patologizzazione del corpo
femminile, ma pu costituire un utile punto di partenza per indagarne ulterior-
mente alcuni snodi e momenti. I contributi della sezione presentano, pur nella
loro diversit, alcuni temi comuni, che motivano ladozione del lungo periodo.
In modo particolare, il rapporto complesso tra il sapere femminile sulla gravidanza
e sul parto, e la sua assunzione allinterno della medicina colta. Un argomento che
ritorna, come si visto, anche in altre sezioni.
Il discorso sul corpo termina con una rifessione su alcuni temi che collegano
la questione della cittadinanza a quella della bioetica. Questultima sembra essere
divenuta lambito di sperimentazione di come sia possibile tradurre, nel vivere
comune, le istanze di libert individuali e collettive fatte valere dalle donne, una
specie di banco di prova per delineare una rinnovata confgurazione della cittadi-
nanza. Sono questi i presupposti dai quali prende le mosse la sezione, curata da
Emila DAntuono, che propone, infatti, una serie di contributi che sviluppano il
loro discorso tra etica, bioetica e diritto. Attualmente, in seguito alla rivoluzione
scientifca e tecnologica, alla trasformazione delle condizioni di vita e dellethos
della civilt occidentale, una serie di eventi, abitualmente collocati nella sfera del
cosiddetto naturale, e quindi accolti in una dimensione privata, sono diventati
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 47 03/05/2013 11:11:10
48
Introduzione
oggetto di scelta e di intervento umano. Perci, come avverte DAntuono, essi
sono attirati nella sfera del valutabile e dellanalizzabile, ovvero nellambito del
giudizio morale, ma anche della decisione politica. Questioni che un tempo ap-
partenevano alla sfera privata e allambito delle decisioni morali, come nascita,
morte, salute, diventano pertanto pubbliche, e chiamano in causa la cittadinanza.
Lottica di genere, che sta tentando di farsi strada nel diritto, pu fornire alla giu-
risprudenza utili rifessioni su tutto ci che attiene al corpo e alla sfera privata, al
fne di restituire senso profondo al principio di autodeterminazione individuale
della donna e, al di l del genere, dellindividuo tout court.
Con nostro grande dispiacere, dobbiamo comunicare che, durante la lavora-
zione degli Atti, scomparsa la storica Maria Lucia Mott (1948-2011), Dottore
di ricerca in Storia, studiosa di Storia della Sanit presso la Facolt di ostetricia e
infermieristica, Ricercatrice presso lInstituto Butantan (Laboratorio de Historia
da Cincia) a San Paolo del Brasile. Lucia Mott ha pubblicato numerosi saggi su
riviste scientifche negli USA, in Francia e in Portogallo. Il suo libro, Comadres e
matronas: contributo para a Histria das Parteiras em Portugal (sculos XIII-XIX),
stato pubblicato a maggio 2011, purtroppo dopo la sua morte. scomparsa pre-
cocemente, lasciando vari e importanti progetti da concludere. Da anni stava lavo-
rando a una storia degli ospedali di San Paolo. Per ulteriori notizie bio-biografche
si veda il Boletim Informativo ABENFO/SP, rgo de Divulgao da Associao
Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras Seo So Paulo, Anno 16, n.
45, Febbraio 2012, consultabile nel sito:
http://www.abenfosp.com.br/boletim/boletim_abenfosp_02-12.pdf
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 48 03/05/2013 11:11:10
Le nuove frontiere della Storia di genere
dallAntichit allEt contemporanea
8
Pauline Schmitt Pantel e Franoise Thbaud
La Storia di genere nata ovunque da una rifessione interna alla storiografa
delle donne in uno specifco Paese nonch da spinte esterne. La storiografa
americana ha avuto un ruolo da pioniere, grazie in particolare alla traduzione,
quasi immediata, del famoso articolo di Joan Scott del 1986
9
e ai dibattiti che
esso ha suscitato. La Storia delle donne/Histoire des femmes, pubblicata in Italia
e Francia tra il 1990 e il 1992, che tentava di dare una sintesi dei lavori sui
venti anni precedenti, proponeva una storia delle donne e delle relazioni tra
i sessi. Essa non rivendicava una storia di genere ma questa dimensione era
gi presente, in particolare nei volumi relativi allAntichit, al Medioevo e al
XX secolo. Il termine, in efetti, diventato frequente in francese non pi di
una decina danni fa: la sezione francese della Federazione internazionale per
la ricerca sulla storia delle donne, nata nel 2000, si chiama Association pour le
dveloppement de lhistoire des femmes et du genre Mnmosyne; il primo col-
loquio di storici che sbandier il genere nel suo titolo fu quello di Rennes
8 Traduzione dal francese di Michle Benaiteau.
9 Scott, J. Gender: a Useful Category of Historical Analysis, in American Historical Review, 91, n.
5, 1986, pp. 1053-75; tr.it. Il genere: unutile categoria di analisi storica, in Rivista di Storia Con-
temporanea, n. 4, 1987, pp. 560-686; ora in Di Cori. P. (a cura di) Altre storie. La critica femminista
alla storia, Bologna, Clueb, 1996, pp. 307-347. Il genere defnito come: un elemento costitutivo
delle relazioni sociali fondate su una cosciente diferenza tra i sessi, e il genere un fattore primario
del manifestarsi dei rapporti di potere.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 49 03/05/2013 11:11:10
50
Le nuove frontiere della Storia di genere dallAntichit allEt contemporanea
del 2002
10
, e per lAntichit, la tavola rotonda Genre et Antiquit del marzo
2005
11
.
Che cosa cambia questo termine nella scrittura della storia delle donne e della
storia in generale? A quale punto siamo oggi? Senza mirare allesaustivit, tentere-
mo di presentare lo stato degli studi e di aprire il dibattito. Ci sembra interessante
riprendere i tre punti del manifesto della nuova storia del 1974.
1. Nuovi approcci. Alcune osservazioni preliminari sulla Storia di
genere
Le/i pi anziane/i tra noi ricorderanno il duplice dibattito degli anni Novanta: ri-
masto moderato in Francia e in altri Paesi europei, assunse forme polemiche negli
USA. Da una parte, ci si chiedeva se fosse necessario sostituire la storia delle donne
con la storia di genere allorch alcune/i denunciavano lastrattezza del concetto e
una sua tendenza eufemistica che poteva portare a occultare il dominio maschile.
Dallaltra, quale era la vera Storia di genere? Una storia sociale delle relazioni
tra i sessi, oppure una storia culturale, che cercasse di capire come si costruisce
il sapere culturale sulle diferenze tra i sessi e quali sono i suoi efetti di potere?
Questo ultimo dibattito era uno dei vari momenti della questione riguardante la
svolta linguistica, se farla o non.
Oggi queste polemiche si sono sopite mentre avanza la difusione delle pro-
blematiche del genere, e si riconosce lesistenza di vie diverse e complementari
nel loro approccio. Lo dimostra la pubblicazione nei primi anni del nuovo secolo
di volumi storiografci in cui dialogano le generazioni e si sottolinea la comple-
mentarit delle impostazioni tra gli aspetti sociali e le rappresentazioni discorsive
(interesse per la storicizzazione del discorso, strutturazione delle realt materiali
attraverso il discorso e le rappresentazioni, obiettivi reali dei confitti di rappre-
sentazioni). Possiamo citare tra gli altri, Gender and the Historian di Johanna Al-
berti, Writing Gender History di Laura Lee Downs (la quale si era opposto a Joan
Scott nel 1993), Les Antiquistes et le genre di Violaine Sebillotte Cuchet, il numero
dellanno 2004 del Journal of Womens History che riguarda la storia delle donne nel
nuovo secolo
12
. Questo numero mette quattro giovani ricercatrici che non sento-
10 Publicato come Capdevila, L.; Cassagnes, S.; Cocaud, M.; Godineau D. et al. (a cura di) Le genre face
aux mutations. Masculin et fminin, du Moyen Age nos jours, Presses Universitaires de Rennes, 2003.
11 Publicata con il titolo Problmes du Genre en Grce ancienne, sous la direction de Violaine Sebillotte
Cuchet et Nathalie Ernoult, Publications de la Sorbonne, Paris 2007.
12 Alberti, J. Gender and the Historian, Longman, Pearson Education, 2002; Downs, L.L. Writing
Gender History, Hodder Arnold, 2004; Womens History in the New Millenium, Journal of Wo-
mens History, vol. 16, n. 4. Sebillotte Cuchet, V. Les Antiquistes et le Genre in Sebillotte Cuchet,
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 50 03/05/2013 11:11:10
51
Pauline Schmitt Pantel, Franoise Tbaud
no il bisogno di un unico paradigma di fronte a Gerda Lerner, pioniera della storia
delle donne negli USA. Questa ultima rimpiange lo spostamento delle tematiche
sociali e politiche a favore delle questioni inerenti le rappresentazioni, la cultura e
lidentit (una storia pi women-focused che women-centered), tuttavia sottolinea
linventivit metodologica e concettuale di oggi.
Pertanto oggi, la storia delle donne possiede ancora una sua legittimit, anche
perch permette di riempire i vuoti della mappa nel passato delle donne del
mondo intero (formula di Gerda Lerner). Essa riceve arricchimento dalle doman-
de sul genere e interroga la complessit delle relazioni tra dominio maschile e
capacit dazione delle donne, il concetto dagency delle ricerche americane. Essa
lavora sui margini di libert, le forme di micro-resistenza, i momenti di consenso.
Non nasconde pi le fgure e le posture considerate negative, come la violenza
esercitata da donne
13
, il loro impegno nazionalistico, la loro partecipazione alle
guerre civili. Essa interroga la nozione di mutamento perch contempla, nella loro
dinamica e delle loro contraddizioni, i modi in cui uomini e donne attribuiscono
signifcato alle nuove esperienze e ricostruiscono oggettivamente e soggettivamen-
te le trasformazioni, osservando tra altro i lenti processi di trasformazione e le
deboli intensit del reale (Arlette Farge), momenti di forte rottura
14
.
Daltro canto, la storia del genere si declina oggi al plurale. Possiamo contare
da sei a sette utilizzi diversi del genere (non escludendosi luno con laltro), che
operano degli spostamenti euristici nella storiografa sulle donne e nella storiogra-
fa generale
15
. Il primo uso consiste nel passare dalle donne al genere, uso questo che
suscita meno reticenze, perch il genere apre la porta a una storiografa delle rela-
zioni reali e simboliche tra uomini e donne, una storia che situa pi nettamente
le donne del passato nei loro quadri storici e analizza in un determinato contesto
la costruzione dei ruoli (maschile/femminile) e delle identit sessuate. Questa sto-
riografa interroga levoluzione dei sistemi del genere (gender system, insieme dei
ruoli sociali sessuati e sistemi di rappresentazioni defnendo il maschile e il femmi-
nile) oppure, seguendo Arlette Farge, indaga linfnita gamma delle varianti negli
incontri tra uomini e donne, incontri non sempre segnati dalla dominazione
16
.
V.; Ernoult, N. (sous la direction de), Problmes du genre en Grce ancienne, Paris, Publications de la
Sorbonne, 2007.
13 Dauphin, C.; Farge, A., De la violence et des femmes, Paris, Albin Michel, 1997.
14 Per la storia medievale, cf. il bilancio fatto in occasione della giornata del LAMOP il primo aprile
2008 e pubblicato in Genre et histoire, n. 3, autunno 2008. Per la storia antica, Bruit Zaidman, L.; Sch-
mitt Pantel, P. Lhistoriographie du genre: tat des lieux, in Sebillotte Cuchet, V.; Ernoult, N. (sous la
direction de), Problmes du genre en Grce ancienne, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007 p. 27-48.
15 Tbaud, F. Ecrire lhistoire des femmes et du genre, Lyon, ENS Editions, 2007.
16 Si veda Dauphin, C.; Farge, A. (dir.), Sduction et socits. Approches historiques, Paris, Seuil, 2001.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 51 03/05/2013 11:11:10
52
Le nuove frontiere della Storia di genere dallAntichit allEt contemporanea
Il secondo uso, che opera uno spostamento dal neutrale al genere (o dalluniverso
maschile al genere), mette in questione la storia generale e ogni forma di scrittura di
storia. Propone una rilettura sessuata degli eventi e dei fenomeni storici, una storia
mista, duale, che contribuisce alla spiegazione dei problemi classici della storia so-
ciale, politica e culturale. Pi in generale, e bisogna parlare di un terzo uso, molto
controverso in Francia, sinterroga sul genere di per esempio la protezione sociale,
la cittadinanza, la nazione, limmigrazione o la naturalizzazione
17
ovvero ci che
permette di analizzare la vera portata dei signifcati della divisione tra maschile e
femminile e di comprendere meglio la costruzione dei rapporti sociali gerarchici. Al
seguito di Joan Scott, che ha scritto molto a proposito di questimpostazione ispirata
dal postmodernismo e dalla storia culturale, si tratta meno di mettere laccento sugli
elementi (uomini e donne) che sul principio di partizione e dei suoi signifcati. Tale ap-
proccio concerne maggiormente le storiche dellepoca moderna (early modern history
in inglese), che cercano di correlare ideologie e realt nella societ di rappresentazio-
ne dellAntico Regime, e di inseguire la coerenza interna delle costruzioni parallele
e incrociate delle gerarchie sociali e sessuate
18
.
Un altro uso ancora consiste nel confrontare il genere ad altre categorie danalisi
e dinterpretazione, pi classiche per lo storico (quali la libert e la schiavit nel
mondo antico, le citt e le campagne nella storia medievale, la classe sociale nella sto-
ria contemporanea o la nozione dordine dellAntico regime), per valutarne la perti-
nenza in una congiuntura specifca e misurare leterogeneit del gruppo delle donne
o di quello degli uomini (si sposta laccento dal gruppo ai suoi membri). Oggi pi
che ieri, la storia di genere sinteressa alle diferenze nella diferenza, ma guarda an-
che alle somiglianze capaci di riunire, in certe circostanze, individui dambo i sessi.
Passare dal neutrale al maschile, poi dai generi al plurale, ecco una quinta mo-
dalit che ha aperto il vasto cantiere di una storia delle mascolinit, che osserva la
costruzione delle virilit ed esamina le posizioni dominanti e le soferenze degli
uomini
19
. Questa storia delle mascolinit stata in parte preparata, almeno nel
campo della storia antica e medievale, da una storia rinnovata dellomosessualit
20
.
Tutto ci oggi confuisce nel progetto, complesso ma stimolante, di una storia
delle identit sociali sessuate.
17 Su questi temi sono stati pubblicati libri e tesi recenti nella storiografa contemporanea francese.
18 Vedere in particolare i lavori di Sylvie Steinberg, tra i quali, La confusion des sexes. Le travestissement
de la Renaissance la Rvolution, Paris, Fayard, 2001.
19 Citiamo per la Francia i lavori di Odile Roynette, Rgis Rvenin, Anne-Marie Sohn per i Con-
vegno internazionale di giugno 2009 organizzato a Lione da A.M.Sohn sulle mascolinit.
20 Due opere da pionieri: Dover, K.J. Greek Homosexuality, New York, Vintage Books, 1978 e Boswell,
J. Christianity, Social Tolerance and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the beginning of
the Christian Era to the Fourteenth Century, Chicago, Te University of Chicago Press, 1980.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 52 03/05/2013 11:11:10
53
Pauline Schmitt Pantel, Franoise Tbaud
Lultima modalit, ancora poco seguita in Francia, tesse il flo del genere in
quanto costruzione culturale e sociale, la quale implica possibili distorsioni tra i dati
dellanatomia, del genere e della sessualit. Il sesso ha anche la sua storia e le societ
non sempre hanno posto la classifcazione degli individui tra i due sessi sul primo
piano della loro costruzione, essendo tale divisione diventata prevalente soprattut-
to a partire dal secolo XVIII. possibile allora scrivere con laiuto della nuova sto-
ria delle scienze una storia della distinzione tra sesso e genere, iniziata da Tomas
Laqueure e continuata da altri, considerando che il genere non ricopre la stessa
realt sotto lAntico Regime o nel XX secolo, per esempio
21
. A partire dal XVIII
secolo, la pregnanza nella cultura occidentale di una norma di corrispondenza tra
sesso e genere (e dellidea che il sesso biologico la spiega), per molto tempo ha
fatto s che fossero dimenticate le questioni del travestimento, delle omosessuali-
t, dellandroginia, delle pratiche transgenere. Tutte queste questioni didentit
sono poste oggi dalla corrente queer, la quale insiste sulla fuidit del genere, a par-
tire dallo studio precursore di Judith Butler, tradotto in francese solo nel 2005
22
.
2. Lemergere di una storia globale
Unaltra novit consiste nel leggere la storia delle donne e del genere nei termini della
storia globale, concetto che non assume lo stesso signifcato per la storia dellantichi-
t o per quella contemporanea. Per la storia dellantichit, si tratta ormai di rifettere
sulle logiche di genere
23
. Pi precisamente, si tratta di vedere come funzionano le
identit di genere quando si fanno variare tre criteri danalisi: la diversit geografca
e cronologica, la diversit dei tipi di fonti esaminate, la diversit dei tipi dattivit
considerate (economia, religione, istituzioni politiche, sessualit). preferita una
prospettiva dinamica interna che fa interagire tutti questi livelli, piuttosto che una
prospettiva evoluzionista che vedrebbe succedere nel mondo antico la liberazione
della donna romana alla subordinazione di quella greca.
Nella storia moderna o contemporanea, la storia globale un indirizzo
prevalentemente coltivato nel mondo accademico anglofono, sviluppatosi nel
seno delle prospettive postcoloniali e dellattuale mondializzazione economica e
culturale
24
. Bonnie Smith ne la principale promotrice, dopo avere iniziato in
21 Laqueur, T. La Fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident, Paris, Gallimard, 1992.
22 Butler, J. Trouble dans le genre. Pour un fminisme de la subversion, prefazione di Eric Fassin, Paris,
Editions La Dcouverte, 2005 (edizione originale, Routledge, 1990).
23 Programma: Logiche del genere proposto da Violaine Sebillotte Cuchet nel quadro del gruppo
di ricerca Histoire et anthropologie des Mondes anciens (Storia ed antropologia dei Mondi antichi) del
2010-2013.
24 Dimensione molto presente nel corso delle ultime Berkshire Conferences e nellultimo convegno
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 53 03/05/2013 11:11:10
54
Le nuove frontiere della Storia di genere dallAntichit allEt contemporanea
quanto storica della Francia poi dellEuropa
25
. Oltre la volont di non esaminare
il passato da un punto di vista unico, limpostazione della globalit assume pi
aspetti: presta attenzione a tutte le regioni del mondo al fne di dare la pi
ampia dimensione possibile alla nozione di diferenza culturale; moltiplica e
incrocia le comparazioni tra le esperienze delle donne dei diversi continenti,
regioni e nazioni; sinteressa ai fenomeni che operano al di l delle frontiere
nazionali o regionali come le migrazioni, gli scambi culturali o le internazionali
femministe; in fne, e forse maggiormente, osserva con attenzione le interazioni
e le forme di ibridazioni delle politiche e delle culture. In questo modo, la storia
detta globale un invito a pensare diversamente le diferenze, le gerarchie, le
circolazioni e le ibridazioni.
3. Nuovi oggetti di studio. Diverse declinazioni della storiograa
recente
Diverse curvature originano in parte dalla diversit degli ambienti storiografci
propri di ogni paese. Possiamo indicarne tre. Primo, con un movimento gi ini-
ziato negli anni Novanta, lasse principale della ricerca si spostato dallindagine
della sfera privata (oggetto nuovo di storia negli anni Settanta e Ottanta) allanalisi
di come le donne siano emerse nella sfera pubblica (con lesercizio di diritti politici
e limpegno nelle associazioni), di come abbiano avuto accesso alla cittadinanza,
degli usi sessuati dello spazio pubblico, del genere delle politiche o della simbolica
nazionale
26
. In questo quadro, il discorso dicotomico sfere private/pubbliche ha
lasciato posto ad analisi in cui si evidenzia quanto variamente e dialetticamente
le due sfere siano intersecanti. Questo tema particolarmente presente nella sto-
riografa del mondo antico dove stato al centro di convegni e di recenti pubbli-
cazioni sugli spazi al femminile e al maschile che mostrano che la separazione tra
spazio privato e spazio pubblico, pensata come calco della diferenza tra i sessi,
solo una costruzione storiografca del secolo XIX
27
. Studiare con precisione i
luoghi reali o immaginari, dove il maschile e il femminile sono separati, contigui,
della Fdration internationale pour la recherche en histoire des femmes, intitulato Womens History
Revisited:Historiographical Refections on Women and Gender in a Global Context (Sydney,
2005). Si ritrova anche centrale nel progetto di museo internazionale delle donne in costruzione a
San Francisco (IMOW).
25 Smith, B.G. (dir.), Global Feminisms since 1945, London and New York, Routledge, 2000, Womens
History in a Global Perspective, University of Illinois Press (voll. 1, 2, 3), 2004-2005, Oxford Encyclo-
paedia of Women in World History, Oxford University Press, 2008.
26 Studi troppo numerosi per proporre qui una scelta di citazioni.
27 Harich-Schwarzbauer, H; Spth, T. (ed.) Rume und Geschlechter in der Antike, Iphis, 3, 2005.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 54 03/05/2013 11:11:10
55
Pauline Schmitt Pantel, Franoise Tbaud
confrontati o a volte confusi, un buon modo di precisare la costruzione spesso
mobile del genere
28
.
Nella storia medievale, lo studio delle reti delle relazioni tra donne permette una
domanda dello stesso tipo: fno a quale punto riesce possibile distinguere tra com-
portamenti maschili e femminili? Il posto delle donne medievali nella sfera pubblica
al centro di convegni riguardanti donne di potere e potere delle donne, o donne
di potere e potere politico. Le pratiche del potere femminile sono diverse da quelle
del potere maschile? Cos larte del regnare? Laccesso al potere rende i contrasti del
genere pi rigidi? Parallelamente, nella storia contemporanea, si ritornato a valoriz-
zare il tempo breve dellevento e della posizione dellattore individuale.
Una seconda tendenza propria della storia contemporanea
29
: in modo pi
accentuato rispetto agli anni Novanta, la storia delle donne e del genere contri-
buisce allo sviluppo della storia culturale, che utilizza insieme approcci antro-
pologici e politici. Osserva sia i rapporti sociali del sesso nel campo culturale
sia le pratiche culturali dal punto di vista del genere: cosa signifca leggere al
femminile? La scrittura epistolare un genere femminile? Per quale ragione e
come le donne hanno fatto della scrittura domestica una forma delle scritture
ordinarie il loro campo privilegiato
30
? In generale, la ricerca sviluppa lanalisi
sessuata della produzione, della ricezione e degli usi dei prodotti culturali, in-
contrando cos gli interessi pi antichi di ricercatori e ricercatrici del mondo
anglosassone sui consumi, la moda, i divertimenti o la bellezza. Lo scopo pro-
muovere un approccio congiunto della cultura dellelite, della cultura di massa
e della cultura materiale.
Come terzo aspetto, si nota la nuova o ritrovata attrativa del genere
biografco, diventato un campo di sperimentazione per lo storico. Il genere della
biografa si , in efetti, rinnovato nel campo della storia antica o medievale, dedi-
cando nel ritratto proposto unattenzione uguale alla storia demografca, politica,
sociale e culturale
31
. Nel campo della storia contemporanea vediamo af ancati
percorsi di militanza, biografe intellettuali e racconti di sequenze biografche di
una vita singola. Dappertutto si elabora una rifessione sulla scrittura biografca e
luso storico degli archivi del s (corrispondenze, diari, autobiografe, testimonian-
28 Montepaone, C. Lo Spazio del Margine, Prospettive sul femminile nella comunit antica, Paestum,
Pandemos, 1999. Schmitt Pantel, P. Aithra et Pandora. Femmes, genre et cit dans la Grce antique,
Paris, LHarmattan, 2009.
29 Nella storia antica e medievale con storia culturale si considera un campo pi vasto di quello delle
pratiche intellettuali e del pensiero, perch include le forme e le pratiche materiali caratterizzanti di
una societ.
30 Molti lavori di Dominique Fabre, Christine Plant o Agns Fine.
31 Un esempio: Kunst, C. Livia. Macht und Intrigen am Hof des Augustus, Stuttgart 2008.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 55 03/05/2013 11:11:10
56
Le nuove frontiere della Storia di genere dallAntichit allEt contemporanea
ze orali), i quali non sono unicamente fonti documentarie ma anche oggetti storici
che informano sulle pratiche culturali della scrittura, sul lavoro della memoria, sui
processi di messa in scena o di auto-costruzione del s.
4. Oggetti antichi rivisitati
I temi classici della storia delle donne e di genere il corpo, la maternit, il la-
voro, la religione, le lotte sindacali e politiche, la citt, leducazione, i movimenti
femministi, limpegno associativo e anche eventi come la rivoluzione francese
o la guerra, sono stati rivisitati per allargare le conoscenze, sviluppare una nuova
impostazione o ofrire delle nuove sintesi storiografche e nuove interpretazioni.
Il corpo delle donne, cos com costruito dai discorsi dei medici, com vis-
suto nella maternit, com rappresentato nei diferenti momenti dellet e in par-
ticolare nella vecchiaia, un soggetto di studio molto presente nei lavori recenti
di storia antica e medievale, che integrano nelle analisi tutte le problematiche
sviluppate dalla storiografa sul corpo
32
. Allo stesso modo, nella storia contem-
poranea, lindagine sul corpo non un semplice calco delle domande poste negli
anni Settanta, che erano centrate sullesperienza vissuta dalle donne o sulle forme
di costrizione (biopoteri, formattazione scolastica ecc.). Oggi, linteresse rivol-
to alle rappresentazioni del proprio corpo e del corpo dellaltro nelle loro mutevoli
confgurazioni e le diferenze di genere, alle molle del desiderio maschile e femmi-
nile, alle norme delle pratiche corporali, anche distinguendo le varie classi det,
inclusa la vecchiaia
33
. Si scrive una storia della bellezza che non unicamente
quella dei mezzi per imbellirsi ma anche quella dei codici estetici e dello sguardo
34
.
Nella storia del XX secolo, la questione della violenza sessuata diventata centrale,
notevole lemergenza della storia degli stupri nella guerra
35
.
32 In Spagna per esempio, il tema della maternit ha dato luogo a numerosi seminari e convegni. Tra
le pubblicazioni recenti: Cid, R. Madres y maternidades. Construcciones culturales en la civilizacion
clasica, Oviedo, KRK, 2009. Dasen, V.; King, H. La mdecine dans lAntiquit grecque et romaine,
Lausanne, 2008. Dasen, V.; Boudon-Millot, V.; Maire, B. (ds), Femmes en mdecine. En lhonneur
de D. Gourevitch, Paris 2008. Sulla vecchiaia, Ehmer, J.; Wagner-Hasel, B. Sozialgeschichte des Alters,
Krner Verlag (in corso di stampa).
33 Le corps des jeunes flles (Paris, Perrin 2001, sous la direction de L. Bruit-Zaidman, L.; Houbre, G.;
Klapisch-Zuber, C.; Schmitt Pantel, P.) comprende 3 parti: le corps vu/il corpo visto, le corps social/il
corpo sociale, le corps imaginaire/il corpo immaginario.
34 Vigarello, G. Histoire de la beaut. Le corps et lart dembellir de la Renaissance nos jours, Paris,
Seuil, 2004; Corbin, A.; Courtine, J.J.; Vigarello, G. Histoire du corps 1. De la Renaissance aux Lu-
mires, 2. De la Rvolution la Grande Guerre, 3. Les mutations du regard: le XX
e
sicle, Paris, Seuil,
2005-2006.
35 Cfr. il convegno internazionale organizzato a Parigi nel maggio 2009: Les viols en temps de
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 56 03/05/2013 11:11:10
57
Pauline Schmitt Pantel, Franoise Tbaud
Nella storiografa tedesca
36
o spagnola
37
dellantichit e del medioevo si assiste
anche al rinnovamento di temi allincrocio tra storia sociale e del diritto, per quan-
to riguarda gli studi di storia urbana, della sociabilit femminile o degli statuti di
categoria, come per gli schiavi a Roma. Lo studio del rapporto delle donne con la
religione rimette in discussione alcuni stereotipi, come la non presenza delle donne
ai sacrifci sanguinosi nella societ greco-romana
38
. Le fonti agiografche ed eccle-
siastiche medievali, indagate sotto langolo del genere, ofrono nuove prospettive
su penitenti dambo sessi in Italia, sul misticismo in Germania, sulla costruzione
del miracolo e della santit in generale con i processi di canonizzazione
39
.
Infne gli studi sulle rappresentazioni, limmaginario, che erano le prime que-
stioni iscritte nella problematica del genere, continuano la loro strada. I saperi
femminili sono messi a confronto con quelli maschili
40
. Sulle orme di Nicole Lo-
raux e di Froma Zeitlin, i lavori attuali sul teatro, al di l della semplice opposi-
zione maschile/femminile, approfondiscono le tensioni, le ambiguit e le strategie
messe in opera nelle relazioni tra i sessi
41
. Infne, nel campo dello studio dei miti
e del politeismo greco, uno sguardo pi attento al carattere di genere dei racconti
e dei riti, nel testo come nelle immagini, permette una rilettura della mitologia e
del panteon
42
.
5. Nuovi oggetti
Nuovi soggetti di studio si incontrano in Francia da circa una diecina danni. Si
ritrovano in ogni settore della storiografa, con lievi diferenze legate alle proble-
matiche della storia generale.
guerre: une histoire crire (Stupri in tempo di guerra: una storia ancora da scrivere).
36 Stavrianopoulou, E. Gruppenbild mit Dame, Untersuchungen zur rechtlichen und sozialen Stellung
der Frau auf den Kykladen im Hellenismus und in der rmischen Kaiserzeit, Stuttgart, Steiner, 2006.
Chryselius, S. Umfreie Mnner und Frauen im antiken Rom. Darstellung und Vergleich geschlechtsspe-
zifscher Lebensbedingungen, Bergfelde, 2006.
37 Cfr. Iriarte, A. Fminin/masculin versus Histoire Sociale dans luniversit espagnole, in Rencon-
tres europennes du RING: A propos des tudes de genre dans les pays europens. O en sommes-nous?,
www.univ-paris8.fr/RING/activites/rencontres.euro/iriarte.espagne.html (2006).
38 Bodiou L.; Mehl, V. (ed.), La religion des femmes en Grce, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2009.
39 Vedere un bilancio in: Genre et histoire, n 3, 2008, citato in nota 7.
40 Ando, V. Lape che tesse. Saperi femminili nella Grecia antica, Roma, Carocci, 2005.
41 Vedere una rassegna di questi studi in: Bruit Zaidman, L.; Schmitt Pantel, P. 2007 cit. nota 7.
42 Frontisi-Ducroux, F. Lhomme-cerf et la femme-araigne, Paris, Gallimard, 2003. Pironti, G. Entre
ciel et guerre. Figures dAphrodite en Grce ancienne, Lige, Kernos, Suppl., 2007.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 57 03/05/2013 11:11:10
58
Le nuove frontiere della Storia di genere dallAntichit allEt contemporanea
Per lantichit, la fonte archeologica interrogata dal punto di vista del genere
almeno in due campi: le pratiche funerarie
43
e le modalit dellabitare
44
. Le novit
dovute alla prospettiva del genere dipendono da un nuovo metodo danalisi dei
reperti e allapertura degli archeologi verso altre scienze sociali. La storia della
famiglia e della parentela ora investita dallangolazione del genere, essendo i
primi studi dedicati alle relazioni tra uomini e donne allinterno della famiglia
e in particolare tra fratelli e sorelle. Questi studi, nella Storia dellantichit come
del Medioevo, sposano le impostazioni antropologiche con quelle storiche e si
trovano al crocevia tra la storia sociale e la storia culturale, ponendo un accento
sulle rappresentazioni
45
.
Le mascolinit gi evocate riguardano tutte le epoche storiche. Lo studio de-
gli uomini, in quanto non semplici esseri sessuati ma sessualmente costruiti, pro-
gredisce vistosamente; lo studio delle sessualit avanza notevolmente. Nel mondo
greco romano antico, la rifessione sulla sessualit e le costruzioni delle identit di
genere sono state ampiamente rinnovate attraverso lo studio dellerotismo maschi-
le in particolare, e quello dellomosessualit femminile
46
. La rifessione collettiva si
dirige attualmente sul modello, le norme e le pratiche
47
. Sinserisce in unindagine
pi vasta in cui il genere occupa un posto privilegiato, che riguarda il sistema dei
piaceri nellantichit
48
.
Anne Claire Rebreyend autrice di una tesi recente dedicata allintimit degli
individui ordinari del XX secolo, ossia sessualit e sentimenti amorosi
49
ha ri-
portato recentemente sul numero di Clio, Histoire, Femmes et Socits centrato sul-
43 Cuozzo, M. Reinventando la tradizione. Immaginario sociale, ideologie e rappresentazione nelle necro-
poli orientalizzanti di Pontecagnano, Paestum, Pandemos, 2003.
44 Nevett, L.C. House and Society in the Ancient Greek World, Cambridge, Cambridge University
Press, 2001.
45 I lavori di Christiane Klapisch in storia medievale aprirono la strada in questo campo. Alaux, J. Le
lige et le flet, Paris, Belin, 1995. Lett, D. Histoire des frres et surs, Paris, La Martinire, 2004. Har-
ders, A.C. Suavissima Soror. Untersuchungen zu den Bruder-Schwester-Beziehungen in der rmischen
Republik, Mnchen, Beck, 2008.
46 Dupont, F.; Eloi, T. Lrotisme masculin dans la Rome antique, Paris, Belin, 2001. Boehringer, S.
Lhomosexualit fminine dans lAntiquit grecque et romaine, Paris, Les Belles Lettres, 2007. Iriarte, A.;
Gonzalez, M. Entre Ares y Afrodita. Violencia del erotismo y erotica de la violencia en la Grecia antigua,
Madrid, Abada, 2008.
47 Atelier EFiGiES Antiquit, Genre, sexe, sexualit dans les mondes grec et romain, programme
2009-2010.
48 Davidson, J. Courtesans and Fishcakes, Te Consuming Passions of Classical Athens, Londres, Harper
Collins, 1997.
49 Rebreyend, A.C. Intimits amoureuses, France 1920-1975, Toulouse, PUM, 2008. Le fonti princi-
pali consistono in biografe e corrispondenze.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 58 03/05/2013 11:11:10
59
Pauline Schmitt Pantel, Franoise Tbaud
le utopie sessuali (2005), un bilancio delle ricerche in questo campo, comparate
alla vasta produzione anglo-americana centrata sullapproccio costruzionistico
delle categorie dellomosessualit. Di l dalle problematiche importate da fuori
e spesso ispirate ai lavori di Michel Foucault, la storiografa francese, prima degli
antichisti, poi dei medievisti e modernisti citiamo la recente Histoire du plaisir
di Robert Muchembled (2005) intraprende una sua rotta con lavori su uomini
e donne e linsieme delle pratiche sessuali. La nascita nel 2003 dEFiGiES Asso-
ciazione di giovani ricercatori e ricercatrici in studi femministi, genere e sessualit
testimonia che il tema non pi trascurato e pu mostrarsi in ununiversit
francese, giudicata, tempo fa, pudibonda da Alain Corbin. Anche gli storici gi
afermati prendono la sessualit come oggetto dindagine, dalla sessuologia (Sylvie
Chaperon) allermafrodismo (Gabrielel Houbre), dal crimine dOnan denun-
ciato dalla Chiesa cattolica (Claude Langlois), alle lotte per la liberazione sessuale.
In riferimento alla storia contemporanea, invece, sono pi specifci altri sog-
getti, in particolare il colonialismo e la/le colonizzazione/i, le migrazioni, pur
dovendo notare ancora una sfasatura cronologica e quantitativa tra storiografa
di lingua inglese e ricerche francesi. In Francia, tuttavia, lavori recenti
50
pongo-
no le donne e il genere al cuore di unanalisi complessa del progetto imperiale e
delle societ coloniali, e anche di unanalisi delle societ schiavistiche sorte dal
commercio triangolare. Approcci e conclusioni convergono verso i risultati delle
opere anglosassoni, si concentrarono maggiormente sulle colonie inglesi, olandesi
o tedesche. Ne risulta che le donne sono state attive dai due lati della barriera
coloniale: ci sono le militanti dassociazioni colonizzatrici espatriate volenti o no-
lenti, delle quali messa in rilievo la diversit sociale, culturale e generazionale; ci
sono le donne colonizzate, dai molteplici passati che le politiche della metropoli
non infuenzarono allo stesso modo. Si sottolinea inoltre limportanza che le poli-
tiche hanno accordato al controllo della sessualit e delle nascite, o si rifette sulle
categorie giuridiche della nazionalit e della cittadinanza che suscitano le forme
di meticciato. Emergono in piena luce le metafore del genere e della famiglia
che strutturano la comprensione europea delle relazioni coloniali tra paesi virili
e popoli efeminati, tra metropoli protettrici e popolazioni che devono essere
guidate come bambine verso la civilt. Gli studi coloniali hanno anche bisogno
di pensare larticolazione tra questioni razziali (sessualizzate) e questioni sessuali
(razzializzate), tra poteri e saperi, nella costruzione di una scienza imperiale negli
ultimi decenni del XIX secolo e i primi del XX secolo.
Abbozzati gi da altre discipline, e argomenti scelti da gruppi di giovani ri-
cercatrici/tori, sicuramente stanno per irrompere lavori di storia delle donne e
50 Taraud, C.; Hugon, A.; Barthlmy, P.; Cottias, M.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 59 03/05/2013 11:11:10
60
Le nuove frontiere della Storia di genere dallAntichit allEt contemporanea
del genere sullimpatto della schiavit e della colonizzazione sulle istituzioni, le
rappresentazioni e le politiche pubbliche delle societ postcoloniali.
In quanto fenomeni in parte legati in parte indipendenti dalla colonizzazione,
le migrazioni provinciali, intra-europee e lontane, gli scambi universitari, gli esili
politici, tutti i fenomeni delle migrazioni e naturalizzazioni stanno diventando in
Francia un tema essenziale della storia generale come della storia delle donne e del
genere. Organizzato nel 2006 dal Centre dHistoire du XXe sicle de lUniversit
Paris-1 e dellEcole Normale Suprieure, un convegno intitolato Histoire, genre,
migration ha mostrato le molteplici potenzialit di tale indirizzo e sottolineato
ancora una volta limportanza dei lavori allestero i quali hanno fornito pi dei
due terzi dei contributi. Ma la situazione si evolve. Basta segnalare la tesi di dotto-
rato di Linda Guerry in corso di stampa sul genere nellimmigrazione e nella
naturalizzazione a Marsiglia tra le due guerre: la ricerca insieme attenta ai saperi
uf ciali e amministrativi sullAltro, alle politiche di genere nellimmigrazione e
la naturalizzazione, alle pratiche sociali degli individui dambo i sessi come delle
amministrazioni.
6. Nuove questioni. Un diverso modo di vedere i rapporti tra
femminismo e ricerca
Questo cambiamento si manifesta in due modi. Da un lato, la storia delle donne e
di genere un sapere che si inizia a studiare sotto langolo della storia e della socio-
logia delle scienze (studio delle comunit scientifche e delle loro regole di funzio-
namento, studio delle pratiche scientifche e dellarticolazione di queste pratiche
con i mondi sociali e politici). Daltro canto, seguendo lesempio di Delphine
Gardey che opera molto in quel senso, si tratta di chiedersi non solo qual il
posto delle donne nelle scienze o le tecniche, ma piuttosto cosa fanno le scienze
e le tecniche alle donne. Per esempio, le scienze attribuiscono la diferenza tra i
sessi alla natura, ricercano la categorizzazione sessuale nellanatomia, gli ormoni,
i cromosomi o i geni, cancellano ogni forma dambiguit sessuale, come nel caso
del trattamento dellintersessualit o la determinazione del sesso degli sportivi
51
.
Allo stesso modo, le tecniche che partecipano della cultura maschile, fabbricano
delle identit di genere, contribuiscono a produrre e riprodurre dei ruoli maschili
e femminili
52
.
51 Gardey, D.; Lwy, I. (dir.) Linvention du naturel. Les sciences et la fabrication du fminin et du
masculin, Paris, Editions des archives contemporaines, 2000. Cfr. anche Lwy, I.; Rouch, H. (a cura
di) La distinction entre sexe et genre. Une histoire entre biologie et culture, in Cahiers du genre,
n. 34, 2003.
52 Chabaud-Rychter, D.; Gardey, D. (dir.) Lengendrement des choses. Des hommes, des femmes et des
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 60 03/05/2013 11:11:11
61
Pauline Schmitt Pantel, Franoise Tbaud
7. Le difcolt dellistituzionalizzazione
In Francia questo problema ricorrente piuttosto che nuovo, tuttavia prende forme
inedite. Da un lato si pu parlare di un riconoscimento intellettuale ma non seguito
da riconoscimento istituzionale. Il riconoscimento intellettuale dobbligo davanti
alla qualit e al numero delle ricerche pubblicate, e anche al peso degli approcci del
genere nelle istituzioni europee e internazionali (il fnanziamento europeo preme).
Sarebbe ormai impossibile alle politiche pubbliche francesi ignorare studi di questo
tipo, ma spesso si accontentano nellIstruzione Universitaria e la Ricerca di solleci-
tare delle missioni o dei comitati consultativi che iniziano il censimento delle ricer-
che solo per buttarlo in un cassetto (ruolo attuale della Missione Parit al CNRS).
Lautonomia delle Universit invocata oggi per giustifcare il non sostegno a livello
nazionale. Questa strategia negativa istituzionale impedisce la trasmissione dei sa-
peri a tutti i livelli dellinsegnamento. Si trova attenuata dalliniziativa delle regioni,
nuove protagoniste nel panorama dellinsegnamento e della ricerca (Institut Emilie
du Chtelet en Ile-de-France), e dallintroduzione dindirizzi di genere, a volte plu-
ridisciplinari, in alcuni laboratori di ricerca
53
. Il genere in questo modo appare pi
come procedura e approccio trasversale che non un oggetto dindagine.
Bisogna infne sottolineare in Francia come in altri Paesi dellEuropa, il di-
namismo delle associazioni di ricerca (SIEFAR, Mnmosyne, EFiGiES, Archives du
fminisme) che tentano di ovviare alla defcienza istituzionale: organizzano conve-
gni, distribuiscono premi alla ricerca, svolgono attivit editoriali. Non dobbiamo
dimenticare inoltre il ruolo organizzativo delle riviste nel campo della ricerca fran-
cese, anche per il dialogo con la ricerca fuori della Francia: Clio, Histoire, Femmes
et Socits (32 numeri dal 1995) e la neonata Genre&Histoire, rivista elettronica
lanciata dallAssociazione Mnmosyne in prevalenza orientata verso le giovani ri-
cercatrici e i giovani ricercatori.
8. La Storia dellAntichit e del Medio Evo: un mondo a parte?
facile constatare che gli storici di queste due discipline sono raramente presenti
nelle sintesi generali attraverso le et o pluridisciplinari sul genere
54
. In realt, le
storiche dellet classica e del medioevo non sono meno interessate delle altre a
techniques, Paris, Editions des archives contemporaines, 2002.
53 Un esempio: stato creato un laboratorio trasversale sul genere allUniversit Paris 1 nel 2009. Esso
raggruppa tutte le discipline delle scienze umane, giuridiche, economiche delluniversit.
54 Fougeyrollas-Schwebel, D. Le genre comme catgorie danalyse, Paris, LHarmattan, 2003; Bard,
C. (ed.), Quand les femmes sen mlent. Genre et pouvoir, Paris, La Martinire, 2004. Opitz, C. Um-
Ordnungen der Geschlechter. Einfhrung in die Geschlechtergeschichte, Tbingen, Ed. Diskord, 2005.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 61 03/05/2013 11:11:11
62
Le nuove frontiere della Storia di genere dallAntichit allEt contemporanea
questo tipo di orientamento, ma i colleghi di storia moderna e contemporanea
considerano questi periodi come dei mondi a parte, che essi conoscono male e sui
quali leggono poco. Tale ostracismo non signifca che la nostra ricerca sia in ritar-
do rispetto alla loro, ma che le nostre problematiche, pi vicine allantropologia
e alla storia delle rappresentazioni, portano a percorrere strade diverse da quelle
della storia moderna o contemporanea.
Unaltra questione pi dolente consiste nel chiedersi se la Storia di genere
abbia trovato posto nellanalisi storica globale sul medioevo o lantichit. La ri-
sposta ha molti distinguo. Il fatto di lavorare in gruppi di ricerca dove il genere
pienamente accettato, di insegnare nelle universit (poche) dove la storia di genere
pu entrare in un corso di studi di storia, non pu fare dimenticare quale grande
deserto ofra la Francia in questo campo. Va rilevato in proposito che un sondag-
gio recentissimo presso colleghi di vari Paesi europei permette tuttavia di estendere
il gran deserto europeo
55
. Piuttosto che lamentarci, riconosciamo che uno sforzo
in pi si rivela necessario per spiegare meglio la procedura della storia di genere e
la sua applicazione concretissima ai documenti e ai temi storici. Esistono adesso
manuali che trattano della storia delle donne per tutte le et storiche, ma bisogna
continuare lo sforzo didattico in direzione della storia di genere. Vediamo unin-
dicazione in tale senso in tre volumi recenti: a cura di Michle Riot-Sarcey, il pri-
mo propone per ogni periodo un esempio dapproccio sotto il punto di vista del
genere, il secondo un manuale destinato ai docenti delle scuole secondarie, che
rilegge linsieme dei programmi dal punto di vista delle donne e del genere (pa-
trocinato da Mnmosyne)
56
; lultimo un libro collettivo coordinato da Sandra
Bohringer e Violaine Sebillotte Cuchet
57
, che combina una presentazione teorica
e tematica della storia di genere a commenti precisi di documenti.
Cercare di delineare le nuove frontiere della storia del genere ha fatto capire
che resta impossibile ofrire una visione unifcata di questa ricerca. La sua ricchez-
za dipende senzaltro dalla diversit degli argomenti studiati e delle impostazioni
oggi in corso. Probabilmente non pi il tempo delle reticenze e delle resistenze
davanti a quel campo di studio: la Storia di genere non una foglia di fco che
nasconde il sesso, non nemmeno disincarnata (Gianna Pomata). In quanto alle-
55 A proposito della Germania, si veda Genevive Bhrer-Tierry, Histoire du genre dans les pays de
langue allemande, in Genre et Histoire, n. 3, 2008.
56 Riot-Sarcey, M. (dir.) De la difrence des sexes. Le genre en histoire, Larousse, 2010; Dermenjian,
G.; Jami, I.; Rouquier, A.; Tbaud, F. (dir.), La place des femmes dans lhistoire. Une histoire mixte,
Paris, Belin, 2010.
57 Bohringer, S.; Sebillotte-Cuchet, V. (dir.) Hommes et femmes dans lAntiquit grecque et romaine,
Paris, Armand Colin, 2011.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 62 03/05/2013 11:11:11
63
Pauline Schmitt Pantel, Franoise Tbaud
voluzione constante delle sue problematiche, va rilevato che essa legata a una
storia sociale e politica vivace, radicata nella storia contemporanea, le sue lotte
e i suoi interrogativi
58
. Il genere per molti di noi un processo, una costruzione,
un campo dindagine che si evolve con capacit dapertura e di creativit, insom-
ma un modo non irrigidito di fare storia. utile pertanto far conoscere meglio
questimpostazione storica, e forse giunto il nostro turno di scrivere delle storie
generali per ciascuno dei periodi che ci sono familiari, dando al genere il posto che
gli spetta. Insomma, occorre saltare il Rubicone e passare dalla Storia di genere a
una riscrittura di tutta la storia, realizzando un obiettivo gi evocato molte volte.
58 Un esempio: il legame instaurato in Spagna, in particolare tra le ricerche sulle donne e quelle
sullambiente, la storia ecologica, scaturito dalla forte consapevolezza molto viva tra le donne della
dipendenza umana nei confronti delle risorse naturali.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 63 03/05/2013 11:11:11
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 64 03/05/2013 11:11:11
Madame la Terre, Monsieur le Capital:
quale il genere del progresso nel XIX secolo?
Marta Petrusewicz
1. La danse macabre
Siamo in pieno secolo decimonono
59
, in un mondo stregato, deformato e capo-
volto [dove] si aggirano i fantasmi di Monsieur le Capital e Madame la Terre,
come caratteri sociali e insieme direttamente come pure e semplici cose
60
. Nella sua
evocazione della danse macabre, Karl Marx ironizza sulla tendenza degli economisti
a personifcare categorie che per lui sono solo economiche e sociali: il proftto e la
rendita, la classe agraria e quella industriale. In questo saggio, per, mi servir pro-
prio di questa immagine antropomorfca di Marx per parlare di classi sociali, visioni
della modernit, mentalit e regimi di rappresentazione e mettere nello stesso tempo
in evidenza le caratteristiche di genere del Capitale e della Terra.
Nella danse macabre i fantasmi di Monsieur le Capital e Madame la Terre vol-
teggiano stretti luno allaltra. A unirli un rapporto organico e indissolubile, allin-
terno del quale ciascuno mantiene la propria specifcit. La terra lUniversale e
il Locale: fonte di sussistenza, legata organicamente alla natura e al rinnovamento
ciclico dellenergia umana, simbolizza anche lunicit del suolo, del luogo e delli-
59 Quanto segue sono spunti nati nellambito di una mia lunga ricerca sulle modernit alternative
nelle periferie europee dellOttocento, dove la dimensione di genere diventa man mano sempre pi
palese. Queste rifessioni sono state presentate per la prima volta al Congresso napoletano della So-
ciet delle Storiche nel 2010, occasione di cui sono grata alle organizzatrici. Ringrazio altres Renata
De Lorenzo per il suo perspicace commento che ha contribuito alla presente versione.
60 Marx, K. Il Capitale, vol. 3, Roma, Editori Riuniti, 1964, p. 943.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 65 03/05/2013 11:11:11
66
Madame la Terre, Monsieur le Capital: quale il genere del progresso nel XIX secolo?
dentit
61
. La terra rimane fsicamente dove e dove sempre stata, come iscritta
nella vita con un destino storico proprio, un valore non moltiplicabile, diverso da
tutti gli altri. Il capitale, invece, privilegia il nesso materiale, sovra-locale, staccato dai
luoghi e dalle storie specifche. mobile e cambia facilmente di forma e inseguendo
le opportunit oferte dal proftto, si accumula e si moltiplica allinfnito.
La mente agricola volta a capire, osservare, rispettare la Natura, dialoga con
lei e ne ascolta la voce
62
perch da questa relazione dipende il rinnovamento della
vita. La mente commerciale, invece, astratta e fredda; ipocrita, volgare, noiosa, ru-
morosa, sprecona e ignorante, diceva Charles Fourier. La terra alla perenne ricerca
dellarmonia, il capitale insegue la concorrenza, il confronto e lantagonismo.
Questa ancestrale costruzione della diferenza messa brutalmente in discus-
sione agli albori della Rivoluzione Industriale. La popolazione europea era cresciuta
rapidamente, soprattutto per efetto del calo della mortalit, passando dai centot-
tantacinque milioni nel 1800 ai quattrocento nel 1900. Il maggiore fabbisogno
alimentare esercita una formidabile pressione sul settore agricolo per aumentare la
produttivit e privilegiare i prodotti ad alto contenuto calorico e la pastorizia. La
produzione agricola, entrata in un ciclo di crescita negli anni Trenta dellOttocento,
aumenta di pi del doppio nei quattro decenni successivi. Lo sfruttamento pi in-
tenso del suolo conduce in tempi brevi alluso dei moderni fertilizzanti chimici e il
plurisecolare sistema di rotazione triennale cede il passo alla rotazione permanente.
Tutti questi cambiamenti, accompagnati dallemigrazione di massa verso le grandi
citt, causano uno spopolamento delle campagne, soggetto frequente di nuovi
studi sociologici
63
. Altri studi mostrano che in Inghilterra, dove la conversione dei
terreni alla produzione cerealicola/pastorale, sancita nel 1803 dal General Enclosure
Act, inizia per prima, la vecchia agricoltura diversifcata scompare quasi del tutto
64
.
Madame la Terre, messa sotto attacco da parte di Monsieur le Capital e i
suoi alleati, gli economisti post-Smithiani e i governi riformatori, viene accusata
di essere arretrata, tradizionale, antiquata e immobilizzata da usi comunitari. I
governi centrali entrano nei villaggi per riformare le pratiche agricole forzando la
transizione dal comunalismo allindividualismo agrario. Forte di questi appoggi
e cresciuto in importanza e potere, Monsieur le Capital tenta di trasformare la
consorte a propria immagine e somiglianza, da terra-materia in terra-capitale, un
capitale fsso che si modifca, come qualunque altro, soggetto alle leggi della pro-
priet. Si potrebbe dire, per anticipare ci che andr argomentando, che Monsieur
le Capital tenta di androgenizzare la consorte.
61 Reboul, C. Monsieur le Capital et Madame la Terre: fertilit agronomique et fertilit conomique,
Paris, INRA, 1989.
62 Come il Signor Cogito che cerca di distinguere la voce umana da quella della natura.
63 Per esempio Bonnemre, E. Les paysans au XIXe sicle, Nantes, Impr. Veuve Mellinet, 1847.
64 Tirsk, J. Alternative agriculture: a history, Oxford, Oxford University Press, 1997.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 66 03/05/2013 11:11:11
67
Marta Petrusewicz
2. Terra-Capitale: opposizioni binarie
La tensione tra la Terra e il Capitale, che avrebbe impermeato le dottrine econo-
miche e le politiche di tutto il XIX secolo, viene espressa al livello discorsivo con
una serie di opposizioni binarie qui di seguito sintetizzate.
Capitale Terra
Industria Agricoltura
Citt Campagna
Proftto Rendita
Produzione/Investimento Riproduzione/rinnovamento
Interesse proprio (self interest) Sacrifcio (bene comune)
Guadagno Nutrimento
Commercializzazione Autosuf cienza (sussistenza)
Crescita esponenziale Ciclicit (eterno ritorno)
Mobilit Radicamento (immobilit)
Volatilit Eternit
Tempo breve (impazienza) Tempo giusto
Rinvio di gratifcazione (accumulazione) Godimento di frutti
Cosmopolitismo (senza patria) Localismo (amor patrio)
Dominio mondiale Coltivare il suolo patrio
Ragione Sentimento
Scienza Natura
Individualismo Cooperazione
Lotta Armonia
Rischio Stabilit (linerzia apparente)
Libera scelta Necessit (scelte vincolate)
Sfera maschile Sfera femminile
Quando la tensione si acuisce, queste opposizioni binarie diventano tasselli
di costruzioni normative aspre e sprezzanti. Il Capitale considera la Terra come
una sopravvivenza feudale e medievale, una roccaforte dellarretratezza economica
e della conservazione sociale, delloscurantismo e delle gerarchie, mentre si auto-
rappresenta come fautore della libert, della mobilit e del progresso umano, al
passo con il suo secolo
65
.
65 La denominazione et del capitale fu attribuita alla parte centrale del XIX secolo da Hobsbawm,
E.Te Age of Capital: 1848-1875, London, Weidenfeld & Nicolson, 1975, tr.it. Il trionfo della bor-
ghesia. 1848-1875, Roma-Bari, Laterza, 1976.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 67 03/05/2013 11:11:11
68
Madame la Terre, Monsieur le Capital: quale il genere del progresso nel XIX secolo?
Madame la Terre, da parte sua, si difende ricorrendo alla dicotomia morale
tra citt e campagna, la prima abitata dal Diavolo, la seconda da Dio
66
. Associato
al Diavolo, il Capitale visto come un freddo calcolatore, privo di compassione,
arido di sentimenti e sprezzante verso legami che non siano mediati dal danaro (il
cash nexus di Tomas Carlyle). La sua citt un luogo di invidia, brama di danaro,
ipocrisia, perdizione. La Terra, invece, appartiene a Dio che la assiste sempre, tra-
mite il suo vicario la natura e in collaborazione con il coltivatore attento (del resto
Dio predilesse la campagna come luogo di redenzione).
Malgrado queste polemiche aspre, le opposizioni binarie sopra elencate si
collocano comunque in un universo culturale condiviso dalle due parti, forma-
tesi sulle stesse letture di Montesquieu, Herder e Ritter: la fede nella libert, il
determinismo naturale e la superiorit della razza bianca. Ad esempio, quando il
Capitale cerca di dominare il mondo e la Terra di coltivare il suolo patrio, partono
tutti e due dalla convinzione che Dio abbia prediletto i cristiani europei dotandoli
di una superiorit razziale e culturale nonch ambientale, anche se poi ne deriva-
vano pratiche diverse
67
. Cos, alla base dellopposizione tra Scienza e Natura, c il
riconoscimento condiviso dellautorit della Natura e dei suoi dettati normativi,
bench anche qui le due parti ne derivavano conclusioni diferenti. Per il Capitale,
Natura determina la natura della specie e dellindividuo, ma anche un tiranno
al quale giusto ribellarsi per afermare la propria autonomia. Per la Terra, invece,
Natura vicario di Dio; fssa gli standard del buono, bello, giusto e virtuoso, e i
limiti del potere individuale di scelta. Le leggi di Natura, e il posto che a ognuno
viene assegnato, vanno rispettati se si vuole godere dei suoi premi terre fertili e
pecore lanose, diceva Esopo e evitarne le punizioni
68
. Infne, alla base dellop-
posizione tra Libera Scelta e Necessit, troviamo la condivisa priorit accorda-
ta alla libert ma idee diferenti sui suoi limiti: per il Capitale, oltre a quelli fssati
dai contratti sociali, i limiti sono ben pochi; viceversa, per la Terra sono molteplici
e consapevoli perch derivati da un senso di responsabilit
69
.
66 Williams, R. Te City and the Country, London, Chatto and Windus, 1973.
67 Le due concezioni deterministiche sono ben rifesse in due studi recenti: Diamond, J. Guns, Germs,
and Steel: Te Fates of Human Societies, New York, W.W. Norton, 1997, tr.it. Armi, acciaio e malattie,
Milano, Il Saggiatore, 2002 e Landes, D.S. Te Wealth and Poverty of Nations: Why Are Some So Rich
and Others So Poor?, New York, W.W. Norton, 1998, tr.it. La ricchezza e la povert delle nazioni.
Perch alcune sono cos ricche ed altre cos povere, Milano, Garzanti, 2002.
68 Vedi: Daston L; Vidal, F. (a cura di) Te Moral Authority of Nature, Chicago, University of Chicago
Press, 2004.
69 Il concetto era importante per i neo-ruralisti inglesi come il poeta Edmund Blunden, lagronomo
Harold Massingham e altri.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 68 03/05/2013 11:11:11
69
Marta Petrusewicz
3. Le due modernit
importante notare che, oltre ai postulati di cui sopra, il Capitale e la Terra con-
cordano su altri punti fondamentali quali lopposizione alla feudalit, un certo
liberismo economico, la preoccupazione per la ricchezza della nazione e luso dei
termini progresso/arretratezza e trasformazione. Infatti, nel XIX secolo, sono
ambedue entit moderne e interessate alla modernizzazione. Le loro visioni di
modernit sono, per, diverse e tra di loro alternative: due idee di progresso, due
discorsi economici e due insiemi di pratiche che avrebbero coesistito in concorren-
za per quasi tutto il secolo. Inizialmente, il primo modello, quello industriale, era
limitato allInghilterra, e nemmeno tutta, e ad alcune macchie del continente,
per usare la vecchia espressione di Sidney Pollard, mentre il modello agrario domi-
nava tutta lEuropa periferica e molte aree del centro. I rapporti di forza cambiano
poi gradualmente a favore del capitale, ma la rivalit non si sarebbe risolta se non
con la grande crisi degli anni Settanta
70
.
Delle due modernit, quella del Capitale corrisponde alla nostra nozione
abituale: lindustrializzazione; la trasformazione dellagricoltura (terra-capitale);
lurbanizzazione basata sullo spostamento massiccio delle popolazioni rurali; la
mercifcazione di rapporti sociali; la nuclearizzazione della famiglia; il predo-
minio del commercio a lunga distanza; la crescita senza precedenti delle ricchezze
individuali e la statalizzazione del dominio coloniale.
Laltra versione della modernit, quella rappresentata dalla Terra, pone al cen-
tro la terra e lagricoltura. Anchessa auspica una crescita economica e sociale,
ma graduale e moderata: attorno alla ben gestita agricoltura sarebbe cresciuta la
manifattura, la quale a sua volta avrebbe stimolato lestensione del commercio ai
mercati lontani. Le citt moderne non avrebbero perso il loro rapporto organico
con il territorio e la crescita, altrettanto moderata, della popolazione sarebbe as-
sorbita dai tre settori. Infne, anche laccresciuta ricchezza sarebbe in un qualche
modo distribuita in rapporto con la popolazione.
Tanto il Capitale che la Terra si richiamano alla dottrina di Adam Smith delle
Origini della ricchezza delle nazioni, anche se in modi diversi: il primo, alla mano
invisibile e alle leggi formalizzate da Jean Baptiste Say e David Ricardo; la seconda,
alla teoria dei sentimenti morali e al corso naturale delle cose, lo Smith mediato
da Simonde de Sismondi, Fryderyk Skarbek, Cosimo Ridolf, Friederich List e i
cameralisti tedeschi.
La modernit proposta dalla Terra un compromesso tra tradizione e mo-
dernit capitalista. Opposta alla nozione di terra-capitale, essa tenta comunque
70 Quando lagricoltura si commercializz su grande scala e espulse milioni di contadini che presero
la via dellemigrazione. Molti autori fanno durare questa rivalit fno alla Prima Guerra Mondiale.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 69 03/05/2013 11:11:11
70
Madame la Terre, Monsieur le Capital: quale il genere del progresso nel XIX secolo?
di trasformare la terra in un moderno territorio, nel quale il profondo, virgiliano
sentimento georgico si unisce alla scienza. Lingegneria, la chimica e leconomia
politica non lasciano al caso niente di quel che non attiene strettamente alla Natu-
ra. Il territorio si riempie di modi nuovi, lagricoltura assomiglia alla manifattura
e il suolo fertile diventa un prodotto sociale: de progrs en progrs, on arrive
construire la terre arable, absolument comme on construirait un haut-fourneau
scrive entusiasta, nel 1855, lagronomo francese Edouard Lecouteux
71
.
4. Un sistema genderizzato
Il linguaggio delle opposizioni binarie che descrivono Monsieur le Capital e
Madame la Terre spiccatamente di genere, con attributi nettamente maschili
per il Capitale e femminili per la Terra. Il Capitale diventa davvero un uomo
e la Terra una donna, in un rapporto di coppia a caratteri chiaramente otto-
centeschi.
La Terra madre della grande famiglia umana, nutrice, fertile; il Capitale
un padre-padrone freddo, calcolatore, rude e spietato. La Terra si esprime con
il linguaggio dei sentimenti, dellamore e della cura; il Capitale con quello della
razionalit. Il Capitale usa le virt del lavoro per accumulare denaro, la Terra per
dare la felicit privata e pubblica.
Malgrado alcune apparenze, questo linguaggio di genere appartiene propria-
mente al XIX secolo. solo apparente, per esempio, lo status ontologico eterno
della maternit e della madre-natura nutrice; in realt, la maternit viene elevata
a qualit sacrali proprio nel periodo in cui la fertilit andava diminuendo e si stava
afermando una nuova divisione sessuale del lavoro
72
.
Come si visto, il progetto di modernizzazione portato avanti dalla Terra
non parla afatto di un ritorno a un qualche mitico paradiso arcadico femminile
ma piuttosto di una cooperazione, per quanto confittuale, con il Capitale, tra il
femminile sentimento e la maschile scienza. Madame la Terre non pretende di
governare, anche se gode di un grado di libert che usa, in nome delle leggi della
natura, a difesa della propria specifcit. Essa invoca, invece, un good husbandry
71 Lecouteux, E. Principes conomiques de la culture amliorante, Paris, Librairie agricole de la Maison
Rustique, 1855, p. 135.
72 Per la critica dello status ontologico del matriarcato precedente la legge paterna vedi Butler, J.
Te Body Politics of Julia Kristeva in Oliver, K. (a cura di) Ethics, Politics, and Diference in Julia
Kristevas Writing, New York, Routledge, 1993, pp. 164-78. Sulla rappresentata iconografca della
madre-natura, regale ma fragile, una dea con le vesti stracciate, abbondante ma bestiale con le sue
mammelle piene, vedi Park, K. Response to Brian Vickers, Francis Bacon, Feminist Historiography,
and the Dominion of Nature, in Journal of the History of Ideas, vol. 69, N. 1, 2008, pp. 143-146.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 70 03/05/2013 11:11:11
71
Marta Petrusewicz
(il termine non ha lequivalente in italiano) ovvero lautorit di un marito che al
tempo stesso buon agricoltore, allevatore, amministratore, e economo, capace di
governarla con lamore e con il giudizio
73
. Sar poi compito della Terra addolcirlo,
civilizzarlo e moralizzarlo.
Questo linguaggio fa riferimento a un sistema di rappresentazione, gli ste-
reotipi di genere, le credenze sulle caratteristiche psicologiche e biologiche della
mascolinit e della femminilit e le attivit specifche di ogni genere, tutti propri
del XIX secolo.
Fino al Settecento, la divisione sessuale del lavoro era stata poco rigida; le
donne lavoravano nellazienda domestica accanto agli uomini e come questi in-
trattenevano rapporti con il mercato. Lavvento del capitalismo industriale manda
gli uomini fuori a guadagnare e lascia le donne a governare la casa e i fgli, rom-
pendo cos lunit tra produzione e riproduzione e determinando una separazione
tra pubblico e privato senza precedenti nella storia. La sfera pubblica e il lavoro
retribuito diventano dominio degli uomini; la sfera privata, la casa e la famiglia
sono riservate alle donne. Anzi, la casa si defnisce proprio in quanto separata dal
mondo della produzione
74
. Questa rivoluzione produce non poche ansie allin-
terno della famiglia: gli uomini perdono la guida del lavoro familiare, fonte della
loro autorit patriarcale; le donne sono per legge escluse dalla sfera pubblica, li-
mitate nel diritto alla propriet e subordinate allautorit delluomo. A placare in
parte queste ansie arriva una formidabile costruzione discorsiva, ovvero la dottri-
na delle Sfere Separate. Nel nuovo mondo industriale, la sfera pubblica dura e
brutale, fatta di incertezze, di concorrenza spietata, di mercifcazione e di freddo
calcolo. La sfera privata un rifugio da tutto ci, il luogo della moralit sociale e
personale, dellamore materno e delle virt femminili, dove i fgli vengono educati
ai pii sentimenti pi che alla rigida dottrina religiosa. La dottrina oggettivata
dagli studi medici e sociologici che fanno derivare le sfere separate dalle diferen-
ze caratteriali tra i sessi. Per natura e per necessit storica luomo aggressivo,
competitivo, forte, saggio, fermo, deciso, attivo, indipendente e ambizioso. Ma
anche rude, privo di virt innate e di sentimento religioso, incline al peccato e alla
seduzione. La donna invece debole ed emotiva, per natura dipendente e timida,
casta, devota, sottomessa e domestica, ma sempre per natura dotata di senso
73 Anche gli economisti e gli agronomi moderni assegnano ruoli divisi per genere: agli uomini, la
gestione dei campi secondo criteri aggiornati di tecnologia, scienza ed economia; alle donne, la cura
della famiglia e della casa, secondo standard severi di pulizia, ordine e risparmio. Vedi: Burnier, D.
Masculine Markets and Feminine Care: a gender analysis of the National Performance Review, in
Public Administration Review, n. 6, vol. 66, 2006, pp. 861-872.
74 Vedi: Davidof; L.; Hall, C. Family fortunes: men and women of the English middle class, 1780-1835,
London, Routledge, 1987.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 71 03/05/2013 11:11:11
72
Madame la Terre, Monsieur le Capital: quale il genere del progresso nel XIX secolo?
morale e superiorit etica. La donna ha bisogno delluomo per essere protetta e
nello stesso tempo ha la capacit di elevarne la virt
75
.
Gli stereotipi di genere vengono largamente difusi tramite leducazione e
una variegata letteratura di romanzi moralizzanti, giornali, riviste, almanacchi,
catechismi e manuali di ogni tipo e penetrano tutto il discorso del privato e del
pubblico, i rapporti di classe e di razza, la conquista coloniale, la politica, le cate-
gorie economiche e sociali. Cos, per una persona dellepoca facilissimo perce-
pire Monsieur le Capital come luomo calcolatore, razionale e mercenario, attivo
nella sfera pubblica, nel regime della dura concorrenza, sempre in movimento alla
conquista di fortune e di spazi nuovi; e Madame la Terre, invece, come la donna
generosa e nutrice, radicata, sedentaria e domestica, materna e eterna, estimatrice
darte, fonte di moralit e dietica, dedita alle opere pie. Come donna, Madame
la Terre sottomessa a Monsieur le Capital, ma a condizione chegli sappia essere
un good husband.
Lo stereotipo di genere applicato alla confgurazione Capitale/Terra cos
potente da pervadere tutta la grande narrativa europea
76
, persino quella che con
Jane Eyre, Madame Bovary e Nora sta gi sovvertendo limmagine della vera
donna. Il romanzo europeo rappresenta lopposizione tra citt e campagna nei
termini stereotipati di cui si parlato prima, idealizzando un ordine rurale sem-
plice, demonizzando la citt, glorifcando tradizioni natie e locali e la stabilit so-
ciale, stigmatizzando tutto leccesso e disprezzando ebrei e flistei. Questi termini
sono fortemente genderizzati: la terra/campagna/donna promulgatrice di cura,
moderazione e conservazione; il capitale/citt/uomo agente di cambiamento e
mercifcazione.
5. Il romanzo normativo
Nellambito di questa narrativa, si pu distinguere un flone letterario particolare
allesame del quale sono dedicate le pagine che seguono. Lo chiamer il romanzo
normativo perch agisce da portavoce al progetto di altra modernit di cui si
parlato, formulando programmi di miglioramento economico, sociale e morale
e indicando i modi concreti per riconciliare i valori della tradizione con la mo-
dernizzazione. Il romanzo normativo un veicolo per quegli scrittori che si con-
siderano scienziati sociali, oltre che romanzieri, e che ritengono che il loro dovere
75 Vedi, Welter, B. Te Cult of True Womanhood, in Gordon, M. (a cura di) Te American Family
in Social and Historical Perspective, New York, St. Martins Press, 1978, p. 313.
76 Li ritroviamo, a partire da Wilhelm Meister di Johann Wolfgang Goethe, negli scritti di Matthew
Arnold, i romanzi di Honor de Balzac, Georges Sand, Ivan Gonarov, George Elliott, Jane Austen,
Emily Bronte, Tomas Hardy, Luigi Capuana, Elizabeth Gaskell e tanti altri.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 72 03/05/2013 11:11:11
73
Marta Petrusewicz
principale, per dirla con uno di loro, Ignacy Kraszewski, sia sociale e politico [pi
che] artistico.
I romanzi normativi narrano storie straordinariamente simili tra loro e hanno
la stessa struttura narrativa. Lazione si svolge in un luogo di campagna tipico,
dove tutta la terra appartiene a un certo numero di famiglie, spesso nobili. La
trama verte attorno a due famiglie vicine, una di proprietari buoni, laltra di
cattivi. Il proprietario buono risiede nella sua propriet, lamministra in prima
persona, e porta avanti una cauta e graduale modernizzazione senza rinunciare alle
vecchie e nobili virt. Realizza, in poche parole, il progetto di Madame la Terre.
I proprietari buoni sono il Signor Starzycki in Kollokacja del polacco Jzef Kor-
zeniowski, il protagonista di Pan Starosta del polacco Fryderyk Skarbek, il Conte
OHalloran in Te Absentee dellirlandese Maria Edgeworth o il pastore Rein in
Figlie del Governatore della norvegese Camilla Collett
77
. La gestione prudente as-
sicura loro un notevole successo economico, ma rimangono semplici e modesti,
senza ostentare mai la loro ricchezza. Nella vecchia, spaziosa, prospera e ospitale
casa regna la semplicit, il rispetto per le tradizioni, locali e nazionali, per gli anzia-
ni, la religione, la famiglia, coniugati con lapprezzamento del sapere, leducazione
delle donne e ligiene del corpo. I contadini sono trattati bene, hanno contratti
sicuri, case decenti e scuole nei villaggi.
Il proprietario cattivo, invece, un assenteista, intossicato dalla civilt di
denaro e consumo. Lui e la sua famiglia risiedono da qualche parte estera, o
nelle citt capitali, spesso del Paese occupante: il Lord e la Lady Clonbrony di
Te Absentee abitano a Londra; la contessa Podziemska e suo fglio, lefemina-
to Henryk (Henri) di Kollokacja, sulla Riviera italiana, il debauch Grewicz di
Skarbek a Varsavia. Il proprietario cattivo si cura pi di essere la page che della
propria terra, imita i modi metropolitani, dissipa la fortuna ereditata in frivolezze,
abiti allultima moda, romanzi francesi, balli e ricevimenti. sempre indebitato e
piuttosto impoverito, come Grecki, che allet di trentanni sta ormai spendendo
gli ultimi rubli di una fortuna una volta considerevole. Pigro e insicuro, ha una
moglie sciocca e frivola, e le teste dei fgli sono piene di non-sensi. Lontano, in
campagna, la sua propriet gestita da agenti incapaci o disonesti. Le strutture
sono tutte crollate per mancanza di manutenzione, le rese agricole sono basse,
i redditi ancora pi bassi e i contadini ridotti a una miseria abissale. La dimora
degli avi, che il proprietario disprezza e dove si annoia, veramente spregevole per
quanto sporca, dirupata e inospitale.
In genere, in questi romanzi, succede che il proprietario buono ha una fglia
e quello cattivo un fglio. In unaltra variante, il proprietario buono pu agire in
77 titoli in originale e tradotti
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 73 03/05/2013 11:11:11
74
Madame la Terre, Monsieur le Capital: quale il genere del progresso nel XIX secolo?
loco parentis per giovani orfane nobili, come Pan Starosta per la nipote Waleria o
il Conte OHalloran per Grace Nugent. In ogni caso, presto o tardi, i giovani si
incontrano, si innamorano e dopo aver superato innumerevoli ostacoli verso la
fne del romanzo si sposano. Ovviamente non senza che prima la risoluta fdanzata
sia riuscita a ricordurre allovile il giovane, il quale si era perso perch sciocco e mal
guidato ma in realt si rivela essere fondamentalmente buono. Con lui, si conver-
te tutta la famiglia e insieme si ristabiliscono sulla propria terra, assumono modi
locali e vivono a lungo felici e contenti, amati dai vicini e rispettati dai contadini.
In queste storie paraboliche si compie il miracolo della redenzione e della ri-
generazione: le famiglie smarrite ritrovano la retta via, abbandonano falsi valori e
consumi futili, ritornano nella terra ancestrale per amarla e farla rendere (good hu-
sbandry) ritrovando cos la pace dellanima, la salute, la prosperit e la felicit. Que-
sto succede per merito dellamore e dellinfuenza delle donne, ma anche per la loro
risolutezza. Senza questultima, la rovina dei proprietari assenteisti, incompetenti,
avidi e negligenti si sarebbe consumata, come avviene in un altro romanzo di Maria
Edgeworth, Castle Rackrent, o in Kollokacja e Spekulant di Korzeniowski. Ci che
motiva le eroine del romanzo normativo Grace Nugent, Kamilla Zagartowska,
Sofe Ramm non la ribellione individualista di Jane Eyre, Emma Bovary o, pi
tardi, Anna Karenina, ma la missione di dare vita a un progresso armonico
78
.
Il romanzo normativo va oltre il canone di romanzo rurale in quanto cerca
di coniugare lapologia della semplicit e della verit insite nella vita di campagna
e dei valori e lordine della tradizione, tipici di questultimo, a un contesto di
modernizzazione. Vi si prospetta un ordine sociale armonioso, centrato sulla Terra
e guidato da una classe agraria ravveduta. La Terra e il dovere di preservarla e di-
fenderla si trovano al centro della trama. Chi vive sulla terra si trova a far parte di
ununione organica, ragion per cui la presenza fsica sulla terra del good husband
ritenuta una condizione necessaria per realizzare un ordine armonioso, donde
la polemica contro lassenteismo. Questordine sar guidato dalla classe agraria di
cui il ruolo e la propriet non vengono messi in questione, a condizione che essa
sappia compiere il proprio dovere.
6. Una nota nale: Terra e Nazione
Il romanzo normativo, forito soprattutto nelle periferie dellEuropa, prive allepo-
ca della sovranit nazionale, portatore di un messaggio ulteriore: coltivare bene la
78 Questo lesempio di unagency diretta delle donne nella causa nazionale, che va oltre il ruolo sim-
bolico di cui parla Anne McClintock in Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial
Contest, New York-London, Routledge, 1995.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 74 03/05/2013 11:11:11
75
Marta Petrusewicz
terra un dovere patriottico e la rigenerazione della classe agraria, dellagricoltura
e della campagna non sono che dei passi verso una ben pi grande rigenerazione,
quella che riguarda la patria/nazione
79
. La terra degli avi rappresenta una domaine
patriotique la nazione, il paese e la patria insieme localizzata e radicata, diversa
dal cosmopolita Capitale il quale, nella corsa senza frontiere al proftto, si dimen-
tica del bene patrio. Come scrisse il poeta polacco Kajetan Komian:
la strada dellamore di tutto quello che nazionale, della solidariet [..] del sa-
crifcio, del lavoro organico, dellattivismo locale [..] conduce verso la Polonia; la
strada del cosmopolitismo, delle contraddizioni, dellavidit, del materialismo [..]
conduce lontano da essa
80
.
79 tra i pratici agricoltori, abitatori di contrade che il noto agronomo abruzzese Ignazio Rozzi
vedevasi risvegliare i sopiti sentimenti dellamor patrio e del pubblico bene. Ignazio Rozzi. com-
pletare.. 1841
80 Ziemiastwo polskie (La nobilt terriera polacca), 1839. Traduzione mia.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 75 03/05/2013 11:11:11
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 76 03/05/2013 11:11:11
CAPITOLO 1
A partire da Nicole Loraux:
il femminile tra hybris e nomos
a cura di Claudia Montepaone e Gabriella Pironti
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 77 03/05/2013 11:11:11
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 78 03/05/2013 11:11:11
Introduzione
Claudia Montepaone e Gabriella Pironti
Il presente panel antichistico intende riferirsi a quello che stato lorientamento
principale degli studi di Nicole Loraux (1943-2003) nei suoi scritti sul politico,
il maschile e il femminile, la tragedia e la commedia antiche, intese quali for-
me di rappresentazione e mediazione delle contraddizioni sociali. Integrata su di
uno sfondo antropologico e impiegata essenzialmente come modello euristico, la
prospettiva di genere si conferma un valido strumento interpretativo del mondo
antico, della relazione maschile/femminile nei contesti dati, delle dinamiche della
polis, della stasis, delle trasformazioni socio-politiche, segnalando contraddizioni
del sistema sociale, istituzionale, culturale e religioso e consentendo di superare i
rischi di una lettura di tipo evolutivo.
Quella tra hybris e nomos una delle opposizioni cardine su cui si costruisce
lidea di polis, di citt arcaico-classica: da Louis Gernet e Jean-Pierre Vernant a
Pierre Vidal-Naquet, gli studiosi del mondo antico hanno sottolineato il ruolo
fondamentale di questa polarit. Cos anche Nicole Loraux, che presta una par-
ticolare attenzione al ruolo funzionale che assume, nel ribadire i nomoi, il mec-
canismo di apparente sovversione dei nomoi stessi da parte di fgure della hybris,
spesso di genere femminile. Basti ricordare le sue acute analisi sulla Lisistrata di
Aristofane
1
. Ripensare, a partire da Nicole Loraux, il femminile tra hybris e nomos,
consiste quindi nellesplorare le rappresentazioni del femminile nel mondo greco
1 Loraux, N. Les enfants dAthna. Ides athniennes sur la citoyennet et la division des sexes, Paris, La
Dcouverte, 1984
2
[1981]; Ead., Aristophane, les femmes dAthnes et le thtre, in Entretiens sur
lantiquit classique, XXXVIII, Vanduvres-Genve, 1993, pp. 217-219.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 79 03/05/2013 11:11:11
80
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
antico lasciando emergere le tensioni che lo attraversano, tensioni in cui si esprime
storicamente, a vari livelli, la dialettica maschile/femminile, in risonanza con quel-
le tra ordine e disordine, misura e dismisura, regola ed eccezione.
Questa tematica sar afrontata allinterno del panel da diverse prospettive, ma
che hanno tutte unattinenza con i temi e gli interessi sviluppati dalla Loraux nei
suoi studi: si pensi, ad esempio, alla tragedia e alla commedia attiche. Alcuni contri-
buti privilegiano un preciso contesto storico, altri sono rivolti allanalisi di un culto
preciso e considerano la dialettica maschile/femminile dal punto di vista del rituale.
Anche le rappresentazioni religiose verranno interrogate in una prospettiva di gene-
re. Non mancher uno sguardo flosofco nel tentativo di far dialogare a distanza, sul
politico e sul femminile, la studiosa francese con Hannah Arendt.
Ha contribuito a ispirare la tematica di questo panel la fgura di eroine tragiche
quali Antigone e Medea, lette sulla scorta dei fondamentali contributi di Jean-Pierre
Vernant, Pierre Vidal-Naquet e Nicole Loraux. La scena tragica, come questi studio-
si ci hanno insegnato, un osservatorio privilegiato per cogliere allopera, nella citt
greca, la rappresentazione dei rapporti di forza, ivi compreso quello tra maschile e
femminile. La tensione tra questi due poli, nelle pratiche sociali come nellimmagi-
nario a esse sotteso, stata al centro di molti lavori di Nicole Loraux. Basti pensare a
libri collettivi come La Grecia al femminile
2
, da lei curato, cui hanno contribuito tra
gli altri Claude Moss, Stella Georgoudi e Claudia Montepaone; questo interesse,
unitamente a quello per il politico privilegiato ne Linvention dAthnes
3
, percorre
molte opere della Loraux da Les Enfants dAthna
4
a Les Expriences de Tirsias.
Le fminin et lhomme grec
5
. Le ricerche della studiosa francese sono percorse dalla
volont di far emergere dai vari contesti il pensiero della diferenza, maschile/fem-
minile certo, ma non solo. Le rifessioni sullaspetto strutturante del confitto in
generale, e di quello politico in particolare, sviluppate ad esempio ne La Cit divise
6
e nella raccolta postuma La Tragdie dAthnes
7
, sono un lascito ancora fecondo di
prospettive per meglio comprendere svariati aspetti del mondo antico, ivi comprese
alcune rappresentazioni proprie del politeismo greco
8
. Le sue brillanti e ineccepibili
2 Loraux, N. (a cura di) La Grecia al femminile, Roma-Bari, Laterza, 1993.
3 Loraux, N. Linvention dAthnes. Histoire de loraison funbre dans la cit classique, Paris, Payot,
1993
2
[1981].
4 Loraux, N. Les Enfants dAthna cit.
5 Loraux, N. Les Expriences de Tirsias. Le fminin et lhomme grec, Paris, Gallimard, 1989 (trad. it. di
Guidobaldi, M.P.; Botteri, P. Il femminile e luomo greco, Roma-Bari, Laterza, 1991).
6 Loraux, N. La Cit divise. Loubli dans la mmoire dAthnes, Payot, 1997 (trad. it. di Marchesoni,
S. La citt divisa, Vicenza, Neri Pozza, 2006).
7 Loraux, N. La Tragdie dAthnes. La politique entre lombre et lutopie, Paris, Seuil, 2005.
8 Vd., ad esempio, sul dio Ares, Loraux, N. La Cit divise cit., pp. 26-35, 121-145, ma anche Ead.,
Le corps vulnrable dArs, in Le Temps de la Rfexion, n. 7, 1986, pp. 350-354.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 80 03/05/2013 11:11:11
81
Introduzione
analisi sulla citoyennet e sulla costruzione della polis, sullidea di autoctonia e sulle-
sclusione inclusa della donna e del femminile, si alimentano dellampia prospettiva
storico-antropologica da cui la Loraux ha guardato al mondo greco antico e alla cit-
t in particolare, spaziando dallorazione funebre allacropoli comica, dalla tragedia
allimmaginario mitico-religioso.
Da un analogo tentativo di variet di prospettiva, le autrici dei contributi qui
presenti guardano al tema generale di questo panel ed entrano in risonanza con
lopera di Nicole Loraux.
Ida Brancaccio si interessa al personaggio di Medea, una delle memorabili
rappresentazioni del femminile della tragedia attica che i tragediograf ateniesi
hanno messo in scena. Un esempio tra tutti, attraverso cui Euripide esplora le
contraddizioni della condizione femminile e la posizione problematica della don-
na nella citt degli uomini. La peculiarit di Medea consiste essenzialmente nel
suo essere diversa: straniera, barbara, depositaria di saperi antichissimi e lontani
dalla cultura greca, espressione di unalterit spesso rappresentata come modello
negativo. il nomos greco, dunque, che riconosce e condanna la hybris di Medea.
La sua hybris genera nel nomos degli altri paura e ostilit, al punto da rendere
dif cile la comprensione del suo codice di valori, che viene soltanto intravisto
nella forma del deinos.
Il travestimento intersessuale in ambito rituale e dunque linversione dei ge-
neri, il tema che afronta Anna Chiaiese analizzando in particolare la festa argiva
degli Hybristika, che porta nel nome stesso il legame con la hybris. Il rito presen-
te nella festa, caratterizzato da un signifcativo e temporaneo rovesciamento dei
ruoli, mostra una singolare pratica di travestimento intersessuale, la cui indagine
appare rilevante soprattutto in unottica di genere. Emerge infatti, sia a livello di
signifcante sia a livello di signifcato, una peculiare caratterizzazione del ma-
schile e del femminile, la cui portata stata segnalata da Nicole Loraux.
Marcella Maresca si specifcamente interessata al rapporto tra hybris e nomos,
a partire dallo studio di Nick Fisher. Nel suo contributo rifette su questo tema, e
sul femminile che a esso si collega, a partire dalla commedia e da quellosservatorio
suggestivo che sono i nomi parlanti dei personaggi femminili evocati sulla scena
teatrale. Secondo la tesi di Nick Fisher del 1992
9
, che identifca la hybris con un
atto di oltraggio fnalizzato allumiliazione, la Lisistrata di Aristofane costituisce
un interessante e paradossale caso di hybris al femminile: disobbedendo al proprio
ruolo tradizionale e oltrepassando i limiti domestici, le donne di Atene ristabili-
scono la pace con Sparta e assicurano il bene comune. Diversamente, seguendo
9 Fisher, N. Hybris: A study in the Values of Honour and Shame in Ancient Greece, Warminster, Aris &
Phillips, 1992.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 81 03/05/2013 11:11:11
82
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
la prospettiva di Nicole Loraux, la hybris, in questo caso, pu costituire uno stru-
mento di manifestazione della propria virt e della propria identit, a patto che
trovi presto i suoi limiti e resti puramente metaforica.
Quando si parla del ruolo della donna nella societ antica, il modello di riferi-
mento, anche perch meglio documentato, quello oferto dalla citt di Atene. Ma
in quella costellazione di citt che la Grecia antica, esistono anche altre realt sto-
riche: cosa pensare, ad esempio, di Sparta, dove da tradizione non spartana si sa che
le fanciulle ricevevano uneducazione ginnica? Le diferenze signifcative nelleduca-
zione femminile, tra Sparta e Atene, sottendono una diferenza sostanziale nellim-
magine della donna e del suo ruolo nella societ? Sono appunto gli interrogativi
che si pone Maria Luisa Napolitano. Il suo studio prende spunto dalle osservazioni
di Nicole Loraux relative al lessico antico sulle irruzioni femminili nellemergenza
militare della polis, tradizionale appannaggio maschile. Le qualifche femminili di
thrasyts e di thorybos enfatizzano le valenze negative del contributo politico delle
donne, tra le quali risaltano le Spartane. A partire dalla prospettiva ideologica ate-
niese, attraverso lesame dei testi antichi e della storiografa successiva alla Loraux, ci
vengono proposte alcune rifessioni sulle diferenti ottiche storiografche attraverso
cui la realt femminile spartana, specifcamente delle parthenoi, viene rielaborata e
riproposta in forma ideologizzata dalla rifessione maschile.
Al centro del saggio di Maria Letizia Pelosi troviamo unanalisi del rapporto
tra pubblico e privato, tra oikos e polis quale si confgura nel pensiero di Hannah
Arendt. Questultimo pu essere confrontato con la diversa prospettiva adottata
sul medesimo tema da Nicole Loraux, anche in merito alla relazione dialettica tra
maschile e femminile. Nella flosofa pitagorica le donne non sono solo laltro
dalla vita pubblica, ma partecipano al comune modello educativo e cosmologico.
La separazione tra oikos e polis come condizione indispensabile per la realizzazio-
ne della libert politica, che la Arendt aveva preso in esame nella sua opera Te
Human Condition
10
, non teneva conto delle relazioni prepolitiche allinterno
dellorganizzazione domestica, pur considerandole alla base della vita nella polis.
In una prospettiva di genere, invece, quale quella inaugurata dagli studi di Nicole
Loraux e come emerge dalle testimonianze delle donne pitagoriche, loikos non
solo lambito della produzione e della riproduzione naturali, ma soprattutto un
aspetto fondamentale delle rappresentazioni e delle forme del politico in Grecia.
Ventanni fa, Nicole Loraux si chiedeva in un celebre articolo Che cos una
dea?
11
. La relazione problematica tra femminile umano e divino al femminile, che
10 Arendt, H. Te Human Condition, Chicago, University of Chicago, 1958 (tr. it di Finzi, S. Vita
Activa. La condizione umana, Milano, Bompiani, 1997
4
).
11 Loraux, N. Che cos una dea?, in Duby, G.; Perrot, M. (ed.), Storia delle donne. LAntichit (a
cura di Schmitt Pantel, P.), Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 13-55.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 82 03/05/2013 11:11:11
83
Introduzione
la studiosa francese ha messo in evidenza, ancora oggi una delle piste di ricer-
ca che si ofrono alla rifessione per tentare di rispondere a questa fondamentale
domanda: il saggio di Gabriella Pironti si muove appunto in questa direzione.
Lo studio delle societ antiche ha compiuto signifcativi progressi integrando la
prospettiva di genere; i dcalages tra piano umano e rappresentazione del divino
potrebbero rivelarsi strumenti euristici altrettanto signifcativi per indagare la pe-
culiare fsionomia delle de e degli di del pantheon ellenico.
Il presente panel ofre una sintesi delle relazioni presentate dalle autrici al V
Congresso della SIS, Nuove frontiere per la storia di genere, tenutosi a Napoli nel
Gennaio 2010; in quelloccasione, hanno partecipato al dibattito sui rapporti tra
storia antica e studi di genere Pauline Schmitt Pantel e Violaine Sebillotte Cu-
chet
12
, studiose francesi particolarmente rappresentative di questo flone di studi,
che hanno condiviso con le relatrici la loro conoscenza approfondita di Nicole
Loraux e della sua opera. Ringraziamo Pauline Schmitt Pantel per aver contribuito
alla pubblicazione degli atti con un suo saggio. Lanalisi che la celebre storica fran-
cese ofre ai lettori in questa sede riguarda una serie di racconti in cui fanciulli e
fanciulle subiscono violenze analoghe a opera di cittadini potenti: limmagine che
la polis ofre di s in questi testi apparentemente sconcertante, in quanto le au-
torit civiche si mostrano protettive nei confronti dei cittadini colpevoli e indife-
renti alle vittime della hybris, siano esse ragazze o ragazzi. Nello studio delle societ
antiche la relazione maschile/femminile, e quella tra hybris e nomos, sono dunque
indissociabili da classifcazioni essenziali come quelle che oppongono ladulto al
fanciullo e, soprattutto, il cittadino al non cittadino. In questa prospettiva, una
nuova frontiera per la storia di genere applicata al mondo antico potrebbe essere
rappresentata proprio dalla sua capacit di interagire in maniera sempre pi ef -
cace con altri metodi di analisi, tenendo nella dovuta considerazione la specifcit
dei contesti storici, al di l di ogni generalizzazione.
12 Per il proflo di Pauline Schmitt Pantel, cfr. la presentazione delle autrici; tra le opere di Violaine
Sebillotte Cuchet ricordiamo Librez la patrie. Patriotisme et politique en Grce ancienne, Paris, Belin,
2006; Sebillotte Cuchet, V.; Ernoult, N. (a cura di) Problmes du genre en Grce ancienne, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2007.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 83 03/05/2013 11:11:11
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 84 03/05/2013 11:11:11
1. La hybris di Medea e il nomos degli altri
Ida Brancaccio
Prima ancora che Euripide scrivesse la sua Medea, la forza interiore, le contraddi-
zioni, la potenza espressiva di questo personaggio erano gi profondamente difuse
e radicate nellimmaginario collettivo della cultura greca. Il racconto mitico che
la vede protagonista infatti risale alla storia pi antica della Grecia, afondando le
proprie radici in ambienti geografci e cronologici assai remoti: Iolco, la Colchide,
il golfo di Pagase, Corinto, Atene.
Medea per personaggio peculiare non solo perch appartiene a livelli cro-
nologici antichi, ma soprattutto per il suo essere diversa: perch straniera, bar-
bara, perch depositaria di saperi antichissimi, perch espressione di unalterit
costantemente in antitesi con la cultura ellenica, che la considera un modello
negativo. Medea una straniera, oltre che una donna che eccede nella sua arrogan-
za, ma questo agli occhi dei Greci. Lalterit di Medea quindi non si esprime in
termini assoluti, ma secondo il punto di vista di chi si rivolge a Medea: il nomos
greco che riconosce e condanna la hybris di Medea.
Gli stessi sentimenti che Medea genera nellaltro sono di paura e ostilit.
La sua condotta, il codice di valori a cui si richiama, risultano dif cili da com-
prendere agli occhi della polis. Diventa colpevole, ma la sua colpa non mai
resa in maniera univoca, cos come il valore della negativit che emana non mai
espresso in termini defniti. Medea simbolo di esclusione perch non accettata
dalla polis e dalle sue regole. Questo evidente soprattutto nella tradizione tragica,
fondamentale strumento di rappresentazione delle contraddizioni sociali, in cui
forte il riferimento alla dinamica politica ma anche a valori morali ancestrali che,
seppure nel tempo hanno cambiato forma, restano sempre legati a un sentimento
vivo rispetto al politico, al femminile, allesclusione.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 85 03/05/2013 11:11:11
86
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
Il racconto del mito di Medea utilizzato da Euripide nel 431 a.C. , ancora una
volta, tentativo di rifessione da parte del poeta sulle contraddizioni sociali vissute
in quegli anni dagli Ateniesi. La traiettoria Colchide-Atene, seguita da Medea, fa
intravedere limmagine che la societ poliade ha di se stessa in opposizione allim-
magine dellaltro, situato fuori dallo spazio della cultura ellenica. Nel V a.C. Medea
si presenta donna, barbara, in opposizione alle norme sociali, almeno in apparenza.
Ella la barbara che Giasone ha portato con s a Corinto e che ora ha abbandonato
per sposare la fglia del sovrano della citt
13
, una donna abituata a comandare per
condizione sociale, perch di stirpe reale (fglia di re), e proprio per rispetto del rango
sociale e per lorgoglio della propria origine rifuta con fermezza di subire oltraggio
da parte dei nemici cos come di assecondare soluzioni di comodo
14
.
Medea simbolo di alterit per pi di un motivo. donna, ma anche barba-
ra
15
e apolis
16
. Completamente fuori dal tessuto civico. Una senza patria che ha rot-
to violentemente ogni legame con la famiglia dorigine e la terra natia, e per questo
diventa estremamente vulnerabile
17
. Le modalit del matrimonio (distrugge loikos
dorigine, non ha un kyrios ma ratifca lei stessa il patto matrimoniale
18
), la col-
locano sullo stesso piano delluomo e non a livello subordinato, confermando il
suo essere donna virile. consapevole della sua posizione e quando si rivolge al
Coro, le donne di Corinto, evita di accomunare la sua situazione alla loro: essendo
straniera sa di non poter contare sui vantaggi che derivano dal vivere in patria, non
fosse altro che lappoggio dei parenti, il sostegno della famiglia
19
.
Pi volte infatti nella tragedia si sottolinea la dissociazione fra Medea e la polis
in cui si trova a vivere, con cui non pu rapportare la propria esistenza o richiama-
re alla mente il proprio vissuto. Consapevolezza lucida a cui fa eco il Coro quando
con forza chiede di non essere mai privato della propria polis
20
, come se la condi-
zione di apolide dovesse essere associata a uno stato di amchania, incapacit di
afrontare e risolvere i propri problemi, diventando il male peggiore per qualsiasi
individuo
21
. Medea vive in una citt straniera, dove si sente fuori posto, estranea.
Tuttavia si crea con le donne di Corinto un legame, una simpatia, che proviene
13 Di Benedetto, V. Euripide: teatro e societ, Torino, Einaudi, 1971, p. 31.
14 Euripide (Eur.), Med., 119-121.
15 Ivi, 238-240; 591-592; 655-657; 1329-1332.
16 Ivi, 255.
17 Ivi, 31-33; 166-167; 328;431-438; 402-503; 506-508.
18 Martina, A. Identit eroica e identit femminile della Medea di Euripide, in Uglione, R. (a cura
di) Atti delle giornate di studio su Medea (Torino 23-24 ottobre 1995), Torino, Celid, 1997, pp. 20-21.
19 Eur., Med., 252-258.
20 Ivi, 643-651.
21 Di Benedetto, V. Introduzione, in Euripide, Medea, Troiane, Baccanti, Milano, Rizzoli, 2000
(1982), p. 10.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 86 03/05/2013 11:11:12
87
1. La hybris di Medea e il nomos degli altri
da una solidariet che va al di l del dato politico e corrisponde allindividuazione
di una fascia pi profonda della realt che dichiara il proprio rifuto verso una
societ in cui luomo ad avere tutti i diritti e tutte le libert
22
. Il comportamento
di Giasone sempre condannato
23
( detto kakonymphos, il cattivo sposo
24
). Si
tratta di una solidariet che arriva a negare la validit dellassociazione del concet-
to di mondo greco con valori etici fondamentali quali il rispetto dei giuramenti e
il pudore (aids) e che va al di l della contrapposizione di greci e barbari come
termine positivo contrapposto al termine negativo in cui la Grecia rappresenta la
civilizzazione, lordine, la legge e Medea il disordine del barbaro
25
.
In questo ordine di idee si spiega il fatto che nella Medea compaiano del-
le teorizzazioni sulla donna
26
in quanto tale che, nella loro novit, non trovano
precedenti nella tragedia greca. Medea rifette sulla sua situazione secondo una
prospettiva pi ampia e non puramente soggettiva. Le dif colt in cui si trova ca-
ratterizzano il sesso femminile. Quando parla alle donne corinzie quello che dice
non riguarda solo la sua esperienza personale, ma rifette il sentire e le consuetudi-
ni di una societ maschilista. Le donne sono costrette a comprarsi un padrone del
proprio corpo (despots somatos)
27
, rischiando di legare la propria vita a un uomo
indegno, malvagio, da cui lunico riparo la morte
28
. la dimensione femminile
a essere messa in evidenza e lindividuazione di una identit sociale che si pone ed
esiste di per s, di fronte alla quale tende a porsi fuori campo anche un dato cos
importante per la societ antica quale quello della polis.
La novit del modo di porsi di Medea di fronte alla questione femminile resa
esplicita dal richiamo polemico a concezioni tradizionali, come quella della donna
che se ne sta a casa garantendosi una sicurezza di cui invece non godono gli uomini
che afrontano i rischi della guerra. Tale diferenziazione viene presentata da Medea
in termini di assenza e presenza di rischio, contrapponendo al rischio delluomo in
guerra quello della donna durante il parto, confronto quanto mai provocatorio
29
. Il
Coro in perfetta sintonia con Medea quando rivede il rapporto uomo/donna da un
nuovo punto di osservazione, non pi maschile ma proprio delle donne. Limmagi-
ne metaforica dello stravolgimento dellordinario corso dei fumi per cui le correnti
tornano allindietro, vuole rendere lidea di una realt che sembra rovesciarsi rispetto
22 Eur. Med., 179-180; 1236.
23 Ivi, 85-88; 205-206; 228-229; 514-515; 578; 690; 991-995.
24 Ivi, 206.
25 Moreau, A. Le mythe de Jason et Mede. La va-nu-pied et la sorcire, Paris, Les Belles Lettres, 1994,
p.272.
26 Eur. Med., 230-251.
27 Ivi, 233.
28 Ivi, 230-243.
29 Ivi, 247-250.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 87 03/05/2013 11:11:12
88
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
alle comuni credenze sociali: gli uomini sono spergiuri (Giasone) mentre le donne
meritevoli di gloria (Medea), perch rispettose dei vincoli di fedelt
30
.
Maschile e femminile sono in una prospettiva totalmente nuova rispetto alla
cultura greca tradizionale. Le esigenze istituzionali in relazione alla prosecuzione
della famiglia, alla conservazione dei beni ereditari, alla trasmissione di padre in
fglio del patrimonio culturale, non sono pi al centro dellattenzione. La novit
della tragedia che le donne protagoniste (Medea, il coro, la nutrice) sono lontane
dalla cultura precedente, sollecitandone una nuova: in esse gioca un ruolo essen-
ziale la consapevolezza di una dimensione esclusivamente femminile, in contrap-
posizione al mondo degli uomini
31
.
Il confronto con il maschile avviene, nella tragedia, negli incontri con Gia-
sone, Creonte ed Egeo. Nei dialoghi tra Giasone e Medea
32
luomo mette ben in
evidenza la netta contrapposizione tra parole e fatti, tra i discorsi pronunciati da
Medea e i reali rapporti di forza, dai quali ella uscir sconftta. Se anche Medea
continuasse a ripetere che Giasone il peggiore degli uomini, ci non le giove-
rebbe perch comunque subirebbe lesilio. La replica di Medea durissima: lo
accusa di mistifcare e alterare la realt. Lo scontro dialettico tra Medea e Giasone,
che evidenzia la contrapposizione tra logos e realt, rende, dal punto di vista di
Giasone, lantitesi tra logos come espressione del risentimento di Medea nei suoi
confronti e la consapevolezza dei rapporti di forza esistenti. Per Medea invece il
logos larte di parlare bene, strumento retorico dei sofsti, che si contrappone
alla realt dei fatti che non pu essere modifcata
33
.
Al centro del discorso di Giasone vi un messaggio fondamentale: trasferen-
dosi in Grecia Medea stata largamente ricompensata dellaiuto che gli ha fornito
in Colchide
34
, sottolineando che la decisione di sposare la fglia di Creonte torna
utile anche a lei e ai suoi fgli
35
. A ci si contrappone la testimonianza di Medea:
solo grazie al suo aiuto Giasone entrato in possesso del vello doro e la spedizione
degli Argonauti andata a buon fne, permettendo il ritorno degli eroi in Grecia.
Gloria e fama di Giasone provengono da Medea
36
. Medea dunque benefattrice e
come tale deve essere trattata, da philos e non da echthros
37
. Pur considerando una
grande ricompensa lessere stata condotta da una terra barbara in Grecia, laddove
30 Ivi, 410-420.
31 Di Benedetto, V. Introduzione cit., p. 15.
32 Eur., Med., 446-626; 866-100; 1293-1414.
33 Ivi, 579-587; 798-802.
34 Ivi, 534-541.
35 Ivi, 559-565.
36 Ivi, 475-485.
37 Ivi, 95.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 88 03/05/2013 11:11:12
89
1. La hybris di Medea e il nomos degli altri
per Grecia deve leggersi la terra della giustizia, del diritto e delluso delle leggi,
della santit dei giuramenti, il greco Giasone si comportato da echthros, perch
ha violato proprio i valori che sono alla base dei giuramenti che ha tradito, ha
infranto la retta norma. Giasone anomos
38
nella misura in cui lamore saggio e
virtuoso non ricerca altre unioni al di l di quelle legittime
39
.
evidente la nota critica che Euripide insinua nel pubblico, esortandolo a ri-
fettere: losservanza dei giuramenti e la lealt che contraddistinguono i Greci e che
per bocca di Giasone si contrappongono ai barbari rozzi e violenti risultano nei fatti
essere qualit proprie dei non Greci (Medea), nella misura in cui proprio Giasone,
fglio dellEllade, espressione della pi alta civilt, si comporta da traditore.
Creonte
40
dif dente e teme Medea, tanto pi che la leggendaria sophia
41
che
le viene attribuita corrisponde alla conoscenza di arti magiche, pericolose per s
e per sua fglia. Al contrario Egeo
42
nutre profondo rispetto per le qualit sovran-
naturali della donna, ponendola al di sopra del livello medio degli uomini e ap-
prezzando proprio quella sapienza tanto temuta da Creonte. Fra i due si instaura
un rapporto di sintonia: egli comprende Medea, e parimenti compreso da lei.
Si rende subito conto di quanto sia oltraggioso il comportamento di Giasone nei
suoi confronti e non esita a giurarle fedelt
43
.
Ci che risulta chiaro che prima del tradimento di Giasone il comporta-
mento di Medea doveva essere irreprensibile: tutto lascia pensare che non avrebbe
voluto niente di pi che essere una buona moglie e una buona madre. Medea si
caratterizza per coraggio, lealt e devozione. La sua natura appassionata, il suo
grande intelletto lavevano aiutata a ricoprire il ruolo di madre e moglie, e quindi
di perfetta cittadina di Corinto
44
. Qualsiasi scatto dira, latente nella sua passio-
nale personalit, diventato manifesto solo in seguito alla gravissima provocazione
messa in atto da suo marito e supportata dallo Stato. una denuncia forte contro
le autorit del Paese che lha accolta, che arriva a minare gli stessi fondamenti della
societ
45
. Non pi brava moglie, perch non accetta di sottostare ai desideri
delluomo, si oppone alla norma ordinaria, che avalla da parte del marito la pos-
sibilit di ripudiare la moglie, e segue un proprio, personale nomos. A quel punto
38 Ivi, 1000.
39 Di Benedetto, V. Introduzione cit., p. 9.
40 Eur., Med., 271-356.
41 Ivi, 298-304; 384-386.
42 Ivi, 663-758.
43 Ivi, 746-753.
44 Ivi, 14-16; 222-224.
45 Moreau, Le mythe cit., p. 197.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 89 03/05/2013 11:11:12
90
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
la condotta di vita di Medea non pi riconosciuta dalla citt di Creonte e di
Giasone, perch non aderisce allordine civico stabilito.
Medea aveva fatto delloikos del marito il centro della propria vita, creando
legami di sangue attraverso la generazione di fgli, lasciandosi dietro distruzione
e morte. Essere allontanata dalloikos a cui aveva dedicato tutta se stessa rompe
ogni equilibrio, determinando linsurrezione e la fuoriuscita dalle regole civili.
Pur consapevole di essere vincolata alla marginalit, diventa minaccia per la polis
e lo status quo vigente, determinando una rottura dellordine sociale, politico e
religioso, perch elemento destabilizzante: decide di cancellare loikos del marito
con luccisione dei fgli e di Glauce, colei che potrebbe assicurare a Giasone una
continuit biologica, sociale e religiosa
46
.
Lo scontro tra uomini e donne nella tragedia attica si comprende alla luce di
confitti antropologici fondamentali delluniverso tragico: quello tra citt (polis) e
gruppo familiare (oikos), il primo prodotto dalla societ maschile in quanto fonda-
trice di regole civili, il secondo appannaggio delluniverso femminile ancorato allo
spessore dei legami di sangue: ancora una volta irrompe la dialettica tra cultura
(nomos) e natura (physis). In questa prospettiva Medea, barbara fra Greci, mette
in discussione lordine greco e la civilizzazione fondata sulla supremazia degli uo-
mini
47
, incarnando temi che tendono a sfuggire ai codici maschili e che tuttavia
urgono sotto lordine e le leggi degli uomini, interferendo pesantemente con il si-
stema culturale della citt, con le sue regole di autocontrollo e i suoi ideali di bene
collettivo. Agli occhi dei Greci (Giasone, Creonte) Medea eccede in arroganza, e
pecca quindi di hybris, rispetto ai ruoli sociali: Medea hybrizn perch, in quanto
donna, non ha diritto di parola e non dovrebbe pretendere quanto invece ritiene
sia suo di diritto (marito, fgli, casa), e perch, in quanto barbara, non potrebbe
far altro che essere grata di vivere fra Greci. La verit che Medea non pu avere
la presunzione di esistere: una donna, per giunta straniera, in un contesto dove
il non-greco normalmente avvertito come qualcosa di estraneo, al tessuto sociale
e al sistema di valori tipicamente greci. Disobbedendo al ruolo tradizionale impo-
stole dalla societ e superando i confni domestici, ella rompe il silenzio e d voce
al dissenso. Ma il suo dissenso privo di diritti.
Medea donna e barbara vive la sua vicenda tragica in un impressionante iso-
lamento e tuttavia mette in discussione la stabilit e la natura delloikos, uno dei
principali punti di riferimento del pensiero ellenico e fondamento della stessa
polis. La polis, secondo il messaggio di Euripide quindi, doveva elaborare unetica
alternativa e solo lintegrit eroica di una donna barbara rendeva quanto mai forte
il confronto con la societ.
46 Martina, Identit eroica cit., p. 25.
47 Moreau, Le mythe cit., p. 276.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 90 03/05/2013 11:11:12
2. Le Hybristika di Argo: un caso di
travestimento intersessuale
Anna Chiaiese
Le Hybristika sono delle feste della citt di Argo, il cui rito centrale consiste in uno
scambio di vesti tra uomini e donne. Plutarco, la cui fonte lo storico Socrate di
Argo, datato da Jacoby al periodo ellenistico
48
, narra che Telesilla
49
, giovane no-
bile argiva, purtroppo inferma, recuper la salute e acquist la fama presso i suoi
concittadini, dopo aver accondisceso alle indicazioni delloracolo di una dea, iden-
tifcata con Afrodite
50
, che la invitava a dedicarsi alla poesia. Fu Telesilla, secondo
Plutarco, a guidare la resistenza armata delle donne che, imbracciate le armi e
postesi sui bastioni, difesero Argo dallattacco degli Spartani, che avevano gi ster-
minato lintero contingente dei soldati argivi in un tremendo scontro, identifcato
con la rotta di Sepeia, datata dai pi al 494 a.C. Alla fne della battaglia, mentre le
morte furono seppellite lungo la via argiva, alle vive fu concesso di innalzare una
statua a enialio.
48 Cfr. lintroduzione di Boulogne, J. (a cura di) Plutarque. Oeuvres Morales. Tome IV, Paris, Les Belles
Lettres, 2002, pp. 3-4. Plutarco, De mulierum virtutibus, 245 c-f (= Socrate di Argo, 310 F 6 Jacoby).
Polieno, Stratagemata VIII 33, riassume Plutarco. Cfr. Stadter, P.A. Plutarchs historical methods. An
analysis of the Mulierum Virtutes, Cambridge, Harvard UP, 1965, pp. 17-19.
49 Cfr. Clemente Alessandrino, Stromata, IV 19.
50 Si segue ledizione de Les Belles Lettres, la pi accreditata e coerente col contesto cultuale descritto
in seguito, che riporta il femminile t; Jacoby e la Teubner, diversamente, accolgono la correzione in
t di Bachet de Mziriac, sebbene sia vs omnes codices.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 91 03/05/2013 11:11:12
92
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
Di Telesilla parla anche Pausania
51
, introducendola con la descrizione di una stele
nel tempio dAfrodite
52
ad Argo, che la raf gura nel duplice aspetto assegnatole
dalla tradizione di poetessa (i libri gettati ai suoi piedi) e guerriera (lelmo che si ac-
cinge a indossare)
53
. Anche secondo Pausania, pur collocando sulle mura schiavi,
giovani e vecchi, furono le donne a combattere, con armi sottratte dalle case o dai
templi, e da sole riuscirono ad aver presto la meglio su Spartani decisi a non lot-
tare con avversarie cos fuori dal comune. Questo fu, a suo dire, il compimento di
un antico oracolo delfco, profetizzante una vittoria della femmina sul maschio e
riportato da Erodoto (VI 77-83), che laveva per diversamente interpretato come
un semplice avvertimento agli Argivi a guardarsi da una qualche furberia spartana.
Plutarco termina cos il suo racconto:
Dicono che la battaglia sia avvenuta allinizio del mese, oggi quarto, anticamen-
te (detto) Ermaio dagli Argivi, alcuni il settimo giorno, altri il primo, durante
il quale ancora oggi celebrano le Hybristika, vestendo le donne con chitoni e
clamidi maschili, gli uomini con pepli e veli femminili. Per sanare la penuria di
uomini, unirono in matrimonio le donne non, come riporta Erodoto, agli schia-
vi, ma, dopo averli resi cittadini, ai migliori tra i perieci. Ritengono anche che
li trattassero con disprezzo e trascurassero di dormirci insieme, quasi che fossero
inferiori. Donde posero una legge che ordinava che le mogli, portando una barba,
dovessero dormire con gli uomini.
Erodoto, che aveva parlato dei nuovi cittadini come ex-douloi (schiavi)
54
, vie-
ne qui smentito: lo storico, del resto, non cita Telesilla n collega questevento ad
alcuna festa.
Tornando a Plutarco, si noter subito che le armi delle sue Argive non sono
di fortuna, n il loro comportamento quello che generalmente la tradizione
attribuisce alle donne in guerra, quando queste, con armi improprie, irrompono
sulla scena virile del confitto, avvolte dal thorybos, creando scompiglio. Telesilla
dispone soldati, pianifca movimenti, elabora strategie: la sua non unirruzione
51 Pausania, II 20, 8-10, da cui dipende Suda, s.v. Telesilla.
52 Musti, D.; Torelli, M. (a cura di) Pausania. Guida della Grecia II, Milano, Mondadori, 1986, p.
279, note 68-73. Cfr. inoltre Pirenne-Delforge, V. LAphrodite grecque, Kernos suppl. 4, Athnes-
Lige, CIERGA, 1994, pp.153-170 e Pironti, G. Entre ciel et guerre. Figures dAphrodite en Grce
ancinne, Kernos suppl. 18, Lige, CIERGA, 2007, p. 262, n. 271.
53 Cfr. di Tiro, M. Dissertationes, XXXVII 5.
54 Cfr. Aristotele, Politica, 1302b33-1304a14 e Diodoro X 26. Per una bibliografa di riferimento,
cfr. Bearzot, C, I douloi/perioikoi di Argo. Per una riconsiderazione della tradizione letteraria, in
Lincidenza dellantico, n. 3, 2005, pp. 61-82.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 92 03/05/2013 11:11:12
93
2. Le Hybristika di Argo: un caso di travestimento intersessuale
disordinata e confusa nella mischia. Tuttaltro. Ne prova lapparato bellico di
queste guerriere, in una logica dice la Loraux che quella della leggenda
55
,
laddove, per Vidal-Naquet, Erodoto descriverebbe col suo oracolo un mondo ca-
povolto, in cui le donne prevalgono e gli schiavi comandano
56
.
Secondo una logica di rovesciamento non in efetti strano che donne che
abbiano vestito hopla virili e combattuto come andres, di questi acquisiscano an-
che i culti specifci
57
, arrivando persino a esperire la bella morte: il seppellimento
lungo la via argiva rappresenta la consacrazione alla memoria e alla gloria
58
, il rico-
noscimento di una morte maschile. Su unaltra via argiva (forse sulla stessa?), Pau-
sania (II 24, 2) ci dice che furono seppellite le teste che le fglie di Danao avevano
spiccato dai corpi dei mariti e inviato al padre. Del resto, se la statua di Telesilla
si trova nel tempio di Afrodite, altro segno del culto della dea nella citt uno
xoanon, che la rappresenta nel suo aspetto di Nikephoros, dedicatole, pare, proprio
dalla danaide Ipermnestra (II 19, 6). Quanto allonore concesso alle sopravvissute
dinnalzare una statua a Enialio, vi si riferisce probabilmente lo Pseudo Luciano
(Amori, 30), quando ci dice che ad Argo, Ares tenuto in conto dalle donne
(Ares, in origine distinto da Enialio, con questo spesso confuso).
Nel doppio tempio fuori delle mura, in cui venivano congiuntamente adora-
ti
59
, la statua di Afrodite si trovava nella cella a Est, rivolta in direzione della citt;
quella di Ares, nella cella a Ovest, in direzione dellArcadia
60
.
La festa si svolge il primo del mese, giorno di luna nuova. Il mese Ermaio (di
Ermes, dio liminale per eccellenza
61
, onorato ad Argo proprio insieme ad Afrodite)
coincide con lattico Gamelione
62
, ovvero col nostro gennaio (o con un periodo tra
gennaio e febbraio)
63
. Il tempo del rito, dunque, pare essere linverno, la stagione
ideale per i riti di passaggio, non ultimo il matrimonio
64
. La festa ha il suo momento
55 Loraux, N. Les xperiences de Tirsias. Le fminin et lhomme grec, Paris, Gallimard, 1989, tr.it. di
Guidobaldi, M.P. Il femminile e luomo greco, Roma-Bari, Laterza, 1991, p. 258.
56 Vidal-Naquet, P. Le chasseur noir, Paris, Maspro, 1981, tr.it. di Sircana, F. Il cacciatore nero, Mi-
lano, Feltrinelli, 2006, pp. 229-231.
57 Cfr. Graf, F. Women, War, and Warlike Divinities, in Zeitschrift fr Papyrologie und Epigraphik,
n. 55, 1984, pp. 245-254 e Pausania, VIII 48, 4-6.
58 Loraux, N. Il femminile cit., p. 256.
59 Pausania, II 25, 1.
60 Cfr. Pirenne-Delforge, LAphrodite cit., p. 167 sgg.
61 Pausania, II 19, 6. Cfr. Graf, Women cit., p. 250.
62 Halliday, W.R. A note on Herodotus VI 83 and the Hybristik, in Annual of British School at
Athens, n. 16 1909-1910, pp. 212-219.
63 Graf, Women cit., p. 250 nota 35.
64 Aristotele, Politica, VII 1335a 35 sgg e Gernet, L. Anthropologie de la Grce antique, Paris, Ma-
spro, 1968, tr.it. di Rocchini, A. Antropologia della Grecia Antica, Milano, Mondadori, 1983, p. 31.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 93 03/05/2013 11:11:12
94
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
centrale nello scambio di vesti tra andres e gynaikes, due termini che specifcano
lindividuazione e le relazioni tra i cittadini di pieno diritto e le mogli (o madri)
legittime di questi, comunit delle donne cui concesso, seppur in un contesto di
eccezionalit, parodia o paradosso, fare irruzione sulla scena maschile. Per esclusio-
ne, sono questi i soggetti normalmente aventi diritto a generare una prole legittima
65
e, dunque, ad attuare linversione dei generi, creando uno scarto tra signifcante
66
(labito
67
, il genere)
e signifcato (il sesso). Chitoni e clamidi, pepli e veli (i capi
dabbigliamento oggetto del travestimento intersessuale descritto) si trovano qui
in posizione simmetrica e di contrasto: chitoni e pepli identifcano, in modo diretto
ed essenziale, i due generi, come per unintuitiva metafora. Clamidi e veli, invece,
sembrano evocare piuttosto il compiuto raggiungimento dello status di adulti.
Dal racconto plutarcheo apprendiamo che, in riferimento ai matrimoni mi-
sti
68
, le donne, ostentando hybris, rifutarono gli sposi. Di qui la necessit di un
nomos che stabilisse che dormissero coi mariti e lo facessero indossando una barba,
altra metafora dellaner, non meno del chitone e della clamide
69
.
Dif cilmente potremmo conciliare in un quadro storicamente coerente le
diverse notizie che questa fonte riporta. A ben guardare, infatti, ci troviamo di
fronte a un aition posto a motivazione di tre fatti diversi: una statua dedicata a
Enialio dalle donne, il rito delle Hybristika, lapplicazione di una barba posticcia
alla sposa, in connessione alla cerimonia nuziale. Il racconto di Telesilla e delle
donne guerriere, posto a eziologia del tutto, consente di assemblare in ununica
narrazione tre pratiche rito-cultuali del tutto distinte. Mentre la dedica di una
statua ad (Ares) Enialio da parte delle donne trova omologhi in altre tradizioni
(vedi nota 27), nel caso dellapplicazione della barba posticcia ci troviamo chiara-
mente dinanzi a un rituale dinversione connesso alliniziazione allet adulta e al
matrimonio (di cui nota la primitiva simultaneit), laddove, con le Hybristika,
abbiamo piuttosto a che fare con un rito di passaggio dal carattere carnevalesco,
che marca una dimensione di momentaneo caos e sovvertimento, organizzato at-
traverso il rito, in vista della riafermazione di un nuovo ordine.
65 Cfr. Loraux, N. Sur la race des femmes et quelques-unes de ses tribus, in Arethusa, n. 11, 1-2,
1978, pp. 43-87.
66 Cfr. Ead., Il femminile cit., pp. XII e 130. Cfr. Erodoto, I, 105 e IV 67 e Delcourt, M. Hermaphro-
dite, Paris, Presses Universitaires de France, 1958, pp. 160-161.
67 Cfr. Gernet, Antropologia cit., pp. 166-167.
68 Non tutti i codici riportano lultimo periodo: cfr. Aulotte, R. Amyot et Plutarque. La tradition des
Moralia au XVI sicle, Genve, Droz, 1965, p. 256.
69 Ad Atene solo efebi ed efeminati sembrano aver fatto a meno della barba ed era del resto proprio
la comparsa dei peli a sancire la fne del ruolo di eromenos nei rapporti omoerotici: cfr. Stratone in
Antologia Palatina, XII 10, 12 e 220.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 94 03/05/2013 11:11:12
95
2. Le Hybristika di Argo: un caso di travestimento intersessuale
Il racconto plutarcheo ci presenta questi tre dati come interconnessi luno
allaltro e tutti e tre allaition, ma Pausania non si riferisce a nessuno dei tre, il
che raforza lidea che Plutarco (o la sua fonte, Socrate di Argo) abbia utilmente e
coerentemente raggruppato azioni aventi un comune denominatore nel principio
dinversione (e scambio di genere) che le caratterizza e forse nelle divinit referenti
di queste pratiche: Ares, dio caro alle donne, che si fanno guerriere e gli dedicano
una statua, padre delle Amazzoni e signore della guerra, monopolio degli andres;
e Afrodite, per omerica memoria inadatta alla guerra
70
, ma qui compagna di Ares,
della cui natura e potere partecipa
71
, dea vicina alla mischia e al vigore e a cui
sono cari i travestimenti (e che non disdegna dindossare la barba)
72
, che presiede
ugualmente alla lotta amorosa e alle opere belliche.
Nelle Hybristika di Argo, attraverso lo scambio simmetrico delle vesti e lin-
versione dei generi, operata tramite un travestimento intersessuale, la cittadi-
nanza drammatizzava la partecipazione della sfera maschile a quella femminile e
viceversa, sottolineando allo stesso tempo il carattere temporaneo di questa parti-
colare licenza (hybris). La hybris nefasta, tradizionalmente associata a conseguenze
esiziali, diviene allora, nella narrazione, pi quella delle ritrose spose che quella di
Telesilla e del suo extra-ordinario esercito.
Nellaition e nel rito il capovolgimento di ruoli attuato dalle guerriere, bene-
fco e necessario, marcato da un regime di separazione sessuale, in cui le don-
ne agiscono da sole in spazi tradizionalmente maschili, rifutando gli uomini o
escludendoli: cos nel mito delle Lemnie e delle Danaidi
73
, nella leggenda di Mar-
pessa
74
di Tegea e in quella delle Argive di Telesilla (nella fctio narrativa, le soprav-
vissute allassedio sono le stesse che poi respingono gli sposi-perieci, simulando
una ritrosia e unostilit presto contenute dalla riafermazione della normalit)
75
.
70 Iliade, V, 426-430.
71 Cfr. Vernant, J.P. Le mariage en Grece archaque, in La Parola del Passato, n. 28, 1973, pp. 51-79,
ed. it. in Mito cit., p. 79.
72 Cfr. il gi citato Filocoro Fr. 184, in Macrobio, Saturnalia, III 8 2.
73 Cfr. Dumzil, G. Le Crime des Lemniennes. Rites et lgendes du monde gen, Paris, Geuthner, 1924,
tr.it. di Nappi, M.P. Riti e leggende del mondo egeo, Palermo, Sellerio, 2005, p. 35 sgg.
74 Marpessa di Tegea, detta Choira (scrofa), organizza con le donne della sua citt, fattesi guerriere,
un agguato ai danni degli Spartani, che assediavano la citt, mentre i cittadini tegeati (maschi) ten-
tavano senza successo di respingerli. Riportata una straordinaria vittoria (grazie alla quale i Tegeati
riuscirono a fare tra i nemici molti prigionieri, compreso il re Carillo), le donne, che da sole avevano
vinto, fecero un sacrifcio ad Ares senza gli uomini e ugualmente li esclusero dal banchetto sacrif-
cale. Per questo nellagora di Tegea vi una stele dedicata ad Ares Gynaiokothoinas (che festeggia a
banchetto le donne): cfr. Pausania VIII 48, 4-5.
75 Cfr. Gernet, L.; Boulanger, A. La gnie grec dans la religion, Paris, La Renaissance du Livre, 1932,
pp. 52-53.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 95 03/05/2013 11:11:12
96
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
Il montaggio plutarcheo non quindi privo di coesione testuale: il capitolo
sulle donne di Argo, iniziato allinsegna della hybris e della guerra, si chiude sotto
il dominio del nomos e della concordia.
La cronologia dissuade dallattribuire credibilit allintervento della poetessa
Telesilla e problematico risulta esprimersi anche sulla natura e lautenticit dello-
racolo. Dopo Sepeia, le Argive sposarono i migliori tra i perieci (i douloi ero-
dotei), elementi comunque estranei alla cittadinanza e successivamente in essa
integrati, sebbene ci sfugga a prezzo di quali confitti interni
76
. Il ricordo lontano
della scampata rovina e loracolo erodoteo, insieme a un episodio analogo avvenu-
to in et ellenistica
77
, potrebbero aver agito da suggestione in modo che fonti locali
collegassero questaition al rito.
Naturalmente, la straordinariet delle circostanze che consente la hybris
femminile, quella positiva delle guerriere e quella esecrabile e subito contenuta
delle neo spose che, rifutando i coniugi e dunque la procreazione
78
, mettono in
pericolo la riproduzione di quegli stessi andres che, uf cialmente, rappresentano
lunico presupposto necessario alla defnizione e allesistenza stessa della citt.
In unottica di genere, allora, ci che di questa tradizione sorprende soprat-
tutto la rappresentazione di un femminile che si appropria positivamente degli
attributi dellaner: qualora gli uomini, o perch assenti (Telesilla) o perch incapa-
ci (Marpessa), non possano proteggere la citt, essa trova (mitopoieticamente), in
quelle stesse donne che (storicamente) pone ai margini, un baluardo di sopravvi-
venza e continuit identitaria.
76 Cfr. Bearzot, C.; Landucci, F. Argo, una democrazia diversa, Milano, V&P, 2006.
77 Cfr. Pausania, I 13, 8 e Stadter, Plutarchs cit., p. 52.
78 La riproduzione implicito presupposto e fne del matrimonio: cfr. Loraux, Sur la race cit., p. 90,
n. 80; Vernant, Mito cit., p. 53.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 96 03/05/2013 11:11:12
3. Disonore, disobbedienza e disordine civile:
la hybris
79
di Lisistrata
Marcella Maresca
Lo studio dei rapporti tra maschile e femminile ad Atene si traduce spesso, nello-
pera di Nicole Loraux, nellanalisi delle modalit di partecipazione della donna
alle istituzioni politiche e rappresentative. La conclusione a cui si approda unica:
non esistono donne Ateniesi, ma solo donne di Ateniesi
80
.
La studiosa aveva gi messo in relazione questo dato con un altro: Aristofane
non fa mai uso dellaggettivo Athenaiai riferito a donne, nella sua produzione lette-
raria
81
. Linsieme di questi dati interpretato in chiave politica, alla luce della rigo-
rosa esclusione delle donne dalla vita politica e dal corpo civico in senso stretto, che
ne impedisce lidentifcazione con la nozione di cittadino. Scrive Nicole Loraux
82
:
Diversamente dalla donna corinzia o della spartana che hanno diritto al nome di
79 A proposito del termine hybris, occorre ricordare che la traduzione del termine tuttora oggetto di
dibattito tra gli studiosi. Ricordiamo la posizione di Louis Gernet in Recherches sur le dveloppement
de la pense juridique et morale en Grce, pref. di Eva Cantarella, Paris, Albin Michel, 2001
2
[1917]: lo
studioso francese ritiene che il termine hybris abbia subito dallet arcaica al IV secolo un signifcativo
mutamento, passando da ipostasi divina a principio soggettivo del delitto. Diversa la posizione di
Nick Fisher in Hybris: A study in the Values of Honour and Shame in Ancient Greece, Warminster, Aris
& Phillips, 1992: per lo studioso inglese la hybris coincide con un serio atto di oltraggio volto al diso-
nore altrui, e non ha connessioni dirette con la sfera del sacro. Nel mio studio ho seguito soprattutto
questa seconda interpretazione.
80 Loraux, N. Les enfants dAthna, Paris, Maspro,1981, pp. 124-132.
81 Loraux, N. Aristophane, les femmes dAthnes et le thtre, in Entretiens sur lantiquit classique,
XXXVIII, Vanduvres-Genve, 1993, pp. 217-219.
82 Loraux, N. Les enfants dAthna cit., p. 124.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 97 03/05/2013 11:11:12
98
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
Korinthia o di Lakaina
83
, le donne di Atene sono caratterizzate anzitutto dal pro-
prio rapporto di appartenenza a un cittadino attraverso il matrimonio legittimo.
lo stesso uso linguistico osserva la studiosa francese
84
a testimoniarci questa
esclusione sostanziale della donna: il lessico Suda, sotto la voce Athenaias, ci riferisce
che le donne di Atene sono piuttosto denominate Attikas, per evitare lomonimia
con la divinit poliade, e cita pochissime eccezioni in proposito: Ferecrate, Cantaro,
Filemone
85
. Tali autori sono tutti noti per essere compositori attici di commedie:
fatta eccezione per il pi tardo Filemone, che datato tra IV e III secolo a. C., tutti
gli altri sono attivi in pieno V secolo a.C.. Il grammatico Frinico, che defnisce non
attico questo uso improprio dellaggettivo, identifcabile con latticista del III secolo.
Il punto centrale del mio studio losservazione delle condizioni che, in una
prospettiva strettamente letteraria e connessa al meccanismo comico del rovescia-
mento, consentono ai comici citati dalla Suda di riferire laggettivo Athenaiai a
donne. In questo senso mi servir di un modello interpretativo conforme al pro-
cedere di Nicole Loraux: posto che la virt della donna si manifesta innanzitutto
attraverso la trasgressione dellordine stabilito dei valori e ancora che oltrepas-
sando i limiti imposti al proprio sesso, e solo in questo modo, che una donna la-
scia un nome nella memoria degli uomini
86
, afermiamo che la donna che merita
lappellativo di Athenaia da parte dei comici, la donna-cittadino ateniese in
realt una donna-quasi uomo (Lisistrata, che il prototipo di questo popolo di
donne, salutata dal coro come andreiotat
87
ovvero donna virile
88
e questa
sua aret, cio virt, che le consente di distinguersi dalle altre, coincide con un
atto di hybris
89
). Tre volte, nel corso della commedia, il seguito di Lisistrata viene
accusato, rispettivamente, dal coro dei vecchi
90
e dal proboulos
91
per i ripetuti atti
di hybris compiuti a danno dei cittadini maschi.
83 Cfr. Erodoto, Storie, III, 134.
84 Cfr. Loraux, N. Aristophane, les femmes dAthnes et le thtre cit., p. 218, nota 34.
85 In un altro punto della stessa voce, la Suda cita a tal proposito Diflo, che nellAmastris defnisce la
fglia di Temistocle la straniera Ateniese (cfr. Diflo, CAF vol. II, fr. 10 Kock) e gli scoli di Pindaro,
che per ho escluso dalla mia trattazione perch richiedono approfondimenti distinti.
86 Loraux, N. (a cura di) Grecia al femminile, Roma-Bari, Laterza,1993, pp. XXIII-XXIV.
87 Aristofane, Lisistrata,1108.
88 Guido Paduano traduce anche vera donna (cfr. Aristofane, Lisistrata, Milano, BUR, 2007
[1981], v. 1108)
89 Sulla hybris di Lisistrata, cfr. Fisher, Hybris cit., p. 118: lo studioso inglese aferma che disobbedire
o peggio tentare di dominare i propri mariti costituisce un serio atto di hybris. Lo stesso Fisher se-
gnala, ibidem, nota 230 lopera di Nicole Loraux (Aristophane, les femmes dAthnes et le thtre cit.).
90 Ar. Lys., 399, 658.
91 Ar. Lys, 425. I probouloi sono magistrati straordinari introdotti ad Atene a seguito della spedizione
in Sicilia.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 98 03/05/2013 11:11:12
99
3. Disonore, disobbedienza e disordine civile: la hybris di Lisistrata
Nel percorrere, sulla scia di Nicole Loraux, il flo della connessione tra citta-
dinanza femminile e hybris
92
, torniamo ai passi dei comici nominati dalla Suda.
Ferecrate, anzitutto, autore di una commedia, La Tirannide
93
, in cui viene svi-
luppato il tema di unimprobabile quanto oltraggiosa
94
gestione statale da parte
delle donne. Sulla base di questi elementi lecito ipotizzare che lutilizzo dellag-
gettivo Ateniese riferito a donne e alle loro alleate
95
trovi una sua coerenza entro
lo stesso meccanismo comico del paradosso, sviluppato in unopera diversa.
Cantaro e Filemone stringono notevolmente, rispetto a Ferecrate, il numero
di soggetti cui laggettivo pu riferirsi. Il primo ricorre allespressione greca che
sintetizza il modello della virt eroica maschile, declinata, per, al femminile:
kaln kai agathn, nel senso di eccellente; il secondo ricorre allindicazione di un
numero preciso di individui concreti: Ateniesi possono chiamarsi solo le Ipponi-
ca, le Lisistrata e le Nausinica
96
. Si tratta di nomi attestati al maschile
97
, meno
nella loro versione femminile; Ipponica presente in uniscrizione
98
di carattere
sepolcrale privato, rinvenuta a Egina vicino a unedicola; Nausinica nominata
solo in unopera di Plutarco
99
, mentre il nome Lisistrata, a parte nellomonima
opera aristofanea, presente in uniscrizione su un monumento marmoreo attico
di IV secolo
100
, rinvenuto sullEgialeo, monte prospiciente Salamina.
Certo che la documentazione in materia di donne nel mondo antico sem-
pre troppo esigua per poter garantire la certezza di ogni statistica. Tentiamo, tutta-
via, di superare questa aporia ammettendo che Filemone abbia intenzionalmente
92 Anche Varrone ci testimonia delluso attico di non nominare le donne con lappellativo di Ateniesi,
riconducendo laition a una votazione, avvenuta al tempo di Cecrope:cfr. Agostino, La citt di Dio, 18,
9; e inoltre, sul carattere civilizzatore della politica di Cecrope, cfr. Scholia in Ar. Pluto,773.
93 Cfr. lintroduzione di Massimo Vetta a Aristofane, Le donne allassemblea, Milano, Lorenzo Valla,
2000 [1989], p. XVII.
94 Il carattere oltraggioso del comando delle donne sugli uomini signifcativamente espresso da
Democrito (Dem., fr. 111 Diels-Kranz): essere dominato da una donna rappresenta (per un uomo)
un oltraggio (hybris) estremo e una mancanza di virilit (anandri). Da notare lutilizzo di questo
secondo termine.
95 A tal proposito, cfr. Ferecrate, CAF vol. I, fr. 34 Kock, dove leditore commenta: versus fortasse ex
precationis publicae parodia petitus est.
96 A tal proposito cfr. Filemone, CAF vol. II, fr. 65 Kock. Tradurrei anche quelle sul modello di
Ipponica, Nausinica e Lisistrata.
97 Disponiamo, infatti, di attestazioni in testi letterari: cfr. Pape, W.; Benseler, G.E. Wterbuch der Gri-
echischen Eigennamen, Akademische Druck- u.Verlagsanstalt, Graz 1959 [1850], p. 566 (Ipponikos),
pp. 832-833 (Lisistrato), p. 980 (Nausinikos). Cfr. le stesse pagine per le rispettive forme femminili.
98 Inscriptiones Graecae, IV, 101-105.
99 Plutarco, Sulla malignit di Erodoto, 39.
100 Supplementum Epigraphicum Graecum, XXIV 256.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 99 03/05/2013 11:11:12
100
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
fatto riferimento a nomi femminili che un pubblico di spettatori avrebbe facil-
mente identifcato con precise fgure dellimmaginario comico-letterario, e non a
nomi comuni. Daltra parte, i lessici onomastici rivelano che non si tratta afatto
di nomi difusi tra le donne greche. Si tratta di nomi parlanti: le vincitrici a ca-
vallo, le scioglitrici deserciti, le vincitrici sulle navi sono donne che danno
corpo a virt esemplari che si esplicano in ambiti strettamente maschili come lo
sport e larte della guerra. Nella parabasi della Lisistrata il coro di vecchi defnisce
hybris latteggiamento della donna e subito dopo enumera le nefaste conseguenze a
cui lostinazione femminile pu portare, se le si concede il minimo appiglio: Co-
struiranno navi, vorranno combattere per mare e darci addosso come Artemisia.
Se poi si mettono a cavalcare, la fne dei cavalieri [] Guarda le Amazzoni
101
.
Tre sono i punti enumerati dal coro di vecchi: la hybris femminile, che ten-
ta con loccupazione dellAcropoli di sciogliere gli eserciti, potrebbe osare anche
battaglie navali e scontri a cavallo; imprese incredibili e paradossali gi ricordate
implicitamente nella triade onomastica segnalata da Filemone, come riportato dalla
Suda. Ipponica, Nausinica e Lisistrata sono dunque donne speciali, perch sono
andreiotatai e, al contempo, hybristai; sono donne eccellenti perch vicine a un
modello maschile, come le Amazzoni
102
, creature mitiche il cui modello sotteso
nelloccupazione dellAcropoli da parte delle donne aristofanee. Le Amazzoni sono,
in qualche modo, il corrispondente mitico, larchetipo presente nel nome Ipponica
di cui parla Filemone. Alle Amazzoni af ancato anche un altro personaggio fem-
minile, ben noto al pubblico ateniese per la sua eccezionalit: Artemisia.
Erodoto ascrive Artemisia alla categoria dei thmata (fatti eccezionali, pro-
digiosi): donna guerriera e consigliera, a capo di cinque navi durante le Guerre
persiane, schierata al fanco di Serse, coraggiosa e celebre per la sua mtis (stra-
tegia astuta). La vicenda di Artemisia rientra in unottica di rovesciamento dei
ruoli reciproci di uomini e donne: in questo senso va letta anche lafermazione di
Serse
103
che commenta la strategia di Artemisia durante la battaglia di Salamina
esclamando che gli uomini sono diventati donne, e le donne uomini. Allincirca
nella stessa chiave vanno lette e interpretate anche la notizia di Marco Giunano
Giustino
104
nel compendio da lui redatto delle Storie Filippiche di Pompeo Trogo
che, a proposito di Artemisia, scrive che come in un uomo si sarebbe potuto
scorgere timore muliebre, cos in una donna appariva una virile audacia. Non
101 Ar. Lys., 673-680.
102 Cfr. a tal proposito: Hdt., IV,110-117; Strabone, XI, 5,1-4; Diodoro, III, 53-55.
103 Hdt., VIII,8, 8,3; cfr. in tal proposito Visconti, A. Artemisia di Alicarnasso ovvero il potere in-
visibile, in Marino, S.; Montepaone, C.; Tortorelli Ghidini, M. (a cura di) Il potere invisibile. Figure
del femminile tra mito e storia, Napoli, Filema, 2002, pp. 63-75.
104 Marco Giunano Giustino, II, 12, 23-24.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 100 03/05/2013 11:11:12
101
3. Disonore, disobbedienza e disordine civile: la hybris di Lisistrata
diversamente, Polieno
105
riferisce che Serse consegn ad Artemisia unarmatura
e al navarco della spedizione fuso e conocchia, a marcare questo rovesciamento
simmetrico dei ruoli dei sessi in una contingenza eccezionale come quella della
guerra contro i Greci.
Artemisia, insomma, sarebbe larchetipo storico, lalter ego presente nel nome
Nausinica. Nel trattato di Plutarco Sulla malignit di Erodoto, la confutazione del
racconto su Artemisia (Hdt., VIII, 68) precede immediatamente lunica menzione
del nome Nausinica
106
, una delle fglie di Adimanto, generale corinzio impegnato
nella battaglia di Salamina. Plutarco, confutando le afermazioni di Erodoto
107
,
nota che egli (Adimanto) non avrebbe osato chiamare una delle sue fglie Nau-
sinica se la sua condotta di allora non gli fosse valsa una certa reputazione e un
certo lustro: Nausinica, infatti, vuol dire vittoria sulle navi: Plutarco dunque ne
riconosce il valore di nome parlante. Le due iscrizioni a cui ho fatto riferimento
108
,
inoltre, sono entrambe collocate in regioni interessate dalla battaglia di Salamina:
Egina, infatti, a pi riprese presentata da Erodoto come protagonista valorosa
della lotta antipersiana
109
, ed da Egina che giunge Aristide, ateniese ostraciz-
zato. Il monte Egialeo, inoltre, il punto di osservazione delle manovre militari
della fotta assunto da Serse, a seguito delloccupazione dellAttica. Si pu perci
avanzare lipotesi che si tratti di nomi femminili a valore storico-commemorativo
(come Nausinica) e legate alle vicende della Seconda Guerra Persiana.
Sappiamo quanto Aristofane faccia uso di nomi parlanti
110
per alludere al
ruolo che i personaggi assumono sulla scena: ci accade verosimilmente anche per
Nausinica e per Ipponica. Dunque Ipponica, Lisistrata e Nausinica sono versioni
femminili di corrispondenti maschili
111
e risponderebbero a un tipo preciso, quello
della donna andreiotat che si sostituisce alluomo debole e inetto, dando luogo a
una versione rovesciata della realt. Si tratta di personaggi costruiti secondo precisi
fni letterari e dunque immaginari e non storici forse Nausinica e Ipponica sono
le protagoniste di qualche opera letteraria ben presenti almeno agli occhi del
pubblico del terzo secolo avanti Cristo, quando scrive Filemone che, utilizzando
laggettivo Ateniese in relazione a donne, lo fa soltanto riferendosi a maschere di
donne virili. Ateniesi possono dirsi, in sostanza, solo donne eccezionali: donne
105 Polieno, VIII, 53, 2.
106 Plut., Sulla malignit di Erodoto, 39, 871.
107 Cfr. Hdt, VIII, 5 e VIII, 94. Erodoto riferisce che il valore di Adimanto fu oggetto di grandi
discussioni tra gli Ateniesi e i Corinzi.
108 Cfr. supra nota 25 e 27.
109 Hdt., VIII, 86; VIII, 91; VIII, 93.
110 Macdonald Cornford, F. Lorigine della commedia attica, Lecce, Argo, 2007, p. 48.
111 Cfr. supra nota 17.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 101 03/05/2013 11:11:12
102
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
quasi-uomini che, come Lisistrata, appartengono al mondo fttizio dellarte e della
rappresentazione letteraria, in modo che la loro trasgressione rispetto al tradizio-
nale quadro di valori resti sostanzialmente lontana da ogni concretezza storica.
Nicole Loraux, prendendo in considerazione la voce del lessico Suda, diretta-
mente o indirettamente
112
, se ne serve per la rappresentazione dellacropole comi-
que. Suo testo di riferimento Lisistrata, la commedia che per eccellenza mostra,
entro il meccanismo retorico del rovesciamento, le conseguenze paradossali cui
conduce la disobbedienza femminile al nomos (ordine dei valori stabiliti): la hybris
delle donne di Atene funge da principio di disordine civile e disorganicit politica.
Questa motivo (hybris femminile-disordine) condizione sovvertita soltanto nella
rappresentazione letteraria: qui la hybris femminile cifra dellaret del personag-
gio. Attraverso uno sguardo approfondito che intreccia personaggi femminili e
testi distanti tra loro, ma accumunati da questa corrispondenza, questa chiave di
lettura della voce Athenaias del lessico Suda ci consente di riafermare la prospet-
tiva della studiosa francese sulla rappresentazione del femminile come alterit,
attraverso i meccanismi retorici che sono propri della deformazione comica e del
rovesciamento.
112 Cfr., rispettivamente, Loraux, N. Aristophane, les femmes dAthnes et le thtre cit. p.217-218,
nota 34, e Ead., Les enfants dAthna cit. p. 125. In questultimo caso Nicole Loraux non fa esplici-
tamente riferimento alla Suda, ma parla di glossatori antichi, riferendo la notizia dellomonimia
con la dea Atena.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 102 03/05/2013 11:11:12
4. Parthenoi e controllo sociale nella
prospettiva di genere: il caso delle Spartane
Maria Luisa Napolitano
Queste rifessioni si riallacciano a un mio flone di studi per molti versi ispirato
dalle osservazioni di Nicole Loraux
113
sullanomalia rappresentata dalla realt fem-
minile spartana agli occhi degli altri Greci: una sorta di hybris, una trasgressione
dif cilmente tollerabile perch indebita appropriazione di spazi e ruoli non fem-
minili. Luomo greco non riconosce alla donna ci che egli le ha usurpato e da cui
lha esclusa: limpulso allazione negli spazi civici, al potere, alla difesa armata della
citt, elementi che emergono comunque, ma come dati non agevolmente stori-
cizzabili e da esorcizzare, cos da consentire in defnitiva la riafermazione della
volont di dominio maschile. Al di l delle apparenze, e in mancanza di una voce
propriamente spartana, losservazione valida anche per le donne di Sparta
114
. A
partire dalla prospettiva ateniese, propongo qui qualche considerazione sulle dif-
ferenti ottiche attraverso cui il percorso educativo delle ragazze laconiche, talora
indicato come esempio di libert o di licenza, viene rielaborato dalle rifessioni
maschili; pur nella variet delle formulazioni non si intravedono reali prospettive
di eguaglianza tra i sessi.
noto che a Sparta leducazione delle parthenoi veniva curata dallo stato
come per i coetanei maschi e si fondava sullesercizio fsico obbligatorio (i gymna-
113 Loraux, N. Les expriences de Tirsias. Le fminin et lhomme grec, Paris, Gallimard, 1989, tr.it. di
Guidobaldi, M.P. Il femminile e luomo greco, Roma-Bari, Laterza, 1991, e particolarmente: Il letto,
la guerra, pp. 5-29; La bella morte spartiata, pp. 53-67; Ponos. Considerazioni su pnos come nome del
travaglio, pp. 30-47; La natura femminile nella storia, pp. 249-275.
114 Sullargomento vd. Pomeroy, S.B. Spartan Women, New York, Oxford UP, 2002.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 103 03/05/2013 11:11:12
104
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
sia) nelle palestre, con fnalit eugenetica; listituzione si faceva risalire a Licurgo.
Un unicum in Grecia, che scandalizzava molti Ateniesi anche perch comportava
ladozione di una prospettiva femminile rovesciata: dal chiuso delle pareti dome-
stiche agli spazi aperti della polis e addirittura ai ginnasi, altrove solo maschili e
connessi alle pratiche degli agoni e alla guerra. Le Spartane non erano come le
altre. Scrive la Loraux: nella parthenos [spartana] la futura sposa che si allena, la
procreatrice di cittadini per sopportare il parto come loplita sopporta lassalto
del nemico. Cos il fne delladdestramento femminile, irrigidito nel mirage, in
una con la propaganda della maternit come procreazione di forti opliti ovvero
di robuste fattrici, riduce di molto la prospettiva di liberazione e di autonomia
accolta talora come chiave interpretativa del fenomeno. Neppure in tale paideia si
prevedono addestramenti femminili con fnalit militari, un campo di importanza
vitale per la polis che a Sparta come altrove in Grecia resta monopolio maschile.
Il letto, la guerra; ma lantinomia, al di l forse delle intenzionalit e nello
stesso immaginario maschile, svela il suo fondo di ambivalenza, nella simultaneit
del richiamo, anche linguistico, alla generazione-procreazione e alla guerra; indi-
zio di un sostanziale accoglimento nel maschile del femminile, indispensabile alla
comunit nel suo rigenerarsi; per la donna, un potere virtualmente enorme, che si
vuole riassorbito o circoscritto e normalizzato, ammesso per quanto lo consente la
sua uf ciale esclusione dal politico maschile. Anche ad Atene e non solo a Sparta
una precisa distinzione funeraria apparentava in onore civico le donne morte di
parto al cittadino morto in guerra. Tuttavia ad Atene e non a Sparta che le don-
ne, per dirla con Cicerone
115
, mollissimo cultu parietum umbris occuluntur, ivi
educate e trattenute, nel loro essere civico in tutto sottoposte allautorit maschile.
Le peculiarit della paideia ginnica delle Lacedemoni, unitamente allesenzio-
ne dalla tessitura occupazione delloikos assegnata, a Sparta, alle ilote
116
, e pro-
babilmente allaf do dei neonati a nutrici specializzate
117
, imponeva nellantichit
il confronto tra i due modelli, ugualmente greci. Cos lepisodio del 369 a.C., in
cui allattacco tebano dellinviolato territorio lacedemone le Spartane reagisco-
no con inconsulto spavento, forse con terrore, atteggiamento femminile altrove
ricadente nellordinario, provoca in Atene il disorientamento dei flo-spartani
118
e ofre il fanco alle durissime accuse aristoteliche di thrasyts (laudacia come
parodia del coraggio), di confusione e disordine (il thorybos, connaturato alla-
115 Tuscolane II 36.
116 Senofonte, Costituzione degli Spartani I 4; Platone, Leggi. 806 A; Plutarco, Opere morali (Detti
degli Spartani) 241 D,9; permane una tessitura sacra per korai scelte dalla locale aristocrazia.
117 Plut., Licurgo 16,4.
118 Senofonte, Elleniche VI 5,27-28; Plut., Agesilao, 31, 33.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 104 03/05/2013 11:11:12
105
4. Parthenoi e controllo sociale nella prospettiva di genere: il caso delle Spartane
zione femminile
119
), di lassismo, anarchia, elementi di danno per i combattenti
maschi pi dei nemici stessi
120
. Dallopposto versante, Platone, nipote del flo-
lacone Crizia, estimatore come lo zio della realt spartana, contemporaneo di Se-
nofonte e in parte del pi giovane Aristotele, propone per le istituzioni laconiche
femminili correzioni estreme: militarizzare i ginnasi equiparandoli agli addestra-
menti maschili salvo riservare al combattimento femminile le armi leggere
121
,
dal momento che [le Spartane] non prendono parte alla guerra. E neppure se
si producesse una qualche fortuita necessit di combattere per lo stato e per i fgli
esse sarebbero in grado di praticare con arte larco [] n le altre armi da getto
[] per resistere nobilmente alla rovina della patria
122
.
La singolarit spartana provoca cos la rifessione di per s, per ripensare o pre-
servare limiti e caratteri della ripartizione civica maschile/femminile. Pi tardi Plu-
tarco
123
elencher le esercitazioni licurghee delle parthenoi in forma pi dettagliata
della sua fonte senofontea e con analogo rilievo alla fnalit procreativa
124
: corsa,
lotta, lancio del disco e del giavellotto, questultimo di possibile impiego in un ar-
mamento leggero quale quello prescritto da Platone. E a conclusione, un inedito
proposito educativo
125
: (af nch), se ve ne fosse necessit, esse siano in grado di
combattere per s, i fgli e la patria. Una innovazione con il tono di una replica:
dalleducazione impartita le Spartane acquisiscono anche le competenze per com-
battere, che per non esercitano, implicitamente, per riguardo alla ripartizione isti-
tuzionale dei ruoli, opliti e madri, guerra e parto. Daltronde, nel successivo episodio
riabilitativo dellattacco di Pirro alla loro citt (273/2 a.C.)
126
, pur collaborando con
i combattenti, esse lasciano ai soli maschi il compito della difesa militare, porgendo
loro le armi e incitandoli secondo i dettami della belle mort. Sono gli andres il ba-
stione possente della citt, scriveva Alceo
127
; cos anche a Sparta.
In un noto passo dallAndromaca
128
, lateniese Euripide esprime la sua con-
danna dei ginnasi femminili di Sparta. Avversata dalla spartana Ermione, sua riva-
le e legittima moglie di Neottolemo, Andromaca difesa da Peleo che disapprova
119 Loraux, N. Il femminile cit., pp. 267-270, 349-350.
120 Aristotele, Politica 1269a-1270.
121 Plat., Leg. 804 C-E.
122 Plat., Leg. 806 A-B.
123 Plut., Lic. 14,3.
124 Sen., Cost. Sp. I 4:di corsa e di lotta.
125 Lespressione aggiunta a concludere Plut., Mor. (Detti degli Sp.) 227D, 12, passo per il resto in
tutto analogo a Lic. 14,3.
126 Plut., Pirro 26-29; Polieno, VIII 49; Trogo-Giustino, XXIV 4, 1, 6-8.
127 Alceo, fr. 112,10 Liberman.
128 Euripide, Andromaca 597-600.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 105 03/05/2013 11:11:12
106
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
duramente le consuetudini educative delle Lacedemoni, categoria cui Ermione
appartiene. Lattacco si volge alleducazione, allabbigliamento succinto (con le
gambe nude e le vesti sciolte), alle corse e alle palestre delle ragazze spartane,
in comune con i maschi, usanza intollerabile e causa dellabbandono femmi-
nile degli spazi domestici; limputazione di immoralit. La critica dal versante
ateniese si sostanzia di ulteriori elementi: le vesti provocanti, adatte alla palestra,
e la koinonia con i coetanei maschi negli allenamenti, dispregiativamente intesa
come mescolanza sessuale e perci mancante di sophrosyn. Essa tuttavia non risul-
ta nella documentazione flo-spartana e anzi parrebbe il contrario, dal momento
che le trattazioni delle due paideiai si presentano costantemente separate. certo
possibile limpiego di strutture analoghe per lallenamento e inoltre, in particolari
festivit cittadine, i giovani maschi potevano osservare e incontrare le parthenoi,
nude o in vesti succinte, intente ad attivit agonali connesse alle classi det; ri-
volgendosi ai ragazzi presenti, esse li esaltavano o li deridevano. Di tali occasioni
di contatto Plutarco
129
defnisce le fnalit: parormtika pros gamon. La riprovazio-
ne ateniese della condotta di vita delle giovani spartane poggia, dunque, anche
sullamplifcazione di un elemento peculiare del loro sistema educativo, gli agoni
pro-matrimoniali, proiettato sullintera istituzione ginnica da respingere, pena la
crisi del modello femminile alternativo.
A favore dei ginnasi delle Lacedemoni si esprimevano per ad Atene e per
Atene conservatori come loligarca Crizia
130
e il cavaliere Senofonte
131
, entrambi
autori di opere sulla costituzione degli Spartani. Dalla generazione alleducazione
fsica e al regime di vita, con Crizia si indica lesercizio ginnico anche per la donna
incinta, ovviamente con fnalit eugenetica. Non libert incontrollata n immora-
lit, ma intransigenza e un fne preciso nellinteresse non privato ma della prole,
e dunque dello stato. la replica degli ambienti flo-laconici e oligarchici, dai
risvolti politici, tanto pi che Crizia tenta lattuazione nellAtene dei Trenta di un
regime di marca laconizzante. Per Senofonte, di contro allo stile di vita delle ragaz-
ze ioniche, con nutrizione scarsa, vita sedentaria e segregata, connessa dif colt a
ben procreare, Licurgo aveva imposto alle Spartane alimentazione e addestramenti
pari a quelli maschili, con obiettivo la teknopoia. Anche qui, regola e non licenza
per un fne programmato dallo Stato che nullifca ogni personalismo. La teoriz-
zazione che presiede a tali afermazioni prevede dalla madre e non solo dal padre
un apporto determinante alla buona generazione, in quanto entrambi, con il loro
regime di vita, improntano di s la prole.
129 Plut., Lic. 15,1.
130 Crizia, fr. 32 Battegazzore-Untersteiner apud Clemente Alessandrino, Miscellanea VI 9.
131 Sen., Cost. Sp. I 1-4.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 106 03/05/2013 11:11:12
107
4. Parthenoi e controllo sociale nella prospettiva di genere: il caso delle Spartane
Nel confronto con le formulazioni greche sulla generazione, risalta per contra-
sto la posizione di Aristotele, per il quale il genere femminile, pi lento e inattivo
per natura, necessita di minor quantit di cibo. La sede naturale della donna, fragile
e piagnucolosa, un luogo dove ella pu vivere oziosa e immobile
132
, con leccezione
di un moto moderato per le gravide
133
che, se eccessivo, comporterebbe rischi per i
maschi, i feti pi preziosi
134
. Il contributo femminile alla procreazione produce pura
corporeit per il nascituro, mentre lintervento maschile assicura vitalit e anima
135
.
Il maschio reca i principi della generazione, suo il calore corporeo e il secco,
femminile il freddo e lumido
136
; lui portatore di forma, lei generatrice di materia.
Le posizioni aristoteliche rappresentano una sorta di irrigidimento della pi
antica tradizione ippocratica, nella quale il seme maschile si af ancava al femmi-
nile e il sesso del nascituro era determinato dalla casuale predominanza quantita-
tiva di uno dei due semi. La donna dunque poteva incidere sui caratteri sessuali
della prole
137
. Nel contempo per linferiorit femminile risultava dalla maggiore
gracilit e permeabilit ai liquidi; unico ponos il mestruo, un ponos domestico e
smaltito nellinattivit delloikos, a cui restava estraneo lesercizio fsico, prerogati-
va maschile. Nella letteratura ippocratica, dunque, si registra un pi attivo ruolo
femminile alla generazione che per non occulta il vincolo della donna allimmo-
bilit delloikos, pena la perdita della fecondit.
Nella documentazione presocratica si distingue per una sorta di flone pro-
gressista, con la concorrenza di entrambi i sessi alla procreazione (Anassagora,
Democrito, Alcmeone
138
, Empedocle, Parmenide
139
), sulla base del seme pi ab-
bondante che pu essere femminile (Alcmeone) o della sezione dellutero ove il
seme ricade, destra per linfuenza maschile sul feto, sinistra per quella femminile
(Empedocle). Parmenide pone in relazione il caldo con la madre, il freddo con il
132 Arist., Storia degli animali 608b, 8-15. Per le teorizzazioni antiche sulla generazione vd. Campese,
S.; Manuli, P.; Sissa, G. Madre materia, Torino, Boringhieri, 1983; Sissa, G. Platone, Aristotele e la
diferenza dei sessi in Schmitt Pantel, P. (a cura di) Storia delle donne. Lantichit, Roma-Bari, Laterza,
2000 (1990), pp. 58-100.
133 Arist., Pol. 1335b, 6-20.
134 Il rischio diminuisce per le femmine, meno mobili: Arist., Generazione degli animali 775a, 4-9,
31-40.
135 Arist., Gen. anim. 729a, 9-12, 22-33; 716a 4-8, 14-23; 727a, 26-30; 727b, 31-33; 732a, 7-11.
136 Arist., Gen. anim. 766b, 31-33; 775a, 15-16.
137 Corpus ippocratico: Generazione IV 1; V 1; VI 1-2; Malattie femminili I 8; VIII 34; Natura del
bambino XII 1-2.
138 Frr. 59A 107; 68A 141; 24A 13 e 14 Diels-Kranz. Democrito in Aristotele: Gen. anim. 704a,
36-38; 764a, 36-38.
139 Frr. 28A 54; 24A 13; 31A 81 Diels-Kranz.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 107 03/05/2013 11:11:12
108
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
padre, afermazioni riportate in Aristotele che ovviamente le avversa
140
. Per Anas-
sagora, nella suddivisione della cavit uterina il luogo determina il sesso (destra-
maschio; sinistra-femmina) con il seme pi abbondante; ed lutero materno che
plasma il nascituro determinandone le fattezze. Ancora, da Empedocle ricaviamo
la possibilit che il seme meno caldo sia quello del padre; in questo caso prevarr
lapporto materno. In particolare, la madre pu assegnare caratteri peculiari alla
prole con la phantasia, se attratta dalle sembianze di statue o di personaggi dipinti.
Questo ruolo materno pi dinamico con leventuale determinante apporto del
seme femminile alla genesis e con lutero che come uno stampo pu imprimere
caratteri sessuali e anche somatici alla prole, questa possibilit per la madre di
improntare di s il fglio la teorizzazione che meglio si confronta con la realt
spartana e con la sua ideologizzazione.
Nel riconoscimento del ruolo femminile, la prospettiva si conferma tuttavia
maschile: alluomo spettano la sezione destra dellutero e il calore, alla femmi-
na la sinistra e il freddo; pi freddo anche il seme di lei con cui tuttavia pu
condizionare la prole. Cos a Sparta lequivalenza maschile-femminile interna e
funzionale a una realt maschile che riconosce e valorizza lapporto della donna
alla procreazione in quanto la indirizza in vista della riproduzione di s. Da una
madre forte quanto un maschio allenato nei ginnasi nascono fgli sani e vigorosi o
potenziali madri robuste e prolifche, prole idonea ai ruoli civici futuri. N occulta
tutto questo laneddotica riservata soprattutto da Plutarco alle madri spartane
141
,
in cui il conclamato riconoscimento dellapporto generatore femminile si stempe-
ra nella sottrazione e nellallontanamento dei fgli da parte della citt, incoraggiati
ove non costretti a morire per lo Stato dalle stesse madri; una maternit, per cos
dire e a mio avviso, incompiuta.
Illusione, o mistifcazione, nellapophthegma plutarcheo dedicato a Gorgo,
moglie di Leonida
142
; a una donna attica che le aveva chiesto: Perch voi Lacede-
moni siete le sole a comandare agli uomini? la Spartana avrebbe risposto: Perch
siamo anche noi sole a generare uomini.
140 Arist., Parti degli animali 648a, 29-32; Gen. anim. 765b, 18-22.
141 Plut., Mor. (Detti Sp.) 240C-242C.
142 Plut., Mor. (Detti Sp.) 240 E,5. Su Gorgo vd. Paradiso, A. Gorgo, la Spartana, in Loraux, N. (a
cura di) Grecia al femminile, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 108-122.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 108 03/05/2013 11:11:12
5. La separazione tra oikos e polis in una
prospettiva di genere
Maria Letizia Pelosi
Nelle pagine di Vita activa dedicate allanalisi storica delle strutture politiche e
sociali, Hannah Arendt considera la separazione tra sfera pubblica e vita privata
il presupposto fondamentale di ogni forma di organizzazione politica. Secondo
Hannah Arendt la politica esprime la pluralit ovvero la natura intersoggettiva
della condizione umana. La pluralit si realizza quando gli uomini si riconoscono
reciprocamente e vivono e si muovono nel mondo consapevoli del loro essere
in relazione gli uni con gli altri. Solo nellambito pubblico gli uomini possono
svolgere attivit politicamente determinanti, poich alla luce degli altri il soggetto
politico parla, agisce, d inizio a qualcosa di nuovo.
Hannah Arendt ritiene la separazione tra spazio privato e spazio pubblico il
concetto cardine della polis classica. La polis, scrive lorganizzazione delle perso-
ne cos come scaturisce dal loro agire e parlare insieme [] lo spazio dellapparire,
nel pi vasto senso della parola: lo spazio dove appaio agli altri come gli altri
appaiono a me
143
. La citt-stato greca rappresenta per Hannah Arendt lesempio
storico della forma di organizzazione politica dove si realizza il vivere in presenza
di altri uomini; vivere insieme nella polis signifca manifestarsi sulla scena pubblica
e abbandonare, conseguentemente, la dimensione privata dellesistenza.
possibile riferirsi alla libert politica o al suo contrario solo rispetto allo spa-
zio pubblico del reciproco manifestarsi, e per incontrarsi i soggetti politici devono
essere liberi dalle necessit materiali della vita. La vita privata ha il suo centro nella
143 Arendt, H. Te Human Condition, Chicago, University of Chicago, 1958, tr. it di Finzi, S. Vita
Activa. La condizione umana, Milano, Bompiani, 1997
4
, p. 145.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 109 03/05/2013 11:11:12
110
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
casa e nella famiglia. In questa dimensione lessere umano naturalmente assog-
gettato alle necessit della vita produttiva e riproduttiva: necessit di procurarsi
il cibo, di curare il corpo, di conservarsi attraverso la generazione di altri indivi-
dui. I vincoli delle necessit e dei bisogni nella Grecia classica dominano la sfera
dellassociazione naturale delloikos e vengono abbandonati nella dimensione della
polis. Nella vita pubblica gli uomini si sono afrancati dalle necessit biologiche, e
possono vivere liberamente. Nella sfera domestica gli uomini vivono insieme per-
ch spinti dai bisogni e dalle necessit naturali, che determinano tutte le attivit
che hanno luogo nella comunit domestica. Il dominio della polis, la sfera della
libert, mentre la necessit scrive Hannah Arendt soprattutto un fenomeno
prepolitico caratteristico dellorganizzazione domestica privata
144
.
La separazione su cui si basa il pensiero politico dellantica Grecia, tra oikos
e polis, ricalca secondo Hannah Arendt la pi fondamentale distinzione tra cose
che sono per s e cose che devono la loro esistenza alluomo
145
. Si comprende
il senso di tale separazione nella risposta che nel 1963 Hannah Arendt d alle
critiche di Gershom Sholem in riferimento al libro La banalit del male. A propo-
sito del problema della resistenza degli ebrei e della debolezza dimostrata dai capi
ebraici Scholem le rimprovera di utilizzare un tono di insensibilit inappropria-
to a unebrea. Hannah Arendt risponde:
la verit che io non ho mai avuto la pretesa di essere qualcosa daltro o diversa
da quella che sono, n ho mai avuto la tentazione di esserlo. Sarebbe stato come
dire che ero un uomo e non una donna cio qualcosa di insensato. So, natu-
ralmente, che esiste un problema ebraico anche a questo livello, ma non mai
stato il mio problema nemmeno durante linfanzia. Ho sempre considerato la
mia ebraicit come uno di quei dati di fatto indiscutibili della mia vita, che non
ho mai desiderato cambiare o ripudiare. Esiste una sorta di gratitudine di fondo
per tutto ci che cos come ; per ci che stato dato e non , n potrebbe essere,
fatto; per le cose che sono physei e non nomi
146
.
In queste parole il confne tra dominio naturale e attivit umana talmente
netto da attraversare anche la sfera dellappartenenza storica e culturale. Unap-
partenenza ibrida per principio, poich individuale per nome e nascita (e non
per scelta) ma legata a un soggetto politico e comune (e non privato). Tale appar-
144 Ivi, p. 23.
145 Ivi, p. 13.
146 Ead., Te Jewish Writings, Jerome Kohn e Ron H. Feldman (a cura di) New York, Schocken
Books, 2007, tr.it. parz. di Giovanna Bettini, Ebraismo e modernit, Milano, Feltrinelli, 2003, p. 222
[n.d.r.: in corsivo nel testo].
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 110 03/05/2013 11:11:13
111
5. La separazione tra oikos e polis in una prospettiva di genere
tenenza diventa nel discorso di Hannah Arendt un puro dato pre-politico che,
per, pu avere conseguenze politiche. Lebraicit lidentit naturale pre-poli-
tica che pu condizionare la vita politica ma dalla quale rimane sostanzialmente
separata, proprio come loikos lo spazio separato dalla polis, senza il quale la polis
non potrebbe aver luogo. Dalle parole di Hannah Arendt essere ebrea ed essere
donna risultano dati pre-politici o naturali, estranei allo spazio politico, che si
caratterizza invece per il suo essere frutto dellagire umano.
La disamina della separazione tra oikos e polis ofre ad Hannah Arendt
loccasione per unanalisi critica dellet moderna, contraddistinta dalla scon-
fnamento della societ nella sfera pubblica e dalla conseguente perdita della
dimensione genuinamente politica delluomo: lemergere della societ dallo-
scuro interno della casa alla luce della sfera pubblica ha non solo confuso lan-
tica demarcazione tra il privato e il politico, ma ha anche modifcato, fno a
renderlo irriconoscibile, il signifcato dei due termini e la loro importanza per
la vita dellindividuo e del cittadino
147
. Dal momento in cui il comportamen-
to sociale prende il posto dellattivit politica, esso annulla limprevedibilit e
la novit, poich segue le regole della ripetizione e della standardizzazione. In
questo modo la sfera delle necessit naturali assume una valenza pubblica. Tale
il tratto che secondo Hannah Arendt rappresenta la societ di massa moderna,
diretta conseguenza dellesperienza totalitaria, dove non sono ammesse attivit
che non siano interamente prevedibili.
Sono state mosse diverse critiche alla lettura arendtiana della dinamica fuori/
dentro che caratterizza la polis, in particolare laddove la separazione tra priva-
to e pubblico esprime intrinsecamente il problema del rapporto tra maschile e
femminile. Il silenzio di Hannah Arendt sulla esclusione della vita privata dalla
sfera degli afari pubblici lascia in sospeso la domanda dov la donna? luogo
oscuro, privo e privato della luce dellincontro con gli altri, non solo inseparabile
dal concetto di polis, ma che lo presuppone. Il concetto del pensiero femminista
il personale politico che rimarca limportanza delle esperienza di vita delle
donne e dei loro rapporti con gli uomini non avrebbe per Hannah Arendt nes-
sun senso politico. Per questo la critica femminista ha ravvisato nella teoria poli-
tica arendtiana una legittimazione patriarcale dellidea di libert e una negazione
del potenziale femminile di liberazione oppure un ethos anti-democratico che
rende inaccettabile la sua visione politica per unidea di diritti politici realmente e
radicalmente universali
148
.
147 Arendt, Vita Activa cit., p. 28.
148 Cfr. Dietz, M.G. Feminist Receptions of Hannah Arendt, in Honig, B. (a cura di) Feminist Inter-
pretations of Hannah Arendt, University Park, Pennsylvania State University Press, 1995, pp. 17-50;
Butler, J.; Chakravorty Spivak, G. Who sings the Nation-State?, London, Seagull, 2007, trad. it. di
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 111 03/05/2013 11:11:13
112
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
La coscienza o lidentit femminile portano invece una voce diferente nella
vita pubblica? In che modo e in che senso le donne o il femminile partecipano
della vita della polis?
Nella flosofa pitagorica Il ruolo della donna contiene un ampio contenuto
simbolico: lo spazio delloikos non solo il polo negativo delle opposizioni fon-
damentali tra anima e corpo, virt ed eccesso, forza e debolezza. Le donne non
sono solo laltro, escluse dalla vita politica, ma partecipano al modello educati-
vo e cosmologico pitagorico. La criticit delloikos messa in risalto ad esempio
nellarticolo Teano de Crotona a cura di Montserrat Jufresa, in cui la distinzione tra
spazio pubblico e spazio domestico presente nella tradizione antica viene chiarita
attraverso il riferimento allesperienza della comunit delle donne pitagoriche
149
.
Come emerge nelle testimonianze delle pitagoriche e nella prospettiva inau-
gurata dagli studi di Nicole Loraux, loikos non solo lambito della produzione e
della riproduzione naturali ma un aspetto fondamentale delle rappresentazioni
e delle forme del politico in Grecia. Una volta fssata la distinzione oikos/polis le
analisi di Nicole Loraux consentono di sfumare la nettezza di tale divisione, dal
momento in cui laltro non viene riconosciuto come esterno ma come interno
alla polis: il femminile cio entra a far parte della polis in quanto riassorbito
dalluomo libero. Assorbimento per Nicole Loraux signifca integrare nel proprio
essere il femminile, farlo giocare fno allimpossibile
150
proprio come il Socrate
di Aristofane gioca con le parole e fa diventare il femminile di gallo la gallessa,
distruggendo con ci lidea che un gallo sia solo ed esclusivamente un animale
maschio. La paura della confusione e la necessit di rappresentarsi un modello
coerente, in cui ruoli, capacit, natura, siano separati e opposti, rispondono al
problema greco della mescolanza. Al fne di uscire dal quadro delle opposizioni
dicotomiche e di incrinare ogni opposizione costitutiva che possa infciare lorga-
nicit dellessere (opposizione maschile/femminile, ma anche corpo/anima, vita/
morte), il pensiero greco secondo Loraux ha fondato la polis non su di una sepa-
razione ma piuttosto su di una esclusione. Lesclusione prevede infatti una serie
di procedimenti che consentono anche di inglobare laltro, di mescolare laltro al
s in modo da conquistarlo o indebolirlo. Linclusione del femminile nel mondo
maschile manifesta sempre la superiorit delluomo sulla donna, ma perch ci sia
possibile, perch il femminile venga catturato, esso va anche propiziato ricavando-
Ambra Pirri, Che fne ha fatto lo stato-nazione?, Roma, Meltemi, 2009.
149 Gutirrez, M.; Jufresa, M; Mier, C. et al., Teano de Crotona, in Enrahonar. Quaderns de flo-
sofa, n. XXVI, 1996, pp. 95-108.
150 Loraux, N. Il femminile e luomo greco, Roma-Bari, Laterza, 1991, p. IX. (trad. it. di Maria P.
Guidobaldi, Paula Botteri, tit. or. Les Expriences de Tirsias. Le fminin et lhomme grec, Paris, Gal-
limard, 1989).
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 112 03/05/2013 11:11:13
113
5. La separazione tra oikos e polis in una prospettiva di genere
gli un posto allinterno di s. Il femminile entra dunque a far parte della polis in
quanto riassorbito dalluomo libero. A ci che appare ancora pi mortifcante per
la condizione femminile della mera reclusione nella sfera del privato, Loraux asso-
cia linteriorizzazione del femminile in quanto espressione della positivit del fem-
minile, non pi nel senso oscuro e negativo del pre-politico ma come elemento di
una mescolanza in cui convivono le diferenze. Una volta fssata la composizione
ibrida della polis si apre il campo per inseguire il sogno
151
di riconoscere nella
storia e in modo particolare nella storia dei concetti delle interruzioni brusche
determinate dalla diferenza dei sessi. La mescolanza come problema greco rimette
in discussione quello che sembrava un sistema perfettamente coerente grazie alla
presenza di una questione di genere che rifuta il modello antagonistico e si pone
nel segno del riconoscimento della diferenza.
151 Ivi, p. XXVI.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 113 03/05/2013 11:11:13
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 114 03/05/2013 11:11:13
6. Alle soglie dellOlimpo: prospettiva di
genere e analisi del politeismo greco
Gabriella Pironti
Le rifessioni che seguono non hanno certo lambizione di risolvere gli innume-
revoli problemi inerenti alla rappresentazione sessuata del divino nelle religioni
antiche, questione daltra parte strettamente legata a quella pi generale dellan-
tromorfsmo. Mi limiter dunque a presentare qualche osservazione sul politei-
smo greco antico e, pi in particolare, sulla pertinenza di unanalisi del pantheon
in termini di maschile/femminile.
La risposta data da Nicole Loraux alla domanda Che cos una da?
152
con-
serva intatta, ventanni dopo, la sua validit e si presenta come il necessario punto
di partenza per ogni analisi ulteriore: una da non una donna. Tra femminile
divino e femminile umano le diferenze sono tante e tali da invitarci a concludere
che, in una da, il genere femminile subordinato alla natura divina. Non un
caso se per esprimere il divino al femminile la lingua greca possa adoperare tanto
il femminile thea, quanto il maschile theos preceduto dallarticolo femminile. Va
ricordato poi che gli di del politeismo, secondo la lezione di Jean-Pierre Vernant,
non sono propriamente persone divine, ma potenze
153
e che, in quanto tali, essi
non si identifcano mai del tutto con le loro manifestazioni. In questo senso, e
contrariamente alla vulgata, il loro antropomorfsmo relativo: un dio si fa pre-
sente in molti modi e in vari luoghi, si manifesta nei fenomeni naturali, negli spazi
152 Loraux, N. Che cos una dea?, in Duby, G.; Perrot, M. (ed.), Storia delle donne. LAntichit (a
cura di P.Schmitt Pantel), Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 13-55.
153 Vernant, J.P. Mythe et pense chez les Grecs. tudes de psychologie historique, Paris, Franois Ma-
spro, 1969
2
[1965], p. 274.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 115 03/05/2013 11:11:13
116
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
del rito, in rappresentazioni iconiche, aniconiche o teriomorfe, e comunica la sua
potenza, e la sua presenza, attraverso una moltitudine di segni.
Portando questo assunto alle sue necessarie conseguenze, la Loraux avanza
lipotesi che persino lepifania di una divinit nella forma umana che le tradizio-
nalmente attribuita altro non sia che unulteriore variet, la variante teomorfca
appunto, della metamorfosi
154
. Tale discorso tanto pi valido qualora una divi-
nit si manifesti agli uomini prendendo una forma umana diversa da quella che
le tradizionalmente assegnata: si pensi, ad esempio, ad Atena che pu tranquil-
lamente assumere sembianze umane maschili
155
. E se tale scelta potrebbe apparire
motivata dalla scarsa femminilit della da parthenos, la vergine-guerriera che
rifuta il gamos, che dire allora di Hera, divinit protettrice del matrimonio? Anche
la sposa di Zeus, la sposa divina per eccellenza, che talvolta defnita la pi bella
tra le de immortali
156
, non esita a penetrare in un corpo umano maschile e a
lanciare, una volta prese le sembianze di Stentore, il pi terribile grido di guerra
157
.
Il saggio della Loraux percorso dalla sana volont di smantellare quella vi-
sione stereotipata secondo cui ogni da incarnerebbe un aspetto della femminilit:
Demetra la madre, Hera la sposa, Afrodite la cortigiana o la prostituta, Atena la
vergine-guerriera, Artemide la vergine-cacciatrice e via di seguito. Nel criticare le
analisi improntate a una simile semplifcazione
158
, la Loraux riserva alla fgura di
Afrodite un paragrafo signifcativo, in cui mette in evidenza i molteplici aspetti
della da, mostrando come questultima sia irriducibile allo stato di puro simbolo
femminile dellamore. Alcuni studi dedicati successivamente alle fgure di Afrodite
in Grecia antica hanno confermato la polivalenza della da, le cui competenze
spaziano dalla sessualit alla sfera politico-militare
159
: anche in Afrodite, che pure
generalmente considerata come la pi femminile tra le de, il divino prevale
dunque sul femminile.
Per misurare il dcalage tra la societ degli uomini e quella degli di, basti
pensare che le de fanno politica e combattono
160
. Le dee godono infatti nellas-
154 Loraux, N. Che cos una dea? cit., pp.21-22.
155 Cfr., ad esempio, Omero, Odissea, XXII, 205-206.
156 Inno omerico a Hera (XII), 2; Inno omerico a Afrodite (V), 41-42.
157 Omero, Iliade, V, 784-786.
158 Cfr., ad esempio, Friedrich, P. Te Meaning of Aphrodite, Chicago, University of Chicago Press,
1978, da leggere insieme alla recensione di Nicole Loraux, Journal of Hellenic Studies, n. 102, 1982,
pp. 261-263.
159 Pirenne-Delforge, V. LAphrodite grecque, Athnes-Lige, 1994 (Kernos, suppl. 4); Pironti, G.
Entre ciel et guerre. Figures dAphrodite en Grce ancienne, Lige, 2007 (Kernos, suppl. 18).
160 Lesclusione dallo spazio politico e dal campo di battaglia non implica tuttavia che il ruolo sociale
della donna greca fosse insignifcante, solo che questo ruolo si esprimeva in spazi e modi distinti da
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 116 03/05/2013 11:11:13
117
6. Alle soglie dellOlimpo: prospettiva di genere e analisi del politeismo greco
semblea divina di un rango identico a quello delle divinit maschili. Ci vale tanto
in quei racconti tradizionali che chiamiamo comunemente miti quanto nei culti
delle poleis. E se questa par condicio condizionata dalla subordinazione relativa
di di e de a una suprema autorit sovrana che si esprime al maschile nella fgura
di Zeus, non va tuttavia trascurato il fatto che, nei pantheon locali, il posto di
divinit poliade spetti, ben pi spesso che a Zeus, a fgure quali Atena e Hera, e
che il dio sovrano si associ volentieri ad Atena nella protezione della comunit
politica nel suo insieme. Questa forte presenza delle divinit femminili nella sfera
del politico non ha nulla a che vedere con una presunta Grande Dea Onnipo-
tente di cui le de greche sarebbero il pallido ricordo
161
. Come spiegare allora la
notevole presenza di divinit poliadi al femminile nelle citt greche? O per meglio
dire, il femminile un tratto pertinente nellanalisi delle funzioni assegnate alle
varie divinit allinterno di un pantheon, oppure la scelta di una divinit poliade
indipendente dal genere?
Per tentare una risposta a questa domanda, tuttaltro che semplice per un
sistema complesso di divinit polivalenti qual il politeismo, occorre partire pro-
prio dal dcalage tra mondo degli uomini e mondo degli di: le contraddizio-
ni tra femminile umano e femminile divino partecipano della tensione specifca
dellimmaginario greco a rappresentare il divino, laltro da s, in forme sensibili, e
a esprimere sotto forme umane, e quindi mortali, ci che per defnizione non-
umano e non-mortale. Gli studi consacrati al corpo degli di sono esemplari di
questa problematica. Gli di sono dotati, nelle rappresentazioni narrative, di un
corpo che al limite tra il sur-corps et il non-corps
162
. Il codice corporeo, nel pro-
iettarsi dal piano umano a quello divino, si scompone per riconfgurarsi altrimenti
in quanto operatore simbolico di caratterizzazione delle potenze divine in gioco.
Potremmo ipotizzare un analogo destino per la distinzione in generi: in tal caso,
lo studioso del politeismo greco non dovrebbe limitarsi a prendere atto del dca-
lage, ma piuttosto, partendo da questa constatazione, servirsi del dcalage come
strumento euristico.
Posto che la diferenza maschile/femminile non costruisce un Olimpo scisso
in due met e non infcia le pari opportunit delle de, e che la diferenziazione
dei ruoli e delle funzioni non sembra corrispondere a quella tra generi, come
identifcare allora quei tratti di una potenza divina che il genere contribuirebbe
quelli riservati agli uomini. Ed appunto questa specifca ripartizione genre che non trova riscontro
nella societ degli di.
161 Il mito storiografco della Grande Dea stato suf cientemente smascherato negli ultimi decenni
perch sia necessario ritornarci in questa sede. Cfr. Loraux, N. Che cos una dea? cit., pp. 33-37.
162 Vernant, J.P. Corps obscur, corps clatant, in Le Temps de la Rfexion, n. 7, 1986, pp. 19-45.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 117 03/05/2013 11:11:13
118
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
a rappresentare? Come Nicole Loraux, anche Jean Rudhardt
163
ha seguito alcune
piste al fne di tracciare i contorni di una confgurazione del divino al femminile.
La studiosa sottolinea come siano al femminile la maggior parte dei gruppi divini,
del tipo Moire, Ore, Cariti, e delle personifcazioni astratte, ad esempio Dike
(Giustizia), Metis (Intelligenza astuta), Mnemosyne (Memoria), quasi che il
femminile fosse tendenzialmente adatto a rappresentare sub specie dei il collettivo,
limpersonale, lanonimo, lastratto
164
. Come la Loraux, anche Rudhardt osserva
la femminilit delle potenze divine legate, come ci si poteva attendere, alla sfera
della maternit, del parto, del matrimonio: si pensi a Gaia, la Terra primordiale,
a Ilizia, da che presiede al parto, e a Hera, la sposa di Zeus. Entrambi gli studiosi
rifettono poi sullo statuto di parthenoi che contraddistingue Atena, Artemide ed
Estia: pur introducendo una diferenza fondamentale tra il piano umano, in cui
la verginit non consentita, e quello divino, dove questa funge invece da tratto
caratterizzante, la parthenia delle de assumerebbe comunque il matrimonio e la
sessualit adulta come punto di riferimento, anche se a contrario.
La Loraux e Rudhardt prestano una grande attenzione al ruolo del femminile
nella Teogonia di Esiodo, e fanno notare come nel mito di successione che, attra-
verso il regno di Urano e poi di Crono, porta al regno di Zeus, le de rappresente-
rebbero lelemento dinamico o perturbatore, favorendo il passaggio da una gene-
razione divina allaltra, mentre la stabilit e lordine si declinerebbero preferenzial-
mente al maschile. Tra i tratti pertinenti del femminile divino, Rudhardt include
anche la particolare vicinanza delle de agli esseri umani, lattenzione sollecita,
quasi materna, con cui esse seguono passo passo, nel mito, il percorso dei giovani
eroi e la protezione ravvicinata che esse ofrono alle comunit umane nel culto,
laddove le divinit maschili proteggerebbero eroi o esseri umani a debita distan-
za. La maggiore implicazione delle de nelle vicende umane troverebbe poi una
conferma nella particolare sensibilit di questultime alle emozioni: nel pantheon,
la collera e il risentimento, come lafetto e la benevolenza, si declinerebbero di
preferenza, al femminile.
Tra le piste di rifessione segnalate, alcune meriterebbero di essere esplorate
pi attentamente, come ad esempio il rapporto tra femminile e collettivit divine,
altre di essere leggermente sfumate anche le divinit maschili possono riverlarsi
sensibili, e lo sono particolarmente al desiderio erotico , altre ancora di essere
approfondite, e ci anche alla luce dei progressi compiuti negli studi di gene-
re, sempre pi attenti a pensare la relazione maschile/femminile piuttosto che il
femminile in s. Il rapporto che le lega a Zeus indispensabile, a mio avviso, per
163 Rudhardt, J. Les dieux, le fminin, le pouvoir, Genve, Labor et Fides, 2006, pp.41-72.
164 Loraux, N. Che cos una dea? cit., pp. 28-29.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 118 03/05/2013 11:11:13
119
6. Alle soglie dellOlimpo: prospettiva di genere e analisi del politeismo greco
comprendere fgure divine quali Atena ed Hera, la cui dimensione politica non
solo una conseguenza del maggiore coinvolgimento delle divinit femminili nelle
vicende umane, ma condizionata dalla partecipazione alla sfera della sovranit,
che si esprime appunto nel legame privilegiato di queste de con Zeus.
Se in linea di massima cos dif cile cogliere e isolare, nel mondo degli di, le
specifcit di genere, che forse la complicit, sullOlimpo, tra maschile e femmi-
nile prevale sulla diferenza, e che gli dei, pur essendo distinti in maschi e femmi-
ne, hanno, oltre al privilegio dellimmortalit e delleterna giovinezza, anche quel-
lo di poter confondere, o anche riarticolare, i generi
165
. Quasi che, immuni alla
mortalit e alla vecchiaia, gli di lo siano anche al rapporto confittuale tra generi,
e che la diferenza maschile/femminile si riconfguri, sullOlimpo, per esprimere
la complementariet funzionale tra potenze divine.
Secondo unopinione difusa, ad esempio, Afrodite e Ares costituirebbero due
opposti complementari: in questa coppia, la da rappresenterebbe la femminilit,
lunione amorosa, la debolezza, il dio incarnerebbe invece la virilit guerriera, lo-
dio, la forza. Tale visione, che gia semplicistica tenendo conto dellinsieme delle
fonti letterarie, si ritrova smentita dai dati cultuali che mostrano Afrodite implica-
ta nella sfera politico-militare; inoltre, Afrodite e Ares presiedono entrambi allin-
contro dei corpi e alle pulsioni incontrollate; soprattutto, Afrodite, in quanto pre-
posta alla sessualit in tutte le sue forme, tutela la trasformazione dei fanciulli in
adulti e si rivela strettamente associata alla potenza virile
166
. Consideriamo unaltra
coppia, Atena e Ares, e il modo diverso in cui intervengono nella sfera della guer-
ra: troveremo spesso la da associata allaspetto strategico e militare del confitto, il
dio alla cieca furia del corpo a corpo. Questa visione non infondata, ma possia-
mo collegarla a buon diritto al genere delle due divinit, quando per la mtis che la
contraddistingue Atena degna fglia di suo padre Zeus
167
, e per leris (contesa)
che lo abita Ares degno fglio di sua madre Hera
168
? Qualora si considerino appun-
to gli aspetti confittuali di Ares e lelemento perturbatore che Dioniso porta con
s, ci si domander allora se il maschile al divino sia sempre sinonimo di ordine
e stabilit, o se questa conclusione non sia pi specifcamente valida nel contesto
di un mito di successione come quello raccontato nella Teogonia, incentrato sulla
fgura di Zeus. Che dire poi dellassociazione tra Estia e Hermes, da un lato la da
che esprime la fssit del focolare e la permanenza delloikos, e dallaltro Hermes,
165 Cfr. Hritier-Aug, F. La costruzione dellessere sessuato, la costruzione sociale del genere e lambiguit
dellidentit sessuale, in Bettini, M. (a cura di) Maschile/Femminile. Genere e ruoli nelle culture antiche,
Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 113-140, in particolare p. 131.
166 Pironti, Entre ciel et guerre cit., passim.
167 Cfr. Esiodo, Teogonia, 892-896.
168 Cfr. Omero, Iliade, V, 889-898.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 119 03/05/2013 11:11:13
120
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
che tutto mobilit, percorso, passaggio
169
? Forse che, in altri contesti e in altre
confgurazioni divine, la mobilit e lo spazio esterno alloikos possono essere asso-
ciati anche a una divinit femminile: si pensi, ad esempio, ad Artemide.
Questa breve rassegna di esempi e controesempi non vuole dimostrare che il
genere non sia un criterio pertinente nello studio delle divinit greche. La prospet-
tiva di genere illuminante, talvolta indispensabile, soprattutto come strumento
euristico volto a precisare forme e modalit del dcalage tra piano divino e piano
umano. Talvolta, infatti, proprio lirriducibilit alla diferenza di genere, o anche
la sua contrapposizione a essa, che permette di comprendere meglio, nella sua
specifcit, e nella sua fondamentale alterit, una potenza divina
170
.
169 Vernant, Mythe et pense cit., pp. 97-158.
170 Questo discorso, incentrato sulla rappresentazione del divino, non esaurisce il pi vasto problema
della diferenza di genere nella religione greca, diferenza che si palesa con maggiore chiarezza via via
che spostiamo lo sguardo dalla societ degli di a quella degli uomini. Nella scelta del personale di
culto, nella sfera rituale, come nella selezione delle vittime sacrifcali, il genere infatti una compo-
nente non trascurabile. Per ulteriori approfondimenti sul tema qui trattato, cfr. Burkert, W. Wei-
bliche und mnnliche Gottheiten in antiken Kulturen: Mythische Geschlechterrollen zwischen Biologie,
Phantasie und Arbeitswelt, in Martin, J.; Zoepfel, R. (a cura di) Aufgaben, Rollen und Rume von Frau
und Mann, vol. I, Freiburg-Mnchen, Alber, 1989, pp. 157-179; sul femminile e la fgura di Pan-
dora, cfr. Pirenne-Delforge, V. Prairie dAphrodite et jardin de Pandore. Le fminin dans la Togonie,
in Delruelle, E.; Pirenne-Delforge, V. (a cura di) Kpoi. De la religion la philosophie. Mlanges oferts
Andr Motte, Lige, 2001 (Kernos, suppl. 11), pp. 83-99, con bibliografa.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 120 03/05/2013 11:11:13
7. Discorsi di genere nelle Storie dAmore
attribuite a Plutarco
171
Pauline Schmitt Pantel
Le Storie dAmore Erotikai Diegeseis riuniscono cinque racconti che sono
stati attribuiti a Plutarco, ma secondo gli editori questopera di et imperiale
non possiede nessuna delle qualit comunemente riconosciute al famoso
scrittore
172
. Tralasciando i giudizi di valore che pesano su queste mediocri
produzioni, vorrei invece chiedermi se esista una qualche coerenza in tale raccolta
apparentemente eterogenea. Il titolo suggerisce che a fungere da collegamento sia
la rappresentazione dellamore, delleros, ma questi racconti, come vedremo,
appartengono piuttosto alla srie noire che non ai romanzi della collezione
Arlequin
173
. Mi sembra tuttavia che un tema li accomuni: quello del genere, dal
momento che queste storie riguardano sia ragazze che ragazzi che si imbattono
in avventure del tutto simili. Seguendo dunque questo flo conduttore mi
limiter a studiare tre di queste storie, di cui alcune sono ben note e che
riassumer qui a grandi linee.
171 Ringrazio sentitamente Gabriella Pironti per aver tradotto il mio testo in italiano.
172 Vd. lintroduzione di Marcel Cuvigny alledizione pubblicata nella Collection des Universits de
France: Plutarque, uvres Morales, tome X, Paris, Les Belles Lettres, 1980. Mi servo di questa edi-
zione e traduzione, e cito i passaggi come da convenzione. Vd. anche Plutarco, Narrazioni dAmore,
a cura di Giuseppe Giangrande, Napoli, DAuria, 1991; Capriglione, J.C. Narrazioni senzamore,
in Nieto Ibanez, J.M.; Lopez Lopez, R. (a cura di) El Amor in Plutarco, Leon, Universidad de Leon,
2007, pp. 255-264.
173 La srie noire una collezione di romanzi polizieschi, la collezione Arlequin invece una serie di
romanzi rosa.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 121 03/05/2013 11:11:13
122
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
La prima storia quella di Aristoclea, fglia di Teofane, ed ambientata ad
Aliarte, in Beozia
174
. Aristoclea ha due pretendenti: Stratone, originario di Orco-
meno, il pi ricco, il pi nobile e il pi innamorato dei due, mentre laltro, Calli-
stene, proveniente da Aliarte, un consanguineo. Indeciso, il padre della fanciulla
vuole rivolgersi alloracolo di Trofonio per scegliere tra i due pretendenti. Stratone
chiede allora ad Aristoclea di esprimersi: Teofane interroga sua fglia alla presenza
di tutti ed ella sceglie Callistene
175
. Stratone invitato al banchetto nuziale dove
arriva con alcuni compagni e servitori. Egli tenta di rapire la fanciulla la quale,
presa tra il gruppo dei parenti e quello di Stratone, muore dilaniata. Callistene
sparisce e Stratone si suicida sul cadavere di Aristoclea.
La seconda storia quella di Atteone ed ambientata a Corinto
176
. Per riassu-
merla brevemente, Atteone, fglio di Melisso, il pi bello e il pi saggio dei suoi
coetanei, e numerosi sono i suoi erastai. Egli per ne rifuta uno: Archia, un uomo
famoso per la sua ricchezza e il suo potere, che tenta di rapirlo in occasione di un
komos che si svolge nella casa di Melisso. Tirato da una parte e dallaltra rispet-
tivamente dai suoi difensori e dai suoi aggressori, il giovane muore. Non avendo
ottenuto giustizia dalla parte dei Corinzi, il padre del fanciullo in occasione dei
giochi Istmici li maledice, per poi suicidarsi gettandosi sulle rocce dallalto del
tempio di Poseidone.
La terza storia consta di due racconti intrecciati e presentati in parallelo
177
.
Ne sono protagoniste le due fglie di un uomo di Leuttra, Schedaso, di modesta
condizione, e il fglio di un vecchio di Oreo. Schedaso ha oferto ospitalit a due
giovani di Sparta che si recano a Delf per consultare loracolo e che si innamorano
delle due ragazze presenti in quella casa. Le fanciulle ospitano ancora i due Spar-
tiati al loro ritorno da Delf, e i due giovani approfttano dellassenza del padre per
violentarle, poi le uccidono e gettano i loro corpi in un pozzo. Schedaso, una volta
tornato a casa, comprende laccaduto e si reca a Sparta per vedere gli efori. Strada
facendo, incontra un vecchio di Oreo che gli racconta la sua storia: suo fglio ha
rifutato le proferte amorose dellarmosta dei Lacedemoni, Aristodemo, che lha
poi rapito e ha tentato di fargli violenza; alla resistenza del giovane, Aristodemo
ha reagito sgozzandolo ed poi rientrato in citt per partecipare a un banchetto.
Il vecchio si allora recato a Sparta per reclamare giustizia ma gli efori si sono ri-
futati di ascoltarlo. La stessa cosa accade a Schedaso, il quale dopo inutili tentativi
fnisce per suicidarsi maledicendo gli Spartiati, una maledizione che riemerge in
174 Plutarco, Moralia, 771 e 772 c.
175 Plut., Mor., 772 a.
176 Plut., Mor., 772 c- 773 b.
177 Plut., Mor., 773 b-774 c.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 122 03/05/2013 11:11:13
123
7. Discorsi di genere nelle Storie dAmore attribuite a Plutarco
occasione della sconftta che gli Spartiati subiscono a Leuttra, proprio accanto alla
tomba delle due fanciulle.
Questi quattro racconti, pi incentrati su storie di crimini che non di amore, se-
guono lo stesso schema narrativo: un incontro erotico, un rapimento, violenze e mor-
te, e per fnire, la vendetta. Un aspetto interessante il parallelismo che si crea tra storie
damore tra uomini, quella di Atteone e quella del fglio del vecchio di Oreo, e storie
damore tra uomini e donne, quella di Aristoclea e quella delle due fglie di Schedaso.
Le numerose somiglianze tra queste storie sono lampanti. In ogni caso, le
vittime sono giovani, siano essi fanciulli o fanciulle, i kyrioi sono i padri, i loro
tutori legittimi.
La violenza infitta ai giovani una violenza sessuale espressa dai termini bia-
zein, che pu signifcare violentare (uno dei primi esempi del suo impiego in
questo senso proviene dallInno omerico a Demetra), e hybrizein, che appunto il
termine di uso legale. A questo tipo di violenza il giovane non pu che opporre
quel rifuto e quella resistenza che causano la sua morte.
La morte dei personaggi anchessa particolarmente violenta e contrastante
con le norme civiche. Per Aristoclea e Atteone si tratta di un dilaniamento: si
ritrovano nelle mani dei presenti (en kersi anthelkontn) che si gettano gli uni sugli
altri, e sono tirati da una parte e dallaltra. Per le fanciulle di Leuttra si tratta di
un omicidio seguito dalla precipitazione in un pozzo (o secondo altre versioni, di
impiccagione o colpi di pugnale), per il fglio del vecchio di Oreo invece, di sgoz-
zamento (aposphazein). Consideriamo i gesti: il dilaniamento (azione che ricorda
il diasparagmos) e il vocabolario del sacrifcio (sphagein) qui evocati fanno coinci-
dere tra loro sfere che normalmente restano distinte nella citt: gli esseri umani
non possono essere trattati come lo sono gli animali.
Coloro che fanno ricorso alla violenza presentano una personalit simile. Si tratta
di uomini di potere: i pretendenti di Aristoclea sono di ottima famiglia; laggressore
di Atteone, Archia, un nobile di Corinto appartenente alla dinastia degli Eraclidi,
nonch futuro fondatore di Siracusa; Aristodemo, che uccide il fglio del vecchio di
Oreo, un armosta; gli aggressori delle fglie di Schedaso sono cittadini Spartiati.
Non si tratta quindi di briganti o individui marginali e declassati, ma di uomini per-
fettamente integrati nella citt che abusano del loro potere alla maniera dei tiranni.
Labuso di potere talvolta accompagnato da circostanze aggravanti. I giovani
aristocratici di Aliarte catturano Aristoclea mentre questa si reca alla fontana delle
Ninfe per ofrire un sacrifcio preliminare al matrimonio. Il rapimento delle fan-
ciulle alla fontana un tema assai frequente in Grecia, ma nel caso qui in esame
va notata laggravante dellempiet, poich si tratta di unirruzione che ha luogo
nel bel mezzo di un atto sacro. I due giovani Spartiati ofendono a Leuttra uno dei
riti pi rispettati dai Greci, quello dellospitalit. La xenia sotto la tutela diretta
di Zeus. Ogni ofesa fatta allospite, e a maggior ragione la violenza e la morte, si
confgura come un grave atto di empiet.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 123 03/05/2013 11:11:13
124
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
Ben diferente da quello degli aggressori lo statuto sociale dei padri che,
ognuno in maniera diversa, rappresentano comunque i deboli della societ. Sche-
daso povero, luomo di Oreo un vecchio, Melisso uno straniero a Corinto
(la sua famiglia proviene da Argo); Teofane appartiene probabilmente alla buona
societ di Aliarte, ma ha paura dei pretendenti ed un indeciso che non sa as-
sumersi le sue responsabilit in quanto kyrios di sua fglia: questi quattro padri
si trovano dunque in condizione di inferiorit rispetto agli aggressori. Essi non
soltanto non sono in grado di impedire gli omicidi, ma non ottengono alcun ap-
poggio da parte delle autorit legittime della citt. Questultimo punto degno di
interesse. Infatti, sia il vecchio di Oreo sia Schedaso si recano a Sparta a chiedere
giustizia, ma la citt, attraverso la voce degli efori, ma anche tramite quella dei re
e dei cittadini, respinge le loro richieste. La loro posizione di stranieri rispetto alla
citt un elemento essenziale per comprendere latteggiamento delle autorit che
si volgono a proteggere i propri concittadini. Il caso di Melisso simile: il cadavere
di suo fglio esposto nellagor, luogo al tempo stesso pubblico e sacro, eppure
la deplorazione per laccaduto resta confnata nel privato. La citt di Corinto non
riconosce Melisso come uno dei suoi: quello che ai nostri occhi appare un abuso
delle autorit civiche in realt la traduzione dello statuto giuridico degli stranieri.
La via legale della rivendicazione davanti alla giustizia dunque impossibile. Resta
ununica possibilit di ricorso, e cio appellarsi alle divinit.
Un altro elemento comune a tutti questi racconti la vendetta divina, su-
scitata dalla maledizione che pronunciano i padri delle vittime. Il racconto di
Melisso quello che sviluppa maggiormente questo tema, coniugando tra loro
pi strategie. Dal momento che lesposizione del corpo del giovinetto nellagor
non aveva avuto alcun esito, il padre di questi approftta di un importantissimo
momento di riunione non soltanto dei Corinzi, ma dei Greci tutti, i giochi Istmici
appunto, per denunciare laccaduto in pubblico e, fatto ancor pi signifcativo,
in un luogo sacro: il tempio di Poseidone, la divinit in cui onore si celebravano
i giochi. Egli attese che si celebrassero i giochi Istmici e a quel punto, salito al
tempio di Poseidone, lanci la sua invettiva contro i Bacchiadi, ricord i meriti
di suo padre Abrone e, dopo aver invocato gli di, si precipit sulle rocce
178
.
Abrone che aveva svelato ai Corinzi un complotto del re argivo Fidone inteso ad
annientarli, aveva salvato loro la vita. Anche se pronunciata contro i Bacchiadi,
la famiglia aristocratica che deteneva il potere a Corinto, la maledizione riguarda
la citt tutta intera. La vendetta ormai nelle mani degli di ed una vendetta
duplice, per la morte del giovane Atteone e per quella dello stesso Melisso. Suici-
dandosi in un luogo sacro, questultimo fa inoltre correre alla citt il pericolo di
una grave contaminazione.
178 Plut., Mor., 773 a.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 124 03/05/2013 11:11:13
125
7. Discorsi di genere nelle Storie dAmore attribuite a Plutarco
Schedaso agisce in modo simile, anche se la sua azione meno spettacolare.
Di fronte al rifuto degli Spartiati di concedergli giustizia: Subto anche lui un
insuccesso, si mise a correre per la citt, tendendo le mani verso il sole, poi percos-
se il suolo invocando le Erinni e infne si uccise
179
. Linvocazione alle Erinni, de
preposte alla vendetta, una richiesta di punizione. Inoltre, il suicidio di Schedaso
contamina linsieme della citt di Sparta.
Gli di reagiscono come da programma: scatenano un fagello (loimos) sulla
citt di Corinto e provocano la sconftta militare di Sparta a Leuttra, nella batta-
glia contro i Tebani. Il fagello si abbatte sia sul territorio sotto forma di siccit,
sia sugli esseri umani, sotto forma di malattia. Per comprenderne il motivo, i
Corinzi si rivolgono alloracolo di Delf e Archia, per evitare la punizione, parte
esule in Sicilia dove morir assassinato a sua volta dal suo amasio. Si crea cos una
corripondenza tra la punizione divina e il crimine di Archia. La punizione degli
Spartiati invece diferita nel tempo, poich la morte delle due fglie di Schedaso
sarebbe avvenuta ben prima della battaglia di Leuttra. In questo caso, lintera
citt o per lo meno i suoi opliti che pagano con la morte sul campo di battaglia,
nei pressi della tomba delle fanciulle, il fo per il crimine commesso dai due gio-
vani Spartiati. Ma si tratta pur sempre di vendetta divina, come dimostra il fatto
che al capo tebano Pelopida appare in sogno Schedaso che lo incoraggia dicendo
che: I Lacedemoni giungevano a Leuttra per pagare il loro debito verso di lui e
le sue fglie
180
.
Queste storie, che ofrono numerosi spunti di rifessione, sono state analizzate
in parallelo con racconti simili che si ritrovani in numerosi altri testi greci: si pensi,
in particolare, alla storia delle fanciulle di Leuttra
181
e alla storia di Atteone
182
. Lin-
sieme costituito da questi racconti paralleli troppo ampio per renderne conto in
poche pagine. In tal sede, mi limiter dunque a constatare che in alcuni racconti
che mettono in scena desiderio sessuale, violenza e morte, i fanciulli e le fanciulle
sono trattati in maniera assai simile. Tale constatazione pu apparire sorprenden-
te, nella misura in cui ci si attenderebbe che siano piuttosto le fanciulle a ritrovarsi
vittime di violenza sessuale, mentre i fanciulli dal canto loro dovrebbero invece
morire in guerra. Tuttavia questi racconti non costituiscono un caso isolato. Ero-
doto racconta che il tiranno di Corinto, Periandro, aveva inviato trecento ragazzi
179 Plut., Mor., 774 b.
180 Plut., Mor., 774 d. La battaglia ebbe luogo nel 371 a.C.
181 Senofonte, Elleniche, VI, 4, 7. Pausania, IX, 13, 5-6. Diodoro Siculo, XV, 54, 1-3. Plutarco,
Pelopida, 20, 5. Eliano, fr. 77 Herscher.
182 Partenio, Erotika Pathemata, XIV. Plutarco, Sertorio, 1-4. Diodoro Siculo, VIII, 10. Scolio ad
Apollonio Rodio, Argonautiche, IV, 1212.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 125 03/05/2013 11:11:13
126
Capitolo 1. A partire da Nicole Loraux: il femminile tra hybris e nomos
di Corcira al satrapo di Sardi perch questi ne facesse degli eunuchi
183
. E il tiranno
di Argo, Fidone, aveva progettato di far venire ad Argo i mille giovani Corinzi pi
rinomati per vigore e coraggio, nellintenzione di ucciderli e ridurre cos la potenza
di Corinto
184
. In entrambi i casi, si tratta di indebolire o anche di sopprimere una
citt, Corcira o Corinto, privandola della difesa e della capacit riproduttiva che i
giovani rappresentano.
Nelle Storie dAmore, le avventure raccontate sono relative a casi individuali e,
probabilmente, impossibile mettere sullo stesso piano lo strupro di un fanciullo
o di una fanciulla e lannientamento di una classe di et. Ma una domanda si im-
pone: tali attitudini violente rivelano soltanto il carattere pieno di hybris del loro
autore che non tollera un rifuto, oppure queste descrivono, in maniera pi gene-
rale, un rapporto di genere e un rapporto di potere? In efetti, un punto in questi
racconti appare piuttosto sconcertante: il non intervento delle comunit civiche,
sia Corinto che Sparta (per ben due volte), come se la citt potesse chiudere gli
occhi su queste vessazioni e preferire alla giustizia la difesa dei suoi cittadini. Pur
esistendo nelle citt leggi contro ogni forma di hybris, in particolare in materia di
sessualit, tali storie mostrano una sorta di connivenza tra citt e aggressori.
Stratone che non viene scelto come sposo, Archia e Aristodemo che non sono
accetatti in quanto erasti, gli Spartiati il cui abuso nei confronti delle fanciulle di
Leuttra viene considerato un atto di hybris: queste situazioni mettono in discus-
sione una delle forme di potere che caratterizza il cittadino, il potere sessuale che
egli esercita indiferentemente su fanciulli e fanciulle. Questo rapporto costruisce
in seno alle citt una gerarchia netta tra uomini-adulti-cittadini e giovani di ambo
i sessi che non siano cittadini
185
. La linea di separazione non passa semplicemente
tra maschile e femminile, ma piuttosto tra i cittadini adulti e gli altri. In questo
caso il genere, inteso come la maniera in cui una societ costruisce i rapporti tra
i sessi, indissociabile dagli altri due sistemi di classifcazione propri delle citt,
vale a dire quello che distingue le diverse classi di et e quello che separa i cittadini
dai non cittadini. Di conseguenza, questa forma particolare di costruzione sociale
e politica che appunto il genere, si articola con altre forme di costruzione per
defnire i lineamenti dellidentita civica
186
. Le Storie dAmore non sono soltanto
storie di genere.
183 Erodoto, Storie, III, 48.
184 Plut., Mor., 772 d.
185 Schmitt Pantel, P. Aithra et Pandora. Femmes, genre et cit dans la Grce antique, Paris, LHar-
mattan, 2009.
186 Sebillotte Cuchet, V.; Ernoult, N. (a cura di) Problmes du genre en Grce ancienne, Paris, Publi-
cations de la Sorbonne, 2007.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 126 03/05/2013 11:11:13
CAPITOLO 2
Gender and Politics in Early Modern
Europe
edited by Linda Jauch
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 127 03/05/2013 11:11:13
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 128 03/05/2013 11:11:13
Introduction
Linda Jauch
Te contributors of this section frst met one year ago at a postgraduate convention
at the University of Cambridge. Tey all share the view that a signifcant gap in
historical scholarship exists when questions of gender and politics are concerned.
While a gendered study of politics has, in the last few years, slowly received more
historical attention pointing at the fact that the importance of the relationship
between gender and politics can no longer be ignored, all contributors feel that a
thorough analysis is still missing. Tis section thus brings together young scholars
who either just completed their doctoral research or are in the process to do so. It
wishes to provide new insights into the interrelations between gender and politics,
close a gap in historical scholarship, and present a forum for exciting new streams
of research which will allow historians to gain new conceptions of the study of
early modern politics and its related institutions.
Te study of political history has traditionally focused almost exclusively on
men, applying a male perspective on political concepts and issues. Even though
especially social historians have underlined the inadequacy of the traditional dichot-
omy of a public male and private female sphere, in political history and the history
political thought this concept still seems to persist
1
. Only very slowly is the study
of political history broadening its understanding of power to include more informal
relationships, to diferentiate between formal authority and the power to shape po-
litical events, and to examine the gendered experience of politics. As a result, women
emerge as active participants in early modern politics who through their patronage
1 For early modern social historians challenging the public-male/private-female spheres see, for
example, Roper, L. Te holy household, Oxford, Clarendon, 1998. Kovesi Killerby, C. Sumptuary law
in Italy, 1200-1500, Oxford, Clarendon, 2002. Zarri, G. Storia delle donne e storia religosa: un
innesto riuscito, in Calvi, G. (eds.) Innesti: donne e genere nella storia sociale, Roma, Viella, 2004.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 129 03/05/2013 11:11:13
130
Capitolo 2. Gender and Politics in Early Modern Europe
and personal engagement shaped ideas, political discourse, and political realities
2
.
A gendered analysis of political treatises, on the other hand, will allow historians to
reach a more nuanced understanding of political writings and their composers and
will consequently challenge previous assumptions. Trough a study of early modern
gender and politics historians can gain new insights into the political organisation
of the time, its paradigms and structure.
All the papers in this section are concerned with elites. Rather than concen-
trating on informal power, the contributors of this section focus on the process of
political decision-making and womens ability to engage in it. As a result, court
culture plays an important role in three of the four papers presented here. Te
court has a long tradition of historical scholarship, and when women are con-
cerned, it is especially medieval queenship where most research has been carried
out
3
. Tere also exists vast historical scholarship on female rulers on the British
Isles in the early modern period and around fgures like Mary and Elizabeth Tudor
or Mary Stuart
4
. On the continent Catherine deMedici and Anne of Austria
were likewise the focus of much research. However, the role of female consorts in
the daily running of their husbands realms or their role after the death of their
spouses has received considerably less attention.
But more so than the ruler, the female consort was in need of her own power
strategies and political knowledge to strengthen her courtly and political impact.
She lacked the institutionalised claim to power of her husband, she was often a
foreigner who came to her husbands court, and as a result it was important for her
2 Recent publications in the feld include, for example, Calvi, G. (Ed.) Women rulers in Europe:
agency, practice and the representation of political powers (XII-XVIII). European University Institute
Working Papers, HEC No 2008/2, San Domenico di Fiesole, European University Institute, 2008.
Swift, H.J. Gender, writing, and performance: men defending women in late medieval France, Oxford,
Oxford University Press, 2008. Jansen, S.L. Debating women, politics, and power in early modern Eu-
rope, New York, Palgrave, 2008. Arcangeli, L.; Peyronel, S. Donne di potere nel Rinascimento, Roma,
Viella, 2008. Cox, V. Gender and eloquence in Ercole deRobertis Portia and Brutus, in Renais-
sance Quarterly, vol. LXII, n. 1, 2009, pp. 61-101. Cruz, A.J.; Suzuki, M. (Eds.) Te rule of women
in early modern Europe, Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 2009.
3 Parsons, J.C. (Ed.), Medieval queenship, Phoenix Mill, A. Sutton, 1984. Duggan, A.J. (Ed.),
Queens and queenship in Medieval Europe: proceedings of a conference held at Kings College London,
Woodbridge, Boydell Press, 1997. Taylor, C. Te Salic Law, French queenship, and the defence of
women in the late Middle Ages, in French Historical Studies, vol. 29, n. 4, pp. 543-564. For early
modern queenship see Campbell-Orr, C. (Ed.) Queenship in Europe, 1660-1815: the role of the con-
sort, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
4 See, for example, Richards, J. To promote a woman to beare rule: talking of queens in Mid-
Tudor England, in Sixteenth Century Journal, vol. 28, n. 1, 1997, pp. 100-121. McLaren, A. Te
quest for a king: gender, marriage and succession in Elizabethan England, in Journal of British
Studies, vol. 41, n. 3, pp. 259-290.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 130 03/05/2013 11:11:13
131
Introduction
to enhance her position and create own networks to succeed in this fragile power
balance. Te relationship between the spouses which could include a partnership,
mere cooperation when necessary, and even rivalry was also an important factor
that determined the amount of infuence the consort could exercise and to an
extent even its success. While female political roles were always defned in relation
to male interests, whether as spouse, childbearer, or ensurer of dynasty, female
consorts always aimed at creating their own networks, forwarding their own dy-
nasties ambitions and personal interests. By exchanging letters and gifts, acting as
patrons, and commissioning medals, paintings, and defences of women, they tried
to emphasise their roles and power. Tus early modern debates on questions as
to whether a proper education would allow women to reach a level of knowledge
comparable to that of men, and whether women were naturally weak and thus
unable to exercise power were important
5
.
Tis leads us to the second focal point of this section: the question of female
adaptability to engage in politics. Questions of the possibility and acceptability
of female power, women as rulers, or women as key political power players were
vividly discussed by political writers in the ffteenth and sixteenth centuries. Ear-
ly Modern political developments contributed to a growing interest in womens
power. Women ruled as regents, consorts, or widows, and were very prominent,
for example in the court culture of the Italian peninsula. As Serena Ferente has
recently highlighted early modern Europe witnessed an unprecedented number
of queens regnant who were ruling in their own right, including Joanna I and
Joanna II of Naples, Margaret I of Denmark, Mary I and Jadwiga I of Hunga-
ry-Poland, Isabel I of Castile, Mary I and Elizabeth I on England
6
. Whether
admired or hated (for example by the Marian exiles at Strasbourg or Geneva),
powerful women seemed to produce a new demand for discussions and debates
and also inspired authors to discuss a wide range of topics in relation to women,
for example their intellectual ability, their involvement in the Fall, and the positive
impact of women on politics.
5 Te discussion of womens virtues was not confned to literary works but was also part of an
artistic discourse. See for example Franklin, M. Boccaccios heroines: power and virtue in Renaissance so-
ciety, Aldershot, Ashgate, 2006. Franklin distinguishes between the socially acceptable representation
of women in republican Florence and the representation of the aforesaid in courtly Ferrara. Stephen
Campbell analyses the paintings in Isabella dEstes studiolo in relation to her self-positioning as pow-
erful consort. Campbell, S.J. Te cabinet of Eros: Renaissance mythological painting and the studiolo of
Isabella dEste, New Haven, Yale University Press, 2004.
6 Ferente, S. Naturales dominae: female political authority in the late middle ages, in Calvi, G.
(Ed.), Women rulers in Europe: agency, practice and the representation of political powers (XII-XVIII).
European University Institute Working Papers, HEC No 2008/2, San Domenico di Fiesole, European
University Institute, 2008.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 131 03/05/2013 11:11:13
132
Capitolo 2. Gender and Politics in Early Modern Europe
Often these writings took the form of catalogues of women who were dis-
played either for their virtue or vice, and used to discuss womens achievements in
the past and their overall capacity for virtue. Using Boccaccios De claris mulieribus
and his biographies of ancient women as model, these highly ideological works
created diferent images of women, served as reference books on historical women
and, just like Renaissance advice books, so-called regole, they tried to instruct con-
temporary women on proper behaviour. Texts that defended (exemplary) women,
often had two ideological functions: to argue for female capacity to attain virtues
normally associated with men, like fortitude and constancy, and to challenge the
long-established misogynistic thought which was mostly based on a combination
of the medieval scholastic tradition, readings of Aristotle, Roman Law, the Gen-
esis, the New Testament epistles, and/or the Church Fathers.
It has often been questioned whether defences of women can be taken seri-
ously or whether they represent merely a literary exercise, a paradoxical enco-
mium, or the fattery of an author in pursuit of female patronage. Many treatises
have a certain ambiguity in their defence but the sheer number of ffteenth and
early sixteenth century texts dealing with the question of powerful women sug-
gests a need and a market to discuss these themes. It needs to be remembered that
most authors were not concerned with any social reform to free all women from
patriarchal structures, but that the women discussed in these texts all present an
elite minority with access to power. It seems ironic that treatises that argue against
womens capability for political power never had to undergo the same scrutiny has
those defending them.
One paper of this section concentrates on one of the most famous writers
against female political engagement, Jean Bodin (1529/1530-1596). In her paper,
Anna Becker demonstrates how Bodin in his major work Les Six livres de la R-
publique connects conceptions of the political with questions of gender, notably
focusing on the relationship of husband and wife. For Bodin an understanding
of the family and its inherent relationship form the basis for an understanding of
politics, according to Becker. Tus, the very basis of politics is shaped by questions
of gender, family, and the relationships between the sexes. Te paper also refects a
major concern of this panel: to include discussions of political theory and to show
how these, too, were shaped by questions of gender, even though this has often
been overlooked by traditional historical scholarship.
Te three remaining papers in this section examine the nature and role of fe-
male consorts, depicting the interrelationship of the political, domestic, econom-
ic, and ideological aspects of the of ce. Trough their networks and communica-
tions women were part of various political power strategies and responsibilities; of
their natal families and that of their husbands, of their own and that of their peers.
In her analysis of various works that emerged around the Duchess of Ferrara, Ele-
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 132 03/05/2013 11:11:13
133
Introduction
onora dAragona (1450-1493), Linda Jauch shows in what ways writers believed
it was acceptable for women to engage in politics and the ruling of the state. Te
ffteenth century witnessed the emergences of various defences of women, espe-
cially around the Ferrarese and Mantuan courts. While these treatises have largely
been overlooked by political historians, they provide important insights into the
political understanding of ffteenth century thinkers and courtiers close the ruling
family. For a long time historical scholarship has tended to ignore sources that do
not ft with the modern paradigms of what makes a work a political treatise, or
likewise did not analyse political treatises with questions of gender in mind. Jauch
argues that Eleonora dAragona not only served as an inspiration and dedicatee
for these writings but that her own political style very much reassembles the ad-
vice given to her in these works. By not questioning male superiority to rule and
by equating the love for her husband with the love for her duchy, she was able
to become one of the most politically infuential women in the ffteenth century.
A very diferent strategy for power was applied by Mary Habsburg, Queen
of Hungary (1505-1558). As a widow she was determined to remain in charge of
her dower lands and Andrea Frhlich analyses the rhetorical strategies applied by
Mary to secure her possessions. While Marys court preacher, Johannes Henckel,
wished that some transformation would be possible and the queen would become
the king; for the fate of the homeland would then be better, Mary had to apply
a frm policy and oppose her brothers to protect her own status and her dower
lands, i.e. the portion of her deceased husbands estate which was granted to Mary
by law for life. Mary tried to secure her income from the mining towns given
to her as a dower. Te paper shows the problems of elite widows to secure their
income and infuence and how, unlike suggested by some recent historiography,
they often challenged their siblings and family to achieve their aims.
Te understanding of the family unit as basis for politics is a reappearing
theme in this section. It is here that further historical research should be directed
at. Not only is this an important factor in the thought of Bodin; for many of
the defenders of female power in the ffteenth century a successful relationship
between the ruling spouses was a prerequisite for a successful relationship between
ruler and subjects. Likewise, Mary Hapsburg tried to use familial ties in her at-
tempt to keep control of her territories. Te fnal paper of this section by Sarah
Bercusson outlines the often complex relationship between consort and ruling
husband in her analysis of the Austrian Archduchess Giovanna of Habsburg and
her sisters. Giovanna became Duchess of Florence in 1565. Her sisters, Eleanor
and Barbara, married the dukes of Mantua and Ferrara respectively. Bercusson be-
lieves that becoming a successful and infuential consort in early modern Italy de-
pended on a variety of factors, its basis again lying in familial relations: a consorts
ability to adapt to the new court and its values and traditions, a relatively early
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 133 03/05/2013 11:11:13
134
Capitolo 2. Gender and Politics in Early Modern Europe
birth of a male heir, a paid dowry, solid relations with the natal family, whether the
consort was able to establish good relationships with her courtiers and could thus
establish an independent power base, and, fnally, whether her husband allowed
her to participate in the running of the state. As a result, the female consort and
her designated court depended on much more shifting factors to exert (political)
infuence than the male ruler and his court.
As noted above, this section presents recent fndings by young scholars and
hopes to demonstrate new ways of combining research on political history with
questions of gender. It aims to provide a new understanding of early modern po-
litical history and to open up further points for discussion. Te political role of the
female consort, as wife and widow, her relations to writers and thinkers at court,
and the understanding of the family as basic political unit in the early modern
period all deserve more attention by future research.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 134 03/05/2013 11:11:13
1. Marriage and Rule in Jean Bodins Political
Thought
Anna Becker
Jean Bodins (1529/1530-1596) major work Les Six livres de la Rpublique
7
(1576)
is generally analysed chiefy regarding his seemingly wholly public conception of
indivisible sovereignty, and the Rpublique is foremost examined in its signifcance as
the foundational work of absolutism
8
. Tis scholarly focus is justifed with the con-
tention that it was mainly Bodins analysis of sovereignty that informed his think-
ing on the state and made the Rpublique a celebrated work
9
. Tereby it is often
overlooked that Bodins work outspokenly connected conceptions of the political
with questions of gender, most notably focusing on the relationship of husband and
wife. Bodins understanding of the political life was based upon a careful study and
exploration of the family and its power relationships, since these matters form the
foundations of his thinking on politics, the state, and public authority.
Te emphasis Bodin puts on the topic of the family is clear from the Rpub-
liques very beginning. Its frst chapter commences with the famous defnition
A Commonwealth is the rightful government of a number of households, and
7 Bodin, J. Les Six Livres de la Rpublique, Frmont, C.; Couzinet, M.D.; Rochais, H. (eds.), VI vols.,
Paris, Fayard, 1986; Bodin, J. De Republica Libri Sex, Frankfurt, 1594. All translations are my own.
8 See Franklin, J.H. Jean Bodin and the Rise of Absolutist Teory, Cambridge, Cambridge University
Press, 1973, p. VII; see Salmon, J.H.M. Bodin and the Monarchomachs, in Denzer, H. (Ed.), Jean
Bodin, Munich, C.H. Beck, 1973, pp. 359-378; see Skinner, Q. Te Foundations of Modern Political
Tought, vol. II, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, p. 285, n. 1.
9 Franklin, J.H. Introduction, in Jean Bodin, On Sovereignty, in Franklin, J.H. (Ed. and Transl.),
Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. xii-xiii.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 135 03/05/2013 11:11:13
136
Capitolo 2. Gender and Politics in Early Modern Europe
of those things which are their common concern by a sovereign power
10
. Bodin
then instantly defnes the family, or the household as the rightful government
of a number of subjects owing obedience to a head of the family, and of those
interests which are his proper concern. Te second term of our defnition of the
commonwealth refers to the family, which is the true source and origin of all
commonwealths, and their principal constituent
11
. Te fundamental notion of
Bodins understanding of politics emerges thus right from the start of his work
on political philosophy; he lays down that the family is at once the mirror, and
the source of the state. In his Latin translation Bodin calls the family the seed-bed
(seminarium) of the whole res publica
12
, thus echoing Cicero, who had used the
same comparison in De of ciis
13
. Te family, for Bodin, is thus both the principal
member, and the fundament of any res publica.
In this short article we turn to Bodin analysis of the conjugal relationship,
which is intimately intertwined with an exploration of the nature of rule. Bodin
thought that the conjugal relationship was the most important of the three gov-
ernmental relationships in the household, because the power of the husband over
the woman is the source and origin of any human society
14
. In what follows I
shall show that this is one of the central statements to understand Bodins notion
of power, notably the absolute power of the sovereign. Bodins conception of the
private marital power is a fundamental and vital part of his theory of the state and
thus a long neglected aspect of his political theory, which links his contemplation
of absolute sovereignty directly to notions of gender. For Bodin, as we shall see,
private power and public power do not denote two distinct entities. Rather, he
emphasises that one entails and requires the other. Bodin hence insists that the
nature of rule can only be explored by examining the smallest parts of rule, or
imperium, frst. Because Bodin wants to make it clear that it is with the conjunc-
tion of male and female that society and rule originate, we encounter in his work
a philosophical approach to the matter of ruling amidst the discussion of the
conjugal relationship. For absolute authority is an exact mirror of the power that
a husband has over his wife.
Bodin points out that as soon as we are living in a society, our liberty is neces-
sarily under potestas ac imperium of somebody else. All human societies united by
law, whether it be families or colleges, or universities, are maintained by the mutual
duties to rule and obey; so that that liberty, which nature has given to each and eve-
10 Bodin, J. Rpublique cit., I,1, p. 39.
11 Ivi, p. 39
12 Bodin, J. De Republica cit., p. 12.
13 Cicero, De of ciis, I (54).
14 Bodin, J. Rpublique cit., I, 2, p. 52.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 136 03/05/2013 11:11:14
137
1. Marriage and Rule in Jean Bodins Political Tought
ryone unrestricted by any law, is subjected to the imperium and potestas of somebody
else
15
. He shows that this is something entirely natural; it corresponds directly with
our nature. Natural liberty is such, that the soul, which is well shaped by nature,
would refuse any imperium other than that of the immortal God, except its own,
that is the right reason, which never disagrees with the divine will
16
. Mans own
natural liberty is already inherently defned by rule and obedience. Natural liberty
means that, although we are not constrained by the imperium of anybody else, we
are already under the command of our reason
17
. In the marginal notes Bodin refers
to Florentinus defnition of liberty as the natural power of doing whatever anyone
wishes to do unless he is prevented in some way, by force or by law
18
. But Bodin
stresses emphatically that instead of that which is forbidden by force or by the law,
i.e. by matters that lie outside ourselves and in the rules of human society, it is in
our very selves that the forces of command and obedience reside. Natural liberty as
such already contains an element of being ruled by our self, our own reason and
the divine will. Absolute freedom in the sense of not being dependent on anything,
or having any restraints whatsoever, is nonsensical and does not exist. Liberty and
command are inseparably connected. Tis thought, of fundamental importance to
understand Bodins political philosophy, helps furthermore to explain his notion
on the role of women in the structure of both the family and society. We can thus
understand that for Bodin it was no contradiction that a woman, as a free person,
was subservient to absolute command of her husband. Tis was directly refected
in his conception of citizenship. By comparison with the position of the woman
it becomes clear how for Bodin a citizen can be both free and at the same time be
ruled over with absolute sovereignty. Certainly this represents a commonplace in
political thinking. Aristotle does not see it as a contradiction to say that women
are half of the free population
19
, although they are not free to participate actively
in politics. Similarly in classical Roman law a person is free even if he or she is not
sui iuris and is, in fact, under the potestas of somebody else. To this efect, all fliifa-
milias, regardless of their age or public position, are free, but at the same time they
are under the potestas of their fathers. But whereas this seems to be on the margins
of the notions of the political for other thinkers, Bodin makes this fundamental
connection of liberty and obedience the central point upon which the relationship
of the citizen to the sovereign rests.
15 Bodin, J. De Republica cit., p. 21.
16 Ivi, p. 22.
17 See Brett, A. Liberty, rights and nature, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 165-
204.
18 Digest, 1.5.4.
19 Aristotle, Politics, 1260b8-1260b20.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 137 03/05/2013 11:11:14
138
Capitolo 2. Gender and Politics in Early Modern Europe
Te contention that stresses the inherent connection of liberty and obedience
is further expounded in Bodins analysis. Reason (ratio), he states, is the greatest
and oldest natural imperium of allover cupiditas
20
, and he emphasises, using a clas-
sical Ciceronian motif, that before we can govern anybody else rightfully, we frst
have to master our own desires
21
. Not only are liberty and command intrinsically
connected through the rule of ratio over cupiditas in a free being, but the virtue
of justice itself depends crucially upon achieving the correct relationship between
them. Yet this justice is the highest of all, it is the foremost and most noble of all
virtues, which have to be cherished and maintained before all the rest
22
. At this
point Bodin elucidates why he starts his chapter on conjugal relationship with a
contemplation of the origins of liberty and command. Bodin insists that master-
ing our own desires is the frst law of natural command (haec naturalis imperii
prima lex est)
23
, which God has given to humankind, and expressis verbis to the
frst of all matresfamilias
24
. Bodin does not explain this point any further, as it
must have been rather obvious to his contemporaries. In the marginal notes Bodin
refers to Genesis 3: After Eve had eaten from the tree of wisdom and after she had
made Adam eat from it, God curses her: and thy desire shall be to thy husband,
and he shall rule over thee. Tis is hence the exact moment in which God gave
imperium to Adam over Eve. Bodin lays down that that command (imperium)
which God gave Adam over his wife is to be understood in a double sense. Its
literal meaning is the power that God granted to husbands over their wives. But
above this, it also signifes the moral imperium of reason over appetite (libido)
25
,
and, as the French version states in addition, the command of lame sur le corps
26
.
To clarify his argument, Bodin adds a crucial passage to his Latin version
which we do not fnd in the French: the mind and the reasonable part of man,
he points out there, is like a husband
27
crucially he does not write like a man.
Tis important distinction is to be found throughout the Six livres. Bodins work
is deeply characterised by a gendered understanding of the mechanisms of politics.
But this understanding is subtle and complex: it is not suf cient to simply state
that Bodin operates with a general masculine-feminine dichotomy; he does not
liken imperium in both state and in human nature to the rule of the male over the
20 Bodin, J. De Republica cit., p. 22.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Bodin, Rpublique cit., I, 3, p. 52.
27 Bodin, De Republica cit., p. 22.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 138 03/05/2013 11:11:14
139
1. Marriage and Rule in Jean Bodins Political Tought
female faculty. Far more specifc, he constructs rule as a mirror of the husbands
power over his wife; and this is why Bodin discusses the nature of ruling in the
chapter on the conjugal relationship. Tis is acutely demonstrated in the narrative
of the creation of Adam in the frst chapter of the Genesis. Although this is before
the creation of Eve in Genesis 2, God said there: Here I create man and wom-
an
28
. Tis passage was a commonplace in Renaissance literature about women.
Te famous Leo Hebraeus, for example, in his celebrated Dialoghi dAmore, that
Bodin had read the work is demonstrated by the marginal notes to his discussion
of vita activa and contemplativa in the previous chapter of the Rpublique had
used the same passage to show Genesis 1 to be the birthplace of love. For Bodin,
however, this same passage signifes rather than the birthplace of love, the birth
of command. By referring to the frst chapter of Genesis Bodin can show that
Gods curse to the woman, making her subject to her husbands authority, denotes
equally and simultaneously a command over the husband-like and female parts
of the individual man himself. Bodin thus comes back to his initial point; it is
cupidit which the Holy Writ almost always calls a woman
29
.
Bodin thus holds that rule, command and obedience, and an intricate rela-
tionship of liberty and dependence, are the primary and structuring principles
which guide both the individual and society. But furthermore he highlights that
this principle of ruling is intrinsically gendered. Rule is the dominance of the hus-
band-like faculty over the feminine. Te Fall is the ultimate reason for this original
command. Te foundation of families follows from the Fall, and the subsequent
banishment from the Garden of Eden. Tese families now are fundamentally de-
fned by the mothers punishment to endure absolute command. And because, as
Bodin has shown, states emerge out of families and are their mirror images, it is
only logical that society is moulded after the blueprint of the absolute obedience
that a wife owes to her husband. But simultaneously the individual itself is gov-
erned according to the principle of husband-like command over feminine obedi-
ence. Tus the superiority of the husband over the feminine is all-encompassing;
it is the fundamental ordering principle of each person, of a well-ordered society,
and the universe. Bodin has therefore turned a discourse on the foundations of
ruling into a discourse of its conjugal elements; and has shown that the universe is
in itself determined by the principle of a husbands rule over his wife.
28 Ibidem; see Clyne Horowitz, M. Te Image of God in Man. Is Woman Included?, in Te Har-
vard Teological Review, n. 73, 1979, pp. 175-206.
29 Bodin, Rpublique cit., I, 3, p. 52.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 139 03/05/2013 11:11:14
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 140 03/05/2013 11:11:14
2. The Female Consort in Italy:
Giovanna of Austria and her Sisters
Sarah Bercusson
Introduction
Early modern scholars are paying increasing attention to the lives and roles of
aristocratic women; not only those who exercised power directly as queens or
regents, but also those who, as consorts, did not govern but headed courts of their
own. My own research focuses on the female consort and aims to build on recent
literature on the court by investigating the relationship between court households
and examining a socio-political context where the male ruler drew his authority
from his designation as sovereign, while his consort was forced to rely on a variety
of shifting, less formal factors to exert infuence. My analysis focuses on the lives
and activities of three women in particular: Eleonora, Barbara and Giovanna of
Austria, the daughters of the Habsburg Emperor Ferdinand I, who married into
the ducal dynasties of the Gonzaga, Este and Medici families, in the second half
of the sixteenth century. In this paper I will look at some of the factors that could
afect the position of the consort and explore some of the issues they might face.
The Female Consort as Alien
In almost all marriages contracted between ruling elites, the bride brought
courtiers with her to form part of her new household. Tis could be a threat to
the ruler, who had no claims to their loyalty, and to the other courtiers who might
not welcome rivals for the rewards and privileges ofered at court. Te ruler was
fully aware of the potential confict that could arise with an inimical court and
might take increasingly aggressive steps to ensure his control over his wifes actions
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 141 03/05/2013 11:11:14
142
Capitolo 2. Gender and Politics in Early Modern Europe
and the members of her household. One way of efectively isolating the consort
and ensuring that her relationships were formed under the guidance of her hu-
sband was by attempting to control the composition of her court at the start of her
married life. Te thorny question of who was allowed to accompany the bride and
the composition of her court therefore arose frequently in marriage negotiations.
The Composition of the Female Court
Eleonora came down to Italy before her two sisters and the negotiations for her
marriage were already taking place in 1560. A body of correspondence dating to
this period demonstrates that Guglielmo was keen to establish control over the
creation of his wifes household and to ensure that she was provided with courtiers
loyal to the Gonzaga dynasty. It appears from the letters that the future Duchess
of Mantua had little or no command over who came with her to her new residence
in Mantua the missives take into account only the will of the Emperor and Gug-
lielmo himself and Eleonoras voice is completely absent
30
.
Tis situation is refected in the arrangements made for the courts of Ele-
onoras two sisters, Barbara and Giovanna. As with Eleonora, it is questionable
how much choice Giovanna herself had in selecting her courtiers. Certainly the
evidence indicates that Giovanna was ultimately unable to assert her own wishes
over those of her male relatives, whether Florentine or German, in the composi-
tion of her court
31
. As a consequence of their husbands insistence upon the inclu-
sion of Italians in their courts, one of the key tasks the Archduchesses faced was
the establishment of relationships with people whom they did not know and with
whose language they were unfamiliar.
Female Networks and Patronage
Tere is clear evidence of substantial ducal intervention in the composition of
all three Duchesses households at the beginning of their married lives. However,
30 For archival sources I use the following abbreviations and sources: ASF = Archivio di Stato di Fi-
renze, MdP = Mediceo del Principato, Depositeria Generale Parte Antica: 643, Mediceo del Principato:
6355/A, 5094. ASM = Archivio di Stato di Mantova, AG = Archivio Gonzaga, Archivio Gonzaga:
200, 332, 1087, 2146. ASMo = Archivio di Stato di Modena, ASE = Archivio Segreto Estense,
Archivio Segreto Estense: Casa e Stato: 83, Cancelleria Ducale Estense: Ambasciatori, Agenti e Corrispon-
denti Estensi, Italia: Firenze: 24. Here: ASM, AG 200, Rubrica 17, Fascicolo I, II.
31 Katritzky, M.A. Te Florentine Entrata of Joanna of Austria and other Entrate described in a
German Diary, in Te Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, n. 59, 1996, p. 155, note
69. See also Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, ltere Ceremonialakten I, fol. 196r-197v. Tese
references are taken from Lietzmann, H. Der forentinische Wagen: eine Kutsche fr Giovanna
dAustria, in Munchner Jahrbuch der bildenden-Kunst, n. LIV, 2003, pp. 151-81.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 142 03/05/2013 11:11:14
143
2. Te Female Consort in Italy: Giovanna of Austria and her Sisters
while the Duchesses appear to have been unable to control the initial composi-
tion of their courts, their access to control over new appointments seems to have
difered. Archival documentation suggests that Eleonora may have been able to
arrange appointments to court positions without asking the Duke
32
, but in Gio-
vannas case, evidence indicates that the Duke of Florence, Francesco exerted on-
going control over the composition of Giovannas court
33
. Although she was able
to request and petition for certain people to join her court, she did not have the
fnal say over appointments. Her lack of control is illustrated by a letter dating to
1566. Here the Duchess apologises for not being able to take on a young girl as
her husband Francesco says she has enough ladies-in-waiting as it is
34
.
Not only did the two sisters situations diverge over court appointments, their
roles within their respective duchies also difered. Eleonora had an active of cial role
within the duchy. According to both her contemporary biographers, Eleonora had
been placed in charge of the administration of justice within the duchy with the help
of the Senate, and one of them also adds that she was left in charge in the absence
of her husband
35
. Tis enabled her to be publicly identifed as a fgure of authority,
capable of exercising power independently of her husband. Furthermore, she also
benefted from the possession of her own property, unlike her sisters. Eleonora held
the property of the Camata, which she had received as a gift from Guglielmo in
1561 and to which she had added a substantial amount of further land following
a fnancial gift from the Emperor on her visit to Vienna after the birth of her son
Vincenzo. Te property was adjacent to the Palace and gardens of Porto, which had
itself been given to Eleonora by her mother in law in 1566
36
. Tis property, while
relatively small, together with her judiciary role within the duchy gave Eleonora a
key independent platform from which to operate, and meant that she could extend
patronage of cially and without having to rely solely on interceding with her hus-
band. Tis in turn made it easier for her to establish a strong centralised rule within
her court and prevent loss of loyalty amongst her courtiers.
32 Letters survive from Eleonora appointing men to positions as bodyguards: ASM, AG 2146,
Fascicolo II, p. 63.
33 Tis is also the case for Barbara: ASMo, ASE, Sezione Casa e Stato 83, Lettere di Alfonso II
dEste Duca di Ferrara alla moglie Barbara dAustria, letter dated 15 March 1571 (unpaginated).
34 ASM, AG 1087, Fascicolo 5, p. 309.
35 Possevino, A. Vita et morte della serenissima Eleonora arciduchessa di Austria et duchessa de Mantova.
Recitate nelle generali essequie di lei, Mantua, 1594, pp. 30-31; Folcario, A. Vita della serenissima Eleo-
nora duchessa di Mantova collaggiunta delle meditationi che faceva in vita, e dellestratto di quelle
colle quali si prepar alla morte, etc, Mantua, 1598, pp. 81-82.
36 ASM, AG 332, Rubrica 2, unpaginated; Folcario, A. Vita della serenissima Eleonora cit., p.23;
Bilotto, A.; Rurale, F. (Eds.), Istoria del collegio di Mantova della Compagnia di Ges scritta dal padre
Giuseppe Gorzoni, Mantua, Gianluigi Arcari, 1997, p.88.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 143 03/05/2013 11:11:14
144
Capitolo 2. Gender and Politics in Early Modern Europe
Eleonoras position was further strengthened by the fact that of the three sisters
who came down to Italy, she was the only one who received her dowry
37
. By hav-
ing her dowry paid on time, by providing Guglielmo with a son early on in the
marriage, by having an independent residence at Porto and a source of patronage
in her possession of the Camata, and by possessing of cial judicial powers, Eleon-
ora created a strong position for herself as head of her court, Duchess of Mantua
and a patroness in her own right.
Giovanna, on the other hand did not have any governmental role, nor did she
own any property. While Eleonora had her own palace, Giovanna was allocated
apartments in the Palazzo Vecchio, where her husband also lived. Te Duchess
had her own ladies in waiting, male companions, chaplain and servants, and she
lived in her own rooms; but although on the surface she might appear to inhabit
a parallel and independent universe from that of her husband and his court, in
fact there were continual overlaps and ambiguities in the way that it was fnanced
and run. Male control over the female court was not only manifest in ducal in-
terference in the appointment of courtiers it was also revealed in the fnancial
arrangements made for the consort and her court. Like her sister Barbara in Fer-
rara, Giovanna relied entirely on the allowance she received from her husband.
According to the terms of her marriage contract, she was to use this allowance to
pay for her own upkeep and that of her courtiers, however the archives reveal that
both Giovanna and Francesco paid provisions to the members of her court, giving
a clear indication that the female court was not considered, at least from a bureau-
cratic point of view, a completely separate entity
38
. Tis is another indication of
the fuid boundaries between the courts and the lack of a defned space in which
Giovanna was sole and unopposed head. All this gives us a far more nuanced vi-
sion of the way in which diferent female courts might operate.
The Collapse of Giovannas Court
In the frst half of this paper, I have sought to discuss and identify some of the
dif culties female consorts could face in defning their own separate identity and
constructing an independent power-base at court. I have highlighted the suspicion
the consort faced as a potentially dangerous alien, and emphasised the fuidity of
the boundaries that separated the male and the female court and the potential over-
laps between the consorts area of control and that of her husband, with consequent
erosion of her autonomy. Te female court could co-exist in a stable and measured
37 ASM, AG 200, Fascicolo I, pp. 108-115
38 ASF, Depositeria Generale, Parte Antica 643, Fascicolo dated 1577-1578, p. 818.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 144 03/05/2013 11:11:14
145
2. Te Female Consort in Italy: Giovanna of Austria and her Sisters
way with the male court and Eleonora provides just such an example. However, such
success depended on the maintenance of positive relationships with both courtiers
and key powerholders, relationships which were in turn dependent on variable and
shifting factors. I will now turn to a more detailed discussion of Giovannas situation
in Florence as it provides a useful example of the vulnerability of the female consort
and the problems that could arise when key relationships soured.
Giovanna faced a series of problems in establishing successful relationships
in Florence. First of all, she was a foreigner, and therefore without ready-made
alliances in the Florentine court, second Habsburg lack of funds entailed that
Giovannas dowry was never paid and she was not endowed with any independ-
ent means of fnancing herself or her court, third she was for many years unable
to provide the essential male heir to the duchy, fourth she was forced to compete
with the Dukes mistress Bianca Cappello for the his attention and for the role of
key intercessory agent, and fnally, she was active in the interests of her Habsburg
relatives. Indeed, Giovanna not only protected Habsburg interests but also went
against those of her new family, much to the anger of her husband who wrote in
response to her request for a loan:
Whoever gives 3,000 scudi at a time to Prayner [Baron Preiner], who Her Hi-
ghness [Giovanna] knows is an enemy of her house [i.e. the Medici], can easily
sort out paying her own debts, it being no surprise that she has them throwing
money away like this
39
.
Te most important problem Giovanna faced, however, especially during the
later years of her residence in Florence, was without doubt the alternative source
of feminine patronage evinced by the powerful fgure of Bianca Cappello, Franc-
escos mistress and later wife. Biancas permanence on the scene in Florence, and
the fact that she had the ear of the Duke meant that Giovanna was confronted
with an extremely powerful rival for the role of ducal intermediary.
A detailed chronicle of Giovannas struggle with Francesco and the deteriora-
tion of her position at court is provided by the Ferrarese ambassador Ercole Cor-
tile. His account of the deteriorating situation between Giovanna and Francesco
is confrmed by further correspondence that circulated between the Duchess, her
Habsburg relatives and her allies
40
. Cortile was ambassador in Florence in the
39 chi dona 3/m di per volta al Prayner, che sa Sua Altezza esser linimico di casa sua, puo pensar
facilmente pagar li suoi debiti, non sendo meraviglia che si faccino buttando via li denari a questo
modo. ASF, MdP 6355/A, p.63.
40 See for example the letters exchanged between Giovanna and Baron Preiner, ASF, MdP 5094,
Fascicolo I, pp.109, 115.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 145 03/05/2013 11:11:14
146
Capitolo 2. Gender and Politics in Early Modern Europe
years between 1575 and 1577. In his correspondence for these years he described
a situation in which Francescos mistress, Bianca Cappello, was receiving the at-
tention and loyalty which was actively prevented from reaching the Dukes wife,
Giovanna. Te ambassador repeatedly wrote that all of Florence went to Bianca
for help and to gain positions and prestige
41
. Tis was the role that Giovanna was
supposed to play and its removal and the Dukes lack of interest in her meant that
her powers to run her court and ensure the loyalty of her courtiers were severely
curtailed. A letter from October 1575 illustrated the receding of Giovannas posi-
tion as Cortile recounted that Francesco had chosen to severely limit the num-
ber of her personnel, ruling that only a certain few gentlemen could attend the
Duchess, and those had to be selected by him
42
. We now see that the control that
Francesco had only mildly asserted at the beginning of Giovannas life in Flor-
ence is now aggressive and threatening. Te contents of Cortiles letters reveal that
Giovannas status as head of her own court was so compromised by l576 that she
could no longer have any trust in those courtiers she had around her. He claimed
that her courtiers, and the Countess of Bagno is picked out as a particular culprit,
far from being her servants, had now become her keepers, spying on her and ready
to intercept any letters which she might attempt to smuggle out
43
. Although the
Countess may have been required to operate as a spy, we cannot be sure as to the
extent of her actual desire to fulfl this role. Indeed it appears that when the Coun-
tess was taken on as one of Giovannas ladies, Giovanna proclaimed herself very
fond of her and intervened with her brother-in-law, the Duke of Mantua to help
her son
44
. Te Countess situation provides a clear example of a scenario where the
Dukes desire to intervene in the female court as the stronger power-holder could
shatter traditional courtly relationships and create a situation where courtiers were
forced to choose between conficting demands for loyalty.
Unfortunately for Giovanna, even when she was fnally able to reveal to her
natal family the trials she was enduring at the hands of her husband, this did her
little good. Te alliance with the wealthy Medici was too useful to the debt-ridden
Imperial family to allow any severing of relations. Her brother the Archduke of
Tyrol remonstrated with Francesco furiously, but he could provide no real suc-
cour.
41 For example: Hereone must go through Bianca for everything. ASMo, Cancelleria Ducale
Estense: Ambasciatori, Agenti e Corrispondenti Estensi, Italia: Firenze: Busta 24, Fascicolo 13, letter
dated 28 April 1576.
42 Ibidem, Fascicolo 12, letter dated 31 December 1575.
43 Ivi, Fascicolo 14, letter dated 29 July 1576.
44 ASM, AG 1087, Fascicolo 5, p.372.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 146 03/05/2013 11:11:14
147
2. Te Female Consort in Italy: Giovanna of Austria and her Sisters
Conclusion
Te situation described over these critical years by Cortile provides evidence of
how the success of the consorts court depended on a variety of key factors, in-
cluding her own character and her willingness to adopt new customs and support
her new family, the attitudes and demands of her native family and their power
to intervene on her behalf, the presence or absence of a single powerful mistress at
court, the network of alliances the consort managed to weave, whether her dowry
had been paid, the extent to which she was allowed to participate in administra-
tive or judicial activities, and fnally whether or not she had yet produced a male
heir. Te fuidity of the boundaries separating the male from the female court
and the potential for ducal intervention ensured that if the consort failed to live
up to expectations, her position was infnitely vulnerable. Tis is exemplifed by
Giovannas situation as she struggled on almost all the above counts: unlike her
sisters she had no access to of cial means of participating in the government of
the duchy; and unlike them she was profoundly ambiguous in her attempts to as-
similate. She was under pressure from her native family to act in their interests and
she appears to have chosen to operate on their behalf and to present herself as a
Habsburg frst and foremost. Unlike Eleonora, she was also without an independ-
ent powerbase and she was upstaged by and powerless to get rid of the contender
for her intercessory role, Bianca Cappello. Furthermore she was in a precarious
position fnancially her dowry was never paid and she relied on the Duke for her
allowance. Her refusal to accept the status quo and to ally herself incontrovert-
ibly to the Medici, combined with these factors, resulted in Francescos increasing
confict with her and his intervention in her court, until the relationship between
Duchess and courtier was fatally harmed, and she was no longer seen as a reliable
patron, as she no longer had the essential support of the Duke. Tis course of ac-
tion had been advised against by Eleonora: there is a letter from her in which she
urges Giovanna to behave like a wise princess and look to God for comfort from
her tribulations, as otherwise next time her fght with Francesco might not end
so well
45
. Te intimation, one that might apply to many female consorts, is that
Giovanna should hold her tongue for fear of worse.
45 ASF, MdP 5094, Fascicolo I, p. 97.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 147 03/05/2013 11:11:14
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 148 03/05/2013 11:11:14
3. Mary Habsburg and her Hungarian
dower lands
Andrea Frhlich
In March 1526 Johannes Henckel, Mary Habsburgs court preacher, wrote to a
councillor in Kaschau, Hungary, I wish that some transformation would be pos-
sible and the queen would become the king; the future of the homeland would
then be better
46
. Tough she was only 21 when this letter was written it is clear
that Mary Habsburgs preacher recognised and admired the young queens politi-
cal abilities, and thought her capable of playing an active role in the then troubled
state of the kingdom of Hungary. At the time the letter was written, Queen Mary
was engaged in a struggle with the Fugger bankers in Hungary, motivated by the
need to protect her dower lands. Tis short article will examine Marys attempt,
as queen and dowager queen of Hungary, to protect those dower lands. Te strug-
gle, which lasted twenty-six years, brought her into confict with her husband, the
Fugger bankers and her own Habsburg family. Marys determination to protect
her property rights in the kingdom of Hungary show her as a woman determined
to defend her own independent fnancial position within her royal house. Te
incidents involved in her actions also draw into question historians portrayal of
Marys life as a woman solely or principally, dedicated to the service of male mem-
bers of her family.
Mary was born in 1505, the daughter of Philip of Burgundy and Joana of
Castile. Within a year her grandfather, Emperor Maximilian, negotiated a mar-
riage contract for her with the as-yet unborn son of King Ladislas of Bohemia
and Hungary. Marys early years were spent in Mechelen in the care of her aunt,
46 Kaschau is Koice in modern day Slovakia, Magyar Orszgos Levltr, Budapest, Dl 47654.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 149 03/05/2013 11:11:14
150
Capitolo 2. Gender and Politics in Early Modern Europe
Margaret of Austria, regent of the Low Countries, where she was undoubtedly
infuenced by her aunts political prominence and humanist court. Te marriage
contract between Mary and king Louis of Hungary was formally concluded with
their marriage in 1522: four years of marriage, and consort-queen of Hungary
followed until her husband was killed at the battle of Mohcs in 1526. On the
death of her aunt Margaret, Marys brother, the emperor Charles V, appointed her
regent of the Low Countries, where she returned in 1531. Mary remained in this
position as regent until 1555. She died at Cigales (Spain) in 1558.
Historians have long been aware of Marys role in Habsburg politics, par-
ticularly as regent of the Low Countries. Research has, however, focused on a
relatively narrow range of related topics servitude to the house of Habsburg, as
well as Marys interest in aspects of the Reformation, of humanism and the arts.
Marys political life as one of service to the Habsburg cause remains a common
assertion in scholarly studies of her life. In her discussion of Habsburg women in
the court of Philip III, Magdalena Sanchez wrote,
Royal women, because of their lineage and upbringing, were political creatures.
Teir marriages were politically motivated, and they served in foreign countries
as unof cial diplomatic representatives for their relatives Tis attitude was
particularly true of Habsburg women, such as Margaret of Austria, Charles Vs
aunt, or Maria of Hungary, sister of Charles V, who historically served as regents
or governesses of important territories
47
.
Marys writing and correspondence serve, in part, to support such a reading of
her life, and her words often mislead the historians attempt to produce a holistic
reading of her life. Marys letters to emperors Ferdinand and Charles are couched
in a vocabulary of loyalty. When she, at times, explicitly expresses dissatisfaction
with various matters, she typically follows with words of apology for her upset.
My research suggests that, though on the surface Mary Habsburg appears to be
the obedient sister, dedicated to her family, the reality is much more complex.
Recently two Hungarian historians, Andrs Kubinyi and Zoltan Csepregi,
have forwarded a new idea, that of Mary Habsburg serving the Hungarian court
in opposition to her own Habsburg family
48
. Such an interpretation leaves Mary
47 Snchez, M. Te Empress, the Queen and the Nun, Baltimore, Johns Hopkins University Press,
1998, p. 5.
48 Kubinyi, A. Te Court of Queen Mary of Hungary and Politics between 1521 and 1531, in
Rthelyi, O. (ed.) Mary of Hungary: the Queen and her court, 1521-1531, Budapest, Budapest His-
tory Museum, 2005, pp. 13-25; Csepregi, Z. Court Preachers in the Entourage of Queen Mary,
in Rthelyi, O. (ed.) Mary of Hungary. Te Queen and her Court 1521-1531, Exhibition Catalogue,
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 150 03/05/2013 11:11:14
151
3. Mary Habsburg and her Hungarian dower lands
in the role of dynastic servitude. Tis article will instead argue that Mary was
determined to protect her own position within a dynasty, even when that brought
her into confict with her husband or fraternal Holy Roman Emperors. Marys de-
termination to retain her Hungarian property, passed to her on marriage to Louis,
demonstrates her will and ability to openly challenge the policies of her brothers.
Here, Mary can be seen as determined in her desire to carve her own fnancial
position within her royal house.
In her marriage contract, drawn up in Vienna in 1515, it was confrmed that,
on marriage to Louis, Mary would receive among other property, seven mining
towns as her wedding morning gift or Morgengabe
49
. Tese seven towns of Schem-
nitz, Kremnitz, Neusohl, Libethen, Pukkanz, Knigsberg and Diln formed the
largest proportion of the income for the queens household in Hungary
50
. Te
wedding was concluded in January 1522 and shortly thereafter Louis gifted these
mining towns, to Mary. Te agreement stated that Mary would receive 25,000
ducats a year and, if revenue from this property fell short of that amount, the king
would compensate by paying the diference. If, however, Marys property yielded
more than 25,000 ducats, the surplus revenue fell to her
51
.
Te Hungarian queens connection with these seven mining towns in the
Carpathian mountains dates back to 1428 when Sigismund of Hungary, in an
attempt to reconcile with his wife Barbara of Cilli, bequeathed to her the seven
mining settlements. Te grant was intended to enable queen Barbara, even if she
were rendered a widow, to maintain a court ftting to her station. Tereafter the
tradition continued that the mines remained the property of the queens of Hun-
gary and were typically granted as Morgengabe.
Te use of new chemical processes and mechanical devices to aid mining pro-
duction increased the productivity of the mines in late ffteenth-century Hungary,
particularly following fnancial investment from the Fugger Turz company.
While the mines continued to be gifted to the queens, the increased value of the
mining area led to attempts to curtail this tradition. Matthias Corvinus widow
Beatrice had the mines confscated in 1497. Queen Anna, wife of king Ladislas,
possibly under duress, signed the mines over to the Fugger Turz consortium the
day after they were gifted to her by her husband in 1502
52
.
Budapest, Budapest History Museum, 2005, pp. 48-61.
49 Hatvani, M. Magyar trtnelmi okmnytr, I, Pest, Eggenberger Ferdin nd Akad., 1857, pp. 54-63.
50 Tese are the German names of the towns, used in contemporary documents. All of the towns are
in modern day Slovakia, known today as: Kremnica, Bansk tiavnica, Bansk Bystrica, Lubietov,
Pukanec, Nov Baa, Bansk Bel.
51 Hofkammerarchiv, Vienna, Vermischte Ungarische Gegenstnde 1 (hereafter HKA VUG), fol. 13.
52 Probszt, G. Die niederungarischen Bergstadte. Ihre Entwicklung und wirtschaftliche Bedeutung bis
zum bergang an das Haus Habsburg, Munich, Oldenbourg, 1966, p. 68.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 151 03/05/2013 11:11:14
152
Capitolo 2. Gender and Politics in Early Modern Europe
Mary was determined not to relinquish control of the mines. When the Fug-
ger Turz lease expired in 1523, Mary took the opportunity to appoint her own
commissioners to administer the mining towns. In 1524 Bernhard Beheim was
named her Kammergraf
53
. Tat same year Marys envoys to the mining towns com-
piled a list of the losses sufered by the king and queen at the hands of the Fug-
gers
54
. Mary fuelled the fres of opposition in Hungary to the Fugger Turz frm.
At the diet of Hatvan, in 1525, the Hungarian nobility raised complaints against
the guilty exploiters whom they identifed as the Fuggers, foreign courtiers and
Lutherans
55
. Mobs looted the Fugger house and factory in Buda and anti-Fugger
activity culminated with the confscation of Fugger property throughout Hun-
gary. Te mining area was once again under royal control, or more precisely that
of Queen Mary.
Yet Marys administration of the towns was not without problem. Dissatis-
fed with the debasement of coin and most likely with working conditions, the
copper-mining town of Neusohl rebelled. An additional problem arose when
Marys Habsburg family expressed dissatisfaction with Marys actions against the
Augsburg banking family in Hungary. Charles V put pressure on Louis to enter
into another contract with the Augsburg bankers. Mary was dissatisfed with the
terms of the new contract, but did not resist the Fuggers return, most likely as she
appreciated they would correct the decline in production sufered since the Fug-
gers withdrawal
56
. Mary later claimed, that Louis sought more favourable terms
on her behalf and would remedy matters on his return from the Turkish wars
57
.
King Louis never did return from the war with the Turks. He met his end in
August 1526 in a swamp near Mohcs while fghting Suleyman the Magnifcents
troops. John Szapolyai, a Hungarian nobleman absent from the battle, was elected
king by the Hungarian diet; but Ferdinand Habsburg, brother of Mary and hus-
band of the dead Louiss sister Anna, claimed the crown through marriage and on
the terms of a contract agreed at Vienna in 1515
58
. Ferdinand knew, that in order
53 Kammergraf was the name given to the highest royal of cial in the mining towns.
54 Hei, G. Knigin Maria von Ungarn und Bhmen (1505-1558), unpublished PhD dissertation,
University of Vienna, 1971, p. 281.
55 Fraknoi, V. Ungarn vor der Schlacht bei Mohcs (1524-1526), Budapest, Laufer, 1886, p. 114;
Ratko, P. Dokumenty, Bratislava, Vydavatelstvo Slovenskej akademie vied., 1957, p. 463.
56 Paulinyi, O. Te Crown Monopoly of the Refning Metallurgy of Precious Metals and the Tech-
nology of the Camaral Refneries in Hungary and Transylvania in the Period of Advanced and Late
Feudalism (1325-1700), in Kellenbenz, H. (ed) Percious Metals in the Age of Expansion, Stuttgart,
Klett-Cotta, 1981, pp. 27-39, here: p. 38.
57 Hatvani, M. Magyar trtnelmi okmnytr II, Pest, Eggenberger Ferdin nd Akad., 1858, p. 183.
58 HKA, VUG 1, fol. 121.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 152 03/05/2013 11:11:14
153
3. Mary Habsburg and her Hungarian dower lands
to successfully wrest the crown from Johns hands, he would need the support of
his sister, the dowager queen Mary. Ferdinand appeared, at frst, unsure of his sis-
ters support. In the autumn of 1526 Ferdinand appealed to Mary for support and
promised her protection from the rival and newly crowned king John. Ferdinand
knew it was in Marys interest that he become king; it was unlikely, with John as
king, that her dower lands would remain in her possession. Mary remained in
Hungary until Ferdinand invaded in July 1527; she negotiated with the Hungar-
ian nobility, often using her own funds to buy their support
59
. At Ferdinands
coronation in October 1527, Mary occupied the seat next to him, symbolically
endorsing his claims to the crown of Hungary
60
.
With her brother Ferdinand now king, Mary immediately turned her atten-
tion to securing his recognition of her property rights in Hungary. Ferdinand had
agreed, in August 1527, to pay Mary a monthly allowance; this promise was most
likely made on the basis that Mary would serve as his regent in Hungary, a post
Mary later refused. Neither the income from the mining towns, nor the allowance
agreed to by Ferdinand, was paid regularly in the years between 1527 and 1531
61
.
From the time Mary refused the post of regent of Hungary, Ferdinand and his ad-
visors attempted to persuade Mary to relinquish her property rights to the mining
towns. Ferdinand succeeded in gaining his sisters acquiescence to her Bohemian
property, but faced a struggle of twenty-two years to bring her Hungarian dower
lands under his control.
When Mary was appointed regent of the Low Countries by her brother em-
peror Charles V her claims to the dower entitlements intensifed. Te cost of up-
keep of her court in Brussels was estimated at 67,000 forins; Charles was prepared
to meet 47,000 of that cost, the remaining 20,000 forins he thought Mary could
acquire from her Hungarian dower income
62
. Opposition in Hungary towards
Marys claims of ownership was growing. Continued war with the Turks, and
Habsburg war with John Szapolyai, depleted the resources of the kingdom. Mary
appealed to Ferdinand to keep her mining areas neutral in any fghting, to ensure
her continued income. Ferdinand refused to issue any such guarantees. After 1529
the mining areas in Transylvania came under the control of John Szapolyai, sup-
ported by the Ottoman sultan. Tereafter, the diet of Habsburg Hungary opposed
59 Bauer, W.; Lacroix, R. Die Korrespondenz Ferdinands I. Familienkorrespondenz 1527 und 1528,
Wien, A. Holzhausens Nfg., 1938, p.17, p. 19, pp. 65-66.
60 Plfy, G. Koronzsi Lakomk a 15-17 Szzadi Magyarorszgon, in Szzadok, n. 138, 2004, pp.
1005-1101, here: p. 1098.
61 Bauer/Lacroix, Familienkorrespondenz 1527 und 1528, cit, p. 146, p. 162.
62 Wolfram, H.; Tomas, C. Die Korrespondenz Ferdinands I. Familienkorrespondenz 1531 und 1532,
Vienna, Holzhausen, 1973, pp. 234-235.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 153 03/05/2013 11:11:14
154
Capitolo 2. Gender and Politics in Early Modern Europe
any revenue from the remaining mines leaving the kingdom and requested that
Ferdinand confscate the mines from his sister
63
.
All the while, Mary stubbornly continued with her battle for full recognition
and payment of her dower entitlements in Hungary. She maintained her own
representation in the mining towns, and she closely scrutinised news from the
towns. In 1537 Mary called her Kammergraf, Bernhard Beheim, to Brussels where
she had him imprisoned for fnancial irregularities
64
. Mary also remained in direct
communication with the towns councils. With the death of John Szapolyai in
1541, Marys struggle for full recognition of her Hungarian property entitlements
again intensifed, though with little success. In 1546, the Fuggers chose to with-
draw from their activities in Hungary. Te Ottoman threat, internal problems,
and new world metal (especially silver) on the market made the Hungarian con-
cern too great a risk. Mary was now the only obstacle to bringing the mines under
royal control. Ferdinands wife, Anna, had sought to have the mines gifted to her
as queen, but her hopes were not realised
65
.
Ferdinands battle to convince Mary to relinquish her Hungarian property
ended in 1548, when Mary, Ferdinand and Charles met in Augsburg and all par-
ties reached an agreement. On 7 March 1548, a contract was signed at Augsburg
which ended the 120-years tradition of the Gran river mining towns being the
property of the Hungarian queen
66
. Why, after over twenty years of resistance,
Mary fnally acquiesced to such agreement is unknown. It is likely that, pressure
from Charles and Ferdinand to come to an agreement that would end the argu-
ment between the siblings, exercised her greatly. Although what Mary received in
compensation under the terms of the Concordia was much less than that to which
she claimed entitlement, the terms were tolerably favourable. Te settlement al-
lowed Mary an annual sum of 34,000 Hungarian forins for the rest of her life and
the right to gift, in her will, some 200,000 Hungarian forins.
Tus, despite resistance the tradition of the seven mining towns being the
property of the Hungarian queen ended with Mary Habsburg. Te battle to re-
tain these lands allows us a glimpse into Marys concept of living in a dynasty, as
a woman who held no political position in her own right. Mary Habsburgs life
went beyond servitude to her family. She sought to create and maintain her own
independent fnancial position while living within royal households.
63 Schmidt, F.A. Chronologisch-systematische Sammlung der Berggesetze der sterreichsichen Monarchie.
Erste Band: 1053-1564, Vienna, Sollinger, 1834, p. 117.
64 Hatvani, Magyar trtnelmi okmnytr, I, cit, p. 376.
65 HKA VUG 1, fol. 131.
66 HKA VUG 1, fols. 660-662.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 154 03/05/2013 11:11:14
4. Eleonora dAragona and the discourse
surrounding female political power in
Quattrocento Northern Italy
Linda Jauch
Eleonora dAragona was a successful and politically infuential consort. She per-
sonally controlled, for example, the various accounts, credits, debits, outgoing
and incoming payments of the duchy of Ferrara on a weekly, monthly, and annual
basis
67
. She further undertook various diplomatic missions and ensured that du-
cal towns like Modena paid their taxes
68
. But Eleonora dAragona had been in a
strong position even before she married Ercole dEste, Duke of Ferrara, Modena,
and Reggio, in 1473: she was already a princess, daughter of King Ferrante I of
Naples and Isabella di Chiaramonte. Eleonora was also an established personality,
with her twenty-three years being relatively mature for a Renaissance bride
69
.
At the beginning of his reign, the other Italian rulers regarded Ferrara and
Ercole largely with hostility. Te new Milanese Duke, Galeazzo Maria Sforza,
to whose brother Eleonora had previously been engaged, did not want his great
rival, Ferrante of Naples, to establish a Ferrarese link via Eleonora
70
. Shortly be-
fore the death of Ercoles predecessor, Borso dEste, Galeazzo, in an attempt to
67 Chiappini, L. Eleonora dAragona, prima duchessa di Ferrara, Rovigo, S.T.E.R, 1956, pp. 38-39.
68 For Eleonoras travels see Massarenti, A. In cammino: unanalisi dei viaggi compiuti da Eleonora
dAragona, unpublished PhD thesis, Ferrara, Universit degli studi di Ferrara, 2005.
69 Klapische-Zuber gave the average age of sixteen for Florentine brides in the ffteenth century. See
Klapisch-Zuber, C.; Herlihy, D. I toscani e le loro famiglie: uno studio sul catasto forentino del 1427,
Bologna, Mulino, 1988, pp. 534-542.
70 Ilardi, V. Towards the tragedia dItalia: Ferrante and Galeazzo Maria Sforza, friendly enemies and
hostile allies, in Abulafa, D. (Ed.), Te French descent into Renaissance Italy, 1494-1495: antecedents
and efects, Aldershot, Variorum, 1995, p. 113.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 155 03/05/2013 11:11:14
156
Capitolo 2. Gender and Politics in Early Modern Europe
bring Ferrara under Milanese infuence, told his ambassador to Ferrara, Hiero-
nymo Maletta, to make sure Ercole would sign a pact of neutrality for the case
that Milan should be attacked. Galeazzo Maria, on the other hand, would not
object to Ercole gaining the rule of Ferrara, or force Ercole to ofend its neighbour
Venice. Further, Maletta had the task to convince Ercole not to marry a daughter
of his enemy Ferrante but Barbara Gonzaga who was pretty, gallant, and all for
good
71
. But Ercole refused to promise anything to Galeazzo Maria Sforza. Rather,
he reminded Maletta of his own standing and power. In a letter to Galeazzo Maria
Sforza, Maletta recounted Ercoles arguments:
Because he had come to this state a lord and a free man, and therefore he did
not wish to make himself a subject or a servant, as he would do if he were to sign
those treaties and conventions, which we have discussed together. Because he
wishes to be in his liberty to be neutral or not as it seems to him and as it would
be best for him and for his state. But he wishes to assure your lordship that he will
always be a good friend and inferior to you, and not less but more, than anyone
of his predecessors have been
72
.
Ercole was keen to assure that even though he would marry a princess, he would
still be Galeazzos inferior. From the beginning of the two-year long marriage nego-
tiations between Ferrara and Naples, Eleonora was the proof of Ercoles personal
and political freedom, his power, and the new Este lineage he wished to create. Te
marriage with Eleonora thus underlined his acceptance as independent Renaissance
lord. He did not merely want to marry a beautiful, benign Gonzaga girl with Sforzas
blessing. One cannot highlight enough Eleonoras important and powerful position
in this marriage right from the start. Even though Eleonoras arrival at the court of
Ferrara was a decision made by the men around her, her personal and political posi-
tion was strong and she would become one of the most infuential female consorts
of the ffteenth century. But Eleonora also never questioned male superiority to rule.
I would like to suggest that she thereby followed the advice given to her in various
treatises on governance that were either dedicated or directly connected to her.
71 Galeazzo Maria Sforza to Hieronymo Maletta, 20 August 1471. Archivio di Stato Milan (hereafter
ASMi), Sforzesco (Ferrara), 323, cc. 98-101. Bella, galanta, et tutto da bene.
72 Hieronymo Maletta to Galeazzo Maria Sforza, 24 August 1471. ASMi, Sforzesco (Ferrara), cartella
323, cc. 117-118. Perch in questo stato el venuto signore et libero e per non se vole fare subdito
n servo come el se faria quando el venesse ad quelli pacti et conventione quali insieme havemo
preaticati perch vole essere in libert sua de essere neutrale, o no, como gli parir e meglio se facia
per luy e per el stato suo ma che ben certifca la vostra signoria che sempre gli ser bono amico et
inferiore et non manco, imo pi che sia stato niuno suo antecessore.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 156 03/05/2013 11:11:14
157
4. Eleonora dAragona and the discourse surrounding female political power
Already before her arrival at Ferrara Eleonoras tutor and adviser to her father,
Diomede Carafa (c. 1406-1487), dedicated and his most famous and important
work, I doveri del principe, to her
73
. Te treatise is a very practical and applicable
guide of how to govern well and maintain power. Carafa repeatedly reminded
Eleonora that the preservation of the state should be the main goal of the rul-
ing dynasty that stands above bonds of friendship or family. He discussed the
regional and situational diferences of courts to highlight Eleonoras complicated
role in her husbands realm and to urge her to establish bonds of faithfulness and
sympathy at Ferrara. Carafa emphasised the importance of especially Eleonoras
eloquence and her role as intermediary between the ruler and his subjects for the
good of the state note well, madamma mia, he wrote, that it is not possible to
give gold and money and goods to all you talk to, as these arent endlessly avail-
able. But wise words and good council you can give to all
74
. Te female consort
here is turned into a guardian of the people, someone who prevents a tyrannical
ruler and fosters content subordinates.
Bolognese notary Sabadino degli Arienti confrmed this role of the consort
even more explicitly. In his Gynevera de le clare donne (around 1490) he had one
of his female exemplars state that rulers must with all their power transfer every
advantage, proft and beneft to their subjects and citizens from whom came the
good, loyalty and security of the state
75
. Te consort is supposed to guarantee a
successful relationship between ruler and his subjects. She watches over the moral-
ity of the state and the well-being of its subjects. She can, through her impact on
her sons, prevent a tyrant and educate a moral prince. Her role becomes much
more political far beyond a mere child bearer and prestigious dynastic link, al-
ready commencing with the praise of her the love for her husband which refects
a personal harmony that extends into the social harmony of the state. From De-
cember 1489 Arienti had sent individual biographies to possible patrons, such as
the biography of Isabella di Chiaramonte to her daughter, Eleonora dAragona
76
.
73 Te vernacular title conventionally given to Carafas treatise, I doveri del principe, is a nine-
teenth-century addition; the original is untitled. Carafa, D. Memoriali. Edited by Franca Petrucci
Nardelli, with Antonio Lupis and Giuseppe Galasso, Rome, Bonacci, 1988, pp. 97-209.
74 Ivi, p. 131. Che non foria possebile ad tucti ve parlano dare auro et argento et robba, ch no li
bastaria lo mundo. Ma s, che bone parole et bona cera porrite dare ad tutte.
75 Degli Arienti, G.S. Gynevera delle clare donne. Edited by C. Ricci and A. Bacchi della Lega. Scelta di
curiosit letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XIX; 223. Photoreproduction of edition published
Bologna, 1887, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1968, pp. 297-298. Sempre dicea, che
li signori doveano cum ogni sforzo loro transferire lutile, le richeze e l bene a li subditi et citadini
loro, da li quali procedea el bene, la fede et la securit del stato ne li loro signori, li quali doveano
solamente triumphare et godere del titolo del principe.
76 Degli Arienti, G.S. Te letters of Giovanni Sabadino degli Arienti (1481-1510). Edited by Carolyn
James, Florence, Leo S. Olschki, 2002, pp. 20-21.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 157 03/05/2013 11:11:14
158
Capitolo 2. Gender and Politics in Early Modern Europe
Augustinian monk Jacopo Filippo Foresti da Bergamo (1434 1520) must
have had access to Arientis manuscript while at Ferrara as he used many of Arientis
examples in his De plurimis claris selectisque mulieribus, printed 1497 in Ferrara
77
.
Te text was dedicated to Eleonoras sister, Beatrice, Queen of Hungary. De plurimis
claris renders especial homage to women at Ferrara, with Eleonora dAragonas bi-
ography covering almost four pages in the printed edition of 1521. In a letter from
September 1498 to Ippolito dEste, son of Ercole and Eleonora, Foresti reported
on his stay at the court of Ferrara and a history of the family of Este he composed
(most probably meaning at least parts of the De plurimis)
78
. It is noteworthy that
Foresti believed some of his biographies to be not merely a collection of exemplary
women but also a history of the Este family as a whole. Women were thus perceived
as praiseworthy by him but also always as part of wider familial structures and not
independent fgures. It is probable that Foresti wanted to dedicate his treatise to
Eleonora dAragona but she died shortly before his completion of the work in 1493
and as a result he seems to have chosen her sister Beatrice instead
79
.
Foresti acknowledged womens achievements in the political sphere, if their
overall lives were lived within Christian standards. He praised Eleonora for her
political abilities:
Her husband recognised the wondrous prudence and famous intelligence of his
young wife and soon he entrusted her with almost all of the administrative duties
of the realm, he believed in her diligence and her strong wisdom: she held this
position until her death, especially because the husband was often away from
home on military campaigns
80
.
77 Toretta had already noted the plagiarism in 1903. For a discussion of Forestis copying of Arientis
work see Torretta, L. Il Liber de claris mulieribus di Giovanni Boccaccio. Parte V. I plagiari, gli
imitatori, i continuatori del Liber de claris mulieribus, in Giornale storico della letteratura italiana,
n. 40, 1902, pp. 50-65. See also Pianetti, E. Fra Jacopo Filippo Foresti e la sua opera nel quadro
della cultura bergamasca, in Bergomum, n. 33, 1939, pp. 171-172, and Zaccaria, V. La fortuna del
De mulieribus claris del Boccaccio nel secolo XV: Giovanni Sabbadino degli Arienti, Iacopo Filippo
Foresti e loro biografe femminili (1490-1497), in Mazzoni, F. (Ed.), Il Boccaccio nelle culture e
letterature nazionali, Florence, Olschki, 1979, pp. 519-545.
78 Pianetti, E. Fra Jacopo cit., p. 169.
79 Krmmel, A. Das Supplementum Chronicarum des Augustinermnches Jacobus Philippus Foresti
von Bergamo, Herzberg, Bautz, 1992, p. 69.
80 Foresti, I.F. De plurimis claris selectisque mulieribus, in Ravisius, J.T. (Ed.), De memorabilibus
et claris mulieribus, Paris, Simon de Colines, 1521, p. 153. Ipse maritus cognita adolescentulae
admirabili prudentia, et celebri ingenio: mox eidem universam pene sui regni administrationem,
illius fde et consilio maxime fretus, credidit: quod et ad ultimum vitae suae usque pro maiori parte
administravit. quia maritus ipse, in armis exercitatissimus, minus propter stipendia atque alia maiora
regni negotia domi esse poterat.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 158 03/05/2013 11:11:14
159
4. Eleonora dAragona and the discourse surrounding female political power
Te biography of Eleonora obviously also praised Ercole for having married
such a skilled woman and recognising her talents. Foresti continued by repeat-
edly referring to Eleonoras chastity and modesty, her religiosity and adherence
to fasting, her wisdom, and how she engaged in the ruling of the state. He espe-
cially noted her bravery and capability during the Venetian War
81
. It seems that
Eleonoras supposedly purity of body and mind was a prerequisite for her success
as a ruler and representative for her husband for Foresti. Only this morality al-
lowed Eleonora to be a successful ruler and at the same time not to pose a threat
to existing power structures. Te role assumed by Eleonora in this text lies within
the daily running of Ferrara and the administration while her husband was away
on military duties. A certain power divide which relates to more traditional views
of womanhood is noticeable: Eleonora concerned herself with the administration
of the state which could be seen as an extension of her household while Ercole was
absent fghting. Traditional views of men and women and their associated roles
are not violated while at the same time Eleonoras competence and capability in
relation to the daily political processes of the state are praised.
Only one treatise related to Eleonora dAragona advanced a more radical po-
sition for women: Bartolomeo Goggio (c. 1430-1493), a notary employed by
Ercole dEste, argued for the superiority of women in his De laudibus mulierum
(written 1487). Te work is dedicated to Eleonora and in his letter of introduction
Goggio presented his treatise as a celebration of the excellence of women, written
as a result of his friendship with women and especially his acquaintance with Ele-
onora. Te De laudibus mulierum was never printed circulated exclusively around
Eleonora dAragona. Goggio intended to narrate the foundation and consoli-
dation of kingdoms and show how in reality all the principal monarchies were
derived from women
82
. Women are not only capable of political action, they are
superior to men in doing so and they are also the founders of politics, according
to Goggio. Like most of the treatises in defence of women, Goggios work also
contains some inconsistencies and ambiguities. Common stereotypes of women
are turned around to underline arguments in favour of their powers and abilities
(for example men are weak because they can not resist women).
Overall, however, the defences of women and political power that emerged
around Eleonora dAragona all suggest that a successful marriage of the ruling
81 Foresti, I.F. De plurimis cit., p. 154.
82 Goggio, B. De laudibus mulierum (Ad divam Eleanoram de Aragona, inclitam Ducissam Ferrariae,
de laudibus Mulierum Bartholomei Gogii), London, British Library, Additional MS 17415, f. 63 v.
Intendo narrare de le fundatione di regni et instauratione. Et como in veritade tuti le principale
monarchie sono provenute da done. Et cuss descrivendo se dimostrar come ne larte militarae le
done non sono state inferiore a lhomo.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 159 03/05/2013 11:11:14
160
Capitolo 2. Gender and Politics in Early Modern Europe
couple guarantees a successful state. Te female consort acts for the beneft of its
people and territory on a daily basis but especially in times of need, such as, for
example, when a condotta means the husband is away from his court or in times
of illness. Her political engagement and the love for her husband and his state are
essentially same. Eleonora lived up to these expectations and used them to leave a
political mark onto Ferrara. She was a powerful woman who was deeply engaged
in the politics of her duchy but who was at the same time devout and chaste. Te
image of an ideal prince paired with the ideals of a modest woman it was within
these boundaries that the politically powerful consort was perceived benefcial
for the state and its people and also the boundaries in which Eleonora dAragona
operated.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 160 03/05/2013 11:11:14
CAPITOLO 3
Identit e percorsi di donne nella sfera
pubblico-politica del lungo Ottocento
lombardo
a cura di Maria Luisa Betri
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 161 03/05/2013 11:11:14
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 162 03/05/2013 11:11:15
Introduzione
Maria Luisa Betri
Dalla stagione degli studi coltivati negli ultimi decenni e che ha avuto signifcativi
momenti di rifessione in due convegni svoltisi a Milano nel 1989 e nel 2002 Don-
na lombarda. Un secolo di vita femminile e Salotti e ruolo femminile in Italia tra fne
Seicento e primo Novecento
1
sono emersi alcuni elementi nettamente caratterizzanti
il formarsi di unidentit femminile lombarda nel lungo Ottocento che, in unestrema
sintesi, potrebbero compendiarsi in una tendenza difusa nelle donne ad assumere
responsabilit verso se stesse e verso la societ in senso lato, manifestandosi in capacit
diniziativa, in azioni di reciproca solidariet, in gesti dautonomia sia nellimpegno
flantropico-assistenziale e in seguito emancipazionista, sia nella partecipazione al
movimento nazional-patriottico e successivamente nellaspirazione alla piena cittadi-
nanza nellambito dello Stato nazionale. Sulla base di queste premesse alcuni recenti
percorsi di ricerca hanno inteso indagare larticolarsi, nel caso lombardo, dei rapporti
tra sfera privata e sfera pubblico-politica, e le implicazioni nel cambiamento delle
relazioni di genere. Nellambito del pi ampio processo di formazione dellidentit
femminile in et contemporanea, dei suoi caratteri e dei suoi limiti, del suo dif cile
accesso alla cittadinanza sociale e politica, si imposta infatti come questione rilevan-
te quella delle relazioni tra il modello di domesticit femminile connesso allascesa
della famiglia borghese dalla spiccata impronta di intimit afettiva e lapertura alle
donne, tra Settecento e Ottocento, di nuovi spazi e nuovi ruoli che potrebbero def-
1 Gigli Marchetti, A.; Torcellan, N. (a cura di) Donna lombarda. Un secolo di vita femminile, 1860-
1945, Milano, Franco Angeli, 1989; Betri, M.L.; Brambilla, E. (a cura di) Salotti e ruolo femminile in
Italia tra fne Seicento e primo Novecento, Venezia, Marsilio, 2004.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 163 03/05/2013 11:11:15
164
Capitolo 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo Ottocento lombardo
nirsi quasi politici. Nei quali si modul, pur con dinamiche diverse in molte realt
della Penisola, e cos anche in quella lombarda, un processo che consent il costituirsi
di una sfera di socialit e di opinione pubblica, distinta sia dalla dimensione domesti-
ca sia dalla vera e propria sfera politica. Luoghi emblematici di contatto, o soglia fra
privato e pubblico, furono i salotti, ritrovi di conversazione, talora connotati in senso
aristocratico-conservatore, altrove pi aperti alla commistione tra nobilt e borghesia
e alle opinioni liberali, nei quali la conduzione femminile si incarn spesso in fgure
di primo piano dellet risorgimentale e postunitaria.
Uno degli obiettivi dei percorsi di ricerca di cui si dato conto negli inter-
venti di questo panel appunto quello di esplorare in che modo il pubblico la
nazione prima e lo Stato nazionale poi sia o meno entrato nel privato, tra le
mura domestiche, e abbia orientato modelli e rappresentazioni di genere, strategie
familiari ed educative; ovvero di considerare il mutamento della concezione che le
donne avevano di se stesse e del proprio ruolo, decostruendo il modello borghese
omologante della madre virtuosa segregata nello spazio domestico, convalidato
da quella categoria interpretativa, particolarmente radicata nella storiografa di
marca anglosassone, che ha lungamente individuato nella separazione tra una sfera
femminile privata e domestica e una maschile, pubblica, uno dei tratti identifca-
tivi della nascita della societ borghese ottocentesca
2
.
Sugli orientamenti di questi studi hanno inoltre infuito le suggestioni di al-
cuni tra i pi signifcativi contributi ultimamente apparsi in tema di donne, Ri-
sorgimento e formazione dellidentit nazionale: dal pregnante saggio su Il Risor-
gimento delle donne, pubblicato nel ventiduesimo volume degli Annali Einaudi,
in cui Simonetta Soldani ha esortato a cogliere le dinamiche e articolazioni di un
processo troppo a lungo identifcato con lapporto delle donne a un Risorgimento
italiano visto come altro da loro, e dalle trasformazioni di cui esse al tempo stesso
furono via via soggetto e oggetto, ai contributi del volume a cura di Ilaria Porcia-
ni, Famiglia e nazione nel lungo Ottocento italiano
3
.
Gli studi in cantiere di cui qui si riferito, svolti da studiose che fanno rife-
rimento alle Universit milanesi Statale, Bicocca e Cattolica e alla Biblioteca
di Storia moderna e contemporanea di Roma, si sono anche potuti ampiamente
avvalere di carteggi, epistolari, diari, memorie, vale a dire di quelle forme primarie
di scrittura alle quali la storiografa andata riservando una crescente attenzione
4
.
2 Cfr. Caglioti, D.L. Extraterritorialit, liberalismo e flantropia: i salotti delle straniere a Napoli
nellOttocento, in Betri, M.L.; Brambilla, E. (a cura di) Salotti e ruolo femminile cit., p. 365.
3 Soldani, S. Il Risorgimento delle donne, in Banti, A.M.; Ginsborg, P. (a cura di) Storia dItalia,
Annali, vol. XXII, Il Risorgimento, Torino, Einaudi, 2007, p. 189; Porciani, I. (a cura di) Famiglia e
nazione nel lungo Ottocento italiano. Modelli, strategie, reti di relazioni, Roma, Viella, 2006.
4 Cfr. Betri, M.L.; Maldini Chiarito, D. (a cura di) Dolce dono graditissimo. La lettera privata
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 164 03/05/2013 11:11:15
165
Introduzione
Ormai svincolata dai modi espressivi codifcati dalla tradizione colta dei circuiti
letterari umanistico-rinascimentali o sei-settecenteschi nella societ aristocratica di
antico regime, la corrispondenza, e quella femminile in particolare, divenne, com
noto, durante il XIX secolo uno strumento di comunicazione abituale, una forma
di colloquio dai ritmi ravvicinati fno alla quotidianit, senza per questo scadere in
scrittura senza qualit. Ancora oggi tuttavia nuclei consistenti di lettere vergate
da mani femminili, frammischiate ad altre carte su cui si fonda la memoria storica
tanto dellaristocrazia quanto dellemergente borghesia ottocentesca, costituiscono
giacimenti documentari nascosti negli archivi pubblici e privati, tra cui riserbano
scoperte spesso di rilevante interesse quelli famigliari. Per ovviare alle dif colt del
reperimento di questa documentazione, non sempre agevolata da adeguati strumen-
ti di consultazione, si pu ora segnalare una iniziativa del Dipartimento di scienze
della storia e della documentazione storica dellUniversit degli studi di Milano che,
in collaborazione con la Regione Lombardia, con le Raccolte storiche del Comune
di Milano, e con lIstituto lombardo di Storia contemporanea, ha promosso un cen-
simento delle scritture femminili conservate nelle sedi archivistiche milanesi, di cui
si conclusa la prima fase, e i cui risultati sono in corso di pubblicazione nel volume
Gli archivi delle donne. Repertorio delle fonti femminili negli archivi milanesi (1814-
1859), a cura di Maria Canella e Paola Zocchi.
Quali fra i tratti dellidentit femminile sopra richiamati accomunano fgure
tra loro apparentemente diverse e distanti per estrazione sociale e per esperienze di
vita in epoche diverse? Qual il fl rouge che consente di accostare le colombe,
le esposte adulte cos chiamate dalla ef gie nello stemma dellOspedale Maggiore
di Milano, a Cristina Trivulzio di Belgioioso, aristocratica di cospicui natali e dalla
esistenza trascorsa allinsegna di uninquieta intensit? E ancora, le fondatrici di
case private di educazione femminile, sul modello delle maisons deducation difuse
in Francia gi da fne Settecento, a Laura Solera Mantegazza, benefattrice e madre
patriottica ardente di entusiasmo garibaldino, e alle Lazzati Romussi, partecipi
di un clima politico-culturale in cui limpegno femminile stava ormai virando
dal flantropismo alla rivendicazione dei diritti civili e politici delle donne? Un
primo denominatore comune sembra potersi individuare in gesti di autonomia,
sia pure diversamente declinati. La dialettica tra il ruolo paterno degli ammi-
nistratori dellOspedale Maggiore la Ca Granda, al centro della ramifcata rete
assistenziale milanese e le esposte nubili, studiate da Flores Reggiani nel lungo
periodo, dalla met del XVII secolo allet napoleonica, costellata di episodi di
ribellione manifestatisi in ripetuti atti di insubordinazione. E, in seguito, nelle
dal Settecento al Novecento, Milano, Franco Angeli, 2000; eaedem (a cura di) Scritture di desiderio
e di ricordo. Autobiografe, diari, memorie tra Settecento e Novecento, Milano, Franco Angeli, 2002.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 165 03/05/2013 11:11:15
166
Capitolo 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo Ottocento lombardo
rivendicazioni delle giovani, in nome dei diritti del cittadino maggiorenne a eleg-
gere il proprio stato, dopo che la legislazione del 1806 aveva stabilito in ventuno
anni la soglia della maggiore et per entrambi i sessi. Il carteggio amministrativo
dellOspedale Maggiore restituisce le voci di donne che si rapportarono in modo
diverso con gli amministratori: ora postulando con forza, dopo il periodo trascor-
so nellaf do esterno presso famiglie contadine, una riammissione nellospizio,
cos da perpetuarvisi per fruire di un vantaggioso mantenimento, ora rifutando
le incombenze loro assegnate nei servizi interni, ora rivendicando, ormai maggio-
renni, una libera scelta di vita.
Lintraprendenza di donne, appartenenti al ceto civile, giunte al seguito delle-
sercito francese nelle cui fle militavano mariti, parenti o amanti, di cui traccia
alcuni profli Natalia Tatulli, contribu a colmare nella Milano capitale del na-
poleonico Regno dItalia il vuoto istituzionale venutosi a creare a seguito della
soppressione, per mano del governo asburgico prima e napoleonico poi, degli
educandati per fanciulle dei ceti agiati, gestiti da congregazioni religiose. Talune
dotate di una educazione raf nata, altre invece pi concretamente sperimentate
nella gestione di imprese commerciali, ma complessivamente abili a intessere una
fruttuosa rete di relazioni con membri dellentourage di governo francese, esse fon-
darono e diressero case private deducazione per fanciulle di nascita civile della cit-
t che riuscirono presto a conquistarsi una ragguardevole reputazione nella societ
milanese, consentendo loro di personifcare un modello femminile alternativo a
quello prevalente di madre di famiglia o di religiosa.
Luna aristocratica, laltra borghese, Cristina Trivulzio di Belgioioso, tra le pi
originali protagoniste del Risorgimento, proprio per questo spesso circonfusa da
unaura agiografca, e Laura Solera Mantegazza, una delle madri simboliche del
Risorgimento lombardo, condivisero, ancor prima della cifra di un patriottismo in-
tensamente vissuto, alcune scelte personali coraggiose, come la rottura delle loro
unioni matrimoniali. La poliedrica fgura della Belgioioso studiata da Antonietta
Angelica Zucconi quale prototipo della aristocratica dclasse, parallelamente a Ma-
rie dAgoult, la francese emarginata dal mondo legittimista parigino dopo la sua
fuga con Franz Liszt, ma soprattutto guardata con sospetto per il suo essere donna
colta, scrittrice e animatrice di un salon molto frequentato. La prospettiva da cui si
considera il proflo di Cristina, anchessa salonnire intelligente e ammirata, scrittrice
e giornalista, dedita alla causa dellindipendenza italiana che sostenne, fnanzi e
nella quale fu direttamente coinvolta nel 1848 e 1849, benefattrice, e infne viag-
giatrice curiosa, suggerisce una rilettura critica di questa fgura singolare, da un lato
dracine, ma dallaltro mai, di fatto, defnitivamente distaccatasi da uno status privi-
legiato e molto attenta a preservarsi dal cattivo gusto del demi-monde.
La consolidata conoscenza di Laura Solera Mantegazza come operosa bene-
fattrice, promotrice con Giuseppe Sacchi nella Milano degli anni Cinquanta dei
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 166 03/05/2013 11:11:15
167
Introduzione
primi ricoveri per bambini lattanti istituiti sul modello delle francesi crches, della
prima scuola per analfabete, e nel 1862 della sezione femminile dellAssociazione
generale di mutuo soccorso degli operai milanesi, si arricchisce nella ricerca di
Alessandra Porati della sua componente pi propriamente politica, anche grazie a
quanto emerge dalla consultazione della ftta corrispondenza che ella intrattenne
tra il 1835 e il 1872 con una molteplicit di destinatari, tra cui molti dei pi noti
esponenti dello schieramento democratico. Nella sua vicenda, segnata in profon-
dit dal nesso famiglia-nazione, chiaramente leggibile levoluzione del paradig-
ma della madre patriottica, dalla sua preminente funzione di cura nel prodigarsi a
soccorrere i feriti e nel raccogliere fondi a favore degli insorti durante le milanesi
Cinque giornate, a una pi diretta e consapevole azione politica, allinsegna del
mito garibaldino, nel promuovere allindomani dellunifcazione, intessendo una
ftta rete di solidariet femminile, molteplici iniziative a sostegno delle iniziative
di parte democratica.
Sul terreno dellattitudine flantropico-assistenziale sostanziata di militan-
za patriottica sarebbe maturato, sul fnire del secolo, quel flone di femminismo
pratico che diede proprio nella realt milanese una delle prove pi convincenti,
in un clima permeato di laicismo. In questa atmosfera si inquadra la vicenda di
Maria Lazzati, moglie dal 1879 dellavvocato Carlo Romussi, poi direttore del
pi importante quotidiano milanese dellepoca, Il Secolo, ed entrata quindi in
relazione con gli ambienti democratico-radicali in cui emergeva la personalit
di Felice Cavallotti. Altea Villa ha potuto ricostruire il crescente impegno della
Lazzati Romussi nei dibattiti sul tema del pacifsmo e dei diritti civili e politici
delle donne attraverso il suo epistolario, conservato insieme a quello della madre,
Cristina Lazzati Rossi, presso larchivio privato Romussi. E anche la vicenda di
questultima emblematica di una genealogia femminile peculiare dellOttocento
lombardo: attiva nella raccolta di fondi a sostegno del volontariato garibaldino,
Cristina Lazzati condivise con la Solera Mantegazza limpegno nei sodalizi dellas-
sociazionismo femminile milanese e corrispose, tra gli anni Sessanta e Ottanta,
con gli esponenti pi in vista di parte democratica: da Mazzini a Saf , da Quirico
Filopanti a Vincenzo Brusco Onnis.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 167 03/05/2013 11:11:15
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 168 03/05/2013 11:11:15
1. Fra protezione e autonomia: le colombe
dellospedale maggiore di Milano
(XVII-XIX secolo)
Flores Reggiani
Lutilizzo delle categorie storiografche di genere non solo si rivela un mezzo in-
dispensabile per indagare quel peculiare rapporto di fliazione artifciale che, in
passato, era connesso con lappartenenza alla famiglia di un ente caritativo, ma
costituisce un approccio utile per comprendere alcune svolte cruciali nella storia
dellassistenza.
Fin dalle sue origini (1456) lOspedale Maggiore di Milano aveva assunto fra
i propri compiti il ricovero dei bambini esposti. Bench le consuetudini contem-
plassero la possibilit che, al termine di un primo periodo trascorso presso balie e
nutrici foresi, essi potessero restare nelle famiglie private come fgli adottivi o
come servi, la norma, formalizzata nel sedicesimo secolo, prevedeva un percorso
diverso. In linea di principio, bambini e bambine dovevano essere riconsegnati
allOspedale fra i quattro e i sette anni, perch potessero ricevere uneducazione
cristiana, unistruzione di base e un addestramento artigianale: requisiti ritenuti
suf cienti, insieme con la dote assegnata alle femmine, per inserirli nella vita so-
ciale e produttiva, soprattutto cittadina
5
. Fra il 1653 e il 1655 fu invece deciso
con una scelta destinata a mutare le sorti dei futuri trovatelli di prolungare laf-
fdamento alle famiglie esterne, perlopi contadine, anche dopo il termine dellin-
fanzia: i tenutari, in cambio, avrebbero ricevuto un tenue salario e il corredo fno
5 Per un proflo storico del brefotrofo milanese e per la bibliografa si rimanda a Reggiani, F. La fa-
miglia dellOspedale nei secoli, in Canella, M.; Dodi, L.; Reggiani, F. (a cura di) Si consegna questo
fglio. Lassistenza allinfanzia e alla maternit dalla Ca Granda alla Provincia di Milano (1456-1920),
Milano, Skira, 2008, pp. 35-103.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 169 03/05/2013 11:11:15
170
Capitolo 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo Ottocento lombardo
al compimento dei quindici anni
6
. Il nuovo indirizzo nacque dalla convinzione
che, in una fase di diminuzione delle rendite e di decadenza delleconomia urbana,
accentuata dalla recente pestilenza, esternalizzare i servizi educativi come direm-
mo oggi sarebbe stato meno oneroso che erogarli direttamente. Non si trattava,
tuttavia, solo di questo.
Da tempo, cos come avveniva in altri brefotrof, i deputati milanesi erano
sottoposti a pressioni contrastanti nellesercizio del loro ruolo paterno nei con-
fronti delle esposte nubili, chiamate colombe dallinsegna dellente. Alla dif -
colt di ospitare donne di ogni et e condizione dalle bambine alle anziane, dalle
sane alle inabili si aggiungeva limperativo di proteggere lonore sessuale delle
assistite, mentre la volont di non allontanare le ragazze pi esperte nei lavori di
cucito e tessitura, che erano anche le pi richieste come mogli e come serve, era
bilanciata dal desiderio di liberarsi delle inette. Nel corso dei decenni i depu-
tati avevano quindi adottato provvedimenti contraddittori, nel vano tentativo di
sgravarsi dellinsopportabile peso costituito dalle centinaia di nubili che vive-
vano stabilmente nelle strutture dellOspedale Maggiore
7
. Fino alla met del Sei-
cento il Capitolo aveva cercato di favorire i matrimoni e talvolta le monacazioni
con la concessione di una dote, che solitamente arrivava almeno a duecento lire.
Si erano utilizzati a questo scopo, in misura e proporzioni variabili, sia i lasciti dei
benefattori sia i proventi delle attivit manuali svolte dalle assistite allinterno sia i
salari dei servizi domestici prestati allesterno
8
. Il metodo, tuttavia, si era rivelato
inadeguato, soprattutto nel momento in cui le commesse di lavoro e le richieste
di serve specializzate avevano cominciato a decrescere. Ma lostacolo pi forte era
forse costituito dalle stesse colombe. Per capirne le motivazioni, necessario
richiamare quali fossero le loro condizioni di vita dopo il rientro dal baliatico.
Per un verso, le delibere capitolari dei primi due secoli successivi alla fonda-
zione del Maggiore delineano il tipico stile di vita claustrale adottato nei conser-
vatori femminili. Le colombe, tuttavia, sebbene meno esuberanti delle gravide e
6 Archivio Ospedale Maggiore di Milano (dora innanzi AOM), Ordinazioni capitolari generali
(dora innanzi Ocg), 7 luglio 1653 e 25-26 aprile 1655.
7 I dati approssimativi fnora rintracciati indicano che nellOspedale di San Celso, destinato fno
al 1671 al ricovero di esposti e partorienti, le assistite interne erano 700 nel 1579, 500 (contando
solo le giovani) nel 1627 e 700 nel 1629. AOM, Ordinazioni speciali per San Celso (dora innanzi
Osc), 4 aprile 1579; Ocg, 30 aprile 1627; Decio, C. Notizie storiche sulla ospitalit e didattica ostetrica
milanese, Pavia, Fusi, 1906, p. 86.
8 Lombardi, D.; Reggiani, F. Da assistita a serva. Circuiti di reclutamento delle serve attraverso le
istituzioni assistenziali (Firenze-Milano, XVII-XVIII secc.), in Cavaciocchi, S. (a cura di) La donna
nelleconomia. Secc. XIII-XVIII atti della Ventunesima Settimana di Studi, (Istituto Internazionale di
Storia economica F. Datini, Prato 10-15 aprile 1989), Firenze, Le Monnier, 1990, pp. 301-319;
Reggiani, F. La famiglia dellOspedale nei secoli cit., pp. 40-47.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 170 03/05/2013 11:11:15
171
1. Fra protezione e autonomia: le colombe dellospedale maggiore di Milano (XVII-XIX secolo)
delle balie, da cui sarebbero dovute restare rigorosamente separate, non erano del
tutto sottomesse alle regole. Abbiamo notizia come in altre strutture simili
9
di
trascuratezza nelle pratiche devote, perfno da parte della priora e delle velate
10
.
Leggiamo, nelle delibere capitolari, insistenti denunce di uscite e di contatti non
autorizzati, che venivano attuati accampando i pi svariati pretesti e stratagem-
mi. Tuttavia, cos come avvenne intorno al 1675 tra le esposte romane del Santo
Spirito
11
, le ribellioni pi consuete da parte delle adulte non si manifestavano con
le fughe, che, invece, erano frequenti nei conservatori per pericolate
12
. Nemme-
no abbiamo notizie di rivolte contro eventuali soprusi perpetrati ai loro danni,
com documentato per altri ospizi
13
. Al contrario, le resistenze pi strenue e pi
severamente punite erano dirette contro i tentativi compiuti dagli amministra-
tori di allontanare le nubili, mandandole a servire nelle case private, per quanto
referenziate. Evidentemente, la prospettiva di un matrimonio con mariti scelti dal
Capitolo non era suf ciente a rendere accettabili alle colombe n la separazione
dalle compagne, n il rischio di subire maltrattamenti e abusi da parte dei padroni,
n la prospettiva di essere sottoposte a discriminazioni secondo quanto previsto
dalle norme interne per quelle che rientravano dal servizio n, tanto meno,
la possibilit di essere trasferite nei conservatori per pericolate, come accadeva a
quelle che capitavano male
14
. Si ha limpressione che, se avessero potuto sceglie-
9 DAmico, S. Assistenza o reclusione? I rifugi per peccatrici e fanciulle pericolanti nella Milano
della Controriforma, in Dimensioni e problemi della ricerca storica. Rivista del Dipartimento di Storia
moderna e contemporanea della Sapienza Universit di Roma, n. 2, 2008, p. 247.
10 Un esempio in AOM, Osc, 24 aprile 1604.
11 Schiavoni, C. Gli infanti esposti del Santo Spirito in Saxia di Roma tra Cinquecento e Ot-
tocento: numero, ricevimento, allevamento e destino, in Enfance abandonne et societ en Europe,
XIVeXXe sicle, Rome, cole Franaise de Rome, 1991, pp. 1043-1045.
12 DAmico, S. Assistenza o reclusione? cit., p. 249.
13 Lombardi, D. Povert maschile, povert femminile. LOspedale dei Medicanti nella Firenze dei Me-
dici, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 173-174; Fubini Leuzzi, M. Dellallogare le fanciulle degli In-
nocenti: un problema culturale ed economico, 1577-1652, in Prodi, P. (a cura di) Disciplina della-
nima, disciplina del corpo e disciplina della societ tra medioevo ed et moderna, Il Mulino, Bologna,
1994, pp. 895-896; Sandri, L. Da assistite a traviate. Le Nocentine tra XVI e XVIII secolo, in Da
Molin, G. (a cura di) Forme di assistenza in Italia dal XV al XX secolo, Udine, Forum-Soc. Ed. Univ.
Udinese, 2002, pp. 24-25; Calzola, L. Caratteristiche demografche e modalit di abbandono degli
esposti allOspedale di S. Maria della Misercordia di Perugia nei secoli XVI e XVII, in Da Molin,
G. (a cura di) Trovatelli e balie in Italia, secc. XVI-XIX, Bari, Cacucci Editore, 1994, p. 23; Grendi, E.
Ideologia della carit e societ indisciplinata: la costruzione del sistema assistenziale genovese (1470-
1670), in Politi, P.; Rosa, M.; Della Peruta, F. (a cura di) Timore e carit. I poveri nellItalia moderna,
Cremona, Annali della Biblioteca statale e libreria civica di Cremona, 1982, p. 74.
14 Ordini novi per lHospitale di San Celso, 26 aprile 1594, a stampa, pp. 4, 8, 10, 12; Decio, C.
Notizie storiche sulla ospitalit cit., p. 50.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 171 03/05/2013 11:11:15
172
Capitolo 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo Ottocento lombardo
re, le colombe avrebbero preferito restare a vita in un ricco ospedale, dove, senza
padroni n mariti, godevano di un buon vitto a base di carne e dove, salvo alcune
mansioni da eseguire a turno, potevano lavorare poco. E, infatti, esse cercavano di
perpetuarsi nellospizio a grave danno dellOspitale
15
.
Si comprendono dunque quali furono, in aggiunta alle congiunture econo-
miche negative, le motivazioni che, nel 1655, indussero gli amministratori del
Maggiore a favorire il matrimonio delle colombe, facendole crescere in cam-
pagna ambiente considerato moralmente pi sano della citt a diretto contatto
con i potenziali coniugi, e versando a tutte una dote di cento lire, pi il panno
per una sottana, senza o quasi far conto sui loro guadagni. Ridurre al minimo
i tempi di permanenza nel brefotrofo non solo permetteva di contenere le spese
di gestione, ma impediva o limitava la nascita di legami afettivi fra le assistite ed
evitava che esse si abituassero alla vita protetta dellospizio. Cos come avvenne
a Firenze
16
, il prolungamento dellaf damento riusc l, dove avevano fallito le
assegnazioni straordinarie di doti
17
, ma anche i metodi coercitivi, come il divieto
di riammettere le adulte mandate a servire
18
o le minacce despulsione senza dote
per quelle che non avessero trovato un padrone o un marito entro una certa et
19
.
Non sappiamo se le minacce furono messe in atto, come forse avvenne a Firenze
20
,
ma probabilmente non ve ne fu pi bisogno, perch dal 1662 fno al 1759
21
epo-
ca in cui le accettazioni di bambini avevano gi cominciato ad aumentare in modo
inedito, arrivando alle settecento unit annuali non sembrano esservi state pi
lamentele sulleccessiva presenza di fglie nellospizio. Si continuarono quindi ad
accogliere, oltre alle inabili, le esposte che, pur cresciute in campagna, non erano
riuscite a collocarsi. Le nubili, infatti, conservarono fno al 1784 il diritto di tor-
nare in qualunque et nelle strutture della Ca Granda
22
, che rimase un rifugio
15 AOM, Ocg, 25-26 aprile 1655.
16 Fubini Leuzzi, M. Dellallogare le fanciulle degli Innocenti cit., pp. 872, 885.
17 AOM, Ocg, 28 marzo 1558; Osc, 4 aprile 1579; Ocg, 5 febbraio 1590; Ordini novi per lHospitale
di San Celso cit., p. 11; Ocg, 21 giugno 1605; Osc, 18 marzo 1628.
18 AOM, Ocg, 31 luglio 1648.
19 Nel 1644 il Capitolo aveva ingiunto alle colombe zitelle di sposarsi o di andare a servizio entro tre
mesi dopo il compimento dei 18 anni, senza possibilit di rientrare (AOM, Ocg, 1 febbraio 1644).
Poco tempo dopo il provvedimento del 1655, furono minacciate di espulsione senza dote quelle
che a 20 anni non avessero ancora trovato un padrone o un marito (AOM, Ocg, 12 giugno 1662).
20 Fubini Leuzzi, M. Dellallogare le fanciulle degli Innocenti cit., pp. 867, 877.
21 AOM, Ocg, 13 luglio 1759. In quellanno le colombe ospitate nel quarto delle donne erano
in numero eccessivo, ma si prefer, anzich ampliare i locali, trasferire le abili nellOspedale di San
Vincenzo, anchesso dipendente dal Maggiore, e destinarle alla tessitura, stante il vantaggio della
fabbrica della tela per gli usi interni.
22 Regole generali degli esposti e partorienti della Pia casa in S. Caterina alla ruota [1781], in
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 172 03/05/2013 11:11:15
173
1. Fra protezione e autonomia: le colombe dellospedale maggiore di Milano (XVII-XIX secolo)
sia per le inette, sia per le ragazze rimaste sole a causa della disgregazione delle
famiglie af datarie.
Tuttavia, nel 1784 quattro anni dopo il trasferimento del ricovero per gli
esposti e per le partorienti nella Pia Casa di Santa Caterina alla ruota, sempre
dipendente dal Maggiore nellambito delle riforme promosse dallimperatore
Giuseppe II, la riammissione fu limitata, anche per le femmine, al periodo prece-
dente il compimento dei quindici anni
23
. La situazione si complic ulteriormente
in epoca napoleonica, soprattutto dopo che la legislazione del 1806, oltre a defni-
re il proflo giuridico degli amministratori nei confronti degli assistiti, fss a ven-
tuno anni la maggiore et per tutti i cittadini di entrambi i sessi
24
. Alle richieste
di alcune colombe che, prive di sostegno familiare, volevano essere riammesse
nellospizio oltre il termine, si intrecciarono infatti le proteste, espresse anche con
fughe e rivolte, da parte delle fglie assegnate ai servizi interni: alcune rifutavano
le incombenze loro assegnate, altre, invece, ormai maggiorenni, rivendicavano il
diritto di allontanarsi dalla Pia Casa, pur senza avere in vista alcun matrimonio.
Non possibile dare conto qui di queste vicende, che in qualche caso coin-
volsero anche la prefettura e il ministero degli interni, ma anticipiamo alcune
conclusioni
25
. Gli amministratori del Maggiore condussero le trattative con lin-
tento di salvaguardare la loro autonomia decisionale e il loro ruolo paterno forte.
Mostrarono quindi una certa fermezza nellattenersi ai regolamenti nei confronti
delle postulanti esterne, anche se sostenute da patroni e autorit cittadine, e si
prodigarono ma senza successo per veder riconosciuto dallo Stato quello che
ritenevano essere, di l dalle norme giuridiche, un loro dovere morale: il dovere di
impedire che la legge divenisse un pretesto per sovvertire le gerarchie domestiche,
il dovere di proteggere anche contro la volont delle interessate donne che essi
giudicavano maggiorenni di diritto ma non di fatto, sia perch incapaci di sottrarsi
Instituzione della Pia Casa degli esposti e partorienti in Santa Catterina alla Ruota di Milano, Milano,
20 settembre 1784, p. 11, art. 7.
23 Metodo per laccettazione e mantenimento degli esposti nellOspedale di S. Caterina alla ruota
e delle condizioni delle loro balie, in Instituzione della Pia Casa degli esposti cit.
24 Codice di Napoleone il Grande pel Regno dItalia, Quarta edizione originale ed of ciale, Milano,
Reale Stamperia, 1806, t. 1, art. 488; Decreto diretto a migliorare la tutela, emancipazione e cura de
fgli abbandonati ed esposti, 4 dicembre 1806, in Bollettino delle leggi del Regno dItalia, Parte III,
Dal 1 settembre al 31 dicembre 1806, Milano, Reale Stamperia, [1806], pp. 1041-1044. Sul tema
della tutela degli esposti in epoca napoleonica: Polenghi, S. Fanciulli soldati. La militarizzazione
dellinfanzia abbandonata nellEuropa moderna, Carocci, Roma, 2003, pp. 175-186; Reggiani, F. La
costruzione dellidentit sociale degli esposti (Milano, XVIII-XIX secolo), comunicazione presentata al
Convegno della Societ italiana di demografa storica (S.I.De.S.), Demografa e diversit: convergenze
e divergenze nellesperienza storica italiana, (Napoli 5-7 novembre 2009), in corso di stampa.
25 Gli esiti complessivi della ricerca saranno pubblicati a breve.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 173 03/05/2013 11:11:15
174
Capitolo 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo Ottocento lombardo
alle lusinghe di persone disoneste, sia perch succubi delle proprie debolezze e dei
propri istinti. Se molti episodi di ribellione alla fne si ricomposero in famiglia,
osserviamo che gi allora si sollevava esplicitamente e si lasciava irrisolta una
questione destinata a divenire centrale nella storia della cittadinanza, e non solo
in relazione alle donne: come potesse esservi afermazione di un diritto, laddove
la societ e le istituzioni non ofrissero i mezzi perch quel diritto fosse realmente
esercitato.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 174 03/05/2013 11:11:15
2. Spose, vedove, avventuriere. Proli di donne
francesi nella Milano di Napoleone
Natalia Tatulli
Con la trasformazione di Milano in capitale della Repubblica Cisalpina, poi Italiana
e infne nel 1805 del Regno dItalia, la citt divent un centro dattrazione per gli
abitanti di ogni parte della penisola. Ugo Foscolo, come osserva il Pecchio, amico
e biografo del poeta, la scelse come residenza perch era una specie di colonia che
accordava la sua cittadinanza a tutti i patrioti raminghi dItalia. Milano soltanto due
anni prima, calma, silenziosa, dove si menava una vita agiata e molle, ma languida e
soporifera, tutto ad tratto era diventata il teatro di continui cangiamenti. [] Tutto
era nuovo; uomini, nomi, linguaggio, vestiti, emblemi
26
. A creare questo clima di
rinnovamento per cui tutto (o quasi) sembrava possibile contribuiva, oltre ai rivol-
gimenti politici, la presenza in citt della corte del vicer Eugenio, dellentourage di
governo e soprattutto dellesercito francese che grazie al mito delle proprie vittorie
esercitava un vero fascino sulla popolazione milanese di ogni ordine e grado.
La penetrazione della lingua, della cultura, delle mode doltralpe, incomin-
ciata nel XVII secolo e intensifcatasi a partire dalla met del Settecento, vide
nel ventennio napoleonico unaccelerazione senza pari tanto che Milano grazie
allaf uire di emigrati, di soldati e di impiegati, [] per il suo vivere sciolto e
rumoroso era detta la piccola Parigi
27
.
Le persone che giunsero a Milano durante questo periodo non furono per
solo patrioti italiani fuggiti da regimi ostili o militari della Grande Armata che ave-
vano partecipato alla campagna dItalia; a ingrossare le fle degli emigrati contri-
26 Pecchio, G. Vita di Ugo Foscolo, Lugano, 1830, p.40.
27 De Castro, G. Milano e la Repubblica Cisalpina, Milano, 1879, p. 398.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 175 03/05/2013 11:11:15
176
Capitolo 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo Ottocento lombardo
buirono anche numerose persone appartenenti alla societ civile, arrivate da tutta
Italia e dalla Francia al seguito dellesercito, con la speranza di sfruttare al massimo
le possibilit economiche e di successo oferte dalla nascita di un nuovo regno.
La Grande Armata, ovunque andasse, trascinava con s un folto e composito
schieramento femminile. Durante le lunghe e faticose marce, negli accampamenti
in attesa della fne delle battaglie e infne nelle citt conquistate o asservite, viveva-
no, fanco a fanco, condividendo con i compagni entusiasmi e soferenze mogli,
fglie, prostitute e amanti, in una mescolanza di ruoli concessa solo nello stato
eccezionale di sospensione della realt rappresentato dalla guerra.
Milano accolse lesercito francese pi volte e insieme a esso apr le porte an-
che alle donne della Grande Armata che afollarono della loro presenza esotica le
strade e le case della citt. Le fgure pi appariscenti furono sicuramente le amanti
di soldati e graduati tra le quali spiccano Ezelina Van Aylde Yonghe detta Ida
SamtElmo e Mlada la Malorquine. La prima, divenuta famosa sotto la Restau-
razione per le sue memorie, fglia di un conte russo e di una olandese, fu data in
sposa a un ricco fammingo, ammiratore dei principi rivoluzionari, che segu a
Lille dove incontr il primo dei suoi amanti, il futuro generale Marescot. Dismessi
gli abiti femminili e abbandonato il marito divent lamante del generale Moreau
con il quale giunse a Milano e si install a Palazzo Fagnani, presentata uf cialmen-
te come sua sposa. Torner in citt nel 1805 insieme al nuovo amante, il generale
Ney, per assistere allincoronazione di Napoleone a Re dItalia
28
. Mlada, bellissima
orfana dalmata di umili origini, al contrario della SantElmo non pot scegliere i
propri amanti dai quali fu usata come merce di scambio fnch non la not il ge-
nerale Lauriston; abbandonata da questultimo a Trieste si trasfer a Milano dove,
fno al 1813, frequent a detta delluf ciale Montigny, nobili, magistrati e alti
prelati riuscendo a conquistare anche un discreto credito presso il vicer
29
.
Numerose furono le donne di ogni ceto che approdate a Milano insieme a
mariti, parenti o amanti, tentarono di rifarsi una vita cercando di sfruttare a pro-
prio vantaggio la posizione, che speravano essere di privilegio, data dalle loro ori-
gini francesi e riuscendo a tessere una rete di rapporti, sia pubblici che privati, non
solo allinterno della propria comunit ma anche con la societ milanese.
Molte si dedicarono al commercio, allarte o allistruzione, e in particolare in
questultimo settore si distinse un gruppetto di donne che a partire dal 1804 fno
al 1814 fondarono case private di educazione femminile sul modello delle maisons
dducation difuse in Francia gi a partire dagli ultimi decenni del Settecento
30
.
28 Saint Elme, I. Souvenirs dune courtisane de la Grande Arme, Villeneuve dAscq, Talandier, 2004.
29 Montigny, L.G. Souvenirs anecdotiques dun of cier de la Grande Arme, Gosselin, Paris, 1833,
pp. 39-56.
30 Sonnet, M. Leducazione di una giovane, in Storia delle donne. Dal Rinascimento allet moderna,
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 176 03/05/2013 11:11:15
177
2. Spose, vedove, avventuriere. Profli di donne francesi nella Milano di Napoleone
Tra le prime ad arrivare in citt ci fu Elisabetta Perillier Pradel, giunta a Mila-
no a seguito del marito e rimasta vedova nellottobre del 1803 allet di 45 anni.
Per qualche mese mantenne s e la giovane fglia ricamando per conto di alcuni
mercanti e grazie allaiuto del fratello che era coinvolto nelle forniture militari;
ma
allinizio del 1804 decise di rendersi indipendente cercando di mettere a frutto la
raf nata educazione che aveva ricevuto in patria (e che comprendeva, oltre alla
musica e al disegno, anche nozioni di storia e geografa), aprendo la prima casa
privata deducazione per fanciulle di nascita civile della citt
31
.
Nel 1808 giunse a Milano Madame Drely, cinquantenne nativa di Angers,
istruita nel commercio, in grado di parlare e scrivere correttamente linglese, e da
sempre alla testa di imprese di dimensioni considerevoli, come quelle destinate
allapprovvigionamento delle truppe e degli ospedali, della direzione della Posta a
cavalli di Angers e della Posta dei Messaggeri del dipartimento del Maine et Loire:
tutte attivit che dirigeva in luogo del marito, occupato dagli afari della Ferma
Generale alla quale era addetto. Madame Drely rimase vedova nel 1800 con quat-
tro fgli di cui occuparsi e decise di trasferirsi a Parigi nel 1803 a seguito di alcuni
rovesci di fortuna che la portarono ad abbandonare lincarico alle poste di Angers.
Dopo cinque anni trascorsi nella capitale francese, dove ebbe modo di conoscere
alcune persone infuenti tra le quali il Prefetto del Dipartimento di Parigi, si trasfe-
r con una fglia a Milano, sollecitata da una parente impiegata presso il Ministero
della Guerra, con lo scopo dichiarato di aprire una casa deducazione per fanciulle.
Subito cerc di sfruttare a suo vantaggio tutti i titoli che poteva vantare (tra cui la
conoscenza personale del Barone Darnay, Direttore generale delle poste del Regno
dItalia e segretario personale del Vicer, e i gradi militari dei due fgli arruolati
nellesercito napoleonico) per ottenere dalle autorit aiuti economici o sociali.
Cos facendo, ad esempio, nel 1810 riusc ad assicurare alla fglia Alessandrina
un posto nel neonato Conservatorio di Milano come allieva nella classe di canto.
Sempre nel 1808 giunsero a Milano, con lintenzione di aprire una casa dedu-
cazione, Madame De Antoni, vedova dellavvocato Rouxel, cinquantenne nativa di
Brest, con un fglio tenente nella marina italiana
32
, e una coppia di Metz, che apr
una casa deducazione femminile, formalmente diretta dalluomo, Monsieur Rouy,
a cura di Zemon Davis, N.; Farge, A. Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 119-155. Per lItalia si veda
Bianchi, A. Le case private deducazione femminile a Milano nellet della Restaurazione, in Id. (a
cura di) Listruzione in Italia tra Sette e Ottocento. Lombardia-Veneto-Umbria, vol. I, Brescia, Editrice
La Scuola, 2007, pp. 599-623.
31 ASMi, Studi p.m., cart. 588, fasc. Pradel, Il Prefetto di Polizia del Dipartimento dellOlona al
Ministro dellInterno, Milano 29 febbraio 1804 .
32 ASMi, Studi p.m., cart. 590, fasc. Rouxel, Il Direttore Generale della Polizia al Sig. Direttore
Generale della Pubblica Istruzione, Milano 2 febbraio 1810.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 177 03/05/2013 11:11:15
178
Capitolo 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo Ottocento lombardo
ma di fatto retta dalla sua compagna, Mademoiselle De Bar. La madre della De Bar,
vedova di un generale in ristrettezze economiche, aveva concesso a Rouy di portare
con s in Italia la fglia con la promessa di sposarla non appena giunti a Milano
33
.
Come prevedibile il matrimonio non ebbe mai luogo, ma questo non imped a M.lle
De Bar, nel corso dei cinque anni in cui resse la casa deducazione nota sotto il nome
del compagno, di crearsi in citt la reputazione di abile e stimata educatrice
34
. In
seguito, quando la De Bar tent di aprire una casa deducazione per proprio conto,
lautorizzazione le fu negata dalle autorit di pubblica istruzione a motivo di una
condotta privata (le spese eccessive e forse un nuovo amante) ritenuta insoddisfacen-
te per una persona destinata a educare fanciulle della buona societ
35
.
Anche su altre due direttrici si allung lombra della cattiva reputazione: Ma-
dame Landoir e Marie Anne Elisabeth Debrien in Saint Edme, parigine, rispet-
tivamente madre e fglia, aprirono a Milano una piccola casa deducazione nel
1813. Spose entrambe di militari francesi, corsero il rischio di dover chiudere il
loro istituto a causa di una voce che si era andata difondendo in citt e che accusa-
va la madre, vedova, di avere un amante. Le indagini di polizia per non trovarono
nessuna macchia nella condotta della donna e ipotizzarono che la maldicenza si
fosse difusa a causa degli abiti sfoggiati dalle due donne, ritenuti troppo costosi
rispetto alle loro condizioni economiche.
Infne nel 1814 anche Caterina Menard decise di aprire una casa deducazione
per fanciulle a Milano, in societ con la moglie del proprietario dellimmobile de-
stinato a ospitare listituto. La Sig.ra Menard appartiene a una famiglia di Parigi
gi comoda, e accreditata nel Commercio, che soggiacque a molte sventure nella
rivoluzione, indi risorta in parte nelle somministrazioni Militari, ricadde nuova-
mente nella miseria collesercizio dellAlbergo della Citt in questa Capitale
36
.
Catherine Menard giunse a Milano nel 1801 e risolse dinvestire nel settore delle-
ducazione femminile solo dopo la vedovanza e il fallimento dellattivit familiare,
dimostrando, con la decisione di aprire la casa deducazione in societ, di aver ben
presenti i possibili rischi di unamministrazione individuale di unimpresa.
Una donna impegnata in unattivit commerciale di successo ricordata nelle
memorie di viaggio di Stendhal, che nel 1811 menziona pi volte una trattoria
33 ASMi, Studi p.m., cart. 440, fasc. De Bar,Madame Drely al Sig. Consigliere Direttore Generale
della Pubblica Istruzione, Milano 27 maggio 1814 .
34 ASMi, Studi p.m., cart. 440, fasc. De Bar, Il Direttore Generale della Polizia al Sig. Consigliere
Direttore Generale della Pubblica Istruzione, Milano 24 giugno 1814 .
35 ASMi, Studi p.m., cart. 440, fasc. De Bar, Il Direttore Generale della Polizia al Sig. Consigliere
Direttore Generale della Pubblica Istruzione, Milano 24 giugno 1814 .
36 ASMi, Studi p.m., cart. 455, fasc. Menard Petracchi, Il Prefetto dellOlona al Sig. Direttore Gene-
rale della Pubblica Istruzione, Milano 10 maggio 1814.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 178 03/05/2013 11:11:15
179
2. Spose, vedove, avventuriere. Profli di donne francesi nella Milano di Napoleone
molto nota a quel tempo a Milano e tenuta da una coppia di francesi, i Vieillard
37
.
La fama che il locale era riuscito a conquistarsi era dovuta in particolare allarguzia
dellanziana proprietaria, ex cameriera di una dama francese emigrata, che aveva
reso il locale alla moda con la sua vivacit e con i gradevoli epigrammi che indiriz-
zava agli avventori. La trattoria dei Vieillard fu un apprezzato ritrovo per i letterati
milanesi anche negli anni successivi al ritorno degli Asburgo
38
.
Anche nel settore delle confezioni in stofa si distinse la sartoria diretta da
Madame Carron-Ribier, attivit nata negli anni del dominio napoleonico ma che
prosegu ben oltre la fne di questo e che quasi alla met del secolo veniva ancora
segnalata, in una guida dItalia per turisti francesi, tra le Marchandes des Modes
pi rinomate di tutta Milano
39
.
Lambiente teatrale, in aggiunta a quelli educativo e commerciale, un altro
campo in cui si trovano attive delle donne francesi, infatti oltre alla ballerina Ca-
roline Pitrot, della quale noto il ritratto dellAppiani conservato alla Pinacoteca
Ambrosiana, documentata la presenza in citt della cantante parigina Giuseppi-
na Fabre, allora allieva gratuita del neonato Conservatorio di Milano. La Fabre fu
una delle prime alunne del prestigioso istituto nel quale rimase dal 1807 al 1813,
anno in cui il padre la ritir diciannovenne per farle iniziare a calcare le scene
dei teatri. Il Vicer, visti i rapporti con il padre, suo Matre dHotel, e gli ottimi
risultati ottenuti dalla ragazza nello studio del bel canto, le accord 800 franchi di
gratifca e la possibilit di continuare a cantare nellAccademia del Conservatorio
fno al primo ingaggio fuori Milano
40
. Il primo riconoscimento uf ciale M.lle
Fabre laveva ottenuto gi a quindici anni, con la sua esibizione da soprano nello
Stabat Mater di Pergolesi, eseguita nellaprile del 1809 nella chiesa di S. Maria
della Passione
41
. Dieci anni pi tardi, lex allieva del conservatorio di Milano, nel
pieno della propria carriera, si esibir a Palermo, sul palcoscenico del Real Teatro
Carolino, nel ruolo di protagonista nel Torvaldo e Dorliska di Rossini
42
. Non ebbe
37 Stendhal, Secondo viaggio in Italia. Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli (1811), in Viaggio in
Italia (1801-1818), Rizzoli, Milano-Roma, 1942, pp. 135;140;180.
38 Verga, E. Storia della vita Milanese, Nicola Moneta, Milano,1931, p. 437-438.
39 Valery, A.C. LItalie confortable:manuel du touriste, appendice aux voyages historiques, littraires et
artistiques en Italie, J. Renouard, Paris, p. 33.
40 ASMi, Studi p.m., cart. 309, fasc. Fabre Il Signor Ministro dellInterno al Cenosre del Conser-
vatorio di Milano, Milano 31 luglio 1813.
41 ASMi, Studi p.m., cart. 297, Discorso pronunciato da S.E. Il Signor Conte Di Breme Ministro
dellInterno in occasione della distribuzione dei premi ai convittori del Regio Conservatorio di Musica
nellAccademia del 3 settembre 1809.
42 Rossini, G.; Sterbini, C. Torvaldo e Dorliska, Dramma Semiserio da Rappresentarsi Nel Real Teatro
Carolino per Sesta Opera Dellanno 1818 e 1819. Dedicato a Sua Altezza Reale il Duca di Calabria,
Palermo, Crisanti, 1819.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 179 03/05/2013 11:11:15
180
Capitolo 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo Ottocento lombardo
lo stesso successo nonostante mostrasse genio e inclinazione
43
per il canto, la
quattordicenne Alessandrina Drely, che come abbiamo visto, grazie allinteressa-
mento della madre, dal 1810 era compagna della Fabre al conservatorio.
Dalla galleria di ritratti appena percorsa af orano fgure di donne capaci di
costruirsi esistenze relativamente autonome, alternative ai destini di madre di fa-
miglia o di religiosa proposti come modelli femminili prevalenti dellepoca. Le
posizioni acquisite sia con il saper fare e lo studio sia con le relazioni sociali e fami-
gliari, confermano come il fenomeno dellemigrazione abbia da sempre coinvolto
per lo pi uomini e donne dotati di conoscenze e abilit da convertire, nel Paese
di arrivo, in utili strumenti di emancipazione.
Queste donne, vere imprenditrici di s stesse, mettendo a frutto lesperienza
maturata grazie a uneducazione mirata, seppero appropriarsi degli spazi che erano
stati loro lasciati o af dati, riuscendo anche, come le direttrici di case deducazio-
ne, a rispondere soddisfacentemente a nuovi bisogni della societ milanese.
43 ASMi, Studi p.m., cart. 309, fasc. Drely, Il Prefetto di Polizia del Dip. dellOlona al Signor
Ministro dellInterno, Milano 28 aprile 1810.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 180 03/05/2013 11:11:15
3. Cristina di Belgiojoso, Marie dAgoult e la
gura dellaristocratica dclasse
Antonietta Angelica Zucconi
Sotto lAncien Rgime le donne dellaristocrazia, pur abbandonandosi alle pi
grandi follie, amorose o fnanziarie o anche intellettuali, rimanevano sempre
nellambito della loro classe di origine; dopo la Rivoluzione francese e la fne della
socit dordres e poi nel corso del XIX secolo, in cui predominarono una moralit
puntigliosa (quel cult of respectability di cui parlano Harold Nicolson e George L.
Mosse)
44
e un modello di femminilit pi discreta, borghese, le aristocratiche si
trovarono invece esposte a una possibile degradazione e perdita di status.
Un esempio di aristocratica dclasse uno dei personaggi di Le ct de Guer-
mantes di Marcel Proust, la marquise de Villeparisis: la marquise, legata per nascita
e matrimonio alla grande nobilt del suo tempo, non gode tuttavia di unelevata
situazione mondana; riceve infatti nel suo salon solo un public de troisime ordre,
bourgeoisie, noblesse de province ou tare
45
, e viene trattata con disdegno da
persone di rango e di intelligenza inferiori al suo. Lautore suggerisce che il dclasse-
ment e la decadenza sociale della marquise nascano s dai suoi eccessi di giovinezza,
da infrazioni alle regole morali, ma soprattutto dal suo aver sempre coltivato con
una certa presunzione e pedanteria i propri interessi culturali, e dallessere stata
considerata uninsupportable bas-bleu
46
.
44 Nicolson, H. Good Behaviour, being a Study of Certain Types of Civility, Boston, Beacon Press
Beacon Hill, 1960; Mosse, G.L. Te culture of Western Europe. Te nineteenth and twentieth centuries.
An introduction, Chicago, Rand McNally, 1961; idem, Sessualit e nazionalismo. Mentalit borghese e
rispettabilit, Bari-Roma, Laterza, 1984.
45 Proust, M. la recherche du temps perdu, Le ct de Guermantes, I, Paris, Gallimard, 1954, p. 222.
46 Ibidem, p. 225.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 181 03/05/2013 11:11:15
182
Capitolo 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo Ottocento lombardo
Il personaggio dellaristocratica dclasse comunque ricorrente, tra la secon-
da met e la fne dellOttocento, in molta letteratura francese e anche italiana
dinfuenza francese (ne sono esempi: Frdric Bchard, Les existences dclasses;
Eugne Bonnemre, Les Dclasses; molti saggi del critico legittimista Armand de
Pontmartin; Alfred Sirven, Les femmes dclasses; le aristocratiche angoisses de
se sentir dclasses, douloureuses, inquites, nerveuses, dvores de dsirs impos-
sibles raliser dei romanzi dei Goncourt
47
; mile Zola, Au bonheur de dames;
Auguste Lepage, Une dclasse, M. Legrain, Dclasses; Louis Xavier de Richard,
Mmoires dune dclasse. Les foucades de la duchesse; Luigi Gualdo, Costanza Gerar-
di; Enrico Castelnuovo, Il fallo di una donna onesta, ecc.).
Si tratta di romanzi minori, scritti in genere da uomini; questi personaggi fem-
minili non hanno la complessit della marquise de Villeparisis, sono quasi sempre
fgure stereotipate: se sono state ridotte in povert senza loro colpa da catastro-
f familiari, devono lavorare per mantenersi e, dopo aver duramente combattuto
contro la sorte avversa, fniscono per morire di stanchezza e di malattia, oppure si
rassegnano alla mediocrit. Se invece la fuoriuscita dallambiente di origine dovuta
a scelte attive della donna (in genere per un amore adultero o colpevole, ma anche
per aver abbracciato opinioni politiche stravaganti), allora lautore descrive il suo
personaggio con un misto di piet e sdegno, ne accompagna la caduta e se la pro-
tagonista non si pente e torna a casa le fa fare una brutta fne, oppure (in romanzi
sul flo del porno) le fa vivere una vita equivoca e ai margini della societ. Per Zola
dclasse vuol dire anche dtraque (guasta, malandata, squilibrata). Emerge in queste
opere sia la paura della decadenza di esseri considerati vulnerabili e incapaci di rico-
struirsi una vita con le sole loro forze, sia il timore di una loro deriva verso lignoto,
sia infne la dif denza verso una possibile libert diniziativa femminile.
Molti di questi romanzi sono opere a chiave, e in queste aristocratiche dclas-
ses era ed ancora possibile riconoscere delle persone reali. Indagando su quali
possano essere stati i modelli efettivi cui gli autori si sono ispirati, ho individuato
alcuni personaggi che a mio avviso hanno rappresentato per le loro vicende e le
loro scelte dei prototipi di queste fgure. Le due aristocratiche da cui ho iniziato
la mia ricerca sono Marie dAgoult e Cristina Trivulzio di Belgiojoso. Tengo tutta-
via a rilevare che, studiando le loro biografe, si percepisce quanto le loro persona-
lit siano state diverse (pi complesse, contraddittorie e originali) dalle immagini
stilizzate sia pure con profondit e raf natezza dai romanzieri.
Marie de Flavigny, nata nel 1805 da nobile famiglia, sposata al conte Charles
dAgoult, allinizio del 1833 si innamor di Franz Liszt e nel 1835 fugg con lui,
suscitando uno scandalo enorme. La loro relazione, nonostante la nascita di tre
47 Sabatier, P. Lesthtique des Goncourt, Paris, Hachette, 1920, p. 377.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 182 03/05/2013 11:11:15
183
3. Cristina di Belgiojoso, Marie dAgoult e la fgura dellaristocratica dclasse
fgli, dopo qualche anno si esaur e Marie ritorn a Parigi, decisa a riconquistarsi
un posto in una societ che laveva messa al bando. Grazie alla sua intelligenza,
alla sua cultura, alla sua bellezza, ritrov un ruolo non nel mondo della nobilt
legittimista in cui era nata (anche la sua famiglia si rifut di riceverla), ma tra gli
intellettuali. Scrisse libri e articoli con lo pseudonimo di Daniel Stern, divenne
amica di Victor Hugo, Tophile Gautier, Sainte-Beuve, Eugne Sue ed mile de
Girardin, riusc a formare un salon molto frequentato; molti degli uomini che la
circondavano sinnamorarono di lei, che per li respinse. La resistenza ostinata di
una donna che aveva infranto con tanto coraggio le regole del suo ambiente cre
sconcerto, le diede la fama di seduttrice cerebrale e crudele. In politica Marie si
avvicin ai repubblicani, e la rivoluzione del febbraio 1848 segn il suo trionfo
come salonnire e la sua consacrazione come scrittrice (la sua Histoire de la Rvo-
lution de 1848 considerata unopera di riferimento). Sotto il Secondo Impero si
situ nellopposizione al regime imperiale; mor il 5 marzo 1876
48
.
Cristina Trivulzio nacque nel 1808 in una grande e ricca famiglia della nobilt
milanese; nel 1824 spos per amore, e contro la volont della sua famiglia, il prin-
cipe Emilio di Belgiojoso. Emilio la contagi con la siflide e ben presto la trad
apertamente: Cristina non volle accettare una situazione di compromesso e nel
1828 si separ dal marito. Appassionatasi agli ideali liberali e patriottici, nel 1829
si fece iniziare alla Carboneria. Alla fne del 1830 dovette rifugiarsi in Francia, e
a Parigi si leg a personaggi favorevoli alla causa italiana (Gilbert de La Fayette,
Franois Mignet, Augustin Tierry), e ricevette gli artisti e i letterati pi importan-
ti del momento (Franz Liszt, Alfred de Musset, Adolphe Tiers, Vincenzo Bellini,
Heinrich Heine). Il mondo che frequentava, tuttavia, non era quello della nobilt
legittimista o anche orleanista legato alla corte, i suoi amici erano piuttosto (come
nel caso di La Fayette o di Tiers) dei nobili o dei politici tenuti ai margini e visti
con sospetto dalla famiglia reale e dalla societ pi tradizionalista. Intelligente e
sarcastica, sicura di s, dotata di una strana bellezza, Cristina era molto ricercata
ma anche molto contestata: era accusata di posare, di sedurre e poi tormentare
i suoi adoratori (le si conobbe una sola e lunga storia damore, con lo storico
Franois Mignet, relazione da cui nacque la sua unica fglia Maria).
48 Biografe di Marie dAgoult: Pommier, A. Mme la Comtesse dAgoult, Paris, E. Dentu, 1867;
Monod, M.O. Daniel Stern, comtesse dAgoult, Paris, Plon, 1937; Vier, J.A. Marie dAgoult: son mari,
ses amis, Paris, Les ditions du Cdre, 1950; Id., La Comtesse dAgoult et son temps, Paris, Armand
Colin, 6 vol. (I, 1955; II, 1959; III, 1961; IV, 1961; V, 1962; VI, 1963); Desanti, D. Daniel ou le
visage secret dune comtesse romantique, Marie dAgoult, Paris, Stock, 1980; Dupchez, C. Marie dA-
goult. Le grand amour de Liszt, Paris, Perrin, 2001, 3
me
ed. corrige (comprende un elenco completo
delle sue opere). La sua corrispondenza completa in corso di pubblicazione: Marie de Flavigny,
comtesse dAgoult: Correspondance gnrale, d. tablie et annote par Charles Dupchez, Paris, H.
Champion, 3 (tome I, 1821-1836, 2003; tome II, 1837-1839, 2004; tome III, 18391841, 2005).
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 183 03/05/2013 11:11:15
184
Capitolo 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo Ottocento lombardo
Nel 1840 Cristina trov un accordo con il governo austriaco e pot tornare in
Lombardia. Si stabil nella sua propriet di Locate e prese a occuparsi del benessere
e dellistruzione dei contadini: fond scuole, fece costruire case, organizz strut-
ture di accoglienza. Studiava e scriveva e nel 1842 pubblic (in forma anonima)
unopera di teologia, lEssai sur la formation du dogme catholique, che venne im-
mediatamente messo allindice dalla Chiesa. Si tenne comunque in contatto con
gli amici francesi e and sovente a Parigi, mentre continuava ad aiutare i patrioti
esiliati, a fnanziare e a scrivere in giornali che sostenevano la causa italiana. Nel
1848, allannuncio della rivoluzione milanese, organizz un battaglione di volon-
tari e part per la Lombardia. Rientrati gli austriaci a Milano, Cristina torn a Pa-
rigi e cerc di mobilitare lopinione pubblica francese in favore dellunit dItalia.
Nellaprile 1849 and a Roma, e qui Mazzini le af d lorganizzazione dellassi-
stenza ai feriti; caduta la Repubblica Romana, dovette prendere la via dellesilio:
decise, dopo un periodo in Grecia, di stabilirsi in Anatolia, dove acquist una
propriet agricola. Qualche anno dopo torn in Italia; la situazione politica era
ormai mutata e Cristina, di cui era stato sovente rimproverato e messo in ridicolo
limpegno politico e sociale, veniva ormai considerata una madre della patria.
Mor il 5 luglio 1871
49
.
Cristina e Marie erano dunque contemporanee, avevano frequentato gli stessi
ambienti, e avuto idee politiche molto simili (anche Marie dAgoult sosteneva la
causa dellunit italiana ed era legata a Mazzini) e molti amici in comune. Divisero
il medesimo destino di emarginazione dalla loro classe di provenienza, dovuto a
scelte afettive e politiche e (oltre ad aver sperimentato questo distacco, che aveva
anche un valore positivo, di rottura coraggiosa) attirarono entrambe per anni
la curiosit pubblica, rimanendo continuamente esposte a critiche e pettegolezzi.
Veniva loro rimproverata la visibilit, il non nascondersi in un ambiente ristretto e
protetto, il far parade, pure dei fgli nati dalle relazioni illegittime.
La societ milanese, che aveva cominciato a occuparsi di Cristina gi quan-
do la ragazza aveva deciso di sposare Emilio, la biasim aspramente quando la
principessa si accorse dellerrore commesso e moglie apertamente tradita volle
49 Biografe di Cristina di Belgiojoso: Barbiera, R. La Principessa di Belgiojoso, Milano, Treve, 1894;
Id., Passioni del Risorgimento. Nuove pagine sulla Belgiojoso e il suo tempo, Milano, Treves, 1903;
Whitehouse, H.R. A Revolutionary Princess, London, Fisher Unwin, 1906; Tierry, A.A. Une hroine
romantique, la princesse Belgiojoso, Paris, Plon, 1926; Malvezzi, A. La principessa Cristina di Belgiojoso,
Milano, Treves, 3 vol. (I, 1936; II, 1936; III, 1937); Severgnini, L. La principessa di Belgiojoso. Vita
ed opere, Milano, Virgilio, 1972; Guicciardi, E. Cristina di Belgiojoso Trivulzio. Cento anni dopo,
Milano, La Martinella, 1973; Brombert, B.A. Cristina, Portraits of a Princess, London, Hamilton,
1978; Incisa, I.; Trivulzio, A. Cristina di Belgiojoso. La principessa romantica, Milano, Rusconi, 1984.
Karoline Rrig sta lavorando a una nuova biografa. Per una bibliografa degli scritti della Belgiojoso
cfr. Severgnini, La principessa di Belgiojoso cit., pp. 291-294.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 184 03/05/2013 11:11:15
185
3. Cristina di Belgiojoso, Marie dAgoult e la fgura dellaristocratica dclasse
separarsi dal marito; allamica Ernesta Bisi Cristina scrisse nellottobre 1830 che
la sua era una esistenza manque, ma che non si era mai pentita del passo im-
portante col quale mi chiusi le porte di Milano
50
. Tornata a Milano nel 1840,
per quanto impegnata a fondo in attivit benefche, venne trattata gelidamente
anche da Alessandro Manzoni (in cui lei aveva molto fducia), che non le permise
neanche di visitare la madre di lui, Giulia Beccaria, morente. Quando negli anni
Cinquanta rientr defnitivamente nella sua citt, la Belgiojoso era certo aureolata
dal suo contributo alla causa italiana, ma trov ancora critici e detrattori. Anche
Marie dAgoult, che soggiorn in Lombardia con Franz Liszt tra il 1837 e il 1838,
rimase ai margini della vita mondana milanese, mentre il musicista veniva ricevu-
to ovunque. Lei visse questa situazione con molto disagio, tenendo a prendere le
distanze da unaltra coppia irregolare allora presente a Milano, quella formata da
Gioacchino Rossini e dalla sua amante, la demi-mondaine Olympe Plissier, che le
avevano fatto qualche avance.
Marie e Cristina erano molto attente a distinguersi dalle donne del demi-
monde; in particolare, esigevano che ai loro ricevimenti venissero osservate con
cura estrema le buone maniere e le convenzioni sociali. Cristina rimise seccamente
al suo posto il presuntuoso Victor Cousin, che voleva prendere il passo sullam-
basciatore russo
51
, e Marie rilevava le continue infrazioni al savoir vivre dei de-
mocratici suoi amici
52
. Il loro dclassement era stato una libera scelta, ma non
comportava n un incanaglimento n la rinuncia a uno status privilegiato.
Per i contemporanei, erano delle personalit disturbanti, inaferrabili: spre-
giudicate ma molto riservate, intelligenti e colte ma non sentimentali. La stessa
etichetta di dclasses (il principe Napoleone Gerolamo Bonaparte, molto amico
di Marie dAgoult, la considerava une grande dame fourvoye
53
, e Pontmartin
una trs grande dame dclasse)
54
non bastava a defnirle. Inoltre entrambe, pur
se deluse nelle scelte che le avevano messe fuori del loro ambiente (Marie fn per
lasciare Liszt, e Cristina torn in Lombardia) non si dimostrarono mai pentite. Il
loro ambiente, che le avrebbe accettate con il capo coperto di cenere, rimase stupi-
to dal vederle perseverare con convinzione nelle loro posizioni. Anche se erano due
donne fragili (Marie sofriva di depressione, Cristina ebbe per tutta la sua vita una
50 Malvezzi, A. La principessa Belgiojoso, vol. I: Le prime armi, 1808-1832 cit., p. 161.
51 Cfr. Jaubert, C. Souvenirs de Madame C. Jaubert. Lettres et correspondances, Paris, J. Hetzel et Cie,
1881, 5
me
ed., pp. 315-316.
52 Cfr. Lamber Adam, J. Mes souvenirs, Paris, Alphonse Lemerre, 1902-1910, II vol.: Mes pre-
mires armes littraires et politiques, 1904, p. 87.
53 Dardano Basso, I. (a cura di) La princesse Julie Bonaparte marquise de Roccagiovine et son temps.
Mmoires indits (1853-1870), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1975, p. 329.
54 de Pontmartin, A. Mes Mmoires. Seconde jeunesse, Paris, Calmann Lvy, 1886, p. 343.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 185 03/05/2013 11:11:15
186
Capitolo 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo Ottocento lombardo
salute incerta), ed erano ben coscienti della dif colt e della delicatezza della loro
situazione, conservarono sempre un forte senso di s, e non si fecero condizionare
pi di tanto dallo sguardo degli altri.
Laltra pesante accusa che venne loro fatta e che si ritrova nel personaggio
letterario della marquise de Villeparisis era di occuparsi di scienze considerate
per soli uomini, come la storia, la flosofa, la teologia e la politica (Pierre-
Joseph Proudhon, ne La pornocratie ou Les femmes dans les temps modernes scrive
che La pire espce dafranchie est la femme esprit fort, celle qui se mle de
philosophie)
55
. Barbey dAurevilly le accomun nella sprezzante defnizione di
bas-bleus, e rimprover loro di non essersi dedicate a scrivere bei romanzi, come
la loro amica-nemica George Sand
56
. interessante il paragone di Marie e Cri-
stina con George Sand (che il critico Pontmartin defniva una femme volon-
tairement dclasse)
57
: il destino della Sand fu diverso grazie al suo eccezionale
talento di scrittrice, alla sua libert di spirito e alla sua audacia che Pontmartin
considerava virile, caratteristiche le permisero non di evitare ma di ignorare il
dclassement.
Fu contestato anche il lavoro di giornaliste di Marie e Cristina, che le portava
a occuparsi della realt quotidiana e a esercitare una qualche infuenza sullopi-
nione pubblica; secondo una salonnire loro contemporanea, madame Ancelot, le
donne autore dovevano accontentarsi di destare con le loro opere des bons sen-
timents et de bienfaisantes penses dans lesprit de leurs lecteurs, e non aspirare
a nulla di pi
58
.
I loro salons erano molto ricercati, ma Marie e Cristina venivano accusate
di non limitarsi ad accettare gli omaggi alla loro bellezza e a ricevere con grazia e
fatterie, e di mettersi in concorrenza con il lavoro dei loro amici. Pure il loro corpo
era sempre sul davanti della scena, veniva osservata e ammirata la loro eleganza ma
erano seguiti con curiosit e malignit i segni del loro invecchiare. La vita sessuale
di entrambe era oggetto di commenti contraddittori: Marie era accusata di essere
frigida, oppure una dbauche froid par curiosit plus que par temprament
59
,
55 La pornocratie ou Les femmes dans les temps modernes, Paris, Lacroix, 1875 (uvres posthumes,
crit en 1861 ca.), p. 90
.
56 Barbey dAurevilly, J. Les uvres et les hommes. Les bas-bleus, Paris, Socit gnrale de Librairie
catholique, 1878, Chap. VI, Daniel Stern, pp. 63-82, e Chap. XII, Mme la Princesse de Belgiojoso,
pp. 159-168.
57 de Pontmartin, A. Dernires causeries du samedi: deuxime srie des causeries littraires, Paris, Mi-
chel Lvy et frres, 1866, De la personnalit dans le roman. Madame Sand. M. Paul de Musset, p.
358.
58 Ancelot, M.L.V. Un salon Paris 1824-1864, Paris, 1866, p. 136.
59 De Viel-Castel, H. Mmoires sur le rgne de Napolon III (1851-1864), Paris, 1883-1884, III vol.,
p. 158, Vendredi 8 juin 1855.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 186 03/05/2013 11:11:15
187
3. Cristina di Belgiojoso, Marie dAgoult e la fgura dellaristocratica dclasse
mentre si rimproverava a Cristina di essere unallumeuse, di voler refaire le monde
sans refaire lamour
60
, o al contrario di essere lesbica, ninfomane e necrofla.
Sia Marie che Cristina si interessarono alla condizione femminile: Cristina
riconosceva alle ragazze il diritto di studiare, ma raccomandava loro di armarsi
di pazienza e di annegazione e ricordava quanto fosse dif cile far accettare una
condizione pi libera (quale era stata la sua) e quanto fosse facile confondere la
libert di spirito con una condotta immorale: Un grandissimo numero di quelle
donne che si vorrebbero liberare dal giogo, respingono sdegnate una libert che
non chiesero mai, e il cui nome sembra loro sinonimo di vizio e di libertinaggio
61
.
Marie non solo esortava le sue contemporanee a studiare e ad agire, ma rivendi-
cava la capacit femminile di essere une femme dhonneur che, se non si batte
a duello come gli uomini, comunque perfettamente in grado di difendere il suo
feur de lhonntet
62
.
Entrambe per sapevano di appartenere a unlite sociale e intellettuale, si
ritenevano delle donne superiori, diverse dalle donne comuni (Marie si rap-
present in suo romanzo sotto il nome di Diotima)
63
, e non condividevano certo
la solidariet descritta da Michle Riot-Sarcey tra le democratiche e le saint-simo-
niane degli anni Trenta e Quaranta
64
. Non vi fu nessuna complicit neanche tra
loro due: Marie era gelosa dellamicizia tra Franz Liszt e Cristina e la chiamava la
Comdienne
65
, Cristina giudicava Marie dura e afettata. Tutte e due preferirono
condurre da sole la loro lotta e tenersi stretta la cerchia di amici e ammiratori che
le circondavano, si chiusero in un narcisismo che escludeva la presenza e lamicizia
di unaltra donna considerata una rivale.
60 Houssaye, A. Les confessions. Souvenirs dun demi-sicle (1830-1880), Paris, E. Dentu, 1885, tome
II, p. 17.
61 Di Belgiojoso, C. Della presente condizione delle donne e del loro avvenire, in Nuova Anto-
logia, volume 1, Firenze, 31 gennaio 1866, pp. 96-113, p. 110.
62 dAgoult, M. Esquisses morales. Penses, rfexions et maximes, Paris, Calmann Lvy, 1880 [prima
edizione 1849], pp. 155-156.
63 DAgoult, M. Dante et Goethe, Paris, Didier, 1866.
64 Riot-Sarcey, M. La dmocratie lpreuve des femmes. Trois fgures critiques du pouvoir 1830-1848,
Paris, Albin Michel, 1994.
65 Correspondance Franz Liszt Marie dAgoult, prsente et annote par Serge Gut et Jacqueline
Bellas, Paris, Fayard, 2001, pp. 575-576, 586, 728.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 187 03/05/2013 11:11:15
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 188 03/05/2013 11:11:16
4. Laura Solera Mantegazza tra militanza
politica e impegno sociale
Alessandra Porati
La fgura di Laura Solera Mantegazza, qui presa in considerazione attraverso lesa-
me di un consistente corpus di lettere scritte tra il 1835 e il 1872 e conservate pres-
so larchivio dellIstituto per la storia del Risorgimento italiano di Roma, si pone
allinterno di uno spazio di intersezione in cui elementi tradizionali della cultura
femminile si mescolano ad atteggiamenti fortemente innovativi, dando vita a un
proflo in cui gli slanci verso una modernit intesa come rivendicazione di genere
si sovrappongono ad aspetti ancora dominati da unideologia fortemente segnata
da quello che Laura Guidi ha defnito come il modello borghese omologante
della madre virtuosa segregata nello spazio domestico
66
.
Istruita secondo i consueti dettami della precettistica educativa ottocen-
tesca, Laura manifest presto una spinta verso lindipendenza e lautonomia,
separandosi da un marito non voluto, giudicato incapace di sostenere la famiglia
e inetto nelleducazione dei fgli, verso cui la donna mostr unattenzione fuori
del comune, allattandoli al seno nonostante la salute cagionevole e fondando
la relazione con essi su una dimensione afettiva basata sulla confdenza e sul
rispetto reciproco
67
.
66 Guidi, L. Introduzione, in Guidi, L. (a cura di) Scritture femminili e storia, Napoli, Cliopress,
2004.
67 Su Paolo Mantegazza vedi Gatti, R. La giovinezza di Paolo Mantegazza nelle pagine del suo
diario, in Risorgimento: Rivista di storia del Risorgimento e di storia contemporanea, n. 2-3, 2005,
p.329.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 189 03/05/2013 11:11:16
190
Capitolo 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo Ottocento lombardo
La spinta innovatrice e trasgressiva si manifest in Laura nel corso dellin-
surrezione del Quarantotto, momento in cui, con la partecipazione delle donne
alla causa nazionale, lItalia giunse secondo la testimonianza di Vincenzo Gioberti
a maturit civile e a pieno essere di coscienza come nazione
68
. Fu proprio nel corso
delle insurrezioni quarantottesche che si vennero stringendo le maglie di una rete
di relazioni destinata a durare nel tempo e a dar vita allidealizzazione della madre
risorgimentale pronta a rispecchiarsi negli ideali dei fgli e a identifcarsi nel loro
sacrifcio.
Secondo la testimonianza di Paolo Mantegazza, principale artefce dellesalta-
zione della fgura materna
69
, lo scoppio dellinsurrezione milanese coinvolse Laura
in unintensa attivit di raccolta di fondi a favore degli insorti e nellassistenza ai
feriti. Fortemente impressionata dagli avvenimenti, si dedic inoltre alla stesura di
una poesia traboccante di fervore patriottico in cui il connubio tra religione, patria
e famiglia era reso immediatamente evidente quale strumento di legittimazione
dellidentit nazionale. Il componimento si rispecchiava in quella ricca messe di
raccolte di versi scritti in occasione degli avvenimenti rivoluzionari in cui con la
raf gurazione della madre italiana veniva delineato il proflo di una donna che,
pur priva della titolarit dei diritti posti a fondamento della cittadinanza, nella
dedizione ai fgli impegnati per la patria, entrava in contatto con una sfera civile
a lei ancora preclusa.
In seguito alla facile riconquista austriaca della Lombardia, Laura come la
maggior parte delle donne che avevano partecipato alle giornate rivoluzionarie,
decise di ritirarsi dalla vita attiva, rifugiandosi alla Sabbioncella, la villa di famiglia
sul lago Maggiore.
Come nota Simonetta Soldani, leredit degli avvenimenti appena trascor-
si, e cio la declinazione costituzionale del discorso nazionale impersonata dal
Parlamento subalpino, non solo riguard le donne ma ne evidenzi e ne esalt
la sostanziale alterit con la conseguenza di favorirne le propensioni populistico-
autoritarie centrate sullesaltazione di un padre che avrebbe potuto essere il re
ma anche Mazzini o Garibaldi in grado di rappresentare e di guidare la grande
famiglia nazionale
70
.
Allinizio incerta tra la fgura del genovese e quella dellEroe dei due mondi,
Laura scelse di seguire il secondo in quanto rappresentazione vivente di quello che
68 Gioberti, V. Apologia del libro intitolato il Gesuita moderno con alcune considerazioni intorno al no-
stro risorgimento a cura di Orecchia, R., Cedam, Padova, 1974 citato da Soldani, S. Il Risorgimento
delle donne, in Banti, A.M.; Ginsborg, P. (a cura di) Storia dItalia, Annali 22, Il Risorgimento,
Torino, Einaudi, 2007, p. 217.
69 Mantegazza, P. La mia mamma, Firenze, Barbera, 1887.
70 Soldani, Il Risorgimento delle donne cit., p. 223
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 190 03/05/2013 11:11:16
191
4. Laura Solera Mantegazza tra militanza politica e impegno sociale
Lucy Ryall defnisce il tipico eroe risorgimentale; democratico e romantico, corag-
gioso e indisciplinato, espressione piena e concreta del popolo, sensuale, sensibile,
amante della famiglia. La creazione del mito garibaldino ricorse a precise fgure
che ne sottolinearono il dissenso nei confronti della cultura tradizionale e che
nello stesso tempo tracciarono un modello di patria come collettivit eterogenea
in cui anche la componente femminile era proposta come elemento basilare di una
nuova vita democratica nazionale
71
.
Fu proprio in questazione di partecipazione alla creazione di una mitologia
garibaldina capace di includere nel discorso nazionale anche il mondo femminile
che Laura Solera diede il suo contribuito politico pi importante.
Dagli avvenimenti rivoluzionari del Quarantotto milanese dovevano ancora
trascorrere alcuni anni perch limpegno di Laura si trasformasse dalla tradizionale
assistenza femminile ai feriti in una pi coinvolgente azione politica.
Nel corso del decennio di preparazione prevalsero le iniziative flantropiche
con la creazione nel 1850 del primo Ricovero per bambini lattanti in contrada
santa Cristina a Milano, a cui seguirono nel volgere di alcuni anni altre tre istitu-
zioni destinate ai fgli neonati delle donne operaie, la scuola professionale femmi-
nile e, a unifcazione avvenuta, la societ di mutuo soccorso per le operaie sezio-
ne femminile della gi avviata societ di mutuo soccorso degli operai di Milano.
Arriv il 1859 e fu di nuovo guerra. Rispondendo allappello di Garibaldi
che chiedeva un milione di fucili per i Cacciatori delle Alpi, il 25 giugno 1859,
allindomani della battaglia di San Martino vinta dai franco-piemontesi, Laura
lanciava un proclama alle donne italiane in cui la tradizionale rappresentazione
della donna partecipe della vita collettiva del proprio Paese nella cura amorevole
del focolare domestico veniva superata in nome di una pi diretta e consapevole
azione politica:
Gli uomini che abbiamo mandato a combattere contro gli austriaci (i nostri ma-
riti, fgli, fdanzati) hanno bisogno di armi. Se noi perch siamo donne non pos-
siamo impugnarle e combattere al loro fanco, almeno compriamole per ofrirle
allesercito: facciamolo a costo di essere disapprovate dai famigliari, di intaccare
il patrimonio, di impoverire la nostra casa. E facciamolo perch gli uomini la
smettano di relegarci in cucina, casalinghe e modeste e capiscano che possiamo
essere loro compagne
72
.
71 Riall, L. Garibaldi. Linvezione di un eroe, Roma-Bari, Laterza, 2007.
72 Farina, R. Solera Laura in Mantegazza, in Farina, R. (a cura di) Dizionario biografco delle donne
lombarde 568-1968, Milano, Baldini e Castoldi, 1995.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 191 03/05/2013 11:11:16
192
Capitolo 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo Ottocento lombardo
Lamarezza di fronte allarmistizio di Villafranca spinse molti democratici, e
la Solera con essi, a credere nellef cacia di un altro tipo di azione patriottica che
avesse in Garibaldi il centro propulsore. La preparazione della spedizione dei Mille
vide tutto il gruppo delle patriote milanesi allopera per la raccolta di fondi. Laura
organizz nella propria abitazione una lotteria, mettendo in palio oggetti di sua
propriet e inviando il ricavato allamico Bertani. A partire dal giugno poi diede
vita a un progetto a sostegno della spedizione garibaldina al quale lavor alacre-
mente, intessendo una ftta rete di solidariet al femminile e avvalendosi dellaiuto
di Adelaide Bono Cairoli, con cui strinse un serrato rapporto epistolare tra il giu-
gno 1860 e il luglio 1862. Insieme le due madri italiane contribuirono allela-
borazione del mito garibaldino con la proposizione di una coccarda patriottica re-
cante al centro lef gie delleroe da vendersi in ogni citt lombarda al costo di una
lira. Il successo delliniziativa fu tale da indurre la Solera a riproporre liniziativa
anche in occasione della presentazione del progetto di ofrire ai Mille un vitalizio.
Nel richiedere alla Cairoli solidariet e collaborazione, Laura ofriva una concreta
espressione del valore simbolico assunto dalla spedizione nellopinione pubblica
democratica: se tanti erano stati i seguaci di Garibaldi in Sicilia, solo i Mille pote-
vano a suo dire meritare il segno della riconoscenza dello Stato perch i mille soli
tentarono unimpresa che logicamente savrebbe potuta giudicare impossibile []
i mille soli afrontando con poche e orribili armi il pericolo di 1000 palle contro
ognuno dei loro tiri, si esposero a divenire anche il pasto dei pesci, e a perire sul
patibolo oppure a languire tutta la vita nelle crudeli prigioni del re di Napoli
73
.
Pi tardi la volont di afrontare la questione irrisolta di Roma e Venezia con
la creazione di una guardia nazionale, richiesta da Garibaldi deputato a Napo-
li come espressione concreta del sogno democratico della nazione armata, trov
ancora una volta Laura pronta alla mobilitazione e decisa a riproporre la formula
della lotteria per raccogliere i fondi necessari allimpresa. Consapevole del valore
fortemente evocativo dellimmagine del generale, non esit inoltre a ricorrere alla
vendita di suoi ritratti autograf, senza tuttavia riscuotere il successo sperato.
Le reazioni suscitate dal drammatico ferimento di Aspromonte ofrono
unimmagine estremamente signifcativa del livello raggiunto dal mito garibaldino
nellimmaginario collettivo. Laura stessa ofr allamica e collaboratrice Noerina
No una descrizione dellaccaduto ricca di tonalit epiche: in quella posizione
[] non solo avrebbe potuto distruggere completamente il corpo che lo attacc,
ma occorrendo, tener testa a uno che fosse stato dieci volte pi numeroso. Rinun-
ciare in questa occasione alla vittoria, al suo prestigio di invincibilit, era un dove-
73 Laura Solera Mantegazza ad Adelaide Bono Cairoli, Milano, 4 maggio 1861, Biblioteca civica
Bonetta, Archivio Cairoli, cart. 320, fasc. 95, n. 1.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 192 03/05/2013 11:11:16
193
4. Laura Solera Mantegazza tra militanza politica e impegno sociale
re; ma la sublimit di questo dovere, quantaltri fuori di lui, ofeso, assassinato, lo
avrebbero saputo raggiungere?
74
.
Accorsa alla fortezza del Varignano per prestare al generale assistenza e soste-
gno, la donna giungeva a esclamare in una lettera a Nicostrato Castellini: oh con
quanta gioia gli darei le mie due gambe inutili, o quasi!
75
.
Continui nelle lettere di quei mesi gli accenni a Garibaldi come santo mar-
tire, secondo Cristo, grande apostolo, sublime credente, luce del popolo,
adoratissimo angelo nostro, nostro salvatore, in un crescendo di esaltazione
devozionale fortemente imbevuta di elementi religiosi.
Totalmente annullata nellassistenza alleroe, concretizzatasi nel fornirgli le
prime flacce ricavate da un lenzuolo che provvidenzialmente aveva condotto con
s, si accontentava di poterlo vedere pochi minuti al giorno, il tempo suf ciente
per rassicurarsi e commentare per lettera allamica Noerina: egli era in s buono
stato quando lho lasciato. Pareva per nulla smagrito e ancora pi bello di prima.
Dopo alcuni giorni di cure assidue era riuscita a entrare in confdenza con
il Generale, che scherzosamente la chiamava donna Laura e le regalava sorrisi
divini. Indotta ad allontanarsi dalloggetto della sua adorazione dallarrivo al suo
capezzale di Jessie White Mario, candidamente confessava di sentirsi una colpe-
vole egoista trascurando tanti doveri per legoismo di sentirmi qualche volta dare
un ordine da lui, ordine che chiunque potrebbe eseguire
76
.
La miracolosa guarigione di Garibaldi ricondusse Laura a una prassi flan-
tropica e politica fatta di quotidiani e concreti interventi a favore dei progetti
democratici, dove tuttavia la fgura delleroe dei due mondi emergeva in tutta la
sua forza carismatica. Tra le diverse iniziative spicca limpegno profuso per il Bazar
Garibaldi, progettato nel gennaio 1864 con lausilio di Noerina No, Caterina
Foldi Raiberti, Lucia Prinetti Adamoli, Ismenia Sormani Castelli e di altre signore
milanesi, e consistente nellorganizzazione di un emporio, i cui proventi avrebbero
dovuto essere destinati al Generale qualora la forza degli avvenimenti gli [avessero
porto] una felice occasione di liberare i fratelli schiavi. Gli oggetti da vendere
avrebbero dovuto essere oferti da noti patrioti italiani, vicini alleroe e partecipi
con lui della creazione del mito garibaldino.
Nelle intenzioni dellorganizzatrice il Bazar avrebbe dovuto estendersi anche
ad altre citt italiane: contatti erano stati presi da Giovannina Lucca con Giovanni
Cadolini per Cremona e a Torino si era cercato di coinvolgere Grazia Mancini e la
74 Eadem a Noerina No, Spezia, 5 settembre 1862, Museo Centrale del Risorgimento di Roma,
Archivio Bruzzesi, cart. 97, fasc. 32, n. 1.
75 Eadem a Nicostrato Castellini, Varignano, 20 ottobre, 1862, in Castellini, G. Pagine garibaldine
(1848-1866), Torino, Bocca, 1909, pp. 125-126.
76 Ibidem.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 193 03/05/2013 11:11:16
194
Capitolo 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo Ottocento lombardo
madre Laura Beatrice Oliva, mentre a Genova la stessa Laura era in relazione con
un gruppo di signore che avevano dato vita a un associazione femminile di mutuo
soccorso su modello di quella milanese.
Non dato conoscere lesito delliniziativa. Nel luglio comunque lesperienza
sembrava conclusa. Le incomprensioni nate tra le protagoniste del Bazar e le dif-
fcolt incontrate avevano minato una profonda e radicata convinzione di Laura:
la fducia nella pervicace ostinazione femminile nel perseguire obbiettivi concreti:
Non ne parlate con gli uomini aveva scritto a Noerina nel settembre 1862 a
proposito della raccolta di fondi a favore dei garibaldini dopo Aspromonte al-
trimenti ci guastano le cose. Essi pi che noi possono e sanno dare la vita; ma in
queste pratiche manca loro la persistenza e lostinazione
77
.
A ci si aggiunse il progressivo deterioramento delle sue condizioni di salute.
Limpossibilit di prendere parte attiva alle iniziative legate allo scoppio della terza
guerra di indipendenza fu motivo di profonda frustrazione. Ancora una volta la
fgura di Garibaldi ritornava prepotente nel suo immaginario tanto da indurla a
sentirsi colpevole e a temere che leroe non fosse pi soddisfatto di lei: lo temo
malcontento di me perch pot pensare alla possibilit di un malcontento mio
verso di lui (!) e pi perch non so pi far nulla e questo mi accora grandemente.
Oh che lo salvi Iddio, porgendogli il premio tanto meritato di vedere la patria
libera
78
. Perfno nel momento della pi profonda af izione in occasione della
frma dellarmistizio con lAustria, il suo pensiero tornava al generale, con il desi-
derio di confezionare per lui un punch come quello che portava in Aspromonte.
E fu ancora un mantello tessuto con le sue stesse mani a segnare lultimo estremo
omaggio di Laura alleroe pochi mesi prima di morire e lultima testimonianza di
una vita per dirla ancora con Laura Guidi densamente militante.
77 Laura Solera Mantegazza a Noerina No, Sabbioncella, 25 settembre 1862, Museo Centrale del
Risorgimento di Roma, Archivio Bruzzesi, cart.97, fasc. 32, n. 4.
78 Laura Solera Mantegazza a Noerina No, Bernareggio, 26 giugno 1866, Museo Centrale del
Risorgimento di Roma, Archivio Bruzzesi, cart. 99, fasc. 81, n. 3.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 194 03/05/2013 11:11:16
5. Mazzinianesimo e radicalismo nei carteggi
della Romussi-Lazzati nella seconda met
dellOttocento
Altea Villa
Obiettivo del mio intervento presentare i risultati di una ricerca sulla vita e latti-
vit di due donne milanesi, Cristina Lazzati Rossi e Maria Romussi Lazzati (madre
e fglia), che nel corso dellOttocento non solo furono testimoni delle vicende che
interessarono il nostro Paese, ma parteciparono attivamente alla promozione di
campagne ideali quali lindipendenza nazionale, la causa mazziniana, il pacifsmo,
lemancipazione femminile. Le fonti che mi hanno permesso di condurre tale in-
dagine sono gli epistolari delle due donne, e in particolare della madre, conservati
presso larchivio privato Carlo Romussi di Milano
79
.
Grazie alle lettere ricevute dalle Lazzati mi possibile oggi tracciare un proflo
biografco essenziale di due soggetti le cui esperienze politiche, rimaste totalmente
in ombra fno a questo momento, aggiungono a mio parere un tassello non insigni-
fcante alla storia delle donne milanesi durante il Risorgimento e nei primi decenni
postunitari. Devo chiarire fn da subito che risulta dif cile collocare in una categoria
politica defnita la militanza delle due, ma soprattutto di Cristina Lazzati Rossi;
volendo trovare degli aggettivi che possano descrivere momenti del suo impegno,
sceglierei quello di mazziniana, ma anche di garibaldina, pacifsta, emancipazioni-
sta, radicale. Come si pu notare, si tratta di aggettivi che, rinviando tutti al campo
democratico, fanno di Cristina Lazzati e anche della fglia due esponenti di un mo-
vimento vasto e variegato, che comprende al suo interno numerosi personaggi con
le quali le due donne entrarono in contatto nel corso della loro vita.
79 Linventario dellarchivio Carlo Romussi stato pubblicato: Massari, S. (a cura di) Carlo Romussi
1847-1913. Inventario dellArchivio, Torino, Edizioni Visual grafka, 2007.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 195 03/05/2013 11:11:16
196
Capitolo 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo Ottocento lombardo
Due vite non comuni
Cristina Rossi nasce a Milano nel 1823; della famiglia non sappiamo molto, solo
che il padre Francesco un ingegnere, mentre della madre Maria Calvi non abbia-
mo notizie. Nel necrologio scritto per la morte di Cristina, nel 1913, si sottolinea
come la sua fosse una distinta e storica famiglia milanese, che tutto sacrifc per la
liberazione dItalia, e tanto fu perseguitata nei tristi tempi del servaggio
80
.
Se per quanto riguarda la formazione patriottica di Cristina, allinterno del
nucleo familiare, sono in possesso unicamente di supposizioni, mi possibile di-
mostrare come fn nella giovinezza la donna fosse su posizioni repubblicane. Nel
1848 la Rossi ebbe un primo ingenuo contatto con Giuseppe Mazzini, al quale
don una coccarda tricolore durante il suo soggiorno milanese nel maggio 1848.
Il patriota genovese rispose con un biglietto, gentile quanto impersonale, per rin-
graziare la donna che gli aveva inviato lomaggio.
Se tale dono pu apparire poco signifcativo, non lo afatto alla luce della
corrispondenza che i due si scambieranno negli anni Sessanta, di cui parler pi
avanti. Altro evento rilevante per la vita e per lopinione politica della Rossi il
matrimonio, celebrato nel 1850, con il ragioniere Osvaldo Lazzati (1822-1887).
La famiglia Lazzati estremamente patriottica, e vede i suoi componenti impegna-
ti nelle Cinque giornate di Milano. Osvaldo e i fratelli saranno arrestati nel 1852:
se il marito di Cristina viene rilasciato dopo un periodo di detenzione, il cognato
Antonio, implicato nei moti milanesi del 6 febbraio 1853, rischia lesecuzione tra
i martiri di Belfore
81
, ma scampa fortunosamente alla morte e rimarr il Lazzati
pi famoso della famiglia.
Le lettere presenti nellarchivio Romussi sono relative al lavoro della Rossi
Lazzati a partire degli anni Sessanta, quindi non dir nulla sugli anni Cinquanta,
se non che nel 1851 nacque lunica fglia dei Lazzati, Maria, altra protagonista
della mia ricerca.
Dopo lUnit dItalia Cristina collabora attivamente con Laura Solera Mante-
gazza, dividendosi tra le numerose societ che compongono luniverso dellassocia-
zionismo femminile milanese. Tale collaborazione ha inizio con le raccolte di fondi
per i volontari garibaldini, organizzate fn dal 1860
82
con lotterie e bazar che per-
mettono di inviare cibo, medicinali e camicie rosse ai combattenti. Le numerose
iniziative, tra cui possibile ricordare il Soccorso a Venezia e il Dono per le camicie
rosse, vengono tutte coordinate dalla Societ Patriottica Femminile; questa associa-
80 Un altro lutto in casa Romussi, in Il Secolo, 12 aprile 1913.
81 Luzio, A. I martiri di Belfore e il loro processo, Milano, Cogliati, 1916; pp. 232-233.
82 Se ne parla, per esempio, in una lettera di Laura Solera Mantegazza ad Agostino Bertani, datata
20 maggio 1860; Milano, Civiche Raccolte Storiche, Fondo Bertani, cart.35, plico 146, lettera 262.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 196 03/05/2013 11:11:16
197
5. Mazzinianesimo e radicalismo nei carteggi della Romussi-Lazzati
zione, di cui si hanno scarse informazioni, viene forse costituita in seno allAssocia-
zione Unitaria Italiana, dato il suo costante legame con Agostino Bertani.
Cristina Lazzati e la fglia, ancora bambina, cominciano a prender parte alla
Societ prima donando denaro e oggetti, e poi diventando volontarie per la rac-
colta degli stessi doni nelle diverse campagne. Quando, nel 1862, la Solera Man-
tegazza fonda lAssociazione Generale di Mutuo Soccorso per le operaie milanesi,
Cristina fgura tra i membri del comitato esecutivo, rivelando la sua sensibilit
nei confronti non solo dellidea di patria, ma anche pi ampiamente verso il pro-
blema sociale femminile. In questo periodo la Rossi Lazzati diviene una corri-
spondente di Giuseppe Mazzini, il quale la ritiene una valida sostenitrice della
causa repubblicana. Le lettere che i due si scambiano tra il 1862 e il 1870 non
sono molte, ma contengono gli elementi pi caratteristici del mazzinianesimo
femminile: limportanza dellimpegno e dellattivit femminile, anche sulla scena
pubblica, per lunit della patria
83
e la fgura simbolica della madre-cittadina come
fulcro delleducazione patriottica dellindividuo
84
. In una lettera che Mazzini invia
nellagosto 1862 a Maria, ma che vuole le venga consegnata solo nel giorno del
suo matrimonio, o, in alternativa, al compimento del suo ventesimo anno, scrive:
serbate questo ricordo di un uomo il cui pensiero, morendo, sar sentiero da-
more, per quante fanciulle italiane costituiranno la pi alta speranza della Patria
nascente, educando s stesse, e pi tardi i loro fgli, e sempre tutte coloro che mo-
veranno nella loro sfera, a sperare, ad agire e combattere, perch lItalia sia Una,
Grande, Virtuosa e Devota, al Giusto, al Vero, al Bello, a Dio e alla sua legge, che
Progresso per tutti. E voi, ne ho fede, sarete fra quelle
85
.
Anche se Cristina Lazzati fu solo una delle tante corrispondenti di Mazzini,
ci non toglie che questi la considerasse unottima lavoratrice, e le dichiarasse
in voi fdo
86
.
Lattivit internazionale
Nel corso degli anni Sessanta, ma soprattutto degli anni Settanta, la Lazzati non
svolge solo compiti legati allassociazionismo milanese, ma segue anche una serie
83 Gazzetta, L. Una doppia rivoluzione. Il mazzinianesimo femminile tra etica e politica, pagg.39-
40, in Bertolotti, M. (a cura di) La nazione dipinta. Storia di una famiglia tra Mazzini e Garibaldi,
Milano, Skira editore, 2007.
84 Gazzetta, Una doppia rivoluzione cit. p. 41.
85 Giuseppe Mazzini a Maria Lazzati, 6 agosto 1862; Archivio Carlo Romussi, 13, 06, 04
86 Giuseppe Mazzini a Cristina Lazzati Rossi, 17 settembre 1866; Archivio Carlo Romussi, 13, 06, 08.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 197 03/05/2013 11:11:16
198
Capitolo 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo Ottocento lombardo
di attivit collaterali nel campo del pacifsmo internazionale. Prima con il marito,
e in seguito anche con la fglia, socia della Lega per la pace e la libert, fn dallan-
no della sua fondazione a Ginevra, nel 1867. Questa lega, il cui fne principale
la costruzione di unEuropa democratica aperta a sviluppi socialisti
87
, vede tra i
suoi membri Charles Lemonnier, lo stesso Garibaldi, Ernesto Teodoro Moneta
e gode quindi di un respiro realmente internazionale. La famiglia Lazzati segue da
vicino le attivit dellassociazione, attraverso il suo giornale, LEtats Unis dEurope,
e tramite i congressi. Durante il congresso di Lugano, nel settembre del 1872, le
Lazzati conoscono Marie Goegg. La svizzera Goegg, nata Pouchelin, non era solo
membro della Lega per la pace, ma aveva introdotto tra le questioni da afrontare
nella Lega quella femminile, fatto che aveva destato non pochi scontri tra i suoi
membri. Fondatrice, nel 1870, dellAssociazione Internazionale delle donne, viene
considerata uno dei simboli del femminismo internazionale; quando conosce i
Lazzati da qualche mese vice-presidente di una nuova organizzazione femminista
internazionale, nata da una costola della precedente, lAssociazione per la difesa dei
diritti della donna
88
. Questa nuova associazione vede, oltre a un comitato centrale,
anche numerosi comitati locali dislocati sia in Europa sia negli Stati Uniti; quello
italiano composto da Carolina Varesi e da Gualberta Beccari. Cristina e Maria
Lazzati diventano socie alla fne del 1872, e per qualche tempo non ho notizie su
una loro pi fattiva collaborazione; parallelamente Cristina impegnata nei lavori
per la fondazione e la gestione, a Milano, della Scuola Professionale Femminile.
Dal 1875 al 1880 Cristina Lazzati diviene segretaria e tesoriera del comitato
milanese dellAssociazione per la difesa dei diritti della donna, e riesce in questo
modo a garantire una borsa annuale alle allieve della Scuola Professionale, i cui
progressi sono comunicati al comitato centrale a Ginevra. Con le sue conoscenze
riesce inoltre ad assicurare una serie di adesioni illustri, quali quelle di Benedetto
Cairoli, Agostino Bertani i cui nomi vengono esaltati nelle righe del bolletti-
no trimestrale, chiamato Solidarit. Anche la fglia Maria partecipa fattivamente
allorganizzazione svizzera, scrivendo le corrispondenze in lingua francese per lo
stesso bollettino. I brevi articoli descrivono attentamente il procedere del dibattito
sulla questione femminile in Italia, mettono in evidenza labilit delle studentesse
milanesi premiate e i risultati ottenuti a scuola, riportano necrologi di personag-
gi come Laura Solera e Giulietta Pezzi, oltre agli appunti su letture pubbliche e
congressi. Proprio in seguito a un articolo
89
scritto su una conferenza tenuta da
Vincenzo Brusco Onnis alla Scuola Mazzini sul tema dellemancipazione della
87 Pieroni Bortolotti, F. La donna, la pace, lEuropa. Lassociazione internazionale delle donne dalle
origini alla prima guerra mondiale, Milano, Franco Angeli, 1985, p. 26.
88 Pieroni Bortolotti, La donna, la pace, lEuropa cit, p.163.
89 Solidarit, n. 13, agosto 1877.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 198 03/05/2013 11:11:16
199
5. Mazzinianesimo e radicalismo nei carteggi della Romussi-Lazzati
donna, Maria riceve una lettera del patriota, gi corrispondente della madre, che
loda il suo lavoro:
Vedere qualche fanciulla italiana consacrarsi, come voi fate, ai serii e utili studi,
e, disdegnosa di ogni frivola occupazione, porre lanimo e la mente a ci che
pi conferisce ad afrettare i grandi ideali dellumano progresso, , credetelo, un
sommo conforto alla povera vita mia
90
.
Verso la fne degli anni Settanta limpegno di Cristina Lazzati si concentra
soprattutto sul pacifsmo e sullemancipazionismo. Il 1879 un anno chiave per
lei; infatti diviene socia e segretaria della sezione milanese dellitaliana Lega della
Libert, Fratellanza e Pace, dove lavora a stretto contatto con Paolina Schif, e con
lavvocato e giornalista del Secolo Carlo Romussi, che quello stesso anno diventa
suo genero.
Inoltre il nome della Lazzati fgura nel comitato esecutivo della Lega pro-
motrice degli interessi femminili, fondata da Annamaria Mozzoni, e da ci si pu
dedurre che abbia avuto rapporti anche con questo fondamentale personaggio
del femminismo italiano, anche se non sono presenti testimonianze a questo ri-
guardo. Negli anni Ottanta le Lazzati, alle quali si aggiunge ora Carlo Romussi,
continuano a promuovere le cause che stanno loro a cuore, in particolar modo la
Scuola Professionale femminile, di cui rimangono ispettrici; bisogna rilevare che
entrambe vengono considerate punti di riferimento per chi necessiti di una solida
base dappoggio nella citt di Milano. Utile esempio lamicizia che Cristina e
Maria stringono con Giorgina Craufurd Saf ; questa, inglese e sposata con il pa-
triota romagnolo Aurelio Saf , una fervente mazziniana che molto combatte per
la patria, per listruzione, per la lotta alla prostituzione
91
. In una lettera del 1883
92
la Saf appare impegnata anche sul fronte dellirredentismo e si rivolge a Cristina
Lazzati perch aderisca e difonda a Milano e in Lombardia delle schede a sostegno
di Trieste libera.
Grazie al matrimonio di Maria con Carlo Romussi, le due donne entrano in
una nuova fase di impegno politico e sociale, che legata al gruppo dei radicali mi-
lanesi, di cui fa parte anche Felice Cavallotti, molto vicino alla famiglia Romussi.
Maria Lazzati diventa membro di numerose societ di mutuo soccorso, di cui
il marito spesso presidente, e segue da vicino le vicende che impegnano Carlo
Romussi, che nel 1896 diviene direttore del quotidiano Il Secolo.
90 Vincenzo Brusco Onnis a Maria Lazzati, 7 settembre 1877; Archivio Carlo Romussi, 13, 23, 01.
91 Gazzetta, L. Giorgina Saf . Contributo alla storia del mazzinianesimo femminile, Milano, Franco
Angeli, 2003.
92 Giorgina Saf a Cristina Lazzati Rossi, 4 gennaio 1883; Archivio Carlo Romussi, 22, 11, 10.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 199 03/05/2013 11:11:16
200
Capitolo 3. Identit e percorsi di donne nella sfera pubblico-politica del lungo Ottocento lombardo
Del lavoro della madre Cristina, divenuta vedova nel 1887, non abbiamo pi
notizie; certo che lintera famiglia viene fortemente scossa dallarresto di Romus-
si in seguito ai moti del 1898. Dopo il processo in cui viene giudicato colpevole,
luomo resta per tredici mesi nel carcere di Finalborgo, ad Alessandria. In questo
frangente molti dimostrano solidariet alla famiglia; per esempio Edoardo Porro
scrive a Maria: Possano i giorni futuri compensarla delle amarezze soferte per la
cecit e la cattiveria degli uomini che reggono il povero paese nostro
93
!
Come si pu notare da questa breve testimonianza, la carcerazione di Ro-
mussi lascia il segno nellopinione pubblica italiana e internazionale; numerose
iniziative vengono organizzate per fare pressione sul governo af nch conceda
lindulto ai detenuti politici; tra queste la pubblicazione dellopuscolo Pro Amni-
stia, la raccolta di fondi, e la difusione di migliaia di schede raf guranti Turati,
Romussi e De Andreis.
Cristina Lazzati Rossi muore, come abbiamo visto, nel 1913; non si hanno
ulteriori dati sulle sue attivit negli ultimi anni di vita, anche se lecito pensare
che un personaggio di tale proflo non abbia mai rinunciato allazione, fossanche
solo costituita da un attento esame della situazione politica e della questione fem-
minile.
La fglia Maria, che rimane vedova nel 1913 e muore nel 1938, non toccher
mai nel Novecento il grado dimpegno che aveva raggiunto tra gli anni Sessanta
e gli anni Ottanta dellOttocento, quando accompagnava la madre; rimane per
membro di numerosissime opere pie e societ di mutuo soccorso.
93 Edoardo Porro a Maria Romussi Lazzati, 9 settembre 1899; Archivio Carlo Romussi 3, 10, 01.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 200 03/05/2013 11:11:16
CAPITOLO 4
Che genere di nazione?
a cura di Raffaella Bianchi
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 201 03/05/2013 11:11:16
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 202 03/05/2013 11:11:16
Introduzione
Raffaella Bianchi
Women as a whole where divided between those who did and those who did
not contributed to the nations moral well-being
1
Questa sezione si interroga sul genere della/nella nazione italiana nel perio-
do storico che prelude e precede lUnit nazionale, identifcato dallemergere del
concetto di italianit. I seguenti contributi giocano sullambiguit con cui il
titolo della sezione viene espresso che intrinseca nelluso del termine genere
nella lingua italiana. Qui, genere si riferisce sia al flone accademico di studi di
genere, che ha arricchito di nuove prospettive epistemologiche e metodologiche
lanalisi storica e delle scienze sociali negli ultimi decenni, sia alluso corrente della
parola genere, vale a dire tipo. Il termine evoca anche un altro ambito che
quello della cultura; genere si riferisce infatti allambito artistico, nelle accezioni
genere letterario o musicale, ecc. Gli interrogativi che le studiose si pongono
nelle pagine seguenti ruotano attorno a questi tre concetti che sono interrelati
e prendono via via diverse connotazioni nei loro contributi. Si tratta, quindi, di
ricerche di storia culturale che utilizzano lanalisi di genere nellintento di arricchi-
re il concetto di nazione, defnita come costrutto culturale. Sulla scia degli studi
pubblicati sul ruolo del genere nei nazionalismi, come, per citare solo due studi
comparati, limportante saggio edito a cura di Ida Blom, Karen Hagemann e Ca-
1 Landes, J.B. Visualizing the Nation. Gender, Representation and Revolution in Eighteen-Century
France, Ithaca and London, Cornell University Press, 2001, p.16.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 203 03/05/2013 11:11:16
204
Capitolo 4. Che genere di nazione?
therine Hall
2
e, avvicinandoci alla nostra area geografca dinteresse, le rifessioni
di Alberto Banti
3
sul genere nel nazionalismo europeo, ci interroghiamo sullim-
portanza dellidentit di genere nel discorso nazionale italiano. Nellinterrogarci
sulla funzione di uomini e donne, di femminilit e di mascolinit nella costruzio-
ne immaginaria (e non) della nazione italiana sin dai suoi albori, riscopriamo un
concetto di italianit costruito attraverso queste stesse femminilit e mascolinit,
e in esse incarnato.
Il 2011 segna il centocinquantesimo anniversario dellunit italiana. Quale
momento migliore per rifettere sul concetto di nazione? Eppure questanalisi non
sembra essere centrale nella vita intellettuale della Penisola. Sar che lera della glo-
balizzazione ha reso la nazione un vestito un po fuori moda, non adatto alla nuova
temperie politico-economica. Sar che la nazione italiana come costrutto culturale
viene attaccata dal di dentro, da campanilismi e regionalismi trasformatisi in istan-
za politica disgregante. Comunque, un partito spesso tacciato di razzismo del nord
che ha riassegnato un signifcato separatista a uno dei simboli dellunit dItalia,
il coro verdiano Va pensiero utilizzato nei rituali leghisti di Pontida, dovrebbe in-
durre a una rifessione profonda, anche in chiave storica, sui simboli identitari di
questo Paese in relazione al discorso nazionale. Quella italiana, oggi, si confgura
come unidentit che viene giocata in occasione dei mondiali di calcio, ma che ri-
esce di dif cile defnizione, e la cui storia di formazione politico-culturale sembra
essere sparita dagli scafali delle maggiori librerie, dove davvero raro trovare una
sezione specifca dedicata alla storia del Risorgimento. Sembra quasi che nella vita
culturale italiana vi sia una sorta di rimozione intellettuale, un vuoto ontologico
attorno al concetto di nazione. E non mi pare un caso che i contributi seguenti
vengano da studiose che per la maggioranza vedono la nazione da una prospettiva
esterna, dove linterrogarsi sulle specifcit della cultura italiana sintreccia con
storie dincontro con lAltro, attraverso vissuti personali di migrazioni fsiche e/o
intellettuali in territori stranieri delle scriventi.
La nazione di Serena Guarracino una nazione altra in quanto sia la catego-
ria di genere, sia il concetto di italianit si costruiscono in relazione con lAltro. Il
cantante dopera italiano qui soggetto migrante e oggetto di uno sguardo altro
attraverso il quale opera e identit italiane vengono identifcate nel contesto della
Londra di fne Settecento alle prese con una ridefnizione della stessa identit in-
glese, preparatoria alla conquista coloniale. In unepoca in cui i castrati dominano
i palcoscenici operistici, litalianit viene associata al femminile, o meglio allefe-
2 Blom, I.; Hagemann, K.; Hall, C. (a cura di) Gendered Nations. Nationalisms and Gendered Order
in the Long Nineteenth Century, Oxford e New York, BERG, 2000.
3 Banti, A.M. LOnore della Nazione. Identit sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII
secolo alla Grande Guerra, Torino, Einaudi, 2005.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 204 03/05/2013 11:11:16
205
Introduzione
minatezza, contrapposta a unidentit inglese virile e scevra dambiguit sessuali
e sessuate. Questo contributo si situa cronologicamente alla fne del Settecento,
un momento di costruzione identitaria rilevante per la Penisola italiana. Secondo
Banti, il termine Italia o italiano veniva utilizzato dal 1796, nella trattatistica
legale
4
, e noi studiose di cultura musicale, inizieremo a veder apparire queste ac-
cezioni anche nei titoli di alcune opere a cavallo dellOttocento, come LItaliana in
Londra (1778) di Domenico Cimarosa e le celeberrime opere rossiniane LItaliana
in Algeri (1813) e Il Turco in Italia (1814). Si tratta comunque di unitalianit in
nuce che si defnisce nellincontro e nel confronto con lAltro. Trovo interessante
notare come la rappresentazione di genere sui palcoscenici operistici di questo pe-
riodo sia contraddistinta da una maggiore ambiguit rispetto alle epoche appena
successive, oggetto della mia ricerca
5
, quando la comunit nazionale diventa un
costrutto politico-immaginativo pi sentito Un esempio interessante di questo
cambiamento di sensibilit viene rilevato nella critica teatrale, infatti, nella Gaz-
zetta Privilegiata di Milano qualche decennio dopo, il 14 Novembre 1831, il ve-
stimento da uomo, costume di scena della cantante Giuditta Grisi, viene criticato
in quanto non confacente alla sua gentil fgura
6
. Le rappresentazioni di genere
cambiano quando sui palcoscenici operistici viene decretata la fne dei castrati. Si
tratta non solo di un cambiamento di gusto, ma anche di un mutamento generale
del rapporto tra genere e politica nel discorso nazionale e nella percezione stessa
del genere in ambiti diversi della vita ottocentesca dove si assiste a un generalizza-
to irrigidimento delle categorie genere/sessualit. Il genere maschile e femminile
nel Risorgimento viene defnito rigorosamente in relazione al sesso e nemmeno il
teatro dopera pu pi rappresentare un luogo di ambiguit, anzi viene a essere il
palcoscenico privilegiato che mette la donna sul piedistallo della rappresentazione
del discorso nazionale.
Un periodo risorgimentale che viene analizzato da Simonetta Chiappini nelle
sue peculiarit musicologiche, dove lulteriore cambiamento di centralit delle voci
4 Per una storia delluso del termine Italia e italiano nel Risorgimento, a partire dalla trattati-
stica legale, attraverso i pamphlet politici fno ad arrivare a un uso pi generalizzato, si veda Banti,
A.M. La Nazione del Risorgimento. Parentela, santit e onore alle origini dellItalia unita, Torino, Ei-
naudi, 2006, pp. 3-29.
5 Il mio dottorato di ricerca si concentra sul periodo della Restaurazione analizzando il ruolo poli-
tico del teatro alla Scala di Milano nel Risorgimento dal ritorno degli austriaci alle Cinque Giornate.
Mentre recentemente ho pubblicato un articolo sulla funzione della cultura operistica nella costru-
zione identitaria nazionale in Italia e in Turchia: Bianchi, R.; Coskun, B. Opera across the Borders:
the construction of Italian and Turkish national identities, in Guarracino, S.; Vitale, M. (a cura di)
Music Across Borders: Music and the Performance of Identity. Anglistica, vol. 13, n. 2, 2009, pp. 59-70.
6 Appendice critico-letteraria teatrale e di variet, in Gazzetta Privilegiata di Milano, n. 365, 31
December, 1831, pp. 1-2.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 205 03/05/2013 11:11:16
206
Capitolo 4. Che genere di nazione?
sui palcoscenici operistici, da quelle contraltili rossiniane allegemonia dei soprani
degli anni trenta dellOttocento, viene spiegato in rapporto alle diverse funzioni
del femminile nel discorso nazionale. I soprani, donne inserite in un contesto di
desiderio precipuamente eterosessuale, ispiratrici di furori che si ridestano prepa-
ratori alle stragi che sapprestano
7
, sono usati strumentalmente nella costruzione
speculare di una mascolinit che diventa sempre pi monolitica e univocamente
espressa dalla fgura delleroe
8
. Queste fgure di donna-nazione sono immaginarie
e insieme reali nella loro corporalit, una corporalit che rappresenta idealmente
e fsicamente la costruzione del corpo della nazione. Donne immaginarie come
Norma, ma anche reali che recitano e vivono battaglie ideali, sul palcoscenico e/o
nella vita culturale del tempo, come la cantante e patriota Giuditta Pasta. Una vita
culturale che afascina per la sua ricchezza, quella raccontata da Giulia Frontoni
dove troviamo le donne come operatrici culturali nella costruzione della nazione,
in relazione con il mondo tedesco
9
. Questo contributo sinserisce nel flone di
rifessione che sottolinea limportanza della comunit famigliare nella costruzione
della comunit nazionale
10
. Mentre il ruolo tradizionale delle donne nei movi-
menti nazionali si esplica in relazione alluomo, la donna fonte di ispirazione e di
supporto alla battaglia, la funzione patriotica si inserisce nel suo ruolo di nutrice
dei fgli e, per esteso, della nazione. Sacrifcando lamore, sia esso romantico o f-
liale per il fne politico della costruzione delle comunit nazionali, la donna viene
a incarnare la nazione stessa. Benedetta Gennaro ci presenta anche una tipologia
di donne altre, combattive e combattenti in prima persona. La femminilit nella
costruzione del discorso della nazione viene presentata in questi contributi nella
sua declinazione plurale, dapprima da forme di genere meno defnite in chiave
eterosessuale, come nei palcoscenici operistici visitati da Guarracino, che sono in
contrappunto con le forme di femminilit pi convenzionali, come nel caso delle
madri nella sfera pubblica europea analizzate da Frontoni, ma si delineano anche
fgure altre che assumono nuove funzioni, trasformandosi con il passare degli
7 Romani, F. I Capuleti e I Montecchi: musica di Vincenzo Bellini, Atto primo, consultabile online:
http://www.librettidopera.it/capumon/capumon.html
8 Heller, W. Reforming Achilles: Gender, opera seria and the rhetoric of the Enlightened hero,
in Early Music. Metastasio, 1698-1782, vol. 26, n. 4, November 1998, pp. 562-581.
9 Per luso del termine tedesco durante il Risorgimento per riferifersi in maniera generalizzata ai
popoli di lingua tedesca e in particolare allelemento dominante austriaco, si veda Frontoni, G. Odio
gli Austriaci: Donne italiane tra amicizia, legami familiari ed interessi politici nel 1848/49. (Italy and
Emotions: Perspectives from the 18th century to the present. London, Te Association for the Study
of Modern Italy Annual Conference, 27 28 Novembre).
10 Per un recente contributo in questo senso si veda Ngaire Heuer, J. Te Family and the Nation.
Gender and Citizenship in Revolutionary France, 1789-1830, Ithaca and London, Cornell University
Press, 2005.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 206 03/05/2013 11:11:16
207
Introduzione
anni e col mutare delle esigenze politiche, come il cangiante ruolo dei contralti ana-
lizzato da Chiappini per gli anni Trenta o il giudizio sulle donne in armi registrato
dalla Gennaro alla vigilia delle Guerre dIndipendenza.
La funzione pubblica e politica di queste femminilit al plurale, lo sguardo
di e verso queste donne sul piedistallo rappresentato dal palcoscenico, nella sfera
pubblica borghese internazionale o nel chiuso della scrittura nelle loro stanze tutte
per s e sugli aperti campi di battaglia, al centro della nostra rifessione. Dal
punto di vista epistemologico, non si tratta pi solo di ampliare la prospettiva
dindagine dalla storia tradizionalmente intesa come narrazione al maschile a una
storia al femminile, ma di scardinare e ricontestualizzare il contenuto stesso di
identit nazionale attraverso una (ri)lettura di genere. Si tratta di rifettere sulla na-
zione da una prospettiva femminista che considera il genere non un dato biologico
ma una categoria costruita socialmente dove femminilit e mascolinit entrano in
un gioco di relazioni di signifcato e questa relazione diventa costrutto nazionale.
Questo non signifca che la ricerca storica non debba concentrarsi sulla storia al
femminile: troppi secoli di storia scritta dagli uomini, o incentrata su personalit
maschili, hanno lasciato la storia delle donne come un tema marginale e margi-
nalizzato, e i seguenti contributi sono centrati attorno a fgure femminili proprio
nellintento di colmare questa lacuna di potere e di sapere.
Ma riteniamo che questa storia al femminile si possa e si debba inserire in una
prospettiva di ricerca pi ampia, dove una prospettiva femminista metta in discus-
sione non solo il femminile, ma anche il maschile, e dove femminilit e mascoli-
nit (al plurale) have a meaning in relation to each other, as a social demarcation
and cultural opposition
11
. Se vero, come sostiene Benedict Anderson, che lim-
magine della tomba del milite ignoto satura di ghostly national imaginings
12
che si giocano sulla relazione tra nazionalismo e morte, allora i corpi femminili
immaginati e reali rimandano alla connessione tra nazionalismo e vita. Verso que-
sto collegamento sembrano indirizzare gli studi che analizzano la nazione come
comunit immaginata usando le tematiche di genere come strumenti metodolo-
gici. Lormai classico studio di Nira Yuval Davis sul genere e la nazione
13
vede la
fgura del combattente, protettore della nazione e quella della donna, riproduttrice
della nazione, come correlate e speculari nella costruzione del discorso nazionale.
Questa specularit delle funzioni assegnate al femminile e al maschile nel discorso
nazionale ben si coniuga con la visione di Banti di un discorso del nazionalismo
europeo costruito attorno alle metafore di sangue e parentela. Come questa fun-
11 Connel, R. Masculinities, Sydney, Polity Press, 1999, p. 44.
12 Green, A. Cultural History, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2008, pp. 109.
13 Yuval-Davis, N. Gender and Nation, London, SAGE, 1997.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 207 03/05/2013 11:11:16
208
Capitolo 4. Che genere di nazione?
zione sia interconnessa con il desiderio e quale la sua funzione in rapporto alle
strutture egemoniche di mascolinit
14
, sono argomenti che auspichiamo vengano
ripresi e ampliati per il periodo risorgimentale, ed esplorati anche nello studio di
altri periodi storici fondamentali per la costruzione dei discorsi sulla comunit
nazionale italiana.
Questo interrogarsi sui pericoli di una nazione basata sul concetto di unioni
di sangue e di legami famigliari vuole anche essere unagenda di ricerca con una
funzione politica precisa in un momento delicato per il nostro Paese. Ci teniamo
a sottolineare come la nazione incarnata nei corpi e costruita sulle metafore e i
desideri che circondano il senso dei legami famigliari abbia chiare ricadute po-
litiche. Per esempio, Banti vede in questo costrutto culturale uno dei fattori alla
base dellaggressivit europea verso lAltro, che sfocia nella Grande Guerra del
secolo scorso. Vorremmo altres sottolineare come un nazionalismo costruito su
immagini che sottolineano i legami di sangue come il cemento della nazione possa
rivelarsi poco capace di accogliere culturalmente lAltro, quello che, mosso dalla
speranza, oggi si presenta alle nostre frontiere, bussando alle porte della Fortezza
Europa. Come non interrogarsi come storiche culturali sulla capacit dinclusione
delle nazioni europee di fronte allesplosione di razzismo in unEuropa sconcertata
dagli efetti della globalizzazione? Ma il nostro studiare la storia del discorso nazio-
nale per interrogarsi sul genere di nazione che abbiamo di fronte oggi ha anche
una caratterizzazione di genere pi precisa. Come San Tommaso vogliamo pun-
tare il dito della nostra analisi nella piaga del corpo delle donne strumentalizzato
nella costruzione immaginaria della politica italiana. Vediamo la rappresentazione
del femminile che viene veicolata dalle donne al potere nel contesto di una pi ge-
neralizzata volgarizzazione mediatica del corpo delle donne, ma ci interroghiamo
anche sullo specifco della strumentalizzazione di tale corpo nella politica italiana.
Andando alle origini del rapporto tra genere e poteri in Italia, interrogandoci su-
gli sguardi desideranti e le funzioni del femminile e del maschile alle radici della
sua costruzione identitaria, si auspica di contribuire a una rifessione intellettuale
pi ampia sulla strumentalizzazione dei corpi e degli immaginari femminili nella
politica italiana. Rifessione che speriamo si approfondisca alla ricerca degli ele-
menti di una specifcit che ha portato a una rappresentazione del femminile e del
maschile nellItalia odierna che, come intellettuali e come donne, consideriamo
altra, un genere di nazione al quale non sentiamo di appartenere.
14 Desiderio, defnito come cathexis e hegemonic masculinities sono due interessanti ambiti di
studio delle mascolinit teorizzati da Connell cit.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 208 03/05/2013 11:11:16
1. Laltra nazione: cantanti (e) castrati italiani
nella Londra del diciottesimo secolo
Serena Guarracino
Nel suo ultimo lavoro, dal titolo emblematico Sacrifcium (2009), la mezzosoprano
Cecilia Bartoli reinterpreta leredit dei cantanti castrati non solo attraverso le arie
pi note anche al pubblico contemporaneo come Ombra mai fu dal Serse di George
Friedrich Handel (1734) o Son qual nave dallArtaserse (1738) di Riccardo Broschi,
ma proponendo anche molto materiale registrato per la prima volta in questa occasio-
ne
15
. Sulla copertina che campeggia nella sezione classica di HMV a Oxford Street,
a pochi isolati dalla casa di Handel a Londra Bartoli si ritrae come castrato, il corpo
un nudo marmoreo maschile privo di organi genitali su cui la testa della cantante
svetta come un gesto di conquista della voce castrata da parte dellinterprete donna.
Loperazione di Bartoli si inserisce in una tradizione gi consolidata, in cui il reperto-
rio dei castrati stato interpretato da cantanti donne a partire dalla met del dician-
novesimo secolo; tuttavia essa mette anche in scena una riappropriazione della musica
scritta per castrati dopo che i recenti successi di controtenori come David Daniels o
Derek Lee Ragin hanno reclamato questo repertorio alla performativit maschile
16
.
Il passaggio delle voci e dei repertori operistici tra corpi maschili e femminili
una caratteristica del genere lirico, e ci lo rende centrale per lo studio e la proble-
matizzazione dellattribuzione del genere sessuale in termini biologici e sociali. Le
eroine travestite della fne dellOttocento incarnano una sfda alla codifcazione del
15 Cecilia Bartoli, Sacrifcium, in collaborazione con Il Giardino Armonico (Decca 2009).
16 Ho gi elaborato una rifessione, per certi versi parallela a questa, sui controtenori e lidentit na-
zionale inglese: vedi Guarracino, S. Voicing the Archive. Sexual/National Politics in Early Music,
in AION Anglistica, n. 8.1-2, 2004, pp. 185-201.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 209 03/05/2013 11:11:16
210
Capitolo 4. Che genere di nazione?
binarismo maschile/femminile sia sul palco sia nella letteratura; questo saggio si sof-
ferma tuttavia su un diverso aspetto di questo fenomeno nel contesto della Londra
del primo Settecento
17
. Sia il Serse di Handel che lArtaserse di Broschi ebbero infatti
la loro prima nella capitale inglese, che vide rappresentate, spesso per la prima volta,
molte delle opere che ancora oggi fanno parte del repertorio barocco. Tuttavia la pe-
culiarit del contesto londinese ne ha segnato la marginalizzazione allinterno della
grande narrativa dellopera italiana; qui infatti le traiettorie dellopera, dellidentit
nazionale e della storia delle donne si incrociano in modalit discontinue rispetto
allinvestimento nellopera come genere nazionale che avviene sul territorio italiano.
Di conseguenza, il concetto stesso di italianit in relazione allopera prende strade
necessariamente diverse sul suolo londinese rispetto a quelle che condurranno alla
costituzione del discorso nazionale italiano sullopera lirica
18
.
Lopera, che domina i teatri europei, un genere di esportazione dagli stati
italiani a partire dal primo Settecento, e contribuisce a creare un immaginario
condiviso sullItalia pur essendo, allo stesso tempo, un fenomeno a cui contribu-
isce tutta lEuropa, a pioneer in globalization come scrive Craig Calhoun
19
. In
particolar modo lopera seria italiana, se non nei compositori (insieme a Scarlatti
e Porpora vanno ricordati Hasse, Mozart, e soprattutto Handel) nella lingua e
soprattutto negli interpreti: John Rosselli defnisce il cantante dopera, almeno
fno agli anni Ottanta dellOttocento, a distinct Italian profession
20
; e se dal
Romanticismo in poi, sulla scia di Wagner e del suo Gesamtkunstwerk, il composi-
tore stato investito di autorit ultima e fnale sulla propria opera, la storiografa
musicale recente ha invece rivalutato la rilevanza delle altre fgure coinvolte in quel
complesso spettacolo che lopera lirica, e in particolar modo quella dei cantanti,
veri e propri divi che spesso non si limitavano a dare corpo e voce ai propri per-
sonaggi in maniera strumentale, ma ne diventavano i creatori veri e propri: come
scrive Ella Rosand, an opera did not exist independent of its singers, [who] transpor-
ted the operatic product to the consumer
21
.
17 Vedi il capitolo Elogio della voce di mezzo. La mezzosoprano nelle scritture femminili nel mio
La primadonna allOpera. Scrittura e performance nel mondo anglofono, Trento, Tangram Edizioni
Scientifche, 2010, pp. 99-124.
18 Sullopera lirica e limmaginario nazionale italiano vedi in particolar modo Morelli, G. Lopera,
in Isnenghi, M. (a cura di) I luoghi della memoria. Simboli e miti dellItalia unita, Roma-Bari, Laterza,
1996, pp. 45-113.
19 Calhoun, C. Foreword, in Johnson, V. Opera and Society from Monteverdi to Bourdieu, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2007, p. xxv; vedi anche Bianconi, L. Il Teatro dOpera in Italia,
Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 14-16
20 Rosselli, J. Singers of Italian Opera. Te History of a Profession, Cambridge, Cambridge University
Press, 1992, p. 6.
21 Rosand, E. Opera in 17th Century Venice: Te Creation of a Genre, Berkeley, University of
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 210 03/05/2013 11:11:16
211
1. Laltra nazione: cantanti (e) castrati italiani nella Londra del diciottesimo secolo
Non ho usato il maschile, divi, in maniera casuale, perch la preminenza dei
performer nellopera seria non vede le donne assumere un ruolo di primo piano,
come invece accade in epoche pi tarde. Il divo dellopera barocca, com noto,
invece soprattutto il cantante castrato, una fgura dal fascino innegabile sia per i
contemporanei che per i giorni nostri. Tuttavia, in un panorama post-freudiano
in cui la castrazione vista in termini di femminile
22
viene spesso dimenticato
che i castrati, pur nascendo dal divieto per le donne di esibirsi in chiesa e nei teatri,
non fungevano da surrogato delle cantanti donne, con cui condividevano il palco
in tutti i contesti al di fuori dello Stato pontifcio
23
. Lopera barocca inglese, al
contrario, mostra non solo come castrati e donne non si escludessero reciproca-
mente, ma come entrambe queste tipologie di performer siano coinvolte nellarti-
colazione di un discorso nazionale inglese e, di rifesso, italiano.
Lopera italiana rappresenta una presenza constante a Londra almeno dal
1708, anno in cui il castrato napoletano Nicolino Grimaldi, detto Nicolini, fece
la sua prima apparizione nellopera Pirro e Demetrio di Alessandro Scarlatti al Dru-
ry Lane Teatre
24
. Lopera fgura qui tra i protagonisti di un momento fondante
della storia della cultura britannica, alle prese con le prime spedizioni coloniali e
la nascita di una stampa giornalistica nazionale: il giornalismo di Robert Steele e
Joseph Addison, in seguito entrato nel canone letterario anglofono, si confronta
con lopera lirica italiana, istituita come termine di paragone rispetto allidentit
nazionale inglese in formazione in quegli anni. La voce operistica rappresenta
qui ci che Homi Bhabha defnisce un sovrapporsi continuo di categorie nel
discorso nazionale: categorie come sessualit, classe, o una pi generale diferenza
culturale rimarcano come la nazione sia la misura della marginalit presente
nella modernit culturale
25
. Lidentit nazionale si rivela abitata dal fantasma del
proprio altro, perch pu costituirsi solo mediante la costituzione di unalterit
California Press, 1991, p. 221.
22 Luce Irigaray riscrive il processo di soggettivizzazione della bambina elaborato da Freud alla luce
del femminismo in questi termini: simpone quindi la prova della castrazione. [] Lumiliazione
dessere cos mal provvisto, di fare una fgura tanto misera, in confronto al pene, lunico sesso, suscita
inevitabilmente la voglia di avere qualcosa di simile, e sarebbe questa la molla del divenire una
donna normale, secondo Freud; Irigaray, L. Speculum. De lautre femme, Paris, Les ditions de Mi-
nuit, 1974, trad. it a cura di Muraro, L. Speculum. Laltra donna, Milano, Feltrinelli, 1989 (corsivo
nel testo).
23 Il veto per lesibizione delle donne era basato su un passo della Prima Lettera ai Corinzi di San
Paolo (14, 34), secondo cui mulier taceat in ecclesia, le donne devono tacere in chiesa; vedi Heriot,
A. Te Castrati in Opera, London, Calder and Boyars, 1956, p.9.
24 Burney, C. General History of Music, New York, Dover Press, 1957 [1776-89], p. 659.
25 Bhabha, H.K. Te Location of Culture, London, Routledge, 1994, trad. it. di Perri, A. I luoghi
della cultura, Roma, Meltemi, 2001, p. 197.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 211 03/05/2013 11:11:16
212
Capitolo 4. Che genere di nazione?
che si identifca, in questo caso, con il soggetto migrante del cantante dopera
italiano e castrato.
Questo altro, in un percorso che si innesta allinizio delle narrative nazionali
occidentali, naturalmente un altro femminile: nelle scritture del tempo lopera,
come scrive Tomas McGeary, il feminine other in contrasto al quale si scrive
il carattere maschile (e aggiungerei bianco) dellidentit nazionale inglese
26
. In
un commento sulla Beggars Opera di John Gay (1728), che rappresent uno dei
pi riusciti tentativi di risposta autoctona alla popolarit dellopera italiana, Jona-
than Swift scrive che la musica italiana inadatta al nostro clima settentrionale e
al genio del nostro popolo, cos che siamo soprafatti dallefeminatezza italiana,
e dalle sciocchezze italiane
27
. Lutilizzo ripetuto dellaggettivo Italian signi-
fcativo: lefeminatezza si associa infatti a una ben defnita identit, culturale se
non ancora strettamente nazionale, che appunto italiana e che indicata come
elemento oppositivo nei confronti del quale defnire the genius of the people.
piuttosto signifcativo, tuttavia, che questa efeminatezza non sia costrui-
ta su un corpo femminile, bens su quella rappresentazione anormativa del cor-
po sessuato che il corpo castrato. Si assiste qui a una dicotomia radicale tra la
rappresentazione discorsiva dellopera italiana come altro femminile e il ruolo
delle cantanti donne allinterno di questo stesso panorama. Un caso di particola-
re importanza per defnire questo paradigma riguarda quella che fu forse la pi
importante cantante inglese del tempo, Mrs. Katharine Tofts, la cui storia rappre-
senta la sconftta della tradizione inglese a opera dellinvasore, il castrato italiano
e androgino: nel 1708, si legge ad esempio in una lettera di Lady Wentworth alla
fglia, la cantante si rifut di cantare alla prima di Pirro e Demetrio perch the
Etallian Nicolini era in ritardo
28
. Questo episodio si inserisce in un immagina-
rio da guerra culturale che caratterizza i resoconti dei tentativi del teatro inglese
di opporsi allavanzata italiana. Un esempio rappresentato da Charles Burney,
primo musicologo contemporaneo, in cui lesotismo dellopera contrastato da
26 McGeary, T. Gendering Opera: Italian Opera as the Feminine Other in Britain, 1700-42, in
Journal of Musicological Research, n. 14, 1994, pp. 17-34.
27 Tis Comedy likewise exposeth with great Justice that unnatural Taste for Italian Musick among
us, which is wholly unsuitable to our Northern Climate, and the Genius of the People, whereby we
are over-run with Italian Efeminacy, and Italian Nonsense. Swift, J. A Vindication of Mr. Gay, and
the Beggars Opera, in Te Intelligencer, n. 3, 1729, p. 25 [traduzione mia].
28 Rupert Christiansen cita questo brano a testimonianza di ci che egli defnisce uno dei primi
episodi di divismo e di quella capricciosit che in seguito diventer caratteristica della fgura pubblica
della primadonna; vedi Christiansen, R. Prima Donna. A History, London, Pimlico, 1995, 13.
Un altro episodio, riguardante invece la rivalit tra Mrs. Tofts e la cantante italiana Margherita de
lEpine, raccontato da George Hogarth nel suo Memoirs of the Musical Drama, London, Richard
Bentley, 1838, pp. 243-244.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 212 03/05/2013 11:11:16
213
1. Laltra nazione: cantanti (e) castrati italiani nella Londra del diciottesimo secolo
una percezione ben defnita dellidentit nazionale, e della minaccia portata a essa
dallinsediamento di un genere straniero. Larrivo dellopera italiana una vera e
propria invasione del suolo britannico:
1708. Con unimprovvisa rivoluzione nella politica teatrale, Betterton e la sua
compagnia [] hanno completamente abbandonato il loro territorio di Hay-
market agli invasori stranieri []. [] Questo cantante [Nicolini] non arriv in
Inghilterra che a fne anno, e fu allora che la falange dellopera marci da Drury
Lane a Haymarket in gennaio, quando, il giorno quattordici dello stesso mese,
essi aprirono la loro prima campagna sotto il Generale Swiney
29
.
In questo panorama, Mrs. Tofts diventa lepitome della sconftta britannica.
Le cronache menzionano un non meglio defnito disagio mentale allorigine del
suo ritiro dalle scene a seguito di questo e altri episodi: ancora nel 1957, Dennis
Arundell ce la descrive in preda al delirio, imprigionata nel suo ruolo pi famo-
so, quello di Camilla regina dei Volsci. Lopera Camilla di Bononcini era stata
rappresentata per la prima volta il 30 marzo 1706 con libretto Englished, ossia
tradotto in inglese: ed nellinglese nazionale che Mrs. Tofts celebra nella follia la
propria passata gloria
30
.
Con il ritiro di Mrs. Tofts, la fgura della cantante inglese scompare dai palco-
scenici londinesi; non scompaiono per le cantanti donne, che mancano tuttavia
di visibilit, anche negli studi contemporanei, rispetto ai pi famosi cantanti ca-
strati. In questo contesto, che sembra anticipare in maniera involontaria proprio
il paradigma freudiano, la donna scompare sotto il peso della castrazione. Nella
Londra della prima met del Settecento, cos come nelle altri corti dEuropa che
intendessero fregiarsi di unautentica stagione di opera italiana, il corpo del can-
tante soprattutto quello del divo castrato; tuttavia, laddove mancasse un castrato
non si rifuggiva dallingaggio di cantanti donne. Fino alla prima met del 1720,
prima dellingaggio di Senesino, la Royal Academy of Music basava il proprio
prestigio sulla presenza del soprano Margherita Durastanti, a cui furono af date
tutte le parti da primo uomo della stagione e in particolar modo il ruolo da pro-
29 1708. By a sudden revolution in theatrical politics, Betterton and his company of comedians
[] abandoned their dominions in the Hay-market wholly to foreign invaders []. [T]his per-
former [Nicolini] did not come to England till the end of the year, and the opera phalanx marched
from Drury-Lane to the Hay-market in January, when on the 14
th
of that month, under General
Swiney, they opened their frst campaign. Burney, General History cit., p. 660 [traduzione mia].
30 Arundell, D. Te Critic at the Opera, London, Ernest Benn Limited, 1957, pp. 177-78; vedi
anche Christiansen, Prima Donna cit., p.18.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 213 03/05/2013 11:11:17
214
Capitolo 4. Che genere di nazione?
tagonista nel Radamisto di Handel (1720)
31
. Tale casting seguiva criteri secondo
cui la nazionalit e una certa formazione musicale avevano la priorit rispetto alle
convenzioni di genere: litalianit dellinterprete, maschile o femminile che fosse,
garantiva lautenticit dello spettacolo operistico come intrattenimento esotico
per le classi benestanti della Londra che in quegli anni diventava capitale coloniale
con lascesa della compagnia delle Indie Orientali e quella dei Mari del Sud, di cui
Handel era azionista
32
.
Nel novembre 1720 larrivo di Senesino e di altri cantanti permise alla Royal
Academy di mettere in scena uno spettacolo unico in tutta Londra, con un cast
composto esclusivamente da cantanti italiani
33
. Insieme a castrati come Senesino,
che rilev il ruolo di Radamisto da Durastanti, arrivarono anche Faustina Bordoni
e Francesca Cuzzoni: la rivalit tra i sostenitori di queste due dive occupa i giornali
dellepoca in maniera non molto dissimile da quella che caratterizzer, nel secolo
successivo, il binomio Pasta/Malibran o quello ancora pi recente Tebaldi/Callas.
Bordoni, meglio nota come Faustina, cre interpretandoli per la prima volta
i ruoli di Alceste in Admeto (1727), Emira in Siroe (1728) ed Elisa in Tolomeo
(1728). Cuzzoni cre invece il ruolo di Emilia in Flavio di Handel (1723) e Aste-
ria in Tamerlano (1724), nonch la Cleopatra del Giulio Cesare (1724), una delle
poche opere handeliane a essere rappresentate oggi
34
.
I personaggi che ho menzionato fnora sono tutti ruoli femminili, e non un
caso: con larrivo dei castrati i ruoli si stabilizzano, e mentre costoro impersonano
leroe, o primo uomo, le cantanti donne si appropriano sempre pi stabilmente del
ruolo di prima donna, o interprete femminile principale. Non si tratta di una pras-
si rigida: Durastanti, ad esempio, potr interpretare sia Gismonda in Ottone (al
fanco di Cuzzoni e Senesino), sia Sesto nel Giulio Cesare
35
. Lassegnazione delle
parti resta una questione di opportunit, ma anche di caratteristiche dei diversi
cantanti, che danno forma ai personaggi in concerto con il compositore: Larue
sottolinea come i protagonisti handeliani di questi anni, che condividono molte
caratteristiche, furono scritte per lo stesso interprete
36
. da notare per che men-
tre Durastanti, che aveva creato il ruolo eponimo nel Radamisto, veniva pi spesso
utilizzata in ruoli sia maschili che femminili, le due primedonne, arrivate a Londra
in un momento successivo, crearono esclusivamente ruoli femminili, relegando
31 Vedi Larue, S.C. Handel and His Singers. Te Creation of the Royal Academy Operas, 1720-1728,
Oxford, Clarendon Press, 1995, 81-82.
32 Vedi Harris, E. Handel the Investor, in Music & Letters, n. 83. 2004, pp. 521-575.
33 Larue, Handel cit., 144-180.
34 Ivi, p. 159 e 138.
35 Ivi, p. 83.
36 Ivi, p. 125.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 214 03/05/2013 11:11:17
215
1. Laltra nazione: cantanti (e) castrati italiani nella Londra del diciottesimo secolo
i castrati a ruoli maschili. In questo, tali cantanti (inclusa Mrs. Tofts) sembrano
anticipare la grande stagione delle dive dellopera che caratterizzer lOttocento
europeo e, colonizzando il repertorio femminile, aprono la strada alle grandi so-
prano romantiche. Con la scomparsa dei castrati e dellopera seria, saranno infatti
i personaggi femminili a prendere il sopravvento (emotivo se non numerico) nelle
narrative nazionali di cui lopera fa parte, personaggi che diventeranno, non pi a
Londra ma in unItalia ormai in formazione, la voce della patria.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 215 03/05/2013 11:11:17
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 216 03/05/2013 11:11:17
2. Leroina romantica tra passione e martirio.
Storia di una rivoluzione vocale
Simonetta Chiappini
Che disgrazia Pap mio, avere una fgliola disgraziata tribolata come sono io!
Pap mio tanto venerato e caro! Ti prego di mandarmi la tua benedizione tutte le
sere che mi conforti e mi aiuti a sofrire, addio! E a guarire!
37
.
15 marzo 1856: cos Matilde, scrive allamatissimo padre lontano, al gran-
de Alessandro Manzoni. Matilde sarebbe morta di tisi undici giorni dopo, senza
il conforto della sua presenza, invocata invano e tanto a lungo. Figlia trepida e
appassionata, Matilde ha i tratti delleroina dopera ottocentesca, pronta al sacrif-
cio, ad annullarsi, a sperare, pur con qualche fnale momento di ribellione, come
canta Violetta nella verdiana Traviata: Gran dio, morir si giovane! (III, VII).
La devozione al padre una costante delle protagoniste del melodramma otto-
centesco: Senza padre, maledetta (II, VIII) intona in Oberto conte di Bonifacio,
Leonora, una delle numerose eroine verdiane straziate dal rimorso e dal confitto
tra il mondo dei padri e il diritto alla felicit dei fgli. Felicit che balugina un
solo momento e fugge poi lontano, lasciando come unica via, come per Matilde,
il sacrifcio, il martirio, la morte. Meno di un secolo prima, quando questo diritto
alla felicit era stato sancito dalla Costituzione americana, i ruoli genitoriali non
erano cos univocamente delineati e limmaginario familiare appariva pi diver-
sifcato e fuido
38
. Ma cosa intervenuto tra Sette e Ottocento a ridisegnare cos
profondamente lorizzonte dei rapporti familiari e sociali? Perch una pesante cap-
pa di piombo, intessuta di lacrime e martri, avvolge il destino delleroina?
37 Manzoni, M. Journal, a cura di Garboli, C. Milano, Adelphi, 1992, p. 60.
38 Bizzocchi, R. Una nuova morale per la donna e la famiglia, in Storia dItalia, Il Risorgimento
(Annali), vol. XXII, a cura di Banti, A.M.; Ginsborg, P., Torino, Einaudi, 2007, pp. 69- 96.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 217 03/05/2013 11:11:17
218
Capitolo 4. Che genere di nazione?
Se il culto delle lacrime una specifcit dellestetica romantica, la sensibilit
femminile ne indubbiamente la depositaria privilegiata; tutta la sua vita, proprio
per le condizioni di segregazione e di minorit in cui si svolge, costituisce un
virtuoso laboratorio della soferenza, attraverso cui il senso della vita e della storia
si rivela, illuminandosi di luce segreta. Il personaggio femminile, ardente seguace
della rousseauiana legge del cuore, acquista unimportanza sempre pi centrale,
fno a diventare il perno afettivo e narrativo intorno al quale si svolge la vicenda
melodrammatica. Martiri predestinate alla sconftta esistenziale le donne tradu-
cono in splendido canto la loro capacit di sofrire. Ma possiamo andare oltre:
la moralizzazione del melodramma, auspicata da Mazzini nella sua Filosofa della
musica del 1836
39
, in vista della redenzione politica dellItalia, passa attraverso la
creazione di eroi salvifci, capaci di riscattare lonta del passato attraverso il sangue
del martirio. Ma il personaggio sicuramente pi adatto a interpretare questo ruolo
soteriologico, che pi di tutti sceglie limmolazione, non tanto il tenore virile,
ma egocentrico, quanto la vibrante eroina operistica, capace di totale ed esemplare
oblazione di s.
Ma come viene espressa e codifcata questa centralit femminile nello speci-
fco vocale e interpretativo del melodramma romantico? Per rispondere bisogna
partire pi da lontano, dal presupposto che luso della voce in senso artistico sia un
fenomeno storico e come tale in continua e complessa costruzione e trasformazio-
ne. Si dice spesso di un cantante: ha una voce naturale, ma di naturale il cantante
ha solo lapparato fonatorio, non il modo in cui lo usa. Inoltre la voce e la gola
sono organi sessuali secondari, la produzione vocale quindi ha indubbiamente a
che vedere con lidentit sessuale e con la sfera sessuale in genere
40
; il che si presta
a notevoli rifessioni per chi voglia afrontare il problema del rapporto tra voce e
struttura sociale in unottica antropologica
41
.
39 Mazzini, G. Filosofa della musica, note di lettura di Stefano Ragni, Pisa, Domus mazziniana,
1996.
40 Per una stimolante analisi etnomusicologica che collega lemissione vocale folklorica con i com-
portamenti legati ai temi dellonore, della gelosia e della sessualit si vedano: Lomax, A. Nuova ipo-
tesi sul canto folkloristico italiano, in Nuovi Argomenti, n. 17-18, novembre 1955-febbraio 1956,
pp.108-135; ripreso da: Leydi, R. La musica dei primitivi. Manuale di etnologia musicale, Milano,
Il Saggiatore, 1961. Per lerotismo legato alla voce operistica interessanti, ma talvolta unilaterali, i
pareri di Daolmi, D.; Senici, E. Lomosessualit un modo di cantare. Il contributo queer allin-
dagine sullopera in musica, in Saggiatore musicale, a VII, 2000, n. 1, pp. 137-178 e di Beghelli,
M. Erotismo canoro, in Saggiatore musicale, a VII, 2000, n. 1, pp. 122-136; Per unopposizione
tra maschile semantico e femminile vocalico e per il primato del canto sulla parola nel melodramma
si veda: Cavarero, A. Voci del melodramma in A pi voci. Filosofa dellespressione vocale, Milano,
Feltrinelli, 2003.
41 Per uno sguardo generale sulla fenomenologia della voce si veda: Bologna, C. Voce, in
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 218 03/05/2013 11:11:17
219
2. Leroina romantica tra passione e martirio. Storia di una rivoluzione vocale
Che cosa cambia nella voce e nel personaggio femminile, fnita lera dei castrati e
dei cicisbei, sulla scena del nuovo cristianesimo romantico? Sicuramente labolizione
del castrato durante la campagna napoleonica in Italia fu salutata da intellettuali quali
Parini, Pindemonte, Salf, Gioia e Foscolo stesso, come il segnale di un necessario rin-
novamento del melodramma, ormai ridotto a stanto genere di intrattenimento di un
mondo corrotto e privilegiato. Castrato da una parte, cicisbeo dallaltra sono stati per
tutto i Settecento oggetti di feroce critica da parte degli osservatori italiani e stranieri,
giudicati esempi entrambi di mollezza, di difusa mancanza di carattere e di impegno
civile
42
. Daltra parte la nuova concezione della famiglia e del matrimonio, basata sugli
afetti e sulla fedelt coniugale, garantita dalla specchiata moralit della donna, moglie
e madre esemplare
43
, costituiva la base necessaria dellauspicato rinnovamento sociale
e politico, il fondamento stesso del progetto nazionale ottocentesco.
Esiste un Ancien Rgime musicale e vocale, parallelamente a quello sociale e
politico, che entra in crisi e subisce un mutamento, progressivo e sostanziale, tra
la fne del Settecento e i primi decenni del secolo successivo, con un punto di
arrivo e sistemazione intorno agli anni trenta dellOttocento. Una vera e propria
rivoluzione che arriva a codifcare in modo nuovo e funzionale i ruoli vocali, la
tecnica di emissione, la struttura e il signifcato della performance operistica. Il
cambiamento investe ambiti diversi: innanzi tutto i ruoli delleroina sono da qui
in avanti interpretati esclusivamente da donne e non pi anche dai castrati. Non
un mutamento da poco, sintomatico di un atteggiamento realistico e moraliz-
zante tipico del teatro romantico, caratterizzato dalla defnizione naturalistica dei
ruoli sessuali. Con la scomparsa del castrato, macchina per cantare artifciosa e
mirabolante
44
, dalla sessualit (e voce) ambigua e perturbante, viene meno anche
Enciclopedia, vol. XIV, Torino, Einaudi, 1981, pp.1257-1292; inoltre: Barthes, R. La grana della
voce, in Lovvio e lottuso, Torino, Einaudi,1986; Cavarero, A. A pi voci. Filosofa dellespressione
vocale cit.; Chiappini, S. Peripezie vocali, in Folli, sonnambule, sartine. La voce femminile nel melo-
dramma italiano dellOttocento, Firenze, Le Lettere, 2006, pp. 167-210.
42 Sullidea di rinascita morale intesa come necessit di rivirilizzare il popolo italiano, il cui de-
grado rappresentato come una femminilizzazione caratterizzata dallinettitudine e dallozio si
veda Patriarca, S. Indolence and regeneration: tropesand tensions of Risorgimento patriotism, in
Te American Historical Review, 110 (2005), n. 2, pp. 380-408.
43 Il pensiero di J.J. Rousseau intorno alla donna e alla famiglia (V libro dellEmilio, Giulia o la
Novella Eloisa, Emilio e Sofa o i solitari,) produsse un impatto di lunga durata nella societ e nella
sensibilit del Settecento e, ancor pi, del secolo successivo. Per la posizione degli intellettuali italiani
come Muratori, Baretti, Chiari, Verri si veda: Guerci, L. La sposa obbediente. Donna e matrimonio
nella discussione dellItalia del Settecento, Torino, Tirrenia Stampatori, 1988.
44 Vedi la voce evirato curata da Fedele dAmico in Enciclopedia dello spettacolo, vol. IV, Roma,
Sadea, 1975, pp. 1719-1723; Martha Feldman, Denaturing the Castrato in Te Opera Quarterly,
XXIV (2008), n. 3-4, pp. 178-199; Per lerotismo della voce castrata: Barthes, R. S/Z. Una lettura
di Serrasine di Balzac, Torino, Einaudi, 1970.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 219 03/05/2013 11:11:17
220
Capitolo 4. Che genere di nazione?
labitudine idealizzata e aristocratica di attribuire a cantanti uomini o donne par-
ti indiferentemente maschili o femminili. Nellopera barocca il primo amoroso
poteva essere un musico castrato o donna en travesti, che cantavano in tessitura di
contralto o di soprano. La voce naturale maschile era considerata troppo rozza e
quindi inadeguata a esprimere i languori dellinnamorato, allinterno del gusto
androgino per la meraviglia vocale, per lallegoria e lastrattezza, atta a dipingere il
mondo mitico e divino degli dei e delle ninfe. Al tenore (in epoca barocca barite-
nore) venivano af date parti di antagonista, vecchio padre, confdente, caratterista.
Nella vocalit romantica, inoltre, a partire da Bellini, ma soprattutto da Donizetti
(anni Trenta-Quaranta), la spinta di tutte le voci verso lacuto diviene evidente: si
viene a creare la voce del tenore, cos come noi oggi la intendiamo, nella direzione
della moralizzazione della virilit canora: il tenore non pi solo lamoroso, ma
soprattutto un eroe vocale, maschilmente teso verso lo slancio imperioso della-
cuto. Lesplosivo barrito canoro che lo caratterizza il frutto di una svolta tecnica
e di un cambiamento del gusto. Al cantante viene ora richiesto di raggiungere gli
estremi della tessitura non pi schiarendo e femminilizzando la voce, ma man-
tenendo, attraverso la tecnica della copertura
45
, la caratteristica maschile della
voce stessa. Dal canto suo il soprano, dora in poi sempre donna, mira costante-
mente in alto, come a volere imitare la ballerina in tut sulle punte, per raggiun-
gere una sfera ideale in cui le passioni possono esprimersi al di l delledonismo
virtuosistico, raggiungendo i limiti estremi della dedizione sentimentale. Per tutte
le voci, insomma, non c pi posto per ambiguit sessuali o per il gusto degli ab-
bellimenti, che caratterizzavano il regno del castrato. Le forettature e i melismi
46
devono ridursi, grazie alla tensione verso lespressivit musicale, verso una scrittura
eroica e ricca di slanci sentimentali e morali. Si viene cos a creare la tipica coppia
romantica del passo a due: soprano lei, tenore lui, giovani, innocenti, innamorati,
minacciati dal destino e dai perfdi antagonisti, baritono e mezzo-soprano.
Ma qual il destino del contralto, timbro scuro, corposo e intenso, che aveva
costituito (sia per le cantanti donne che per i castrati) il fulcro dellespressivit pre-
romantica, fno a Rossini? Alla scomparsa del castrato Rossini oppose la lussureg-
giante vocalit del contralto donna, medio e profondo, impegnato sia nelle parti
di civetta e amorosa (Rosina del Barbiere di Siviglia siamo nel 1816) oppure nelle
creazioni en travesti di giovinetti dal fascino virilmente efebico come Arsace nella
Semiramide, in cui la doratura vellutata del timbro, le ombrosit del registro di petto,
lo splendore degli acuti e la precisione degli abbellimenti richiamano sicuramente la
45 Il meccanismo detto della copertura ottenuto con labbassamento della laringe che, limitando
il naturale assottigliarsi delle corde vocali nellottava superiore, rende possibile l emissione degli acuti
di forza a piena voce.
46 Abbellimenti virtuosistici in cui il cantante vocalizza emettendo pi note sulla stessa vocale.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 220 03/05/2013 11:11:17
221
2. Leroina romantica tra passione e martirio. Storia di una rivoluzione vocale
maestria e lermafroditismo vocale dei contraltisti castrati. Finita, intorno agli anni
Trenta, la stagione del contralto rossiniano, assistiamo a una profonda mutazione:
let del romanticismo, caratterizzata dalla predilezione delle zone acute della voce,
simbolicamente cariche dei valori innovativi della tensione giovanile allideale, se-
gna, se non la fne, sicuramente la drastica riduzione nellutilizzazione di questa voce
preziosa. La messa in ombra del contralto avviene seguendo due direttrici diverse
ma complementari: da una parte, con la generale tendenza allinnalzamento delle
tessiture vengono valorizzate le voci medie rispetto alle gravi (quindi il baritono, al
posto del basso e il mezzo-soprano al posto del contralto), dallaltra a queste voci me-
die vengono ora attribuiti non pi i ruoli da protagonista, ma quelli di antagonista,
di solito caratterizzati negativamente rispetto ai valori etico-sacrifcali incarnati dal
tenore e dal soprano, intorno a cui ruota tutta la costruzione drammatica dellopera
ottocentesca, che sottende e giustifca ladesione al discorso nazionale.
Infatti, se in altri momenti della storia del gusto musicale (come nelle opere
mozartiane o nel bel canto rossiniano) la pienezza giovanile era accompagnata alle
voci testosteronicamente vigorose e vellutate; in altri, come nel romanticismo, la
giovinezza assimilata alla purezza, lingenuit e lo slancio. Si costruirono quindi
i presupposti per la valorizzazione della vocalit tesa e luminosa del tenore e del
soprano e per lidentifcazione delle voci gravi maschili, come il basso, con la vec-
chiaia, il potere o la gravit sacerdotale. La voce media del baritono cominci a
impersonare luomo maturo, il rivale, laltro, il cattivo, o il padre.
In questo contesto, che arriv a maturazione con Verdi e Wagner, la vecchia
concezione del contralto venne a decadere, per giungere a esprimere, attraver-
so la voce del mezzo-soprano, il principio antagonistico della rivale, dellaltra
per eccellenza, dellamore profano in antitesi a quello sacro: della donna cattiva,
sensuale, egoista, come a signifcare che la sfera bassa della voce corrisponde,
appunto, alle zone basse della femminilit. la voce della donna socialmente
marginale o riprovevole: zingara, prostituta, maga, adultera. Il canto di Carmen, la
protagonista dellopera omonima di Bizet, in cui rimangono solo alcuni echi delle
profondit contraltili, quello della donna pericolosamente libera, foriera di sven-
ture. un personaggio raro, un unicum nella storia del melodramma ottocentesco,
il cui destino dionisiaco comunque segnato dalla morte tragica.
Pare dimostrato che i suoni bassi siano quelli maggiormente percepiti e graditi
dal feto e della piacevolezza fsica del timbro profondo di bassi e contralti nessuno
pu dubitare
47
. La qualit della voce potente e scura del contralto sembra origi-
nalmente legata allespressione atavica della vitalit, ma proprio per questo appare
sostanzialmente ambivalente: piacevole e afascinante, ma anche scandalosa, proprio
47 Per avvicinare le cognizioni di tecnica vocale si vedano: Fussi, F.; Magnani, S. Larte vocale, Torino,
Omega, 1994 e il classico Vennard, W. Singing: Te Mechanism and the Technic, New York, Fisher,1967.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 221 03/05/2013 11:11:17
222
Capitolo 4. Che genere di nazione?
perch intimamente corporea e quindi legata alla sessualit e alle componenti ar-
caiche delle religioni terrestri. Il timbro del contralto scuro, il range vocale cir-
coscritto alle ottave della tessitura bassa e centrale, vicino quindi a quello delle voci
maschili, in genere dal sol o fa
2
basso in alcuni casi anche mi e mi b
2
come Rossini
scrisse in Ricciardo e Zoraide per Rosmunda Pisaroni , fno a unaltezza variabile,
secondo lo sviluppo vocale e tecnico del periodo: sol
4
in genere (ma anche fno a si
4
o
do). Dopo gli anni Trenta, nellOttocento il vero contralto profondo scompare, tran-
ne che per interpretare, con paradossale logica di negazione, il ruolo asettico della
vecchia. Lesorcizzazione del contralto ci pare in un rapporto non casuale con il ten-
tativo, che percorre tutta la cultura dellOttocento, prima e soprattutto dopo lUnit
italiana, di costruire un discorso nazionale basato sullistituzione di un canone ideale
di donna italica feconda e pura, madre martire di martiri, fondamento della virt
e purezza della Patria. Esemplare a questo proposito la posizione dellinsegnante e
teorico di canto Enrico Panofka, che in Voci e cantanti del 1871 scrive:
un errore comune che il vero contralto sia una voce mascolina. No: questa
voce, notevole pel suo timbro dolce, tenero, qualche volta anche melanconico,
si presta alle parti che rappresentano la donna matura, buona e sensibile; ma che
nello stesso tempo dotata di tal forza di carattere e di tale energia, che le fanno
sopportare con rassegnazione i pi vivi dolori morali, e la rendono suscettibile
anche di esaltazione politica fno a farsi martire del proprio eroismo. Ma tale
eroismo non quello guerriero, bens quello della matrona romana e di molte
donne italiane che, in questi tempi moderni, hanno saputo sfdare il carcere. Che
videro morire i loro fgli per la santa causa della patria senza mormorare contro
la Provvidenza. Esse erano eroine, s ma altrettanto nobili spose e madri adorate;
infne donne nel senso pi sublime della parola
48
.
Sembra scomparire cos la possibilit di sfuggire a una codifcazione che non
ammette deroghe e che circoscrive, pena lanatema sociale, la donna e la sua voce
nella funzione di rassicurante vestale della famiglia. Nel Novecento, ma non in Ita-
lia, il timbro brunito del contralto ritorner ad arricchire, come nel mahaleriano
canto della terra
49
la tavolozza musicale e a esprimere, le forze telluriche di un
femminile non domato.
48 Panofka, E. Voci e cantanti (Firenze 1871), Bologna, Forni 1984, p. 121
49 Das Lied von der Erde una composizione di Gustav Mahler per voci soliste (tenore e contralto,
o baritono) e orchestra composta fra il 1908 e il 1909. Oltre a Mahler nel Novecento utilizzarono la
voce del contralto anche Richard Strauss, Britten, Stravinskij e gli autori di scuola russa come Glinka,
Rimskij- Korsakov, Musorgskij.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 222 03/05/2013 11:11:17
3.Per la generazione che verr.
Limpegno politico femminile nel 1848
negli Stati italiani e tedeschi.
Giulia Frontoni
Fin dalla teoria ottocentesca sulle generazioni di Wilhelm Dilthey, divenne sem-
pre pi frequente per i contemporanei mettere la propria biografa in relazione
con i grandi sconvolgimenti e cambiamenti socio-politici vissuti e i giovani ri-
voluzionari del 1848 sono spesso i primi a essere presi ad esempio
50
. Tuttavia,
sia la formulazione di Dilthey che quelle dei teorici successivi, come Mannheim,
riservano il termine generazione al mondo maschile, mettendo in primo piano sia
determinate modalit di espressione e partecipazione che la conseguente risonanza
dellintervento maschile
51
. innegabile che il concetto di giovent dallOttocen-
to a oggi abbia subito delle modifcazioni, cos come va tenuta presente anche la
diversa accezione del termine per il mondo maschile e quello femminile e le sue
implicazioni. Larticolazione della propria biografa in chiave generazionale, per,
non un fenomeno puramente maschile
52
. Come pi di recente stato notato da
50 Dilthey, W. Introduzione alle scienze dello spirito: ricerca di una fondazione per lo studio della societ
e della storia, tr.it. di De Toni, G.A., Firenze, La nuova Italia, 1974. Per il caso italiano cfr. Balzani, R.
I giovani del Quarantotto. Proflo di una generazione, in Contemporanea, n. 3, 2000, pp. 403-416.
51 Mannheim, K. Le generazioni, Bologna, Il Mulino, 2008. Per unanalisi del concetto di mascoli-
nit in Mannheim cfr. Benninghaus, C. Das Geschlecht der Generationen. Zum Zusammenhang
von Generationalitt und Mnnlichkeit um 1830, in Jureit, U.; Widt, M. (a cura di) Generationen.
Zur Relevanz eines wissenschaftlichen Grundbegrifs, Amburgo, Hamburger Ed., 2005, pp. 127-158.
52 Per unanalisi generazionale delle dinamiche di mutamento sociale del mondo femminile Cfr.
Porciani, I. Women and the writing of national history. Italy, 1860-1914, in Isaacs, A.K. (a cura di)
Political Systems and Defnitions of Gender Roles, Pisa, Edizioni Plus, 2001, pp.107-116; Mori, M.T.
Le poetesse del Risorgimento tra formazione letterararia e controllo morale, in Passato e Presente,
n. 75, 2008, S. 33- 56.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 223 03/05/2013 11:11:17
224
Capitolo 4. Che genere di nazione?
Beate Fitze, gli attori generazionali lottano attraverso i mezzi di comunicazione
nella sfera pubblica per il riconoscimento e lafermazione dei nuovi orientamenti
culturali, che non sono mai del tutto costruiti ex novo, ma vengono elaborati
combinando elementi culturali tradizionali e interpretazioni attuali
53
. Il 1848 con
la maggiore apertura degli spazi pubblici permise lemergere di un discorso fem-
minile di stampo generazionale. Le donne, che parteciparono ai dibattiti in corso,
erano spesso gi sposate da diversi anni, non pi in giovane et (vale a dire al di
sopra dei trenta anni), con gi almeno un fglio, di solito maschio. Dai loro scritti
emerge una particolare lettura degli eventi e una volont di farsi promotrici di
proprie iniziative, come si legge nel Proemio del giornale veneziano Il circolo delle
Donne italiane:
Noi vogliamo prendere parte agli interessi della patria. Noi obbligammo gli sposi
e i fgli a fuggire i teatri; ad operare da eroi pella nostra redenzione; raccogliemmo
le oferte pella patria, vestimmo i militi fratelli, assistemmo gli spedali ora vo-
gliamo fare di pi: vogliamo educare noi e i nostri fglioli. Nessuno potr negare
che il pregiudizio di non istruire le femmine non sia ricaduto sopra agli uomini.
Lamore di patria, lideale di fratellanza che dora in avanti ogni fanciullo berr
col latte e confonder con il bacio materno preparer allItalia una generazione di
eroi, che sar la sua salvezza e il terrore dello straniero
54
.
Il giornale pubblicato a Venezia dalla fne di settembre alla met di ottobre
del 1848 ed redatto da Adele Cortesi e dal Circolo delle Donne Italiane, un
gruppo di donne che si riuniva in modo informale nelle case delle socie durante
le conversazioni serali
55
. Per legittimare il loro operato in un ambito cos cruciale
come il giornalismo la caporedattrice Adele Cortesi non esita a mettere laccento
sulla complementariet femminile al mondo maschile e sul ruolo della donna
nellambito famigliare. La Cortesi riprende cos la funzione tradizionalmente
attribuita alle donne, quella di provvedere alla famiglia, mettendola in relazio-
ne con il proprio vissuto quotidiano di madre, anche se molto probabilmente
un vissuto immaginario. Nel testo si fa, infatti, riferimento a una determinata
fgura di madre: colei che allatta i suoi fgli al seno, che li educa alla solidariet,
allamore di patria e al sacrifcio per essa, inserendosi in un discorso che aveva
53 Fitze, B. Historische Generationen. ber einen sozialen Mechanismus kulturellen Wandels und
kollektiver Kreativitt, Bielefeld, transcript, 2009, pp. 104 sgg.
54 Cortesi, A. Proemio, in Il circolo delle Donne italiane, Venezia, 26 Settembre 1848..
55 Sulla partecipazione femminile al 1848 veneziano cfr. Filippini, N.M. Donne sulla scena po-
litica: dalle Municipalit del 1797 al Risorgimento, in Ead. (a cura di) Donne sulla scena pubblica,
Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 81-137.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 224 03/05/2013 11:11:17
225
3.Per la generazione che verr. Limpegno politico femminile nel 1848 negli Stati italiani e tedeschi
preso piede gi nei decenni precedenti
56
ed esplicitando cos le responsabilit
politiche af date alle donne
57
. Esaltando lesperienza quotidiana femminile del
legame parentale, il giornale Il Circolo delle Donne italiane sostiene la necessit
di coinvolgere le donne, si incarica di metterle al corrente degli avvenimenti
politici e richiede spazi in cui confrontarsi per dare il proprio contributo al
cambiamento in atto
58
.
Vi era, per, chi non mancava di ironizzare su questa percezione dello spazio
dazione femminile. Gi alla fne del Settembre del 1848 Cassandrino, giornale
umoristico di stampo clericale
59
, cos commentava luscita a Roma di un nuovo
giornale: Solo il Giornalismo non aveva avuto donna femmina; or tu, o DONNA
BIZZARRA, hai tolta questunica eccezione, Dio ce la mandi buona. Le Donne
hanno un punto pi del Diavolo; fgurati le donne giornaliste ne avranno un cen-
tinaio, pi di tutto lInferno
60
.
.
Parte integrante di quel giornalismo minore di breve vita
61
, La Donna Biz-
zarra era un settimanale che venne pubblicato dalla fne di settembre alla prima
met di ottobre del 1848 a Roma. Ai suoi esordi il giornale viene presentato come
lennesimo capriccio di una donna, la quale sa di suscitare risate perch ha deciso
di scrivere un giornale
62
. Nonostante il titolo del giornale, la compilatrice Virgina
Gazzini non ha intenzione di interessarsi alla politica, perch di politica non ne
mangio e non voglio fare come i tanti giornaletti foccati come la neve
63
. Al con-
trario di quanto annunciato, per, la Gazzini si occupa di politica: taccia Gioberti
di volubilit, commenta le iniziative femminili nelle altre citt italiane in favore di
Venezia e sprona le donne romane a fare altrettanto.
56 Sulla funzione materna nelleducazione e formazione morale dei fgli cfr. DAmelia, M. Figli,
in Melograni, P. (a cura di) La famiglia italiana dallOttocento ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 1988,
pp. 465-523.
57 De Donato, G. Donna e societ nella cultura moderata del primo Ottocento, in De Donato,
G. (a cura di) La parabola della donna nella letteratura italiana dellOttocento, Bari, Adriatica Editrice,
1983, pp.11-86; Soldani, S. Il Risorgimento delle donne, in Banti, A.M.; Ginsborg, P. Il Risorgi-
mento, Storia dItalia, vol. 22, Torino, Einaudi, 2007, pp. 183-224.
58 Cfr. Filippini, Donne sulla scena politica cit., p. 121.
59 Cfr. Della Peruta, F. Il giornalismo dal 1847 allUnit, in Galante Garrone, A.; Della Peruta, F.
La stampa italiana del Risorgimento, in Castronovo, V.; Tranfaglia, N. (a cura di) Storia della stampa
in Italia, vol. 2, Roma-Bari, Laterza, 1979, pp. 249- 465.
60 VEH Che prurito!!!, in Cassandrino, n. 35, Roma, 21 settembre 1848.
61 Dappio, C. I periodici femminili dellOttocento in due biblioteche romane, in Memoria, n. 5,
novembre 1982, pp. 118-122, Cfr. Della Peruta, F. Il giornalismo cit.,
62 Due parole alle signore donne, in La Donna Bizzarra. Giornale politico-critico, n. 1, Roma, 18
settembre 1848.
63 Ibidem.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 225 03/05/2013 11:11:17
226
Capitolo 4. Che genere di nazione?
Il giornale pensato direttamente per le donne perch fra donne ci intendiamo
temo, mentre sarebbe invece troppo pretendere che gli uomini occupati in cose di
pi importanza prestassero orecchio alle nostre frivolezze
64
. Il Cassandrino, invece,
si era accorto di questa nuova presenza nel giornalismo romano e La Donna Bizzarra
tesse con lui fn dal suo secondo numero un vivace battibecco settimanale, rispon-
dendo a tono alle sue critiche: Se, come voi dite, non v male che una donna non
centri, potrei provarvi che anche nel bene molte donne vi hanno fatto parte, forse al
presente ve lhanno. Chi sa forse che le donne, colla loro fnezza non arrivino a sco-
prire cose agli uomini stessi nascoste, e cos esser loro di non poco giovamento?
65
Dopo questarticolo di risposta il Cassandrino ritorna sui suoi passi e inscena
il suo innamoramento ne La Donna Bizzara, che dalle sue pagine si schernisce e
difende il suo onore. Cassandrino inizia a sostenere il giornale femminile, difen-
dendone lonore, afermando che la causa nazionale possa giovarsi proprio della
forza muliebre
66
e arrivando a paragonare La Donna Bizzarra a una novella Geor-
ge Sand
67
, fnch La Donna Bizzarra non cessa improvvisamente le pubblicazioni
nellottobre 1848. Nel mese di novembre Cassandrino confessa che: al quarto d
di sua vita la Donna Bizzarra morta; allora si preser le indagini per la fraterna
necrologia, e che tu sia scorticato! Era un uomo che si avea preso il nome di
Donna. [] Il povero Giornalismo non sa pi oggi chi sia uomo e chi sia donna.
Cassandrino racconta, quindi, un capovolgimento dei ruoli: non una donna
con abiti maschili per partecipare alla rivoluzione, ma un uomo si mascherato
da donna per dar voce alle critiche sulle opinioni e pratiche politiche maschili,
non mancando di ironizzare sulla crescente partecipazione emotiva delle donne
alla rivoluzione.
Parlare dei fgli si rivela nel 1848-49 come un argomento capace di suscitare un
ampio interesse nellopinione pubblica anche femminile. Il riferimento a essa permet-
te alle donne di avanzare una propria interpretazione delle tensioni attuali e unidea di
cambiamento futuro, potendo contare sulla comprensione anche maschile.
Cosi nel 1849 la marchesa Costanza Arconati Visconti scrive da Bruxelles a
Giuseppe Massari: sono persuasa che conviene educare Gian Martino in Italia.
[] Se fossi certa che fra ventanni lItalia sar nelle condizioni presenti non vorrei
che mio fglio fosse italiano e lo educherei in Francia, ma giova pensare a un altro
avvenire e prepararlo per quello
68
.
64 Ibidem.
65 A Cassandrino, in La Donna Bizzarra, n. 2, Roma, 23 settembre 1848.
66 Le donne e le parrucche, in Cassandrino, n. 42, Roma, 7 ottobre 1848.
67 Ibidem.
68 Costanza Arconati Visconti a Giuseppe Massari, Bruxelles 4 Agosto (1849), Archivio del Risor-
gimento di Roma, Fondo Arconati, 383/5.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 226 03/05/2013 11:11:17
227
3.Per la generazione che verr. Limpegno politico femminile nel 1848 negli Stati italiani e tedeschi
importante tenere in considerazione che qui la marchesa Arconati Visconti
sta parlando del suo unico fglio, maschio. Essere madre di un maschio porta con
s un rispetto e anche una responsabilit sociale che va tenuta in considerazione.
Non a caso la tedesca Malwida von Meysenbug scrive, con una certa profusione,
in una delle sue prime lettere a Johanna Kinkel sulle responsabilit di una madre
proprio facendo riferimento alleducazione del fglio maggiore della Kinkel.
Cara signora, insegnate ai vostri fgli ad odiare, che un sinonimo di amare: unu-
nica cosa odiare per sempre e mortalmente il principio dellassolutismo ed amare
ardentemente la libert. Gli si potrebbe raccontare anche dei principi che hanno di-
ritto al ricordo e allimmortalit data dalla storia, nel caso abbiano servito alla causa
civile, riconoscendo le necessit del loro tempo[]: lui imparer a essere giusto.
Ma voi sapete, cosa da insegnargli, [] perch Voi siete sposa e madre giusta
69
.
Nellottobre del 1849 Malwida von Meysenbug inizi a scrivere lettere di
sostegno a Johanna Kinkel, in seguito allincarcerazione del marito di questul-
tima Gottfried Kinkel, rivoluzionario democratico. Il legame di Malwida von
Meysenbug
70
con Johanna Kinkel divenne rapidamente molto stretto. Allepoca
della lettera citata Malwida von Meysenbug era una non pi giovane donna di
33 anni, non sposata non bella, il cui aspetto giovanile stato segnato dagli
ultimi dolori morali e fsici
71
. Proprio a causa delle sue convinzioni politiche
von Meysenbug era in rotta con la sua famiglia aristocratica, che in seguito lasci
per spostarsi ad Amburgo, ove comp la sua formazione come educatrice, e poi a
Londra per seguire i Kinkel. In Inghilterra entr in contatto con gli esuli tedeschi,
russi, ma anche italiani, tanto da diventare amica di Giuseppe Mazzini.
La vita di Johanna Kinkel rappresentava per Malwida von Meysenbug un
esempio: sposata al democratico Gottfried, ne condivideva gli ideali e si era im-
pegnata a sostenerne le iniziative portandole avanti in sua assenza, a vivere in ri-
strettezze economiche e a provvedere anche economicamente ai quattro fgli. Agli
occhi della nubile scrittrice lunione dei Kinkel appariva come la realizzazione del
suo incompiuto desiderio di matrimonio con il giovane democratico Teodor Al-
thaus. Soltanto nella coppia, infatti, avrebbe potuto compiersi il destino politico e
sociale del singolo, come von Meysenbug scrive nel 1849:
69 Malwida von Meysenbug a Johanna Kinkel, Detmold, 19 Dicembre 1849, in Rossi, S. (a cura di)
Briefe an Johanna und Gottfried Kinkel 1849-1885, Bonn, Rhrscheid, 1982, p. 24.
70 Sulla vita di Malwida von Meysenbug cfr. von Meysenbug, M. Ricordi di una idealista, Roma,
Edizione della nuova parola, 1905.
71 Malwida von Meysenbug a Johanna Kinkel, Detmold, 19 Dicembre 1849, in Stefania Rossi,
op.cit., p. 29.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 227 03/05/2013 11:11:17
228
Capitolo 4. Che genere di nazione?
Quando io penso a lei, penso che ora fnalmente conosco una coppia, che unita
nel senso del nuovo tempo, che si ama totalmente e tuttavia conosce un terzo al
di sopra del proprio amore; lumanit, la patria a cui si sacrifcano(..) per questo
voi dovreste essere i suoi martiri e per quanto possa essere triste altrettanto bello.
Sebbene io conosca uomini che anelino a tale destino, non hanno per la donna
giusta e le giuste donne non sono unite agli uomini eroi
72
.
Cos come viene formulato da von Meysenbug, alla donna spetta il compito
di sostegno del marito e ha il dovere di tramandare ai fgli i nuovi ideali politi-
ci democratici per cui afermazione il consorte ha combattuto contro il vecchio
mondo. Le donne diventano le educatrici della prossima generazione, quella dei
futuri cittadini
73
. Questo compito viene percepito e visto come proprio della gene-
razione di Malwida von Meysenbug e di Johanna Kinkel, ma si pu dire che trova
una sua articolazione anche nelle enunciazioni delle donne italiane che partecipa-
no alle mobilitazioni in nome della generazione che verr.
72 Ibidem, p. 25
73 Soldani, S. Prima della Repubblica. Le italiane e lavventura della cittadinanza, in Filippini,
N.M.; Scattigno, A. (a cura di) Una democrazia incompiuta. Donna e politica in Italia dallOttocento
ai nostri giorni, Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 41-90.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 228 03/05/2013 11:11:17
4. Donne in armi e Risorgimento
74
Benedetta Gennaro
Nella Toscana del diciannovesimo secolo circolava una stampa popolare intitolata
Il mondo alla rovescia, nella quale dodici diverse immagini ritraevano con ironia
altrettanti improbabili scenari: un asino cavalca il proprio padrone, una coppia
di ovini sotto un albero osserva due uomini che pascolano nelle vicinanze, due
scolari infiggono una punizione corporale al proprio istitutore e una donna che
impugna un fucile mentre suo marito le siede accanto
75
.
In questultima immagine, lo scorcio di vita domestica alla rovescia, nel suo
disordine
76
, mette in discussione la posizione normativa che i due sessi avevano
nella confgurazione gerarchica della societ ottocentesca.
Luomo, seduto sulluscio di casa, tiene in mano un fuso e porta in grembo un
neonato; indossa una gonna rosa e una camicia azzurra. La donna gli accanto,
in piedi, vestita da soldato, sfoggia un cappello piumato e impugna una baionetta
con la mano sinistra. La didascalia che accompagna il disegno recita:O quanti in
rimirar quel ch qui fatto/A se stessi diran: il mio ritratto.
La forzatura implicata nellinversione rivela, attraverso lironia, il carattere pro-
fondamente innaturale della scena: cos come un asino non pu cavalcare il proprio
padrone, cos anche una moglie non pu combattere mentre il marito si prende
74 Vorrei ringraziare Rafaella Bianchi, Mauro Resmini e Sara Tarissi de Jacobis per i loro consigli.
75 Cocchiara, G. Il mondo alla rovescia, Torino, Bollati Boringhieri, 1981.
76 Uso il termine disordine nel senso suggerito da Carole Pateman, a indicare, cio lelemento desta-
bilizzante insito in quei comportamenti femminili non-conformi che, portati allestremo, possono
contribuire alla distruzione dello Stato. Cfr. Pateman, C. Te Disorder of Women: Democracy, Femi-
nism, and Political Teory, Stanford, Stanford University Press, 1989.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 229 03/05/2013 11:11:17
230
Capitolo 4. Che genere di nazione?
cura della casa e della prole. Sebbene Il mondo alla rovescia ridicolizzi scenari distorti
e innaturali, la stampa popolare suggeriva tuttavia la possibilit di uninversione di
ruoli e ammoniva sulle conseguenze di tale scelta sugli equilibri sociali.
La reazione suscitata alla vista della donna in armi sottolinea la separazione esi-
stente tra una nozione astratta di identit di genere basata sulla dicotomia uomo/
donna, soldato/madre, pubblico/privato e la complessa realt fatta di scelte con-
traddittorie che potevano portare alla delegittimazione di tali opposizioni binarie.
Limmagine della donna in armi trovava particolare opposizione perch con-
traddiceva la struttura sociale basata sulla dicotomia soldato-madre, secondo la
quale luomo-soldato combatteva per proteggere donne e bambini, mentre il ruo-
lo della donna-madre era quello di proteggere la propria famiglia e la propria casa
per assicurare la discendenza e larmonia domestica.
La presenza delle donne in battaglia veniva letta come innaturale, inaccetta-
bile e inopportuna.
In momenti di crisi come quelli rappresentati dagli anni centrali dellOt-
tocento, invece, la necessit di mobilitare tutta la popolazione attiva nella lotta
per lindipendenza e lunifcazione ha permesso linclusione delle donne in armi
nellimmaginario e nella pratica guerresca inclusione dettata appunto dallemer-
genza. Una delle conseguenze di questo atteggiamento inclusivo stata lindulgen-
za con la quale alcune azioni e alcune scelte vennero lette e tramandate, sebbene
contraddicessero la morale comune. Una lettura anche superfciale dei cosiddetti
Plutarchi femminili (cataloghi biografci, spesso redatti da donne, per onorare le
gesta delle eroine del passato) mostra lo sforzo compiuto nella costruzione di una
genealogia di gesta femminili che contribuisse alla formazione di una comunit
culturale nazionale.
Non tutte le donne che combatterono per lindipendenza nazionale trovarono
lo stesso spazio allinterno di queste storie: in altre parole possibile osservare un
cambiamento nel giudizio riservato alle donne in armi a seconda della posizione
da loro presa in battaglia. La donna che combatte per proteggere la casa e la fami-
glia ma che poi, a emergenza conclusa, sceglie di tornare tra le mura domestiche,
viene accolta dalla pubblicistica storica in maniera molto diversa rispetto alla don-
na che sceglie una posizione di attacco, confondendosi nella mischia del campo
di battaglia, senza mai rinunciare a un ruolo attivo e anzi facendone un tratto
essenziale della propria identit
77
.
77 Basti pensare alla reazione negativa e allostracismo esercitato nei confronti di donne quali la prin-
cipessa Belgiojoso o la contessa Della Torre. Per quanto riguarda Maria Martini Della Torre molto
deve ancora essere scritto: la partecipazione della piemontese alle vicende garibaldine dallimpresa dei
Mille a Mentana, il suo cosmopolitismo e acume politico non sono ancora state oggetto di studio
della storiografa contemporanea.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 230 03/05/2013 11:11:17
231
4. Donne in armi e Risorgimento
La partecipazione femminile al Risorgimento stata essenziale per il successo
del movimento di indipendenza e unifcazione italiana e la storiografa recente,
grazie anche al positivo infusso degli studi di genere e dei cultural study, ha co-
minciato a ofrire numerose ricostruzioni e importanti considerazioni sul ruolo, le
motivazioni e le diverse esperienze avute dalle donne della penisola.
Non pi possibile narrare oggi la storia del Risorgimento senza considerare
il contributo dato dalle donne ne possibile parlare della storia delle donne italia-
ne senza far riferimento al processo di unifcazione.
Nonostante questa ritrovata visibilit, ancora pochi sono gli studi specifci che
indagano la partecipazione delle donne in armi al Risorgimento, ovvero di quelle
donne che decisero di imbracciare un fucile e prendere parte attiva ai combatti-
menti per lindipendenza.
La rappresentazione delle donne in armi e il modo in cui le loro gesta vengo-
no ricevute, talvolta come modelli se non da imitare quanto meno da celebrare,
talaltra come aberrazioni dellordine delle cose, rispecchia il complicato rapporto
delle donne con la sfera pubblica.
Citando Paola di Cori, il rapporto che le donne intrattengono con la sfera
pubblica [] sembra quasi suggerire che la loro visibilit e laccesso alla vita po-
litica in alcuni momenti particolari siano associati alluso di spade, di mitra e di
pistole
78
.
precisamente su questi momenti particolari che si sofermer la mia
indagine.
Durante tutto lOttocento, le donne piemontesi, lombarde, venete, toscane,
romane, napoletane e siciliane si impegnarono attivamente per il raggiungimento
dellunifcazione sia a livello materiale che intellettuale. Di loro rimangono spesso
tracce, nelle memorie autobiografche di patrioti, nelle corrispondenze private, in
qualche ritaglio di giornale, in poesie scritte alla memoria (come nel caso della ga-
ribaldina Tonina Marinelli, immortalata dai versi di Francesco DallOngaro) o in
immagini depoca, come quella che ritrae la celebre combattente milanese Luigia
Battistotti Sassi, fucile in spalla e fascia tricolore.
Le donne in guerra ci sono sempre state e narrazioni delle loro gesta hanno
percorso le letterature europee, popolari e non, per secoli. Ci che mi interes-
sa analizzare in questa sede il modo in cui a seconda del momento particola-
re, limmagine della donna in armi sia cambiata. Pi precisamente come si sia
modifcata linterpretazione delle sue gesta militari a seconda delle contingenze
politico-militari e delle necessit per cos dire culturali di sostenere lideale
78 Di Cori, P. Partigiane, repubblichine, terroriste. Le donne armate come problema storiografco,
in Ranzato, G. (a cura di) Guerre fratricide. Le guerre civili in et contemporanea, Torino, Bollati Bo-
ringhieri, 1994, pp. 304-329. Corsivo mio.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 231 03/05/2013 11:11:17
232
Capitolo 4. Che genere di nazione?
nazional-patriottico, includendo ogni soggetto abile per il raggiungimento dello-
biettivo fnale.
Paola di Cori si riferiva allesperienza della guerra mondiale, ma anche il Ri-
sorgimento uno di quei momenti particolare, una congiuntura durante la quale
equilibri sociali e dinamiche consolidate vengono di continuo adattate alle neces-
sit pi immediate.
La variet dei modi di rappresentazione delle donne in armi nel corso dellOt-
tocento (nellopera bufa come nel melodramma, nelle canzoni popolari, nei libri
per il popolo, nelle gazzette e nelle biografe delle donne illustri) mostra come tali
rappresentazioni si siano trasformate a seconda del momento della loro produzio-
ne e circolazione. Guardando alle forme di rappresentazione visibile
79
che hanno
contribuito alla costruzione dellimmaginario della donna in armi si avverte un
cambiamento di rotta in particolare nella produzione culturale degli anni centra-
li del secolo (1846-1861), perch tali rappresentazioni suggeriscono modalit di
partecipazione attiva in battaglia che non mettono in discussione equilibri sociali
e di genere.
Il repertorio di immagini circolanti nella prima met dellOttocento e negli
anni successivi al raggiungimento dellUnit nazionale, al contrario, esemplifca
unattitudine pi conservatrice nei confronti della donna in armi. Nella versione
italiana de La Fille du Rgiment di Gaetano Donizetti, per esempio, la protagoni-
sta, Maria, accetta di normalizzare il suo desiderio di far parte del reggimento che
lha cresciuta sposando un giovane soldato: abbandona il sogno di combattere in
favore di un destino prestabilito nelle vesti di moglie e madre. Maria canta: Son
persuassisima challa battaglia/io pur con gli altri saprei marciar []/Schioppi
e sciabole,/bombe e mitraglia/con voi pugnando,/saprei sfdar []/Vuol s che
ognun somiglia al padre,/somigli al mio./[] Saprei marciar saprei pugnar!
80
.
Lepilogo sarebbe stato diverso nei testi pubblicati negli anni delle guerre dIn-
dipendenza.
Tra il 1840 e il 1870 la produzione poetica, melodrammatica e pittorica ofre
esempi di donne che non si limitano a incoraggiare uomini intimoriti o codardi,
ma li af ancano, o addirittura li superano in ardimento, dimostrando altrettanto
coraggio ed eroismo. La donna dimostra cio di poter partecipare alla nazione in
armi dalla quale fno a quel momento era stata esclusa.
Il concetto di nazione in armi, prevedeva infatti da una parte la militarizza-
zione della mascolinit e dallaltra la rigida divisione dei sessi, basata anche sulla
capacit naturale di ciascuno: il destino delluomo quello di combattere ed, even-
79 Aguhlon, M. Marianne au combat: limagerie et la symbolique rpublicaines de 1789 1880, Paris,
Flammarion, 1979.
80 Donizetti, G. La fglia del Reggimento, 1847 (edizione italiana). Atto primo, scena quinta.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 232 03/05/2013 11:11:17
233
4. Donne in armi e Risorgimento
tualmente, togliere la vita al nemico, mentre alla donne riservato il ruolo oppo-
sto, ovvero quello di protettrice dello spazio domestico e riproduttrice della stirpe.
Ma dopo il 1846, lelezione di Pio IX d nuovo impulso alla lotta per lindi-
pendenza, la necessit di mobilitazione generale ha fatto s che limmagine fem-
minile uscisse dalle mura domestiche talvolta con un moschetto in spalla. Questo
modello di donna in armi viene non solo accettato ma anche celebrato: Odabella,
principessa amazzone nellAttila di Giuseppe Verdi, non solo incita alla ribellione
contro gli invasori ma infigge al re degli Unni il colpo mortale quando se ne
presenta loccasione.
La retorica risorgimentale ha fatto uso di fgure e personaggi di epoche lon-
tane nel tentativo di creare una narrazione patriottica che fosse radicata in una
gloriosa storia comune, che risaliva al Medioevo e Rinascimento. Questa epica
nazionale veniva pubblicata in collane di letteratura popolare, come i Libri per il
Popolo della casa editrice torinese Baricco & Arnaldi. Stamura dAncona raggiunse
la quarta ristampa in pochi mesi
81
: nel 1173, quando Ancona assediata dalle
truppe inviate da Federico Barbarossa, una donna combatte eroicamente e contri-
buisce alla cacciata del nemico.
Sebbene nelle intenzioni delleroina non ci fosse il desiderio di unifcare lI-
talia, le sue gesta vennero usate nella narrativa nazional-patriottica risorgimentale
come esempio di straordinaria determinazione e coraggio femminile.
Stamura non sceglie la guerra, piuttosto ne viene soprafatta, trovando in se
stessa le risorse per reagire e far reagire i suoi concittadini. Una volta cessate le osti-
lit, Stamura abbandona le vesti guerresche e torna a essere una donna di casa.
la consapevolezza della propria posizione nello spazio pubblico e di conseguenza
la capacit di saper ritrovare il proprio posto nella struttura sociale che consente
a Stamura di essere ammirata precisamente per la sua capacit di aderire allo status
quo, anche quando circostanze eccezionali richiedono gesta eccezionali.
Anche la storia di una tra le pi famose eroine del 1848, Luigia Battistotti
Sassi, ofre spunti di rifessione per le modalit con le quali stata rappresentata.
interessante notare come Luigia agisca durante uno dei momenti topici della lotta
risorgimentale, le Cinque Giornate di Milano, che riconosciuto anche come una
delle prime mobilitazioni del femminismo, come lotta politica e sociale. fonda-
mentale tenere presente ci, se si vogliono comprendere le cronache che esaltano
il patriottismo della giovane popolana milanese e non ne condannando la trasgres-
sione. Lo stato di emergenza rappresentato dalle Cinque Giornate permetteva
la sospensione di molte norme e regole, anche di genere: il coraggio di tutti i
81 Govean, F. Stamura DAncona, Torino, Baricco & Arnaldi, 1848. Devo ringraziare Simonetta
Chiappini per avermi segnalato il volume di Felice Govean su Stamura dAncona; un mio saggio
dedicato alla donna anconetana in corso di pubblicazione.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 233 03/05/2013 11:11:17
234
Capitolo 4. Che genere di nazione?
cittadini era necessario a spingere laustriaco fuori dalle porte della citt e anche
leroismo delle donne contribuiva alla propaganda risorgimentale che mirava al
coinvolgimento del popolo, senza distinzioni di sesso.
Luigia tra le prime a capire limportanza strategica di costruire barricate e
di formare mini-battaglioni di quartiere che perlustrassero e difendessero zone
geografche limitate; la giovane si mette alla testa di un battaglione vestendo abiti
maschili, e commette numerosi atti di violenza contro il nemico austro-croato,
[per] esprimere e far emergere doti che traboccavano dal modello normativo di
femminilit
82
.
Cos facendo, Luigia esce dal ruolo tradizionale di moglie e madre a lei asse-
gnato
83
e si posiziona in una zona di confne allinterno della quale linversione
di ruoli (madre/moglie > combattente) viene pi facilmente accettata perch
eccezionale.
Le storie, esperienze e immagini delle donne in armi complicano [the] as-
sumption that the history of women can be subsumed and symbolized by a single,
all-ecompassing image of femininity
84
e con ci contribuiscono anche a compli-
care e sfumare la rappresentazione spesso mono-dimensionale della donna risorgi-
mentale, cristallizzata nella triade madre/moglie/sorella.
82 Guidi, L. Patriottismo femminile e travestimenti sulla scena risorgimentale, in Guidi, L.; Lamarra, A.
(a cura di) Travestimenti e metamorfosi: percorsi dellidentit di genere tra epoche e culture, Napoli, Fi-
lema, 2000, pp. 54-92. In altra sede sar interessante analizzare come veniva descritta, e si descriveva,
Luigia; laccento sulla mascolinit della giovane donna contribuisce a inserire Luigia nella categoria
di donne la cui femminilit (e quindi normativit) viene messa in discussione.
83 Per una brillante analisi delle conseguenze dellatto di uscire dai confni normativi di genere, si
veda Perrot, M. Uscire, in Fraisse, G.; Perrot, M. (a cura di) Storia delle donne in Occidente. LOtto-
cento, vol. IV, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 446-482.
84 Felski, R. Te Gender of Modernity, Cambridge, Harvard University Press, 1985.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 234 03/05/2013 11:11:17
CAPITOLO 5
Modelli di genere e iniziativa femminile
nella costruzione dellItalia unita
a cura di Laura Guidi
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 235 03/05/2013 11:11:17
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 236 03/05/2013 11:11:17
Introduzione
Laura Guidi
Nel trattare in chiave di genere specifci del aspetti processo di costruzione e con-
solidamento dellunit italiana, i testi compresi in questa sezione analizzano spazi
diversi, ma tutti di confne tra il pubblico e il privato, tutti ugualmente segnati dalli-
niziativa e dalla partecipazione delle donne. Altro flo rosso che lega tra loro queste
ricerche costituito dal Mezzogiorno: presente, di volta in volta, come parte irri-
nunciabile del processo di unifcazione, patria antiunitaria nella visione rovesciata
della resistenza borbonica, o, gi in fase preunitaria, questione, elemento di rischio
e debolezza rispetto a un processo di reale unifcazione nazionale, a causa della sua
irriducibile alterit rispetto al modello (e al mito) di un Nord moderno e civile.
Questultima chiave di lettura prevalente nelle considerazioni preoccupate
e lucidamente critiche della lombarda e cosmopolita Cristina di Belgiojoso, la cui
conoscenza del Sud era dovuta pi a letture, corrispondenze e conversazioni che ai
due brevi soggiorni nel napoletano il pi memorabile dei quali fu senza dubbio
quello del 1848, in cui radun un drappello di volontari per condurli a Milano,
reduce dalle Cinque giornate, al cospetto del governo provvisorio. Lo sguardo del-
la Belgiojoso sul Sud, oggetto del contributo di Karoline Rrig, appare infuenzato
da uno stereotipo difuso nel Risorgimento, alla cui costruzione contribuirono gli
stessi esuli meridionali, che addebitavano principalmente al malgoverno borboni-
co lo stato di povert e arretratezza in cui versavano quelle terre. Il Mezzogiorno
era [..] considerato come un paese fondamentalmente sano e forte, oppresso da
una tirannia, osserva Marta Petrusewicz
1
. Dovremo aspettare la met degli anni
1 Petrusewicz, M. Come il Meridione divenne una questione. Rappresentazioni del Sud prima e dopo
il Quarantotto, Catanzaro, Rubbettino, 1998, p. 143.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 237 03/05/2013 11:11:17
238
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
Settanta perch studiosi come Pasquale Villari, Leopoldo Franchetti e G. Sidney
Sonnino aprano la prima stagione di approfonditi studi economico-sociali sulle
cause ben pi complesse che allontanavano il Sud dal processo di modernizzazione
avviato nelle pi avanzate regioni del centro-nord. Pur basandosi su informazioni
parziali e di parte, sotto un aspetto almeno la Belgiojoso accostabile ai primi
meridionalisti: nel considerare il Sud una cruciale questione nazionale, la cui
mancata soluzione minaccia la compattezza e la stessa identit della nuova Italia.
Ma, nonostante la simpatia espressa per i lazzari (in contrasto con la severa
stigmatizzazione delle lite meridionali) e il riconoscimento della capacit della
societ napoletana di evolversi (vedi le Osservazioni del 1868) la patriota lombar-
da individua lunica, ardua, possibilit di riscatto del Sud in una cooperazione
fraterna con il Nord in cui solo a questultimo e pi specifcamente alla sua
componente liberista e laboriosa, puritana e anglofla viene assegnato il ruolo di
guida ai fni di un processo che, per la patriota lombarda, non pu che essere di
assimilazione.
Il Mezzogiorno che ricorre negli altri interventi della sezione ci viene presen-
tato, al contrario, visto da angolature che ne mettono pi o meno esplicitamente
in discussione gli stereotipi, sottolineandone aspetti di modernit. il caso di
quelle sue lite dal respiro cosmopolita grazie alle relazioni politiche, culturali e di
amicizia, ai viaggi, alle letture, agli esli. il caso, analizzato da Franca Bellucci,
di Angelica e Laura Caracciolo di Torella, legate da stretta amicizia e da relazioni
epistolari con il patriota toscano Vincenzo Salvagnoli, che a fne anni Trenta di-
scutono con lui della vita ideale: un tema pervaso da elementi romantici, che
accomuna, diversamente declinato, tante colte corrispondenze e conversazioni,
poesie e scritture delle intellettuali meridionali prima del 1848
2
, allepoca in cui
esprimono le proprie istanze di rinnovamento della societ ancora in una chiave
pi culturale che esplicitamente politica, come osserva Bellucci.
Modernit, liberalismo, legami con la cultura europea connotano anche le fa-
miglie napoletane di Francesco Capecelatro, Giuseppe Ferrigni, Antonio Ranieri,
analizzate da Marcella Varriale: famiglie nelle quali fn dallinfanzia si apprende a
onorare la memoria dei martiri del 1799 e si coltivano dottrine liberali. Nei loro
salotti, prima del Quarantotto, donne e uomini si riuniscono soprattutto per fare
musica e parlare di letteratura, ma il comune sentire liberale a unirli in modo
pi profondo, fn quando, nel 1848, dal piano culturale si passer a quello espli-
2 Sulle intellettuali napoletane prima del 1848 vedi Russo, A. Alla nobile donzella Irene Ricciardi.
Lettere di Giuseppina Guacci Nobile, in Guidi, L. (a cura di) Scritture femminili e Storia, Napoli,
ClioPress, 2004 (disponibile in formato digitale: http://www.storia.unina.it/cliopress/guidi.html), pp.
271-294; Rascaglia, M. Da madre a fglia: percorsi ottocenteschi del sapere di genere, ivi, pp. 173-190;
Angarano, M. Sorelle, (non) madri, nipoti, tra pietas cristiana e passione risorgimentale, ivi, pp. 191-238.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 238 03/05/2013 11:11:17
239
Introduzione
citamente politico e si aprir una stagione di confitti e repressioni in cui le donne
svolgeranno un ruolo insostituibile
3
.
Moderno e modernizzatore appare, nel contributo di Francesco Muollo, Fran-
cesco De Sanctis. Anche per lui lesilio in particolare quello svizzero ha rappre-
sentato una fase importantissima di apprendimento e rifessione sui temi intercon-
nessi della modernit e della nazione. Divenuto ministro della pubblica istruzione,
con una legge nel 1878 dar un contributo decisivo alla difusione della ginnastica
come strumento di educazione dei cittadini e delle cittadine italiani, sfdando i dif-
fusi pregiudizi che circondavano, in particolare, la ginnastica e lo sport femminili.
Moderna e innovatrice, per altri versi, appare anche lantirisorgimentale Ma-
ria Sofa di Borbone alla cui biografa Ugo Della Monica d un contributo tratto
da fonti inedite nel riformulare i linguaggi della regalit, creando forme ef caci e
dirette di comunicazione con il popolo. A tal fne la regina utilizza tecniche nuove,
come la fotografa, e, soprattutto, mette in gioco la sua stessa persona, scegliendo
con felice intuito abiti, atteggiamenti, parole che la renderanno una vera icona del
legittimismo, conquistando nobili e uomini di chiesa
4
, soldati e rozzi contadini,
nei cui casolari durante le spedizioni contro il brigantaggio i soldati troveranno
piccoli ritratti, spesso fotografe, che la vedono risplendere nella sua fera bellezza
accanto alla fgura pi scialba e schiva del marito
5
.
Dagli interventi di questa sezione, dunque, le lite meridionali vengono collo-
cate in una dimensione che non si restringe entro i confni del Mezzogiorno n in
quelli della nuova nazione, ma piuttosto si apre a una cultura cosmopolita, in cui si
elaborano e si confrontano idee e modelli di societ, forme istituzionali e pubbliche
e stili di vita individuale e privata: temi e discussioni che circolano nelle relazioni epi-
stolari, nei salotti, nei romanzi, nella poesia, nel teatro, nella produzione musicale e
lirica. Entro questo spazio di cultura meridionale parzialmente sradicata, ma senza
dubbio arricchita e rinnovata, le donne svolgono ruoli attivi e creativi.
La militanza femminile nel Risorgimento uno dei temi ricorrenti della se-
zione. In alcune fgure, assume caratteri di protagonismo: il caso della regina
Maria Sofa o, sul fronte opposto, di Cristina di Belgiojoso, due donne in grado
3 Sulla militanza delle patriote del Sud dopo il 48 vedi Guidi, L.; Russo, A.; Varriale, M. Il Risorgi-
mento invisibile. Patriote del Mezzogiorno dItalia, Napoli, Edizioni del Comune di Napoli, in corso
di stampa.
4 Cfr. Meriggi, M. Il seduttore e il cappellano. Elaborazioni della guerra e del genere lungo la
strada dei Mille, in Guidi, L. (a cura di) Vivere la guerra. Percorsi biografci e ruoli di genere tra Risor-
gimento e primo confitto mondiale, Napoli, ClioPress, 2007 (disponibile in formato digitale: http://
www.storia.unina.it/cliopress/guidi_gurra.html), p. 39.
5 Cfr. Guidi, L. La regina-soldato: Maria Sofa di Baviera, in Mafrici, M. (a cura di) Allombra
della corte. Donne e potere nella Napoli borbonica (1734-1860), Napoli, Fridericiana Editrice Univer-
sitaria, 2010, pp. 177-190.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 239 03/05/2013 11:11:18
240
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
di sottrarsi al canone borghese ottocentesco della riservatezza/domesticit femmi-
nile in virt dei propri privilegi di rango, oltre che di eccezionali doti personali.
In altri casi troviamo fgure che oscillano tra afermazioni a favore di una sfera
femminile separata e il rivendicare, quanto meno per se stesse, ruoli che di fatto
la travalicano.
Il Quarantotto, come osserva Franca Bellucci, segna lingresso di molte in-
tellettuali dallo spazio letterario e artistico al terreno del confitto politico vero
e proprio sia pure in forme ausiliarie (ma non per questo poco rilevanti). La
dimensione ideale entro cui si muovono queste patriote unisce in un nodo indis-
solubile la famiglia alla patria: la seconda appare estensione della prima, e non solo
in senso metaforico, ma anche nelle concrete forme di iniziativa militante.
Daltra parte, famiglia e patria appaiono indissolubilmente legate anche nel
sentimento legittimista che ispira le cospirazioni antiunitarie di Maria Sofa. In tal
caso, la famiglia non quella borghese, nucleare-intima, ma la famiglia/dinastia,
fondamento del legittimismo politico; tuttavia, sia pure in modo contraddittorio,
la stessa Maria Sofa (per altro, prima della caduta del Regno, aperta a un mode-
rato liberalismo costituzionale) fa propri molti elementi romantici nel rielaborare
e modernizzare limmagine e il linguaggio della sovranit. Dal punto di vista della
giovane regina, daltra parte, lo scontro non tra modello tradizionale e liberali-
smo, ma tra due famiglie dinastiche: luna legittima e premurosa del suo popolo,
laltra, i Savoia, straniera, predatoria, arrogante.
Patria e famiglia appaiono profondamente legate anche nelle vicende familiari
analizzate da Marcella Varriale, che sottolinea il ruolo femminile nellelaborare e
custodire per le generazioni future memorie in cui privato e pubblico appaiono
inscindibili: maternit educatrice e patriottismo non potrebbero fondersi in un
nodo pi stretto di quello che emerge dai ricordi familiari e risorgimentali di
Enrichetta Capecelatro Carafa DAndria, ultimo anello di una genealogia di pa-
triote. Grande storia e storia privata vengono a rispecchiarsi luna nellaltra nella
narrazione di Enrichetta, fno a delineare una pedagogia nazionale.
Linsieme di questi testi, dunque, aggiunge qualche tassello a una recente sto-
riografa di genere sul Risorgimento che, restituendo alla memoria lampia mo-
bilitazione patriottica (nonch la mobilitazione antiunitaria) femminile dellet
risorgimentale ha contribuito a una rilettura complessiva della storia italiana ot-
tocentesca in chiave sociale e culturale
6
. Alla luce di questa nuova generazione di
6 La produzione storiografca sulla partecipazione femminile al Risorgimento ormai cos numerosa
che richiederebbe ben pi di una breve nota bibliografca. Si pensi, tra gli altri, agli scritti di Simo-
netta Soldani, Ilaria Porciani, Nadia Maria Filippini, Maria Luisa Betri, Daniela Maldini Chiarito,
Maria Teresa Mori, Rosanna De Longis. Il volume a cura di A.M. Banti e P. Ginsborg, Il Risorgi-
mento. Storia dItalia. Annali 22, Torino, Einaudi, 2007, rappresenta un tentativo molto interessante
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 240 03/05/2013 11:11:18
241
Introduzione
studi non possiamo oggi pi considerare il Risorgimento come un processo agito
esclusivamente da ristrette lite politiche e intellettuali, tanto meno come mero
susseguirsi di annessioni e avvicendamenti dinastici pianifcato nelle corti e nei
gabinetti diplomatici e concluso sui campi di battaglia. Degli stessi protagonisti
del canone risorgimentale si indaga il loro ruolo di icone entro processi di mo-
bilitazione e nazionalizzazione di massa che includono classi subalterne, giovani,
donne
7
. I testi poetici, teatrali e narrativi di quello stesso canone vengono riletti
alla ricerca delle fgure profonde che allepoca conferirono al linguaggio patriot-
tico la capacit di coinvolgere emotivamente e mobilitare
8
. La storiografa riscopre
in tal modo i decenni centrali dellOttocento come fase di costruzione di una
societ nazionale nei suoi aspetti molteplici dai modelli educativi alle relazioni
familiari, dai ruoli di genere ai riti e alle liturgie patriottici, dalla socialit ai luoghi
di formazione dellopinione pubblica.
Lunifcazione apr nella societ italiana un processo di normalizzazione del-
le relazioni di genere: alle intrepide eroine del 1848 o del 1860 si chiese di trasfor-
marsi in mogli e madri rispettabili e di ritirarsi dalla sfera pubblica uf ciale (anche
se non tutte lo fecero); i gruppi radicali (di ispirazione mazziniana o garibaldina),
dopo aver avuto un ruolo protagonista nel processo unitario, vennero respinti ai
margini, insieme con le utopie di giustizia sociale che avevano mobilitato mol-
ta parte del patriottismo femminile. Bisogner attendere una nuova generazione
perch emerga una classe lavoratrice capace di dar vigore a nuove utopie sociali e
perch il femminismo esprima con rigore intellettuale e capacit organizzativa la
propria prospettiva di una nazione di cui le italiane siano parte non subalterna.
Tuttavia tra patriottismo femminile e prime espressioni del femminismo non
vi un salto generazionale, ma al contrario una stretta linea di continuit, anche
biografca tanto pi evidente se guardiamo alle repubblicane, alle mazziniane, alle
garibaldine. La garibaldina napoletana Giulia Caracciolo Cigala, ad esempio, nel
1867 presiede il primo Comitato nazionale per i diritti delle donne, a sostegno delle
iniziative del parlamentare Salvatore Morelli: del Comitato fanno parte, oltre alla
sorella di Giulia, Enrichetta, anche una fglia di Garibaldi, Teresita, oltre a quella che
diventer la pi celebre femminista del secondo Ottocento, Anna Maria Mozzoni.
Signifcativo appare anche il ruolo delle militanti che si impegnano nella rico-
struzione storica e memorialistica: il caso di Cristina di Belgioioso e di militanti
risorgimentali venute da altri paesi, che riconoscono nel Risorgimento un luogo
cruciale per lafermazione di valori universali di libert, come Jessie White Mario
di rilettura complessiva del Risorgimento anche attraverso la categoria di genere.
7 Cfr. Riall, L. Garibaldi. Linvenzione di un eroe, Roma-Bari, Laterza, 2007.
8 Banti, A.M. La nazione del Risorgimento. Parentela, santit e onore alle origini dellItalia unita,
Torino, Einaudi, 2000.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 241 03/05/2013 11:11:18
242
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
e Louise Colet. Nel 1926 Enrichetta Capecelatro Carafa DAndria si inserir sul
solco di questa tradizione storica e memorialistica femminile
9
.
Rispetto alla cristallizzazione operata da un canone storiografco che aveva ri-
dotto la partecipazione femminile al Risorgimento in termini di sacrifcio/dolore/
virt materni, le fgure di donne che emergono dai saggi qui presentati parlano
daltro. Ricostruiscono un peculiare intreccio tra romanticismo, individualismo
liberale e patriottismo che liber, allepoca, aspirazioni ed energie femminili,
comportando decise rotture rispetto allordine patriarcale. Basti pensare a quante
patriote ruppero unioni coniugali in cerca di una pi autentica realizzazione della
propria vita (da Cristina di Belgiojoso, a Enrichetta di Lorenzo, a Giulia Carac-
ciolo Cigala, a Laura Solera Mantegazza); a quante altre si ribellarono alle ge-
rarchie familiari rifutando destini imposti. Attraverso la costruzione di un nuovo
modo di concepire la coppia, la famiglia, il rapporto con i fgli, le donne lasciano
unimpronta forte sulla societ risorgimentale e post-risorgimentale, resistendo,
nella sfera privata prima che in quella pubblica, ai tentativi di restaurazione del
patriarcato, e ponendosi come elementi chiave della modernit.
9 Sulle storiche italiane vedi Casalena, M.P. Scritti storici di donne italiane, Firenze, Olschki, 2003;
Palazzi, M.; Porciani, I. (a cura di) Storiche di ieri e di oggi, Roma, Viella, 2004.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 242 03/05/2013 11:11:18
1. Risorgimento italiano.
Naturali protagonismi di donne
Franca Bellucci
1. La fonte utilizzata. Le sue potenzialit
Il termine risorgimento, con il suo richiamo catartico, non si stabilizzato pres-
so gli storici che di recente: concorrendo con rinascimento, infne sono stati en-
trambi adottati, acquisendo le diverse determinazioni attuali. Nel 1859 si parlava
invece di grande riforma, espressione laica che suggeriva la radicalit delle tra-
sformazioni e la loro difusione capillare, quella naturalezza che fu un segno di-
stintivo. Il termine, che segnalava un coinvolgimento sociale pi ampio dei gruppi
che fecero politica in senso stretto, interessante: spinge a includervi fermenti di
romanticismo, un modello nuovo e unitario per le donne. LUnit prima di tutto
da intendersi come nuovo atteggiarsi sociale, in rappresentanza maschile ma con
unadesione femminile larga e in gran parte convinta.
Le considerazioni presentate da questa relazione scaturiscono da uno scanda-
glio limitato ma signifcativo: linsieme (circa 2800) delle lettere scritte da donne
conservato, con altri documenti, in un Archivio privato custodito dal comune
di Empoli. dei Salvagnoli-Marchetti (dora in avanti ASM)
10
, una famiglia co-
10 Cfr. Arrighi, V.; Guerrini, L.; Insabato, E.; Terreni, S. (a cura di) Inventario dellArchivio Salva-
gnoli Marchetti, Pisa, Pacini editore-Comune di Empoli, 2002. Per i convegni sullargomento, si veda
in particolare: Il Risorgimento nazionale di Vincenzo Salvagnoli. Politica, cultura giuridica ed economica
nella Toscana dellOttocento. 1802-2002 Secondo centenario della nascita di Vincenzo Salvagnoli (a cura
del Comune di Empoli, Soprintendenza archivistica della Toscana et alii. Cura editoriale di Insabato,
E.; Terreni, S.), Ospedaletto (Pisa), Pacini Editore, 2004. Nel citare le lettere, i due numeri indicano
busta e fascicolo.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 243 03/05/2013 11:11:18
244
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
spicua da cui provennero due esponenti del Risorgimento, Vincenzo Salvagnoli
(1802-1861, dora in avanti VS) e il fratello Antonio (1810-1878, dora in avanti
AS)
11
. Il pi noto Vincenzo, uno dei Moderati toscani, ministro del culto nel
governo provvisorio Ricasoli. I due esercitarono professioni liberali: grande avvo-
cato il primo e medico igienista il pi giovane. La corrispondenza privata
12
che
essi ricevettero da molte donne ebbe ragioni professionali, politiche, familiari
13
.
Larco temporale compreso fra il 1819 e il 1876. Lo stile delle scriventi indica
un proflo sociale sfaccettato. Talora i testi sono minimi, ma altri hanno qualche
pretesa letteraria, poich letterato e mecenate fu VS
14
.
La variet dei contatti dei Salvagnoli, specialmente di Vincenzo, tale da dare
limpressione di una geografa peninsulare delle frequentazioni. Del resto molti
privati contribuirono al ruolo di centralit culturale che la Toscana svolse, nel
tempo risorgimentale, quasi vestale delle glorie patrie
15
, assecondandone il pre-
stigio di lingua e istituzioni culturali, la vocazione alla divulgazione peninsulare.
Da ricordare i Congressi degli Scienziati ospitati in varie citt italiane a partire da
Pisa, tra il 1839 e il 1847
16
, i contatti dellAccademia dei Georgofli, fra scienza
botanica e proposte per la conduzione proprietaria ideale.
Nella fonte, gentildonne delle casate Corsini e Rinuccini, Azzolino e Di Ba-
gno, Bassi e Pasolini si riferiscono di frequente a relazioni fra Toscana, Stato pon-
tifcio (Roma, Bologna, Macerata, Iesi, Rimini, Forl), Piemonte, Lombardia. Ma
i Salvagnoli consolidarono particolarmente un proprio asse Roma-Napoli espe-
rito per tempo da un fratello, poi morto prematuramente, il canonico Giuseppe
(1799-1829): implicato nei fatti del 1821, aveva trovato protezione presso i Po-
11 La situazione dei Salvagnoli vista come tipica (per propriet e professione) in: Sereni, E. At-
tualit del Giusti. La cultura toscana nel 1848 e il signifcato storico della mezzadria, in Conferenze
forentine, Firenze, Sansoni, 1950, p. 44.
12 Chemello, A. Premessa, pp. VII-XI, in Chemello, A. (a cura di) Alla lettera. Teoria e pratiche epi-
stolari dai Greci al Novecento, Milano, Guerini Studio, 1998, qui p. IX. Il confronto di espressioni e
referenti ha seguito Pomata, G. La storia delle donne: una questione di confne, in Il mondo contempo-
raneo. Gli strumenti di ricerca,10-2, Questioni di metodo, pp. 1434-1469, Firenze, La Nuova Italia, 1983.
13 Mi si consenta indicare su tali lettere il libro (da una tesi, Pisa, 2003-04, relatore A.M. Banti): Bel-
lucci, F. Donne e ceti fra romanticismo toscano e italiano, Ospedaletto (Pisa), Pacini editore-Comune
di Empoli, 2008.
14 VS era fra gli avvocati letterati formatisi nellAteneo pisano con Giovanni Carmignani,: cfr.
Pazzagli, C. Vincenzo Salvagnoli e leconomia politica, in Il Risorgimento nazionale di VS cit., pp.
151-189, qui p. 154.
15 Gnoli, D. Nazionalit ed arte, in Nuova Antologia, v. 151 (16. II 1897), pp. 594-613, qui p. 599. Sulla
Toscana: Coppini, R.P. Il Granducato di Toscana. Dagli anni francesi allUnit, Torino, UTET, 1993.
16 Patriarca, S. Patriottismo, nazione e italianit nella statistica del Risorgimento, in Banti, A.M.;
Bizzocchi, R. (a cura di) Immagini della nazione nellItalia del Risorgimento, Roma, Carocci, 2002,
pp. 113-132.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 244 03/05/2013 11:11:18
245
1. Risorgimento italiano. Naturali protagonismi di donne
tenziani, colti marchesi e agronomi infeudati a Rieti. lasse che si rintraccia die-
tro gli scritti della matura Angelica, consorte del marchese Ludovico Potenziani,
fglia di Cristophe Saliceti
17
, zia dei napoletani Caracciolo di Torella. Da giovane
si era formata
18
nella Firenze napoleonica; da qui aveva avuto accesso alle buone
amicizie
19
conservate nel tempo.
A fne anni Trenta (1838-39) alcune grande dame napoletane della famiglia
Caracciolo di Torella, Angelica coniugata Rende e Laura
20
, dissertavano con Vin-
cenzo Salvagnoli della vita ideale, dando limpressione di un laborioso dibattito
comune in Italia. Angelica
21
replicava allavvocato sul tema comella dice che deb-
bono essere le donne, in merito al portamento e alla relazione damore. Lideale
era una vita ritirata e solitaria, priva di divertimenti e balli, fondata sul controllo
di s o, come si legge, sulla moderazione: insomma quella delle tediose periferie
lontane. Trovandosi Angelica a Giovinazzo con il marito durante lagosto 1839, ed
essendo impedita da unafezione agli occhi, con buona dose dironia ammetteva
di essere nella perfezione del modello desiderabile, poich si spendeva tutta fra le
pareti domestiche: Leggo, scrivo, lavoro e dipingo. Lautodisciplina era noiosa,
ma corrispondente allideale dover essere.
2. Contaminazioni unitarie di pratiche sociali aristocratiche e borghesi
Fu quanto bast per dare base alla grande riforma. certo appropriato, come
dice Simonetta Soldani
22
, riconoscere che le donne spesso aderivano a un con-
17 Il Saliceti era stato vicino al Bonaparte e a Gioacchino Murat, in Toscana, fra Firenze e Lucca,
negli anni 1801-1805 e a Murat nel suo regno a Napoli. Mor nel 1809, quando la fglia Angelica era
ancora agli studi a Firenze: cfr. Sacchetti Sassetti, A. Angelica Potenziani Saliceti (1792-1865), Rieti,
Tipografa Nobili, 1962.
18 Sulla storia delle istituzioni culturali a Firenze, cfr. Soldani, S. (a cura di) Leducazione delle donne.
Scuole e modelli di vita femminile nellItalia dellOttocento, Milano, Franco Angeli, 1989.
19 ASM, 85,1, Potenziani, Angelica, lettera Roma 11 giugno 1833, pubblicata in Bottacin, A.
Una comune amicizia di Stendhal e Vincenzo Salvagnoli: i marchesi Potenziani. Con documenti
inediti, in Il Risorgimento nazionale di VS cit., pp. 405-424.
20 ASM, 70,5, Caracciolo, Angelica (1814-1887) contiene 6 lettere; in ASM, 85,6, Rende, A.: 14
lettere. In ASM, 70,5, Caracciolo, Laura (1817-1891) ha 2 lettere. Entrambe fglie di Giuseppe
Caracciolo principe di Torella, duca di Lavello, coniugato a Firenze 1806 con Caterina Saliceti. Su
Angelica Caracciolo si veda Bottacin, A. Lamicizia di Stendhal con i marchesi Potenziani e i prin-
cipi di Torella, in Rivista storica del Lazio, n. 18, a. XI, 2003, Roma, Gangemi edit. A p.164 lipotesi
che Angelica sia la donna desiderata da Stendhal con il nome di Little.
21 ASM, 70,5, Caracciolo, Angelica, lettera Napoli 27 aprile 1839.
22 Soldani, S. (a cura di) Italiane! Appartenenza nazionale e cittadinanza negli scritti delle donne
dell800, in Genesis. Rivista della Societ italiana delle Storiche, 1, 2002, pp. 85-124; cfr. p. 85.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 245 03/05/2013 11:11:18
246
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
cetto di patria, concepita come convivenza analoga rispetto a quella familiare,
almeno fno ai primi anni Novanta. Fu questo il tracciato del percorso risorgi-
mentale per le donne, un vero sfondo di massa con molte contiguit, fra i vari
stati della penisola, nelle istanze istituzionali, sociali, culturali. Dopo il Con-
gresso di Vienna
23
si liquid la legislazione civile del periodo napoleonico ma
conservando una relativa disponibilit alle contaminazioni fra i ceti sociali
24
. Il
richiamo alla tradizione e allimmagine della famiglia fu premessa per innestare
dottrine attuali ma moderate. Era nuovo, rispetto al Settecento, che le donne
spostassero lattenzione dai padri ai partner, essendo nodi dellorganizzazione i
buoni padri di famiglia: il nuovo clima consent che in base ai bisogni maritali
si impiegassero le ricchezze dotali. Dagli anni 1827-1830, constatiamo anche
nelle scritture dellArchivio Salvagnoli, era difuso che le donne si identifcassero
con lintimit della famiglia in atteggiamento oblativo di s, ponendo al centro
lessere e il sentirsi madre.
Nellarco temporale lungo delle lettere si osserva che le performance delle don-
ne notabili raggiunsero nuova capacit di coinvolgimento: le feste, campestri o
cittadine, le attivit pi o meno benefche, poterono aprirsi alla condivisione della
causa politica. Altre pratiche preesistenti al risorgimento, ma che nei momenti di
accelerazione politica diventarono ef caci strumenti, furono i viaggi. Non con-
siderando i soggiorni allestero imposti dallesilio, il modello di viaggio da cui
scatur ef cacia politica fu quello del tour culturale, praticato in particolare da
signore di rango, ma presto ripreso anche dalle borghesi. Le formalit di presen-
tazione reciproca, di informazione e di intrattenimento, previste nelle tappe del
tour, furono volte a selezionare i contatti e i contenuti. Il tour divent patriottico
per alcune signore: i luoghi dincontri erano relativamente mobili, lo scopo pi
attinente alla politica, lo stile adottato relativamente austero. Fu simile a questo
il giro dei congressi degli scienziati, che non accolsero solo gli addetti ai lavori: le
signore, che mettevano a disposizione le proprie dimore per i lavori congressuali e
che accompagnavano i partecipanti, erano parte attiva e consapevole. Ne parla per
esempio Virginia Bassi
25
, con una lettera del 1845 di ritorno dal Congresso scien-
23 Si vedano i rafronti fra istituti di vari stati preunitari in Calvi, G.; Chabot, I. (a cura di) Le ric-
chezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX sec.), Torino, Rosenberg
& Sellier, 1998.
24 Per un approccio segnalo Romanelli, R. Nobilt europee dellOttocento. In margine a un con-
vegno di studi, in Passato e Presente, n. 11, a. V, 1986, pp. 136-146.
25 Virgilia e Cecilia Bassi, madre e fglia, sono autrici di un gruppo di lettere piccolo, ma protrattosi
fra il 1845 e il 1860. ASM, 67,2, Bassi Virginia, lettera Milano 26 novembre 1845: descrive il
viaggio di ritorno dal Congresso di Napoli (settembre-ottobre 1845). Il nipote Pasolini ivi citato
Giuseppe Pasolini, marito di Antonietta Bassi.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 246 03/05/2013 11:11:18
247
1. Risorgimento italiano. Naturali protagonismi di donne
tifco di Napoli. Anche in questo caso era la religione della famiglia che accendeva
linteresse politico
26
.
Nel folto gruppo di iniziative in cui le donne diedero il loro possibile e na-
turale contributo alla geografa unitaria sceglier alcuni esempi signifcativi, an-
che se disparati, disponendoli in ordine cronologico. Gi sono noti i documenti
riguardanti i marchesi Giuseppe e Costanza Arconati e la loro infuenza sul gior-
nale La Patria (1847-1849) fondato da VS, con Rafaello Lambruschini e Bettino
Ricasoli. Ma nelle scritture di donne oscure che emerge una pratica coerente di
supporto al capo famiglia. In qualche modo c uneco delle forme di risveglio re-
ligioso presenti nellEuropa continentale e convergenti con il romanticismo. Nella
stessa cerchia familiare dei Salvagnoli si attivarono donne, come Amalia Fortini
Rossini, di grande prudenza e af dabilit. Esse condivisero i progetti di vita, anche
svolgendo funzioni di supplenza durante i viaggi e gli esili dei patrioti.
Nella primavera-estate del 1848 si osserva fra le scriventi un pi preciso fan-
cheggiamento del momento politico
27
, forse da intendersi come retroscena di
azioni gi identifcate nella ricerca storica del risorgimento toscano. Uniniziativa
nota delle donne fu quellIndirizzo delle donne forentine per lalbo in onore di Vin-
cenzo Gioberti, difuso a fne giugno 1848, che la Soldani
28
ha presentato, opera
di Caterina Franceschi Ferrucci. Sembra un evento simile, ma mirato a stabilire
contatti fra regioni dItalia, quello di cui parla Isabella Rossi
29
, letterata di qualche
fama, combattiva ed energica, buona amica di Vincenzo Salvagnoli. Il giugno in
cui scriveva
30
, anche se non detto, era certo quello del 1848. Per loccasione essa
reclamava una personale visibilit, che contendeva a molti nomi di signore tosca-
ne, fra cui la Ferrucci:
26 Gioli Bartolommei, M. Il rivolgimento toscano e lazione popolare(1847-1860). Dai ricordi famigliari
del marchese Ferdinando Bartolommei, Firenze, Barbera, 1905; alle pp. 301-303 valuta il contributo
allUnit di aristocrazia e patriziato ovunque scarso; in Toscana laristocrazia e lalta borghesia furono
avverse; determinante la media borghesia [] secondata dalla piccola borghesia e dal popolo.
27 Ivi, p. 51 un episodio: nel 1850 venne fatta una lotteria in aiuto dei bresciani, che avevano subito
inondazioni; il Comitato, presieduto dalla marchesa Bartolommei, era composto da Enrichetta Pe-
ruzzi, Giulia Ridolf, Elisa de Pazzi, Isabella Gabardi Brocchi; poi le signore forentine si schierarono
in due campi e quello della Bartolommei ebbe poche aristocratiche (oltre a lei, la Laiatico e la Digny).
Le ideologie si misuravano dunque con le prove.
28 Soldani, S. (a cura di) Italiane! Appartenenza nazionale e cittadinanza cit. pp. 99-100
29 1808-1893 le date per la Rossi nella biografa di Giovannini Magonio, G. Italiane benemerite
del Risorgimento Nazionale, Milano, Cogliati, 1907; per il compendio di storia italiana nel 1841 fu
ammessa al 2 Congresso degli scienziati a Firenze; promosse la colletta per le siciliane nel gennaio
1848; subentr a G.B. Niccolini allAccademia di Firenze. Cfr. Martini, F. Il Quarantotto in Toscana.
Diario inedito del conte Luigi Passerini De Rilli, Firenze, Marzocco, 1948, p. 517 (nota di p. 337): la
donna vinse il duello la Moltke-Corbelli, respingendo laccusa di malversazione.
30 ASM, 87,1, Rossi, Isabella nei Gabardi Brocchi, lettera s.a. 8 giugno. Mi giunge voce.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 247 03/05/2013 11:11:18
248
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
Egregio Salvagnoli
Mi giunge voce che Corridi a nome della Palagi e proprio desidera fare la risposta
alle Milanesi, e che per ha cercato anche me. Ma stata non so se per frmante
o per componente lindirizzo nominata la Ferrucci. Salvagnoli! Io non sopporto
soperchierie. Io prima, sola, spontanea ho fatto lindirizzo quando nessuno ci
pensava. Io feci quello alle Siciliane quando nessuno ne parlava. [] Ci in con-
fdenza vi dico [] Regolatevi per il meglio! Uomo sommo qual siete, non potete
fare che lottimo. Sono in fretta vostra amica afe.
8 giugno Isabella Rossi Gabardi.
Questa stessa letterata, borghese che si era coniugata con un conte patriota,
Olivo Gabardi Brocchi, di Carpi di Modena, provava disagio nel modellare sulla
dimensione locale lideale patriottico unitario. Ecco un brano dalla lettera
31
che
invi a VS per bene augurare il 1852:
Come vivo, lo volete sapere? Vegeto magnifcamente, in mezzo agli agi ed anzi
posso dire, al lusso. Godo unaria balsamica sopra un giardino, che tocca le mura
della citt, che sono pure possedimento di mio Marito, le quali continuano
sullimmensa pianura, non avente altro limite che le cime delle lontane Montagne
di S. Pellegrino e del Cimone: mangio, dormo, penso, guardo e parlo a modo dei
sonnambuli, cio, senza coscienza di quel che dico, tanto poco mi necessita unire
il pensiero alla parola. Questi buoni carpigiani, che nel 31 dettero la mossa alla
rivoluzione, ora dormono.
Essi mi portano in palma di mano come una cosa rara. Poveretti!
Nel decennio successivo al 1848 i contesti divennero pragmatici, ma si propa-
garono i salotti organizzati dalle signore. Nel carnevale 1858, la forentina Emilia
Rondoni chiedeva a VS di sottoscrivere quote per ofrire un adeguato dono alla
signorina Milli: era Giannina Milli, di origine abruzzese e formazione napoleta-
na, poetessa estemporanea sui temi dei dolori e delle speranze dItalia, nonch su
Dio patria e famiglia, fra il 1856 e il 1866
32
.
Molto materiale dellarchivio riferito al cruciale periodo 1859-1861. Lav-
vocato Salvagnoli era riemerso dallombra fn dal febbraio 1859, con un opuscolo
patriottico che, difuso, diede luogo a missive, utili a riattivare le reti dintesa; nel
governo provvisorio poi fu ministro, fno alla fusione con il Piemonte. Non
poche di quelle missive sono attestati di donne convinte della istanza riformatrice.
31 Ivi, lettera Carpi di Modena 26 dicembre 1851.
32 Mori, M.T. Salotti. La sociabilit delle lite nellItalia dellOttocento, Roma, Carocci, 2003, pp.
133-135.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 248 03/05/2013 11:11:18
249
1. Risorgimento italiano. Naturali protagonismi di donne
Fra queste vi furono anche inglesi amiche di Vincenzo, come la scrittrice Teodo-
sia Garrow Trollope e lady Fanny Russell.
Ha data 14 febbraio 1859 una lettera di Carlotta Poerio Imbriani
33
. Essa, in
condivisione con la scelta patriottica dei familiari, da Torino rispondeva a VS con
notizie frammentarie sul fratello Carlo. Egli, rinchiuso in carceri napoletane dopo
la partecipazione attiva nel 1848 con laccusa di agire per lunit italiana, era stato
liberato il 15 gennaio 1859 con altri detenuti politici, ma con il patto di sbarcare
in America
34
. Riporto alcune frasi:
una sola lettera di Carlo mi giunta del 17 gennaio scritta da bordo al vapore
Stromboli nelle acque di S. Stefano, con la quale egli mi facea noto come il gover-
no aveva commutato le pene de ferri e dellergastolo a circa 80 condannati poli-
tici nel bando perpetuo dal regno, facendoli trasportare a Nuova Jorca (sic). Ella
da ci ben vede come il governo napoletano sa cangiare ogni maniera di grazia in
nuovi tormenti. Carlo mi prometteva di spedirmi altra lettera da Cadice; ed era
questa che io mi aspettava per iscriverle.
Come si vede, gi la convergenza familiare era una forma daiuto non proprio
passivo. Una tale forma di partecipazione ben si concili con il tempo della nor-
malit seguita al compimento dellUnit. Allora cultura e codice civile disegnaro-
no una societ decisamente patriarcale.
3. Leredit di contraddizione della naturalit.
Fra le scritture di donna dellarchivio una signora lucchese, Gaetana Del Rosso
Cotenna, che, come vedova, era vertice del suo nucleo, mostra una dedizione alla
causa patriottica di tipo radicale. Essa, che negli anni del ministero di VS si pro-
clamava pi che settuagenaria, denunciava la sordit del governo proponendosi
con una forza eccezionale e uno stile imbevuto di trecentismo toscano: Il sacco
colmo dogni maniera di rifuti. E sia. Mi viene da ridire. Che se il Danno ne
verr altrui, non gi lonta. denominato codesto Governo-Malva; ma alquanto
di Cicuta dicono vi sia mista
35
.
33 ASM, 77,7, Imbriani, Carlotta, lettera Torino 4 febbraio 1859.
34 Grazie a un avventuroso dirottamento della nave ad opera di Rafaele Settembrini (fglio di
Luigi), i detenuti politici diretti in America furono invece fatti sbarcare a Cork, in Irlanda, dove
riacquistarono la piena libert.
35 ASM, 72,6, Del Rosso, Gaetana, vedova Cotenna, lettera Monte S. Quirico presso Lucca, 19
dicembre 1860.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 249 03/05/2013 11:11:18
250
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
In uno studio successivo ho poi potuto verifcare che questa signora e il nu-
cleo dellunica fglia profusero tutto nella causa patriottica, schierate con il partito
democratico e in dimestichezza con Mazzini, Garibaldi, Dolf. Nel fondo Dolf,
appunto, presso la Domus Mazziniana di Pisa (da ora DM), ho anzi trovato un
Indirizzo poetico della signora, intitolato al 27 aprile 1859, fne del granducato.
Qui, volgendosi a un misterioso Giovin Cantore, la signora inneggiava allunio-
ne dellItalia gi vista come continuit compatta, dalle Alpi alla Sicilia
36
:
sulle incrollabili rocce sue Natura ghiacci eterni pos, meno che a baluardi, quan-
to ad imprimer fortezza ne fgli suoi Ed eruttar Etna fece e Vesuvio nelle estre-
me parti, acciocch rimontando come natura del fuoco , i cuori degli Italiani
tutti saccendessero di santo zelo damor Patrio, di bella gara dOnore e di Gloria.
Morto VS nel marzo 1861, appena dopo la proclamazione del regno dIta-
lia, losservatorio dellASM fornisce ancora informazioni, tramite i documenti del
fratello Antonio. Limpressione che il sostegno alla patria continu nella societ
unifcata, ma spegnendosi la partecipazione emotiva, mentre subentrava un disin-
canto aperto alla critica.
La posizione deflata delle donne nel nuovo stato fu lapprodo delle forze che
avevano voluto la grande riforma. Nel dibattito provocato da John Stuart Mill,
sulla formazione intellettuale delle donne, le lite culturali italiane si distinsero
per lintransigenza contro gli studi universitari delle donne
37
. Anche Isabella Ros-
si Gabardi Brocchi, gi incontrata come protagonista del Risorgimento, nonch
cattedratica presso lAccademia darte a Firenze, attu un duro sbarramento. In
un suo opuscolo del 1878, Emancipazione!
38
la donna era la fragile compagna
dellUomo:
il Creatore, che ha voluto la supremazia del maschio, e che ha posta la femmina
per aiutarlo, non per soverchiarlo. La donna graziosa, gentile, per conquistare
lamore delluomo [] Il connubio una dualit fusa in unit, la quale cos
amalgamata, compone una perfezione completa.
36 DM, Fondo Dolf, DVC 31/1. Non da escludere che il destinatario ideale sia il lucchese Giosue
Carducci.
37 Urbinati, N. Lucifero e lacqua santa. Una discussione forentina su Te subjection of women,
in Giornale critico della flosofa italiana, VI, a. LXVII, 1988, pp. 250-273.
38 Gabardi-Brocchi, I. Emancipazione!Considerazioni sui Diritti della Donna, Firenze, Arte della
stampa, 1878, qui p. 66.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 250 03/05/2013 11:11:18
251
1. Risorgimento italiano. Naturali protagonismi di donne
Pure, proprio lei aveva detto, in una lettera a VS
39
: Vorrei essere trattata da
uomo [] senza complimenti da fratello, via! [] non mi si cambia il cuore,
che batte di tuttaltro, che di ambizioncelle femminili. Ma, evidentemente, altro
la deroga per s, altro la generalizzazione. Non di rado del resto le donne hanno
interpretato la loro naturale vita come attitudine al travestimento
40
: un gioco
che la societ ha disposto da tempo nella creanza femminile, in realt tollerando
gli abiti maschili solo nei momenti delle accelerazioni e porgendo nella norma
un guardaroba caratterizzato da grazia e leggerezza.
39 ASM, 87,1, Rossi, Isabella nei Gabardi Brocchi, lettera 9 maggio 1859.
40 Guidi, L. Patriottismo femminile e travestimenti sulla scena risorgimentale, in Studi Storici, n.
2, 2000, pp. 571-587.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 251 03/05/2013 11:11:18
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 252 03/05/2013 11:11:18
2. Militanza, identit e memoria
in una famiglia napoletana di patrioti
Marcella Varriale
La casa nella quale io entrai sposa era ricca di memorie patriottiche
Sono ormai trentatr anni che io ho lonore di trovarmi fra gli accademici di
questa nostra antica e gloriosa Pontaniana dove fui ammessa ventinovenne ap-
pena, e [], pur mi sento qui come in una famiglia, divenuta cara per lunga con-
suetudine. E sento che anche voi, per vostra benevolenza, mi considerate come
sorella, sicch non mi sembra disdicevole venire a discorrere fra voi di cose per
me sacre e intime, di cose che facilmente cadrebbero nelloblio eterno se io adesso
non ne raccogliessi le vestigia che ancor me ne rimangono nella memoria come
piccoli punti luminosi fra il gran buio della dimenticanza
41
.
Il 21 marzo 1926 Enrichetta Capecelatro Carafa DAndria legge presso lAc-
cademia Pontaniana la storia della propria famiglia, una famiglia napoletana in
tempi di lotte per la libert
42
.
Dimostrare che i propri parenti hanno soferto lesilio, il carcere, la morte
utile per testimoniare lonore della propria famiglia
43
. Enrichetta in numerosi
punti dei suoi Ricordi sottolinea leroismo dei suoi: i Capecelatro, i Ranieri, i Fer-
rigni, i Carafa emergono come costruttori della patria.
41 Carafa DAndria, E. Una famiglia napoletana dellOttocento, Rieti, Biblioteca, 1928, p. 7.
42 Ivi, p. 6.
43 Porciani, I. (a cura di) Famiglia e nazione nel lungo Ottocento. Modelli, strategie, reti di relazioni,
Bologna, Viella, 2006, pp. 23-25.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 253 03/05/2013 11:11:18
254
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
La prima fgura che si incontra nella narrazione il nonno paterno di En-
richetta, Francesco Capecelatro, che impara ad amare la patria sin da bambino.
Difensore della repubblica partenopea in qualit di alfere di vascello, fautore dei
principi della rivoluzione francese, Francesco frequenta le vendite dei carbonari
e ad abbraccia le idee liberali. Durante i moti del 1821, accusato di tradimento
nei confronti del Re, costretto allesilio. Nel 1830, salito al trono Ferdinando II,
tolto il sequestro dei suoi beni, ritorna a Napoli insieme a sua moglie, Maddalena
Santorelli
44
, e ai suoi fgli, che educa in nome delle dottrine liberali. La casa di
Napoli e la villetta di San Paolo Belsito diventano ritrovo di letterati e di musicisti
ma soprattutto di liberali. Protagonista dei moti del 15 maggio 1848, Antonio,
padre di Enrichetta, cospira segretamente e lavora per la libert del proprio Paese:
nel 1859 sar arrestato
45
.
Il processo di nazionalizzazione importante per le famiglie borghesi, le quali
possono dimostrare attraverso la partecipazione al nation building, la loro presenza
alla vita della nazione. Loperazione di Enrichetta pu essere ascritta dunque a
questa volont di attribuire un ruolo preciso alla sua famiglia. Lo stesso matrimo-
nio con Riccardo Carafa sembra ideologicamente inserirsi in questo processo di
unione tra due nuclei familiari attivi nelle lotte risorgimentali. La famiglia Carafa
annovera infatti illustri martiri politici
46
.
Da una generazione allaltra valori liberali e nazionali si susseguono attraver-
so matrimoni tra famiglie attive nel processo risorgimentale. Lunione tra i due
discendenti di famiglie patriote emerge come il presupposto per la conservazione
della nazione. Lamore romantico sintreccia allamore patriottico. Amore-onore-
virt costituiscono una delle fgure profonde del discorso nazionalista. Lessenza
di una nazione consiste nella presenza di una linea genealogica che va conservata
e protetta
47
.
Grazie allamour passion, il matrimonio tra Enrichetta e Riccardo pu testi-
moniare lonore patriottico e la virt eroica di due famiglie partecipi delle lotte
nazionali. A Enrichetta spetta il compito di consegnare alle future generazioni i
ricordi e, attraverso questi, di riscattare lonore familiare. Enrichetta sposa luomo
che lei ha scelto, che fglio di eroi del Risorgimento italiano. In questo modo ri-
44 Donna energica e attiva, madre forte e pronta ad allattare i suoi fgli, moglie prodiga a seguire il
marito nel suo esilio e ad appoggiare le sue speranze politiche, anche lei annovera nella sua famiglia
martiri politici: suo zio Antonio Santorelli, ricercato come giacobino sar scannato al ponte della
Maddalena. Ivi, pp. 9-10.
45 Carafa DAndria, E. Una famiglia cit., pp. 6-22.
46 Carafa DAndria, E. Ricordi forentini, romani, napoletani, BNN, ms XX-2, pp. 186-187.
47 Banti, A.M.; Ginsborg, P. (a cura di) Storia dItalia. Annali 22. Il Risorgimento, Torino, Einaudi,
2007, pp. XXX-XXXII.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 254 03/05/2013 11:11:18
255
2. Militanza, identit e memoria in una famiglia napoletana di patrioti
spetta la tradizione familiare che ha legato in matrimonio sempre personaggi attivi
nel processo di costruzione di unItalia libera e unita
48
.
Io sono stata, sono e sar sempre sinistra
Nella stessa notte in cui viene arrestato Antonio Capecelatro, gli agenti di polizia si
recano in casa di Giuseppe Ferrigni, nonno materno di Enrichetta. La narrazione
dei Ricordi di Enrichetta Carafa segue ora le vicende di casa Ferrigni, anchessa fo-
colare di idee rivoluzionarie. Al fanco di Giuseppe emerge la fgura di sua moglie
Enrichetta Ranieri sorella di Antonio Ranieri donna energica e astuta: grazie a
lei Giuseppe riesce a sottrarsi dalla cattura della polizia
49
.
Animatrice del salotto del marito, ella fa gli onori di casa e prende parte alle
discussioni politiche
50
. Il salotto Ferrigni raccoglie infatti le fgure pi interessanti
dellintellighenzia del tempo e spicca per il suo carattere liberale
51
. Dunque si pu
avanzare lipotesi che in questo laboratorio politico e letterario Enrichetta forgi la
propria ideologia liberale.
Durante la spedizione dei Mille Enrichetta vive giornate di trepidante attesa:
cuce di notte bandiere tricolori che sventoleranno poi in tutto il quartiere allar-
rivo di Garibaldi, leroe delle sue speranze e della sua aspettazione
52
. Raccoglie,
inoltre, sottoscrizioni per donare, insieme ad altre donne napoletane, una ricca
tenda da campo al primo e un fnimento di corallo al secondo. Al fanco di suo
marito, di Antonio e di Paolina Ranieri si reca a Grottammare per rendere omag-
gio al nuovo re dItalia
53
. La posizione politica di Enrichetta Ranieri Ferrigni si
delinea in diverse lettere che indirizza al fratello Antonio:
48 Cfr. Sodini, E. Il buon nome della famiglia e lamore per la patria: Felicita Bevilacqua e la lotteria
patriottica, in Famiglia e nazione, pp. 107-129.
49 Carafa DAndria, E. Una famiglia napoletana cit., pp. 24-25.
50 Villari, L.A. Cenni e ricordi di Giuseppe Ferrigni, Napoli, Di Gennaro, 1895, pp. 37-38.
51 Sul salotto di Giuseppe Ferrigni cfr. Balzerano, A. Giuseppina Guacci Nobile nella vita, nellarte,
nella storia del Risorgimento, Napoli, Di Mauro, 1975, pp. 51-52; Cione, E. Napoli Romantica 1830-
1848, Napoli, Morano, 1957, p. 23; Doria, G. Salotti napoletani dellOttocento, in Aa. Vv., Tiempe
belle e na vota, Napoli, Associazione napoletana per i monumenti e il paesaggio, 1982, p. 17.
52 Carafa DAndria, E. Una famiglia napoletana cit., p. 32.
53 Anche la fgura di Paolina passata alla storia come la suora di carit di Giacomo Leopardi
risulta interessante per il suo sostegno alla causa patriottica. Durante le battaglie del 1860 e del
1866 raccoglie ad esempio denaro, flacce, tele e pannilini da inviare negli ospedali militari. Odo-
ardo Valio, La suora di carit di Giacomo Leopardi, Acerra, Fiore, 1896. BNN, Carte Ranieri, B
22/299, Lettera di Francesco Casotti a Paolina Ranieri, Lecce 9 Ottobre 1860; BNN, Carte Ranieri,
B 64/321, Lettera di Bernardo Nolli a Paolina Ranieri, Napoli 25 Giugno 1866.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 255 03/05/2013 11:11:18
256
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
Mi ha fatto immenso dolore, dopo aver sospirato unintera vita di non essere
stata a Roma il giorno dellapertura del primo Parlamento Italiano, e ci per con-
seguenza delle gravissime disgrazie soferte Io sono stata, sono e sar sempre
sinistra, perch nella sinistra spero la salute dellItalia
54
.
Fautrice della Sinistra, cio di quella parte politica che risponde al malcon-
tento delle genti del Sud per nulla ascoltate dalla Destra storica
55
, in pi occasioni
invita Antonio a scriverle di politica: lui, deputato al Parlamento, pu aggiornarla
con maggiore precisione.
Il desiderio di politicare con il fratello compare in varie lettere: Enrichetta
vuole confrontarsi con lui e conoscere le sue opinioni. Lentusiasta patriota guarda
con occhi pi obiettivi alla situazione dellItalia unita: lo slancio nazionalistico
cede il passo alla descrizione del disagio popolare e alla delusione politica
56
.
Cittadina senza cittadinanza
57
, Enrichetta si mostra molto delusa dellope-
rato dei politici italiani, divisi tra loro e protesi a accontentare i propri interessi.
La critica volta a uno Stato incapace di fronteggiare i problemi del Mezzogiorno.
Limmagine di Enrichetta Ranieri come patriota attiva nelle lotte per la costru-
zione dellItalia conferma che nel processo di nation building coinvolta lintera
famiglia: donne e uomini. La sfera pubblica risulta intrecciata con quella domestica
e privata. Attraverso le vicende di queste famiglie di patrioti si pu constatare
come le relazioni di genere connotino la storia del nostro Risorgimento e i Ricordi
di Enrichetta Carafa DAndria si presentano come una storia di genere del lungo
Ottocento italiano.
Io purtroppo! non mi sentivo lanima eroica
I Ricordi frmati da Enrichetta Carafa si dilatano dallesperienza personale a quella
familiare intrecciandosi con eventi e fatti del Risorgimento italiano: dalla rivolu-
zione partenopea alla Grande Guerra. Enrichetta cuce i racconti a lei narrati con
i suoi ricordi. Gran parte del suo scritto infatti raccoglie aneddoti e vicende tratte
da fonti orali: la nonna Enrichetta, la madre Calliope e il padre Antonio. Le sue
memorie assolvono a un duplice ruolo:
54 BNN, Carte Ranieri, B 51/342, Lettera di Enrichetta Ranieri Ferrigni ad Antonio Ranieri, Na-
poli 3 Dicembre [s. a.].
55 Romanelli, R. LItalia liberale. 1861-1900, Bologna, Il Mulino, 1979, pp. 186-187.
56 BNN, Carte Ranieri, B 46/112, Lettera di Enrichetta Ranieri Ferrigni ad Antonio Ranieri, Napoli
[1869].
57 Fruci, G.L. Cittadine senza cittadinanza. La mobilitazione femminile nei plebisciti del Risorgi-
mento (1848-1870), in Genesis, V/2, 2006, pp. 21-55.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 256 03/05/2013 11:11:18
257
2. Militanza, identit e memoria in una famiglia napoletana di patrioti
celebrare lonore patriottico della sua famiglia
trasmettere ai nipoti e alle future generazioni modelli comportamentali.
I Ricordi di Enrichetta non hanno il fne manzoniano del narrar se stessi
58
, ma
delineano un racconto familiare nel periodo storico del Risorgimento. Enrichet-
ta colloca la storia familiare nellambito della storia nazionale. La sua rilettura del
Risorgimento avviene alla luce del vissuto della propria famiglia e di una fazione
importante della nazione: la corrente liberale. Lopera si chiude con limmagine di
Enrichetta anziana: una nonna che aspira a diventare bisnonna
59
. Appare cos
chiara la seconda funzione che Enrichetta vuole assolvere: conservare e tramandare
la memoria familiare ai propri discendenti. Lautrice si presenta come anello di con-
giunzione tra le generazioni passate e quelle future. In primo luogo come depositaria
delle memorie familiari, cerca di salvare queste ultime dalloblio. In secondo luogo
come educatrice delle generazioni successive, propone paradigmi comportamentali
di fgure, in particolare femminili, che hanno lottato per la libert.
Durante il periodo del nation building la presenza di donne risulta molto atti-
va nella sfera pubblica: il modello di madre incarna valori quali abnegazione di s,
sostegno ai mariti e ai fgli, patriottismo. La Grande Guerra chieder una missione
ancora pi grande: il sacrifcio diventer maggiore poich si inviteranno le donne
a non ostacolare la partenza di fgli e/o di mariti
60
.
Enrichetta riconosce il suo ruolo di custode delle memorie familiari: alle madri
patriottiche af dato il compito di educare i fgli e i nipoti alla patria. Per assolvere
questa missione, Enrichetta propone uomini e donne della propria famiglia come
modelli di sacrifcio e di lotta
61
. Fornisce inoltre unimmagine di moglie e di madre
che rispecchia le esigenze coeve. Il sacrifcio al quale chiamata allo scoppio delle
guerre le impone di non mostrare alcuna soferenza sul proprio volto
62
.
Se Riccardo riassapora lebbrezza della guerra che ha vissuto negli anni passati,
Enrichetta sofoca le sue inquietudini sotto una fttizia tranquillit. Allallegria del
marito che prepara i bagagli si contrappone il dolore della moglie. Il cuore [le]
58 Betri, M.L.; Maldini Chiarito, D. (a cura di) Scritture di desiderio e di ricordo. Autobiografe, diari,
memorie tra Settecento e Novecento, Milano, FrancoAngeli, 2002.
59 Carafa DAndria, E. Ricordi forentini, romani, napoletani, in Fiorentino, G. (a cura di) Ricordi
napoletani. Uomini, scene, tradizioni antiche 1850-1920, Napoli, Electa, 1991, p. 64.
60 Cfr. Guidi, L. Un nazionalismo declinato al femminile. 1914-1918, in Guidi, L. (a cura di)
Vivere la guerra. Percorsi biografci e ruoli di genere tra Risorgimento e primo confitto mondiale, Napoli,
ClioPress, 2007, pp. 93-118.
61 Porciani, I. Storiche italiane e storia nazionale, in Palazzi, M.; Porciani, I. (a cura di) Storiche
di ieri e di oggi. Dalle autrici dellOttocento alle riviste di storia delle donne, Roma, Viella, 2004, pp.
51-66.
62 Carafa DAndria, E. Ricordi forentini, romani, napoletani, in Ricordi napoletani cit., p. 61.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 257 03/05/2013 11:11:18
258
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
si stringeva, ma non contrasta le decisioni prese
63
. Alla donna non si chiede che
di tacere. Limpossibilit di dar voce al proprio stato danimo dettata da un
senso di pudore nellesprimere il proprio dolore personale, che appare poca cosa
di fronte a quello di migliaia di mogli e di madri
64
.
Il patriottismo della madre risorgimentale acquista dunque una nuova ve-
ste. La donna partecipa alla vita pubblica non pi soltanto ricamando bandiere
ma addirittura sacrifcando il proprio fglio alla patria
65
. Enrichetta Ranieri cuce
bandiere, presenzia alle riunioni liberali nel salotto di casa, rende salva la vita del
marito fervente patriota , coinvolge altre donne in attivit di propaganda. Sua
nipote, come chiede la retorica del tempo, sacrifca il marito e il fglio
66
.
Una trasmissione dunque di valori patriottici: da madre a fglia
67
di una cate-
na genealogica che coinvolge donne e uomini. Il valore della patria, lonore della
nazione
68
viaggiano attraverso il flo di una memoria non solo maschile, ma so-
prattutto femminile.
Com caro ricordare, e amar sempre, e mantener viva la memoria
di chi merita di essere onorato dai posteri!
Allindomani dellUnit si avvia un discorso di sacralizzazione politica col quale si
vuole dimostrare e ricordare il sacrifcio adempiuto dagli eroi del Risorgimento:
molte scrittrici raccolgono le memorie degli eroi del processo risorgimentale. Nel
fondo Antonio Ranieri
69
ci simbatte in uninteressante fgura femminile: Cesira
Pozzolini Siciliani, salonnire e scrittrice forentina
70
.
63 Ivi, p. 62.
64 Gibelli, A. Lof cina della guerra, Torino, Bollati Boringhieri, 2007.
65 Porciani, I. La festa della nazione. Rappresentazione dello Stato e spazi sociali nellItalia unita,
Bologna, Il Mulino, 1997, p. 93.
66 Il fglio di Enrichetta parte nella primavera del 1915 in qualit di sotto-tenente di cavalleria.
Carafa DAndria, E. Ricordi forentini cit., pp. 61-62.
67 Rascaglia, M. Da madre a fglia: percorsi ottocenteschi del sapere di genere, in Guidi, L. (a cura
di) Scritture femminili e Storia, Napoli, ClioPress, 2004, pp. 173-190.
68 Cfr. Banti, A.M. Lonore della nazione. Identit sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal
XVIII secolo alla Grande Guerra, Torino, Einaudi, 2005.
69 Il fondo conservato presso la Sezione Manoscritti e Rari della Biblioteca Nazionale di Napoli,
formato da circa centocinquantamila pezzi e diviso in centocinquanta buste, si presenta come un
vasto archivio privato nel quale il notabile raccoglie documenti e scritti che ricoprono un lungo arco
cronologico, dagli anni Venti agli anni Ottanta dellOttocento.
70 Delle lettere di Cesira conservate presso la Sezione Manoscritti della Biblioteca Nazionale di Na-
poli, la prima, in ordine cronologico, datata Firenze 3 Maggio 1879 e lultima Firenze 15 Marzo
1887. Sulla fgura di Cesira cfr. Signorini, M.A.; Visconti, A. Il salotto di Gesualda e Cesira
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 258 03/05/2013 11:11:18
259
2. Militanza, identit e memoria in una famiglia napoletana di patrioti
Nel 1879 Cesira avvia il suo colloquio epistolare con Antonio Ranieri per
intercessione di Atto Vannucci. Le prime lettere che Cesira e Antonio si scrivono
afrontano tematiche letterarie. Nel 1880, Cesira d notizia della pubblicazione
della sua opera Napoli e dintorni. Impressioni e ricordi. Lopera si chiude con il ca-
pitolo Una visita a Luigi Settembrini. Il viaggio a Napoli non sembra motivato
solo dallinteresse di conoscere una citt ricca di storia e di arte, ma soprattutto
dalla possibilit di incontrare alcuni dei martiri del nostro Risorgimento, tra i
quali Luigi Settembrini
71
.
Una sincera venerazione per i patrioti italiani spinge la scrittrice a entrare in
contatto con illustri protagonisti del processo di nazionalizzazione italiana, quali
Antonio Ranieri e Atto Vannucci. Alla morte di questultimo, il desiderio di Cesi-
ra di raccogliere tutte le lettere chegli ha scritto o ricevuto rientra nel progetto di
dar spazio nel martirologio italiano a quanti si sono segnalati per il loro eroismo.
Depositaria delle memorie di Atto Vannucci che le ha lasciato in eredit tutte
le lettere ancora una volta una donna viene additata come perfetta custode di
memorie storiche Cesira si adopera con fervente zelo a catalogare lintera corri-
spondenza. Alcune lettere le pubblica per qualche giornale: in particolare una che
risveglia gli animi patriottici, nella quale Atto Vannucci narra a Teresa Kramer
alcuni momenti signifcativi del processo di unifcazione. Pagine della storia italia-
na elaborate dagli stessi protagonisti si ofrono come testimonianze della parteci-
pazione di massa al Risorgimento. Le parole di questi eroi vanno quindi, secondo
Cesira, non solo raccolte e custodite, ma anche divulgate af nch la memoria del
passato proponga modelli alle generazioni future.
La fgura di Cesira emerge dallo scambio epistolare con Antonio Ranieri in
qualit di storica. Attraverso la sua attivit salva dalloblio unulteriore testimo-
nianza della storia del nostro Paese e d voce al Risorgimento. Inoltre Cesira par-
tecipa, negli anni postunitari, a quel processo di creazione di una religione politica
che vuole ofrire paradigmi comportamentali proponendo tutti gli eroi che nel
Risorgimento hanno sacrifcato la propria vita per la libert dellItalia.
Gli scritti di Enrichetta Carafa e Cesira Siciliani mostrano che in Italia la
narrazione dei fatti avviene anche per mano democratica e coinvolge le donne.
Il riordino delle memorie degli eroi e dei martiri dellUnit avviene attraverso
un lavoro di cura femminile
72
. Entrambe le storiche pervengono al medesimo
fne: costruire la memoria storica nazionale e tramandarla alle future generazioni.
Pozzolini nella Firenze del 1859 in Betri, M.L.; Brambilla, E. (a cura di) Salotti e ruolo femminile in
Italia tra fne Seicento e primo Novecento, Venezia, Marsilio, 2004, pp. 381-403.
71 Pozzolini, C. Napoli e dintorni. Impressioni e ricordi, Napoli, Morano, 1880, pp. 299-300.
72 Porciani, I. Disciplinamento nazionale e modelli domestici nel lungo Ottocento: Germania e
Italia a confronto, in Storia dItalia cit., pp. 97-125.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 259 03/05/2013 11:11:18
260
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
Ancora una volta le donne, escluse dal mondo pubblico, cittadine a met, ma
tuttavia mogli e madri, viaggiatrici e scrittrici, assolvono il ruolo di raccogliere le
vestigia del passato. Sono loro che tutelano lonore maschile e quello femminile
dal mondo delloblio.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 260 03/05/2013 11:11:18
3. Il Mezzogiorno e la Questione meridionale
negli scritti di Cristina Trivulzio di Belgiojoso
Karoline Rrig
Cristina Trivulzio di Belgiojoso (1808-1871) nata, cresciuta e per lunghi periodi
della sua esistenza anche residente a Milano
73
, era una donna del nord. Non co-
nosceva molto bene il Mezzogiorno e i suoi problemi, o comunque solo attraverso
esperienze personali. Solo due volte si rec nel sud dItalia: la prima nel 1829 dopo
la separazione dal marito, principe Emilio di Belgiojoso, per le cure a Ischia. Il
secondo soggiorno fu determinato dal Quarantotto: da inizio febbraio fno a fne
marzo di quellanno fu a Napoli, impegnata come giornalista, consulente politi-
ca e coordinatrice della spedizione militare di un gruppo di volontari napoletani
determinati a combattere nella guerra di liberazione nel Nord. Una storiografa
piuttosto romanzesca ha ricordato come la principessa a capo di questo gruppo
part per Milano dove furono accolti e festeggiati con entusiasmo. Pi importante
tuttavia ricordare che questo secondo soggiorno e il contatto personale e diretto
con la vita e la popolazione di Napoli lasciarono una forte impronta sulla sua
visione del Mezzogiorno.
Le descrizioni e analisi dellItalia meridionale di Cristina di Belgiojoso si ba-
sarono, oltre che su queste esperienze e osservazioni personali, maggiormente su
cose udite o su letture. Troviamo quindi nei suoi scritti molti clich e stereoti-
pi difusi allepoca nellopinione pubblica europea, come il Lazzarone barbaro e
nullafacente o il brigante cattivo. Tra gli amici e i colleghi della principessa vi
73 Per una bibliografa ampia e attuale su questo personaggio cfr. Introduzione in Fugazza, M.;
Rrig, K. (a cura di) La prima donna dItalia. Cristina Trivulzio di Belgiojoso tra politica e giorna-
lismo, Milano, FrancoAngeli, 2010.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 261 03/05/2013 11:11:18
262
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
erano per anche persone originarie del sud come Giuseppe Massari (Taranto)
o Antonio Ranieri (Napoli) con le quali, discorrendo o corrispondendo, poteva
trattare la situazione attuale del Mezzogiorno, la sua storia e la sua cultura. Grazie
a queste conversazioni e scambi di idee con persone ben informate e testimoni
oculari, riusc ad approfondire ulteriormente le sue conoscenze, sviluppando una
consapevolezza profonda della mentalit meridionale e sui problemi del sud, sulle
loro radici, sulle dinamiche e sulle connessioni.
Nonostante questa sua sensibilit e il suo indubbio interesse, se analizziamo
linsieme dei suoi scritti appare chiaro che Cristina di Belgiojoso non dedic mol-
to spesso la sua attenzione allargomento. Nessuna delle sue monografe gi di
per s non numerose e solo pochi articoli redatti per la stampa erano dedicati al
meridione. Il corpus di testi da esaminare perci assai ristretto: si tratta di alcuni
capoversi di una serie di articoli del 1846 comparsi sulla rivista parigina LAusonio,
fondata e diretta dalla principessa, e intitolati Sullo stato attuale dellItalia
74
,
dellopuscolo Ai suoi concittadini. Parole pubblicato nella primavera del 1848 a
Milano
75
, qualche articolo degli anni 1860 e 1862 per il giornale italo-francese
LItalie. Journal politique quotidien
76
e alcuni brani delle Osservazioni sullo stato
attuale dellItalia e del suo avvenire del 1868
77
. Oltre a questi scritti di interesse
qualche articolo non frmato, apparso sempre sulla rivista LAusonio tra il 1846 e
il 1848
78
. poco probabile che fossero scritti dalla Belgiojoso, ma si pu partire
74 Questa serie comprendeva in tutto quattro articoli, non recanti alcun titolo particolare, tranne lul-
timo: art. I, in LAusonio, vol. I, n. 1, 1846, pp. 5-20; art. II, ibidem, vol. I, n. 2, 1846, pp. 77-87;
art. III, ibidem, vol. I, n. 3, pp. 161-180; art. IV (Condizione del basso popolo dellItalia superiore),
ibidem, vol. I, n. 4, pp. 241-255.
75 Trivulzio, C. Ai suoi concittadini. Parole, opuscolo in due parti: parte I, Milano, Tipografa Valen-
tini, 1848, parte II, Milano, tipografa Luigi di Giacomo Pirola, 1848. Riprodotto in Fugazza, M.;
Rrig, K. (a cura di) Cristina Trivulzio di Belgiojoso tra politica e giornalismo cit. Essendo il nostro
volume ancora in corso di pubblicazione allatto di scrivere questo testo, cito qui dalloriginale.
76 Giornale fondato a Milano nel 1860 da Constant Victor Jaccottet. C.di Belgiojoso collaborava con
LItalie dal 1860 al 1865. Cfr. Rrig, K. Cooperare al progresso de veri principii di libert, di in-
dipendenza e di nazionalit. Professione e prassi giornalistica di Cristina Trivulzio di Belgiojoso, in
Conti Odorisio, G.; Giorcelli, C.; Monsagrati, G. (a cura di) Cristina di Belgiojoso. Politica e cultura
nellEuropa dellOttocento, Napoli, Lofredo Editore, 2010.
77 Trivulzio di Belgiojoso, C. Osservazioni sullo stato attuale dellItalia e sul suo avvenire, Milano,
Vallardi, 1868.
78 Della odierna moralit politica delle Due-Sicilie, articolo in quattro parti: art. I, in LAusonio,
vol. III, n. 15, 1847, pp. 17-29; art. II, ibidem, vol. III, n. 16, 1847, pp. 97-114; art. III, ibidem, vol.
III, n. 17, pp. 209-221; art. IV, ibidem, vol. III, n. 18, 1847, pp. 289-304. Larticolo reca la frma
S.D., ma fnora non stato possibile identifcare con certezza lauthorship. Franco Della Peruta lo
attribuiva a Giuseppe De Simone, cfr. Id., Il giornalismo dal 1847 allunit, in Galante Garrone,
A.; Della Peruta, F. La stampa italiana del Risorgimento, in Castronovo, V.; Tranfaglia, N. (a cura di)
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 262 03/05/2013 11:11:18
263
3. Il Mezzogiorno e la Questione meridionale negli scritti di Cristina Trivulzio di Belgiojoso
dal presupposto che siano stati sottoposti al suo vaglio, perch abitualmente tutti
gli articoli proposti alla redazione dovevano essere sottoposti al giudizio della di-
rettrice della rivista per ottenere il suo consenso e il permesso alla pubblicazione.
Da questi testi, che qui per motivi di spazio non possono essere analizzati per
esteso, sorge unimmagine del Mezzogiorno coniata su giudizi e stereotipi molto
difusi allepoca, ma questo non stupisce afatto. Sin dagli studi di Nelson Moe
e Marta Petrusewicz, risalenti alla fne degli anni Novanta, si parla del carattere
composito e complesso della Questione Meridionale, che viene concepita come
una rappresentazione costruita, una costruzione dellimmaginario, il cui signif-
cato cangiante e dipende dal punto di vista dellosservatore, al di l dei fatti
79
.
Condizioni economiche e sociali diverse, ragionamenti politici pi vari, esperienze
e interessi personali, tutto poteva infuenzare il discorso sul Meridione e determi-
nare immagini e giudizi. Cristina di Belgiojoso e i suoi scritti sinseriscono perfet-
tamente in questo quadro. Come scrittrice e giornalista assai celebre (e non meno
contestata) partecip anche se non in prima linea, dato che scelse altri focus nel
suo operare propagandistico e politico alla costruzione e divulgazione dellim-
maginario del Sud.
In questo contesto importante ricordare che, a esclusione delle Parole del
1848, tutti i suoi scritti sopra segnalati venivano pubblicati e distribuiti in Francia
e alcuni di essi, come gli articoli per LItalie o le Osservazioni, anche in lingua
francese
80
. Anche se sappiamo ancora poco sulla ricezione delle opere della Bel-
giojoso in Francia, possiamo ipotizzare che infuenzassero notevolmente lidea che
il pubblico francese si faceva dellItalia. Parlando del rapporto della Belgiojoso con
la Francia dobbiamo ricordare inoltre che la principessa, esiliata a Parigi nel 1831,
visse bench non ininterrottamente quasi la met della sua vita nella capitale
francese, ed fuori dubbio che questo infuenz il suo scrivere sullItalia. Cristina
Trivulzio non era semplicemente una donna del nord, ma per modi di pensare
Storia della stampa italiana, vol. II, Roma, Bari, Laterza, 1978, pp. 247-542, p. 251.
Tra settembre 1847 e febbraio 1848 in una rubrica intitolata Histoire contemporaine LAusonio
pubblicava regolarmente contributi dedicati agli eventi e sviluppi attuali nel Royaume des Deux
Siciles. Di particolare interesse il contributo dellottobre 1847 che rispetto alle altre cronache pi
analitico. Ibidem, vol. IV, n. 5, 1847, pp. 140-151.
Altrettanto interessante e simile nelle sue argomentazioni un articolo in due parti intitolato Dernire
insurrection des Deux Siciles, ibidem, vol. IV, n. 11, 1847, pp. 358-360; n. 12, 1847, pp. 361-373.
79 Cfr. Petrusewicz, M. Come il Meridione divenne una questione. Rappresentazioni del sud prima e
dopo il Quarantotto, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino, 1998, Introduzione, p. 13; Moe,
N. Representing the south in post-unifcation Italy, 1860-1880, Baltimore, Md., John Hopkins Univ.,
Diss., 1994.
80 Trivulce de Belgiojoso, C. Rfexions sur ltat actuel de lItalie et sur son avenir, Paris, A. Lacroix
Verboeckhoven et C.ie, 1869.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 263 03/05/2013 11:11:18
264
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
e di scrivere anche una dama francese. Lo confermava lei stessa in una lettera a
Niccol Tommaseo: Ho cominciato a pensare, a studiare, a fare in Francia. Ivi
la mia qualunque siasi mente ha principato a ricevere, a custodire, a produrre
81
.
Bench fosse una patriota italianissima, in momenti cruciali della sua lotta
politica, quando si sentiva mal compresa, difamata o attaccata, questa sua duplice
identit come Italiana e Francese par choix le serviva come scudo e la aiutava nel
prendere le distanze dai suoi connazionali, non solo dai meridionali, ma anche dai
settentrionali. Lo vediamo nelle sue ripetute critiche alla mentalit municipalista
degli Italiani e delle lotte partitiche tra di loro, nei suoi incessanti appelli alla coe-
sione nazionale e al senso comune. In tali polemiche la principessa assumeva spesso
molteplici ruoli: a volte impersonava lItaliana remissiva e disponibile a collaborare
con i suoi connazionali per rimediare ai malanni accumulatisi in pi secoli di do-
minazione straniera e di cattiva amministrazione e per istaurare un nuovo Stato na-
zionale e un governo legittimo e probo; in altre occasioni invece, sopratutto quando
voleva sottolineare i guai e le debolezze del suo popolo, si comportava come osserva-
trice straniera, una straniera in patria, supponendo di stare al di sopra delle parti,
di guardare le cose italiane con occhio spassionato e di avere quindi giudizi meno
parziali e pi autorevoli rispetto agli italiani, soprattutto quelli rimasti in patria, che,
secondo lei, si stavano esaurendo con le loro liti e invidie.
Questo gioco con ruoli diversi, questo alternante schierarsi con o contro gli
Italiani tipico della produzione politico-propagandistica di Cristina Trivulzio di
Belgiojoso e lo troviamo anche nel suo discorso sul Meridione. indubbio che
nelle sue descrizioni del Mezzogiorno e nei suoi giudizi sulla sua societ non si
distingueva molto dal discorso predominante condannava il malgoverno dei
Borbone e i mali caratteristici della societ meridionale come il clientelismo,
unamministrazione disorganizzata e inef cace, gli abusi di potere e la corruzione;
stigmatizzava laristocrazia meridionale come oziosa, egoista, amorale, esausta e
incapace di adempiere a responsabilit di governo; sulla nobilt napoletana espri-
meva spesso giudizi totalmente negativi:
Dessa non ricevette alcuna educazione, n istruzione politica; non in relazione
cogli uomini di Stato delle nazioni estere; non legge di queste nazioni n i fogli
quotidiani, n i libri, n gli opuscoli; non medit sulle gravi questioni che inte-
ressano lesistenza politica dei popoli, i loro diritti, i loro doveri, ma nacque nel
lusso, crebbe nellozio, vive nellignoranza e nel godimento dignobili piaceri
82
.
81 C. Belgiojoso a Niccol Tommaseo, Locate, 3 gennaio 1842. Biblioteca Nazionale di Firenze,
Carte Tommaseo, 54,20, no. 11.
82 Trivulzio, C. Ai suoi concittadini. Parole cit., fascicolo 2, pp. 18-19.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 264 03/05/2013 11:11:18
265
3. Il Mezzogiorno e la Questione meridionale negli scritti di Cristina Trivulzio di Belgiojoso
Accusava i possidenti delle campagne di essere frivoli, viziosi, nullafacenti
e boriosi, e di sfruttare in modo sfacciato i contadini, che a loro volta sarebbero
stati completamente rozzi, ignoranti e succubi dei loro padroni; con una certa
simpatia considerava invece i Lazzari, che aveva avuto occasione di conoscere e
studiare personalmente nel 1848, e che venivano rappresentati come selvaggi,
completamente ignoranti, ma intelligenti e simpatici: Chi non conosce quella
razza strana e direi quasi misteriosa che viene distinta col signifcante nome di
Lazzari? Razza che vive nel mezzo della civilt come vivrebbe in mezzo a boschi
deserti. N il vestire, n labitare in case, n il raccogliersi in famiglie, n alcuno
di quei costumi che costituiscono il primo stadio della civilt, non furono dai
Lazzari adottati
83
.
Ventanni dopo, nelle Osservazioni, constatava che il tipo Lazzarone era spa-
rito quasi completamente dalle strade napoletane e che il popolo napoletano si
comportava molto civilmente: Desso ha accettato le leggi, i regolamenti, le istitu-
zioni, i decreti che gli furono imposti, sottomettendosi al peso e agli inconvenienti
degli uni, e cavando vantaggi da altri con una spontanea docilit, e una costante
prudenza che da lui non si aspettava
84
.
Con queste descrizioni e giudizi, davvero poco lusinghieri, Cristina di Bel-
giojoso appare palesemente come una donna del Nord che non ha grande consi-
derazione dei meridionali; daltro canto la sua duplice identit, il suo essere stra-
niera in patria, la induceva a intrecciare nei suoi pareri anche floni di critica nei
confronti dei Settentrionali i quali non concepiva certo come cittadini perfetti.
Anzi, non risparmi mai nei loro confronti critiche altrettanto aspre. Parlando
dei difetti dei meridionali e della loro societ intendeva quindi ricordare ai suoi
connazionali le loro imperfezioni e i loro compiti. Nelle sue Osservazioni del 1868
lanciava per esempio il seguente appello: Ora spetta a tutti coloro che si sentono
superiori alle basse passioni del volgo e capaci di cooperare fosse pure menoma-
mente alla riforma di uno stato sociale cos miserabile e vergognoso, il concertarsi
fra di essi, e il dedicarsi a s nobile e cosi sacrosanta impresa
85
.
Nelson Moe ha sottolineato giustamente che il discorso sullunit italiana
coesisteva con un discorso sulla disunit, of which the persistent articulation of
southern Italys diference was a central feature, ma, come vorrei evidenziare, non
era lunico elemento distintivo
86
. Si gi detto che Cristina Trivulzio nellinsieme
della sua produzione non ha prestato molta attenzione alla Questione meridiona-
83 Ivi, p. 17
84 Trivulzio di Belgiojoso, C. Osservazioni cit., p. 12.
85 Ivi, p. 20.
86 Cfr. Moe, N. Representing the south cit., p. 72.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 265 03/05/2013 11:11:19
266
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
le, ma quando ne parla sembra farlo quasi pi come spunto per criticare i cittadini
del nord, che per degradare i meridionali. Il suo discorso sulla disunit, ovvero il
suo parlare del Meridione, si colloca quindi prevalentemente come discorso mora-
le nel quale distinguere tra italiani buoni o cattivi.
Gli articoli pubblicati sul giornale italo-francese LItalie in questo senso sono
signifcativi. In pi articoli dellautunno 1860, per esempio, la principessa discusse
della Spedizione dei Mille, criticando aspramente liniziativa dei Garibaldini per-
ch era convinta che mescolando obiettivi politici con richieste sociali si metteva
a rischio lUnit dItalia
87
. La Belgiojoso, favorevole a riforme sociali sin dai suoi
primi contatti con il mondo e il pensiero socialista degli anni Trenta a Parigi
88
, non
dubitava che le richieste dei repubblicani fossero legittime; ma era dellavviso che
prima si dovesse risolvere la questione politica e realizzare lunifcazione del paese
e poi afrontare la questione sociale con la dovuta attenzione e maggior ef cacia.
Rimproverava a Garibaldi e ai suoi di arrter llan national et politique, di far
perdre un temps prcieux e di seminare des germes de discordes. In questo
caso la parte dei cattivi era quindi attribuita ai repubblicani, mentre a Nous au-
tres Italiens era riservata quella dei bravi e buoni. Di conseguenza, la Belgiojoso
giudicava cosa giustissima che il governo italiano, rappresentante e custode degli
Italiani buoni, intervenisse energicamente per fermare la Spedizione
89
.
Dopo il plebiscito del 21 ottobre la giornalista si mostr soddisfatta, ma an-
che preoccupata delladesione, dubitando che i Napoletani, cosi come tutti i me-
ridionali, potessero cambiare improvvisamente e superare i loro difetti. Avvertiva
la possibilit che lannexion de cette partie de lItalie nous sera plutt une charge
quune acquisition. Riscrivendo i suoi lavori sul Quarantotto, present di nuovo
la teoria secondo la quale i Napoletani, non importa di quale classe sociale, non
erano suf cientemente preparati ed educati per afrontare una qualsiasi respon-
sabilit politica. Secondo lei, non si poteva aspettare di trovare in essi ce dvou-
ement infatigable au succs dune ide, ce bon sens pratique, cette modration,
cette conscience, ce respect pour tout droit et toute justice, cette parfaite entente
des questions les plus compliques, cet abandon des intrts individuels, des habi-
tudes et des agrments de la vie
90
.
87 Sul suo rapporto con Garibaldi vedi la voce Cristina Trivulzio di Belgiojoso di Karoline Rrig in
Dizionario delle interpretazioni di Giuseppe Garibaldi, a cura di Lauro Rossi, in corso di pubblicazione.
88 Cfr. Santonastaso, G. Il socialismo fourierista di Cristina di Belgiojoso, in Rivista Internazionale
di Filosofa politica e sociale, fasc. II, aprile-giugno, 1963, pp. 126-137; con ulteriori riferimenti bi-
bliografci Proia, G. Les paysans de la Lombardie e il pensiero sociale di Cristina di Belgiojoso, in
Fugazza, M.; Rrig, K. (a cura di) Cristina Trivulzio di Belgiojoso tra politica e giornalismo cit.
89 LItalie: Journal politique quotidien, 3 ottobre 1860.
90 Ivi, 4 dicembre 1860.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 266 03/05/2013 11:11:19
267
3. Il Mezzogiorno e la Questione meridionale negli scritti di Cristina Trivulzio di Belgiojoso
Pregi, questi, che caratterizzavano invece gli altri Italiani, i buoni cittadini, e
che li avevano resi capables de mener bon terme daussi dif ciles entreprises
come la liberazione e lunifcazione dItalia.
A dispetto delle critiche, negli articoli per LItalie Cristina di Belgiojoso dimo-
strava tuttavia pi comprensione per i meridionali di quanto facesse prima. Que-
sto cambiamento era lefetto di una maturazione del suo pensiero avviatasi dopo
il 1860, quando con lo scioglimento del Regno delle due Sicilie si cominciavano
a conoscere le efettive dimensioni del decadimento della societ meridionale. Da
allora la Belgiojoso non solo dedic pi attenzione alla Questione meridionale, ma
vi fece ricorso pi spesso e pi abilmente come strumento di educazione civica per
tutti gli Italiani. Sottolineava per esempio: La faute nen est pas ce peuple, digne
dun meilleur sort, mais au gouvernement oppresseur et corrupteur qui [] le
maintint dans une crasse ignorance, dans une immoralit quon pouvait qualifer
dinnocente tant elle est involontaire
91
. Present i meridionali come vittime e
bisognosi di aiuto: gli italiani del Nord, nel loro insieme non meno pieni di difetti
e altrettanto sotto accusa, erano sollecitati a superare i loro pregiudizi e ad aiutare
i loro fratelli a trovare la strada delle virt civiche e del senso comune, dando il
buon esempio e attuando una politica di sviluppo adeguata per il Mezzogiorno,
provvedendo innanzitutto alla creazione di scuole e di infrastrutture.
Rifessi delle dif colt immense di questa collaborazione tra Settentrionali e
Meridionali nellindividuare insieme i principi fondamentali della coesione na-
zionale si trovano in altri contributi per LItalie e anche nelle Osservazioni del
1868. Cristina di Belgiojoso avvertiva i limiti dellavvicinamento tra Nord e Sud
e sicuramente anche quelli dellef cacia del suo discorso di educazione civica, ma
secondo lei non cera alternativa. Fedele a un suo progetto politico propagandi-
stico pi ampio, nel quale la Questione meridionale ricopriva appunto solo una
piccola parte, e come abbiamo visto con signifcati mutevoli, continu lanciare il
suo incessante appello allunione e alla concordia tra tutti gli Italiani:
Cessiamo una volta dallo scambiare fra di noi accuse, sospetti e rimproveri; ma
risolviamo invece unanimi e concordi di conservare i beni conquistati, educando
noi stessi e il popolo ad accrescerli sempre pi, e a trarne quei vantaggi materiali e
morali, che simili beni producono alle nazioni che gi da molti anni ne godono,
e che sanno giustamente apprezzarli
92
.
91 Ibidem.
92 Trivulzio di Belgiojoso, C. Osservazioni cit., p. 147.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 267 03/05/2013 11:11:19
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 268 03/05/2013 11:11:19
4. Sport e ginnastica nella costruzione
degli italiani, tra modelli di estetica femminile
e di educazione sica maschile.
Francesco Muollo
1. Nascita del movimento ginnico nellItalia risorgimentale
Fra Sette e Ottocento, il corpo assume un ruolo fondamentale nellambito dei
processi di trasformazione economica, politica e culturale. A seguito delle nuove
conoscenze scientifche nei campi della biologia, della fsiologia e della medicina
si verifca infatti una nuova utilizzazione sociale del corpo, la cui rivalutazione
assume una rilevanza culturale che tende a permeare lintera societ. Il corpo, una
volta rozzo e vilipeso, viene visto come fattore di modernit e di progresso. Ele-
mento fondamentale di questa nuova attenzione il formarsi di una rete di inizia-
tive, prima culturali e propositive, poi anche organizzative, inizialmente costituite
da singole individualit carismatiche presenti nei gangli dei vari Paesi europei e,
successivamente, da strutture associative che si potenzieranno nel tempo fno a
divenire substrato sistemico per le istituzioni
Nella prima met dellOttocento la ginnastica comincia a legarsi saldamente
con le vicende storiche e politiche di diversi Paesi europei. Le associazioni gin-
niche assumono signifcati diversi in Germania, Italia, Francia, Svizzera, ma in
ciascuno di questi Paesi trovano la loro idea di base nel culto della nazione. Cos
in Italia e in Germania la ginnastica funzionale alle lotte per lunifcazione, in
Francia acquista importanza dopo la sconftta di Sedan (1870), in Svizzera ne-
cessaria per garantire la sicurezza del Paese. Nazionalismo, militarismo, ideologia,
politica imperialista sono i cardini sui quali nasce e si sviluppa lo sport moderno.
Molto diverso invece il signifcato dallattivit fsica nel modello britannico. Qui
essa assume un carattere sportivo, diventa un momento di gioco che risponde a un
bisogno di esercizio fsico in un Paese dove non obbligatorio il servizio militare.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 269 03/05/2013 11:11:19
270
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
Interessante anche il ruolo delleducazione fsica in Svezia, dove risponde soprat-
tutto a esigenze igienico-sanitarie.
La vicenda della ginnastica, gi fortemente intrecciata con la storia europea del-
le rivendicazioni nazionali, anche nel nuovo Regno dItalia rivela uno strettissimo
legame con lideologia risorgimentale, mentre la questione nazionale inseparabile
dalla formazione dei primi nuclei associativi ginnastici. La nuova classe dirigente
aveva af dato alla ginnastica il patrimonio dei valori per la vita e per la guerra,
che dovevano presidiare la formazione del cittadino soldato
93
. La ginnastica educa-
tiva, nella sua genesi e nelle sue aspirazioni, fu quindi strettamente legata agli ideali
risorgimentali e patriottici di costruzione di un nuovo stato nazionale per il quale
occorrevano, sia sotto il proflo del consolidamento interno, che sotto quello della
difesa esterna, uomini sani, energici, valorosi, saldi nello spirito e nel corpo.
Questo ci permette di aprire una fnestra sul problema nazionalistico nelle pa-
lestre. Dai pochi studi fnora condotti sulle origini dellassociazionismo ginnastico
nellOttocento, su un aspetto bisogna fare chiarezza, ossia sulla stretta interdipen-
denza tra la questione nazionale e la fnalit del protonazionalismo sportivo.
Daltra parte limportanza dellattivit fsica traspare anche da alcune pagine dei
maggiori intellettuali italiani della prima met del secolo.
Nel suo Zibaldone, il 7 giugno 1820, Leopardi scrive:
Gli esercizi con cui gli antichi si procacciavano il vigore del corpo non erano
solamente utili alla guerra, o a eccitare lamor della gloria etc. [] Ed cosa gi
osservata che il vigor del corpo nuoce alle facolt intellettuali, e favorisce le im-
maginative, e per lo contrario limbecillit del corpo favorevolissima al rifettere,
(7 giugno 1820) e chi rifette non opera, e poco immagina, e le grandi illusioni
non son fatte per lui
94
.
Sulle pagine del Conciliatore, il primo agosto 1819, Silvio Pellico elogia la
capacit dello sport di agire sullautostima: nella sottolineatura di queste conno-
tazioni morali e civili si pu cogliere un velato invito agli italiani a reagire alla
dominazione austriaca
95
.
Analogamente Mazzini avverte limportanza di assumere lesercizio fsico tra
la giovent come parte del processo educativo.
Nel 1828 il letterato Nicol Tommaseo, per il quale ogni progetto sociale pas-
sa per la progettualit indipendentista e nazionale, ritiene che anche la ginnastica
educativa divenga un fattore di propulsione risorgimentale.
93 Papa, A. Coroginnica, Bari, Editore La Meridiana, 1992, p. 16.
94 Leopardi, G. Zibaldone, Milano, Ed. Mondadori, 1997, p. 59.
95 Pellico, S. Conciliatore, Milano, Foglio scientifco-letterario, Periodici economici, 1814-1914.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 270 03/05/2013 11:11:19
271
4. Sport e ginnastica nella costruzione degli italiani
Il nesso tra sport, associazionismo ginnico e nazione viene ribadito da molti
intellettuali dellet liberale. Scrive un capitolo interessante della storia del Risor-
gimento dItalia chi scrive la storia delle societ ginnastiche. Cos Silvio Benco,
uno dei pi rappresentativi esponenti della cultura triestina del 1900, disegnava
il ruolo svolto dallassociazionismo ginnastico nel periodo risorgimentale. Italo
Calvino da parte sua, introducendo unopera di De Amicis del 1892, notava che
in quella la ginnastica soprattutto unideologia
96
. Si tratta di afermazioni che
chiariscono in modo ef cace il ruolo svolto dallassociazionismo ginnastico ne-
gli anni del secondo Ottocento. Vigore fsico e robustezza derivanti dallesercizio
ginnico sono il corredo di unideologia educativa ispirata agli ideali patriottici
97
.
I sentimenti patriottici non erano suf cienti senza una base fsica che potesse
contrastare i nemici della patria. Inoltre dalla lettura degli statuti si evince che la
difesa della patria, il miglioramento della condizione psico-fsica e il cittadino
soldato, sono concetti continuamente richiamati nel ribadire i compiti di co-
struzione nazionale, alla pari dellistruzione; uno scopo primario della ginnastica
era quello di abituare il corpo a sopportare i gravi disagi, privazione, senza avere
scompensi, fortifcandolo per il futuro
98
.
La ginnastica ottocentesca, come esercizio fsico non ancora intriso di ago-
nismo, un insieme di valori, di controlli posturali, di elaborazioni temporali e
spaziali dellatto, dimitazione gestuale, che esige una docilit del corpo, una sorta
di passivit volitiva. Leducazione fsica ancora sintassi obbligatoria tra corpo e
attrezzi, tra corpo e superfcie, tra comando ed esecuzione. Non ancora manife-
sto il rapporto tra addestramento e prestazione: leducazione ancora impegnata
nel controllare, nel normalizzare, piuttosto che nellottenere prestazioni. Tuttavia
lingenuo proposito di utilizzare lo sport come propedeutico per laccettazione
delle disuguaglianze nel disegno di una societ armoniosa si ribalta in una societ,
come quella del XIX secolo, segnata da profonde disuguaglianze sociali, che riser-
va ricompense solo ai pi bravi e ai privilegiati. Sotto questo aspetto la funzione
dello sport come positivo strumento di integrazione sociale pu fnire per ribaltar-
si anche in espediente negativo, in quanto utilizzabile anche per produrre coesioni
antidemocratiche, nazionalistiche, pronte alle rituali mobilitazioni mistiche intor-
no ai miti della grandezza nazionale, della razza o del partito.
Lo sport, insieme al cinema, stato il primo a riunire gomito a gomito gli
spettatori di tutte le classi sociali, urbane e cittadine, giovani e vecchi, spezzando
lunit delle culture arcaiche e locali per recuperarle in un nuovo universo di valo-
96 Pivato, S. Coroginnica, Roma-Bari, Editore La Meridianai, 1992, p. 32.
97 Societ ginnica di Trieste, Ed. Periodico, Trieste, 1920.
98 Kurschen, L. Convenienze ed utilit della ginnastica, in Mente sana in corpore sano, 16 marzo
1874.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 271 03/05/2013 11:11:19
272
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
ri. Cos il linguaggio dello sport comunicazione tra le varie classi sociali che, se
da un lato getta le premesse di una maggiore interazione e identifcazione sociale,
favorendo linterclassismo dellemozione agonistica, dallaltro accentua la comu-
nicazione su temi neutrali e conformistici.
Leggi dellestetica e delleducazione sica. Lo sport femminile
come rappresentazione di una variabile del bello
Nella seconda met dellOttocento aumenta la consapevolezza della ginnastica per
la salute della donna, come mezzo per renderla pi resistente, forte e in grado di
assolvere al compito primario della maternit, parallelamente allo sviluppo delle
attivit ginnico-corporali maschili per fni esclusivamente militari. La ginnastica
diviene cos uno degli strumenti di formazione dei ruoli e delle identit di genere.
Con la Legge De Sanctis del 1878 si erano gettate le basi per la parifcazione
ginnica dei sessi, anche se rimanevano da superare delle riluttanze verso laspetto
femminile dellattivit. Lo sviluppo del corpo, maschile o femminile che sia, ri-
entra in un contesto storico dove Neoclassicismo (riscoperta moderna del corpo)
e Nazionalismo (utilizzazione del corpo come macchina bellica), fanno si che la
cura fsica non sia pi una ludica perdita di tempo fne a se stessa, ma che risulti
propedeutica a un fne superiore, il bene nazionale. La donna si arricchisce di
nuove funzioni sociali, non semplice angelo del focolare, ma pilastro familiare e
sostegno attivo al cittadino-soldato, in una comunit di fne secolo che ha bisogno
di tutte le sue componenti nelle sue mire di espansione e progresso. NellOttocen-
to europeo, in una concezione binaria dei ruoli di genere, luomo, parallelamente
a quanto avviene per la donna, deve essere in grado di assolvere ai suoi doveri di
marito e padre in un rapporto familiare la cui visibilit non si ferma tra le mura
di casa, ma diventa parte della sua immagine pubblica. Le convenzioni sociali e la
Legge intervengono a sanzionare i comportamenti contrari al modello canonico
di famiglia.
Sono gli anni in cui i moralisti gridano contro la decadenza dei costumi, che
in questo caso non implica un semplice cambiamento delle mode, ma include
una pi ampia messa in discussione dei campi di azione e delle prerogative sia del
maschile che del femminile. Cos facendo, viene ridefnita lidentit di uomini
e donne fno a giungere a quello che per la societ del tempo era un punto di
non ritorno: lattraversamento dei generi, che rompe la tradizionale dicotomia
tra sfera maschile e sfera femminile con la progressiva apertura dello sport al
sesso femminile. Lo spettacolo dello sforzo atletico, tradizionale esibizione della
virilit, testimonia il processo di una trasformazione antropologica della donna
nella nostra cultura. Penetrando in questo spazio ora ludico, ora agonistico, sep-
pure periferico ai grandi momenti della vita collettiva, le donne sembrano sottrarsi
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 272 03/05/2013 11:11:19
273
4. Sport e ginnastica nella costruzione degli italiani
agli obblighi e alle rappresentazioni abituali della femminilit, sperimentando un
diverso uso e valore del proprio corpo.
sorprendente il fatto che proprio nei templi della cultura maschile le pale-
stre e gli stadi sia stato superato per la prima volta il pregiudizio antifemminile;
ci si pu chiedere com stato possibile che proprio in questo contesto gli uomini
abbiano saputo rinunciare alle tradizioni che normavano lesibizione pubblica del
corpo femminile, o perch lo sport abbia accolto con notevole anticipo la nozione
della diversit e delluguaglianza della donna. Si comprende allora perch latleta
possa vedere con minor pregiudizio il corpo della donna atleta, riconoscendolo
come regolato da una comune natura in cui le somiglianze sono maggiori delle
diferenze. Esperienza che per altri versi ci fa capire, al tempo stesso, perch la
prevenzione razzistica sia poco rilevante come sentimento personale tra gli atleti, i
quali non conoscono quel misto di estraneazione e repellenza che la diversit fsica
provoca quando preceduta da una categorizzazione sociale negativa.
Se ne desume che, se mutiamo il contesto di esperienza, e quindi di conoscen-
za, vengono meno i giudizi che a tale contesto non appartengono. Allora la donna
atleta appare, come direbbe Simone de Beauvoir, non come un qualcosa di con-
trario delluomo, ma come luomo un essere umano qualsiasi
99
. Paradossalmente,
proprio nel tempio dei valori maschili, possibile vedere come il destino sociale
ottocentesco della donna sia pi segnato dalla convenzione che dalla struttura
fsica; venendo a essere chiaro che il corpo femminile non sia defnibile come cosa,
quanto come situazione e parte attiva della societ.
Dubitare della femminilit della ragazza che fa sport nellOttocento signifca
dare per assoluta e naturale la categoria femminilit, assimilandola per analogia
al concetto di normalit. Da qui limperativo, esterno e interno, che vuole la don-
na conforme alle aspettative stereotipiche della femminilit, cio un suo adeguarsi
caricaturale alle ingiunzioni di un pregiudizio che prescrive unidentit, una serie di
comportamenti ed espressioni di s, da governare af nch lascino trasparire una psi-
cologia perfettamente ingranata con il ruolo che deve essere rappresentato. Tuttavia il
timore che lo sport possa virilizzare la struttura fsica della donna un pregiudizio che
scaturisce dalladesione acritica allo stereotipo fsico ed estetico della femminilit bor-
ghese nella mentalit ottocentesca: un pregiudizio che rende molte donne prigioniere
esse stesse di una mistica corporea della femminilit, costruita allo stesso modo dei
piccoli piedi delle cinesi dellepoca imperiale, che bloccati nella crescita mediante
fasciature e cos deformati venivano a essere parametro della bellezza femminile.
Il problema della percezione della donna-atleta come mascolina non riguarda
solo le sportive, dal momento che tende a investire tutte le donne che, in misura
99 De Beauvoir, S. Les Belles Images, Torino, De Agostini Editore, 1966, p. 56.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 273 03/05/2013 11:11:19
274
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
diversa, svolgono attivit orientate al successo. inevitabile, quindi, trovarsi coin-
volti in un intreccio che vede legate attivit fsica maschile e femminile come,
daltronde, risulta consequenziale un coinvolgimento delle palestre nelle vicissitu-
dini nazionali; ed qui che il corpo di donna e quello delluomo si fondono per
la prima volta per raggiungere quellideale superiore che il bene nazionale. Non
casuale che siano proprio la ginnastica prima e poi lo sport a permettere per la
prima volta tale avvicinamento, al di l delle diferenze sociali, politiche e di sesso;
come non casuale che sia proprio nel XIX secolo che ci avvenga. Ormai, infat-
ti, sembra essere maturo il tempo in cui uomini e donne siano parte integrante
della medesima societ anche se con compiti diversi. proprio sulla diversit dei
compiti che i ginnasiarchi giocano per preparare tutte le componenti sociali al
proprio ruolo per la creazione di uno Stato capace di far fronte alle nuove sfde.
Donna procreatrice, uomo soldato sono le categorie che nella societ ottocentesca
ginnastica e sport hanno perseguito.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 274 03/05/2013 11:11:19
5. Maria Soa di Borbone: da regina-soldato
ad amica di briganti e anarchici
Ugo della Monica
Indietro Savoia!
Fu questo il grido con cui lultima regina di Napoli, allindomani del 6 settembre
1860, da Gaeta inizi la sua personale lotta contro lusurpatore torinese: quello
della Regina del Sud per i Savoia, infatti, fu odio da subito e dur tutta la vita
100
.
Maria Sofa Wittelsbach rappresenta nella storia e nella storiografa europea
ancora oggi, a distanza di centocinquanta anni dal combattivo processo unitario
del Paese, quellideale di eroina antirisorgimentale pronta, personalmente in armi,
a combattere per difendere un Regno e un trono che non le appartenevano per
nascita, ma che le circostanze della vita le avevano oferto. doveroso, quindi,
rivivere quegli eventi ed esaminare, attraverso lanalisi di documenti inediti, i dif-
ferenti volti di questa protagonista della nostra storia.
La regina
Condotta a sposare, per ragioni dinastiche e di alleanze politico-militari, il prin-
cipe Francesco, unico fglio nato dal matrimonio tra Ferdinando II di Borbone e
Maria Cristina di Savoia, la giovane principessa apprese del matrimonio dal padre
100 Lodio si present fn da quando la giovane regina ebbe modo di ritrovare nello spirito e nel fsico
del marito quegli atteggiamenti di devozione religiosa e rigore morale, ereditati dalla madre Maria
Cristina di Savoia (passata alla storia come la Regina Santa), che dif cilmente si accordvano con
leducazione anticonformista e libera ricevuta da Maria Sofa.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 275 03/05/2013 11:11:19
276
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
il quale, saputo dellaccordo matrimoniale organizzato dalla moglie, le telegra-
f afermando: Francesco di Borbone te lo consiglio un imbecille; lingenua
diciassettenne credette che fosse uno dei soliti scherzi organizzati da suo padre,
simpaticamente conosciuto in tutta la Baviera come il buon duca Max. Sar lei
stessa, a distanza di sessantacinque anni da quel telegramma, ad afermare nella
sua ultima intervista: no il mio re non fu un imbecille come dicono
101
.
La bellezza della giovane regina e la sua forte personalit conquistarono, in po-
chissimo tempo, il popolo meridionale, mentre Francesco, uomo mite e di scarsa
personalit, soggiogato dal suo fascino, le consentiva di sconvolgere le abitudini della
corte: fumava, andava a cavallo, tirava di scherma, si faceva fotografare, si bagnava
nelle acque del porto militare, conduceva i cani in sala da pranzo; era al centro delle
cronache mondane. Laumento di popolarit la port a progettare, in accordo con
il Filangieri, linstaurazione di un regime costituzionale sul modello bavarese, e la
cosa sembra abbia spinto la regina madre Maria Teresa a ordire un complotto per
detronizzare Francesco a favore di un fglio di lei, Luigi, conte di Trani.
Leroina
Il periodo di Gaeta fu quello in cui, vestita con una personale uniforme, un
enorme costume calabrese, tailleur nero di taglio maschile, con su il mantello
nero dei montanari, stivali neri tacco basso e rozzi speroni, il cappello nero a
cono e larghe falde, usato dai contadini di Calabria
102
, dispiegher tutte le sue
forze per gli oltre 150 giorni in cui avr durata la sua perseveranza sulla rocca.
Fin dal giorno del suo arrivo a Gaeta aveva preso a esplicare una grande e in-
consueta attivit: visita ai reparti delle caserme, sopraluoghi sui lavori di aforza-
mento, predisposizioni per le cure ai feriti e agli ammalati, contatti con la popo-
lazione, tra la quale la giovane Sovrana non tard a diventare popolarissima
103
.
I soldati, per lo pi giovanissimi allievi del Collegio Militare Nunziatella di
Napoli, promossi alferi da Francesco, chiamavano la regina, in dialetto, bella
guagliona nuosta e apprezzavano in lei laudacia e la costanza che alimentavano
in lei la speranza nella riconquista del Regno, il modo in cui, senza farsi scrupolo
di mettere a repentaglio la propria vita, sfdava, combattendo col sorriso sulle
labbra, il destino suo e del suo popolo, al fanco dei soldati che ladoravano a tal
101 Lintervista a frma di Giovanni Ansaldo apparve sul Corriere della Sera il 18 novembre 1924.
102 De Lorenzo, R. Tempi brevi e lunghi di un regno al femminile Maria Sofa di Baviera regina
del Regno delle due Sicilie in Tra res e imago in memoria di Augusto Placanica, Soveria Mannelli,
Rubettino, 2007, p. 1058/1059.
103 Tosti, A. Maria Sofa ultima regina di Napoli, Milano, 1947 p. 194.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 276 03/05/2013 11:11:19
277
5. Maria Sofa di Borbone: da regina-soldato ad amica di briganti e anarchici
punto da invocarne il nome anche in punto di morte. Era tale lafetto che la le-
gava ai soldati che, per distrarli dalle soferenze e dalle brutture della guerra, bal-
lava per loro e soprattutto ballava con loro. Fu Maria Sofa ad accendere i cuori
e le anime del popolo e di quanti ancora credevano di poter rivedere sventolare
la bandiera gigliata; in continua attivit, non si perdeva mai danimo e lo sprezzo
del pericolo era una costante del suo comportamento; sapeva afrontare ogni
rischio col sorriso sulle labbra, quasi a sfdare il destino, sempre presente laddo-
ve pi imperversava la battaglia. Quando a Gaeta, col trascorrere dei giorni, la
situazione divent sempre pi tragica a causa dellepidemia di tifo, del grande
freddo e della scarsit di cibo, la regina si rifut sempre ai continui appelli del
marito di lasciare la roccaforte. In una lettera indirizzata a Napoleone III, Fran-
cesco II a questo proposito, non senza compiacimento, dichiar della moglie:
Ho fatto ogni sforzo per persuadere S.M. la Regina a separarsi da me, ma sono
stato vinto dalle tenere sue preghiere, dalle generose sue risoluzioni. Ella vuol
dividere meco, sin alla fne, la mia fortuna, consacrandosi a dirigere negli ospedali
la cura dei feriti e degli ammalati; da questa sera Gaeta conta una suora di carit
in pi
104
.
Il colpo defnitivo si registr quando Napoleone III, accordatosi segretamente
con Cavour per avere in cambio i comuni di Mentone e Roccabruna, annunzi il
ritiro della squadra navale francese da Gaeta, consigliando a Francesco di desistere
dalla resistenza e facendogli intendere che non lo avrebbe appoggiato. Nella trat-
tativa ebbe un ruolo anche la corrispondenza tra limperatrice Eugenia e la giovane
regina di Napoli. Pur ammirando personalmente il coraggio e la determinazione
di Maria Sofa, infatti, Eugenia sottolineava che il marito non avrebbe appoggiato
la sua causa:
Madame ma soeur la lettre si pleine de nobles sentiment que votre majest
ma crite ma profondament touch, et je saisi avec emprepement loccasion
desprimier a Votre Majest mes sentiment de vive sympathie pour lenegrie qui
elle montre ainsi que le Roi dans des circonstances si terribles et si perilleuses.
Je regrette sincerement que la politique de lImpereure ne lui permette pas de
clourer un appui plus ef cace a un jeun souverain que tutte avec tante de courage
contre sa tradison et la mancance fortune, mais il en obtendra sa recompense et
lavenir, jaime a limpereur la lui reserve sur tout coeur bien place ne peut avoir
ma doute que qual cot est la bon droit et lhonneur.
104 Jagger, P.G. Francesco II di Borbone lultimo re di Napoli, Milano, Mondadori, 1982 p. 204.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 277 03/05/2013 11:11:19
278
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
Je prie Votre Majest de me rappeler un souvenir de Roi et cryey la smiure
et afectuose consideraction avec la quelle je suis moderne. De votre majest la
bonne soeur et amie Eugenia
105
.
Umiliata dal comportamento dei francesi, Maria Sofa continu ad aggirarsi
fra le artiglierie, rincuorando i soldati. Con lallontanamento della squadra navale
francese, tutto il fronte di mare rimase scoperto e in balia della fotta piemonte-
se comandata dallammiraglio Persano, anche perch nel frattempo, per ottenere
soldi per poter sopravvivere, il re aveva venduto i battelli Sannita e Saetta
106
. I
sovrani, ancora decisi a non capitolare, andarono avanti a oltranza con i pochi
militari sopravvissuti, fno all11 febbraio 1861, quando Franceschiello riconobbe
la necessit di una pronta e onorevole capitolazione; per cui il 14 successivo, dopo
aver salutato le poche persone, militari e civili, ancora presenti alla piazzaforte,
profondamente commossi (le cronache riportano che la regina singhiozzasse vi-
stosamente), presero il largo sulla Mouette in direzione di Roma e, per lultima
volta, videro ammainare la bandiera gigliata sulla Torre dOrlando; si emoziona-
rono ancora di pi quando osservarono i pochi soldati rimasti spezzare con rabbia
le proprie spade.
La raf gurazione pi bella dellassedio di Gaeta ce la fornisce la descrizione di
uno scudo in onore dei re, pubblicata sulla Gazzetta di Lipsia:
Lo scudo di onore fatto eseguire dal partito conservatore in Prussia e che devessere
presentato allesule Coppia Reale di Napoli terminato. Il professore Fischer in
Berlino fece il modello; i sig.ri Sy e Wagner lo hanno eseguito in argento con bassi
rilievi. Lesecuzione di questo lavoro ha impiegato il tempo di tre anni. Lo scudo
una rondazza di pi di due piedi di diametro. Lorlo forma un intreccio di nastri
doro. Gigli doro, in egual distanza gli uni dagli altri, tengono insieme un fascio
di verghe. Il pezzo di mezzo una piastra dargento. Simile ad alto rilievo sporge
fuori dallo scudo lo scoglio di Gaeta su, di esso, sta il Re Francesco e la Regina
Maria. Contro lo scoglio lultimo luogo di rifugio della Real Coppia imperversa
la rivoluzione. Fra gli assalitori uno tira lo scudo, un altro lermellino del Re. La
corruzione e la calunnia sono attive fra il popolo; un terzo sof a nelle famme
della ribellione; il padre della menzogna sta al fanco e si rallegra della sua opera.
A pi dello scoglio giacciono i fedeli estinti. Anche nelle regioni aeree imperversa
la lotta. Alle teste della Real Coppia sono afaccendate le schiere diaboliche che
con spade nude e coperte di serpi minacciano lo scoglio. Ma gli angeli discendono
alla difesa, vibrando spade e palme, portando calici e croci, ed innanzi allo scudo
105 ASN, Archivio Borbone busta 1151 f. 24.
106 Il carteggio relativo alla vendita dei battelli in ASN, Archivio Borbone b. 1340 f. 113.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 278 03/05/2013 11:11:19
279
5. Maria Sofa di Borbone: da regina-soldato ad amica di briganti e anarchici
di stelle si piega lo scudo di serpenti. Due angeli rialzano la caduta Corona del
Re. La Corona che gli angeli rialzano precisamente formata secondo la Corona
del Re di Napoli ed ornata di diamanti, rubini, smeraldi, zaf ri e perle. Ci che
concerne lo scudo stesso esso la pi rimarchevole e pi grande opera darte della
specie che esiste
107
.
Da regina-brigantessa ad anarchica
Nellesilio romano Maria Sofa inizi unulteriore e pi aspra lotta, combattuta
da fuorilegge, pronta a impugnare le armi per la riconquista del Regno. Era solita
frequentare la farmacia Vagnozzi a Campo dei Fiori, a pochi passi dalla residenza
di Palazzo Farnese, dove si riunivano le bande legittimiste borboniche, capeggiate
da loschi fguri, quali Chiavone, Crocco, Ninco Nanco, Fuoco, Guerra, Giordano, che
venivano ricevuti dalla regina, senza alcuna distinzione, e per i quali ella aveva sem-
pre un sorriso ammirato e un amuleto portafortuna da donare, ben sapendo che
queste erano le uniche persone che potevano dare un concreto contributo militare
alla causa legittimista. Nel frattempo, mentre volontari da tutta Europa giungeva-
no a Roma per prendere parte a una vera e propria crociata per la liberazione del
Sud, focolai di rivolta si difusero nellex Regno, organizzati e diretti da comitati
borbonici. Il popolo meridionale aveva capito che far parte dello Stato unitario non
aveva apportato alcun giovamento, anzi rimpiangeva quel Regno di Napoli che, nel
bene e nel male, aveva avuto per diversi secoli un ruolo predominante tra le vaste e
variegate monarchie dEuropa. Anche una parte della cultura meridionale inizi a
riavvicinarsi a Maria Sofa, ritenendola in grado di modifcare la situazione. Intanto
la ribellione, nata come movimento dei contadini, divent pian piano un moto
sovversivo contro lo Stato piemontese, condito da veri e propri atti di terrorismo
combattuti nelle campagne. I ministri italiani non nascosero il timore di eventuali e
pi concitate sollevazioni popolari nellex Regno; la stampa internazionale, dal can-
to suo, dedic ampio spazio a questa guerriglia che si combatteva nel Mezzogiorno
dItalia, prendendo talora le difese delle popolazioni locali. Maria Sofa fgurava
come la vera ispiratrice della resistenza; aveva fatto della lotta ai piemontesi il suo
unico scopo di vita, tanto che il suo intenso attivismo le attir lodio dei circoli
liberali romani che cominciarono a osteggiarla in tutti i modi, mentre la stampa
internazionale non era da meno: il 28 agosto 1861 il Times di Londra pubblic la
notizia che La regina Maria Sofa nei giardini del Quirinale aveva ucciso un gatto
preso a bersaglio con la sua pistola; lo stesso giornale aveva consigliato al generale
Cialdini di trattare i napoletani come lupi della foresta.
107 ASN, Archivio Borbone, b. 1615-f. 217 s.d.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 279 03/05/2013 11:11:19
280
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
Quella che doveva essere una guerra di liberazione dallinvasore fall nel giro
di un anno, lasciando nel gi mal ridotto Sud una situazione di totale scompiglio
che and avanti per oltre dieci anni, trasformandosi in insurrezione contadina
combattuta da delinquenti comuni, dediti per lo pi a interessi strettamente per-
sonali, che lo Stato non riusciva a tenere a bada neppure in seguito allapplicazione
della legge Pica, che prevedeva, nelle regioni meridionali, la sospensione di ogni
garanzia costituzionale. Col trascorrere degli anni la battaglia legittimista cess del
tutto, anche se in cuor suo Maria Sofa continu a sperare che qualche evento, pur
se tragico, le restituisse il suo amato trono.
Rimasta sola dopo la morte dei genitori, delle sorelle e di Francesco, avvenuta
nel 1894, demoralizzata, era solita ripetere: nel mio cuore non c pi posto nemmeno
per il dolore. C posto solo per la vendetta. Nella residenza francese di villa Hamilton
a Neuilly-sur-Seine, vicino Parigi, Maria Sofa, sul fnire del secolo, entr in con-
tatto con Charles Malato, giornalista dellEcho de Paris, restando subito attratta
dalle idee estremiste professate dal giovane; il suo salotto divenne luogo di raduni
e di incontri clandestini tra anarchici. Le cronache narrano che un giorno si ud la
regina gridare devono liberarlo al pi presto, il signor Malatesta il solo italiano
capace di guidare la rivoluzione
108
; sovvenzion tanto il Malatesta quanto tutto
lambiente legittimista, fgurando tra gli artefci dellevasione del Malatesta dal
carcere di Lampedusa. In seguito alla liberazione dellanarchico, and lavorando
al grande passo: in efetti strani movimenti si registravano sullasse Italia-Francia-
America, facendo pensare che qualcosa bollisse realmente in pentola; lo stesso pri-
mo ministro Giolitti teneva segretamente sotto controllo quella che lui chiamava
la Signora, e che fortemente temeva, tanto da metterle alle costole agenti segreti
109
.
DallAmerica, nellestate del 1900, transit prima in Francia e poi in Italia
lanarchico Gaetano Bresci, che il 29 luglio a Monza attent alla vita di Umberto
I di Savoia uccidendolo. Malatesta, interrogato al riguardo, confess che: il re-
gicidio non fu un gesto individuale, bens un complotto organizzato con tutte le
regole nella preparazione, nellesecuzione, nelle necessarie complicit
110
. Assieme
a quelle necessarie complicit af or il nome di Maria Sofa, o meglio della Signora
come veniva chiamata anche a Parigi dagli anarchici.
Lattentato alla vita di Umberto I risult una mossa poco abile per il movi-
mento anarchico in quanto la nuova Italia, governata dal pacato e poco mondano
Vittorio Emanuele III e dallef ciente e risoluto Giovanni Giolitti, dette una dura
sferzata a tutto il movimento rivoluzionario: si attuarono riforme politiche e sociali
108 Petacco, A. La regina del sud, Milano, Mondadori, 1993 p. 209.
109 Le relazioni degli agenti segreti, inviate a Giolitti sono custodite presso lArchivio centrale dello
Stato.
110 Linterrogatorio riportato in Petacco, op. cit., p. 243.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 280 03/05/2013 11:11:19
281
5. Maria Sofa di Borbone: da regina-soldato ad amica di briganti e anarchici
e cominci un nuovo ciclo di vita per il Paese che fece precipitare, defnitivamente,
la causa legittimista borbonica. Dal canto suo Maria Sofa, lasciata Parigi e rientra-
ta a Monaco, abbandon ogni speranza di riconquista del trono, ma non depose
mai il suo odio verso i Savoia. A testimonianza si riporta un aneddoto riferito al
1919: quando seppe che la giovane pronipote Maria Jos, (la madre di Maria Jos
era fglia di un fratello della stessa Maria Sofa) avrebbe dovuto sposare un Savoia,
espresse personalmente alla giovane principessa il suo disappunto: Sappiate che io
disapprovo fortemente. Non posso tollerare che una mia pronipote vada in sposa
a un discendente dellusurpatore. Sappi che se lo farai te ne pentirai amaramente
e non conoscerai la felicit. Parole profetiche!
Lultimo afondo allormai consolidato Regno sabaudo lex regina lo condusse
nel 1912, muovendo causa allo Stato, tramite lIntendenza di Finanza di Napoli,
per richiedere gli assegni vedovili che mai le erano stati versati e che ammontavano
a 3.825,000 lire, motivando la richiesta con le seguenti osservazioni:
Tale solenne impegno obbligava certamente lo Stato del tempo, in quanto esso
era rappresentato ed impersonato dal suo capo Re assoluto. Limpegno di quello
Stato passato al nuovo Stato, poich se questo si impossessato di tutti i beni del
primo e perfno dei beni privati dei suoi reggitori deve pure rispettare e assumere
come propri i pesi ed i vincoli che su tali beni gravano, il che fu pure riconosciuto
col decreto dittatoriale del 25 settembre 1860, col quale la Commissione nomi-
nata per formare linventario dei beni fu incaricata di accertare anche i pesi e le
passivit di cui erano gravati
111
.
Durante la prima guerra mondiale sper nella sconftta italiana e si leg agli
ambienti dello spionaggio internazionale; nello stesso tempo si occup attivamen-
te nel sociale, trascorrendo gli ultimi mesi di guerra nei campi di prigionia italiani,
portando assistenza a quei fgli napoletani che ancora teneva nel cuore e che dal
canto loro ignoravano chi fosse quella anziana signora, dai modi garbati e gentili.
111 Intendenza di Finanza di Napoli contro il Conte di Gerace F. Caracciolo di Forlino, Vicario generale
della gi Regina delle due Sicilie Maria Sofa Borbone Baviera. Biblioteca Nazionale Napoli, Raccolta
Zangari B. 5/27.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 281 03/05/2013 11:11:19
282
Capitolo 5. Modelli di genere e iniziativa femminile nella costruzione dellItalia unita
R
a
n
i
e
r
i
F
r
a
n
c
e
s
c
o
L
u
i
s
a
C
o
n
z
o
A
n
t
o
n
i
o
A
n
n
a
E
n
r
i
c
h
e
t
t
a
G
i
u
s
e
p
p
e
G
i
u
l
i
a
E
r
m
i
n
i
a
G
o
f
f
r
e
d
o
L
u
c
i
a
n
o
T
e
r
e
s
a
P
a
o
l
i
n
a
D
i
e
g
o
F
e
r
r
i
g
n
i
M
a
r
g
h
e
r
i
t
a
S
i
m
i
o
l
i
S
a
l
v
a
t
o
r
e
G
i
u
s
e
p
p
e
A
n
d
r
e
a
I
g
n
a
z
i
o
A
u
r
e
l
i
a
C
h
i
a
r
a
F
r
a
n
c
e
s
c
o
S
a
v
e
r
i
o
Q
u
i
r
i
n
o
A
m
e
r
i
c
o
L
u
i
g
i
D
i
G
e
n
n
a
r
o
I
f
i
g
e
n
i
a
C
l
o
t
i
l
d
e
A
r
g
i
a
C
a
l
l
i
o
p
e
E
n
r
i
c
o
L
a
n
g
F
r
a
n
c
e
s
c
o
C
a
p
e
c
e
l
a
t
r
o
M
a
d
d
a
l
e
n
a
S
a
n
t
o
r
e
l
l
i
G
i
u
s
e
p
p
e
M
i
c
h
e
l
e
A
n
t
o
n
i
o
E
n
r
i
c
o
V
i
n
c
e
n
z
o
E
t
t
o
r
e
C
a
m
i
l
l
o
A
l
f
o
n
s
o
E
n
r
i
c
h
e
t
t
a
F
e
r
d
i
n
a
n
d
o
C
a
r
a
f
a
D
u
c
a
D
A
n
d
r
i
a
M
.
G
r
a
z
i
a
S
e
r
r
a
d
i
C
a
s
s
a
n
o
R
i
c
c
a
r
d
o
A
n
t
o
n
i
o
V
i
t
t
o
r
i
a
E
l
e
o
n
o
r
a
B
r
i
a
n
n
e
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 282 03/05/2013 11:11:19
CAPITOLO 6
Lampiezza di un margine.
Genere, cittadinanza e politica
nellItalia repubblicana
a cura di Valentina Greco
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 283 03/05/2013 11:11:20
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 284 03/05/2013 11:11:20
Introduzione
Valentina Greco
Il titolo che abbiamo scelto per questa sezione, in apparenza un ossimoro, descrive
perfettamente il flo che lega i tre interventi in essa racchiusi.
Sono tutti percorsi personali e collettivi che, agiti allinterno di momenti sto-
rici fondanti e da essi condizionati, sono rimasti esclusi dalle narrazioni uf ciali.
Percorsi ai margini ma non marginali.
Storie nella storia, storie della storia, storie senza storia.
Grauso, Landini e Voli hanno dato voce a queste vite altrimenti mute, con
minuzia, acume e senso critico si sono incaricati di ricostruirle e di analizzarle, re-
stituendo loro un posto e ofrendo a noi una visione pi ampia della storia dItalia.
Hanno dato conto dellampiezza di quel margine.
Cronologicamente gli interventi si susseguono, quasi afondando luno
nellaltro, nonostante narrino vite fatte di scelte radicali che non si intrecciano,
piuttosto sembrano opposte. Sono raccontate due generazioni di donne: la prima
nata a cavallo del secolo e attiva gi durante il fascismo ma soprattutto nel secondo
dopoguerra; la seconda impegnata politicamente negli anni Settanta.
Descrivere i singoli interventi sembra ridondante, i loro titoli suggeriscono
chiaramente largomento trattato, la loro intelligenza e piacevolezza nella lettura
rendono quasi superfua anche la pi breve delle sintesi.
Luca Grauso ripercorre la vita di Olga Arcuno, fera insegnante di Storia e
Filosofa in un liceo classico di Napoli, fondatrice nel 1930 dellAlleanza Mu-
liebre Culturale e nel 1944 della rivista Solidariet. Olga, antifascista vicina alla
cultura comunista, profondamente avversa a ogni regime, alla Monarchia e alla
Chiesa cattolica, si fa sostenitrice di unidea di educazione non gerarchica e
democratica.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 285 03/05/2013 11:11:20
286
Capitolo 6. Lampiezza di un margine. Genere, cittadinanza e politica nellItalia repubblicana
M. Eleonora Landini ricostruisce la biografa collettiva di quelle donne che al
termine della Seconda Guerra Mondiale restarono convinte sostenitrici dellideo-
logia fascista. Lo fa attraverso la storia del Movimento italiano femminile (Mif ),
associazione assistenziale con chiari rifessi politici che nel primo decennio
repubblicano si occup di sostenere sul territorio nazionale i fascisti incarcerati,
latitanti o in condizioni di disagio. Sono testimoni di cui ancora si conosce po-
chissimo: ignorate dalla storiografa e restie a testimoniare, le neofasciste non sono
neppure state inserite uf cialmente nella storia del Movimento Sociale Italiano,
che non riconobbe loro n valore n visibilit.
Landini ci ofre unanalisi attenta e ampia che non si ferma al nucleo dirigen-
ziale del Movimento, ma tocca anche lampio panorama delle assistite, indagando
volont e motivazioni delle une e delle altre.
Stefania Voli racconta le militanti dei movimenti extraparlamentari degli anni
Settanta, in particolare quelle di Lotta Continua, utilizzando la narrazione auto-
biografca. Donne e uomini vivono lesperienza della militanza nei gruppi extra-
parlamentari in modo diferente, una diferenza che passa spesso, anche se non
esclusivamente, attraverso il genere. Voli, analizzando le memorie di queste don-
ne, osserva come queste rappresentano lesperienza vissuta e si autorappresentano
in essa, sia contestualmente che a distanza di anni. I nodi pi evidenti e intricati
sono costituiti dalle relazioni tra donne e dalla violenza politica, temi indagati con
chiarezza e profondit da Voli che, grazie a questo approccio, riesce a mettere in
evidenza come e quanto il vissuto militante abbia infuenzato il processo di costru-
zione dellidentit di genere e le scelte di vita.
Pur nelle loro profonde diferenze i tre contesti analizzati nei saggi sono ac-
comunati dalla ricerca di spazi di espressione e dazione interstiziali rispetto al
contesto culturale e politico dominante e dal bisogno di dar vita a modalit di
aggregazione e di attivismo diverse da quella, pi tipicamente maschile, della for-
ma partito.
Il primo spunto di rifessione sollecitatomi dalla lettura dei tre testi riguarda
la biografa nellaccezione ampia che qui stiamo utilizzando come strumento
che ofre a chi si occupa di storia di genere di scardinare alcuni luoghi comuni e
ofrire nuovi punti di vista.
Le ricostruzioni di percorsi biografci singoli e collettivi realizzate utilizzan-
do come fonti memorie, interviste, archivi personali, scritti editi e inediti sono,
com stato pi volte sottolineato, un fecondo strumento di indagine del rapporto
tra individuo e societ.
Lo sono, a mio parere, da almeno due punti di vista: quello del rapporto tra
i soggetti della biografa e il contesto culturale allinterno del quale sono vissuti
e quello del rapporto tra lautore della biografa e il contesto culturale al quale si
rivolge.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 286 03/05/2013 11:11:20
287
Introduzione
Le storie qui raccontate dimostrano che fare storia non solo restituire al
presente qualcosa che appartiene al passato, ma anche costruire nuovi spazi di
interpretazione del presente.
I saggi di Grauso, Landini e Voli evidenziano un tracciato che consente non
solo di vedere la presenza, ma anche la persistenza delle donne nella storia politica
dellItalia del Novecento.
Questo raforza la mia convinzione che il concetto di carsismo riferito alla storia
politica delle donne sia improprio, poich come un rifesso in uno specchio defor-
mante, non restituisce la realt ma il racconto pubblico che della realt stato fatto.
Se il rifesso di cui parliamo di per s signifcativo cos come lo il suo racconto,
vero anche che altre narrazioni, come quelle dei saggi di cui parliamo, sono necessarie.
La seconda rifessione riguarda il nodo memoria/storia e il metodo storico.
noto, ci sono silenzi che urlano nella storia dellE donne, ma bisogna avere
un orecchio attento per ascoltarli. Nel momento in cui i soggetti fanno di s gli
oggetti della propria storia iniziano a scriverla, a ofrire se stessi come testimoni e
a ofrire la propria memoria a chi dovrebbe storicizzarla.
Quasi tutto il Novecento stato caratterizzato da unistanza di rimozione
della memoria, istanza che nei regimi totalitari espressa in un vero e proprio
tentativo di cancellazione oltre che di mistifcazione.
Gli ultimi anni del Novecento hanno segnato anche in Italia una netta inver-
sione di tendenza, tanto che Annette Wieviorka ha defnito quella in cui viviamo
era del testimone, concetto che per la storica ha unaccezione ampia che non
riguarda solo i sopravvissuti al genocidio nazista degli ebrei dEuropa
1
.
La relazione storia/memoria trascina con s dei nodi che ancora oggi appaio-
no insolubili, da qualunque prospettiva li si osservi.
Se, per, provassimo a capovolgere i punti di vista e non ci facessimo con-
dizionare dagli schematismi, considereremmo la memoria e la storia luna una
risorsa per laltra.
Memoria e storia non sono le due fasi di un processo dialettico in cui la sintesi
passa per il superamento del dualismo, un processo di sintesi che, in ogni caso,
appare oggi impossibile: la separazione sempre pi netta tra le due ha generato una
dicotomia che ha fnito per ipostatizzarsi.
Per chi ricorda la memoria la storia dellevento narrato, in questo senso la
memoria oggettiva.
Nel raccontare il testimone spiega non solo ci che gli accaduto, ma spiega
laccaduto; nellatto di raccontare il punto di vista del singolo tale solo per chi ha
un punto di vista esterno, non per il singolo stesso.
1 Wieviorka, A. Lera del testimone, Milano, Rafaello Cortina, 1999, p. 227.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 287 03/05/2013 11:11:20
288
Capitolo 6. Lampiezza di un margine. Genere, cittadinanza e politica nellItalia repubblicana
Nel momento in cui lo storico entra in relazione con le memorie piene di vita
dei testimoni deve imparare a guardarle come fonti.
Le fonti vanno circoscritte, contestualizzate, analizzate e sottoposte a critica;
chi scrive la storia deve interrogare le fonti ed essere disposto a farsi stupire da
risposte che non si aspettava; chi scrive la storia deve dar voce alle infnite sfaccet-
tature che assume il silenzio; chi scrive la storia non pu scaricare tutta la respon-
sabilit della narrazione sulla fonte, anche se lo fa in buona fede, magari per una
forma di rispetto della fonte stessa; chi scrive la storia, in sostanza, si deve esporre.
un percorso che sembra ancora pi dif coltoso in relazione alla selezione
del materiale: il ricercatore vorrebbe avere la possibilit di ascoltare tutte le voci,
leggere tutti i racconti, analizzare tutte le memorie, ogni cernita sembra un torto.
Compito dello storico, per, non quello di correggere il testimone, di met-
tersi in relazione con la storia del singolo, ma di mettere in relazione le voci dei
testimoni.
Come ha scritto Ricur c un privilegio che non pu essere rifutato alla sto-
ria, quello non soltanto di estendere la memoria collettiva al di l di qualsiasi ricordo
efettivo, ma di correggere, di criticare, e anche di smentire la memoria Proprio
sul cammino della critica storica, la memoria incontra il senso della giustizia. Che
cosa sarebbe una memoria felice che non fosse anche una memoria equa?
2
.
In questo contesto proprio il metodo analitico di genere teorizzato da Joan
Scott
3
che ofre e ofrir la possibilit di scrivere una storia che superi gli scogli
di cui ho parlato e coniughi la ricchezza e il valore della memoria con le istanze
critiche della storiografa.
I tre saggi che introduco hanno questo grande valore, non sono solo racconti,
sono racconti critici; non sono solo narrazioni biografche, sono ricostruzioni di
un mondo; non sono solo storie di donne, ma tentativi di analisi di genere.
E Grauso, Landini e Voli sono storici che si espongono nella loro analisi, non
nascondendosi dietro le vite che raccontano.
Il margine di cui parlavamo allinizio, e di cui abbiamo tentato di mostrare
lampiezza, si trasforma in una risorsa, perch dopo di esso non c il vuoto ma
pagine ancora da scrivere.
2 Ricur, P. La memoria, la storia, loblio, Milano, Rafaello Cortina Editore, 2003, p. 710.
3 Scott, J.W. Il genere: unutile categorie di analisi storica in Di Cori, P. (a cura di) Altre storie.
La critica femminista della storia, Bologna, Clueb, 1996, pp. 307-348.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 288 03/05/2013 11:11:20
1. Genere e forme di partecipazione politica
tra fascismo e Repubblica:
il caso di Olga Arcuno (1902-1977)
Luca Grauso
La famiglia e gli studi
Lambiente familiare in cui Olga Arcuno nasce e in cui viene educata lascer un
segno notevole sulla sua personalit e sulla sua coscienza, si potrebbe anzi dire che
costituir in qualche modo un solco profondo nella sua vita, allinterno del quale
traccer il proprio percorso. La madre, Giuditta Occhipinti, insegnante elemen-
tare, fglia di Ignazio Occhipinti, repubblicano e membro della spedizione dei
Mille in qualit di medico di Garibaldi. Il padre, Alfredo Arcuno (1869-1946),
anchegli insegnante elementare, spesso descritto con il termine pi ampio di
educatore: egli infatti un attento studioso di pedagogia, uno dei divulgatori in
Italia della teoria dellinsegnamento integrale di Alexis Bertrand
4
. Tale metodo
tendeva a considerare primario laspetto sociale dellesperienza scuola, da intende-
re come una vera e propria comunit, un luogo in cui i bambini sperimentino la
vita pubblica sotto la guida dellinsegnante. Olga si rivela presto una studentessa
straordinaria: dopo il liceo classico si iscrive alla facolt di Filosofa e, nella prima-
vera del 1922, a meno di venti anni, termina gli studi universitari, coronati da una
tesi sulla flosofa di Maurice Blondel
5
. Pochi anni dopo ottiene la cattedra di Sto-
ria e Filosofa presso il prestigioso liceo classico Gianbattista Vico, dove si svolger
4 Bertrand, A. Lenseignement intgral par Alexis Bertrand, Paris, 1898; Arcuno, A. La scuola inte-
grale, Firenze, R. Bemporad e Figlio, 1911.
5 Olga Arcuno fu traduttrice autorizzata e divulgatrice della Filosofa dellazione blondeliana, e
pubblic nel corso della sua vita una serie di saggi divulgativi in merito.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 289 03/05/2013 11:11:20
290
Capitolo 6. Lampiezza di un margine. Genere, cittadinanza e politica nellItalia repubblicana
la sua lunga carriera di insegnante durata sino al 1972. La rilevanza di tale traguar-
do appare tanto maggiore se si tiene presente il ruolo chiave af dato ai licei classici
e alle discipline flosofche dalla riforma Gentile del 1923. stato tuttavia osser-
vato come questa riforma non determinasse solo sperequazioni relative alla classe
sociale, ma ne generasse altrettante dal punto di vista dellappartenenza di genere.
Se da un lato la riforma port a una maggiore scolarizzazione e alfabetizzazione
delle donne, dallaltro essa poggiava su una concezione alquanto misogina della
societ, a causa della scarsa tolleranza nei confronti di sistemi di valori diversi,
compresi quelli solitamente associati alle donne. Sulla scorta di questi presupposti,
che negavano loro di fatto qualunque valore come educatrici, il governo concep
una serie di provvedimenti mirati a defemminilizzare il corpo insegnante, il primo
dei quali, del 1926, prevedeva linammissibilit delle donne allinsegnamento di
Latino, Greco, Storia e Filosofa nei licei
6
. Olga subisce dunque in prima persona
la misoginia del governo, allontanata da quel lavoro che senza dubbio rappresenta-
va il suo obiettivo professionale e personale e costretta probabilmente a insegnare
lettere. Tuttavia, linsegnante napoletana decide di reagire alla politica del regime
a danno delle donne italiane, confnate sempre pi in una dimensione di subor-
dinazione, deprofessionalizzate e quasi relegate allo stato di semplici riproduttrici.
LAlleanza
Nel 1930 Luigia Pirovano
7
e Olga Arcuno fondano lAlleanza Muliebre Cul-
turale Italiana
8
, rispettivamente a Milano e a Napoli: mentre la Pirovano presie-
der lAlleanza, Olga Arcuno sar segretaria nazionale e respondabile della sede di
Napoli per tutto il periodo di attivit dellassociazione. Formata prevalentemente
da insegnanti, ma anche da artiste, medici, letterate e nobildonne, lAlleanza ha
come scopo principale quello di istituire corsi di lezioni completamente gratuiti,
o semigratuiti, riservati alle socie. Sono gratuiti i corsi di lezione mediante i quali
si preparano agli esami di Stato, per il conseguimento di un diploma, le giovinette
impiegate o lavoratrici di condizioni disagiate
9
.
6 Cos come per le cattedre di Italiano e Storia allinterno degli istituti tecnici. Negli anni a venire
tale provvedimento fu af ancato da altri di natura af ne: nel 1928 fu impedito che le donne divenis-
sero presidi di scuole medie e a partire dal 1940 questultima legge fu estesa anche agli istituti tecnici.
7 Nata a Milano nel 1897, a sua volta insegnante superiore di materie letterarie.
8 SullAlleanza si veda Scaramuzza, E. Professioni intellettuali e fascismo. Lambivalenza dellAlleanza
Muliebre Italiana, in Italia Contemporanea, n. 151-152, settembre 1983, pp. 111-133, e Pauncz, A.
Intellettuali italiane negli anni Trenta. LAlleanza Muliebre Culturale Italiana, Dottorato di ricerca in
Storia delle scritture femminili, Universit degli studi di Roma La Sapienza, A.A. 1997-1998.
9 Alleanza Culturale Muliebre Italiana, Statuto, tip. Moneta Giovanni, Milano, 1930, articolo 2.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 290 03/05/2013 11:11:20
291
1. Genere e forme di partecipazione politica tra fascismo e Repubblica: il caso di Olga Arcuno
Appare da subito come tra le varie iniziative dellAlleanza
10
, quelle inerenti i
corsi di sostegno per afrontare gli esami di licenza scolastica superiore, insieme a
quelli per gli esami di abilitazione allinsegnamento, siano da considerare il loro vero
fulcro. Per quanto riguarda la composizione sociale dellAlleanza e le motivazioni in-
dividuali che potevano spingere le donne ad aderirvi, si rileva una notevole eteroge-
neit. Laddove le lavoratrici di umili condizioni si univano allassociazione in cerca
di un sostegno concreto e psicologico per coronare il sogno di unistruzione superio-
re o dellambto impiego pubblico, le intellettuali e le artiste trovavano nellAMCI
un luogo culturale dove esprimersi e dove poter discutere la questione femminile
in relativa libert. Per le studiose e le insegnanti infne (che prestavano a titolo vo-
lontario la propria opera di tutrici) lAlleanza costituiva la possibilit di espandere e
prolungare la funzione educatrice oltre i confni delle aule scolastiche a benefcio di
donne meritevoli o indigenti, contrastando cos in certa misura la carenza di oppor-
tunit di ascesa sociale femminile dettata dalla volont politica del regime. senza
dubbio questultima motivazione a spingere Olga Arcuno a fondare lAlleanza e a
lavorarvi per lunghi anni: nel suo percorso familiare e intellettuale infatti evidente
il grande valore sociale e politico attribuito alleducazione. Circa la natura dei legami
associativi instaurati nellAMCI si dir che, sebbene si basasse su una struttura ge-
rarchica, essa agevolmente assimilabile a una rete di solidariet femminile, essendo
sostanziata da un sentimento di identifcazione e reciprocit tra le socie, ricalcante
non gi le pi comuni relazioni di stampo parentale, ma piuttosto quelle tipiche
del rapporto insegnante-allieva da una parte e allieva-allieva dallaltra. Gi durante i
primi anni di vita dellAlleanza si evince dalle pagine di Cultura Muliebre, periodico
dellassociazione, unesigenza di defnire il proprio campo dazione e la propria iden-
tit culturale, soprattutto rispetto al movimento femminista della fne del secolo,
vittima nel corso del ventennio di una vera e propria opera di rimozione e stig-
matizzazione. Infatti, in un articolo del secondo numero, Luigia Pirovano aferma
risolutamente: lAlleanza non vuole essere femminista. In Italia (chi pi chi meno)
tutti sono antifemministi: il nostro atteggiamento non ha dunque nulla di eroico, e
noi ce ne rendiamo perfettamente conto
11
. Sintetizzando, possiamo sostenere che
lAlleanza non pot, e in certa misura non volle, richiamarsi esplicitamente alle lotte
sufragiste e rivendicazioniste della stagione precedente, ma emerge allo stesso tem-
po un malcelato desiderio che quella stagione, con i suoi temi di giustizia sociale
ormai desueti e largamente denigrati, avesse avuto maggiore successo e pi difuso
10 Oltre a questo scopo principale, nelle sedi dellAlleanza vengono spesso organizzate anche attivit
non strettamente correlate ad esigenze di carattere professionale: concerti, conferenze, mostre, gite
estive e altre attivit di gruppo sono infatti comunemente promosse allo scopo di valorizzare i talenti
delle socie e di incoraggiarne la socializzazione.
11 Pirovano, L. Il femminismo e noi, in Cultura Muliebre, n. 2, marzo 1931, corsivo nel testo.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 291 03/05/2013 11:11:20
292
Capitolo 6. Lampiezza di un margine. Genere, cittadinanza e politica nellItalia repubblicana
rispetto. A sua volta, il rapporto tra lAMCI e il governo fascista va letto sotto la ca-
tegoria dellambivalenza: nonostante le attivit delle alleate contrastassero ipso facto
con le direttive del regime, il tenore generale dellattivit delle alleate non lascia mai
trapelare unaperta ostilit al regime. Del resto, larticolo 14 dello statuto dellAMCI
era concepito in modo esplicito allo scopo di difendere lorganizzazione da insidiose
accuse di dissidenza: LAlleanza esclude qualsiasi forma di attivit sindacale o po-
litica e limita la sua attivit alla difusione della cultura fra le donne
12
. In generale,
appare chiaro che le socie dellAlleanza (o quantomeno i suoi vertici) mirassero a
tenere un proflo basso rispetto al governo fascista, professando unapoliticit (e un
antifemminismo) formale e, potremmo dire, mimetizzandosi sotto le spoglie di una
rispettabile associazione di studiose e letterate. Attenendosi strettamente agli scopi
dichiarati di elevazione culturale delle donne, si sperava che limplicita eversivit
dei contenuti passasse furtivamente il setaccio del regime e che fosse cos possibile
difondere istruzione e consapevolezza. Malgrado ci, i contrasti tra lAlleanza e il
governo cominciarono nel 1935, in relazione alla presunta ridondanza delle attivit
rispetto allAssociazione Nazionale Fascista Donne Artiste e Laureate, cui il governo
attribuiva la funzione politica di assorbire e monopolizzare le istanze e le iniziati-
ve femminili, e che in tal modo forniva il pretesto per commissariare, chiudere e
in generale ostacolare i progetti indipendenti delle donne, come appunto nel caso
dellAMCI (ma non solo)
13
. La fne dellAlleanza Muliebre Culturale Italiana uf -
cializzata il 23 luglio 1939, per volont del vicesegretario del PNF Adelchi Serena.
Latteggiamento elusivo e ambiguo dellassociazione rispetto al regime rese tuttavia
possibile per circa dieci anni e nel periodo di maggior consenso del fascismo alle
donne che vi aderirono di avere esperienza di una realt diversa da quella familiare o
strettamente domestica in cui la cultura dominante le voleva confnate, aprendo uno
spiraglio verso diverse possibili identit di genere e fornendo un supporto concreto,
nonch un sollievo psicologico, a quante di loro non venivano incoraggiate fra le
mura di casa a valorizzare le proprie qualit.
Solidariet
Anni dopo, nel settembre 1944, Olga Arcuno e Lelia Mangiarotti
14
pubblicano
il primo numero di un mensile intitolato Solidariet: rivista di educazione civile e
12 Alleanza Muliebre Culturale Italiana, Statuto cit., articolo 14.
13 Anche la FILDIS (Federazione Italiana Laureate e Diplomate di Istituti Superiori) e la FISEDD (Fede-
razione Italiana per il Sufragio e i Diritti della Donna) vengono sciolte dautorit in questo stesso periodo.
14 Nata a Manchester nel 1912, studia a Napoli e si laurea in Lettere moderne. Comincia a insegnare
nel 1935, e due anni pi tardi viene trasferita presso il Gianbattista Vico, dove conosce Olga Arcuno,
con la quale instaura un sodalizio inscindibile.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 292 03/05/2013 11:11:20
293
1. Genere e forme di partecipazione politica tra fascismo e Repubblica: il caso di Olga Arcuno
politica. Dal suo punto di osservazione in una classe liceale, la professoressa Ar-
cuno ha la possibilit di testimoniare una situazione che, da insegnante e flosofa,
giudica tra le pi gravi emergenze. Ecco come descrive tale preoccupante stato di
cose negli articoli introduttivi del primo numero:
oggi lItalia corre un grave pericolo. Molti, troppi italiani, oggi, si proclamano
apolitici o danno prova di essere malamente informati circa i concetti e i problemi
fondamentali della vita politica. Spesso oscuro il concetto stesso di democrazia.
[] Il contatto con varie categorie di cittadini, giovani e adulti di ambo i sessi,
ci ha condotti, durante questanno di rinascita dellItalia, alla constatazione del
pi grande sbandamento di molte coscienze.
[]
Non dif cile riconoscere che i
maggiori e veri motivi dellattuale disordine di molte coscienze hanno profonde
radici nel ventennio di tirannia fascista
15
.
Leredit pi insidiosa e duratura del fascismo non sarebbe dunque stata la
guerra e la conseguente distruzione, ma piuttosto i segni profondi che il ven-
tennio di dittatura, con il suo monopartitismo, la sua censura e il brutale sof-
focamento del dissenso, aveva lasciato sulla societ civile. Olga Arcuno infatti
sostiene: pi che rivoltarci contro gli indiferenti come contro colpevoli, non fa-
remmo bene a rivolgerci a essi, per aiutarli a vedere pi chiaro, l dove da soli non
riuscirebbero?
16
. senzaltro questo il messaggio, il leitmotiv del periodico, di
questa natura la solidariet che ella ritiene pi urgente e importante ofrire. Pub-
blicare Solidariet ogni mese per tredici anni stato certamente un lavoro enorme
ma altamente gratifcante, molto gravoso soprattutto sotto laspetto economico:
pi volte ribadito nel corso dei mesi come Solidariet fosse completamente in-
dipendente da partiti politici o associazioni, sia dal punto di vista editoriale SIA
da quello strettamente fnanziario. Addentrandoci nel merito dei contenuti del
mensile, possibile evidenziare due tipologie principali di articoli: un corso di
dottrine politiche e gli spazi di discussione aperti ai lettori. Quello che defnisco
corso di dottrine politiche costituisce il primo e pi importante progetto della
rivista: preso atto del difuso disinteresse per la politica, proprio in una fase pregna
di signifcato, che vede linstaurazione di un vero pluralismo in seguito ad anni di
monopartitismo, le due insegnanti descrivono ed esaminano, nel corso del primo
anno di pubblicazione, ciascuno dei partiti del CLN nei suoi presupposti dottri-
nali e nella linea politica. Sebbene i toni prevalenti in tali lezioni siano neutri e
appunto didattici, quando nel terzo numero si giunge alla descrizione del partito
15 Arcuno, O. Presentazione, in Solidariet, n. 1, settembre 1944.
16 Ibidem.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 293 03/05/2013 11:11:20
294
Capitolo 6. Lampiezza di un margine. Genere, cittadinanza e politica nellItalia repubblicana
democristiano, appare evidente un repentino cambio di timbro: Olga Arcuno evi-
denzia infatti aspramente la contraddizione tra il principio di sovranit popolare
e quello di autorit divina intrinseco nel discorso della DC, e accusa apertamen-
te tale partito di essere sostanzialmente antidemocratico17. Sebbene sia possibile
ravvisare un contrasto tra il fervente atto daccusa contro le linee programmatiche
della DC e i proclamati scopi di equanime educazione sociale, appare altrettanto
chiaro che Olga Arcuno sia cosciente di non trovarsi in unaula scolastica e di es-
sere dunque libera dai vincoli deontologici dei quali era peraltro scrupolosamente
rispettosa nellesercizio delle proprie funzioni professionali. Un secondo progetto,
fondamentale ai fni della linea editoriale, riguarda la realizzazione di uno spazio
di dibattito per i giovani, veri protagonisti di Solidariet. Attraverso la creazione
di apposite rubriche, Olga Arcuno decide di dare una valvola di sfogo alle insicu-
rezze, le ansie e la confusione che quella generazione sfortunata aveva accumulato
durante il regime e la guerra. Lidea sottostante a tali rubriche soprattutto quella
di far confrontare le opinioni e le impressioni dei giovani in una sorta di forum
trasversale comprendente sostanzialmente due aspetti: il primo spazio costituito
dalle Confessioni di giovani, in cui chiunque poteva scrivere alla redazione a
proposito di un argomento che lo avesse colpito, mentre un secondo, chiamato
Referendum, era formato dalle lettere pervenute in risposta a tematiche stabilite
volta per volta dalle direttrici. Il primo referendum , ad esempio, strettamente
legato al tema dellapoliticit, che si visto centrale nelle linee programmatiche,
e che dunque appariva logico afrontare da subito. Sebbene sia possibile conside-
rare le questioni poste non del tutto neutre18, e in sostanza contenenti risposte
implicite, sempre allo scopo di una pedagogia civica e politica che vanno messe
in relazione, in questo caso al fne di aiutare a razionalizzare la reazione emotiva
di disgusto e di inadeguatezza. Vale infne la pena di menzionare qualche altra te-
matica introdotta nei mesi successivi, come ad esempio per il quarto Referendum,
quella del voto alle donne, lungamente dibattuto proprio a ridosso del decreto di
estensione del sufragio, o, ancora, il decimo Referendum circa la scelta tra Mo-
narchia e Repubblica, che si protrarr anchesso per diversi numeri della rivista.
Gi a questo punto dellanalisi del periodico appare lampante come Olga Arcuno
abbia in pratica sfruttato, appena possibile, la rinata libert di stampa come uno
strumento di amplifcazione di quella che percepiva come la propria funzione
17 Seguendo questo ordine di considerazioni, salta decisamente allocchio anche il grande spazio de-
stinato sulla rivista ai movimenti socialista e comunista tra il febbraio e lagosto del 1945, laddove
per tutti gli altri partiti del CLN erano bastati due articoli.
18 1) Pu essere un buon cittadino lapolitico? possibile lassoluta apoliticit? 2) Quali caratteri
contraddistinguono nella vita del cittadino lo spirito, il costume democratico?. Cfr. Risposte al primo
Referendum, in Solidariet, n. 2, ottobre-novembre 1944.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 294 03/05/2013 11:11:20
295
1. Genere e forme di partecipazione politica tra fascismo e Repubblica: il caso di Olga Arcuno
sociale di educatrice, che le consentiva di estendere lefetto della sua pedagogia
sociale dalla scala minima di una classe a quella molto pi ampia del paese, ge-
nerando cos una dimensione corale. Guardando complessivamente il lavoro di
Olga Arcuno e Lelia Mangiarotti possibile infne ritenere che Solidariet abbia
costituito implicitamente un considerevole atto di biasimo nei confronti del regi-
me, e in particolare delle sue politiche culturali, considerando il grave danno pro-
curato a molti esponenti delle generazioni nate e cresciute nelle scuole fasciste. Il
duro lavoro sostenuto dalle due inseparabili amiche costituisce quasi il precipitato
delle idee politico-pedagogiche della fondatrice: in primo luogo testimonianza
di unintera vita dedicata al risveglio delle coscienze degli indifesi (giovani, donne),
di cui si mirava a favorire la libert di critica e lo sviluppo delle inclinazioni indivi-
duali. Inoltre, Solidariet il luogo dove linsegnante libera di dare voce a talune
idee politiche che il precedente contesto culturale le impediva di manifestare, se
non a carissimo prezzo: il suo femminismo, il suo antifascismo, la sua avversione
per la corona e la Chiesa cattolica. Tenendo infne presente complessivamente il
suo percorso di attivista, possibile comprendere a pieno le strategie messe in atto
da Olga Arcuno per giungere a un compromesso tra le proprie idee politiche e
il costume di rispettabile e capace insegnante, che in molti casi e per molti versi
infuenz le sue scelte di vita.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 295 03/05/2013 11:11:20
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 296 03/05/2013 11:11:20
2. Fondatrici, sostenitrici, utenti del Movimento
Italiano Femminile:
elementi di una biograa collettiva
M. Eleonora Landini
Resta ancora quasi del tutto insondato come, negli anni di transizione dalla ditta-
tura alla democrazia, larea neofascista, che andava riorganizzandosi, si confront
con la nuova presenza femminile sulla scena politica e se e come le donne di destra
afrontarono la propria specifcit di genere allinterno del loro contesto culturale
di riferimento.
Tanto i movimenti neofascisti quanto il Movimento sociale non prestarono
grande attenzione al ruolo delle donne, probabilmente distratti da pi pressanti
assilli in primis quello della sopravvivenza. Daltronde, da parte delle stesse mi-
litanti di estrema destra non sembra essere presente una convinta vocazione riven-
dicazionista, tant che negli interventi uf ciali e nelle testimonianze delle dirette
protagoniste si evince una scarsa rilevanza conferita allidentit di genere
19
.
Se questa fu senza dubbio la tendenza dominante, la pluralit di anime di cui
fu composto il neofascismo impone alcuni distinguo. Nel pulviscolo di gruppi
di marca neofascista che si difuse nei tardi anni Quaranta, si oppose a questa
prospettiva il Movimento italiano femminile (Mif ), cui merita di essere accordata
unattenzione particolare poich mise in luce un protagonismo femminile insolito.
Oggetto di cancellazione dalla memoria collettiva, anche nei circuiti della destra
reducistica, il Mif stato per lo pi ignorato dalle ricostruzioni storiografche o
19 Dittrich-Johansen, H. Fedelt e ideali delle donne nel movimento sociale italiano. Il caso tori-
nese (1945-1990), in Silvestrini, M.T.; Simiand, C.; Urso, S. (a cura di) Donne e politica: la presenza
femminile nei partiti politici dellItalia repubblicana, Torino 1945-1990, Torino, Franco Angeli, 2005,
p. 718.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 297 03/05/2013 11:11:20
298
Capitolo 6. Lampiezza di un margine. Genere, cittadinanza e politica nellItalia repubblicana
descritto con cenni approssimativi
20
, che di volta in volta lo hanno ridotto a or-
gano del Msi o liquidato come associazione caritatevole. In realt, il Mif che si
occup di assistere a livello morale, materiale e legale fascisti in dif colt, detenuti
o latitanti nacque prima del partito e a esso si leg con un patto di collaborazio-
ne solo nel 1952, mentre il tentativo di appiattire quellesperienza esclusivamente
sullaspetto di cura sarebbe limitante, oltrech fuorviante.
La fondatrice
Il Mif nacque uf cialmente a Roma il 28 ottobre 1946, preceduto da una lun-
ga gestazione. Animatrice del movimento, cui ben presto fu af data la carica
di Segretaria generale, fu la principessa Maria Pignatelli Cerchiara di Calabria.
Nata contessa Elia, rapidamente separatasi dal fglio del prefetto di Palermo, il
marchese De Seta, con cui ebbe quattro fgli, nel corso degli anni Venti e Trenta
Maria aveva condotto la vita agiata che il proprio rango le consentiva. Il legame
amoroso con il quadrumviro Michele Bianchi aveva contribuito a raforzarne la
posizione di infuenza ampiamente descritta e biasimata nelle note informa-
tive del fascicolo che la Polizia politica del regime aveva aperto sul suo conto,
dove limmagine della patronessa si accavalla a quella della mangiatrice di uo-
mini assetata di potere
21
. Nel 1938 avvenne lincontro con il principe Valerio
Pignatelli Cerchiara di Calabria avventuriero, militare di carriera e giornalista,
fascista inquieto che di tanto in tanto rassegnava le dimissioni dal Pnf
22
, che
nel 1942 sfoci in matrimonio.
Tra il 1943 e il 1944 i coniugi Pignatelli furono attivissimi organizzatori di
quella resistenza fascista
23
che nei territori dellItalia meridionale riusc a co-
agulare un numero consistente di fascisti
24
attorno ad azioni dimostrative, ma
anche sabotaggi e attentati, a danno dellesercito alleato e di antifascisti locali.
Proprio per ottenere sovvenzioni per i fascisti meridionali la principessa, nellaprile
1944, avrebbe incontrato Benito Mussolini: questi le avrebbe invece prospettato
20 Cenni al Mif in Rosenbaum, P. Il nuovo fascimo da Sal ad Almirante, Milano, Feltrinelli, 1975
(1974), p. 66; Murgia, P.G. Ritorneremo! Storia e cronaca del fascismo dopo la Resistenza 1950-1953,
Milano, SugarCo, 1976, pp. 168-179 e pp. 172-173; Ignazi, P. Il polo escluso. Proflo storico del Mo-
vimento Sociale Italiano, Bologna, Il Mulino, 1998 (1989), p. 62.
21 Cfr. Archivio Centrale dello Stato, Ministero dellinterno, Direzione generale Pubblica Sicurezza,
Divisione Polizia Politica, Fascicoli personali, 1927-1944, Pacco 425, De Seta Maria Elia marchesa.
22 Parlato, T. Fascisti senza Mussolini. Le origini del neofascismo in Italia 1943-1948, Bologna, Il
Mulino, 2006, p. 39.
23 Ignazi, Il polo escluso cit., p. 17.
24 Parlato, Fascisti senza Mussolini cit., p. 41.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 298 03/05/2013 11:11:20
299
2. Fondatrici, sostenitrici, utenti del Movimento Italiano Femminile
la necessit di un movimento femminile di assistenza animato dalla famma
dellIdea, che trascendesse la semplice funzione di cura per assumere il ruolo di
perno attorno al quale ricostruire una rete, di cui le donne dovevano essere le
maglie connettive.
Arrestati in quello stesso aprile 1944 e tradotti in diferenti campi di concen-
tramento alleati, i principi, insieme a molti compagni di prigionia, si ritrovarono
a Roma nellestate 1946.
Il contesto generativo
La capitale si prestava a ospitare tra il 1945 e il 1946, decine di migliaia
di rifugiati politici, che dopo lamnistia divennero quasi duecentomila
25
. Maria
Pignatelli ebbe in efetti in quei mesi frequenti incontri con quelli che saranno
i fondatori del Mif, tra cui monsignor Silverio Mattei, responsabile della Sacra
Congregazione dei Riti (uno dei dicasteri della Curia romana), che divenne lassi-
stente ecclesiastico del movimento. Ci si cercava e ci si contava nella prospettiva di
riunire i volenterosi [] per assistere i perseguitati. Assistere, lenire i dolori della
guerra ed estinguerne lodio
26
: si dava cos vita a una comunit sparuta ma coesa,
tanto che una delle analogie in quel periodo pi ricorrenti nella pubblicistica del
movimento fu quella coi primi cristiani.
Lautorappresentazione neofascista avr sempre un taglio fortemente vittimi-
sta: fame, miseria, paura, controlli polizieschi ritornano con incredibile frequenza
nelle parole di quanti si considerarono dei proscritti, pur senza considerare le pro-
prie responsabilit (fecero propria lidea del castigo, obliterando lidea del delitto
ha scritto Sergio Luzzatto
27
). Eppure, con lamnistia, si compiva la prima e pi
signifcativa tranche di un percorso che avrebbe condotto a un sostanziale colpo
di spugna sui crimini fascisti
28
, allinterruzione delle norme epurative e al reinte-
gro degli orfani del duce
29
nel corpo sociale. Filippo Focardi ha infatti osservato
che su 12 mila fascisti imprigionati, 7 mila furono rimessi in libert entro il 31
25 Ivi, p. 153.
26 Archivio di Stato di Cosenza, Movimento italiano femminile (dora in poi ASCS, MIF), b. 1, f. 4,
sf. 1, resoconto della Conferenza di Edmondo Cione nel teatro Masciari di Catanzaro il 25/2/51 per
iniziativa del Movimento italiano femminile Mif, s.f., s.d.
27 Luzzatto, S. Il corpo del duce. Un cadavere tra immaginazione, storia e memoria, Torino, Einaudi,
1998, p. 40.
28 Cfr. Franzinelli, M. Lamnistia Togliatti. 22 giugno 1946: colpo di spugna sui crimini fascisti, Mi-
lano, Mondadori, 2006.
29 Cfr. Mammone, A. Gli orfani del duce. I fascisti dal 1943 al 1946, in Italia Contemporanea,
n. 239-240, 2005.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 299 03/05/2013 11:11:20
300
Capitolo 6. Lampiezza di un margine. Genere, cittadinanza e politica nellItalia repubblicana
luglio 1946. Nel luglio dellanno successivo ne rimanevano dietro le sbarre circa
duemila. Nel 1952 ne restavano soltanto 266
30
.
Lassociazione
La fervida attivit che negli ultimi mesi del 1946 e nei primi del 1947 impegn i
promotori del Mif aveva il fne di attirare nuove socie e creare sezioni periferiche,
dipendenti dalla sede centrale romana, che rivestiva compiti coordinativi. La pe-
netrazione del Mif nel tessuto sociale avvenne in modo frammentario, spesso sol-
lecitata dal proselitismo compiuto dalla sua Segretaria generale. Maria Pignatelli,
fn da principio, aveva infatti avviato contatti e accolto proposte per sedi locali
31
: la
solerzia delle risposte fornisce unidea piuttosto precisa della disponibilit a impe-
gnarsi sul fronte neofascista. Basti pensare che nellautunno 1947, a un anno dalla
fondazione dellassociazione, i Mif costituiti risultano 61, di cui 52 in capoluoghi
di provincia (su un totale di 91 province italiane dellepoca)
32
.
Lorganizzazione, per sostenersi, usufru innanzitutto delle possibilit econo-
miche dei soci, che infatti costituirono la maggiore fonte di entrata dopo le muni-
fche elargizioni della principessa. Bench lorganigramma dellassociazione fosse
rigorosamente femminile, intrattenere relazioni con il ct maschile era dunque
essenziale: resta pur sempre vero, come ha notato Laura Guidi a proposito delle
opere di carit ottocentesche, che gli uomini sono indispensabili alleati, perch
solo nellalleanza con il denaro e con il potere le benefattrici possono realizzare i
loro progetti
33
.
Le socie
Lassociazione fu animata da unlite femminile alto-borghese e aristocratica, colta,
politicizzata, nata a cavallo tra il XIX e il XX secolo, educata in et liberale e venu-
ta in contatto con gli stimoli dellepoca il movimento femminile pro-sufragio,
il nazionalismo, il futurismo. Sono donne, quelle che supportarono il Mif, che
30 Focardi, F. La questione dei processi ai criminali di guerra tedeschi in Italia: fra punizione fre-
nata, insabbiamento di Stato, giustizia tardiva (1943-2005), in Storicamente, n. 2, 2006 (www.
storicamente.org).
31 Cfr. ASCS, MIF, b. 84, Agenda del 1946 e Agenda del 1947.
32 Cfr. ASCS, MIF, b. 1, f. 5, sf. 2, Elenco dei M.I.F. costituiti, s.d. (ma collocabile al settembre 1947,
quando doveva tenersi originariamente il I Congresso nazionale del Mif ).
33 Guidi, L. La Passione governata dalla virt: benefattrici nella Napoli ottocentesca, in Ferrante,
L.; Palazzi, M.; Pomata, G. (a cura di) Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia
delle donne, Torino, Rosenberg&Sellier, 1988, p. 159.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 300 03/05/2013 11:11:21
301
2. Fondatrici, sostenitrici, utenti del Movimento Italiano Femminile
esulano nettamente dalla media delle loro contemporanee; sono privilegiate che
avevano ricevuto uneducazione cosmopolita, avevano viaggiato e appreso diverse
lingue straniere (come Maria Pignatelli) o avevano avuto accesso a unistruzio-
ne universitaria e avevano costruito solide carriere professionali. Tutte avevano
aderito al fascismo: le pi politicizzate fn dai suoi esordi, mentre altre solo nel
momento in cui la dittatura si consolid.
La reciproca attrazione tra fascismo e aristocrazia gi usuale durante il regi-
me prosegu nel dopoguerra: la disponibilit di numerose esponenti della nobil-
t romana a impegnarsi pubblicamente nel Mif faceva s che i benefci che deriva-
vano dalla loro posizione economica e sociale fossero al servizio dellassociazione.
Su una discreta rappresentanza potevano contare anche le professioniste, pro-
venienti dalla borghesia medio-alta, la maggioranza delle quali esibiva curricula
politici molto densi. Avevano esperienze politiche pregresse Anna Ghezzi e Fedora
Lazzarini, segretaria del Fascio della capitale la prima, fascista antemarcia la se-
conda; cos come lartista campana Anna Dinella, ultima fduciaria dei Fasci fem-
minili del Pnf della provincia di Salerno
34
e membro del Consiglio nazionale del
Mif. Tra le componenti della Giunta centrale del Mif, inoltre, almeno tre fgure
meritano di essere richiamate: Clementina Santoni Pomarici, Rachele Ferrari del
Latte ed Elda Simeoni Norchi.
La prima, vedova di un detenuto politico e madre di una bambina, era stata
direttrice dellUf cio Statistica e Censimenti del Comune di Venezia e fduciaria
dei Fasci femminili durante la Rsi: epurata e condannata a trentanni di reclusio-
ne dalla Corte dAssise straordinaria di Venezia, benefci dellamnistia nel luglio
1946 e si trasfer a Roma, dove inizi a lavorare negli uf ci del Mif
35
.
Rachele Ferrari del Latte fu invece contattata personalmente da Maria Pi-
gnatelli il giorno stesso della fondazione del Mif
36
, per aderire prontamente alla
neonata organizzazione e rimanervi fno al 1950. Insegnante milanese, vedova,
Rachele del Latte era stata legionaria fumana e quindi si era iscritta al Pnf nel
1923, distinguendosi tra le pi attive promotrici dei Fasci femminili milanesi. Nel
1938 ne divenne Ispettrice nazionale e alla costituzione della Rsi fu tra le quattro
Ispettrici nazionali sulle 18 in carica al 25 luglio 1943 che rimase fedele alla
propria identit politica assumendo responsabilit direttive nel Pfr
37
.
34 Cfr. Appendice 1, Fiduciarie provinciali dei Fasci Femminili, in Dittrich-Johansen, H. Le militi
dellidea. Storia delle organizzazioni femminili del Partito Nazionale Fascista, Firenze, Leo Olschki,
2002, p. 250
35 Le informazioni sono tratte dal promemoria s.d. e s.f. contenuto in ASCS, MIF, b. 11, f. 39, sf.
9. In merito alla vicenda giudiziaria della donna, cfr. Franzinelli, M. Lamnistia Togliatti cit., p. 76.
36 Cfr ASCS, MIF, b. 84, Agenda del 1946.
37 Dittrich-Johansen, H. Le militi dellidea cit., p. 219.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 301 03/05/2013 11:11:21
302
Capitolo 6. Lampiezza di un margine. Genere, cittadinanza e politica nellItalia repubblicana
Chi non abbandon mai il proprio incarico di Vice segretaria generale del
Mif fu Elda Simeoni Norchi. Gi futurista nel 1912, giovanissima, era entrata
in contatto con Filippo Tommaso Marinetti e quindi aveva collaborato a Roma
futurista, da dove scriveva veementi invettive politiche con lo pseudonimo di
Futurluce rimase in ombra durante il Ventennio, laureandosi in Farmacia e spo-
sando il collega Arrigo Simeoni. Ritroveremo Elda Norchi solo nel 1944, come
componente del gruppo clandestino fascista Onore: questo, secondo Piero Igna-
zi, rappresent uniniziativa ben pi ef cace di resistenza agli Alleati rispetto al
tentativo sostanzialmente dannunziano del principe Pignatelli
38
. Arrestata in
seguito allo smantellamento di Onore, condivise la reclusione in campo di con-
centramento con Maria Pignatelli, di cui divenne unamica fdata.
Scorrendo i percorsi biografci di alcune delle appartenenti al nucleo dirigen-
ziale del Mif, limpressione di avere a che fare con delle sopravvissute. Ed esat-
tamente il fatto di avere una coscienza politica viva e una inusuale dimestichezza
con le pratiche e gli ambienti della politica che costituisce il comune denominato-
re tra queste donne, insieme a una provenienza sociale e culturale simile. Proprio
lomogeneit del proflo delle mif ne costituir anche il limite e il principale
motivo di estinzione dellassociazione: al suo interno, tanto al vertice quanto alla
base, non trovarono spazio quante si discostavano dal modello dominante, come
le appartenenti a ceti meno abbienti o a generazioni pi giovani.
Lutenza
Tra il 1946 e il 1953 gli assistiti dallassociazione furono 3323 (di cui 312 donne),
provenienti da tutta Italia e animati dai medesimi ideali. In breve tempo il Mif
ebbe fama di organismo autorevole e infuente, in grado di intercedere in favore
del singolo presso i sistemi di potere.
La maggioranza degli uomini si rivolgeva allorganizzazione per motivi perso-
nali. Per quanti erano in libert, le priorit erano il reintegro lavorativo in seguito
a epurazione, la ricerca di un impiego, lottenimento della liquidazione pensioni-
stica, il bisogno di procurarsi documenti o visti per lespatrio; i detenuti concen-
travano le proprie richieste sui beni primari viveri, indumenti, medicine e sulla
possibilit di essere assistiti legalmente.
Per quanto concerne le donne, 57 intercedono in favore di terzi, 236 si rivol-
gono allassociazione per soddisfare una necessit personale o familiare, nel caso
siano coinvolti i fgli. Un dato che emerge con nettezza dalle lettere delle utenti del
Mif lintraprendenza di queste donne: moltissime, infatti, furono costrette a una
38 Ignazi, P. Il polo escluso cit., p. 18.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 302 03/05/2013 11:11:21
303
2. Fondatrici, sostenitrici, utenti del Movimento Italiano Femminile
brusca responsabilizzazione per via della solitudine imposta dalle circostanze gli
uomini di famiglia, che fossero morti o dispersi in guerra, detenuti o latitanti, per
lo pi non erano al loro fanco.
Le esigenze personali sono le pi disparate, e fanno emergere un quadro in cui si
mischiano ingenuit, astuzie, disperazione. Molte preoccupazioni ruotano intorno
alla casa: case da riscaldare; case dove abitare; case che non si volevano abbandonare;
o le tante case di cui si reclamava la derequisizione. Anche la salute era una tematica
ricorrente nelle istanze delle assistite: erano donne sole, malate, o che non sapevano
come sopravvivere, per le quali un ricovero ospedaliero signifcava poter essere cura-
te, ma anche dormire in una stanza riscaldata e mangiare con regolarit.
Un nucleo corposo concerne le pratiche relative al sistema pensionistico (li-
quidazione, reversibilit o concessione di pensioni civili e di guerra): le utenti
contattavano il Mif talvolta per avere informazioni su come avviare una pratica,
pi spesso perch questo se ne interessasse, ponendosi come intermediario per
sollecitare il buon esito di una gi avviata.
Ma il lavoro a costituire il motivo preponderante per cui le donne contattava-
no il Mif: le richieste variavano dalla ricerca di unoccupazione allintercessione per
evitare il licenziamento, dalla raccomandazione per ottenere un posto statale o un
trasferimento alla domanda di referenze per un impiego. Le pi, tuttavia, si rivolsero
allassociazione di Maria Pignatelli perch epurate, spesso per aver aderito alla Rsi.
Impiegate pubbliche o insegnanti, sovente nubili, impegnate nel ricorso al Consiglio
di Stato o decise a intraprenderlo, chiedevano una consulenza legale o un intervento
del Mif che potesse favorirle, al fne di ottenere il reinserimento lavorativo.
Tra i fascicoli delle assistite, infne, un nucleo di particolare interesse riguarda le
detenute per motivi politici. Sono 43 i casi con cui il Mif entr in contatto, talvolta
in modo tangenziale, talvolta instaurando legami profondi. Alcune prendevano au-
tonomamente liniziativa di scrivere domandando assistenza sia legale sia materiale
dopo essere venute a conoscenza delle attivit e dellorientamento del Mif, magari
grazie alla segnalazione di una compagna di detenzione. Forse pi spesso, per, era
lo stesso Mif ad avvicinare le detenute, che si afrettavano ad accogliere, riconoscenti,
le piccole oblazioni in denaro, le brevi lettere dincoraggiamento o la possibilit di
usufruire gratuitamente dellassistenza legale che il movimento ofriva.
Certamente lappartenenza dei vertici del Mif allaristocrazia o quella di Sil-
verio Mattei alle alte gerarchie vaticane suscitava rispetto. indubbio, inoltre,
che gli assistenti ricoprissero una posizione di privilegio in rapporto alle assistite
e che queste avessero convenienza ad appoggiarsi allassociazione. Tuttavia sono
esigui i casi di assistite che esibiscano uno smaccato ossequio, e non casualmente
coincidono con quante avevano origini pi modeste e un minore livello di scola-
rizzazione. Le pi sembrano considerare che la comune fede politica potesse agire
da potente livella, dando loccasione di creare una relazione che non pu dirsi
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 303 03/05/2013 11:11:21
304
Capitolo 6. Lampiezza di un margine. Genere, cittadinanza e politica nellItalia repubblicana
orizzontale, ma neppure propriamente verticale, dal momento che ci si ricono-
sceva come parti di una stessa comunit. Ci non signifca che mancassero del
tutto stilemi e modalit di rappresentazione pi tradizionali la principessa venne
talvolta paragonata a una madre o a un angelo ma la consapevolezza di essere le
componenti di una famiglia, o le attrici di un progetto comune, era senza dubbio
pi pregnante.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 304 03/05/2013 11:11:21
3. La violenza femminile singolare
Stefania Voli
I gruppi della sinistra cosiddetta extraparlamentare che fanno ingresso nel conte-
sto politico italiano sul fnire degli anni Sessanta ponendosene non di rado al
centro acquistano valore di cesura nella storia politica italiana ed europea del
secondo dopoguerra
39
, attraverso forme di protesta e militanza nuove, concepite
e attuate da altrettanto nuovi attori sociali prima non presenti sulla scena pub-
blica. Questi si inseriscono nella crisi della rappresentanza dei partiti tradizionali
con pratiche, quale ad esempio la presa di parola in prima persona, portatrici di
una responsabilizzazione diretta e soggettiva che contribuisce alla percezione di s
come soggetto politico a pieno titolo
40
.
Proprio al fne di mettere in primo piano i nuovi attori che nel passaggio
di decennio acquistano ruolo di protagonisti, mi sembrato urgente fssare lo
sguardo sul terreno della soggettivit. In particolare, tornare per mezzo della nar-
razione autobiografca sui passi di coloro i quali negli anni Settanta si distinsero
come attori dellampliamento dello spazio politico e della rimessa in discussione di
quello privato (nonostante proprio sulle memoria si condensino le pi controver-
39 Tra i principali testi di riferimento: Teodori, M. Storia delle nuove sinistre in Europa (1956-
1976), Bologna, Il Mulino, 1976; Tarrow, S. Democrazia e disordine. Movimenti di protesta e politica
in Italia 1965-1975, Roma-Bari, Laterza, 1990; Lumley, R. Dal 68 agli anni di piombo, Firenze,
Giunti, 1998; Artires, P.; Zancarini-Fournel, M. 68 une histoirie collective, La Decouverte, 2008;
Dreyfus-Armand, G.; Frank, R.; Lvy, M.F. et al. (dir.) Les Annes 68. Le temps de la contestation,
Paris, Complexe, 2000 (II ed. 2008).
40 Tolomelli, M. Giovani anni Sessanta: sulla necessit di costruirsi come generazione, in Capuzzo,
P. (a cura di) Genere, generazioni e consumi. LItalia degli anni Sessanta, Roma, Carocci, 2003, p. 213.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 305 03/05/2013 11:11:21
306
Capitolo 6. Lampiezza di un margine. Genere, cittadinanza e politica nellItalia repubblicana
se questioni storiografche dedicate al periodo) ha reso possibile lindividuazione
di alcune delle intersezioni presenti tra eventi collettivi, esperienza individuale e
costruzione di soggettivit.
Soggettivit e approccio di genere sono, in questo percorso di ricerca, saldi
compagni di viaggio: donne e uomini attraversano lesperienza della militanza
nei gruppi extraparlamentari in modo diferente. , questa, una diversit che non
passa solo attraverso il genere, ma a volte lo fa soprattutto attraverso questo. Le
memorie consentono di osservare come donne e uomini si siano autorappresentati
durante (e dopo) lesperienza vissuta e di verifcare (se e) come tale autorappre-
sentazione abbia indirizzato il processo di costruzione delle identit di genere e la
ricostruzione della propria traiettoria biografca tout court.
In particolare, la questione della violenza politica si confgura come passaggio
cruciale nella soggettivazione dei singoli, per la capacit di tale tema di rivelare le
maggiori contraddizioni proprio allincrocio tra la memoria e lo sguardo di genere,
diventando crocevia nella creazione di una controversa memoria collettiva quan-
to di (auto)ripensamento individuale allinterno di quella esperienza. Proprio su
questo piano, lesperienza della narrazione femminile sembra giocare la sua partita
pi controversa.
Il 12 dicembre 1969 alla Banca Nazionale dellAgricoltura di Milano: la stra-
ge di Piazza Fontana si fssa nella memoria di molti testimoni come evento pe-
riodizzante, tanto a livello politico quanto individuale. Al clima di tensione che
tale momento instaura nel Paese, Lc reagisce con una maggiore strutturazione che
si traduce in una distribuzione del potere pi manifesta: lassegnazione di ruoli di
responsabilit messa in atto rende infatti esplicita lassenza delle donne nei posti
di gestione di unorganizzazione che ha molti vertici, quasi tutti di segno maschile.
Nonostante ci, attraverso le sue molte accezioni
41
la violenza e la sua te-
orizzazione entra a far parte della vita quotidiana di tutte e tutti i rivoluzionari
diventando un elemento collettivamente accettato o, comunque, accettabile
42
. Al-
meno inizialmente. Prima dellesodo, che si verifcher massiccio alla fne del 1976,
indubbio infatti che sia esistita anche tra le militanti una disponibilit, condivisio-
ne, adesione (con tutte le sfumature che le singole storie di vita mettono in campo)
che tuttavia, in sede di intervista va incontro a riaggiustamenti e risistemazioni con
specifche problematicit di genere. Anche per chi (almeno apparentemente) svolge
41 Se i servizi dordine si prestano facilmente come spazio di analisi della violenza politica agita nei
gruppi extraparlamentari esiste in realt una svariata gamma di pratiche e atteggiamenti difusi, che
andavano generalmente sotto letichetta di antifascismo militante, della quale gli scontri di piazza
non erano che un aspetto.
42 Passerini, L. Autoritratto di gruppo, Firenze, Giunti, 1988, p. 157.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 306 03/05/2013 11:11:21
307
3. La violenza femminile singolare
con disinvoltura i propri ricordi (si tratta per la maggior parte di uomini), quello
della violenza rimane infatti largomento che maggiormente va incontro a pause,
silenzi, intercalari, non ricordo, quasi che la memoria necessitasse ancora di spazio
e tempo per ricomporsi, situarsi nel presente, dotarsi di senso.
In tale atteggiamento narrativo non esiste una netta diferenza di genere:
questultima, semmai, passa attraverso gli appigli e i riferimenti che il linguaggio
e le memorie (soprattutto delle donne) si danno per farsi ricostruire, raccontare,
accettare, comprendere.
Con una evidente omogeneit, le interviste raccolte ritrovano nellineluttabi-
lit della difesa una delle interpretazioni pi salde della frammentata memoria
collettiva. Il riferimento al contesto di forte repressione in atto da parte delle isti-
tuzioni (insieme alla crescente presenza neofascista) il punto da cui ogni testi-
mone fa partire il proprio ricordo e che pone le scelte di Lc prevalentemente in
termini di risposta necessaria, reazione inevitabile. Nella costruzione di tale
discorso per gli uomini come per le donne e oggi come allora il legame ideale
con la tradizione antifascista assume inoltre una forte valenza autogiustifcatoria
43
.
Nellesperienza del ricordare, lappartenenza di genere pu pilotare, ma
non determinare le diferenze narrative. Che siano tendenzialmente gli uomini
ad afrontare con maggiore disinvoltura la memoria della violenza agita cosa
quasi ovvia: Lc, come tutte le altre organizzazioni a essa omologhe, non estra-
nea allideologia di tradizione marxista-comunista della violenza rifondatrice che,
concretizzatasi durante la Resistenza nella fgura del partigiano, risale fno a quella
del rivoluzionario leninista e del cittadino in armi della rivoluzione francese. Un
condensato di combattentismo maschile vissuto come cifra naturale della lotta,
che esclude teoricamente a priori la presenza femminile
44
.
Proprio il rapporto meno scontato tra rivoluzionarie e violenza, fn dal primo
momento in cui questo si propone, impone alle militanti di Lc una problematizza-
zione che rispecchia la contraddizione della loro partecipazione a un contesto che va-
gheggia la radicale innovazione della societ, ma lo fa ricadendo nelle pi tradiziona-
li forme della politica (fortemente connotate quindi in senso maschile e maschilista).
Tale antinomia si traduce in un particolare registro narrativo che porta una
connotazione di genere (femminile singolare, non collettivo): ognuna delle ex
militanti (ma anche alcuni compagni) sembra fssare idealmente un limite di
defnizione, di tollerabilit, di condivisione e giustifcazione delluso della forza,
43 Come si legge anche in Sommier, I. La violence politique et son deuil, Rennes, Press universitaires
de Rennes, 1998, p. 82 e in Passerini, L. Autoritratto cit.
44 Cfr Bravo, A. Noi e la violenza. Trentanni per pensarci, in Bravo, A.; Fiume, G. (a cura di) Anni
Settanta, in Genesis. Rivista della Societ Italiana delle Storiche, III/1, Roma, Viella, 2004, p. 43.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 307 03/05/2013 11:11:21
308
Capitolo 6. Lampiezza di un margine. Genere, cittadinanza e politica nellItalia repubblicana
oltre il quale la reazione il disagio, il rifuto, la sottrazione. Mentre prima del-
lo sconfnamento si incontrano termini quali risposta, controviolenza, gioco
(che per quanto pericoloso ancora defnito come tale), ci che si trova oltre
descritto come una deriva, unesibizione, in cui la connotazione teatrale perde
il suo carattere ludico, restando solo come mera dimostrazione di forza, spesso
neppure aderente alla realt. Avvertita la possibilit di sconfnamento la reazione
riscontrata la deviazione del focus del proprio ricordo verso ambiti tradizional-
mente elettivi della presenza femminile, quelli cio che Anna Bravo defnisce le
seconde e terze fle della violenza
45
: incarichi accessori, non da protagoniste.
Ma la memoria difende se stessa cercando anche altre vie di fuga al racconto:
frugando nei ricordi in cerca di un episodio scatenante il distacco da un contesto e
una pratica politica che se fno ad allora era stata accettata, agita, dopo quel mo-
mento mette in atto una (totale o parziale) riconsiderazione. Inoltre i ricordi delle
ex militanti spesso associano la paura provata in presenza di violenza politica alla
dichiarazione di banale accettazione di questa. Lunione dei due elementi ha lef-
fetto (e forse lobiettivo) di allentare ulteriormente il legame tra donne e uso della
forza: accettare signifca acconsentire, approvare condizioni che, per defnizione,
non sono decise direttamente dal soggetto parlante, che lo stesso termine conse-
gna alla passivit (io accettavo, se loro dicevano che era giusto, andavo dietro).
Particolarmente appropriata in questo senso la rifessione della politologa ame-
ricana J.B. Elsthain a proposito degli stereotipi che cristallizzano il rapporto tra
donne e guerra (e, pi generalmente, i contesti di violenza):
La guerra degli uomini: gli uomini sono gli autori storici della violenza organiz-
zata. S, le donne sono state coinvolte ed stato chiesto loro di osservare, sofri-
re, fronteggiare le dif colt, portare il lutto, tributare onori, adorare, testimoniare
e lavorare. Ma sono stati gli uomini a descrivere e defnire la guerra, mentre le
donne ne sono state infuenzate: esse per lo pi vi reagiscono
46
.
La paura, assente nei ricordi maschili, accompagna con frequenza i racconti
delle ex militanti. La sua rievocazione, oltre a essere unemozione reale, si rivela
alloccorrenza anche sentimento utile: diversamente da quanto accade con gli
uomini, esso socialmente concesso (anzi intrinsecamente previsto) al soggetto
donna, facilmente spendibile nel momento in cui questo desidera afrancarsi dalla
partecipazione a eventi che creano confittualit nel processo di creazione del s.
Tendenzialmente si sar molto pi disposti a credere che sia una donna ad avere
45 Bravo, A. Noi e la violenza cit., p. 47.
46 Elsthain, J.B. Donne e guerra, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 228.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 308 03/05/2013 11:11:21
309
3. La violenza femminile singolare
paura di uno scontro fsico con le forze dellordine durante una manifestazione
decretando in questa situazione la sua efettiva estraneit rispetto a circostanze
di uso attivo della forza piuttosto che un uomo. Questultimo non natural-
mente estraneo a quel tipo di sentimento, ma culturalmente formato per essere
reticente ad ammettere per lo pi anche a se stesso di poterlo provare ed ester-
nare senza remore e senza stigmatizzazioni (da parte degli altri compagni ma
anche delle compagne). Risultato di tacite regole e aspettative che la tradizione,
limmaginario, il contesto creano e perpetuano.
Tuttavia importante sottolinearlo le storie di vita intervengono per sot-
tolineare quanto le diferenze possano essere molteplici e non passare necessaria-
mente attraverso le direttrici del genere, mostrando come le parti siano talvolta
scambiate, ma soprattutto come i confni non siano afatto chiari, le dicotomie per
nulla nette
47
. La violenza (il rapporto con questa) forza lidentit delle singole
(e dei singoli) e porta non di rado a una sospensione come si visto spesso di
carattere provvisorio e del tutto reversibile delle regole e delle tradizionali iden-
tit di genere
48
.
Esiste poi unaltra tipologia di paura: anche laddove il ricordo tende a sot-
tolineare il personale rifuto alla partecipazione diretta, negli atteggiamenti delle
militanti presente unaccondiscendenza dovuta alla forza di persuasione eserci-
tata dalle circostanze esterne (che fanno apparire le decisioni organizzative prese
dal gruppo come indotte, e quindi giustifcate), dai principi dellorganizzazione e
dal timore di emarginazione da questa. Nonostante in un secondo momento la ri-
fessione femminista arriver a mettere in discussione laspetto di coesione giocato
dalla violenza, durante i primi anni di militanza, per molte donne il desiderio di
non rimanere escluse dalla comunit di appartenenza si tradurr nella convinzione
o nel convincimento a doverci essere. Questo tanto pi vero parlando di vio-
lenza politica, la quale, come osserva Isabelle Sommier, diventa fondamentale sia
nel percorso di soggettivazione dei militanti sia in quello di coesione del gruppo:
cratrice de valeurs nouvelles, elle (la violenza politica, nda) est signe dappar-
tenance une communaut non seulement en marge du systme, mais en lutte
ouverte contre lui
49
.
47 Saraceno, C. introduzione alledizione italiana di Elshtain, J.B. Donne e guerra cit., p. 12. Le
storie di vita alle quali si fa riferimento, sono state raccolte durante il lavoro di tesi di dottorato di
chi scrive (Soggettivit dissonanti. Movimenti extraparlamentari nellItalia degli anni Settanta. Percorsi
biografci tra storia e memoria. Il caso di Lotta Continua a Torino, Universit degli Studi di Napoli
LOrientale, Dottorato Internazionale in Storia delle Donne e dellIdentit di Genere nellEt Mo-
derna e Contemporanea, VI ciclo).
48 Saraceno, C. in Elsthain, J.B. Donne e guerra cit., p. 13
49 Sommier, I. La violence politique cit., pp. 62-3.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 309 03/05/2013 11:11:21
310
Capitolo 6. Lampiezza di un margine. Genere, cittadinanza e politica nellItalia repubblicana
La possibilit di un confronto (personale e collettivo) sul problema della
violenza agita viene a essere eluso attraverso un ulteriore meccanismo che torna
con frequenza nei racconti femminili: il trasferimento del discorso su un diverso
piano, quello della subordinazione delle donne nellorganizzazione. Come sotto-
posta a uno sforzo di elaborazione complesso, forse doloroso, queste sembrano
adottare una tattica di ribaltamento: non avendo una memoria collettiva cui
aggrapparsi con sicurezza, cui delegare il registro narrativo, le testimoni spostano
il discorso dalla violenza agita a quella (direttamente o indirettamente) subita.
questultima infatti una forma di violenza che risulta pi accettabile alle stesse,
perch conforme alle tradizionali modalit di costruzione dellidentit femminile
e perch successivamente collocata dal movimento delle donne (cui molte delle
testimoni prenderanno parte) allinterno di uno specifco luogo di elaborazione e
trasposizione in parole. Appellarsi alla violenza subita signifca, in ultima analisi,
appellarsi a un registro narrativo, per quanto doloroso e controverso, meno di-
sturbante nel percorso di autorappresentazione, pi sostenibile individualmente e
collettivamente. Gioca a favore di questa trasposizione lesistenza di una memoria
collettiva consolidata che appartiene a Lc riguardante il ruolo del neofemminismo
nella messa in discussione dellintera storia dellorganizzazione, partita anche e
soprattutto dal confitto sulla questione della forza
50
.
Le testimonianze degli uomini come delle donne non negano in assoluto
lesistenza di una reale connivenza femminile con la violenza politica. Allo stesso
modo per il mancato confronto a livelli pi elaborati della memoria che sap-
piano cio smarcarsi dalle stereotipizzazioni non arriva neppure a mettere in
discussione la tendenza pacifsta che si tende ad attribuire alle donne come
una naturalit che non esiste o che si chiama naturale perch cos imposto
dal mondo esistente
51
. In questa mancata costruzione e articolazione di memoria
collettiva costituisce possibilit il fatto che la presenza delle donne in ambiti con-
sacrati al confitto attivo rappresenti semplicemente unassunzione dei tradizionali
modelli (maschili) di militanza, dovuta come gi detto al desiderio di integra-
zione, al timore di marginalizzazione.
Lontano dallesaurimento di una tale controversa e complessa questione,
possibile afermare che la violenza agita dalle donne rappresenta tuttora una pro-
blematica irrisolta nella memoria collettiva e nella storia, che sconta lassenza di
tematizzazione delle tensioni e delle contraddizioni implicate nellattivismo poli-
tico delle donne. In particolare, il farsi memoria dellesperienza delle ex rivoluzio-
50 Cfr Voli, S. Quando il privato diventa politico: Lotta Continua 1968-1976, Roma, Edizioni As-
sociate, 2006.
51 Passerini, L. Storie di donne e femministe, Torino, Rosemberg&Sellier, p. 75.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 310 03/05/2013 11:11:21
311
3. La violenza femminile singolare
narie subisce la problematicit che ha segnato in passato la partecipazione delle
donne alla Resistenza, che pure nella coscienza collettiva e iconografa dominante
stata la guerra giusta per eccellenza. Un tale vuoto di elaborazione collettiva,
non ha consentito di ridefnire radicalmente le identit di genere, in particolare
lidentit sociale femminile, nella societ pur fondata sulla Resistenza
52
. Non di
secondaria importanza segnalare come i principali testi riguardanti la partecipa-
zione femminile alla guerra di Liberazione inizino a essere pubblicati stimolati
anche e soprattutto dalla rifessione femminista a partire dal biennio 1976-77
53
,
quando la parabola dei gruppi extraparlamentari ormai volta al termine e molte
militanti sono entrate a far parte del movimento delle donne (nel quale forte la
tendenza a denunciare la violenza subita e quella introiettata piuttosto che quella
agita e condivisa), prediligendo, se non loblio, almeno unelaborazione pacifcata
del proprio s e contaminata dai discorsi pubblici tendenzialmente criminalizzanti
che su questa esperienza sono stati prodotti.
La combinazione di tutti questi fattori ha compromesso defnitivamente la
possibilit delle militanti dei gruppi extraparlamentari di riconoscere e appellarsi
per lelaborazione dei proprio ricordi a riferimenti storici e immaginari non
tradizionali assolvendo alla funzione di ricreare e garantire la posizione delle don-
ne come non combattenti e quella degli uomini come guerrieri
54
.
Tuttavia, un tale percorso anche esempio di come ottica di genere e storia
orale siano mezzi preziosi per restituire alle protagoniste una soggettivit oc-
cultata dalla storiografa, viziata dagli archetipi e gli stereotipi che le relegano, da
sempre, ma in particolar modo nella storia politica, ai margini, per usare le parole
scelte dal panel. Le autonarrazioni consegnano infatti la percezione che tale margi-
ne sia stato ampio, e che questo possa trovare proprio nellanalisi (transdisciplina-
re) la possibilit di dilatarsi e aggiungere parti a una storia che, come la memoria
che la racconta, si presenta ancora marcatamente frammentata.
52 Saraceno, C. in Elsthain, J.B. Donne e guerra cit., pp. 18-9.
53 Mi riferisco in particolar modo ai testi di Bruzzone, A.M.; Farina, R. La resistenza taciuta. Dodici
vite di partigiane piemontesi, Milano, La Pietra, 1976 e di Guidetti Serra, B. Compagne, Torino,
Einaudi, 1977.
54 Elsthain, J.B. Donne e guerra cit., p. 38.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 311 03/05/2013 11:11:21
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 312 03/05/2013 11:11:21
CAPITOLO 7
Il fare politica e il fare societ delle donne
negli anni Settanta: voci, esperienze, lotte
a cura di Beatrice Pisa
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 313 03/05/2013 11:11:21
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 314 03/05/2013 11:11:21
Introduzione
Beatrice Pisa
Gli anni Settanta, periodo di mutamenti epocali a livello macrosistema come a
livello locale e personale, costituiscono un periodo di dif cile lettura. Il culmine
e poi lesaurirsi della fase della prosperit economica e della stabilit fnanziaria, il
repentino mutamento di prospettive economiche e culturali hanno condotto a un
incrociarsi e sovrapporsi di dimensioni e piani diversi, a un alternarsi repentino di
modifche sostanziali che hanno disarticolato le realt culturali, sociali istituzionali
ed economiche riorganizzandole in maniera molteplice con inattesi esiti collettivi
e individuali.
solo da qualche anno che il mondo degli storici e delle storiche ha preso
atto della crucialit del periodo per una lettura complessiva del secondo dopo-
guerra, focalizzando lattenzione sulla stagione dei movimenti, sulla scolarit di
massa, sul nuovo mercato dei consumi, sulle inef cienze istituzionali, sul disagio
della condizione operaia, sul paese mancato per dirlo con il titolo del fortunato
libro di Crainz. Cos, mentre lopinione pubblica e i manuali scolastici ancora
stentano a concepire la svolta degli anni Settanta come una fase di mutamento
epocale, fnendo spesso per appiattirne la complessit e la vivacit sociale e politica
nellimmagine fn troppo utilizzata degli anni di piombo, essa si pone sempre
pi chiaramente come espressione di un modello di modernizzazione contraddi-
torio e soferto come quello italiano, radice dei futuri inattesi esiti politici e sociali:
dallintensifcarsi dei corporativismi e dei localismi, al progressivo degrado del
sistema politico, fno al difondersi di progetti di sviluppo personali e complessivi
indiferenti al rispetto delle regole.
Questa raccolta di saggi parte dalla convinzione che in quel periodo ricco
di contraddizioni si svilupp una intensissima attivazione di energie positive, la
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 315 03/05/2013 11:11:21
316
Capitolo 7. Il fare politica e il fare societ delle donne negli anni Settanta: voci, esperienze, lotte
quale dette luogo a una fase irripetibile di conquiste sociali, culturali e legislative
che cambiarono il volto della nostra societ. E allinterno di questa fase il nuovo
protagonismo delle donne ha costituito ingrediente e reagente fondamentale, ri-
voluzionario e sovvertitore supplemento, come ha scritto Gabriella Bonacchi,
allinterno di una storia in veloce e tumultuoso movimento. Se le culture e le pra-
tiche politiche delle donne emergono come la sostanziale discontinuit di quegli
anni, la vera messa in discussione degli assetti tradizionali, allora diventa partico-
larmente rilevante proseguire il lavoro di indagine ormai iniziato in sede storica
allargandolo agli ambiti meno scontati e alle interconnessioni non ancora del tutto
analizzate di un percorso vissuto nella molteplicit dei luoghi dellesperienza sog-
gettiva e collettiva delle donne, negli spazi intermedi fra vissuti personali, movi-
menti e partiti. Una evoluzione fatta di presenze e di assenze, di andamenti lineari
e di fratture, di nuove parole come di antichi silenzi, che occorre porre in relazione
alle logiche del grande mutamento allinterno del Paese, ovvero al defnirsi del
nostro modello di modernizzazione, con le sue particolarit e le sue involuzioni.
Gli studi che qui si presentano si propongono di ofrire un contributo al ten-
tativo ormai in atto in sede storiografca di ricostruire un quadro tanto complesso
e non raramente incoerente, seguendo gli aspetti meno indagati di una evoluzione
cresciuta in collegamento a volte stretto e a volte poco evidente con gli ambiti e le
espressioni pi immediate della efervescenza sociale di quegli anni: nelle strade,
nelle piazze, nei piccoli gruppi, ma anche nelle scuole, nelle sedi dei partiti, nei
sindacati e nelle articolazioni meno conosciute o considerate dello stesso movi-
mento femminista.
Il lavoro di Stefania Boscato, utilizzando per la prima volta in maniera in-
tensa e approfondita larchivio del Mf della Dc, esamina il vissuto politico delle
donne appartenenti a questo movimento, giungendo a conclusioni innovative,
a tratti inattese. I meccanismi partitici e le opportunit politiche hanno infatti
fno a questo momento tenuto in ombra il ruolo critico di queste rispetto alle
modalit di gestione del potere da parte del partito e al suo percorso organizzativo
e politico. Da questo saggio emerge invece un inedito ruolo di coscienza critica,
di sollecitazione in senso progressista di queste donne, che and dallappoggio
dato da alcune negli anni Sessanta alle proposte di allargamento a sinistra, fno
alle espressioni in favore di una reale parit fra i coniugi e, perfno, in favore del
divorzio. Non manc, a tratti, neppure la capacit di riattraversare e reinterpretare
gli orientamenti pastorali e i dogmi religiosi, dato signifcativo per la tendenza che
segnala a tenere separate le dimensioni politiche da quelle confessionali.
Le democristiane non solo polemizzarono contro lincredibile scarsit delle
candidature femminili presentate nelle liste del partito e contro limpossibilit del-
le donne di accedere a posizioni di responsabilit al suo interno, ma criticarono la
sua sempre pi accentuata involuzione in senso oligarchico e la sua strutturazione
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 316 03/05/2013 11:11:21
317
Introduzione
correntizia. E anzi, nelle considerazioni di Boscato, stato proprio il rifuto della
dirigenza partitica di ascoltare le istanze provenienti da queste donne, come quelle
provenienti dal movimento giovanile, che ha defnito il graduale percorso di allon-
tanamento della Dc dalle istanze di base, che avrebbe signifcato involuzione clien-
telare e correntizia, ma anche insuf cienza della iniziativa politica. Aver assunto
langolo di osservazione della parte femminile conduce infatti a spiegare alcuni
momenti fondamentali della vita della Dc, come ad esempio la sconftta referen-
daria del 1974. Secondo lautrice lincredibile impreparazione del partito rispetto
al tema famiglia era legata alla incapacit sostanziale di comprendere e ofrire cit-
tadinanza politica alle istanze provenienti dalle donne. La delega fduciaria a
esse di una serie di temi sentiti come femminili fniva per determinare una assenza
politica del partito di notevole portata e conseguenze. Il problema di fondo che si
pose sempre a queste attiviste fu dunque quello della integrazione politica e orga-
nizzativa del Mf nel partito, della alternativa fra agire politicamente come donne,
ma ricevere assai scarsa considerazione, oppure superare la separatezza e accettare
una integrazione in modalit e tematiche in cui non potevano interamente rico-
noscersi. A parere dellautrice, queste rifessioni furono sollecitate in maniera non
secondaria dallirrompere sulla scena politica del movimento femminista.
Anna Balzarro, nel considerare gli orientamenti del mondo della scuola nel
corso degli anni Settanta, in rapporto alla notevole femminilizzazione del corpo
insegnante in quegli anni, esprime una considerazione simile in merito alla capa-
cit di infuenza delle culture femministe. Il suo lavoro, in particolare, osserva il
mondo della scuola da un angolo di osservazione originale e mai utilizzato fno
a questo momento: quello delle riviste del movimento delle donne, e in partico-
lare della pi nota e longeva di esse, Efe. Dallanalisi di quanto appare sulle sue
colonne emerge lesistenza di un rapporto circolare fra movimento femminista e
mondo della scuola che fnisce per qualifcare la scuola degli anni Settanta come
un laboratorio di idee e di speranze. Dalla intensa rete di relazione che ne sca-
tur, ricca di proposte e interventi, si originarono esiti che non appaiono del tutto
soddisfacenti, ma rispetto ai quali lautrice suggerisce di utilizzare uno sguardo
pi attento alle dimensioni meno ovvie ed evidenti. Alcune novit che si introdus-
sero in quegli anni, come labolizione della diferenza fra esercitazioni maschili e
femminili, ma pi in generale il processo di presa di coscienza di molte insegnanti
che scatur dalla nuova atmosfera culturale che il movimento delle donne difuse,
costituiscono infatti a parere dellautrice esiti apparentemente poco eclatanti, a
volte sotterranei, ma tuttavia capaci di incidere in maniera sostanziale sul substra-
to culturale di massa.
Il mio contributo di ricerca sceglie di mettere a fuoco la fase di maggiore
espansione e presenza sulla scena politica del movimento delle donne, evidenzian-
do come fossero attivi in quegli anni femminismi diversi per formazione, cultura,
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 317 03/05/2013 11:11:21
318
Capitolo 7. Il fare politica e il fare societ delle donne negli anni Settanta: voci, esperienze, lotte
modi di agire, che trovarono momenti di incontro, di contaminazione, di sinergia
di particolare intensit. Lo scritto si concentra sul laico e libertario Mld, la cui
vicenda appare particolare nel panorama dellepoca per la sua origine radicale, per
la scelta di continuo confronto/ scontro con le istituzioni, per la sua identit di
femminismo del fare e del rivendicare, per la sua organizzazione a livello naziona-
le. Ma anche per la sottovalutazione di cui stato oggetto. Stretto fra le due grandi
identit e appartenenze politiche e culturali che hanno caratterizzato il nostro Pa-
ese a partire dagli anni del dopoguerra, quella cattolica e quella comunista, riusc a
esprimere una azione intensa, capace di coinvolgere molte donne, ma condannata
allisolamento e allesaurimento. Federato inizialmente al Pr, ha vissuto una con-
danna epocale da parte del resto del femminismo che si attenuata solo nel corso
degli anni Settanta, quando si incontr con le spinte rivendicazioniste di una parte
del movimento, dando vita agli anni in cui il femminismo si espresse con una ten-
sione politica non pi ritrovata. Ma la sua identit politica e il ruolo centrale che
ebbe nel corso degli anni Settanta non hanno avuto fn qui riscontro storiografco.
Impossibile nellet dei movimenti, quando lurgenza dellazione rendeva dif cile
ogni rifessione teorica. Improponibile in seguito, di fronte al continuo perdere
terreno delle culture laiche, alla crescente sordit dei partiti nei confronti delle
istanze delle donne, allegemonia assunta allinterno del movimento delle donne
dal femminismo della diferenza, tutto improntato sulla rifessione flosofca e psi-
coanalitica, indiferente al rapporto con le istituzioni e con la norma.
Il lavoro di Rossella Del Prete, infne, partendo dallo Statuto dei lavoratori del
1970, presenta un signifcativo contributo a quello che pu essere considerato il
tema di fondo delle rifessioni sulla storia della condizione delle donne, quello del
lavoro, inteso sia come momento di espressione della dignit e identit individuale
che come possibilit di realizzare il reddito necessario allindipendenza personale.
Non stupisce quindi che il tema scorra in maniera sotterranea in tutti gli scritti che
qui si presentano. Anche se il neofemminismo degli anni Settanta, maggiormente
attento ai problemi del corpo e della sessualit, non concentr lotte e rifessioni
su tale questione e anzi se ne tenne lontano, per quanto di emancipatorio il tema
aveva sempre suscitato, lasciandolo alle donne pi vicine ai partiti e ai gruppi
extraparlamentari.
Il pregio del lavoro di Del Prete quello di cogliere loccasione del quaranten-
nale della legge 300 per tratteggiare in breve il percorso contraddittorio e acciden-
tato delle culture del lavoro che si sono afermate nel nostro Paese, giungendo a
un giudizio netto sul valore e signifcato di tale legge dal punto di vista della realt
delle lavoratrici. E bisogna dire che fno a questo momento non moltissime stu-
diose si sono cimentate nellimpegno di mettere a fuoco le dimensioni giuridico-
dottrinarie con ottica di genere, per la dif colt di contestare lastrattezza della
norma e di trovare momenti di incontro con una cultura femminista a partire
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 318 03/05/2013 11:11:21
319
Introduzione
dagli anni Ottanta impegnata a coltivare una intensa estraneit alle dimensio-
ni istituzionali e normative. Lo Statuto del 1970, punto di snodo fondamentale
dei diritti sindacali e del lavoro nel nostro Paese, costituisce invece momento di
rifessione irrinunciabile per chiunque si voglia occupare della storia del lavoro
femminile. Resta a dimostrarlo lintensit delle critiche, degli attacchi, dei progetti
di revisione e viceversa delle appassionate difese di cui la legge del 1970 stata
oggetto. Oggi, in particolare, ci troviamo di fronte a progetti di modifca da parte
governativa tanto radicali da annullarne del tutto le potenzialit.
Il problema della inadeguatezza di tale norma di fronte ai profondi mutamenti
che i processi di modernizzazione e di globalizzazione hanno prodotto nel mondo
del lavoro particolarmente complesso se si assume il punto di vista del percorso
culturale e normativo della realt lavorativa femminile. La legge 300 infatti vede
la luce in un momento in cui non solo ancora non si parlava di culture di genere
n di pari opportunit, ma in cui la legislazione italiana non era neppure giunta a
fare proprio il concetto di parit fra i sessi. Eppure tale legge contiene una esplicita
normativa antidiscriminatoria che, nota lautrice, si qualifcata indispensabile
apripista per tutte le norme che sarebbero venute in seguito. La questione se la
ristrettezza delloperativit di tale principio abbia conferito una certa debolezza
alla legislazione antidiscriminatoria italiana, con gravi ricadute sulla regolamenta-
zione del lavoro delle donne. Inoltre, possibile domandarsi se proprio la quan-
tit e lampiezza delle normative in tema di parit, non discriminazione e pari
opportunit approvate nel nostro Paese a partire dagli anni Ottanta, specie per
impulso dellordinamento comunitario, non qualifchi la legge 300 come obsole-
ta. Ulteriori dubbi sulla validit di tale legge vengono avanzati rispetto allassenza
al suo interno di regolamentazioni riguardanti la strutturazione delle defnizioni
di mansioni femminili e maschili, che il sistema tayloristico ha perfezionato nel
tempo, relegando le donne ai lavori pi umili e meno qualifcati. La questione,
di notevole portata per comprendere la costante dequalifcazione dellesperienza
lavorativa femminile, in rapporto al formarsi e al persistere delle rappresentazioni
delle identit dei due generi, ancora sofre di una sostanziale carenza di studi e
rifessioni. Ma lautrice sottolinea che anche per questi aspetti occorre far riferi-
mento al principio generale e fondante dello Statuto, il quale richiama comunque
al rispetto della dignit della persona del lavoratore (e della lavoratrice!) in netto
contrasto con il rigido e gerarchizzato assetto della piramide taylorista.
La conclusione, rilevante per la chiarezza della esposizione, che la legge 300,
che applic nei luoghi di lavoro i principi costituzionali, per uomini e donne,
pi attuale che mai, perch costituisce normativa di indirizzo fondamentale e
irrinunciabile, che sofre essenzialmente di un male tipicamente italiano: quello
di non aver ricevuto completa attuazione. Unica critica sembra quella della man-
canza di uno sguardo di genere nella defnizione del suo stesso nome: ma luso
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 319 03/05/2013 11:11:21
320
Capitolo 7. Il fare politica e il fare societ delle donne negli anni Settanta: voci, esperienze, lotte
del termine maschile lavoratori appare essenzialmente una carenza di rifessione
semantica dovuta al momento storico in cui la legge stata varata, carenza che
non pregiudica il valore di una legge fondante del sistema dei diritti nel campo del
lavoro, per entrambi i sessi.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 320 03/05/2013 11:11:21
1. Il nesso liberazione / emancipazione:
lesperienza del Movimento Liberazione
della Donna
Beatrice Pisa
La scelta di focalizzare lattenzione sul Mld espressione non solo di unurgenza
personale, ma anche della scommessa di incrociare la memoria della testimone
con lo sguardo pi consapevole e rigoroso di chi fa storia, che pu approfttare
della prospettiva di lungo periodo e dellacquisizione di un metodo di indagine.
Proprio dal senno di poi di chi guarda indietro, a un trentennio di distanza,
scaturita la mia convinzione che la vicenda del Mld si pone in modo del tutto
originale nella storia politica delle donne di quegli anni per la capacit di porsi al
centro di una serie di battaglie cruciali in quegli anni nonostante la dimensione
(numericamente) minoritaria del suo femminismo laico e libertario. Quello che
pare rilevante della storia di questo gruppo inoltre non solo limprinting che
questa origine politica ha comportato, ma soprattutto il percorso di maturazione
che essa ha comportato.
Le battaglie, le istituzioni, il partito
Il Mld nasce fra il 1970 e il 1971 come gruppo federato al Pr su un progetto di li-
berazione antipatriarcale, antiautoritario, anticlericale e anticapitalista. Non origi-
na quindi dal piccolo gruppo, n dalla pratica di autocoscienza. Le sue richieste
confgurano una rivoluzione culturale sociale e politica, le sue battaglie puntano
sulla provocazione e sulla disobbedienza civile, ma nei termini di applicazione
delle norme e libert costituzionali e realizzazione dello stato di diritto.
Lorigine partitica e il riferimento allarea laica-libertaria sono stati motivo di
una condanna epocale da parte del movimento femminista che venuta meno o si
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 321 03/05/2013 11:11:21
322
Capitolo 7. Il fare politica e il fare societ delle donne negli anni Settanta: voci, esperienze, lotte
attenuata solo in una breve stagione. Una stagione in cui lattitudine del Mld a
un femminismo del fare e del rivendicare si incontrata con le progettualit di al-
cuni settori di un movimento in quegli anni in tumultuoso sviluppo, dando luogo
a una intensa e forse irripetibile fase di lotta e di protagonismo delle istanze delle
donne. Negli anni Settanta il MLd si trova in efetti al centro di quelle iniziative
e di quelle esperienze che hanno costituito il fulcro delle lotte femministe: i primi
consultori self-help, le lotte sullaborto, il centro di accoglienza per le donne pic-
chiate, la prima elaborazione della legge contro la violenza. Si deve anche al Mld
loccupazione della prima casa delle donne in Roma nel 1976, nonch la scelta di
aprirla a tutte, facendo diventare questo luogo un punto di incontro di culture ed
esperienze diverse, vero crogiuolo di quella politica di rivendicazione nel reale che
contraddistingue lazione del movimento femminista in quegli anni.
Il Mld eredita dal Pr la sua forma organizzativa, comprensiva di congressi,
mozioni, odg, cariche sociali ma, con il passare degli anni, il crescere di un vissuto
politico di genere mette progressivamente in questione tutte queste strutture.
Daltra parte la sua stessa dimensione nazionale (nel 1976 si contano ben 48
collettivi in varie citt italiane) che richiede una qualche forma di organizzazione
interna. Si sviluppa cos un percorso tormentato ma estremamente vitale di ricerca
di un assetto organizzativo in grado di tenere insieme lotta al verticismo e imme-
diatezza dellintervento, spazi di espressivit per ciascuna e conduzione ef cace.
Insomma si sperimenta lesercizio della democrazia dal punto di vista delle donne.
La proposta di continuo rapporto con le istituzioni, con la norma, come con
il mondo dei massa media, il metodo che il Mld propone al resto del movimen-
to, eppure fonte di continui dubbi e continue rifessioni.
Fra i rapporti pi rifettuti soferti di sicuro quello con il Pr: per alcune (le
attiviste della prima ora) fonte di rassicurazione e sostegno, per le donne che man
mano si vanno aggregando intralcio crescente, per tutte occasione di confronto
e scontro con la politica partitica. Lispirazione delle battaglie del Mld in efetti
allinizio oferta dal Pr, ma ogni tema rivisto, rimodellato e rivisitato.
Come nel caso della battaglia per il 50% dei nuovi posti di lavoro alle donne
che, ispirata dai radicali pi vicini alla cultura americana, ha il merito di introdur-
re in Italia, molto in anticipo sui tempi, la questione delle pari opportunit, della
valorizzazione della paternit, del superamento delle disposizioni di tutela. La rie-
laborazione che se ne fa nel Mld la rende la prima battaglia gestita interamente in
proprio, vera a propria speranza di defnizione di una nuova autonomia e di una
rinascita politica e identitaria.
Anche la battaglia sullaborto, che si pone alla base della nascita stessa del
Mld, pare inizialmente ereditata dal Pr, dal quale si riprendono modalit di lotta e
anche lidea che si tratti di un diritto civile da assicurare alla cittadinanza. Tuttavia
ben presto lesperienza fatta nei consultori autogestiti avvia un mutamento pro-
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 322 03/05/2013 11:11:21
323
1. Il nesso liberazione/emancipazione: lesperienza del Movimento Liberazione della Donna
fondo di prospettive, che signifca per il Mld incamminarsi verso una dimensione
della lotta non pi condivisibile con i compagni radicali. Nota Liliana Ingargiola:
Lincontro con il corpo e lutero femminile, nel consultorio self help e nella pra-
tica dellaborto, fu lincontro con il nostro corpo: non pi scisse fra ruolo politico
e vissuto personale. N i radicali n le radicali possono condividere tale pratica
giudicata eccessiva e non politica, uno scendere inaccettabile nella materialit del
corpo, rinunciando quindi alla funzione di guida e di orientamento che invece do-
veva costituire la caratteristica del Mld
1
. Probabilmente anche lidea di aprire un
centro di accoglienza per donne picchiate ispirata dalle esperienze Usa riportate
dai compagni radicali. Ma la realt vissuta sul campo nei consultori che accol-
gono donne di tutte le estrazioni sociali, culturali e politiche, rimodella progetti,
modalit, fno a rivedere dalla radice cosa signifchi fare politica.
Lallontanamento dal Pr avviato in parte (e con dif colt) da alcune delle
componenti del movimento pi vicine al partito, ma poi reso inevitabile dal
moltiplicarsi dalle esperienze di incontro con le altre: nei consultori, ma anche
ai tavoli di raccolta frme, nel crescere e moltiplicarsi degli stessi collettivi Mld che
si formano o si allargano sullonda del coinvolgimento nelle iniziative.
Particolarmente signifcativa lesperienza delloccupazione della nuova sede
di via del Governo Vecchio nellottobre 1976, che avvia un processo di crescita e
di revisione nei metodi, nelle prospettive e nella stessa composizione del movi-
mento, rendendo evidente, fra le altre cose, lincolmabile lontananza che si de-
terminata con il partito, defnitivamente sanzionata con la sfederazione del 1978.
Loccupazione infatti non solo porta allimmissione di molte donne provenienti
da esperienze e culture diverse, ma consente e sollecita un confronto e una crescita
comune con gruppi e collettivi femministi di diversa formazione ed estrazione.
La decisione di aprire a tutte le realt del femminismo, infatti, assai soferta per il
timore che suscita in molte compagne Mld di perdere la propria individualit di
movimento, sanziona la scelta di collocarsi allinterno del movimento femminista,
mantenendo comunque la propria originalit politica.
Il che segnala un altro tratto tipico del Mld, quello di oscillare fra scelta iden-
titaria e disponibilit ad aprirsi alle presenze e ai contribuiti delle altre donne:
attitudine questultima che a volte si rivela destabilizzante, fonte di smarrimento
e tensioni.
1 Ingargiola, L.; Cucchi, M. Dialogo sul Movimento di Liberazione della Donna, in Memoria,
1987, nn. 19-20, p. 60.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 323 03/05/2013 11:11:21
324
Capitolo 7. Il fare politica e il fare societ delle donne negli anni Settanta: voci, esperienze, lotte
Lo strumento legge e la pratica femminista
Il Mld si muove sempre sullo scomodo crinale fra rivendicazione dellautodeter-
minazione delle donne, disobbedienza civile e richiesta di legalit. Compie scelte
eversive, ma nello stesso tempo si pone come custode dellordine.
La prima grande battaglia quella sullaborto. Gi al primo congresso, feb-
braio 1971, il Mld presenta una bozza di progetto di legge di iniziativa popolare
per un aborto libero, gratuito e assistito, lanciando una campagna nazionale per
la raccolta delle frme necessarie. Nel progetto si prevede labrogazione del titolo X
del codice penale riguardante i delitti contro lintegrit e la sanit della stirpe, non-
ch lobbligo per ospedali, cliniche o case di cura sovvenzionate di assicurare anche
il servizio sanitario per laborto volontario e per la consulenza circa ogni mezzo
anticoncezionale
2
. La prospettiva di fondo evidenziata da Adele Faccio: senza
libert sessuale, senza libert di gestione del proprio corpo non si pu dare nessun
tipo di libert [..] Il sesso essenza stessa della vita. Chi lo deforma deforma la vita
3
.
Nei mesi e negli anni seguenti ci saranno le autodenunce, le conferenze
stampa, i picchettaggi sotto il parlamento, i cortei, i sitting-in, i volantinaggi e
la provocatoria costituzione dei gruppi self-help aborto. Intanto il tema, che stava
ponendosi allordine del giorno in tutto il mondo occidentale, si imponeva allat-
tenzione anche del nostro Paese, suscitando una serie di prese di posizione da parte
del mondo della cultura, della scienza, della politica. Anche il mondo cattolico
non mancava di esprimersi: dal Papa, alle Acli, fno ai cattolici per il socialismo.
Suscitare il dibattito aperto nelle piazze e nella stampa fu il primo grande successo
[del Mld], si commenta dallinterno del movimento
4
. Tutti i partiti elaborano
proprie proposte di legge, fno a che si giunge al testo che poi sar approvato, che
il Mld defnisce legge trufa, ambigua e antifemminista
5
, sulla quale tenta di
intervenire con una serie di proposte, che nascono dalla pratica di autogestione del
corpo e della salute, vissuta nei consultori self-help
6
. Solo la minaccia referendaria
dellinizio degli anni Ottanta porter a passare alla difesa della legge 194.
La battaglia per laborto condotta dal Mld suscita fn dalle prime battute lop-
posizione del gruppo di Rivolta femminile, di quello della Libreria delle donne di
2 Si veda il testo della proposta in Mld. Campagna per labolizione del reato di aborto in Italia,
in Corriere della sera, 22 maggio 1971.
3 Faccio, A. Due parole sul Mld, in Roccella, E. (a cura di) Cisa-Mld, Aborto Facciamolo da noi,
Roma, ed. Roberto Napoleone, 1975, pp. 7-13.
4 Mld, la lotta per laborto, ivi, p. 29.
5 Documento del C.F. e del Collettivo consultori del Mld, in Bollettino Mld 4 aprile 1977, n. 10.
6 La Nuova Luna, mensile del Mld, n. 2, ottobre 1977.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 324 03/05/2013 11:11:21
325
1. Il nesso liberazione/emancipazione: lesperienza del Movimento Liberazione della Donna
Milano, e del collettivo di via Cherubini a Milano, a partire dalla considerazione
che laborto, illegale o legale, [] parte integrante e segno di una sessualit an-
cora subalterna al desiderio maschile, che laborto di massa negli ospedali non
rappresenta una conquista di civilt perch una risposta violenta e mortifera al
problema della gravidanza
7
. Quello che si chiede che gli uomini pongano in
discussione il loro rapporto sessuale e che il movimento delle donne esprima au-
tonomia di analisi e di pratica. Da un punto di vista concreto tuttavia le proposte
alternative non sono chiare: la soluzione avanzata sembra quella della semplice de-
penalizzazione, che tuttavia pare troppo vicina alla iniziale posizione del Mld per
rendere ragione di un atteggiamento tanto critico. Di sicuro emerge una profonda
avversione a ogni esito normativo, a ogni ricerca di legge giusta, che si riproporr
con maggiore intensit rispetto alla legge contro la violenza.
La battaglia contro la violenza
Dai problemi drammaticamente proposti dalle tante af uite al centro contro la
violenza Mld e dalla sensazione collettiva che bisognava fare qualcosa, nasce gi
nel 1977 il progetto di modifcare leggi e procedure penali arcaiche e ofensive
per le donne
8
. Lanno della grande discussione sar 1979 quando dalla capitale,
e in special modo da quella originale dimensione comunitaria cresciuta nelle sale
polverose del Governo Vecchio, prende le mosse una iniziativa politica singolare
per larco delle forze coinvolte, ma anche per le conseguenze che porta allinterno
del movimento. Mld, Udi, collettivo di Pompeo Magno, le riviste delle donne, la
Fln donne, vari collettivi costituiscono un Comitato promotore impegnato nella
raccolta di frme per una legge contro la violenza, da presentare in parlamento.
Siamo gi in una fase defnita dai giornali di rifusso: mentre let dei mo-
vimenti afonda di fronte al crescere della violenza politica e la crisi economico-
fnanziaria avvia lavvento della societ post-industriale e post-solidale, si prepara
per una parte del movimento delle donne una signifcativa stagione di lotte. Li-
niziativa galvanizza forze disperse e attira nuove reclute: in tutto il paese nascono
comitati promotori permettendo cos la raccolta di pi di trecentomila frme e
anche lapertura di un notevole dibattito a livello nazionale.
Inizia cos un iter che durer nientemeno che una ventina di anni, in una in-
terminabile schermaglia fra movimento delle donne, logica partitica e istituzionale.
7 Libreria delle donne di Milano, Non credere di avere dei diritti, Torino, Rosemberg & Sellier,
1987, p. 61 ss. Questo testo riporta anche documenti di Rivolta Femminile del 1971.
8 Collettivo contro la violenza delle donne del Mld, Racconto di un anno di lavoro, Roma via del
Governo Vecchio 39, p. 1, s.d., [ma 1977].
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 325 03/05/2013 11:11:21
326
Capitolo 7. Il fare politica e il fare societ delle donne negli anni Settanta: voci, esperienze, lotte
sicuramente signifcativo che per cancellare una norma che defnisce lo stupro
un reato contro lonore e non contro la persona siano necessari venti anni di scherma-
glie parlamentari, ma egualmente notevole che questa battaglia faccia esplodere una
confittualit allinterno del movimento femminista mai sperimentata in precedenza.
Il femminismo dellinconscio e la cultura della diferenza espressi dai gruppi
milanesi che fanno capo alla Libreria delle donne e al collettivo di via Cherubini
portano culture che si sommano alle rivendicazioni antisistema della sinistra an-
tagonista, dando forza a una dimensione di estraneit femminile alla norma e alle
istituzioni che probabilmente non ha eguale nel mondo occidentale. Mentre le
compagne Mld intendono far divenire lo stupro e la violenza casalinga questio-
ni politiche, da altri settori del movimento si alza un richiamo appassionato al
tenersi fuori. Fra i tanti interventi in questo senso quello di Luisa Muraro che
si pronuncia drasticamente contro una legge che vuole spingere le donne nella
disciplina pubblica, che le vuole far divenire cittadine alla pari con gli uomini
9
.
La paura della contaminazione con listituzione pi intensa del bisogno
di difendersi dallo stupratore e la dif denza nei confronti della norma tanto
profonda da condurre allequazione: norma eguale violenza. Questo spinge a eli-
minare ogni referente forte al di fuori del soggetto, rendendo dif cile elaborare la
dimensione del diritto e quindi della giustizia e della pena. Insomma il confronto
sulla violenza si fonde in maniera inscindibile con le rifessioni in merito al rap-
porto con le istituzioni. Il dissidio fondamentale pare essere fra coloro per le quali,
come ha recentemente sottolineato Emma Baeri, lopzione legislativa in merito
alla violenza sessuale ha sollecitato un immaginario violento e quelle per le quali
invece tale opzione viene vissuta come un modo per arginare e controllare lim-
maginario pi violento e feroce allinterno di una cornice defnita e serenamente
considerata
10
. La possibilit di stabilire un qualche rapporto di scambio e di pres-
sing con la norma consente a queste ultime di passare dallo scacco e dalla ferocia
allelaborazione di una dimensione civile di genere.
Si chiude una fase
Alliniziativa sulla violenza contro le donne seguono due battaglie connotate egual-
mente da un deciso atteggiamento rivendicazionista verso le istituzioni, ma assai
9 Medi, E.; Masotto, G.; Motta, S.; Jucker, S. (a cura di) Contro la violenza sessuale. Le donne
la legge. Incontro aperto di donne. Atti del convegno tenuto a Milano, Umanitaria 27-28 ottobre
1979, supplemento a Non detto Pagine di donne, Milano, ciclostilato.
10 Baeri, E. Cerniere di cittadinanza, Il protagonismo femminile negli anni 70, in Filippini,
N.M.; Scattigno, A. Una democrazia incompiuta. Donne e politica dall Ottocento ai nostri giorni,
Milano, Franco Angeli, 2007, p. 165.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 326 03/05/2013 11:11:22
327
1. Il nesso liberazione/emancipazione: lesperienza del Movimento Liberazione della Donna
meno contestate allinterno del movimento: la lotta per i no ai due al referendum
contro la 194 e la battaglia per ottenere una nuova sede dal Comune di Roma.
Da un punto di vista formale ogni iniziativa si chiude con un successo: rac-
colte pi di trecentomila frme sulla proposta di iniziativa popolare, ottenuto il
fallimento dei due referendum e anche la nuova sede del Buon Pastore.
In realt, con linizio degli anni Ottanta sta ormai tramontando proprio un
modo di fare politica delle donne, in armonia con il tramonto dellepoca del mo-
vimentismo e della felicit pubblica. Ma accade anche qualcosa di pi. Nel con-
fronto fra due diversi modi di fare politica, entrambi separatisti, ma uno conno-
tato dalla politica del rivendicazionismo, del confronto con listituzione, e laltra
della pi totale estraneit, vince la seconda: perdono slancio le culture laiche e
libertarie, trionfa il femminismo della diferenza. Il movimento delle donne lascia
le piazze, abbandona il confronto con le leggi, con lo stato, con le istituzioni e si
ritira a coltivare dimensioni culturali, spesso di taglio flosofco, psicoanalitico,
qualche volta sociologico. Le elaborazioni sono intense, il linguaggio suggestivo,
ma praticamente incomprensibile per la maggioranza delle donne. Indubbiamen-
te, come stato osservato, questo fa forire la cultura delle donne e la preserva per
tempi migliori. Ma solo di una parte di essa. Si perde infatti la cultura del fare e
del misurarsi con la societ, proprio mentre sta giungendo in Italia il concetto di
pari opportunit elaborato in sede europea e mondiale e, nelle grandi assisi sotto
legida dellOnu, le donne scelgono di puntare sulle dimensioni giuridiche e isti-
tuzionali, elaborando il concetto di diritti umani delle donne, domandando che le
istituzioni internazionali e quelle statuali si facciano carico di sostenere tali diritti.
Nel nostro paese invece il movimento femminista rimarr estraneo a tutte le
politiche sulla condizione delle donne che si elaborano a livello istituzionale a partire
da quegli anni: dalla creazione dei Comitati e poi del ministero pari opportunit,
fno alla discussione sulle leggi di non discriminazione riguardanti la composizio-
ne per sessi delle liste dei partiti; dalle disposizioni in merito al rapporto lavoro /
famiglia, fno alla enorme difusione del part-time femminile. E la causa di tale
indiferenza non va cercata solo nella fne della grande stagione di mobilitazione
collettiva. La scelta di attestarsi su una posizione di totale estraneit alle dimensioni
giuridico-istituzionali non consente di infuenzare o orientare in alcun modo la mo-
dernizzazione che si realizza in quegli anni. Lattitudine a ritirarsi da qualsiasi forma
di trattativa nei confronti dellesistente sembra coniugarsi nel nostro paese con il
trionfo dellindividualismo e dellef mero e accompagnarsi a una forma crescente di
disimpegno personale e sociale che annuncia lepoca del velinismo.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 327 03/05/2013 11:11:22
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 328 03/05/2013 11:11:22
2. Le democristiane negli anni Settanta fra
tradizione, modernizzazione, secolarizzazione
Stefania Boscato
Il Movimento femminile della Dc era nato come struttura interna al partito nel
luglio del 1944, con gli obiettivi di facilitare il reclutamento nelle masse femmi-
nili, di dedicarsi alla preparazione delle donne alla vita politica, di provvedere alla
formazione di attive propagandiste nonch allo studio e allapprofondimento dei
problemi relativi alla condizione femminile.
Alle soglie degli anni Settanta il Mf si presentava come un organismo che,
privo per disposizione statutaria di autonomia rispetto al partito, esprimeva invece
al suo interno, soprattutto nelle istanze provenienti dalla base, che appariva forte-
mente politicizzata, una chiara necessit di tracciare un proprio indirizzo politico
attraverso la delegata nazionale
11
. Questo argomento monopolizz le discussioni
in seno al Comitato centrale del Mf per tutto larco degli anni Sessanta e Settanta,
in cui si manifest una tendenza volta a interpretare non pi il Movimento fem-
minile come organismo esclusivamente deputato alla formazione politica delle
donne ma anche come un luogo attraverso il quale le donne volevano riconoscersi
politicamente nel partito.
Il quesito di fondo era: aggregarsi per agire politicamente come donne o sca-
valcare la separatezza per farsi valere meglio allinterno del partito?
Il dilemma nasceva anche per ragioni che non escludevano una certa insofe-
renza verso le modalit di gestione del potere da parte del partito, la sua sempre
pi accentuata involuzione in senso oligarchico, la sua strutturazione correntizia
11 Verbale della riunione del Comitato centrale del 15-16 giugno 1960, Archivio Storico delIstituto
Luigi Sturzo (dora in poi Asils), Fondo Dc, Sp, Movimento femminile, sc. 44 fasc.7.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 329 03/05/2013 11:11:22
330
Capitolo 7. Il fare politica e il fare societ delle donne negli anni Settanta: voci, esperienze, lotte
che rendeva di fatto inaccessibile lingresso delle donne alle posizioni di responsa-
bilit negli organi direttivi e nella partecipazione a livello decisionale, in particola-
re riguardo alle candidature al Parlamento.
Alla fne degli anni Sessanta, insomma, il problema della integrazione politica
e organizzativa del Mf nel partito era ancora allordine del giorno.
Le stesse delegate lamentavano, forti di una pi che ventennale militanza po-
litica, la mancanza di un impegno globale e organico del partito verso le maggiori
questioni politico-legislative riconducibili alla sfera femminile di cui, attraverso
una sorta di delega fduciaria da parte della direzione del partito, si occupava
esclusivamente il Mf.
Lassenza, almeno come fatto prioritario, dallagenda della Dc di una compiuta
politica della famiglia (sino a quando il problema non divenne scottante con lappro-
vazione della legge Fortuna-Baslini e il suo successivo esito referendario) pu essere
esemplifcativo di questo stato di cose. La formazione delle commissioni di studio
interne al Mf sulla riforma dei codici, per la parte riguardante il diritto di famiglia,
risaliva invece al 1959 e la proposta di una sua riforma organica, con la relativa, precisa
individuazione dei punti da riformare, appariva gi compiuta nello stesso anno
12
.
Ma quando il ministero Rumor predispose, nel dicembre 1968, una commis-
sione di esperti per la defnizione di un progetto di legge per la famiglia, nessuna
donna venne chiamata a parteciparvi, neppure Tina Anselmi, la cui inclusione il
Mf aveva dato per lo pi per scontata
13
.
12 Nel corso della riunione del Comitato centrale del Mf dellaprile 1959 vennero precisati gli articoli
da riformare: innanzitutto quelli relativi ai rapporti fra i coniugi: la potest maritale (artt. 45-144
c.c.), labbandono del domicilio coniugale (art. 146 c.c.), le cause di separazione (art. 51 c.c.), la
punibilit delladulterio (artt.559-560 c.p.), nuove nozze della madre (art. 340 c.c.), la legge sulla
cittadinanza. Quelli sui rapporti patrimoniali fra i coniugi, in particolare gli articoli riguardanti il
patrimonio familiare (art. 167 c.c.), la dote (art. 177 c.c.), la comunione dei beni (art. 215 c.c.). E
ancora i rapporti tra genitori e prole, in particolare gli articoli sulla patria potest (art. 316 e ss.),
patria potest sui fgli naturali (art. 260 c.c.), patria potest nelladozione (art. 301 c.c.), condizioni
imposte alla madre superstite (art. 338), curatore del nascituro (art. 339 c.c.). Nella battaglia sulla
riforma degli articoli in discussione Maria Jervolino propose un lavoro organico di riforma dellintera
materia del diritto di famiglia, pi che la discussione sulla riforma di singoli articoli, e di assumere
tale criterio nel lavoro interno al Mf attraverso una sintesi di documentazione comprensiva degli
articoli dei codici, delle encicliche papali e del pensiero dei flosof cristiani. Sul rapporto fra genitori
e fgli ad esempio, Maria Jervolino diede subito delle indicazioni sulla modifca alla formula sulla
patria potest, suggerendo come non pi necessaria la menzione del padre e della madre ma dire sem-
plicemente che i genitori esercitano la patria potest. Stefania Rossi volle aggiungere al programma
di studio delle commissioni anche la revisione della questione del delitto donore allinterno del
codice penale. In Asils, Dc, Sp, Verbale del Comitato centrale dell11-12 aprile 1959, sc. 44 fasc. 6.
13 Cfr. Lettera 3.12.1968 di Franca Falcucci a Rumor, Asils, Dc, Sp, Mf, sc. 28 fasc. 6.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 330 03/05/2013 11:11:22
331
2. Le democristiane negli anni Settanta fra tradizione, modernizzazione, secolarizzazione
In tema di rapporti fra il Movimento femminile e il partito, un altro elemento
caratterizzante si pu rintracciare in un atteggiamento moralizzatore del primo
verso alcune forme deteriori della gestione del potere cui il partito era andato
incontro (tesseramento, dinamiche correntizie, fnanziamenti al partito) e nella
assunzione di una sorta di ruolo di coscienza critica che le donne, assieme allal-
tro principale movimento interno alla DC, quello giovanile, svolsero verso un
partito che mostrava un preoccupante vuoto nella carica ideale e una inquietante
elefantiasi burocratica
14
. Al congresso di Maiori del settembre del 1969, il XII
congresso nazionale del Mf, esplose un dibattito dai toni fortemente polemici.
I due interventi maggiormente contestatari verso la linea del partito, quelli di
Maria Paola Colombo Svevo e di Paola Gaiotti, facevano perno sul fatto che una
ristretta minoranza del partito, detentrice del potere, metteva fuori gioco tutte le
spinte provenienti dalla base: Non intendiamo operare una rottura delle istitu-
zioni esistenti. Vogliamo per che il sistema subisca un cambiamento. Vogliamo
partecipare ai livelli decisionali
15
.
Va menzionato, per inciso, che lungo tutto il primo ventennio di vita del Mf,
le democristiane manifestarono per la prima volta pubblicamente (il testo venne
spedito a Il Popolo) parole di biasimo nei confronti della condotta del partito in di-
fesa del progetto di ampliamento della base parlamentare del governo con lavvio
dellesperimento del centro-sinistra. Sono note le vicende relative alle frizioni e ai
contrasti interni maturati nel partito durante lesperimento governativo di Fanfani
del 1958 e sulla fne del suo governo, il 26 gennaio del 1959, messo pi volte in
minoranza in Parlamento anche con il concorso di franchi tiratori democristiani
16
.
Fu proprio allora che il Mf decise di reagire stigmatizzando uf cialmente i fatti
verifcatisi in Parlamento a opera dei propri colleghi di partito.
Al di l della salda unit intorno alla rivendicazione di una partecipazione mag-
giore alla vita del partito, il Mf non appariva in realt come un organismo compatto
al suo interno. Il maggiore elemento di attrito era, lo abbiamo visto, il problema
dellautonomia di indirizzo politico e la spinta proveniente dalla periferia verso una
qualifcazione politica chiara: Veniamo accusate di essere incapaci di far sentire la
voce delle donne disse Maria Eletta Martini riassumendo alle colleghe di partito gli
14 Documento conclusivo del comitato centrale del 16-17 dicembre 1967 trasmesso alla segreteria poli-
tica, Asils, Dc, Sp, Mf, sc.44, fasc. 12.
15 Per il resoconto del Convegno cfr. Cicelyn, M. La donna reclama nella societ un ruolo pari al
suo apporto, in Il Mattino, 22 ottobre 1969.
16 Su cui si veda Malgeri, F. La stagione del centrismo. Politica e societ nellItalia del secondo dopoguerra
(1945-1960), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, pp. 331 e ss.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 331 03/05/2013 11:11:22
332
Capitolo 7. Il fare politica e il fare societ delle donne negli anni Settanta: voci, esperienze, lotte
umori provenienti dalle province
17
. Laltro elemento di frizione, tale da rasentare la
spaccatura, si manifest in occasione del dibattito sulla introduzione della legge sul
divorzio. Al congresso di Maiori le delegate giocarono davvero a carte scoperte: sul
tema del divorzio molte di loro, soprattutto le giovani, si dichiararono favorevoli
ma dichiararono al contempo di volersi uniformare comunque alla disciplina del
partito per rispetto della maggioranza
18
, una motivazione da cui risultava assente
il fattore religioso-sacramentale che pure era al centro del dibattito allinterno del
mondo cattolico. A questo proposito, nei lavori preparatori del congresso di Maiori,
qualche delegata propose linserimento, tra i temi in discussione, anche quello del
cattolicesimo del dissenso che aveva preso corpo dopo il Concilio, proposta che
venne rifutata dalla allora delegata nazionale Falcucci. A Maiori venne contestata
anche la dirigenza del Mf, troppo timida nel proporre al partito il vero punto di
vista femminile tant che, ironizz Svevo, i documenti del Mf erano approvati
sempre allunanimit
19
. E ancora il partito intero venne accusato di scarso senso
della realt, soprattutto riguardo allindirizzo politico sulla famiglia laddove, mentre
si moltiplicavano le vedove bianche, si continuavano a fabbricare commissioni
di studio per parlare di unit familiare. Era, questo, un tema caro anche al gruppo
di cattolici democratici che di l a qualche anno, in occasione del referendum sul
divorzio, avrebbero inaugurato una vasta mobilitazione per il NO. Fu dif cile per
Falcucci riportare a un clima sereno la discussione, tanto quanto fu travagliata la
sua rielezione a delegata nazionale, votata proprio in quel convegno. Ad ogni modo
Falcucci mise in guardia le delegate dal pensare che il traguardo della parit giuri-
dica potesse esaurire in s le prospettive di pieno inserimento delle donne nella vita
sociale, e sottoline come il rapido processo innescatosi nel Paese ponesse problemi
di revisione radicale di mentalit, di costume e di rapporti sociali. Mancava per, a
livello giuridico un tassello importante, forse il principale, ed era quello della parit
dei coniugi allinterno del matrimonio.
Nel 1967 il ministro della giustizia Reale present un progetto di riforma
del diritto di famiglia. Il Mf si era gi pi volte pronunciato per una sistemazione
organica della materia, pi che sulla modifca di singoli articoli. Ad ogni modo, il
progetto Reale si divideva in quattro punti:
modifche riguardanti la direzione della famiglia;
istituto della separazione per fatti incolpevoli;
condizione dei fgli adulterini;
modifche al regime patrimoniale.
17 Comitato centrale del 15-16 giugno 1960, Asils, Dc, Sp, Mf, sc. 44 fasc.7.
18 Cicelyn, M. op. cit.
19 Ibidem.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 332 03/05/2013 11:11:22
333
2. Le democristiane negli anni Settanta fra tradizione, modernizzazione, secolarizzazione
Secondo lanalisi del comitato centrale del Mf, la prima parte risultava accet-
tabile dal momento che veniva valorizzato il principio del dovere dellaccordo fra i
coniugi, che si sostituiva al principio gerarchico maschile come criterio di direzione
della famiglia. A lasciare fortemente perplesse le democristiane era, nello stesso pro-
getto Reale, la prevalenza concessa al marito in caso di disaccordo, sia per ci che
riguardava la direzione della famiglia sia per ci che riguardava la patria potest
20
.
Ma questo fu un appunto che rest tutto interno al Mf e al partito, dal momento
che nei successivi progetti di legge (cfr. quello di M. Eletta Martini, ad esempio) ven-
ne difeso in Parlamento il principio secondo cui Al fne sempre di tutelare lunit
della famiglia, e non di porre una gerarchia tra i coniugi, appare peraltro indispensa-
bile che, in caso di disaccordo, prevalga la volont di uno dei due: tale volont, per
la nostra societ, la nostra psicologia, la nostra cultura e le nostre abitudini, non pu
che essere quella del marito
21
. Questa contraddizione era il frutto non solo e non
tanto di una concezione della famiglia che ancora risentiva della persistenza di un
modello tradizionale del rapporto fra i sessi nella sfera privata, ma di una mediazio-
ne complicatissima che le democristiane dovettero afrontare per aggirare la ostilit
delle gerarchie ecclesiastiche e di una parte del partito. Quando, alla fne degli anni
Sessanta, Maria Eletta Martini ed Elsa Conci si recarono dallallora ministro della
Giustizia Guido Gonella a prospettargli la loro volont di mettere mano alla riforma
del diritto di famiglia, Gonella rispose loro che era giusto procedere alla riforma di
alcune norme del diritto penale, ad esempio il delitto donore, ma assolutamente
di non toccare il codice civile
22
. Proprio da queste resistenze, e dal timore di attirare
troppo lattenzione dei settori pi conservatori dei diversi schieramenti politici sulle
donne della DC nasceva la raccomandazione di M. De Unterrichter alle altre diri-
genti del Mf di lavorare a una riforma organica ma in silenzio, cercando nellimme-
diato di insistere su quanto fosse pi facilmente trattabile, come alcune questioni
che trovavano gi soluzione nei fatti perch superate dal costume, come ad esem-
pio i rapporti fra genitori e fgli e la questione dei beni patrimoniali
23
.
Ci interessa adesso mettere a fuoco il rapporto fra i modi con cui le democri-
stiane presero coscienza e posizione di fronte alle nuove istanze esplose negli anni
Settanta in seguito alle grandi trasformazioni sociali e culturali, e la defnizione
della loro azione politica.
20 Considerazioni del comitato centrale del Mf (Roma 11-12 febbraio 1967) sul progetto di riforma
del diritto di famiglia presentato dal ministro della giustizia On. Reale. Asils, Dc, Mf, sc. 44 fasc. 12.
21 Ap, Cd, V Leg., Doc. e prog. Di legge, n. 703 p. 17.
22 Cfr. la testimonianza di Maria Eletta Martini in Di Maio, T. (a cura di) Le Democristiane. Le donne
cattoliche nella costruzione della democrazia repubblicana, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, p. 127.
23 Cos anche Maria Eletta Martini nel suo intervento al Comitato centrale dell11-12 aprile 1959 cit.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 333 03/05/2013 11:11:22
334
Capitolo 7. Il fare politica e il fare societ delle donne negli anni Settanta: voci, esperienze, lotte
Si pu afermare che negli anni Settanta le donne democristiane, che avevano
gi seguito un percorso piuttosto coerente di maturazione di una solida coscienza
civile, erano approdate alle posizioni pi progressiste sia allinterno del partito
(si consideri che erano state fautrici e sostenitrici del centro-sinistra e che molte
avevano trovato, come nel caso della Lombardia, una grossa sponda nelle correnti
della sinistra Dc, in particolare quella di Base) che nellambito del vasto fermen-
to di novit apertosi nel mondo cattolico con la conclusione del Concilio (molte
si erano legate alle correnti del cattolicesimo democratico, molte, come Albertina
Soliani si erano schierate con cattolici del NO per il referendum del 1974).
Di certo non da ultimo, va considerato che lirrompere del neofemminismo
aveva costretto le donne, non solo democristiane, a ripensare il modello di fem-
minilit e di specifcit del femminile al di l delle conquiste giuridiche, che pure
avevano segnato il raggiungimento di notevoli obiettivi. Le donne della DC non
rinunciarono alla propria identit culturale di riferimento, quella cattolica, che ne
defniva in gran parte anche lidentit e lazione politica. Latteggiamento con cui
le democristiane arrivarono allappuntamento e vissero i grandi rivolgimenti degli
anni Settanta va valutato, pi che misurando il grado di dissociazione fra fede/
religiosit e prassi socio-politica, tenendo conto del grado di problematicit di tale
rapporto in cui gli stessi orientamenti pastorali dei vescovi, pi che contraddetti,
furono fltrati dalla coscienza personale delle singole donne.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 334 03/05/2013 11:11:22
3. Lo Statuto dei Lavoratori e delle
Lavoratrici: un compleanno da ricordare
Rossella Del Prete
Rileggevo qualche tempo fa la prefazione di Giulio Sapelli alla nuova edizione del
suo volume di Storia economica, e restai colpita dalla sua rifessione su quella sorta
di immobilismo che caratterizza il nostro Paese, dove nulla di fondamentalmente
nuovo intervenuto in Italia, pur nella trasformazione planetaria in atto: la ca-
pacit possente di rivoluzionare passivamente qualsivoglia epocale cambiamento
che si abbatte su di esso una delle caratteristiche essenziali del paese. La capacit
trasformistica della nostra cultura quella della nostra economia. Anche la globa-
lizzazione e le privatizzazioni sono state addomesticate, castrate, ridotte a orpelli
di una continuit pi forte di quel cambiamento globale che attorno al Belpaese
ruota
24
.
Come dargli torto soprattutto ora che ci accingiamo a mettere in discussione
una delle riforme pi importanti per il nostro Paese? Lo Statuto dei Lavoratori ha
compiuto i suoi primi quarantanni e quarantanni dopo c chi lo giudica or-
mai superato, ma insostituibile, perch ha anticipato signifcativi sviluppi dellor-
dinamento e proprio per questo non pu essere eliminato; chi, con inguaribile
nostalgia, lo vede intramontabile; e chi vorrebbe rivitalizzarlo, nella convinzione
che la fecondit dei suoi principi non sia esaurita, ma anzi attenda tuttora dessere
24 Sapelli, G. Storia economica dellItalia contemporanea, Milano, Mondadori, 2008, p. VII. LAu-
tore, professore di Storia economica e Analisi culturale delle organizzazioni presso lUniversit degli
Studi di Milano, ha lavorato oltre che in diverse universit italiane e straniere anche in diverse im-
prese, ricoprendo incarichi in board di una certa importanza e intrecciando sempre ricerca scientifca
e responsabilit di amministratore indipendente.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 335 03/05/2013 11:11:22
336
Capitolo 7. Il fare politica e il fare societ delle donne negli anni Settanta: voci, esperienze, lotte
riscoperta
25
. Ebbene, sulla scia delle afermazioni iniziali che vedono lItalia il pae-
se pi conservatore del mondo, dove qualunque riforma riesce a essere applicata
senza di fatto riformare nulla di essenziale, proviamo a dire la nostra: lo Statuto dei
Lavoratori, quarantanni dopo, ci sembra pi attuale che mai, nel senso che la sua
sostanziale e radicata applicazione ancora da venire. Come spesso accade in Ita-
lia, nonostante alcune importanti afermazioni, il bilancio dellapplicazione della
legge deludente. Se vero che con la sua istituzione la Costituzione entra[va]
in fabbrica, come recitava uno slogan molto in voga nei giorni della sua approva-
zione in Parlamento, vero anche che i principi fondamentali della Costituzione
Italiana, che guardavano alla classe lavoratrice senza distinzioni di sesso n di razza
n di religione, ribadivano, con maggior forza, proprio nei luoghi di lavoro, il
diritto alla libert di esercitare unattivit lavorativa e, pur senza precisarlo nelle
parole, intendevano garantire tale diritto tanto agli uomini quanto alle donne. Un
lavoro pi libero, lo diceva anche il Labriola, capace di dare signifcato e fnalit
personali al lavoro attraverso lelevamento delle capacit e ricchezze culturali in-
dividuali. Ci che, in sintesi, hanno fatto le donne, conquistando il loro spazio
pubblico, i loro diritti civili e di cittadinanza. Oggi, come allora, avvertiamo,
sempre pi forte, lesigenza di una possibilit di arricchimento della persona gra-
zie anche alle capacit produttive incrementate dalla nostra societ, che spesso,
tuttavia, tende a negarle.
Sul piano istituzionale, il varo dello Statuto dei lavoratori costitu una grande
novit. Esso applic anche nei luoghi di lavoro i diritti di libert costituzionale,
soprattutto contro le politiche repressive della militanza politica e sindacale, ma
contribu anche a rendere operative, negli stessi luoghi, le organizzazioni sindacali
pi rappresentative
26
che da allora poterono convocare uf cialmente assemblee,
indire referendum, af ggere testi e comunicati, tutelare le rappresentanze sindacali
aziendali contro il licenziamento e il trasferimento, ottenendo per loro permessi,
retribuiti e non, e luso di spazi in cui esercitare le varie funzioni connesse alla
rappresentanza
27
. Sul piano giuslavoristico si apriva una nuova stagione riformista.
Lo Statuto, valido per le imprese con oltre 15 dipendenti, divenne un formidabile
strumento di tutela sindacale, di infuenza delle maggiori organizzazioni esterne
25 La rivista Lavoro e Diritto ha dedicato al quarantennale dello Statuto un numero monografco dal
titolo Buon giorno, Statuto, gennaio 2010, in cui alcuni dei giuslavoristi pi esperti ripercorrono
itinerari e posizioni diversi.
26 Cio quelle che avevano maggior numero di iscritti, consistenza organizzativa e partecipavano alla
contrattazione nazionale e provinciale.
27 Sul ruolo delle donne nelle organizzazioni sindacali di quel periodo e sulla loro attivit di rap-
presentanza allinterno dei luoghi di lavoro cfr. Righi, M.L. Lazione delle donne nella CGIL, in
Motti, L. (a cura di) Donne nella CGIL, Roma, Ediesse, 2006, pp.225-245.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 336 03/05/2013 11:11:22
337
3. Lo Statuto dei Lavoratori e delle Lavoratrici: un compleanno da ricordare
allazienda, dunque dei sindacati di categoria aderenti a CGIL, CISL E UIL, di
promozione dei poteri del sindacato tanto nei confronti dei lavoratori che delle
imprese, nonch di sostegno alla contrattazione aziendale. La legge 300, del 20
maggio 1970, il cui testo fu fortemente voluto dallex ministro del Lavoro Bro-
dolini, prematuramente scomparso, e portato a compimento dal suo successore,
il democristiano Carlo Donat Cattin si componeva di tre titoli: nel primo (Della
libert e dignit del lavoratore) si riconoscevano al lavoratore la libert di opinione,
la tutela della salute, il diritto allo studio, la reintegrazione nel posto di lavoro in
caso di licenziamento senza giusta causa, intervenendo anche sui poteri discipli-
nari della direzione aziendale. Nella seconda e terza parte (Della libert sindacale
e Della attivit sindacale) si ampliava la gamma dei diritti sindacali: libert di
associazione, assemblea, permessi, sedi, riconoscimento delle Rappresentanze sin-
dacali aziendali (Rsa), repressione della condotta antisindacale
28
.
Lapprovazione di questa legge alla cui stesura diede un importante con-
tributo il giurista Gino Giugni era stata preceduta da una lunga elaborazione
e da un acceso dibattito (il progetto originario dello Statuto risale al 1968). Il
risultato fu da un lato la riduzione delle tante dif denze alimentate dalla legge,
dallaltro la crescente preoccupazione degli industriali, al punto che lAssolombar-
da formul unesplicita richiesta al governo di garantire in fabbrica il principio
dellautorit
29
. Lo Statuto infatti aferm la necessit di un modello di gestione
del personale decisamente antitetico a quello paternalistico e autoritario che aveva
caratterizzato la fabbrica tayloristica e fordista. Daltronde la disciplina prevista
dal codice civile dellepoca celebrava soprattutto i valori della gerarchia, della fe-
delt, della collaborazione. Contro tutto ci lo Statuto realizzava una forte discon-
tinuit, anticipata dalla legge 604 del 1966
30
.
A chiudere il positivo trend riformista in atto arriv nel dicembre 1971 la
legge n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri e, due anni pi tardi, nel dicembre
1973, la legge n. 877 sulla tutela del lavoro a domicilio. Lo Statuto dei Lavoratori
ha rappresentato il punto di snodo fondamentale nella storia della conquista dei
diritti sindacali e del lavoro nel nostro Paese, ma ci non signifca che nel maggio
del 1970 si determinasse il punto pi alto sul terreno complessivo del recepimento
legislativo delle istanze provenienti dal mondo del lavoro e dalle sue rappresen-
tanze sindacali. Certamente si pu afermare che con lo Statuto si determin in
28 Turone, S. Storia del sindacato in Italia. dal 1943 al crollo del Comunismo, Roma-Bari, Laterza,
pp. 420-421.
29 Accornero, A.; Cardulli, A. Le lotte in Italia 1970-75, in Quaderni di Rassegna sindacale, n.
51, p. 19.
30 Liso, F. Lo Statuto tra Amarcord e prospettive del futuro, in Lavoro e Diritto cit., pp. 75-83,
p. 77.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 337 03/05/2013 11:11:22
338
Capitolo 7. Il fare politica e il fare societ delle donne negli anni Settanta: voci, esperienze, lotte
modo organico e complessivo una regolazione dei diritti del lavoratore anzi del
cittadino/lavoratore nel luogo in cui egli presta la propria attivit, quantomeno
sotto il proflo della tutela della sua dignit e della sua possibilit di svolgere la pro-
pria azione sindacale. In questo senso lo Statuto si rivolse anche alle tante donne
che proprio negli anni Settanta furono, loro malgrado, protagoniste di unintensa
fase di riforme della legislazione sociale. C da dire che le due uniche norme sugli
atti e sui trattamenti economici collettivi discriminatori (artt. 15 e 16), pur costi-
tuendo tuttora due principi basilari, hanno trovato ampia evoluzione in una lunga
serie di leggi su parit e pari opportunit in materia di lavoro: modifche testuali
si ebbero gi nel 1977 con la legge sul lavoro delle donne, e poi nel 2003 con la
considerazione dellhandicap come causa di discriminazione. Ma anche altre nor-
mative ad esempio, il testo unico sullimmigrazione del 1998, le numerosissime
leggi sulla parit tra uomo e donna, culminate nel codice delle pari opportunit
del 2006, il ricordato decreto del 2003 per le discriminazioni fondate sulla razza
e lorigine etnica hanno provveduto ad attribuire a questi due articoli il ruolo di
apripista di tutele meglio rinvenibili in altre fonti (anche lazione civile in materia
stata ridisegnata nel 1998)
31
. Lo Statuto, insomma, prov a ribadire, attrez-
zandoli con una strumentazione giuridica adeguata, i diritti di libert e dignit
del lavoratore che la Carta costituzionale aveva assicurato, ma che fu necessario
defnire ulteriormente e che tuttora, nonostante lapparato legislativo in vigore,
richiedono continue precisazioni.
La legislazione antidiscriminatoria ispirata ai principi di parit e di non di-
scriminazione, inseriti poi nella Carta di Nizza, e, prima ancora, nellordinamento
comunitario, ha costituito un potente fattore di conversione delle risorse perso-
nali, un diritto sociale trasversale che va ben oltre il lavoro subordinato. Si po-
trebbe dunque afermare che laddove non arriva lo Statuto, allora pu arrivare
il principio di non discriminazione. Ma la questione non poi cos semplice. La
dottrina giuslavoristica britannica sostiene che la legislazione antidiscriminatoria
ha largamente superato la rigida separazione tra lavoro subordinato e lavoro indi-
pendente che ha costituito il vero limite allattuazione della tradizionale legislazio-
ne protettiva. In Italia, la prima ad aver intuito la valenza trasversale e pervasiva
del principio di non discriminazione stata Marzia Barbera, che lo ha considerato
utile per tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni
32
. lecito dunque
chiedersi, secondo Bruno Caruso se non sia stato proprio lo Statuto, e la sua
flosofa di fondo, a impedire il pieno dispiegamento culturale di tale principio
e la difusa applicazione delle sue tecniche di tutela nellordinamento laburistico
31 Gaeta, L. Che cosa oggi lo Statuto dei Lavoratori?, in Lavoro e Diritti cit., p. 54.
32 Barbera, M. Discriminazione ed uguaglianza nel rapporto di lavoro, Milano, Giufr, 1991.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 338 03/05/2013 11:11:22
339
3. Lo Statuto dei Lavoratori e delle Lavoratrici: un compleanno da ricordare
italiano?
33
. Forse andrebbe sostituita la nozione di subordinazione con il concet-
to di dipendenza economica, al fne di unifcare la fattispecie, ma diferenziando
le tutele. Lipotesi era gi stata contemplata dalla Carta dei diritti delle lavoratrici
e dei lavoratori, progettata da Amato e Treu nel 2002 e poi ripresentata nel 2006,
ma non riuscita a diventare pi chiara
34
.
Per quanto riguarda le donne, la legislazione degli anni Settanta si concentr
essenzialmente sul contrasto di comportamenti discriminatori nei loro confronti,
delineando prescrizioni e indirizzi fnalizzati a promuovere la parit e a migliorare
la condizione delle donne sul lavoro, in relazione, in particolare a: retribuzione;
trattamento in relazione allaccesso al lavoro, formazione professionale, carriere e
alle tutele dalle discriminazioni fondate sul sesso e dalle molestie sessuali; sicurezza
sociale. Dopo il periodo di crisi occupazionale femminile degli anni del dopoguer-
ra, il 1960 rappresenta il punto culminante della breve ripresa delloccupazione
femminile, dopo un lungo periodo di tendenziale diminuzione. Nel quindicennio
successivo i tassi di occupazione femminile risultano in continua diminuzione,
salvo una lieve ripresa a partire dal 1973. La non occupazione femminile dipese
non da una scelta delle donne n dallaumentato benessere economico e sociale,
ma da precisi condizionamenti economici e di costume. Ce lo conferma unin-
dagine ISTAT del 1973 sulle persone non appartenenti alle forze di lavoro: tra le
donne oltre la met dichiara di non cercare lavoro a causa di responsabilit fami-
liari, mentre l8% delle casalinghe, il 4% delle studentesse, il 2% delle pensionate
dichiarano esplicitamente che sarebbero disposte a svolgere unattivit lavorativa a
particolari condizioni. Si tratta in totale di 931 mila donne che la dif colt di con-
ciliare i compiti che il ruolo di genere assegna loro con unattivit extradomestica,
oppure uninadeguata formazione professionale, esclude dal mercato del lavoro.
Le condizioni indicate, infatti, sono nella maggior parte dei casi, legate alla possi-
bilit di provvedere alla custodia dei fgli o di altri parenti o di disporre di mezzi
di trasporto o di una formazione professionale adeguati. Del resto, confrontando
i tassi di attivit nelle diverse regioni, troviamo una diversit non certo irrilevante
tra uomini e donne: sulla occupazione femminile gli squilibri regionali incidono
assai pi pesantemente, non solo per il peso degli squilibri economici e del con-
seguente livello della domanda di lavoro, ma per le enormi diversit culturali e di
costume. Dopo il 1972 si registra un aumento delloccupazione femminile. Dif -
cile dire se sia dipeso da mutamenti strutturali di pi ampia portata. Di sicuro, da
un lato ha pesato la ripresa congiunturale del 1973, i cui efetti in una certa misura
si sono manifestati negli anni successivi, dallaltro si verifcato un trasferimento,
33 Caruso, B. Lo Statuto morto: Viva lo Statuto, in Lavoro e Diritti cit., p. 97.
34 Ballestrero, M.V. Quarantanni e li dimostra tutti, in in Lavoro e Diritti cit., p. 28.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 339 03/05/2013 11:11:22
340
Capitolo 7. Il fare politica e il fare societ delle donne negli anni Settanta: voci, esperienze, lotte
nella realt e nelle rilevazioni statistiche, di quote di lavoratrici dal lavoro nero
alla sottoccupazione uf ciale e dalla sottoccupazione alloccupazione. Analizzan-
do la posizione femminile allinterno dei singoli settori, troviamo ancora una volta
la conferma della posizione marginale della donna. Uninchiesta sul lavoro dipen-
dente ha accertato che nel 1971 la manodopera risulta raramente inserita nelle
qualifche superiori: solo il 15% delle operaie sono qualifcate o specializzate,
appena il 17% delle impiegate sono di concetto e solo il 3% svolgono funzio-
ni direttive. Nella pubblica amministrazione le donne, escludendo le insegnanti,
sono inserite ai gradi pi bassi delle varie qualifche: nel 1971 nella amministrazio-
ni statali le donne sono passate dal 30% al 50% nelle carriere esecutive e solo dal
10% al 20% in quelle direttive; nelle qualifche dirigenziali scendono al 3,6% del
totale, mentre non si registra nessuna donna a livello di direzioni generali. I dati
relativi allagricoltura indicano una situazione ancora pi arretrata
35
.
Lostacolo principale al lavoro femminile resta quello del nucleo familiare che
gestisce luso della forza lavoro dei propri membri. La lavoratrice-madre inevita-
bilmente incide profondamente sugli equilibri familiari. Non si pu non tener
conto del fatto che la realt del mercato del lavoro sia cambiata, ma, a maggior
ragione, riteniamo necessaria una rifessione sulle problematiche organizzative
culturali specifche del lavoro, in particolare di quello femminile tra anni Sessanta
e Settanta: taylorismo e fordismo radicalizzarono la distinzione tra mansioni ma-
schili e mansioni femminili
36
. Lo Statuto sembra non afrontare questi problemi;
tuttavia, esso sancisce che il potere datoriale legittimamente esercitabile, nelle
sue multiformi manifestazioni, solo nel rispetto della dignit della persona del
lavoratore (o della lavoratrice!) e per qualit tecniche. evidente il contrasto con
lassetto della piramide taylorista, in cui la composizione della manodopera, for-
temente disciplinata, rimanda a una struttura altrettanto gerarchica della societ,
congruente con il modello produttivo: il lavoro operaio, faticoso e pesante, es-
senzialmente un lavoro maschile e poche sono le donne che lavorano in fabbrica,
soprattutto nei primi anni di sviluppo del taylorismo. Luomo dunque adibito al
lavoro di produzione, che genera prodotti e ricchezza materiale (ed pertanto re-
munerato), la donna tende a essere sempre pi occupata nel lavoro di riproduzio-
ne e di cura, non a diretto contatto con la struttura materiale della produzione (e
pertanto la sua attivit, seppure essenziale, non viene remunerata). Da qui lo slo-
gan femminista luomo in fabbrica, la donna in cucina
37
. Particolarmente inte-
35 Donna, lavoro e sindacato, Centro Studi Cisl di Firenze, Piccola Biblioteca Sindacale, Firenze
1976.
36 Cevoli, M. Donne e organizzazione del lavoro: dal taylorismo alle risorse umane, la cultura dimpresa
riscopre la diferenza, Roma, Ediesse 1993.
37 Fumagalli, A. Dal fordismo allaccumulazione fessibile: un veloce excursus storico, dispensa (Universit
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 340 03/05/2013 11:11:22
341
3. Lo Statuto dei Lavoratori e delle Lavoratrici: un compleanno da ricordare
ressanti sembrano le diferenziazioni retoriche che le direzioni e gli operai maschi,
ma anche le stesse operaie, adottavano per spiegare come mai una certa (general-
mente banalissima, faticosissima e ripetitivissima) mansione era considerata tipi-
camente femminile (il tocco, la precisione, la pazienza, la tolleranza,(considerati
attributi geneticamente, ovvero naturalmente femminili). Ancora oggi alla fab-
brica Barilla di Melf lunica mansione non automatizzata, limbustamento delle
brioches, af data alle donne, sulla base dellassunto che un lavoro di pazienza
e dunque naturalmente adatto alla componente femminile (che naturalmente
anche la meno retribuita e quella che fa meno carriera)
38
. Il paradigma taylorista-
fordista basa il proprio successo sulla dinamicit della crescita in cui la condizione
di occupato consente laccesso ai diritti civili e di cittadinanza, anche se ci spesso
si accompagna ad attivit di lavoro dequalifcate, pesanti e alienanti (come spesso
avviene nella fabbrica taylorista). Lequilibrio dinamico del fordismo abbisogna
dunque di forte capacit regolativa, di tipo discrezionale, e di standardizzazione
dei comportamenti e delle mentalit; di una struttura sociale fortemente rigida e
gerarchica, in cui ognuno deve stare al suo posto. La vita degli individui, non a
caso, tende a essere scandita da una successione di istituzioni totalizzanti e forte-
mente disciplinari: dalla famiglia (di stampo patriarcale, con una forte diferenzia-
zione sessista), alla scuola (che gi in tenera et divide chi va a operare nella fase
di progettazione (dirigente), chi nella fase di esecuzione (operaio), chi nella fase
di commercializzazione e gestione (impiegato), alla caserma (solo per i maschi,
ma per le donne sar la famiglia a diventare la loro efettiva caserma, nel ruolo di
moglie e madre), sino al luogo di lavoro, listituzione totalizzante e disciplinare
per eccellenza.
Ritornando dunque alleventuale modernit dello Statuto: forse qualcosa da
cambiare c davvero e, andando davvero al cuore dello Statuto, si potrebbe
cominciare proprio dal suo nome. Le parole sono importanti e rivolgersi esplicita-
mente ai lavoratori e alle lavoratrici non pu che tornare utile allafermazione di
un concetto: il diritto al lavoro, come diritto universale.
di Pavia), p. 12.
38 Andrebbe pertanto indagata tutta quella costruzione culturale, violenta e oppressiva, che serv nel
taylorismo a relegare le donne ai lavori pi umili e meno qualifcati. Una costruzione che le donne
stesse, come tutti i diversi avevano e hanno spesso pienamente introiettato. Sarebbe dunque estre-
mamente importante decostruirla in sede storica per capire fno a che punto il movimento femmi-
nista sia stato capace di cogliere questi nessi e farli percepire dalle operaie stesse.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 341 03/05/2013 11:11:22
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 342 03/05/2013 11:11:22
4. Una storia degli anni Settanta: donne a
scuola tra vecchie e nuove culture
Anna Balzarro
Una scuola in movimento
Mangiare quando si ha voglia, sedersi su un tavolo, parlare in dialetto, avere le
ginocchia sporche o indossare una camicetta trasparente, giocare a carte o com-
merciare fumetti, sono tra quelle cose ritenute dal senso comune incompatibili
con la scuola e la sua funzione educativa
39
Si apre con questa frase lIntroduzione de LErba voglio, un volume scritto a
pi mani nel 1971 con lintento di cercare e attuare nella scuola pratiche di inse-
gnamento e di apprendimento allinsegna di un metodo antiautoritario. Questo
desiderio di svecchiamento dellintero sistema scolastico rientra in pieno nel clima
inaugurato dal movimento del Sessantotto e investe unintera generazione di inse-
gnanti. Scrive in proposito una di loro, Maria Luisa Tornesello
40
, che anche nella
scuola dellobbligo come in altri settori della societ (dalla magistratura al dissenso
religioso alla psichiatria) si infuenzati in modo diretto dalla cultura del Sessan-
totto, dal dissenso, pi noto, degli studenti universitari e degli operai.
La scuola degli anni Settanta per i nuovi insegnanti (in genere giovani neo-
laureati ma non manca lapporto di colleghi pi anziani) un laboratorio di idee e
di speranze, un terreno in cui investire energie e idee nuove facendosi portavoce
39 Fachinelli, E.; Muraro Vaiani, L.; Sartori, G. (a cura di) LErba voglio. Pratica non autoritaria nella
scuola, Torino, Einaudi, 1971, p. 13.
40 Tornesello, M.L. Il sogno di una scuola, Piacenza, Petite Plaisance, 2006, p. 12.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 343 03/05/2013 11:11:22
344
Capitolo 7. Il fare politica e il fare societ delle donne negli anni Settanta: voci, esperienze, lotte
di quei fermenti e di quelle idee che agitavano la societ italiana (movimento degli
studenti, antifascismo, femminismo)
41
. Daltra parte, gettarsi anima e corpo in
questo progetto era un modo anche di ripensare se stessi e rimettere in discus-
sione il proprio ruolo professionale. La prospettiva di cambiamento complessivo
era dunque ci che rendeva il movimento della scuola af ne ad altri movimenti
del tempo. In particolare, se teniamo presente che gi allora la maggior parte del
corpo docente era composto da donne, capiamo che il mondo in cui si muovono
le nuove insegnanti va letto in unottica che tenga conto del parallelo sviluppo del
movimento neofemminista. Tra laltro si dibatte, tra le storiche, se alle origini del
neofemminismo italiano possa esserci un movimento del 1966, il Demau, che gi
nel nome (Demistifcazione autoritarismo) ha molte assonanze con i movimenti
della scuola, anche se in questo gruppo laccento rivolto soprattutto contro lau-
toritarismo patriarcale
42
.
A livello ideale, come dialogavano i due movimenti? Come erano elaborati nel
femminismo i temi relativi al mondo della scuola e alla professione dellinsegnante?
La mia ricerca analizza il rapporto tra tematiche relative alla scuola di ogni
ordine e grado e il femminismo negli anni Settanta, cos come emerge allinterno
di alcune riviste femministe
43
, in particolare dalle pagine di Efe, un periodico
ricco di inchieste su tutti gli aspetti dellesistenza femminile, il primo tra i giornali
femministi ad avere difusione nazionale.
Donne e insegnanti: unidentit dalle sfaccettature complesse
La tipizzazione degli interessi scolastici e professionali sulla base del sesso de-
nunciata pi volte nel corso degli anni sulle riviste. Ad esempio in un articolo pub-
blicato da NDWF nel 1977
44
si mostrano le conseguenze di quegli stereotipi tanto
sulla creativit delle bambine, afossata secondo il libro di Elena Gianini Belotti fn
dallingresso nelle scuole elementari, quanto sulla presenza femminile in professioni
considerate espansione del sentimento materno: in particolare nellinsegnamento.
Da questa ghettizzazione professionale deriva anche una marginalizzazione
culturale, con la creazione di facolt universitarie femminili per eccellenza: primo
tra tutti il Magistero.
41 Ivi, p. 16.
42 Bertoncin, B. Alle origini del femminismo, in Sofa, luglio-dicembre 1998, n. 5, pp. 64-70.
43 Materiale conservato presso Archivia, Biblioteca e Centri di documentazione delle donne, Roma.
Ringrazio Mila Corvino per la sua costante e preziosa collaborazione.
44 Gay, R. Appunti sullo stereotipo femminile nellorientamento scolastico e professionale, in
NDWF, n. 2, gennaio-marzo 1977, pp. 48-56.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 344 03/05/2013 11:11:22
345
4. Una storia degli anni Settanta: donne a scuola tra vecchie e nuove culture
Ed proprio sul signifcato della loro frequenza al Magistero che si interroga-
no le ragazze di Padova, aderenti al collettivo Lotta femminista
45
: partendo da
un discorso sulle presunte doti naturali di uomini e donne, le studentesse criticano
la divisione di ruoli secondo la quale agli uomini appartiene il mondo del lavoro
mentre alle donne competono la cura della casa e linsegnamento scolastico. Nel
denunciare, inoltre, lapprendimento acritico e nozionistico che ricevono al Ma-
gistero, le ragazze di Padova contemporaneamente rifutano di farsi trasmettitrici,
come future insegnanti, di quel sapere.
La professione dellinsegnante dunque vista in toto come un mestiere im-
posto, dequalifcante e dequalifcato? Il discorso in realt pi complesso e va
ricondotto allanalisi pi specifca del rapporto tra le docenti e la loro professione.
Nel gennaio 1976 su Efe escono, luno di seguito allaltro, due articoli che
tengono insieme i due termini della questione. Uno dei due articoli, frmato da
un gruppo di compagne di Torino, riprende in sostanza quel che abbiamo detto
fno adesso e critica la scelta dellinsegnamento come unimposizione sociale che
privilegia per la donna unoccupazione che porta via meno ore rispetto ad altri
lavori extradomestici, lasciando pi spazio per la famiglia, e che le chiede di essere
trasmettitrice passiva dei valori che il sistema ha bisogno di inculcare per la sua
conservazione
46
.
Colpisce il confronto con quanto pubblicato nelle pagine immediatamente
precedenti a frma di Donata Francescato. Se gi il titolo signifcativo (Donna
e scuola riprendiamoci il potere), le righe dinizio chiariscono immediatamente il
senso del discorso:
Siamo tante e ormai siamo dappertutto. Negli asili e nelle scuole materne abbia-
mo il monopolio assoluto, nelle elementari e nelle medie la maggioranza e anche
nelle scuole superiori stiamo per arrivarci, persino alluniversit, struttura feudale
per eccellenza e dunque dominata da schiere di baroni, i maschi sono sempre al
vertice della piramide ma tra i valvassori e i valvassini cominciano a spuntare le
donne
47
.
Dunque le donne a scuola sono la maggioranza, anche se la loro presenza
diminuisce via via che si sale negli ordini degli studi, e costituiscono una forza. I
toni non sono trionfalistici, andando oltre si legge ad esempio che bisogna subito
prendere atto che per molte linsegnamento stata una scelta obbligata, per c la
rivendicazione del proprio potere, il desiderio di rivalutare la propria professione
45 Scuola: che ci facciamo al Magistero, in Efe, n. 2, febbraio 1976.
46 Due o tre cose sulle donne insegnanti, in Efe, 1 gennaio 1976, pp. 44-45.
47 Ivi, pp. 43-44.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 345 03/05/2013 11:11:22
346
Capitolo 7. Il fare politica e il fare societ delle donne negli anni Settanta: voci, esperienze, lotte
e di farne uno strumento per modifcare la societ: La scuola una struttura fon-
damentale. Noi siamo la forza lavoro che la fa funzionare. Noi insieme, lottando
unite abbiamo il potere di mutarla
48
.
La consapevolezza del proprio potere, per, altre volte vista come unarma a
doppio taglio, come un alibi, nelle mani della societ per scaricare sulle donne tut-
te le mancanze della scuola italiana (la scuola in mano alle donne, ma la scuola
non funziona dunque le responsabili sono le donne)
49
.
In linea con linterpretazione pi positiva del ruolo delle insegnanti, invece,
un altro articolo di Efe, pubblicato nel 1974, che mette laccento soprattutto
sullimperativo per le docenti femministe di rivedere la cultura che difondono e
reinventarla, ad esempio attribuendo dignit nuova, nellinsegnamento della sto-
ria, allesistenza delle donne o, nellinsegnamento dellarte, a opere dellingegno
femminile (ad esempio a un tessuto fatto al telaio)
50
.
Al tempo stesso, compito delle donne sensibili alle discriminazioni di genere,
quello di ricercarne le radici nelleducazione di bambine e bambini fn dalla pi
tenera et. In quello stesso numero di Efe del 1974, ad esempio, sono raccolti diversi
articoli destinati agli asili, considerati come primi possibili laboratori in cui reimpo-
stare i rapporti tra i sessi: un obiettivo da ottenere anche grazie allaf damento dei
bambini a un gruppo misto di donne e uomini e non pi solo alle cure materne di
una maestra. Tuttavia lo spazio maggiore dato ai condizionamenti che avvengono
nella scuola dellobbligo, alle elementari e alle medie. In particolare, per la scuola
media si individuano quelle discriminazioni di genere (solo le ragazze portano il
grembiule nero
51
; le applicazioni tecniche prevedono programmi diversi per maschi
e femmine, istruendo le fanciulle alluso dellago) che contribuiscono a mortifcare
lidentit delle adolescenti e a orientarle verso un futuro domestico
52
.
Un discorso che si incontra a pi riprese quello che riguarda i libri di testo,
e a essere sotto accusa sono soprattutto i libri per le elementari.
In un numero di Efe del 1973 sono riportati i risultati di una ricerca condotta
su dieci libri di testo in quel momento in uso nelle scuole elementari e sono stati
confrontati i dati con quelli di un lavoro analogo condotto negli Stati Uniti. In
ambedue i casi si notato che solo un 10% di racconti hanno per protagoniste
donne o bambine, e che queste si trovano spesso in situazioni ridicole o di pericolo
per cui vanno tratte dimpaccio, aiutate o protette.
48 Ibidem.
49 Scuola: che ci facciamo al Magistero? cit.
50 Le donne insegnanti, una scuola da inventare, in Efe, luglio-agosto 1974.
51 Giani Gallino, T. Mamma cucina pap invecelavora, in Efe, dicembre 1973, pp. 52-54.
52 A te lago a me il martello, in Efe, ottobre-novembre 1974, pp. 34-35
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 346 03/05/2013 11:11:22
347
4. Una storia degli anni Settanta: donne a scuola tra vecchie e nuove culture
Colpisce, in particolare, la rappresentazione dei padri e delle madri. I primi
infatti, nelle illustrazioni sono in tuta da operaio o con una valigetta da lavoro
sotto il braccio, mentre le mamme, eleganti e sorridenti, fgurano intente alle fac-
cende domestiche. Ma signifcativo, soprattutto, il diverso prestigio interno alla
famiglia: la funzione educativa, infatti, solo prerogativa dei padri, che in genere
sfoggiano una cultura enciclopedica, mentre le mamme sono solo le addette allas-
sistenza afettiva e soprattutto materiale (cucinano pranzi e rammendano calzini)
ma non hanno nessuna voce in capitolo sulla formazione dei fgli
53
.
Conclusioni
La complessit della rifessione sulleducazione dunque ben rappresentata, in que-
gli anni, nelle pagine della rivista femminista Efe, che fa emergere una nuova con-
sapevolezza del ruolo e della responsabilit delle insegnanti nel creare e nellofrire
modelli didattici alternativi. Questa coscienza della propria forza parte per da una-
nalisi obiettiva dei limiti e dei vincoli sociali che hanno troppe volte indirizzato verso
quella professione, spesso subita passivamente pi che liberamente scelta.
In conclusione i fermenti che hanno mosso il mondo della scuola hanno af-
fnit e legami con il pensiero femminista. Guardando oggi alla scuola degli anni
Settanta che giudizio si pu dare sulle realizzazioni di quella stagione? In genere
si pensa a quel decennio come a un periodo di riforme mancate forse perch una
grande e complessiva riforma, paragonabile a quella che ha creato la scuola media
unica agli inizi degli anni Sessanta, di fatto non c stata.
Tuttavia, soprattutto quando si guarda alla scuola in unottica di genere, ci
sono dei cambiamenti che non vanno sottovalutati, in particolare se teniamo con-
to del panorama di arretratezza che cera stato fno a quel momento. Nella scuola
media, lo denunciava Efe nel 1973 e nel 1974, le ragazzine portavano grembiuli
neri e svolgevano un programma di applicazioni tecniche separato rispetto a quel-
lo dei compagni. Non quindi secondario il cambiamento introdotto dalla legge
n. 348 del 16 giugno 1977 che sancisce defnitivamente la fne della divisione
delle applicazioni tecniche in maschili e femminili.
Daltra parte anche uscendo dallesclusiva visione di genere ci sono negli stes-
si anni cambiamenti signifcativi per lintegrazione scolastica di tutti, che vanno
dallabolizione delle classi diferenziali allintroduzione del sostegno per i disabili:
una misura partita negli anni Settanta ma che verr perfezionata ed estesa negli
anni Ottanta e allinizio degli anni Novanta.
53 Giani Gallino, T. Mamma cucina cit. sui libri di testo cfr. anche Montini, I. La bambola rotta:
famiglia, Chiesa, scuola nella formazione delle identit maschile e femminile, Verona, Bertani Editore,
1975, pp. 129 e seguenti.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 347 03/05/2013 11:11:22
348
Capitolo 7. Il fare politica e il fare societ delle donne negli anni Settanta: voci, esperienze, lotte
Il lascito di quel decennio dunque non va a mio avviso sottovalutato. Il senso
di delusione deriva forse dallo scarto tra aspettativa e realizzazione, tra prospettiva
di un cambiamento radicale nelleducazione e nella cultura e gli scogli opposti dal-
la realt circostante. Ma il fermento di idee in s, a volte, a essere importante e a
lasciare un seme. Solo per fare un esempio della realt romana: lasilo Celio azzur-
ro, a tuttoggi un modello di integrazione culturale per linserimento di bambini
provenienti da tutte le parti del mondo, deriva dallesperienza di occupazione di
quella struttura da parte di un gruppo di mamme alla fne degli anni Settanta
54
.
Per quel che riguarda la scuola stato importante che una generazione di
insegnanti motivate vi abbia investito energie, non senza dubbi e ripensamenti
soprattutto in merito al proprio ruolo e al modo di porsi rispetto alle allieve. In un
articolo apparso su Efe nel 1978, ad esempio, uninsegnante di un Istituto profes-
sionale femminile si interrogava sul rapporto con le studentesse, sulla necessit di
mediare tra autoritarismo e permissivismo per avere la loro stima
55
.
Tanti anni dopo, alla fne degli anni Novanta, in un volume collettivo dal
titolo Buone notizie dalla scuola il nodo della giusta assunzione di autorit ancora
allordine del giorno. La scuola viene descritta come un luogo di donne ma non
(ancora) un luogo di autorit femminile
56
. Tuttavia viene da chiedersi se sia possi-
bile staccare la scuola dal mondo che la circonda (era possibile cambiare la scuola a
prescindere da quel che le succedeva intorno?) se abbia quindi un senso imputarle
come una colpa ci che non si realizza neanche in altri ambiti della societ, o se
invece i due piani non fniscano per essere inevitabilmente intersecati.
54 Pivetta, M. La madre metropolitana occupa lasilo nido, in Quotidiano donna, a. II, n. 33,
26/9/1979, p. 5; Ead. Asili nido occuparne uno per ottenerne cento (con piscina), in Quotidiano
donna, a. II, n. 37, 24/10/1979, p. 5.
55 La trappola della cattedra, in Efe, ottobre-novembre 1978, p. 41.
56 Lelario, A.; Casentino, V.; Armellini, G. (a cura di) Buone notizie dalla scuola, Milano, Pratiche
Editrice, 1998, p. 255.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 348 03/05/2013 11:11:22
CAPITOLO 8
Il protagonismo delle donne nellAmerica
Latina del Novecento
a cura di Maria Rosaria Stabili
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 349 03/05/2013 11:11:22
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 350 03/05/2013 11:11:23
Introduzione
Maria Rosaria Stabili
Poco si sa, in Italia, della storia delle donne e di genere dellAmerica Latina. Le
scarse informazioni che circolano sono frammentarie e dovute essenzialmente allo
scambio di alcuni gruppi femministi o di singole donne che nel recente passato,
per ragioni diverse, hanno avuto modo di avvicinarsi alla realt latinoamericana.
Una realt percepita, a ragione, particolarmente segnata dal patriarcato e da un
maschilismo che periodicamente produce una violenza eferata nei confronti delle
donne come i recenti episodi di femminicidio in Messico e in Centro America
indicano. Eppure, quasi a mo di contrappunto, la presenza attiva e riconosciuta
delle donne in molti ambiti della vita politica, sociale e culturale rappresenta uno
degli elementi pi signifcativi dei processi di transizione politica che hanno inve-
stito quella regione nellultimo scorcio del secolo scorso e nei primi anni dellat-
tuale. Tale presenza il prodotto di un lungo percorso ricco, complesso, a volte
contraddittorio, fatto di esperienze simili a quelle vissute e prodotte dalle donne
europee e nordamericane ma anche denso di alcune specifcit forti.
Le poche studiose italiane dellAmerica latina, al netto di singole ricerche con-
dotte isolatamente, di recente hanno cominciato a interrogarsi su tale protagoni-
smo da una prospettiva di genere e cercano di indagarne le ragioni. Il V Congresso
della Societ Italiana delle Storiche rappresenta dunque la loro prima occasione
dincontro. Lobiettivo, molto semplice, quello di provare a ofrire, tratteggiando
alcuni profli femminili, qualche squarcio sul rapporto delle donne con i poteri
maschili che dominano lo scenario pubblico e privato latinoamericano del Nove-
cento e di cominciare a rifettere assieme su alcuni nodi.
Gli interventi che qui si presentano, frutto di un primo approccio al tema,
non contengono rifessioni rilevanti di carattere critico-interpretativo rispetto
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 351 03/05/2013 11:11:23
352
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
allattuale panorama degli studi ma hanno il pregio di raccontare diverse esperien-
ze che permettono forse di capire un po meglio la storia pi recente delle donne
latinoamericane e anche la sua specifcit rispetto ad altre storie che si producono
nel resto del mondo occidentale. Nel loro insieme, tali interventi evidenziano la
discontinuit che si produce, negli anni Settanta del secolo scorso, nei modi e
negli stili della presenza femminile nella politica e nella societ.
Il protagonismo delle donne, per buona parte del Novecento e in linea di
continuit con il secolo che lo precede, simpone per la forza e capacit di singo-
le grandi personalit che emergono su uno sfondo caratterizzato da unapparente
passivit e subalternit femminile. I lavori di Benedetta Calandra e Camilla Cat-
tarulla su Frida Kahlo, Tina Modotti e Mara Rosa Oliver ofrono un esempio di
biografe eccezionali, frutto di percorsi spesso squisitamente individuali.
Le dittature militari, i confitti armati interni ad alcuni Paesi che caratteriz-
zano gli ultimi trentanni del secolo scorso favoriscono, con diverse modalit e a
diversi livelli, una partecipazione delle donne piena, difusa, corale. Le fgure no-
tevoli che emergono nascono e acquisiscono il loro senso allinterno di un inedito
movimento latinoamericano al femminile.
importante dar risalto al fatto che la seconda ondata del femminismo nasce
in America Latina contemporaneamente al movimento per i diritti umani la cui
leadership quasi tutta femminile e a nuovi movimenti sociali di resistenza in un
quadro in cui lautoritarismo, la durissima repressione politica e la violenza gene-
ralizzata evidenziano gli aspetti pi brutali di un sistema patriarcale che spazza via,
per tutti, tutti i diritti conquistati in precedenza
1
.
Molte storie sintrecciano in questi ultimi trentanni. Il movimento femmi-
nista la scommessa della generazione di donne degli anni Settanta e Ottanta del
secolo scorso, di classe media e alta, molte delle quali costrette allesilio dai regimi
autoritari dei rispettivi paesi e che nellesilio o studiando allestero, scoprono e si
appropriano, come dice Julieta Kikwood, di nuovi paradigmi di conoscenza di se
stesse e del mondo e scoprono come si pu essere donne in libert
2
. Tornate,
tra la fne degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, nei rispettivi paesi anco-
ra sotto dittatura o in fase dincipiente transizione democratica, inizialmente si
orientano a creare nuove pratiche collettive di autocoscienza, a sviluppare nuove
categorie di analisi e nuovi linguaggi. Giovani, audaci e irriverenti cominciano a
dare nome a fatti che sino ad allora non ne avevano: sessualit, abusi sessuali, vio-
lenza domestica, violazioni nel matrimonio, riconoscimento del lavoro riprodut-
1 Koonings, K.; Kruijt, D. (a cura di) Societies of fear. Te legacy of civil war, violence and terror in
Latin America, London-New York, Zed Books, 1999.
2 Kikvood, J. Ser poltica en Chile: Los nudos de la sabidura femminista, Santiago, Editorial Cuarto
Proprio, 1986, p. 17.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 352 03/05/2013 11:11:23
353
Introduzione
tivo, autonomia del proprio corpo, femminilizzazione della povert, diritto alla
giustizia e diritto alla libert come parte sostantiva della costruzione democratica
dei loro Paesi. Una dimensione culturale, ludica e simbolica, accompagna le azioni
del movimento che individuano date simboliche, recuperano storie, personalit,
referenti forti che trascendono i singoli Paesi e diventano patrimonio dellintera
regione latinoamericana. Partendo con i gruppi di autocoscienza, progressivamen-
te simpegnano nella produzione di un nuovo patto sociale tra uomini e donne, tra
la societ nel suo complesso e le donne, patto nel quale, a loro avviso, la diferenza
sessuale non debba apparire una dimensione rilevante e la diversit non debba
tradursi in esclusione e disuguaglianza
3
. Non sono le sole.
Il movimento delle donne latinoamericane non rifette un processo omogeneo
quanto, piuttosto, una pluralit di processi che mostra le diverse realt femminili
allinterno dei rispettivi Paesi e nei loro specifci spazi di vita e di azione. In questo
senso, forse, sarebbe pi opportuno parlare di varie tipologie dei movimenti delle
donne per quanto, per una migliore esplorazione delle interrelazioni, preferisco
parlare di un solo movimento la cui caratteristica essenziale leterogeneit. Le
variazioni danno ricchezza e un senso pi chiaro della realt perch rifettono
la complessit e le sfumature dellesistenza femminile. Allinterno di questo mo-
vimento pluralista si individuano, accanto alle femministe, altri versanti: quello
delle donne di estrazione popolare a cui possibile collegare le esperienze delle
donne indigene; quello che emerge negli spazi politici tradizionali e quello delle
donne dei movimenti per i diritti umani.
Le donne dei settori popolari partono dallesigenza di soddisfare necessit e
domande che emergono dai loro ruoli tradizionali utilizzando abilit e compe-
tenze che sono anche il prodotto della loro capacit di socializzare come donne.
Nel farlo, danno un contenuto pubblico a questi ruoli facendo delle loro attivit,
individuali e frammentate, il sostegno di sforzi collettivi. Rendono visibile i con-
tenuti dei loro ruoli tradizionali e rompono, nella pratica, con lidea che sono
precisamente tali ruoli la causa della loro emarginazione dalla sfera pubblica e
dalla partecipazione alle decisioni politiche, confnandole artifcialmente nella sfe-
ra privata, attraverso il controllo della loro vita. Questo versante del movimento
composto soprattutto da donne che vivono nei quartieri pi poveri e periferici
delle citt. Nel caso delle donne indigene che, per una serie di ragioni, presentano
una minore capacit organizzativa, esperienze interessanti si ritrovano anche nelle
aree rurali toccate dai progetti di sviluppo delle organizzazioni non governative,
nazionali e straniere
4
.
3 Vargas Valente, V. Feminismos en Amrica Latina. Su aporte a la poltica y a la democraca, Lima,
Universidad Mayor de San Marco-Ediciones Flora Tristn, 2008, pp. 159-162.
4 Frling, H. (a cura di) Derechos humanos y democracia: la contribucin de las organizaciones no
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 353 03/05/2013 11:11:23
354
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
Alle dinamiche appena accennate possibile collegare le esperienze delle asso-
ciazioni delle madri dei desaparecidos che sono il cuore dei movimenti per i diritti
umani. Le Madri di Piazza di Maggio, in Argentina, sono un esempio chiaro di
come ruoli squisitamente femminili possano acquisire un nuovo signifcato po-
litico e sociale. Rappresentano un radicale allontanamento dal modo in cui la
maternit stata utilizzata in passato. la maternit e, pi in generale, la natura
femminile, che permette e giustifca il loro ingresso in politica, che conferisce
loro totale autonomia rispetto ai partiti e a gruppi politici clandestini. In nome
della funzione materna e utilizzando la sostanziale sottovalutazione che i militari
attribuiscono alluniverso femminile, attivano iniziative inedite, defniscono stra-
tegie dintervento e si sentono protagoniste e portatrici di grande autorit morale
nello sfdare i poteri autoritari e repressivi
5
.
Le donne attive negli spazi pubblici tradizionali come i partiti politici, i sin-
dacati, le associazioni, cercano di modifcare tali spazi e aprirne dei nuovi per
raggiungere una maggiore partecipazione nella presa di decisioni a livello locale e
nazionale e lottano per un riconoscimento formale dei diritti femminili. I lavori
di Claudia Borri, Gabriella Citroni, Stefania Pastorelli, Marzia Rosti, Amanda Sal-
vioni, Sofa Venturoli e il mio, pur sofermandosi su singoli profli, cercano di dar
conto della molteplicit delle esperienze che, tra confronti durissimi, solidariet,
errori e incomprensioni si consolidano e trovano un punto dincontro nello slogan
inventato da Julieta Kikwood: Democracia en el pas y en la casa
6
.
In realt le tante anime del movimento delle donne si toccano e sintrecciano
continuamente. Alcune donne dei partiti politici e dei quartieri periferici si rico-
noscono femministe; le femministe militano nel movimento dei diritti umani e
sono attive nelle organizzazioni popolari, nei sindacati o partecipano ai progetti di
lotta alla povert nelle comunit indigene e cos via. Contemporaneamente, svi-
luppano azioni autonome in diferenti spazi e combinano obiettivi diversi; svilup-
pano specifci meccanismi dinterrelazione e solidariet. Le diferenze rifettono
la forma con cui le donne costruiscono movimento, amministrano le loro realt,
cercano di forgiare nuove identit che cominciano a fondarsi su un sentimento
di appartenenza a un genere. Questi processi non sono afatto semplici: le diverse
realt, esperienze, infuenze, nel loro mescolarsi e interagire con le altre dimen-
gubernamentales, Santiago de Chile, Instituto interamericanos de derechos humanos, 1991; Villavi-
vencio, M. Del silencio a la palabra, Lima, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristn, 1992.
5 Navarro, M. Te Personal is Political: Las Madres de Plaza de Mayo, in Eckestein, S. (a cura di)
Power and Popular Protest, Berkeley, University of California Press, 1989, pp. 241-258, Stabili, M.R.
Il movimento delle madri in America latina, in Bartoloni, S. (a cura di) A volto scoperto. Donne e
diritti umani, Roma, Manifestolibri, 2002, pp. 133-154.
6 Kirkwood, J. Ser poltica en Chile cit, p. 168.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 354 03/05/2013 11:11:23
355
Introduzione
sioni che fanno parte della vita delle donne come la classe sociale, letnia, let,
la localizzazione geografca, assumono una molteplicit di espressioni specifche.
Allo stesso tempo questi processi rifettono, meglio di qualsiasi altro aspetto, la ric-
chezza e la qualit innovatrice del movimento, illuminano le diferenze tra donne
ed esprimono una nuova modalit, concreta e vitale, di trasformarle in forza pro-
pulsiva. La pluralit sociale, etnica, culturale, geografca del movimento infuisce
sul proflo e lo sviluppo delle protagoniste, segna le divergenze e/o le convergenze
immediate ed eventuali interne al movimento.
I diversi versanti sono spazi nei quali le donne latinoamericane cercano di
scoprire un modo nuovo e diverso di essere donne costruendo le basi di una nuo-
va identit. Sono spazi ancorati nella vita quotidiana, in cui le donne scoprono
la complessit della subordinazione e le forme per resistere e respingerla. Sono
spazi pi simbolici che geografci, molteplici e discontinui, costruzione culturale e
punto di riferimento, e rivelano che non esiste a priori uno spazio privilegiato per
decifrare le relazioni di potere ma, al contrario, un numero infnito di luoghi dai
quali lanciare molteplici sfde allordine sociale esistente
7
.
I nuovi movimenti sociali e in modo particolare il movimento delle donne,
per la sola ragione di esistere in una congiuntura antidemocratica, mettono in
discussione radicalmente la forma in cui sono organizzate le rispettive societ. Nel
farlo, mettono in discussione i paradigmi tradizionali di analisi politica e sociale,
evidenziano le molte aree di tensione e dimostrano che esiste una molteplicit di
soggetti sociali portatori di strategie diverse. Generano nuove domande e aprono
nuovi spazi di analisi e discussione sui vincoli esistenti tra la vita quotidiana e le
relazioni di potere allinterno delle quali possibile realizzare una trasformazione
sociale; e rendono possibili nuove azioni sociali collettive per ottenere un cambia-
mento politico. In paesi con profonde radici autoritarie, in cui esistono societ
civili fragili che creano grandi ostacoli al consolidamento dei processi di democra-
tizzazione, ancora dif cile pensare il confitto sociale in termini diversi da quello
della guerra e della distruzione. In questo quadro, attraverso forme ancora non
completamente esplorate, tali movimenti afrontano ed esprimono le diversit e
contribuiscono, in forma signifcativa, ad arricchire le dinamiche sociali dando a
esse forma politica.
Forse, nei processi sinteticamente descritti in queste pagine, possibile rin-
tracciare alcune delle ragioni che spiegano il peso e limportanza oggi riconosciuta
al ruolo delle donne e la loro forte visibilit sullo scenario politico, economico e
sociale dei paesi latinoamericani. Solo per fare un esempio basti ricordare che negli
7 Jelin, E. Women, Gender and Human Rights, in Ead. (a cura di) Constructing Democracy.
Human Rights, Citizenship and Society in Latin America, Boulder, Westview Press, 1996.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 355 03/05/2013 11:11:23
356
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
ultimi anni sono molte le donne che ricoprono la carica di sindaco nelle capitali e
in importanti citt della regione; cinque sono state elette Presidenti della Repub-
blica (Violeta Barrios Chamorro in Nicaragua; Michelle Bachelet in Cile; Cristina
Fernndez in Argentina; Laura Chincilla in Costa Rica; Dilma Roussef in Brasile)
e tra il 1991 (Argentina) e il 1998 (Venezuela), dieci paesi dellAmerica Latina
hanno approvato le quote rosa. Questa tendenza regionale non ha precedenti nella
storia mondiale. Nel 2009 le donne occupano il 21% dei seggi dei parlamenti
latinoamericani su una media mondiale del 18%. Si sono imposte, nella maggior
parte dei casi, grazie al loro radicamento nella societ e non per designazioni av-
venute dalle segreterie dei partiti. Tra grandi problemi e contraddizioni ancora
necessario percorrere un lungo cammino ma la sensazione che tale tendenza ,
in qualche modo, irreversibile.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 356 03/05/2013 11:11:23
1. Biograe femminili a confronto nel Messico
post-rivoluzionario: Frida Kahlo e Tina Modotti
Benedetta Calandra
Frida y Tina: vidas no paralelas
8
: con questo articolo Octavio Paz sottolineava
nei primi anni Ottanta del secolo scorso i numerosi elementi che, a suo avviso,
facevano divergere i percorsi biografci di due icone femminili del Messico postri-
voluzionario. Pochi mesi prima, in Gran Bretagna, una mostra fotografca aveva a
sua volta tentato di costruire un ideale percorso di confronto
9
. Due vite intense e
molto brevi (Tina muore nel 1942, a 45 anni; Frida muore nel 1954, ne ha 47),
che sincontrano sulle ceneri ancora calde della Rivoluzione. Unite inizialmente
dalla politica, dalla politica stessa vengono in seguito divise per divergenze nate in
seno al Partito Comunista
10
.
Tina una creatura nomade, cosmopolita
11
, che sceglie il Messico come paese
dadozione, ma nella cui esistenza giocano un ruolo fondamentale anche lItalia
8 Paz, O. Frida y Tina: vidas no paralela, in Vuelta, n. 82, vol. 7, 1983, p. 48.
9 Mulvey, L.; Wollen, P. (eds.) Catalogo della mostra fotografca Tina Modotti and Frida Kahlo,
Londra, White Chapel Gallery, 1982.
10 Barckhausen-Canale, K. Verdad y leyenda de Tina Modotti, La Habana, Casa de las Amricas,
1989, pp. 170-171, tr.it. Tina Modotti: verit e leggenda, Firenze, Giunti, 2003.
11 nata in Italia, emigrata con la famiglia negli Stati Uniti, trasferitasi da San Francisco a Los Angeles
e in seguito dalla California al Messico, espulsa dal Messico su una nave diretta a Rotterdam, asilo
politico a Berlino, in volo per Mosca, dove la sua attivit per il Comintern la port dapprima a Parigi,
poi in Spagna e infne in aereo di nuovo alla volta della Francia [poi] un ultimo esilio in Messico,
dove mor nel 1942, a soli quarantacinque anni. La permanenza quasi decennale in Messico []
fu, nella sua esistenza adulta, il periodo pi lungo trascorso in un solo paese. Mulvey, L.; Wollen,
P. Radici e movimenti, in Agostinis, V. Tina Modotti: gli Anni Luminosi, Pordenone, Cinemazero-
Edizioni Biblioteca dellImmagine, 1992, p. 91.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 357 03/05/2013 11:11:23
358
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
dove nasce e trascorre la prima adolescenza , gli Stati Uniti, la Russia, la Spagna.
Frida, che sostituisce deliberatamente la sua reale data di nascita, il 1907, con
quella della revolucin armada, il 1910, fa della mexicanidad un emblema costante
della sua personalit. La esibisce feramente attraverso i vestiti indigeni, i gioielli
ispirati allarte precolombiana, le unghie dipinte a colori vivaci anche nel letto
dospedale dov periodicamente immobilizzata per ricorrenti problemi di salute.
Tina viene oggi ricordata nel mondo essenzialmente per le sue foto, alle quali
dedica una gran parte della sua vita. Frida pittrice, ma anche per lei la fotografa
riveste un ruolo cruciale. Nasce in una famiglia di fotograf da due generazioni
(sia il nonno paterno che quello materno) e il padre Wilhelm intraprende una
fortunata carriera divenendo il primo fotografo uf ciale del patrimonio culturale
della nazione
12
. Durante ladolescenza Frida acquisisce precoce familiarit con la
camera oscura, riproduce nei suoi quadri lo stile immobile dei personaggi in posa
di fronte alla macchina, ritocca le foto di famiglia.
Due personalit carismatiche, scandalose nei loro comportamenti pubblici e
privati, continuamente seguite e criticate dalla stampa dellepoca, Tina Modotti e
Frida Kahlo rappresentano per molti versi solo se stesse, e sarebbe probabilmen-
te una forzatura ricercare in esse lespressione di un movimento collettivo. Han-
no per entrambe segnato una forte rottura nei modi e negli stili della presenza
femminile nella sfera pubblica di quel fervente laboratorio di dinamiche socio-
politiche rappresentato dal Messico degli anni Venti e Trenta, dove artisti come
Siqueiros, Rivera e Orozco incarnano tendenze dirompenti nel panorama artistico
e culturale dellepoca, spesso lacerati nel tentativo di coniugare tensione estetica e
militanza di partito
13
.
Questa brevissima rifessione sar centrata su tre aspetti essenziali dei rispet-
tivi percorsi biografci, scelti tra molti possibili spunti comparativi, accomunati
dallelemento del potere e intrecciati tra di loro: la relazione con gli Stati Uniti,
con la politica e con le fgure di riferimento maschili.
Gringolandia
In una recente biografa storica Letizia Argenteri individua nel periodo califor-
niano (1913-1923), sinora poco approfondito, un precedente fondamentale per
interpretare le scelte politiche ed esistenziali di tutta la vita della Modotti. Nel
12 Hooks, M. Frida Kahlo. La gran ocultadora, Mexico D.F., Turner/Oceano, Trockmorton Fine
Art, 2006, p. 10.
13 Funes, P. Salvar la Nacin. Intelectuales, cultura y poltica en los aos veinte latinoamericanos,
Buenos Aires, Prometeo libros, 2006, pp. 50 e ss.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 358 03/05/2013 11:11:23
359
1. Biografe femminili a confronto nel Messico post-rivoluzionario: Frida Kahlo e Tina Modotti
percorso dellafascinante friulana, che condensa almeno quattro aree chiave: la
storia dellimmigrazione, la fotografa, la storia delle donne e la politica
14
, sot-
tolinea dunque il valore altamente formativo del soggiorno in West Coast, terra
che raggiunge ancora adolescente per ricongiungimento familiare. I dieci anni in
contatto con la comunit forida e culturalmente vivace degli italiani a San Franci-
sco
15
, sua citt dadozione
16
, sanciscono linizio di un cammino. In questa terra
di opportunit spiccano in particolare due elementi. Il primo lassociazionismo
degli immigrati, gi molto ben defnito nel 1913, anno del suo arrivo e momento
di svolta nella storia del movimento operaio locale per lelezione al Congresso del
primo membro californiano di origini proletarie e per linsurrezione di Wheat-
land
17
. Il secondo latmosfera di radicalismo bohemien che Tina respira a partire
dal 1916 e che la conduce al primo grande amore, lartista de Richley, futuro
tramite per il Messico. Robo pubblica infatti su Gales, rivista di comunismo
rivoluzionario in lingua inglese nella capitale messicana e lettura di riferimento
obbligato per la comunit di progressisti nordamericani l radicati, afascinati dagli
eventi rivoluzionari come testimoniano la difusione di Isurgent Mexico di John
Reed, le visite di Jackson Pollock, la rivista Regeneracin degli anarchici Enrique
e Ricardo Flores Magn
18
. Tina, Robo e il fotografo Edward Weston vengono
invitati nel 1921 nella terra di Jos Vasconcelos, allepoca ministro della pubblica
istruzione. Due anni dopo, in seguito alla morte del suo compagno, per Tina si
apre lesperienza quasi decennale del Distrito Federal.
Con una tipologia di referenti molto diversa si relaziona al contrario la Kahlo,
che a sua volta risiede negli Stati Uniti, ma negli anni 1929-33. Sedici anni dopo
larrivo di Tina, giovane fglia e migrante, Frida vi giunge come moglie di Diego
Rivera, incaricato di afrescare a San Francisco lArt Institute e lo Stock Echange
Luncheon Club dopo essersi ricoperto di gloria in patria. I caudillos militari neces-
sitavano infatti di intellettuali e artisti per legittimare il nuovo stato postrivoluzio-
nario, rappresentando visivamente lirruzione delle masse in politica e loccupazio-
14 Argenteri, L. Tina Modotti: between Art and Revolution, New Haven, Yale Univ. Press, 2003 tr.it.
Tina Modotti. Fra arte e rivoluzione, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 16-17.
15 Paoli Gumina, D. Te Italians of San Francisco, 1850-1930, New York, Center for Migration
Studies, 1978, p. X.
16 Archivi Edward Weston, Center for Creative Photography, Tucson, Tis might be called my home-
town. Lettera di Tina Modotti a Edward Weston, 23 gennaio 1926, in Argenteri, L. Tina Modotti
cit., p. 43.
17 Fasce, F. Il movimento operaio in California negli anni dieci del Novecento, in Tina Modotti
una vita nella storia, Udine, Edizioni Arti Grafche Friulane, 1995, pp. 97-117.
18 Delpar, H. Te Enormous Vogue of Tings Mexican. Cultural Relations Between the United States
and Mexico, 1920-1935, Tuscaloosa, Te University of Alabama Press, 1992.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 359 03/05/2013 11:11:23
360
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
ne degli spazi fsici e sociali di operai e contadini
19
. Per una popolazione analfabeta
per l80% le potenzialit educative dei murales erano evidenti: veicolo privilegiato
di trasmissione dei nuovi contenuti della nazione, erano emozione, persuasione,
forgiavano identit collettive.
Rivera, che la rivista New Masses vede come la sintesi tra lavanguardia russa
e quella messicana, invitato a varcare i confni del Ro Grande. Scrive il critico
Max Kozlof che in nessun altro luogo unarte che si dichiarava proletaria fu con
tanta generosit sponsorizzata e protetta dal capitalismo
20
. Frida al suo fanco,
non possiede ancora unidentit automa di artista, manifesta una netta distanza
linguistica, culturale, ideologica. Il 3 maggio 1931 scrive allamica Isabel Campos
non mi piace per niente il gringuero: gente molto noiosa e hanno tutti delle
facce che somigliano a torte cotte male
21
. Rivera viene invitato a novembre da
Frances Flynn Payne, consigliere artistico di Rockefeller, per una retrospettiva al
Museo dArte Moderna di New York. Nellaprile del 1932 la coppia si sposta a
Detroit, dove a Diego viene commissionata dal presidente della Ford Motor Com-
pany a grande saga della macchina e dellacciaio. Mentre questultimo afasci-
nato della potenza industriale, Frida parla della citt come di un luogo orribile e
stupido
22
. Questa totale estraneit, cos come il suo amore per la terra dorigine,
compaiono con evidenza nel suo Autoritratto al confne tra Messico e Stati Uniti.
Eppure il passaggio da dilettante a professionista della pittura segnato proprio
dalla risonanza acquisita a gringolandia dopo aver esposto nel 1938 alla Julian
Levy Gallery di New York
23
.
Lultima foto pubblica della Kahlo del 2 luglio del 1954: sfla in una mani-
festazione di protesta contro lintervento della CIA in Guatemala. Undici giorni
dopo muore in un letto dospedale, in circostanze mai del tutto accertate.
Politica e poteri maschili
Il 1927 segna una tappa importante per la relazione che Tina e Frida stabiliscono
rispettivamente con la militanza. La prima aderisce al partito comunista messica-
no, la seconda entra nelle fla del suo movimento giovanile. Entrambe partecipano
attivamente al Frente Unico pro Sacco y Vanzetti, seguendo con passione il caso sino
19 Funes, P. Salvar la Nacin cit., pp. 111-114.
20 In Jamis, R. Frida Kahlo, Milano, Longanesi, 1985, p. 99.
21 Ivi, pp. 136-137.
22 Ivi, p. 98.
23 Lowe, S.M. (eds.) Te Diary of Frida Kahlo, New York, Harry N. Abrams Inc., 1995, tr.it Il diario
di Frida Kahlo:un autoritratto intimo, Milano, Arnoldo Mondadori editore, 1995, p. 27.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 360 03/05/2013 11:11:23
361
1. Biografe femminili a confronto nel Messico post-rivoluzionario: Frida Kahlo e Tina Modotti
alla fne. Nello stesso periodo Tina aderisce alla sezione messicana di Soccorso
Rosso Internazionale, per il quale lavorer anche in Spagna
24
. Intenso anche
limpegno per la campagna Manos fuera de Nicaragua, seguita alloccupazione sta-
tunitense del 1926-27.
La fascinazione per la Revolucin armada invece evidente nei soggetti delle
sue foto, emblemi della memoria collettiva: bandoliere, pannocchie, falci, chi-
tarre. Lo stesso Rivera fssa nel 1928 limmagine della Modotti che distribuisce
armi ai combattenti nel murale Corrido de la Revolucin. Tina si schiera anche
contro il fascismo italiano attraverso alcuni articoli su El Machete, organo uf ciale
del Partito Comunista messicano. Vi contribuisce regolarmente come fotografa e
traduttrice, assumendosi inoltre la responsabilit di esplicite denunce al regime di
Mussolini
25
che la faranno qualifcare come persona non grata in patria
26
.
Mentre il suo compagno, Weston, mantiene una distanza crescente nelle tur-
bolente vicende messicane e internazionali fno alla sua partenza, nel 1926, Tina
rimane, gettandosi sempre pi a capoftto nella politica. La militanza sancisce
dunque una separazione afettiva tra i due e una netta evoluzione nel rapporto
maestro-alunna. Lei gli debitrice per aver appreso le migliori tecniche fotogra-
fche, condividendo una scelta stilistica di fondo: lavversione per la fotografa
pittorica, dagli efetti sfumati e dalla messa a fuoco imprecisa, e la predilezione
per i contorni ben marcati degli oggetti della vita reale. Tuttavia, elabora uno stile
proprio. Per cominciare, Tina port la macchina fotografca in strada, e l foto-
graf la gente
27
.
Anche Argenteri, nel tentativo di separare il mito dalla storia, tende a de-
costruire limmagine di Tina come femme fatale indissolubilmente legata alle
propensioni artistiche, o ideologiche, dei suoi amanti. Rovesciando piuttosto i
termini della questione, sottolinea la capacit di scelta degli uomini al suo fanco
proprio in funzione del suo orientamento politico:
Dal 1926 in poi Tina si interess solo a uomini impegnati politicamente, se non
addirittura militanti. Il che comunque non suf ciente per afermare che fosse
incapace di pensare in maniera indipendente in materia di politica, o per soste-
nere che la fgura della Modotti appartiene pi alla storia delle passioni che non
24 Natoli, C. Tra solidariet e rivoluzione: il Soccorso Rosso Internazionale, in Tina Modotti. Una
vita nella storia cit., pp. 193-211.
25 Los horrores del fascismo en Italia, in El Machete, IV, n. 131, 15 settembre 1928; Manifesta-
ciones antifascistas en Italia, in El Machete, IV, n. 134, 6 ottobre 1928.
26 Archivio del Ministero degli Afari esteri, Documento dei sovversivi n. 015319 in Messico, 3 luglio
1928 cit. in Argenteri, L. Tina Modotti cit., p. 161.
27 Mulvey, L.; Wollen, P. Radici e movimenti cit., p. 92.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 361 03/05/2013 11:11:23
362
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
a quella delle ideologie, come aferma Octavio Paz.[] In efetti, se si osserva la
vita della Modotti, facendo particolare attenzione al suo impegno politico, si nota
che successe proprio il contrario; cio che fu il suo credo politico che dett le sue
scelte sentimentali, e non viceversa
28
.
Alla luce di queste considerazioni si potrebbe dunque leggere diversamente la pre-
senza degli uomini tutti quadri di partito che si avvicendano nel successivo, tu-
multuoso percorso biografco: Xavier Guerrero, Julio Antonio Mella, Vittorio Vidali.
Anche nel caso di Frida Kahlo il nesso tra capacit artistiche, militanza poli-
tica e relazioni con fgure maschili forti ftto e controverso. Introdotta secondo
alcuni proprio dalla Modotti nella giovent del Partito, sviluppa un legame con
la dirigenza sempre pi mediato da quello di Rivera
29
. Prova ne il suo ritiro nel
1929, immediatamente dopo lespulsione del consorte, e il suo rientro solo nel
1948, anche in questo caso su consiglio del marito
30
. Il profondo legame con il
comunismo e con la mexicanidad rimangono per costanti in tutte le sue espres-
sioni artistiche, come evidenziano i frequenti abbinamenti nel suo diario persona-
le tra la falce e il martello con simboli precolombiani.
Per alcuni studiosi una diferenza fondamentale tra queste due icone delle-
poca risiede nel fatto che Frida abbia incarnato il ruolo di moglie e potenziale
madre mentre Tina nonostante laura che associa costantemente le sue vicende
a quelle dei suoi compagni romperebbe con forza questa immagine
31
. Eppure
recenti chiavi di lettura individuano nella Kahlo una propensione molto precoce
allautonomia, riscontrabile persino nella fase di Detroit, quando agli occhi del
mondo vive ancora allombra del gigante. In questo periodo di relativa invisibilit
emergerebbe gi, in nuce, la esposa empresaria, promotrice attiva dellimmagine del
consorte e interprete, dal buon inglese scritto e dalle abili capacit relazionali
con interlocutori complessi come i Rockefeller
32
. Una donna dunque gi sottil-
mente protagonista anche quando si frma Frida Rivera, prima ancora di diventare
Frida Kahlo.
28 Argenteri, L. Tina Modotti cit., p. 145.
29 Lowe, S.M. (eds.) Il diario di Frida Kahlo cit., p. 19.
30 Ivi, pp. 301, 303.
31 Ankori, G. Imagining Her Selves. Frida Kahlos Poetics of Identity and Fragmentation, Westport,
Greenwood Press, 2002, p. 19.
32 Ortoll, S.; Ramrez de Arellano, A. Frida Kahlo. Retrato de la artista como esposa empresaria,
in Desacatos. Revista de Antropologa Social, n. 11, 2003, pp. 120-131.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 362 03/05/2013 11:11:23
2. Mara Rosa Oliver: unargentina
liberal-oligarchico-comunista
Camilla Cattarulla
La fgura di Mara Rosa Oliver (Buenos Aires, 1898-1976) si colloca allinterno di
un processo di trasformazione che attraversa la societ argentina e, in particolare,
il ruolo della donna imposto dalla tradizione. Infatti, loligarchia liberale, negli
anni del suo massimo splendore (approssimativamente 1880-1930), aveva ela-
borato la propria immagine dallinterno mediante una contraddizione di valori,
tanto che nella gestione dei rapporti con la famiglia e con la societ di origine
immigratoria predominava il valore hidalgo (tradizionalista, di retaggio spagnolo),
mentre allesterno era decisamente cosmopolita e aveva nel gentleman inglese e
nel dandy francese i suoi ispiratori per cultura, moda, costruzione e arredamento
delle proprie abitazioni. In un tale modello, la donna (sposa/madre) era diventata
il nucleo di questa contrapposizione, in quanto destinata a essere la custode di
principi profondi e non declamati perch contrastanti con la modernit. Ed
proprio nel periodo di maggior auge di questo modello famigliare e sociale che
diverse intellettuali, appartenenti al for fore delloligarchia argentina, danno vita
a unoperazione fatta di strategie spesso apparentemente di segno contrastante,
di messa in discussione o di riscrittura del discorso maschile sulla donna
33
. Si
tratta di una riformulazione che segue prevedibili itinerari di rifuto del ruolo
imposto alla donna dalla societ maschile e, contemporaneamente, manifesta la
pi inquietante testimonianza di una svolta radicale, segno anche di unepoca di
cambiamenti storico-sociali, di polemiche e dibattiti culturali e politici.
33 Un panorama su queste intellettuali oferto da Muschietti, D. Mujeres: feminismo y litera-
tura, in Vias, D. (direct.) Literatura argentina siglo XX, vol. 2: Graciela Montaldo (comp.), Yrigoyen
entre Borges y Arlt (1916-1930), Buenos Aires, Paradiso, 2006, pp. 111-136.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 363 03/05/2013 11:11:23
364
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
Fra queste intellettuali vi , appunto, Mara Rosa Oliver, la quale, senza rinne-
gare n tralasciare del tutto le proprie radici (non abbandoner mai le amicizie nel
mondo delloligarchia), prende una posizione politica e culturale opposta a quella
che sembrava esserle destinata arrivando a schierarsi contro i valori della propria
classe. Amica di Victoria Ocampo, ma anche, tra i tanti, di J. Amado, P. Neruda, E.
Mallea, A. Reyes, R. Caillois, R. Alberdi, J.L. Borges, Le Corbusier, G. Ciano, A.G.
Bragaglia, Che Guevara, Mara Rosa Oliver stata Vicepresidente della Unin de
Mujeres Argentinas e membro del Consiglio Mondiale per la Pace. Inoltre, per quasi
due anni (1942-43), lavor negli Stati Uniti presso lInter-American Coordinators
Of ce e negli anni Cinquanta viaggi in Cina, dove conobbe Mao Tse Tung, e
in Russia, dove nel 1958 ricevette il Premio Lenin
34
. Questa capacit di muoversi,
sia pur con tentennamenti e ambiguit, tra mondi culturali e ideologici opposti si
rifette anche nei suoi articoli e libri. In particolare vanno ricordati i tre testi autobio-
grafci. Il primo, Mundo, mi casa (1965), unevocazione dellinfanzia e della prima
adolescenza; il secondo, La vida cotidiana (1969), si riferisce agli anni che vanno dal-
la Prima guerra mondiale agli albori della guerra civile spagnola; infne il terzo, Mi fe
es el hombre (1981), copre il periodo che va dallarrivo degli esiliati spagnoli a Buenos
Aires fno ai primordi dellascesa al potere di Pern
35
. Ciascun volume ricostruisce,
pertanto, unepoca della vita sociale, politica e culturale argentina, con incursioni
anche in altre realt latinoamericane (Brasile, Messico, Colombia, Ecuador e Cile)
dovute ai frequenti viaggi e soggiorni dellautrice allestero. E ci nonostante laver
contratto la poliomelite allet di dieci anni la costringesse sulla sedia a rotelle.
In particolare, i tre testi presentano un quadro ampiamente dettagliato del
sistema di vita di una famiglia argentina oligarchica nel primo Novecento e fno
alla met degli anni Quaranta. Lenorme casa a Buenos Aires di fronte a Plaza San
Martn, i fne settimana in campagna, le vacanze estive a Mar del Plata, bambinaie
e domestici, insegnanti privati, anche di musica e di lingue straniere, il t delle
cinque, il giorno delle visite, i pranzi di famiglia e il classico viaggio in Europa,
insieme a mucche e galline trasportate per garantire latte e uova freschi sulla nave,
costituiscono un panorama di costumi e abitudini di una classe sociale in cui lo
sguardo di Mara Rosa individua fn dallinfanzia lesistenza di una scala gerarchi-
ca e lappartenenza a un ceto superiore
36
.
34 Per una biografa di Mara Rosa Oliver cfr. Clementi, H. Mara Rosa Oliver, Buenos Aires, Pla-
neta, 1992.
35 Cfr. rispettivamente: Oliver, M.R. Mundo, mi casa, Buenos Aires, Falbo Librero Editor, 1965;
Ead., La vida cotidiana, Buenos Aires, Sudamericana, 1969; Ead., Mi fe es el hombre, Buenos Aires,
Carlos Lohle, 1981.
36 Solo per citare un esempio, sulla spiaggia le viene vietato di giocare con altri bambini, segno di
unappartenenza sociale distinta (cfr. Oliver, M.R. Mundo, mi casa cit., p. 85).
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 364 03/05/2013 11:11:23
365
2. Mara Rosa Oliver: unargentina liberal-oligarchico-comunista
Nel nucleo famigliare e parentale degli Oliver svettano le fgure della madre e
del padre. La prima risponde in pieno al ruolo che la donna deve occupare allin-
terno della famiglia oligarchica: abnegazione, fedelt, discrezione, ef cienza nella
gestione della casa, impegno nelle opere di carit e, naturalmente, senso materno
sono le doti che non possono mancare a una sposa oligarchica, attenta, inoltre, a
che i fgli non manifestino allesterno unimmagine diversa (trasgressiva) rispetto
a quella confacente al loro livello sociale. Pi articolata, invece, la fgura del padre,
professore universitario e deputato per il partito conservatore, depositario di una
biblioteca grazie alla quale Mara Rosa si rende conto di avere una grande passione
per la lettura pi che per lo studio.
La fgura del padre va di concerto con quella del nonno. I dialoghi tra i due
uomini sono specchio di come la classe liberal-oligarchica agli inizi del XX secolo
stia rifettendo sullidentit nazionale del Paese, anche in rapporto con il suo pas-
sato. Scrive Mara Rosa Oliver:
In casa si parlava pi del futuro dellArgentina che del suo passato. Mio
nonno menzionava la ricchezza del paese, con i suoi campi, i trasporti; pap,
limmigrazione, le scuole, le strade:
Che gli inglesi, padroni delle ferrovie, impediscono di costruire segnalava
spesso.
La cosa non piaceva al nonno che, una volta, a tavola, arriv a dire:
Se gli inglesi avessero scoperto queste terre noi saremmo molto pi avanti.
A ci mio padre ribatt:
Ma dottore, se invece degli spagnoli fossero arrivati gli inglesi, non saremmo
noi.
Non capendo del tutto il ragionamento di pap, gli avevo chiesto di spiegarlo
meglio.
Chi siamo noi? Eh? Tuo nonno, io, insomma voi, siamo tutti discendenti di
spagnoli, come la maggior parte degli abitanti di questo paese. Se lo avessero
conquistato gli inglesi, dove saremmo noi?
37
Ed sempre grazie al padre che Mara Rosa rifette su cosa vuol dire essere
conservatore:
Conservare, secondo me, signifcava mantenere qualcosa come sta. Per esempio, le
sardine in scatola di cui mamma dif dava tanto da annusarle con il timore che ci
37 Ivi, p. 112, corsivo nel testo. Questa e le successive traduzioni sono mie.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 365 03/05/2013 11:11:23
366
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
avvelenassero. E se pap voleva conservare, perch diceva sempre che le cose de-
vono cambiare e che non si pu andare avanti cos? E soprattutto, perch era cos
preoccupato e intristito da quanto a Barcellona avevano fatto o stavano per fare alla-
narchico Ferrer, se, secondo gli zii, gli anarchici sono allopposto dei conservatori?
38
Un primo chiarimento arriva dallo stesso padre, dopo la fucilazione di Ferrer:
Gli chiesi:
Era anarchico?
S e allora?
Doveva essere cattivo
Al contrario Voleva il bene degli altri
Se lui era cos, perch tu sei conservatore? lo pungolai dopo un processo men-
tale che lui doveva aver capito perch mi guard sorpreso, sorrise e mi rispose:
Sono entrato nel partito conservatore perch era quello con cui avevo pi pro-
babilit di diventare deputato e di poter dire e fare qualcosa ma se avessi un
fglio in et da mettersi in politica, non gli consiglierei di essere conservatore
Gli diresti di essere cosa?
Radicale Socialista, forse
Non anarchico?
Anarchico no, sono degli illusi
39
Radicalismo, anarchismo, comunismo e poi femminismo sono per molte
donne oligarchiche movimenti politici spauracchio e tentazione. In La vida coti-
diana, Mara Rosa ricorda come, nel 1916, in occasione della vittoria dei radicali e
dellelezione a presidente di Hiplito Yrigoyen, le donne di casa (e non gli uomini)
avevano proibito a lei e ai suoi fratelli di afacciarsi al balcone al passaggio del-
lurlante e immensa manifestazione [delle] turbe radicali
40
. E ci nonostante la
famiglia frequentasse radicali e soci del Jockey Club o del Crculo de Armas, dove
si riunivano i conservatori, e, al contrario, vi fossero conservatori, come il padre e
il nonno, che in quei luoghi non mettevano piede. In quella circostanza, unaltra
conversazione con il padre le fa prendere coscienza che il termine radicale va
sempre unito a cambiamenti e trasformazioni
41
.
38 Ivi, p. 209.
39 Ivi, pp. 209-210. Venti anni dopo, Mara Rosa avrebbe ricordato come limmagine di uomini
quasi santi fornitale dal padre fosse stata ormai cancellata dagli atti violenti e dagli attentati com-
messi dagli anarchici in Argentina negli anni Venti e Trenta (cfr. Ead., La vida cotidiana cit., p. 351).
40 Ivi, p. 87.
41 Cfr. ivi, p. 88.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 366 03/05/2013 11:11:23
367
2. Mara Rosa Oliver: unargentina liberal-oligarchico-comunista
Le rifessioni politiche e sociali a cui la sollecita il padre cominciano a renderle
sempre pi evidenti, negli anni della Prima guerra mondiale e della Rivoluzione
russa, le diferenze di classe:
Fino ad allora il fastidioso sospetto che, in qualche modo vago, per me impre-
cisabile , la miseria di alcuni era la conseguenza della ricchezza di altri, mi era
passato fugace nella mente. Pi che sapere intuivo che gli scioperi [] e le rivo-
luzioni [] scoppiavano come protesta contro un potere pi grande di quello dei
re e degli zar, ma a questo potere ancora non sapevo dare un nome
42
.
Comincia cos a ricordare le sue simpatie per la Russia a partire da quando il
padre, in occasione della morte di Lenin, lo aveva considerato luomo forse pi
importante di questo secolo. E aggiunge: Poco tempo prima avevo annotato
in un quaderno che quanto era rivoluzionario mi arrivava come un seme e che il
contrario mi risultava inassimilabile. Il contrario era aferrarsi al passato con lidea
che era sempre stato migliore. Sapevo che se veramente era potuto essere migliore,
lo era stato sempre per una infma minoranza
43
.
Sono alcuni amici, Waldo Frank e una coppia di cui non cita i nomi, ad avvi-
cinarla al marxismo e da l al Partito Comunista. Il primo le raccomanda la lettura
de I dieci giorni che sconvolsero il mondo, di John Reed, e i secondi la invitano a
seguire le lezioni sul marxismo di Rodolfo Puiggrs, un argentino appena rientra-
to dalla Russia, a partire dalle quali Mara Rosa comincia a leggere Engels, Marx e
Lenin, il Manifesto Comunista e romanzi della letteratura europea e nordamericana
di tendenza marxista o che comunque lei legge con uno sguardo ormai fortemente
infuenzato dalle recenti letture politiche. Su tutto, il Manifesto Comunista il
testo per lei pi illuminante di qualsiasi altro, sia pure con alcune riserve:
anche se la teoria economica la sentivo aderente alla realt come un albero ben
radicato alla terra, la flosofa del materialismo storico mi sembr cos galleggiante
nellaria, tanto alla merc dei venti come qualunque altra delle flosofe con cui
avevo cercato invano di immedesimarmi. Ma il suo ateismo non mi sciocc
cosa poteva scioccarmi! ; il comportamento individuale e collettiva di coloro che
si proclamavano credenti in Dio aveva esaurito la mia capacit di scandalizzarmi.
Invece, nel marxismo vedevo e per il momento continuo a vedere lunico
mezzo valido per mettere in pratica il Ama il prossimo tuo come te stesso.
Allimbattermi nella frase la religione loppio del popolo, mi ero ricordata di
quella volta in cui mio padre aveva perso autorit di fronte a me sostenendo che
42 Ivi, p. 99.
43 Ivi, pp. 187, 237-238.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 367 03/05/2013 11:11:23
368
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
le donne, pi degli uomini, hanno bisogno della religione perch un freno. Fre-
nare o drogare, pensai, sono mezzi simili per impedire qualsiasi forma di libert
individuale e collettiva
44
.
Ma nonostante le sue idee, non cessa di frequentare gli amici oligarchici, n
cerca di nascondere loro il suo nuovo approccio con la realt politica e sociale che
la circonda, e scrive:
ma, o perch per loro [le mie opinioni] erano conseguenza logica del mio usuale
pensiero, o per considerarle una velleit passeggera o un errore di giudizio che,
immancabilmente, avrei corretto, nessuno, allora, cambi atteggiamento nei miei
confronti. E meno ancora io nei loro: Marx stesso mi dimostrava, con una chia-
rezza prima sconosciuta, che tutti siamo condizionati da un sistema sociale disor-
dinato, ingiusto e condannato a deteriorarsi. Processare il sistema non obbligava,
pertanto, a giudicare individualmente coloro i quali, come me, il caso aveva fatto
nascere nella classe privilegiata
45
.
Con lavvicinamento al marxismo, cominciano anche le sue battaglie per i
diritti delle donne, portate avanti con Victoria Ocampo. Classe sociale, tipo di
educazione, gruppo di appartenenza e amicizie le accomunano, tanto che fn dal
loro primo incontro si svilupper un rapporto afettivo mantenuto anche quando,
negli anni Cinquanta, il viaggio in Russia e lormai totale adesione di Mara Rosa
al comunismo la allontaneranno dalle linea ideologica di Sur, la rivista fondata
dallamica e della quale era stata membro integrante del Consiglio direttivo.
Limpegno delle due intellettuali a favore dei diritti delle donne si concretizza,
nella seconda met degli anni Trenta, nella fondazione, con Susana Largua, della
Unin Argentina de Mujeres, istituita principalmente per impedire lapprovazione
in Parlamento della riforma del Codice Civile. La clausola contestata riguardava il
fatto che la donna sposata non avrebbe potuto esercitare alcun tipo di professione
senza lautorizzazione del marito. La campagna contro la riforma ha successo e la
Unin Argentina de Mujeres continua la sua attivit, raccogliendo al suo interno
donne borghesi con simpatie per il comunismo o per il socialismo.
Al fanco di Victoria Ocampo, Mara Rosa Oliver si schiera anche contro
liniziativa del fascismo italiano di reclutare in Argentina volontari per la guerra
dEtiopia, contro la guerra civile spagnola e a favore degli Stati Uniti in occasione
della Seconda guerra mondiale. Al confitto e alladesione al panamericanismo
Sur, nel dicembre 1941, dedica un intero numero in cui Mara Rosa critica la
44 Ivi, pp. 318-319.
45 Ivi, pp. 346-347.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 368 03/05/2013 11:11:23
369
2. Mara Rosa Oliver: unargentina liberal-oligarchico-comunista
neutralit argentina nel confitto: Se invece della voce dei governi si fosse ascolta-
ta la voce dei popoli, tutte le risposte avrebbero avuto la stessa intensit, la stessa
fermezza
46
; vale a dire: la politica risponde alle esigenze di un gruppo e non
rappresenta la volont del popolo.
Infne, come tutti i collaboratori di Sur, anche Mara Rosa si oppone a Pern
fn dalla sua ascesa, vivendone la vittoria come una sconftta personale ma con
grande riguardo per il popolo che lo appoggia
47
. Le risulta, invece, incomprensi-
bile ladesione del clero al peronismo, pur intendendo che gli interessi economici
e sociali sono pi forti dei principi evangelici o di qualsiasi altro principio volto
al bene comune. Non pu far altro, quindi, che ribadire la propria posizione evo-
cando le frasi che ascoltava dal padre: Ho approfttato poi di questo privilegio
[lappartenenza alla classe oligarchica] per lottare contro i privilegi
48
.
46 Oliver, M.R. El da marcado en los anales de la infamia, in Sur, 87, dic. 1941, p. 20.
47 Sullantiperonismo di Oliver cfr. Senkman, L.; Sosnowski, S. Fascismo y nazismo en las letras
argentinas, Buenos Aires, Lumiere, 2009, in particolare pp. 96-101.
48 Oliver, M.R. Mi fe es el hombre cit., p. 334.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 369 03/05/2013 11:11:23
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 370 03/05/2013 11:11:23
3. Loyola Guzmn Lara, i diritti umani
e la politica in Bolivia
Gabriella Citroni
Loyola Guzmn Lara nacque nel 1943 in una localit in provincia di La Paz e
crebbe a Oruro, vicino al confne con il Cile. Oruro una citt caratterizzata dalla
presenza di miniere di stagno, da una situazione di discriminazione e di sfrutta-
mento della manodopera, nonch da una fervente attivit sindacale e politica.
Fu cos che, a soli dodici anni, Loyola e una decina di altri adolescenti aderirono
alla Giovent Comunista Boliviana (Juventud Comunista Boliviana JCB). In
seguito Loyola studi presso la Facolt di Lettere e Filosofa dellUniversit Ma-
yor de San Andrs, e giunse a far parte del Comitato esecutivo della JCB (unica
donna), nel quale rimase sino al febbraio 1967, quando fu espulsa
49
per via del
suo avvicinamento al gruppo di guerriglia organizzato da Ernesto Che Guevara
e denominato Esercito di Liberazione Nazionale (Ejercito de Liberacin Nacional
ELN), che aveva iniziato le sue operazioni nel novembre 1966
50
. La militanza
nella JCB si svolse nel contesto della dittatura instaurata il 4 novembre 1964 con
un golpe da Ren Barrientos Ortuo e dal generale Alfredo Ovando Canda, che
rimasero al potere sino al 1970. Loyola fu una delle poche donne a partecipare
attivamente allesperienza guerrigliera e, per quanto le sue mansioni si svolgessero
eminentemente nella capitale e si concentrassero nella gestione delle risorse eco-
49 Nel 1966 il segretario generale del Partito Comunista Boliviano, Mario Monje Molina, incontr
Guevara per valutare lopportunit di unalleanza formale tra partito e guerriglia. Essendo state rifu-
tate le condizioni da lui proposte, tolse ogni appoggio a Guevara ed espulse coloro che si rifutarono
di seguire la linea uf ciale del partito.
50 Guevara fu catturato l8 ottobre 1967 nella localit conosciuta come La Higuera e venne ucciso il
giorno successivo.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 371 03/05/2013 11:11:23
372
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
nomiche, ella seppe ritagliarsi un ruolo di primo piano, tanto da essere citata nel
diario tenuto da Guevara
51
.
Il 26 gennaio 1967, quando aveva ventiquattro anni, Loyola incontr per la
prima e unica volta Guevara che, dopo aver conversato con lei, le consegn docu-
menti contenenti istruzioni per i quadri urbani e la conferm come responsabile
della gestione delle risorse economiche. Dopo il colloquio, Guevara riport le
seguenti rifessioni nel suo diario: Loyola mi ha fatto unottima impressione.
molto giovane e dolce, ma si vede che assai risoluta. Sta per essere espulsa dalla
Giovent, ma cercano di ottenere le sue dimissioni
52
.
Lincontro con Guevara fu una sorpresa per la stessa Loyola, dal momento che
circolavano voci secondo le quali il comandante guerrigliero sarebbe stato cattu-
rato o, addirittura, fosse gi morto. Per immortalare levento furono scattate delle
fotografe che ritraevano Loyola a fanco di Guevara e altri membri dellELN. Le
fotografe vennero sequestrate nel corso di unispezione di uno dei depositi allestiti
dai guerriglieri vicino al fume ancahuaz. A causa di ci, allinizio del settembre
1967 Loyola fu arrestata
53
. Quando la notizia divenne di pubblico dominio susci-
t grande scalpore e indignazione, tanto che il sindacato degli insegnanti convoc
uno sciopero generale di protesta
54
.
Durante la prigionia, Loyola fu ripetutamente interrogata con il fne di otte-
nere informazioni sui membri della guerriglia, sui loro piani e sui loro rifugi. Oltre
alle vessazioni e alla pressione psicologica, Loyola fu percossa e torturata: pur di
non confessare, tent due volte il suicidio, riuscendo a salvarsi dopo essersi lancia-
ta da una fnestra del secondo piano del Ministero degli Interni, dove era reclusa,
in quanto i rami di un albero attutirono la caduta
55
. Il 22 luglio 1970 Loyola fu
51 Soria, C. El Che en Bolivia, documentos y testimonios, La Paz, La Razn, 2005. Lautore dello
scritto, membro del Comitato esecutivo della JCB, considera che negli anni Sessanta il discorso
sulleguaglianza di genere era semplicemente assente: seppure vi fossero alcuni tentativi in tal senso,
non vi era nessuna proposta strutturata in merito e meno ancora si poteva parlare di pratiche po-
litiche efettivamente eque. La politica era e nei fatti continua ad esserlo anche quarantanni pi
tardi fondamentalmente una questione da uomini, alla quale al massimo riescono a partecipare
solo alcune donne straordinarie. Nel diario di Guevara vengono menzionate solo tre donne oltre a
Loyola: Tamara Hayde Bunke Bider, Francisca Bernal e Norberta Pinto de Aguilar.
52 Guevara, E. Diario del Che in Bolivia, Milano, Mondadori, 2007, p. 43.
53 Il 15 settembre 1967 Guevara annotava: la radio comunica larresto di Loyola; devono averla
incastrata le fotografe. Guevara, E. Diario del Che cit., p. 193.
54 Il 17 settembre 1967 Guevara scriveva la radio da notizia solo [] di una protesta per larresto
di Loyola Guzmn e due giorni dopo aggiungeva: la radio ha insistito sul caso Loyola e sugli inse-
gnanti che sono in pieno sciopero; gli alunni della scuola dove lavorava Higueras, uno degli arrestati,
hanno proclamato lo sciopero della fame, e gli operai dei pozzi di petrolio stanno per scioperare per
la creazione dellimpresa statale del petrolio (Guevara, E. Diario del Che cit., pp. 194, 196).
55 Commentava Guevara: adesso la radio trasmette la notizia di due tentativi di suicidio di Loyola
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 372 03/05/2013 11:11:23
373
3. Loyola Guzmn Lara, i diritti umani e la politica in Bolivia
liberata insieme ad altri nove prigionieri in cambio di due ostaggi tedeschi che era-
no stati catturati dai guerriglieri. Dopo la liberazione, Loyola lasci per un breve
periodo il Paese e si rec a Cuba, dove ottenne asilo politico. Alla fne del 1970,
rientr clandestinamente in Bolivia e riprese la militanza nellELN, ritenendo che
la lotta armata fosse lunica via percorribile per sovvertire liniquit sociale, far
cadere la giunta militare al potere e instaurare un governo democratico.
Loyola partecip attivamente alle operazioni della guerriglia, opponendosi alla
sanguinaria dittatura di Hugo Banzer Surez (asceso al potere con un golpe nel 1971
e destituito nel 1978)
56
. Lattivismo non imped a Loyola di costruire una famiglia,
seppure in condizioni di estrema dif colt. Nel 1972 diede alla luce il primo fglio
che chiam Ernesto. Lanno successivo, allottavo mese di gravidanza, in occasione
di uno scontro con la polizia fu arrestata a La Paz insieme a suo marito Flix Melgar
Antelo, che in seguito fu fatto sparire. Mentre era in carcere, Loyola partor il pro-
prio secondogenito, Julio. Quando fu liberata lasci nuovamente il Paese per ragioni
di sicurezza e si rec in Svezia, dove ottenne asilo politico e visse per circa due anni
prima di rientrare defnitivamente in Bolivia e riprendere lattivit politica. Segnata
dalla sparizione forzata del marito, Loyola fu una delle fondatrici dellAsociacin
de familiares de detenidos, desaparecidos y mrtires por la liberacin nacional (ASO-
FAMD), della quale fu anche presidentessa. Lattivit di ASOFAMD ha permesso
di denunciare e documentare
57
le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dai
regimi dittatoriali in Bolivia, nonch di ottenere giustizia in alcuni di questi casi sia a
livello nazionale sia a livello internazionale
58
e di lanciare varie iniziative legislative
59
.
Loyola, da sempre attenta alla situazione di altri Paesi latinoamericani e consa-
pevole dellesistenza di alleanze tra i dittatori di questi Stati, fu una delle principali
sostenitrici dellidea di creare una Federazione Latinoamericana di associazioni
per timore di rappresaglie guerrigliere, e dellarresto di alcuni maestri che, se non coinvolti, sono al-
meno nostri simpatizzanti. Sembra che a Loyola abbiano trovato molte cose in casa, ma non sarebbe
strano se tutto dipendesse dalle foto ritrovate nella buca. Guevara, E. Diario del Che cit., p. 195.
56 Il generale Juan Pereda rimase al potere dal 1978 sino al 1979, quando fu sostituito mediante
un golpe dal colonnello Alberto Natush Bush. Nel 1980 sal al potere il generale Luis Garca Meza
Tejada. Nei quattordici mesi successivi si alternarono tre governi militari, nessuno dei quali riusc
a garantire stabilit al paese, sino al 10 ottobre 1982, quando il parlamento proclam presidente
Hernan Siles Suazo.
57 ASOFAMD, Informe sobre desapariciones forzadas en Bolivia, La Paz, Garza Azul, 2008.
58 Grazie al sostegno di ASOFAMD due casi di sparizione forzata (Truijllo Oroza e Ticona Estrada) veri-
fcatisi rispettivamente nel 1971 e nel 1980 sono arrivati sino alla Corte Interamericana dei diritti umani
e sono stati aperti vari processi di fronte alle autorit giudiziarie boliviane. In particolare, contro Banzer
(deceduto nel 2002), contro Garca Meza e Luis Arce Gmez (condannati a trentanni di reclusione).
59 Grazie ad uniniziativa di ASOFAMD nel 2006 la sparizione forzata di persone stata inserita
come fgura autonoma di reato nel codice penale boliviano (art. 292-bis).
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 373 03/05/2013 11:11:23
374
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
di famigliari di desaparecidos. Un primo tentativo risale allottobre 1979, quando
famigliari di desaparecidos provenienti da Argentina, Cile e Uruguay si riunirono
con i membri dellassociazione boliviana e riuscirono a incontrare i diplomatici
che si trovavano a La Paz per lassemblea generale dellOrganizzazione degli Stati
Americani (OEA). Nel momento in cui si stava cercando di formalizzare la crea-
zione della Federazione, il colonnello Natush Bush prese il potere con lennesimo
golpe: sia i diplomatici dellOEA sia i rappresentanti stranieri delle associazioni
di famigliari di desaparecidos vennero fatti evacuare. Nel gennaio 1981 vi fu un
secondo tentativo a San Jos, in Costa Rica e, fnalmente, fu creata la Federazione
latinoamericana di associazioni di famigliari di desaparecidos (FEDEFAM) che,
da allora, svolge un ruolo di primo piano nella difesa dei diritti umani nel conti-
nente. Loyola una dei membri fondatori di FEDEFAM e ha partecipato a tutte
le attivit della federazione, ricoprendo svariate cariche nel comitato esecutivo
60
.
Inoltre, nel 1982, su iniziativa di ASOFAMD, in Bolivia fu creata una tra
le prime Commissioni di Verit a livello mondiale (Commissione Nazionale per
lindagine dei casi di sparizione forzata)
61
: Loyola, in qualit di rappresentante
della societ civile e, in particolare, dei famigliari di desaparecidos, fu la segretaria
esecutiva della Commissione, che riusc a documentare centocinquantacinque casi
di sparizioni forzate. In quattordici casi vennero rinvenuti, riesumati, identifcati e
restituiti ai famigliari i resti delle vittime. La Commissione non riusc per a por-
tare a termine il proprio mandato e a pubblicare una relazione fnale, in quanto a
met del 1984 fu sciolta per mancanza di copertura fnanziaria
62
.
Anche dopo il superamento del sanguinoso periodo delle dittature e i pur
notevoli successi conseguiti sul piano della giustizia, Loyola sempre stata co-
sciente del fatto che in Bolivia permanessero liniquit sociale e le discriminazioni
(soprattutto nei confronti di donne e popolazioni indigene) contro le quali si
coraggiosamente battuta per tutta la vita. Per questo, dopo lelezione di Evo Mo-
rales come presidente (dicembre 2005) e la decisione di creare unassemblea costi-
tuente, Loyola decise di candidarsi nelle fla del Movimiento al Socialismo (MAS)
per prendere parte a questa iniziativa.
60 Tra le iniziative lanciate da FEDEFAM si ricorda ladozione di una Convenzione internazionale per
la protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate (adottata dallAssemblea Generale delle Na-
zioni Unite il 20 dicembre 2006 mediante risoluzione n. 61/177). Loyola ha rappresentato FEDEFAM
durante il negoziato per la redazione di tale trattato presso le Nazioni Unite (Ginevra, 2002-2005).
61 La Commissione, costituita da otto membri, fu stabilita da decreto supremo n. 19241 del 28 ottobre
1982 con il mandato di far luce sui casi di sparizione forzata di persone avvenuti tra il 1964 e il 1982.
62 Loyola ha cercato di ottenere gli archivi contenenti tutti i documenti e le testimonianze raccolte
dalla Commissione al fne di redigere e rendere pubblica una relazione. Ad oggi non si conosce con
precisione la sorte toccata a tali archivi.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 374 03/05/2013 11:11:23
375
3. Loyola Guzmn Lara, i diritti umani e la politica in Bolivia
Eletta, Loyola stata una delle ottantotto donne
63
membri dellassemblea co-
stituente (presieduta da una donna)
64
: una presenza numerica cos signifcativa nel
contesto di unesperienza legislativa di fondamentale importanza per la Bolivia una
novit assoluta in un paese-continente
65
nel quale la partecipazione delle donne
alla vita politica , seppur in graduale aumento, ancora sostanzialmente limitata
66
.
Loyola ha presenziato a tutte le sessioni della costituente, dichiarandosi per
contraria al risultato fnale e chiedendo pubblicamente ai suoi sostenitori di votare
contro il progetto di costituzione
67
. Questa presa di posizione stata il frutto di
una scelta soferta e a lungo soppesata ed costata a Loyola pesanti critiche e le-
spulsione da ASOFAMD.
Nella sua esistenza, Loyola si costantemente messa in discussione, senza ri-
sparmiarsi, anche quando questo ha esposto lei o i suoi cari ad attacchi fsici e ver-
bali, ad accuse infamanti e a isolamento o esilio. Nonostante i vari ostacoli, Loyola
non si arresa e ha posto sopra tutto la coerenza e la difesa degli ideali per cui ha
lottato da quando aveva dodici anni. Loyola stata una delle poche donne ad aver
partecipato, da protagonista, alla storia boliviana degli ultimi cinquanta anni. Si
tratta di una testimone di eccezione e di un esempio vivente della forza delle don-
ne boliviane, mai disposte ad accettare passivamente la discriminazione, e pronte a
lottare con ogni mezzo pur di costruire un mondo diferente. Spesso Loyola stata
una donna sola in contesti di potere e si adoperata concretamente per permettere
ad altre donne di accedere agli spazi loro negati, riscuotendo innegabili successi.
Nello spiegare le ragioni della sua inaspettata scelta di votare contro ladozio-
ne della nuova costituzione boliviana, Loyola concluse la sua lettera aperta dichia-
63 Romero, R.; Oviedo, M.R.; Lanza, M. et al. Discursos polticos de mujeres en el proceso constituyente,
La Paz, Colectivo Cabildeo, 2009; Uriona Crespo, P. Los caminos de la paridad: mujeres, participacin
y representacin en el proceso Post Constituyente, La Paz, Coordinadora de la Mujer, 2009. Il totale dei
membri della costituente duecentocinquantacinque.
64 Silvia Lazarte.
65 Mujeres y poltica: el impacto de las cuotas de gnero en Amrica Latina, Stoccolma, Institute for De-
mocracy and Electoral Assistance, 2009; Llanos, B.; Sample, K. From Words to Action: Best Practices
for Womens Participation in Latin American Political Parties, Institute for Democracy and Electoral
Assistance, Stoccolma, 2009; Fernndez Poncela, A.M. Las mujeres en la poltica latinoamericana:
nuevos liderazgos, viejos obstculos, in Nueva Sociedad, n. 218, 2008, pp. 58-71; e Fernndez Pon-
cela, A.M. La sociedad, la poltica y las mujeres, Citt del Messico, Inmujeres/UAM, 2003.
66 La Costituzione boliviana tra le poche al mondo a garantire il diritto di ogni essere umano a
non essere vittima di sparizione forzata (art. 15, par. IV): questa disposizione in gran parte frutto
del lavoro di Loyola. Molteplici sono gli articoli della Costituzione riguardanti i diritti delle donne
e, in generale, nella redazione del testo, le indicazioni riguardanti le donne hanno sempre la priorit
(nosotros, mujeres y hombres), mentre storicamente sempre che ci fosse una menzione alle donne
veniva utilizzata la formula inversa.
67 Guzmn, L. Carta informe al pueblo boliviano y a la circunscripcin No. 8, La Paz, 16 gennaio 2009.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 375 03/05/2013 11:11:23
376
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
rando di mantenere la propria posizione rivoluzionaria e citando Luis Espinal: ci
sono volte in cui tacere equivale a mentire.
Sono trascorsi cinquantatre anni e Loyola rimane come la vide Ernesto Gue-
vara nella selva boliviana: dolce, ma evidentemente risoluta.
Loyola stata candidata alla vicepresidenza della repubblica nelle elezioni del
dicembre 2009.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 376 03/05/2013 11:11:24
4. La partecipazione femminile
nelle barriadas di Lima
Stefania Pastorelli
Lintento di questo paper quello di illustrare sinteticamente il signifcato della
partecipazione femminile nelle barriadas di Lima, focalizzando lattenzione sugli
aspetti pi soggettivi di questa esperienza.
1. La partecipazione femminile
Nel processo di formazione delle barriadas, il ruolo svolto dalle donne deter-
minante. Infatti, la decisione di partecipare a unoccupazione con lobiettivo di
riuscire ad avere in un futuro una casa di propriet prevalentemente femminile.
Abitare in una barriada, una capanna di stuoia intrecciata, impone un dialogo
permanente, al limite della coabitazione, con i vicini di lotto. In aree prive di ogni
infrastruttura, le attivit connesse alla sopravvivenza quotidiana diventano estre-
mamente dif coltose. La collaborazione diventa dunque essenziale. Collaborazio-
ne, che nella fase iniziale, per lo pi femminile, in quanto seguendo lo schema
tradizionale di divisione dei compiti, gli uomini durante il giorno si recano al
lavoro.
Sebbene le attivit svolte dalle donne non restino circoscritte allambito do-
mestico, in quanto collaborano attivamente con il resto della popolazione alla
realizzazione dei lavori comuni fnalizzati allurbanizzazione del quartiere, il ruolo
svolto allinterno delle associazioni di rappresentanza del quartiere (dette anche
organizzazioni di vecinos) rimane nei primi tempi marginale e subordinato.
A partire dagli anni Sessanta, la vita associativa delle barriadas di Lima si di-
versifca; sorgono nuove associazioni fra le quali acquistano crescente importanza
quelle femminili.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 377 03/05/2013 11:11:24
378
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
Le prime associazioni femminili nelle barriadas di Lima nascono sotto lim-
pulso di agenti esterni, in particolare politici e religiosi. Nella sfera politica, preoc-
cuparsi per le donne delle barriadas solitamente un compito attribuito alla mo-
glie del presidente della repubblica. Nello stesso periodo, coincidente con il primo
grande fusso migratorio verso la capitale, si difonde, per mezzo della Caritas, la
presenza della chiesa cattolica che promuove la nascita di associazioni, denominate
club de madres, dove le donne si riuniscono per tessere, cucinare, cucire e svolgere
altre attivit legate allambito domestico. La partecipazione alle iniziative promos-
se dai club de madres un requisito per ricevere le donazioni, essenzialmente viveri
e medicine. Alla chiesa cattolica fanno poi seguito altre istituzioni religiose, in
particolare la chiesa avventista, ed enti assistenziali nazionali e stranieri
68
.
Queste prime forme associative, che agiscono appoggiandosi alle reti di aiuto
reciproco gi presenti nelle barriadas, sono caratterizzate dalla loro natura assisten-
ziale, subordinata rispetto allente benefattore. I rapporti fra lassociazione e gli
enti di benefcenza sono curati dalle dirigenti presenti in ciascuna di esse.
La severissima crisi economica che, a partire dal 1973, colpisce il Paese impo-
verendo drasticamente i settori popolari genera un mutamento nelle istanze della
popolazione, fno ad allora concentrate prevalentemente sul miglioramento delle
abitazioni e del quartiere, che, dora in avanti, saranno riferite allalimentazione e
alla sopravvivenza quotidiana.
In questa congiuntura le associazioni femminili, sorte con lobiettivo di pro-
muovere iniziative a benefcio della famiglia, assumono una crescente importanza.
Mentre il senso della partecipazione si trasforma in seguito alle riforme av-
viate dal governo di Velasco Alvarado (1968-1975), le associazioni femminili si
rinnovano, poich cambiano le funzioni svolte, che dalla fne degli anni Settanta
in poi sono prevalentemente orientate alla preparazione collettiva dei pasti.
Sul fnire degli anni Settanta, partendo dalle associazioni esistenti, nascono
a Lima i comedores populares autogestiti che hanno la fnalit di ottenere migliori
condizioni nelle donazioni e di cucinare collettivamente gli alimenti ricevuti
69
. I
vantaggi sono innegabili, i comedores populares quindi si difondono ben presto in
tutte le barriadas di Lima
70
.
Da questo momento in poi, i governi che si succedono individuano in queste
nuove forme associative un altro canale di comunicazione prettamente clientela-
re con i settori popolari; cos, anche sovrapponendoli gli uni agli altri, a partire
68 Alfredo, R.; Gustavo, R.; Eileen, W. De invasores a invadidos, in Boletin Oese, n. 1, 1974, pp.
1-59.
69 Blondet, C.; Montero, C. Hoy men popular. Comedores en Lima, Lima, IEP UNICEF, 1995.
70 Sara-Lafosse, V. Los comedores comunales. La mujer frente a la crisis, Lima, SUMBI, 1984.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 378 03/05/2013 11:11:24
379
4. La partecipazione femminile nelle barriadas di Lima
dagli anni Ottanta, i partiti al governo promuovono la creazione di comedores
fornendo infrastrutture e viveri allo scopo di ampliare la propria infuenza politica
in questi insediamenti.
In questo stesso periodo, sulla scorta dellentusiasmo generato dalla vittoria
municipale di Izquierda Unida nel 1983, si difonde nelle barriadas di Lima la
presenza di organizzazioni non governative femministe con un orientamento di
sinistra. Tali associazioni, appoggiandosi alla rete organizzativa gi esistente, pro-
muovono una serie di corsi di formazione in svariati ambiti e mettono in contatto
associazioni femminili di natura e realt diverse.
quindi un periodo di grande importanza per le associazioni femminili, non
solo per le attivit che svolgono, ma per il signifcato simbolico che rivestono, sia
per la societ, sia per le partecipanti. Nonostante le aspettative suscitate e il dina-
mismo dimostrato dalle associazioni femminili, allepoca certamente le pi attive
dellintero Paese, i drastici cambiamenti politico-sociali che si verifcano a partire
dagli anni novanta le indeboliscono considerevolmente al pari di tutte le orga-
nizzazioni popolari. Il persistere della crisi economica, la tendenza del governo di
Fujimori (1990-2000) a disconoscere le associazioni esistenti e infne lintensif-
carsi nella capitale peruviana delle attivit del movimento Sendero Luminoso, che
si propone di distruggere ogni forma associativa, in particolare quelle femminili,
ritenute un palliativo per la povert che riduce il potenziale rivoluzionario del
popolo, ridimensionano notevolmente la partecipazione popolare.
2. Lesperienza soggettiva: creando conciencia
Creando conciencia unespressione che pi volte ricorre nelle interviste raccolte
e che ben sintetizza il signifcato soggettivo della partecipazione femminile. Le
testimonianze di cui dispongo, preciso, sono di persone che in qualche momento
della propria vita hanno svolto un ruolo dirigenziale allinterno di unassociazione
di rappresentanza della propria barriada
71
. Creando conciencia ha quindi un du-
plice valore. Questespressione infatti riferita al percorso individuale presa di
coscienza e al processo che innesca di conseguenza coscientizar.
Il seguente passaggio di una intervista raccolta esemplifcativo
72
:
71 Le interviste sono state raccolte per lelaborazione della tesi di dottorato in Storia Istituzioni,
Relazioni Internazionali dei Paesi Extraeuropei presso lUniversit degli Studi di Pisa dal titolo
Partecipazione e strategie organizzative. Dal riformismo militare al regime di Fujimori. Lima 1968-
1992. Due casi a confronto.
72 Intervista a Isabel (pseudonimo) realizzata nel quartiere di El Agustino nel 1998. Il brano riportato
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 379 03/05/2013 11:11:24
380
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
stato molto dif cile. Nel 1983 ho iniziato a fare le dirigente. stato molto
dif cile perch gli uomini non ci davano lopportunit di partecipare al comitato
direttivo dellassociazione (COPRODE). Ti accettavano ma non ti considerava-
no al loro livello. Ci dicevano: dite quello che dovete dire e poi ritiratevi. Non
potete partecipare, fate venire vostro marito. E io rispondevo: non ho un marito.
Sono il capofamiglia. Cosa volete? Io voglio ascoltare, anche noi abbiamo propo-
ste inerenti i temi trattati: la salute ambientale, le strade. Vogliamo ascoltare. Loro
ridevano. Andate in cucina ci dicevano. Le mie vicine mi dicevano: andiamo. E
io rispondevo: no, restiamo qui. Per sfnimento ci dovranno accettare. Alcune si
addormentavano. E gli uomini dicevano: occupate solo le sedie, andate a casa.
Io dicevo rispondiamo con ironia, non arrabbiatevi. E cos abbiamo fatto e ci
hanno accettato.
Crescita individuale e mutamenti che la partecipazione femminile genera nel
contesto sociale sono quindi due facce della stessa medaglia. Questa citazione, a
mio avviso, descrive una situazione che ci rimanda alle interpretazioni pi recenti
di empowerment inteso come un processo bidirezionale di raforzamento e svilup-
po del singolo a benefcio della collettivit
73
. Acquisire consapevolezza delle pro-
prie capacit e intervenire direttamente modifcando, seppur non trasformando
radicalmente, il luogo in cui si abita sono gli elementi che danno valore e senso
alla partecipazione femminile nelle barriadas di Lima.
Per questa ragione anche da un punto di vista soggettivo la partecipazione,
soprattutto nelle associazioni femminili, acquisisce signifcati diversi: per le diri-
genti costituisce una sorta di ascesa sociale, per le altre diventa fonte di sostegno
e di protezione.
In entrambi i casi la partecipazione introduce cambiamenti nella vita delle
socie. La donna di fatto viene sollevata in parte da compiti che tradizionalmente
le sono stati assegnati ed ha pi tempo da dedicare ad attivit che esulano dallam-
bito domestico. Ancora pi rilevanti sono i cambiamenti che avvengono nelle-
ducazione delle donne. Si visto come il comedor pu diventare anche un luogo
di incontro oltrech di formazione su molteplici tematiche che, essendo stretta-
mente connesse alla quotidianit, modifcano il modo di rapportarsi con gli altri.
Inoltre, frequentare altre donne che si trovano nelle medesime condizioni di vita,
stringere con esse legami di amicizia e condividere esperienze analoghe, garantisce
una sintesi tradotta dellintervista originale. Lintervista depositata presso laudio archivio delle
migrazioni AREIA con sede c/o DISMEC via Balbi 6 Genova areia.associazione@gmail.com.
73 Converso, D.; Imke, H. Il potere in gioco nellempowerment, in Animazione Sociale, 2009,
giugno/luglio, pp. 62-69.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 380 03/05/2013 11:11:24
381
4. La partecipazione femminile nelle barriadas di Lima
alle partecipanti una rete sociale a cui appoggiarsi nei momenti di crisi. Pertanto,
la frequenza a un comedor, oltre a elevare le conoscenze delle donne partecipanti,
raforzandone quindi lautostima, assicura loro una maggiore indipendenza e au-
tonomia, anche afettiva. Vanno poi considerati anche gli aspetti legati alla sfera
pubblica; partecipare a un comedor, soprattutto come dirigente, signifca assumere
un ruolo, pi o meno importante a seconda di ogni realt, ma comunque signif-
cativo, allinterno della propria comunit.
Questo riconoscimento e lesperienza maturata a loro volta aprono nuove
strade. A poco a poco succede che, nellambito delle organizzazioni dei vecinos,
le donne ricoprono incarichi tradizionalmente maschili. Altre volte le conoscenze
acquisite inducono le donne ad avvicinarsi a partiti politici e a candidarsi alle
elezioni locali.
Occorre precisare che unanalisi compiuta della partecipazione femminile do-
vrebbe contemplare elementi non menzionati nel presente paper; mi riferisco alle
politiche governative di volta in volta adottate, alla rappresentazione che della
partecipazione femminile stata fatta e alle dinamiche di funzionamento delle
associazioni delle donne. Alcuni spunti di rifessione sono comunque possibili.
La partecipazione femminile, a seconda del periodo storico o della fase di
sviluppo di ciascuna barriada, si concretizza in diversi modi e, sebbene il pi delle
volte sia strettamente legata al soddisfacimento di necessit essenziali, acquisisce
un valore intrinseco. Si comunque lontani dal poter afermare che i nuovi ruoli
svolti dalle donne possano generare dei cambiamenti di rilievo: il modello di fami-
glia prevalente rimane quello tradizionale e gli incarichi dirigenziali delle associa-
zioni non femminili sono per lo pi predominio maschile. Anche lafermazione
di leadership la cui infuenza fuoriesce dallambito dellinsediamento di residenza
un evento inconsueto. Poich la vita associativa nelle barriadas di Lima, nellarco
di tempo preso in esame, stata ridimensionata a causa della violenza politica e
degli indirizzi governativi afermatisi, il signifcato della partecipazione assume
ancora di pi un valenza individuale. Le singole esperienze sono percepite come
parte di un processo di crescita individuale, di afermazione di s che possono
determinare ricadute positive allinterno della comunit in cui si agisce.
Bibliograa
Barrig, M.(a cura di) De vecinas a ciudadanas. La Mujer en el desarrollo urbano,
Lima, SUMBI, 1988.
Blondet, C. Nuevas formas de hacer poltica: las amas de casa populares, in
Allpanchis Phuturinqa, XXI, n. 25, 1985, pp. 195-298.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 381 03/05/2013 11:11:24
382
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
Blondet, C. La mujer y el poder. Una historia de Villa El Salvador, Lima, IEP, 1991.
Blondet, C. Las mujeres y la poltica en la dcada de Fujimori, Lima, IEP, 1999.
Blondet, C.; Montero, C. La situacin de la mujer en el Per: 1980-1994, Lima,
IEP, 1994.
Blondet, C.; Montero, C. Hoy men popular. Comedores en Lima, Lima, IEP
UNICEF, 1995.
Converso, D.; Imke, H. Il potere in gioco nellempowerment, in Animazione
Sociale, 2009, giugno/luglio, pp. 62-69
Crdova Cayo, P. Liderazgo femenino en Lima, Lima, Fundacin Friedrich Ebert,
1996.
Crdova Cayo, P.; Gorriti, C.L. Apuntes para una interpretacin del movimiento
di mujeres: los comedores comunales y los comits del vaso de leche en Lima, Lima,
SUMBI, 1989.
Degregori, C.I.; Blondet, C.; Lynch, N. Conquistadores de un nuevo mundo. De
invasores a ciudadanos en San Martn de Porres, Lima, IEP, 1986.
Dejo Soto, F. El shock agosto 90. Cuando los ajustes econmicos causan desajustes
sociales, Lima, Radda Barnen-Metric, 1991.
Delpino. N. Las organizaciones femennas por la alimentacin: un men
sazonado, in Psara, L. (a cura di) La otra cara de la luna. Nuevos actores sociales
en el Per, Buenos Aires, Manantial S.R.L.-CLADE, 1991, pp. 29-72.
Driant, J.C. Las barriadas de Lima. Historia e interpretacin, Lima, IFEA-DESCO,
1991.
Gonzales de Olarte, E. La economia regional de Lima. Crecimiento, urbanizacin y
clases populares, Lima, IEP, 1992.
Guzmn, V. Las organizaciones de mujeres populares: tres perspectivas de anlisis,
Lima, Flora Tristn, (documento de trabajo n. 1), 1990.
Matos, M.J. Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Per en la
dcada de 1980, Lima, IEP, 1985.
Montoya, D.; Reyna, C. Sendero: informe de Lima, in Quehacer, n. 76, 1992,
pp. 34-42.
Psara, L. Nuevos actores: devaluacin de la moneda corriente in Psara, L. (a
cura di) La otra cara de la luna. Nuevos actores sociales en el Per, Buenos Aires,
Manantial Srl-CLADE, 1991, pp. 6-29.
Pastorelli, S. Lottare per la casa. Le donne delle barriadas di Lima, Roma, Aracne
Editrice, 1996.
Riofrio, G. Producir la ciudad (popular) de los 90. Entre el mercado y el Estado,
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 382 03/05/2013 11:11:24
383
4. La partecipazione femminile nelle barriadas di Lima
Lima, DESCO, 1991.
Rodrigo, J.M. Le sentier de laudace. Les organisations populaires la conqute du
Prou, Parigi, LHarmattan, 1990.
Rodrguez, A.; Riofrio, G.; Welsh, E. De invasores a invadidos, in Boletin Oese,
n. 1, 1974, pp. 1-59.
Sara-Lafosse, V. Los comedores comunales. La mujer frente a la crisis, Lima, 1984.
Sara-Lafosse, V. Vecinos i pobladores en la crisis (1980-1984) in Balln, E.(cura
di) Movimientos sociales y crisis: el caso peruano, Lima, DESCO, 1986, pp. 67-
142.
Vargas, V. Te Womens Movement in Per. Streams, spaces and knots, in
European Review of Latin American and Caribbean Studies, n. 50, 1991, pp.
7-50.
Yanaylle, M.E. Mejor callarse.!!Y todas se callaron!!, in Mrgenes, IV, n. 7,
1991, pp. 221-237.
Yanaylle, M.E. Seora la admiro. Autoridad y sobrevivencia en las organizaciones
femeninas en un contexto de crisis in Portocarrero, G.(a cura di) Los nuevos
limeos. Sueos, fervores y caminos en el mundo popular, Lima, TAFOS-SUR,
1993, pp. 115-123
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 383 03/05/2013 11:11:24
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 384 03/05/2013 11:11:24
5. Percorsi di apprendimento allazione politica
in una comunit delle Ande Peruviane
Soa Venturoli
Il questo contributo presenteremo brevemente quali sono le dinamiche messe in
atto e i mezzi utilizzati dalle donne della comunit per acquisire un maggiore
peso nella sfera politica e decisionale e come questi si inseriscano e talvolta si
contrappongano alla realt socio-culturale del mondo rurale andino. Faremo ri-
ferimento al processo di decentralizzazione in atto in Per e ai cambiamenti che
questo apporta nella sfera socio-culturale, economica e politica delle zone rurali.
Mi sofermer su due casi di azione politica, uno spontaneo nato tra un gruppo
di donne delle comunit rurali, un altro mosso da una legge nazionale che risulta
centrale per il processo di decentralizzazione e la gestione dei fondi provenienti dal
canon minero
74
, la legge del Presupuesto Participativo. Questa legge dovrebbe essere
uno dei principali strumenti nelle mani della societ civile per raggiungere un
maggiore grado di partecipazione allazione politica, in modo particolare per quei
settori della societ, come quello femminile, che sono tradizionalmente esclusi da
questi ambiti decisionali.
necessario chiarire che quando parleremo di partecipazione politica non
ci riferiamo necessariamente a un coinvolgimento nellambito di un partito uf-
fcialmente riconosciuto, quanto pi a tutte quelle azioni o comportamenti che
mirano a infuenzare in maniera pi o meno diretta le decisioni delle autorit
politiche
75
. Un certo grado di partecipazione politica costituito gi dal prendere
74 Il canon la partecipazione di cui godono i governi locali e regionali sulle entrate e sulle rendite
ottenute dallo stato grazie alle tasse sullo sfruttamento delle risorse minerali. La quota del 50% della
tassa sul reddito che le compagnie minerarie pagano allo stato per sfruttare i giacimenti peruviani.
75 Pasquino, G. La democrazia esigente, Bologna, Mulino, 1997.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 385 03/05/2013 11:11:24
386
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
posizione su determinate tematiche che riguardano la societ in cui si vive che pu
tradursi in tentativi, diversifcati e non necessariamente legati a partiti, di prendere
parte al processo decisionale.
Se uno degli scopi principali della decentralizzazione la democratizzazione,
risulta fondamentale che il suo primo obbiettivo sia quello di integrare e inclu-
dere socialmente e politicamente i cittadini. Tuttavia quando la libert politica
si esercita in contesti sociali di disuguaglianza rischia di riprodurre quelle stesse
disuguaglianze. La valutazione del processo di democratizzazione attraverso la de-
centralizzazione, in atto nelle regioni peruviane, deve basarsi fondamentalmente
sullanalisi della pratica dei cittadini. Drydyk
76
parla di input side e output side:
da un lato laccesso agli strumenti democratici (input side), dallaltro lefetto delle
nostre azioni attraverso gli strumenti democratici, ossia quanto le nostre azioni
infuenzano i policy makers (output side). Per analizzare gli efetti e lef cacia degli
strumenti democratici, nel nostro caso per comprendere se gli strumenti di decen-
tramento possono essere strumenti di maggiore partecipazione politica, fonda-
mentale lanalisi del contesto socio-culturale attraverso un approccio etnografco
e antropologico.
Il mio sguardo alla decentralizzazione peruviana inizia nella sierra, nella re-
gione di Ancash, in particolare la provincia di Huari, e nelle comunit rurali ap-
partenenti al distretto di Huari. Huari la capitale della provincia che porta il suo
nome e comprende sedici distretti. Nella provincia, una zona quasi completamen-
te bilingue, tra il quechua regionale e lo spagnolo, vivono 62.000 persone in una
vasta gamma di altitudini che vanno dai 2150 metri ai 6.370 sul livello del mare.
Solo nel distretto di Huari, nella omonima provincia, ci sono circa 9.300 abitanti.
Huari ha ancora un tasso di mortalit infantile del 30%, un tasso di analfabetismo
del 19% nella zona urbana e del 38% nella zona rurale, oltre a un 70% di inciden-
za sulla povert totale
77
.
La Comunidad Campesina78
Nelle comuidades campesinas le risorse sono di propriet comunale e laccesso a
queste si determina in conformit a norme stabilite dallo statuto interno alla co-
munit.
76 Drydyk, J. When is Development More Democratic? in Journal of Human Development, vol.
6, n. 2, July 2005, pp. 247-267.
77 Instituto Nacional de Estatistica e Informatica (Inei) Censo nacional 2006, Lima, 2006.
78 Sulla defnizione e la storia giuridica della Comunidad Campesina in Per si veda, come ultimo
compendio, Diez, A. et al. (eds.) Que sabemos de las comunidades campesinas?, Lima, Centro
Peruano de Estudios Sociales, 2006.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 386 03/05/2013 11:11:24
387
5. Percorsi di apprendimento allazione politica in una comunit delle Ande Peruviane
Tutto ci che si relaziona alla terra sotto lamministrazione della Junta Direc-
tiva de la comunidad. La giunta un organo che si occupa, tra le varie funzioni, di
tutto quello che ha a che vedere con la terra: divisioni, gestione delle coltivazioni,
assegnazione di parcelle, defnizione dei confni, titolazione delle terre e loro di-
fesa in ambito giuridico. La giunta convoca lAssemblea Generale una riunio-
ne di tutti i membri attivi e autorit massima della comunit agricola quando
sia necessario decidere su attivit economiche e commerciali che coinvolgono le
propriet e le risorse di tutta la comunit. La vita quotidiana delle comunit si
sviluppa in base alla organizzazione delle attivit pubbliche, coordinate dalle auto-
rit locali, in uno schema di regole, obblighi e diritti che tutti i comuneros devono
rispettare nellambito di un calendario basato sul ciclo agricolo, sottolineato da
eventi rituali e feste collettive che contrassegnano il tempo a livello individuale e
comunale. Questi meccanismi sociali si producono in base a un concetto chiave
della cultura andina: la reciprocit
79
. La reciprocit implica uno scambio tra due
parti, non necessariamente allo stesso livello sociale e di potere, uno scambio che
si produce nel momento in cui si contrae un obbligo verso qualcuno che ci ha
reso oggetto di aiuto o di generosit. Lo status di uomo e di donna adulti, nelle
comunit, si raggiunge non con let ma solo al momento della creazione di un
nucleo familiare. Un uomo, cos come una donna, si considerano maturi e adulti,
e gli si conferiscono i pieni diritti e doveri che spettano a ogni comunero, solo dopo
che abbiano costruito una casa e abbiano formato un nucleo familiare. Luomo
e la donna sono considerati complementari, cos come i compiti che sono loro
assegnati, non solo a livello pratico nella funzionale divisione del lavoro, ma anche
a livello simbolico tra la parte produttiva maschile e la parte di cura femminile.
Lambito femminile nella comunit e la partecipazione politica che
viene dal basso
Lunione di un uomo e di una donna rappresenta la perfetta complementarit e
rappresentazione della visione dualista del mondo. La visione duale e comple-
mentare divide e defnisce chiaramente diversi ambiti per luomo e per la donna.
Queste nette divisioni di genere nei compiti quotidiani esprimono bene la ne-
cessit che una donna ha di avere un compagno per essere inclusa nella vita della
comunit. In questo modo, linfuenza sociale e politica delle donne limitata dal
fatto che la sua partecipazione avvenga solo attraverso luomo. Il fatto che una
donna si sposi implica delegare alla controparte maschile della coppia la sfera
79 Venturoli, S. Huarirunas, hombres grandes que dominaban a los cerros. Historias y cambios sociales
en Conchudos, Per, PUCP, Fondo Editorial, Lima, en prensa, 2010.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 387 03/05/2013 11:11:24
388
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
pubblica e decisionale. Il dualismo andino manifesta una gerarchia implicita che
nellalleanza matrimoniale attribuisce al maschile un grado di predominio, no-
nostante la rappresentazione dei generi come mondi paralleli
80
. possibile parlare
di complementariet per la divisione del lavoro, ma senza dimenticare che esiste
una gerarchia essenziale che prevede la subordinazione della donna
81
. Le cariche
politiche e amministrative della comunit sono, in teoria, aperte anche alle don-
ne ma, nelle comunit prese in esame, non mai successo che una donna fosse
eletta nella giunta direttiva o assumesse la carica di tenente governatore o agente
municipale.
Paradossalmente, la condizione di madre soltera, cos disprezzata ed esclusa in
ambito comunitario, sta risolvendosi, per alcune, in uno stimolo alla reazione e al
cambiamento. La necessit di trovare altre risorse e altri strumenti di sopravviven-
za, non avendo accesso alle risorse delle comunit perch non sposate, hanno reso
possibile un movimento di aggregazione tra alcune donne che si delinea come un
primo tentativo di partecipazione politica.
Questa forma di associazionismo prende le mosse dalla formazione che alcune
di queste donne ricevettero nellambito di un progetto sulla salute riproduttiva,
ReproSalud, che fu implementato da una Ong peruviana, Manuela Ramos, dedi-
cata alla promozione e alla difesa dei diritti della donna, nella provincia di Huari.
Questo progetto puntava alla formazione diretta di alcune promotrici molte
delle quali madres solteras individuate come principali agenti del cambiamento
nelle diferenti comunit. Queste promotrici ricevettero una formazione conti-
nua, precisi compiti e responsabilit che le diferenziarono dalle altre e le resero,
in parte, molto pi consapevoli delle loro possibilit di dialogo e di relazione
con le istituzioni e le autorit locali. In seguito alla chiusura del progetto alcune
promotrici si unirono, in maniera apartitica, in un gruppo che si propose come
interlocutore della municipalit provinciale durante e in seguito alle elezioni re-
gionali del 2006 per presentare alcuni progetti di capacitacin y empoderamiento
de las mujeres in alcune comunit della provincia di Huari. Si delinearono come
soggetto di dialogo per progetti fnanziati attraverso i fondi del canon minero. Per
lo pi si tratt di progetti mirati alla formazione femminile su alcune tematiche
principali come la violenza domestica e la partecipazione politica; cos come alla
immediata risoluzione di problematiche pratiche per le donne delle comunit:
come la creazione di asili infantili (Wawa Wasi) e di comedores populares
82
(mense
80 Ossio Acua, J.M. Parentesco, reciprocidad y jerarqua en los Andes, Lima, Pontifcia Universidad
Catlica del Per, Fondo Editorial, 1992.
81 Venturoli, S. Huarirunas, hombres grandes que dominaban a los cerros. Historias y cambios sociales
en Conchudos, Per, PUCP, Fondo Editorial, Lima, en prensa, 2010.
82 I Comedores Populares nacquero negli anni Sessanta e Settanta come strategia di sopravvivenza
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 388 03/05/2013 11:11:24
389
5. Percorsi di apprendimento allazione politica in una comunit delle Ande Peruviane
popolari). Inoltre, questa associazione transcomunale informale di donne, si pro-
pose come principale interlocutore dei progetti gi esistenti, in particolare quelli
che dialogano maggiormente con lambito femminile come quelli di appoggio alla
nutrizione, nazionali e regionali, come il Desayunos Andinos e il Vaso de Leche
83
.
La legge del Presupuesto Participativo: percorsi di partecipazione
politica dallalto
Queste donne, essendosi rese maggiormente visibili grazie allorganizzazione e
allimplementazione di progetti e avendo partecipato attivamente alle campagne
elettorali regionali del 2006 allo scopo di entrare nelle dinamiche della sparti-
zione del canon minero per fnanziare i loro progetti, hanno potuto acquisire
ruoli in ambito politico-amministrativo in alcuni governi municipali di altri paesi
della provincia. Questi incarichi istituzionali, anche se al di fuori della comunit
di origine, hanno conferito maggiore peso alla loro presa di coscienza politica
che esse hanno cercato di spendere anche allinterno della comunit, sia attra-
verso i canali di espressione politica tradizionali, come le assemblee generali, sia
attraverso nuove forme di partecipazione come le riunioni del Presupuesto Parti-
cipativo. Questa legge, infatti, nata come strumento politico e amministrativo,
attraverso il quale le autorit regionale e locali, cos come le organizzazioni della
popolazione, debitamente rappresentate, devono defnire in maniera consensuale
come e per che cosa si orienteranno le risorse, tenendo in conto gli obbiettivi del
Piano di Sviluppo Strategico e Istituzionale, che sono direttamente collegati con
il Piano di Sviluppo Concertato
84
. In base alle norme, le municipalit provinciali
e distrettuali dovrebbero incaricarsi di svolgere campagne informative e periodi
di formazione, aperti a tutta la societ civile, per spiegare il funzionamento della
legge del Presupuesto Participativo. Le campagne annuali di informazione e forma-
zione messe in atto fno ad oggi dalla Municipalit di Huari non sono altro che
una sorta di condizionamento e convincimento delle popolazioni della provincia
sulle decisioni gi prese nella municipalit. Quando la legittimit e lefettivit de-
nelle zone urbane popolate da migranti provenienti dalle campagne e dalla sierra. Furono una stra-
tegia femminile per difendersi e difendere le proprie famiglie dalla povert e dalla fame.
83 Il primo un progetto provinciale, implementato con i fondi del canon minero per fornire a tutti
i bambini in et scolare una prima colazione nutritiva. Il secondo un programma nazionale iniziato
nel 1983 che mira a migliorare lalimentazione dei bambini e dei neonati denutriti attraverso una
razione diaria di alimenti.
84 Ministerio de Economia e Finanza (Mef ) Direccion Nacional del Presupuesto Publico (Dnpp),
Portal del Presupuesto Prticipativo. Presupuesto Participativo, http://presupuesto-participativo.mef.
gob.pe/portal_pp/html/index.php.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 389 03/05/2013 11:11:24
390
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
gli spazi di partecipazione rimane in mano dei governi locali, e quindi si produce
un percorso dallalto verso il basso, una legge che nasce come arma per diminuire
il clientelismo delle elite politiche centralizzate e fomentare una partecipazione
pi ampia della cittadinanza nelle decisioni politiche, si trasforma in un ulteriore
strumento di potere nelle mani di chi gi lo possiede e di nuova centralizzazione
in ambito locale.
Le due esperienze evidenziano come la partecipazione e la presa di coscien-
za verso unazione politica partecipativa sia qualcosa che possibile maturare in
percorsi formativi, collettivi e individuali, che non necessariamente partono con
quello scopo ma che possono avere un risultato inaspettato. Come sia invece poco
utile e non apporti grandi cambiamenti al processo decisionale un percorso isti-
tuzionale e formalizzato che, anche se si presenta democratico e aperto a livello
normativo, essendo gestito dallalto viene modifcato e coordinato in base alle
necessit ed esigenze del singolo politico o del gruppo di partito al potere.
Esiste inoltre il rischio che le donne che hanno raggiunto un certo livello di
partecipazione e di competenze politiche, attraverso percorsi informali, ma senza
esperienze ben codifcate e senza una grande capacit di negoziazione, risultino
un attrattivo da controllare per fni elettorali da parte dei partiti, divenendo preda
di oferte irresistibili legate a un discorso assistenzialista e pragmatico da parte dei
governi locali e non. Nel mercato politico, le donne appaiono gi dagli anni no-
vanta come appetibile bottino per captare voti e controllarli
85
Tale la sfducia dei
peruviani verso le autorit politiche, soprattutto dopo gli anni della guerra civile e
la dittatura fujimorista (1908-2000), che la presenza di donne nelle fle del partito
e nelle liste elettorali oggi proietta unimmagine di maggiore onest, sicurezza,
stabilit e minore confittualit e corruzione.
85 Blondet, C. Leccionees de participacion politca de las mujeres, Lima, Instituto de Investigacin de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, 2004.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 390 03/05/2013 11:11:24
6. Diritto Rovesciato e lotte silenziose.
El Salvador e Marianela Garcia Villas
Chiara Forneis
NellAmerica Latina della seconda met del Novecento, caratterizzata da violenti
regimi autoritari, democratizzazione del processo politico e rivendicazione della
cittadinanza attiva delle donne sono temi strettamente correlati e comuni. Sebbe-
ne siano rintracciabili delle peculiarit nazionali, il protagonismo latinoamericano
delle donne presenta numerosi tratti comuni a partire dal fatto che nasce come
attivismo femminile per poi solo successivamente, nella fase di transizione alla
democrazia, assumere tratti femministi
86
.
In una cultura in cui alla donna assegnata la parte della cura silenziosa e
dimessa della famiglia, alla quale viene garantita una soggettivit (fatta pi di do-
veri che di diritti) limitata alla soglia del privato, quando la realt domestica viene
brutalmente profanata dallesterno, le donne si mobilitano rifutando loblio cui
untuosamente il potere pi oppressivo e feroce vorrebbe relegarle
87
.
La ribellione allingiustizia azione solidale con le lotte maschili, unendosi
in una protesta che assume un carattere anche familiare.
86 Con lassunzione dei due termini femminile e femminista si vuole sottolineare due distinte forme
di attivismo sociale da parte delle donne: con il termine femminile si fa quindi riferimento alla par-
tecipazione delle donne alle lotte politiche, giuridiche e sociali in senso plurale senza una esplicita
dichiarazione, organizzativa e/o sostanziale, di obiettivi i genere; mentre con il termine femminista si
fa riferimento a una mobilitazione femminile chiaramente etichettata e diretta ad ottenere il supera-
mento delle discriminazioni tra uomo e donna in tutti gli aspetti della vita.
87 Le donne costituiscono la presenza maggiore dei movimenti sociali di lotta per il riconoscimento
di condizioni di vita civili, culturali, economiche, politiche e sociali degne. Cos in El Salvador,
Nicaragua, Per, Cile, Argentina e Brasile, solo per citarne alcuni.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 391 03/05/2013 11:11:24
392
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
El Salvador, come molti altri paesi dellarea, stato dilaniato da una lunga
storia di estrema iniquit economica, di autoritarismo politico e militare, culmi-
nata in 12 anni (1980-1992) di guerra civile che cost la vita a 75.000 persone
88
.
Le donne salvadoregne sono sempre state politicamente attive, ma il loro im-
pegno diventa partecipazione piena e di massa negli anni Settanta in concomitan-
za allo strutturarsi di organizzazioni che andranno poi a sfociare nel movimento
rivoluzionario.
Quando le forme di protesta tipicamente maschili, come partiti e sindacati,
sono costrette alla clandestinit, rimangono solo le donne. Spontaneamente studen-
tesse, insegnanti, madri, cattoliche, donne dei mercati e contadine si organizzano
89
nella denuncia delle gravi violazioni e nella rivendicazione dei diritti fondamentali,
esponendosi a gravissimi pericoli. Molte donne entrano nel movimento rivoluziona-
rio
90
. La partecipazione femminile ha un carattere decisamente popolare e di classe
perfettamente amalgamata alle rivendicazioni del proprio paese.
La mobilitazione sociale, sia essa di genere o pi genericamente politica, na-
sce spesso dalla quotidianit in forma non organizzata e assurge agli onori della
cronaca grazie a fgure emblematiche, come lavvocata salvadoregna Marianela
Garcia Villas. La sua storia
91
, con lessere storia comune intrecciata alle vicende
di un popolo intero, ci ofre il senso pi alto e faticoso del progresso civile di quel
paese e delle sue donne. una fgura anomala nel panorama latinoamericano ove
il dinamismo femminile passa per la forza dei sentimenti di madri, fglie e sorelle,
colpiti a morte. Non cos per Marianela il cui impegno deriva da unindignazione
che si fa denuncia contro gli abusi, le torture brutali, la desaparicin, gli assassini
88 La guerra civile salvadoregna deriva dal continuo peggioramento della situazione economico-
sociale, da una corruzione dilagante, e dal controllo sanguinario delle risorse naturali (in primis le
piantagioni di caf) da parte di una ristrettissima oligarchia borghese.
89 Tra le organizzazioni pi importanti spiccano lAsociacin de Mujeres Progresistas de El Salvador
(AMPES), di estrazione comunista; Co-Madres di Monsignor Oscar Romero Comit de Madres y
Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados de El Salvador, parte di una pi ampia mobilita-
zione di denuncia della repressione; Las Dignas Asociacin de Mujeres por la Dignidad y la Vida;
CRIPDES Comit Cristiano Pro-Desplazados de El Salvador; ANDES Asocicon Nacional de
Educatores Salvadore os; il Movimento Campesino de Mujeres Demcratas Cristianas.
90 Le guerrigliere sono impiegate non solo nelle cucine da campo o in attivit di guerriglia dome-
stica, ma anche nelle azioni di lotta armata, e soprattutto nella capillare e sistematica attivit di co-
scientizzazione delle classi popolari, come qualit essenziale per la maturazione di ragione e coscienza
in un armonico circolo virtuoso.
91 Per un approfondimento sulla storia di Marianela Garcia Villas, La Valle, R.; Bimbi, L. Ma-
rianella e i suoi fratelli: dare la vita per i diritti umani nel Salvador, Roma, Icone Edizioni, 2008;
Forneris, C. El Salvador, 1983: Marianela Garcia Villas n. 43,337 nellelenco delle vittime civili, in
Storia delle Donne, Correr questo rischio. Sacrifcio, sfda, resistenza, Firenze, Firenze University Press,
n. 4, 2008, pp. 35-45.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 392 03/05/2013 11:11:24
393
6. Diritto Rovesciato e lotte silenziose. El Salvador e Marianela Garcia Villas
di massa subiti dal proprio popolo nella lotta per il diritto alla vita e allautode-
terminazione.
Laureata in legge e flosofa, durante gli anni delluniversit fa una scelta di
campo a favore dei pi deboli, spinta da un amore per la giustizia e dallimpatto
con la realt del suo paese. Sceglie di rivolgere la professione forense alla difesa dei
fgli delle donne del mercato
92
e ai gruppi di base contadini
93
, costruendo quella
che sar la sua base elettorale. Interpreta il mandato parlamentare
94
in modo del
tutto originale. Membro della Commissione per il Pubblico Benessere, propone
di compiere sopralluoghi e approfondimenti al fne di raccogliere le istanze so-
ciali e cos attuare quella sovranit popolare posta a fondamento delle pubbliche
istituzioni. Sposa la teologia della liberazione e lidea di una chiesa di popolo,
avvicinandosi a Monsignor Oscar Romero, suo sostenitore e confdente. Il 1 apri-
le 1978, Marianela fonda la Commissione per i Diritti Umani de El Salvador
(CDHES) dedicandosi allidentifcazione dei corpi martoriati che, ogni giorno,
apparivano numerosi ai bordi delle carreteras.
Viene uccisa il 13 marzo 1983. Aveva 34 anni.
Dalla disamina condotta nella prima parte, si cercher di palesare alcuni capi-
saldi che istituiscono correttamente il rapporto tra narrazioni individuali e catego-
rie giuridiche, cogliendo loccasione per far emergere le argomentazioni femminili
come promettente immagine di diritto e di mobilitazione per una rifessione pi
generale sullemancipazione e autodeterminazione.
La prospettiva femminile fondamentale per comprendere momenti, luoghi
e processi in cui vengono da un lato elaborati i diritti fondamentali e dallaltro si
92 Le donne del mercato erano coloro che avevano i loro banchi negli undici mercati della citt; con
loro Marianela cominci un lavoro politico, che si doveva rivelare molto importante sia, allinizio,
per il partito, sia, dopo, per la Commissione dei diritti umani. Esse rappresentavano infatti una base
popolare molto signifcativa, sia come numero, perch nel giro della vendita ai mercati era impegnata
una popolazione di circa trentamila persone, sia come qualit, perch si trattava di una fascia sociale
tipica, femminile, cittadina, povera ma intraprendente, stabile ma non sedentaria, tutto il giorno
presente sulla strada, disseminata in tutti i quartieri e in rapporto quotidiano con la citt, con i suoi
avvenimenti e i suoi abitanti, in La Valle, R.; Bimbi, L. Marianella e i suoi fratelli cit., p. 31.
93 Forme di organizzazione contadina spontanee, con le quali Marianela entra in contatto alla fne
degli anni Settanta, introdotta da Maria Paula Perez, personaggio di spicco del movimento contadino
salvadoregno, con la quale fonda il Movimento Campesino de Mujeres Demcratas Cristianas. Per
capirne limportanza va ricordato che la ricchezza de El Salvador, in quellepoca, era prevalentemente
concentrata nelle campagne, ove per il 60% della terra era in mano a pochi ricchi proprietari,
mentre i contadini vivevano in condizioni poverissime.
94 Marienela viene eletta deputato (dal 1974 al 1976) tra le fla della Democrazia Cristiana., della
quale sar Presidente della commissione femminile e dalla quale uscir quando questa si allea con
lestrema destra di DAubuisson, capo degli squadroni della morte e mandante politico dellassassinio
di Monsignor Romero.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 393 03/05/2013 11:11:24
394
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
forma una sfera pubblica generata da reti sociali e quindi normative che propon-
gono modelli di sviluppo utili al ripensamento delle diverse modalit di utilizzo
dello spazio sociale. Nella necessit di inquadramento e individuazione di cate-
gorie scientifche, e in particolare giuridiche, non si pu incorrere nellerrore di
prescindere dalle strutture, relazioni e interazioni sociali e di potere, senza tradire
lo spirito stesso del patto sociale.
La promozione e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare quelli di
genere, pongono al centro del dibattito la discussione sullinquadramento, che
insieme un problema di metodo e di giustizia nel senso di misconoscimento
quindi violazione.
La questione femminile in tutta la sua portata in questo senso paradigma-
tica, contenendo la sintesi della necessit del riconoscimento di unuguaglianza
di genere, non tanto nei risultati bens nelle opportunit e nelle libert
95
. Se ogni
diritto una formula sintetica di un meticciato di narrazioni sociali, allora primo
atto del processo di costruzione del nomos sta nella produzione culturale del diritto
in cui il signifcato giuridico viene prodotto e trasmesso. In tal senso il continente
sudamericano, con la sua storia al femminile e le sue risposte giuridiche, rappre-
senta la concretizzazione dellimmagine del diritto come ponte che lega il presente
al futuro e quindi oltre allessere e al dover essere, il poter essere
96
.
Dalle lotte femminili delle dittature si passati alle rivendicazioni femmini-
ste delle transizioni alla democrazia, nellestenuante processo di superamento del
muro che viene costruito attorno alla donna e che la spinge a difendere in pubblico
quellentit vaga e astratta che identifca[vo] con [se] stessa
97
. Le lotte femminili
vengono coreografcamente relegate al silenzio, laddove la donna, emblema della
sottomissione, oggetto di una doppia vittimizzazione, venendole negato non solo il
diritto alla difesa ma soprattutto la possibilit di fornire la propria versione dei fatti.
Non a caso il presente lavoro parte da una storia di vita e dalla testimonianza per
ricostruire un signifcato specifco a categorie usate nella scienza giuridica e sociale,
cos riconducendo il valore dellelaborazione giuridica alla rifessione sostanziale.
Il tratto peculiare che emerge dallimpegno di Marienela e delle donne latino-
americane, sta nellesigenza del superamento della visione atomista dellindividuo,
a favore di una idea di soggetto sociale frammentato e incompleto, composto da
identit multiple seppure relativizzate.
95 Per un approfondimento sul concetto di giustizia come equit si veda su tutti Rawls, J. A Teory
of Justice, Cambridge (Mass.), Harvard Univerisity Press, 1971, tr.it. di Santini, U. e rivisitazione di
Mafettone, S. Una teoria della giustizia, Milano, Feltrinelli Editore, 1982.
96 Cover, R. Nomos and Narrative, in Harvard Law Review, n. 97, 1983, pp. 4-40, tr.it. di Gol-
doni, M. Nomos e Narrazione. Una concenzione ebraica del diritto, Torino, Giappichelli, 2008.
97 Nafsi, A. Leggere Lolita a Teheran, Milano, Adelphi Edizioni, 2004 p. 136.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 394 03/05/2013 11:11:24
395
6. Diritto Rovesciato e lotte silenziose. El Salvador e Marianela Garcia Villas
Un sistema di sfruttamento e di diritto rovesciato
98
non distingue tra lavo-
ratrici e lavoratori, sebbene le donne siano le meno pagate, cos come non vi
distinzione nel sistema repressivo che colpisce la popolazione nel suo insieme. Le
donne hanno la capacit di vedersi come lidem e lipse
99.
Con le loro mobilitazio-
ni che diventano successivamente emancipazione dalle discriminazioni, si fanno
interpreti di un concetto identitario
100
come processo nel rapporto con laltro,
prima che status.
Limpegno femminile latinoamericano del Novecento rappresenta, in tal sen-
so, unavanguardia in quanto poggia le sue basi sullaver compiuto il passaggio da
identit separate a comunit plurale
101
.
Marienela e le donne latinoamericane, con la loro testimonianza, concettua-
lizzano la necessit di tutelare, attraverso misure attuabili, le richieste e i bisogni
che la comunit, in quanto luogo di realizzazione dellindividuo, solleva.
Le donne hanno una consolidata consapevolezza che le riforme giuridiche
basate sulleguaglianza formale sono del tutto insuf cienti, soprattutto quando
declinate nelle questioni di genere. Se si guarda le questioni sociali attraverso una
lente femminile, ci si rende immediatamente conto dei potenziali efetti distorsivi
di una concezione di uguaglianza di trattamento che non tenga conto delle efetti-
ve condizioni di vita, economiche, culturali e familiari di partenza. La ratio sottesa
allimpegno pubblico femminile si diferenzia da quella della militanza maschile
proprio in quanto le donne hanno in nuce la difesa di s stesse come persone,
mentre gli uomini fondano le proprie battaglie in nome di categorie indefnite.
98 Per un approfondimento sul concetto di mondo alla rovescia e diritto rovesciato si veda Galeano,
E. A testa in gi La scuola del mondo alla rovescia, Milano, Sperling & Kupfer, 1999.
99 Per un approfondimento sul tema si veda Ricoeur, P. Soi-mme comme un autre, Parigi, ditions
du Seuil, 1990, tr.it. di Iannotta, D. S come un altro, Milano, Editoriale Jaka Book, 1993.
100 Per comprendere il referente empirico del diritto collettivo/di genere, si deve fare riferimento
da una parte, al concetto di identit, laddove lindividuo contemporaneo appartiene a pi gruppi
di riferimento e la sua identit frammentata e deriva da una sovrapposizione complessa di diverse
componenti. E dallaltra va letto nella prospettiva della titolarit del diritto. Quindi si tratterebbe
di diritti riconosciuti ed esercitabili da collettivit/generi, oltre che o in aggiunta alla permanente
titolarit individuale.
101 La caratteristica propria della transizione dalla dimensione privata a quella pubblica, risiede []
nella pluralit delle nostre identit, che si intrecciano luna con laltra e sono refrattarie a divisioni
drastiche lungo linee di confne invalicabili a cui non si pu opporre resistenza. La natura di esseri
umani che tutti ci contraddistingue viene messa a dura prova quando le nostre diferenze vengono
ridotte a un sistema artifciale di classifcazione unico e predominante. La menomazione peggiore
avviene forse quando viene trascurato e negato il ruolo della scelta razionale che una diretta
conseguenza del riconoscimento delle nostre identit plurali., Sen, A. Identity and Violence. Te Illu-
sion of Destiny, New York-London, W.W. Norton & Company, 2006, tr.it. di Galimberti, F. Identit
e violenza, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 19.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 395 03/05/2013 11:11:24
396
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
Nelle forme latinoamericane di mobilitazione femminile si pu rintracciare,
come fl rouge, la rivendicazione silenziosa di strumenti e istituzioni per la costru-
zione di un ponte che leghi la visione uf ciale della Costituzione/norma con il
contesto delle persone e quel comportamento sociale impegnato che necessario
per dare corpo al signifcato giuridico e che ne garantisce la sua evoluzione
102
.
102 Tale principio sta alla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulleliminazione di tutte le
forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) adottata dallAssemblea generale delle NU il
18.12.1979, in vigore internazionale dal 3.9.1981. DallItalia stata ratifcata il 10.06.1985; ordine
desecuzione dato con legge 14.03.1985 n. 132; ed in vigore dal 10 luglio 1985.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 396 03/05/2013 11:11:24
7. Donne, diritti e potere: le Madres e le
Abuelas di Plaza de Mayo
Marzia Rosti
1. La nascita delle organizzazioni femminili impegnate per i diritti delle vittime
della dittatura argentina si riconduce allesortazione di Azucena Villafor
103
che,
nel 1977, si rivolse ad alcune donne presenti nellanticamera del Vicariato, dopo
un inutile incontro con Monsignor Grasselli, facendosi interprete del loro disagio
per non riuscire a ottenere informazioni sulla sorte dei propri fgli scomparsi. Le
sue parole indicavano gi quelli che sarebbero stati gli obiettivi e le strategie di
lotta: andare in piazza, diventare sempre pi numerose, apparire (in risposta alla
sparizione), far s che tutti si rendessero conto della loro presenza e obbligare il
potere a dar loro una risposta. Un potere individuato nella persona di Videla che,
in quel momento, ricopriva sia la carica di Presidente de la Nacin sia quella di
capo della Junta Militar.
Lesortazione fu raccolta da alcune madri che, il 30 aprile 1977, si radunaro-
no in Plaza de Mayo, dando origine alle nota organizzazione femminile Madres
de Plaza de Mayo, il cui simbolo identifcativo appunto il luogo in cui i suoi
componenti si riuniscono da allora, ogni gioved pomeriggio, e le cui invenzioni
simboliche sono famose in tutto il mondo (il fazzoletto bianco sul capo, le foto dei
parenti scomparsi, le silhouette disegnate sullasfalto e la marcia circolare).
La capacit organizzativa di Azucena che si impose come leader naturale e
delle prime madri che aderirono alle sue iniziative non lasci del tutto indiferenti
i militari, anche se in un primo momento sembrarono ignorarle e Videla, in ef-
103 Gorini, U. La rebelin de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo (1976-1983), Buenos
Aires, Norma, 2006, p. 63; Gorini, U. Azucena Villafor in www.enciclopediadelledonne.it.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 397 03/05/2013 11:11:24
398
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
fetti, mai le ricevette e chi lo fece per lui ne accentu il silenzio e il distacco. Per
il regime, infatti, non era possibile che un gruppetto di madri disperate potesse
sfdare il potere, mentre era pi probabile che fossero collegate con i sovversivi e
che le loro riunioni fossero cospirazioni. Dunque, nel dicembre 1977 i militari
sequestrarono e fecero sparire Azucena stessa e altre due madri Mara Eugenia
Ponce e Esther Ballestrino
104
che, per lesperienza di lotta sociale o di militanza
in organizzazioni dellopposizione, erano state individuate come le fondatrici o
comunque le ispiratrici della protesta e, dunque, soggetti da eliminare sia per
spezzare leventuale legame con i guerriglieri Montoneros sia per spaventare le
altre donne e indurle a non riunirsi pi; donne che, invece, non vollero restituire
la piazza ai militari e, consapevoli di quanto fosse pericoloso, decisero di tornarvi
ogni gioved pomeriggio.
Ad Azucena, segu Hebe de Bonafni, eletta Presidentessa nel 1979 e ancora
oggi alla guida dellassociazione; la sua determinazione nella lotta e lintransigenza
sulle strategie di protesta e nei rapporti con il potere, prima dei militari e, poi,
democratico, hanno suscitato spesso critiche, incomprensioni e malumori, che in
parte sono stati allorigine delle due scissioni: nel 1978, delle Abuelas de Plaza de
Mayo e, nel 1986, delle Madres de Plaza de Mayo-Lnea Fundadora
105
.
2. Nel 1978 nacquero le Abuelas de Plaza de Mayo, oggi guidate da Estela
Barnes de Carlotto, le cui dodici fondatrici si identifcarono fra le Madres gi
nei primi incontri poich, oltre ai fgli, cercavano i nipoti partoriti dalle fglie o
dalle nuore incinta sequestrate e dei quali si erano perse le tracce. A diferenza
delle Madres, le Abuelas svolsero una vera attivit investigativa e, soprattutto, si
mostrarono disponibili al dialogo con le istituzioni, per ottenere pi informazioni
possibili. Sino ad oggi hanno conseguito notevoli risultati nel ritrovamento dei
nipoti
106
, nei rapporti con le istituzioni, soprattutto dal ritorno alla democrazia
107
,
e nellevoluzione del diritto nazionale e internazionale in materia di tutela dei
minori e del loro diritto allidentit
108
. E proprio questi sono gli aspetti criticati
104 Mara Eugenia Ponce ed Esther Ballestrino in www.enciclopediadelledonne.it. I resti delle tre
madri sono stati identifcati e sepolti nel 2005.
105 Suscitano perplessit le sue recenti dichiarazioni a favore dellETA, delle Farc e degli attentati
dell11 settembre e laugurio a Giovanni Paolo II que se pudra en el Inferno, alla sua morte.
106 Circa un centinaio, 25 dei quali gi durante la dittatura.
107 La nascita dellEquipo Argentino de Antropologa Forense (1984), del Banco Nacional de Datos
Genticos (1987); il test di abuelismo (1982), la campagna Sai chi sei (1997) e la miniserie Tele-
visin por la identidad (2007). La restituzione dei nipoti ritrovati fu sempre possibile, poich la Ley
de Obediencia Debida non comprendeva la sottrazione di neonati.
108 Il contributo agli artt. 7, 8, 11 e 12 sul diritto allidentit della Convenzione internazionale sui
diritti dellinfanzia e allart. 25 della Convenzione contro le sparizioni forzate; nel 1992 la creazione
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 398 03/05/2013 11:11:24
399
7. Donne, diritti e potere: le Madres e le Abuelas di Plaza de Mayo
dalle Madres: il ricevere come associazione denaro dai partiti e dalle istituzioni, il
dichiararsi Abuelas de Plaza de Mayo, ma andare raramente in Plaza de Mayo e,
infne, il voler imporre la nuova identit ai nipoti ritrovati
109
.
3. Nel 1979, mentre la protesta delle donne in piazza aumentava, il potere
eman la Ley de presuncin de fallecimiento, che permetteva ai familiari degli
scomparsi fra il 6 novembre 1974, inizio dello stato dassedio, e la promulgazione
della legge stessa (il 12 settembre) di ottenere la dichiarazione di assenza con pre-
sunzione di morte, suscitando la reazione delle organizzazioni per i diritti umani
110
presenti nel Paese che, in un comunicato congiunto sul Buenos Aires Herald, la
defnirono un tentativo di assassinare la speranza e di negare il diritto di conoscere
la sorte dei propri familiari scomparsi.
Fu lennesima manifestazione di tracotanza del potere, cui si aggiunse, nel di-
cembre 1979, la reazione di Videla allInforme della CIDH, che aveva confermato,
dopo un sopralluogo a Buenos Aires, le migliaia di desaparecidos e le gravi violazio-
ni dei diritti, e al quale Videla replic sostenendo come il governo fosse ricorso ai
mezzi pi idonei in quella situazione. Tracotanza che ritroviamo poi nellattacco
alla Gran Bretagna con la guerra delle Falkland/Malvinas, ma soprattutto con la
Ley de Autoamnista frmata da Bignone il 23 marzo 1983, ultimo atto dei mili-
tari ormai prossimi a lasciare il potere e che il Presidente Alfonsn abrog appena
assunta la carica, perch incostituzionale e in nome della Verit e della Giustizia
che il popolo argentino le madri prime fra tutti reclamava da tempo.
4. Nel 1983 lelezione di Alfonsn come Presidente de la Nacin segn luscita
di scena dei militari e linizio della transizione alla democrazia; e se da una parte
Alfonsn, gi in campagna elettorale, aveva promesso Verit e Giustizia
111
per i cri-
mini della dittatura, dallaltra parte, i militari non mostrarono alcun pentimento
per quei crimini, dichiarandosi piuttosto convinti di aver operato per il bene della
nazione.
della CONADI-Comisin Nacional por el derecho a la identidad, presieduta da Claudia Carlotto,
fglia di Estela; nel 2009 la creazione della Red por la identidad in Spagna e in Italia che estende le
ricerche dei nipoti ai due paesi. Cfr. www.abuelas.org.ar; www.conadi.jus.gov.ar.
109 Padoan, D. Le pazze. Un incontro con le Madri di Plaza de Mayo, Milano, Bompiani, 2006, pp.
305-306.
110 Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga por los Derechos del Hombre, Madres
y Familiares de Personas desaparecidas y Detenidos polticos e Movimiento Ecumnico por los De-
rechos Humanos.
111 Egli indic tre livelli di responsabilit-punibilit: gli artefci della macchina repressiva, coloro che
avevano commesso atti atroci o aberranti eccedendo gli ordini e coloro che avevano obbedito agli
ordini superiori.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 399 03/05/2013 11:11:24
400
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
Alfonsn nomin la CONADEP che con tutti i suoi limiti e difetti
112
ofr co-
munque una prima ricostruzione degli orrori della dittatura nel rapporto Nunca ms
del 1984 e, dallaprile al dicembre 1985, furono processati e condannati i militari
che avevano integrato le Giunte. Gran parte dellopinione pubblica fu convinta che
Videla, Viola, Lambruschini, Agosti e Massera avrebbero scontato le rispettive pene e
attese lavvio dei processi ai militari di rango inferiore, ma la prospettiva di pi di mil-
le nuovi procedimenti, oltre a rivelare le dimensioni della tragedia che aveva colpito
il Paese, gener fra il 1987 e il 1988 resistenze e tensioni nelle Forze Armate, che
rivendicarono il proprio ruolo di difensori della patria. Il timore di un nuovo golpe
mise alla prova la fragile democrazia e dimostr che i militari, abituati a controllare
le istituzioni sin dal 1930, non erano usciti di scena e incutevano ancora timore.
Alfonsn opt allora per la riconciliazione nazionale: per placare gli animi di questi
ultimi eman la Ley de Punto fnal (1986) e la Ley de Obediencia debida (1987) e
ofr ai familiari delle vittime una pensione, purch ne ammettessero la scomparsa.
Il successore Menem prosegu nella riconciliazione nazionale: mentre ofriva
un indennizzo per ciascun desaparecido, concedeva indulti ai militari, di cui be-
nefciarono anche i condannati nel 1985 che, invece, sarebbero dovuti restare in
carcere
113
, suscitando le proteste di parte della societ civile. Fu cos che nessun
membro delle Forze Armate si trov a dover rispondere alla Giustizia per i crimini
commessi durante il regime.
5. Nel 1986, a tre anni dalla fne della dittatura e quando non erano ancora
ben defniti i tratti della forzata riconciliazione nazionale, nelle Madres si deline
un gruppo di donne pi disponibili al dialogo con le istituzioni e favorevoli sia alla
restituzione delle spoglie dei propri cari, una volta ritrovate, sia a un risarcimento
economico. Il vincolo che sino a quel momento era parso indissolubile si spezz:
una ventina di madri si stacc dallassociazione, alla quale restarono i beni e il
nome, per fondare le Madres de Plaza de Mayo-Lnea Fundadora.
Il casus belli fu proprio loferta di un risarcimento economico, in quanto
per le Madres de Plaza de Mayo i politici avrebbero comprato la fne della
protesta e, pertanto, scelsero di non avere rapporti con la nuova classe politica,
che a loro tanto nuova non sembrava, poich vi ritrovavano persone ancora troppo
legate ai militari.
Le fondatrici delle Madres-Lnea Fundadora indicarono soprattutto nel carat-
tere autoritario e impositivo di Hebe la prima causa di separazione, essendo venute
112 Sconcert la teoria dei due demoni esposta nel Prlogo del Nunca ms, per la quale il terrorismo
di Stato era stata linevitabile risposta al terrorismo delle sinistre.
113 Nel 1989 concede lindulto ai generali sotto processo; nel 1990 concede lindulto ai 9 membri
delle Giunte condannati nel 1985.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 400 03/05/2013 11:11:24
401
7. Donne, diritti e potere: le Madres e le Abuelas di Plaza de Mayo
meno quelle condizioni di parit che avevano caratterizzato il movimento sin dalla
sua nascita, oltre alle divergenze su come portare avanti la lotta e sui rapporti con
il potere. Non un caso che nelle Madres-Lnea Fundadora, guidate da Marta
Ocampo
114
, siano confuite come rivela lo stesso nome molte delle fondatrici,
cio coloro che aderirono allesortazione di Azucena.
6. Nel tempo le strategie delle due organizzazioni si sono defnite: entrambe
sono presenti il gioved in Plaza de Mayo, ma ciascuna marcia in gruppi separati;
tutte le madri portano il fazzoletto bianco, ma quelli delle Madres sono tutti ugua-
li, recano la scritta Aparicin con vida e il logo di Madres; mentre ciascuna madre
di Lnea Fundadora porta sul suo fazzoletto il nome del proprio o dei propri fgli
scomparsi, perch ciascuna li possa ricordare e si senta legata alle altre madri che
hanno vissuto lo stesso dramma. Cancellare il riferimento ai fgli sarebbe come
farli scomparire due volte.
Luguaglianza dei fazzoletti delle Madres de Plaza de Mayo , invece, il modo
per rivendicare la storia della collettivit e di tutte le sue vittime, andando oltre
quella individuale.
Anche le iniziative promosse rispecchiano i due approcci diferenti: per Lnea
Fundadora importante fare memoria ricostruendo le singole esperienze e le sin-
gole vite spezzate, per poi intrecciarle, e sono favorevoli alle recenti iniziative volte
a creare luoghi della memoria, mentre per le Madres de Plaza de Mayo, innanzi-
tutto, la ricostruzione del destino dei militanti deve essere univoca e unica, al di l
delle singole diferenze, e rispetto ai luoghi della memoria sostengono che lapidi
e musei restino sterili e ricordino solo la morte dei desaparecidos. Una morte che
esse negano con lo slogan Aparicin con vida e con il rifuto delle riesumazioni.
7. Il Presidente Kirchner, eletto nel 2003 e defnitosi fglio delle madres
115
,
ha avviato una politica di maggiore attenzione, rispetto e tutela dei diritti umani,
promuovendo numerose iniziative per la memoria delle vittime della dittatura e
per riaprire i conti lasciati in sospeso con la Giustizia.
Il 24 marzo 2004, in occasione del 28 anniversario del golpe, chiede perdono
a tutte le vittime della dittatura, anche per il colpevole silenzio di ventanni di go-
verni democratici; qualche ora prima, partecipa al ritiro da parte del generale Ben-
dini, capo dellEsercito, dei ritratti di Videla e di Bignone dal Collegio Militare.
Nel 2006 viene presentata alla Feria del Libro di Buenos Aires una nuova
edizione del Nunca ms con un nuovo Prlogo in aggiunta a quello del 1984, che
114 Anche Presidentessa della Fedefam Federacin de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Cfr.
www.madresfundadoras.org.ar.
115 Durante il suo primo discorso allAssemblea generale dellONU, settembre 2003.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 401 03/05/2013 11:11:25
402
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
espone la posizione del governo Kirchner in merito al terrorismo di Stato e ai
diritti umani, rifutando la teoria dei due demoni. Infne, nellambito della Giu-
stizia, nel giugno 2005 sono abrogate le leggi dimpunit, poich incostituzionali,
consentendo la riapertura dei processi ai militari responsabili dei crimini della
dittatura.
Anche i vertici militari sono stati coinvolti in questa nuova politica: il 3 marzo
2004 lammiraglio Godoy in una cerimonia pubblica ripudia la repressione illegale
della Marina durante la dittatura e, nel riferirsi alla trasformazione dellESMA in
museo della memoria, ricorda come vi siano stati commessi fatti aberranti che niente
e nessuno possa giustifcare
116
; infne, nel maggio 2004, il generale Bendini defnisce
lesercito unistituzione che si assume le responsabilit dei propri errori
117
.
Questo impegno straordinario nella tutela dei diritti e nel rendere Giusti-
zia alle vittime della dittatura stato il vero fore allocchiello della presidenza
Kirchner, che ha posto fne alla percezione dello Stato come terrorista e nemico e
che stato apprezzato dalle tre organizzazioni femminili, le quali hanno sostenuto
nel 2007 la candidatura alla presidenza della moglie Cristina Frnandez, poich
vista come garante della continuit del suo progetto.
8. Da quellincontro spontaneo promosso da Azucena sullonda dellemo-
zione e della rabbia le donne argentine hanno percorso tanta strada e tante ronde
intorno allobelisco, hanno viaggiato per il mondo e hanno raccontato la loro
storia di madri o di nonne, suscitando commozione e tanta ammirazione. Allora
riuscirono a emergere e ad appropriarsi della piazza rimasta vuota e, con il ritorno
alla democrazia e al di l delle loro divisioni interne, ad aggregare diverse forze
sociali nella lotta per i diritti umani e nelle forme di solidariet. Alle donne mature
e anziane si sono af ancate in questi ultimi anni donne pi giovani, che hanno
aderito al loro progetto per una societ pi giusta, rispettosa dei diritti e delle
persone e che custodiscono e simpegnano a trasmettere il messaggio di Memoria,
Giustizia e Verit.
116 Nada ni nadie puede justifcarlo, in Pgina/12, 4 marzo 2004.
117 Bendini: El Ejrcito asume sus errores, in La Nacin, 29 maggio 2004.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 402 03/05/2013 11:11:25
8. Beatriz Sarlo e la critica periferica
Amanda Salvioni
Nelleditoriale che apre il numero 90 (aprile/maggio 2008) di Punto de Vista e che
chiude per sempre una delle riviste culturali e politiche pi infuenti della seconda
met del XX secolo in Argentina, Beatriz Sarlo decide di mettere in scena un Io
autobiografco che sposta apparentemente loggetto del suo intervento da un pia-
no storico/sociale a una dimensione pi schiettamente soggettiva: Per trentanni
Punto de vista ha esercitato il pi grande e il pi importante infusso sulla mia vita.
Altri potranno discutere se sia stata una rivista infuente; che lo sia stata su di me,
non ho dubbi.
118
Lefettiva infuenza della rivista, co-fondata e successivamente diretta per
quasi trentanni da Beatriz Sarlo, sulla vita culturale nazionale pu essere misurata
sul calibro degli autori che le sue pagine hanno introdotto in Argentina, autori che
rifettono nella loro totalit le ossessioni teoriche di Sarlo e che hanno contribuito
in modo decisivo al dibattito critico sulle trasformazioni del Paese tra gli anni Ot-
tanta e i Novanta: da Raymond Williams a Pierre Bourdieu, da Winfried Sebald
alla scoperta di Juan Jos Saer, da Marshall Berman a Carl Schorske, e cos via.
Ma a partire dalla dimensione soggettiva, quasi sentimentale, dellultimo edi-
toriale di Sarlo che viene rivendicato con forza il carattere belligerante della rivista
allepoca della sua fondazione, che segue di due anni linstaurarsi del regime ditta-
toriale. Un carattere, tuttavia, che molti esiliati, tornati in Argentina col ristabilirsi
della democrazia, hanno spesso negato a Punto de vista, attribuendo di rifesso alla
sua co-fondatrice comportamenti politicamente troppo tenui, quando non incon-
118 Punto de Vista, n. 90, 2008, p.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 403 03/05/2013 11:11:25
404
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
gruenti con il dissenso pi fermo pagato da altri a prezzi inestimabilmente pi alti.
Era il marzo del 1978 e sostiene Sarlo la creazione di uno spazio intellettuale
indipendente dallaccademia, dalle sovvenzioni, dai mezzi di comunicazione, dai
gruppi editoriali, dalle convenzioni servili della vita pubblica sotto il regime era
comunque di per s un atto sovversivo, capace, come avrebbe dimostrato in seguito,
di non esaurirsi col cessare delle circostanze storiche che ne avevano determinato la
nascita, ma destinato a rimanere tale nei trenta anni successivi.
Il modo in cui Beatriz Sarlo annuncia e giustifca la chiusura di Punto de Vista
stabilisce una sorta di identit metaforica tra la sua persona e la rivista da lei diretta
che non esita a inquadrare le due esperienze quella esistenziale e quella edito-
riale allinterno di una condizione di marginalit elettiva. Paradossalmente
questo spazio distante, liminare, situato ai margini di ogni altro luogo codifcato
o istituzionalizzato, e per ci stesso combattuto, osteggiato ma mai ignorato, sar
lunico a essere abitato da Sarlo con la naturalezza di chi si sente a casa propria:
Non mi sono mai sentita del tutto nel mio ambiente []. Lunico spazio che ho
percorso per trentanni con la certezza che fosse il mio spazio naturale sono state
le pagine di questa rivista indipendente
119
. Questa condizione di marginalit, che
rappresenta al contempo un punto di vista e un oggetto danalisi, certamente la
cifra di tutto il percorso intellettuale di Beatriz Sarlo, e pu riferirsi almeno a tre
piani diversi della sua esperienza. Lassunzione di una prospettiva distante e peri-
ferica si rifette, infatti, tanto nelle scelte disciplinari quella di collocarsi oltre i
confni degli studi letterari e fare di essi il margine da cui si osservano le trasforma-
zioni sociali e culturali ; nelle scelte tematiche quella di analizzare lesperienza
storico-culturale argentina come manifestazione di una modernit periferica ;
e anche nelle scelte esistenziali labbandono prematuro della vita accademica vis-
suta con disagio e in un clima per certi versi ostile, le scelte di campo confittuali
in un contesto intellettuale e politico dallalto tasso di aggressivit, gli interventi
polemici, o quanto meno fortemente critici sullo statu quo nazionale, lanciati da
canali dinformazione tradizionalmente conservatori, quali il quotidiano La Na-
cin. In questo senso, si pu afermare che Beatriz Sarlo incarni uno dei possibili
paradigmi del protagonismo intellettuale femminile in America Latina, basato su
una profonda identifcazione della propria traiettoria personale col presente nazio-
nale, e sulla consapevolezza del proprio luogo dellenunciazione: un punto di vista
eccentrico e al contempo integrato, capace di orientare la prassi intellettuale e di
incidere sulla realt analizzata. Il riconoscimento internazionale, in primis da parte
del mondo accademico anglosassone ma sempre crescente anche in altri ambiti,
sancisce il suo ruolo centrale negli Studi Latino Americani contemporanei, mentre
119 Ibidem.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 404 03/05/2013 11:11:25
405
8. Beatriz Sarlo e la critica periferica
non ha migliorato le condizioni della sua ricezione in Argentina, ancora fortemen-
te segnata dal contrasto con alcuni dei settori dellintellettualit nazionale.
Nonostante la sconfessione dei propri saggi scritti prima del 1980, ribadita
nel prologo del recente Escritos sobre literatura argentina (2007), lesordio critico
di Sarlo, risultato dalla sua tesi dottorale, evidenzia un campo dinteresse e un
taglio interpretativo destinati a espandersi nei decenni successivi. In Juan Mara
Gutirrez, historiador de nuestra literatura (1967), lattenzione di Sarlo si rivolge
al cuore del canone fondazionale del sistema letterario argentino per indagare le
condizioni di possibilit della sua stessa nascita. Gutirrez, non gi il poeta epi-
gono del romanticismo rioplatense bens lo storico e organizzatore della cultura
nazionale nel cuore del XIX secolo, colto nellatto di interrogarsi sullefettiva
esistenza di un oggetto storicizzabile qualifcato come letteratura argentina, sui
suoi rapporti con la tradizione ispanica e soprattutto con il resto della produzione
letteraria dellAmerica indipendente, considerata quale macro-sistema ineludibile
nella defnizione di ci che proprio. Il punto di vista sulla tradizione nazionale
per certi versi obliquo: di una fgura canonica come Guitrrez viene infatti messa
in valore la rifessione sulla condizione di perifericit dello spazio culturale nazio-
nale alle soglie di una chimerica internazionalizzazione dei suoi prodotti letterari.
Dora in avanti la perifericit, sia che si afrontino autori centrali del canone na-
zionale, sia ci si rivolga a produzioni minori o extraletterarie, sar la condizione di
partenza per ogni atto interpretativo della studiosa argentina.
Con El imperio de los sentimientos. Narraciones de circulacin peridica en la
Argentina, 1917-1927 (1985), il terreno danalisi si sposta dal canone alla lette-
ratura marginale (il feuilleton destinato al pubblico femminile dei settimanali),
inaugurando uno dei versanti della sua ricerca, ora collocatasi decisamente al di
fuori dellambito della letteratura colta, nellottica di espandere il campo degli
studi letterari a testualit marginali di matrice popolare. La linea era quella gi
defnita da Punto de vista in un importante numero del 1983 dedicato alla def-
nizione della cultura nazionale in rapporto alla cultura popolare
120
. Lattenzione
alle letterature minori o a tipologie testuali non conformi al canone estetico
consacrato non era nuova nel panorama critico argentino, ma nella prospettiva
di Sarlo si approfondisce lidea che proprio tali testi rappresentino altrettanto vie
daccesso a uninterpretazione privilegiata della realt sociale intesa nel suo diveni-
re storico. Il libro sancisce ormai chiaramente una defnizione molto pi inclusiva
di produzione culturale e una trasformazione degli studi letterari in senso sempre
pi trans-disciplinare e prossimo agli Studi Culturali.
120 Cultura nacional. Cultura popular. Defniciones y problemas de la poltica y de la historia cul-
tural en la Argentina. Punto de Vista, n. 18, 1983.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 405 03/05/2013 11:11:25
406
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
con Una modernidad perifrica: Buenos Aires 1920 y 1930 (1988) che Sarlo
esplicita ancor pi chiaramente la sua posizione disciplinare, ovvero la volont di
scrivere un libro ibrido miscuglio di critica letteraria, sociale, storica, politica,
economica a sua volta rifesso di una cultura ibrida, o di contaminazione quella
di Buenos Aires cosmopolita, intenta a elaborare la sua peculiare interpretazione
di modernit dai margini del mondo in un circolo virtuoso di identifcazioni fra
oggetto danalisi, sguardo critico e percorso personale. Ancora una volta, infatti,
il registro autobiografco a enunciare la propria posizione disciplinare periferica.
Linadeguatezza della critica letteraria nellinterpretare una testualit non stretta-
mente vincolata al fatto estetico si palesa infatti come una messa in discussione
della propria attivit di critica, e dunque del suo ruolo in quanto intellettuale nella
societ. Considerare la letteratura come un elemento che, al pari di altri, inter-
viene nelle trasformazioni sociali, non signifcava, per, labbandono del campo
letterario, bens lidea di sottoporlo a tensioni inedite, inventando una nuova stra-
tegia per entrare e uscire dai testi, che superasse il vincolo cardinale dellautonomia
estetica ai fni dellinterpretazione sociale della cultura. Una strategia, per altro,
ricavata non da assunti teorici superiori ed estrinseci, bens ritagliata sul personale
modo di leggere e scrivere acquisito da Sarlo nel tempo. Ancora una volta oggetto
danalisi, metodologia e storia personale appaiono inscindibili nella argomenta-
zione critica e nelledifcio teorico che la sostiene. In questo libro si delinea, quale
principale oggetto dindagine, la defnizione di una modernit latinoamericana a
partire dalla condizione di perifericit, che a sua volta circostanza geografca di
distanza dai centri di produzione di cultura e potere, ma anche identit metic-
cia, ibridismo culturale, desiderio mimetico e scontro fra immaginari eterogenei.
Lindagine condotta attraverso il tema del ricordo e della memoria dellesperien-
za urbana cos come vengono organizzati dal discorso letterario, e ancor prima
dallideologia. Questo il flo conduttore di letture molto innovative, divenute
ormai classiche, di autori come Giraldes, Borges, Arlt, Girondo, Ocampo, Mal-
lea, interrogati proprio a partire dai modi in cui la memoria viene strutturata dal
racconto. Sar in seguito la nozione di ideologema, ripresa da Bachtin e succes-
sivamente da Kristeva, a chiarire e sostenere questa posizione critica.
Linedita metodologia danalisi sperimentata in Una modernidad perifrica,
che coniuga dati della ricerca sociale, analisi storiografche e critica letteraria, ha
reso questo libro un fattore di rinnovamento dei paradigmi interpretativi della
realt nazionale.
Negli anni Novanta, la produzione critica di Beatriz Sarlo, chiaramente orien-
tata fn dal decennio anteriore da Raymond Williams, Pierre Bourdieu, ma anche
saldamente ancorata a Walter Benjamin, Claude Lvi-Strauss, e in dialogo costan-
te con Halpern Donghi, Antonio Cndido, Richard Hoggart, Carlo Guinzburg,
Hayden White, si focalizza su diverse tematiche, tutte in relazione fra loro: il
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 406 03/05/2013 11:11:25
407
8. Beatriz Sarlo e la critica periferica
rapporto fra quotidianit dei ceti popolari e il campo intellettuale argentino in
relazione alla formazione di un immaginario collettivo della modernit, lautorita-
rismo e il totalitarismo e le forme di resistenza che questi hanno generato nel siste-
ma letterario nazionale. Ma soprattutto lindagine su modernit e posmodernit,
intesa la seconda come un continuum problematico e confittuale della prima, a
caratterizzare questi studi. Da La imaginacin tcnica: sueos modernos de la cultura
argentina (1992); a Escenas de la vida posmoderna: intelectuales, arte y videocultura
en la Argentina (1994); fno a Instantneas: medios, ciudad y costumbres en el fn de
siglo (1996) e La mquina cultural (1998), Sarlo mette in atto unautentica lettura
metaforica della realt, dove ogni fenomeno culturale, dai testi, agli shopping cen-
ter, alle sale giochi, alla televisione, sono esaminati come parte o metafora di un in-
sieme. Cos il centro commerciale, pensato come moderno labirinto dove lorien-
tamento spaziale basato unicamente sulla disposizione della merce, metafora di
uno spazio pubblico svuotato di senso e a sua volta parte di una aspecifca semiosi
culturale della periferia posmoderna. Il procedimento analitico, che in Istantneas
si ripete nellosservazione dei dettagli del quotidiano, mentre in La mquina si
rivolge alle traiettorie umane e professionali di fgure soprattutto femminili quali
Rosa del Ro, maestra negli anni Venti, accanto a personaggi del calibro di Victoria
Ocampo, chiaramente riconducibile a quello dei Cultural Studies con cui Sarlo
si trova, negli anni Novanta, in dialogo continuo.
Un testo scritto a Cambridge nel 1993 Borges, a Writer on the Edge e
tradotto per il mercato ispanofono nel 1995 Borges, un escritor en las orillas fa
rientrare la sua sfera danalisi nellambito pi esplicitamente letterario lopera
di Borges senza abbandonare la nozione di marginalit come cifra interpre-
tativa, bens defnendola ancor pi ef cacemente. Di nuovo, lenunciazione del
proprio punto di vista af data a unironica e provocatoria defnizione di se stessa
una provinciale ingenua nellatto di restituire a Borges una dimensione che
la ricezione mondiale aveva sottaciuto: largentinit di Borges, non in contrap-
posizione ma compenetrata al suo cosmopolitismo. Dunque la orilla, plasmata
esteticamente nelle poetiche iniziali e declinata successivamente in vari sensi, non
soltanto lo spazio letterario della periferia urbana tematizzato da Borges quale
luogo intermedio e simbolico fra campagna e citt e le loro rispettive tradizioni,
ma traduce la posizione dello scrittore argentino che sceglie proprio il limite tra
generi letterari, tra lingue, tra culture quale luogo privilegiato denunciazione
dal quale poter dialogare alla pari con lintero corpus della letteratura occidentale.
La collocazione di Borges in una frontiera, mobile e porosa come quella teorizzata
da Lotman, stato un tassello fondamentale nellesegesi novecentesca del grande
scrittore argentino.
Dal 2000 Beatriz Sarlo stata presente nel mercato editoriale internazionale
con numerose raccolte di saggi e interventi gi pubblicati su giornali o riviste, ma
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 407 03/05/2013 11:11:25
408
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
il contributo di maggior interesse e originalit forse rappresentato da La pasin
y la excepcin. Eva, Borges y el asesinato de Aramburu (2003). Il testo compone una
sorta di fenomenologia della storia politica e culturale argentina, cui si attribuisce
un carattere di eccezionalit, a partire da tre oggetti tanto eterogenei da rendere
impossibile coglierne la relazione reciproca, se non nei termini in cui il libro la
costruisce: un personaggio storico Eva Pern , una scrittura quella di Bor-
ges , e un avvenimento lassassinio del generale Pedro Eugenio Aramburu per
mano dei montoneros. Il vero flo conduttore fra i tre oggetti danalisi enunciato,
come ormai di consueto, nei termini di una rifessione autobiografca: Quando
ricordo il giorno in cui la televisione [] trasmise la notizia del ritrovamento del
cadavere [di Aramburu] vedo unaltra donna, che non sono pi io. Voglio capir-
la, perch quella donna non era diversa da tante altre e altri
121
. Ci che ha reso
opachi il sentimento morale e lidea politica di allora un vissuto personale e un
sedimento storico a partire dal quale lautrice intraprende il suo lavoro di analisi,
identifcandosi pienamente con loggetto sfuggente e astratto che costituisce la sua
ossessione: il segreto articolarsi della vita nazionale, le relazioni occulte tra feno-
meni diversi, il cui disvelamento costituisce la via per ricomporre e comprendere
leccezionalit argentina.
121 Sarlo, B. La pasin y la excepcin. Eva, Borges y el asesinato de Aramburu, Buenos Aires, Siglo XXI,
p.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 408 03/05/2013 11:11:25
9. Patricia Verdugo (1947-2008).
Alla ricerca della verit nel Cile di Pinochet
Claudia Borri
Tra i ricordi indelebili del mio primo incontro col Cile, nel novembre 1989, ci
sono i mucchi di copie del libro di Patricia Verdugo, Los zarpazos del puma, dispo-
ste alla rinfusa sui marciapiedi di Santiago per essere vendute ai passanti
122
. In una
citt ancora intontita dalla paura, ma gi in fermento per le prime elezioni dopo
diciassette anni di dittatura, quel libro e quelle modalit di vendita ben rappresen-
tavano il momento di passaggio dal regime militare al ristabilimento di un ordi-
ne democratico, ancorch fragile per la presenza del generale Pinochet alla guida
dellesercito. Il volume, uscito da appena due mesi, suscit un enorme interesse tra
i lettori tanto che sarebbe diventato rapidamente un best seller. Conteneva, infatti,
uninchiesta giornalistica che ricostruiva loperato della cosiddetta carovana della
morte, cio del gruppo di militari che, al comando del generale Arellano Stark e a
bordo di un elicottero Puma, nei giorni successivi al golpe dell11 settembre 1973
aveva prelevato dal carcere settantadue prigionieri politici di diverse localit del
Cile, li aveva sommariamente giustiziati e ne aveva fatto sparire i cadaveri.
Lindagine era nata per smascherare le afermazioni contenute nel libro del
fglio del comandante della carovana, lavvocato Sergio Arellano Iturriaga, il quale,
nel 1985, aveva pubblicato una testimonianza personale con lintenzione di di-
scolpare il padre prima ancora che qualcuno tentasse di incriminarlo. Fu proprio
questo tentativo di difesa preventiva che spinse Patricia Verdugo a raccogliere le
prove per smentire le menzogne contenute nella pubblicazione. Tuttavia, ancor
122 Verdugo, P. Gli artigli del puma. I crimini della Carovana della morte nel Cile di Pinochet, Milano,
Sperling & Kupfer, 2006.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 409 03/05/2013 11:11:25
410
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
prima di questa data e anche del 1983, anno in cui fu abolita la censura sulla
stampa, la giornalista aveva pubblicato con Claudio Orrego, ex deputato demo-
cristiano, unindagine sugli abusi in corso dal titolo Detenidos-desaparecidos. Una
herida abierta, che rivelava come quindici contadini del villaggio di Lonqun fos-
sero stati gettati vivi in un altoforno dai militari. Il libro era stato inviato per posta
allindirizzario della casa editrice Aconcagua che si era assunta il rischio di stam-
parlo clandestinamente. In seguito altre sue inchieste erano uscite per denunciare
casi eclatanti di violazione dei diritti umani: nel 1985, Andr de la Victoria, storia
del prete francese Andr Jarlan (1941-1984), ucciso durante unincursione dei
Carabineros nel quartiere popolare de La Victoria; e, nel 1986, Rodrigo y Carmen
Gloria: quemados vivos, storia di due giovani ai quali i militari avevano dato fuoco
mentre partecipavano a una manifestazione di protesta.
Al momento di afrontare linchiesta sulla carovana della morte, perci, Pa-
tricia Verdugo aveva alle spalle un solido tirocinio nel campo dellindagine sulla
violazione dei diritti umani che ne attestava le convinzioni democratiche. Tut-
tavia, nel denunciare gli abusi del generale Arellano Stark e del suo mandante,
Augusto Pinochet, la giornalista aveva evitato di emettere una condanna generaliz-
zata dellesercito, dando rilievo alloperato degli uf ciali che si erano dissociati da
quella famigerata impresa, come il colonnello Rivera Desgroux, comandante della
piazza di Calama, che si era dimesso nel 1974, dopo che, a sua insaputa, ventisei
prigionieri politici af dati al suo comando erano stati eliminati dallo stesso Arella-
no Stark; e come il generale Lagos, che si era presentato spontaneamente come te-
stimone daccusa durante il processo contro lo stesso personaggio. Nel primo e pi
documentato atto daccusa contro i militari lautrice riusciva, cos, a far emergere
il lacerante rapporto tra la cittadinanza cilena e i suoi soldati. Se vero che le Forze
Armate cilene non avevano una tradizione democratica in assoluto, perch nel
corso della storia nazionale avevano attuato pi di un colpo di stato, pure in Cile il
cittadino comune aveva stentato a credere che il golpe del 1973 avrebbe scatenato
una repressione cos feroce e disumana. Era stata proprio unanaloga lacerazione,
vissuta sulla propria pelle, che aveva indotto Patricia Verdugo, giornalista addetta
alle pubbliche relazioni presso luf cio stampa della Scuola Militare di Santiago
e, dopo il golpe, redattrice della rivista cattolica Anlisis, a schierarsi a fanco dei
perseguitati, di qualunque colore politico fossero. Anche se strettamente imparen-
tata con dei militari, in quanto sorella di un tenente e nipote di un colonnello,
Patricia Verdugo, infatti, aveva sperimentato di persona il dolore dei parenti delle
vittime della dittatura. Nel 1976 suo padre, attivista democristiano, era scomparso
da casa. Il suo cadavere era stato ripescato qualche giorno dopo nel Mapocho, il
torrente che attraversa la capitale cilena. Le autorit archiviarono il caso come sui-
cidio. Fu a quel punto che Patricia Verdugo simpegn strenuamente nella raccolta
delle prove necessarie per dimostrare che suo padre era stato sequestrato e ucciso
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 410 03/05/2013 11:11:25
411
9. Patricia Verdugo (1947-2008). Alla ricerca della verit nel Cile di Pinochet
dai militari per motivi politici. Una tesi che, nel 1991, gi in regime democratico,
non fu accolta dalla commissione incaricata di indagare sui crimini della dittatura.
Solo dopo ulteriori e faticosissime ricerche e grazie alla perseveranza di un ispetto-
re di polizia, Patricia Verdugo pot provare di avere ragione.
Queste informazioni sono contenute in Bucarest 187, la sua autobiografa
pubblicata nel 1999
123
. Cattolica e militante della Democrazia Cristiana, esente,
tuttavia, da settarismi ideologici, Patricia Verdugo vi racconta gli avvenimenti pi
signifcativi della propria inquieta vita sentimentale, afettiva e professionale colle-
gandoli alla fase storica che le tocc vivere. Negli anni Ottanta, durante i quali ci
fu una generale ripresa dellattivit politica e delle manifestazioni popolari contro
il regime militare, la giornalista intrecci profonde amicizie con la combattiva av-
vocatessa Carmen Hertz, vedova di uno dei fucilati dalla carovana della morte; con
le giornaliste comuniste Mnica Gonzlez e Marcela Otero; con Fanny Pollarolo,
medico e militante del partito comunista; con Moy de Toh, vedova del vicepresi-
dente di Allende; e con Angelica Bachelet, madre di Michelle (la ex presidenta del
Cile attuale) e vedova di un generale ucciso dai suoi stessi colleghi. Insieme a loro
costitu lassociazione Mujeres por la vida che, come prima iniziativa, fece rappre-
sentare a teatro un atto unico di protesta contro il regime. Nel 1983, come pre-
sidentessa del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, organizz la prima
manifestazione dei giornalisti che sflarono imbavagliati per sostenere la libert di
stampa. Inoltre condivise il lutto e appoggi le accuse contro il regime della nota
attrice Mara Maluenda e di Estela Ortz, rispettivamente madre e moglie di Jos
Manuel Parada, uno dei tre comunisti barbaramente uccisi dai militari nel 1985.
Nel 1988 partecip attivamente alla campagna per il No nel referendum organiz-
zato, senza successo, da Pinochet per convalidare il proprio governo.
Finita la dittatura nel 1989, nei primi anni della cosiddetta transicin a la
democracia, anticipando alcuni dei risultati a cui sarebbe giunta la Commisione
Parlamentare Rettig, che non aveva ancora pubblicato lesito delle sue indagini
sulle uccisioni e i sequestri attuati dai militari e, allo stesso tempo, incalzando-
la nello specifco del suo lavoro, Patricia Verdugo continu a pubblicare le pro-
prie inchieste giornalistiche, tra le quali, con Carmen Hertz, Operacin Siglo XX
(1990), ricostruzione della preparazione dellattentato a Pinochet, messo in atto
senza successo nel 1986 da due giovani della Santiago alto borghese, Jos Joaqun
Valenzuela Levi e Cecilia Magni Camino, divenuti guerriglieri del Frente Patritico
Manuel Rodrguez, braccio armato del partito comunista, i quali per questo furono
barbaramente trucidati dai militari. Ancor pi signifcativo furono Tiempos de das
claros. Los desaparecidos (1990), resoconto arricchito di interviste e di documenti
123 Verdugo, P. Calle Bucarest 187, Santiago del Cile, Milano, Baldini, Castoldi, Dalai, 2005.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 411 03/05/2013 11:11:25
412
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
inediti sui casi pi gravi di detenuti fatti sparire dai militari e Interferencia secreta:
11 de Septiembre 1973 (1998), un testo che rendeva pubbliche le registrazioni
degli ordini impartiti dagli alti uf ciali militari intenti alla presa della Moneda
124
.
Fino alla fne di una vita intensa, precocemente spezzata dalla malattia, dunque,
Patricia Verdugo si batt per la ricerca della verit e perch i responsabili delle
violazioni dei diritti umani fossero puniti.
Le ragioni della sua autobiografa risiedono, perci, soprattutto in questo pri-
mario obiettivo morale, ma non solo. Dal suo discorso scaturisce la necessit di
rendere conto pubblicamente della trasparenza del proprio operato, che avrebbe
potuto essere messo in ombra proprio da quel suo appartenere a una famiglia di
militari e dalle prime esperienze giornalistiche, di fatto partite dalla stessa Scuola
Militare, cuore del potere dellesercito, per approdare a una rivista che, quantun-
que per sopravvivere, si sottoponeva a una autocensura costante e oculata. In un
Paese dilaniato dalle delazioni e dalle repentine conversioni a favore dello schie-
ramento pinochetista, si pu supporre che una certa dif denza circolasse negli
ambienti dellopposizione, nonostante i riconoscimenti che lautrice si era guada-
gnata in patria e allestero. In conseguenza di ci, la verbalizzazione del proprio
vissuto e la confessione pubblica erano necessarie al fne di elaborare il lutto per
lassassinio del padre, di recuperare le forze per dimostrare che di assassinio efet-
tivamente si era trattato e di fornire la propria versione dei fatti.
Patricia Verdugo, daltra parte, apparteneva allala della Democrazia Cristia-
na che faceva riferimento a Bernardo Leighton (1909-1995), uomo di pace e di
grande onest, che, nel 1975, era rimasto gravemente ferito, insieme alla moglie,
Anita Fresno, in un attentato fascista a Roma. In confronto a buona parte degli
oppositori del regime, appartenenti allo schieramento di Unidad Popular, la sua
adesione a un partito di centro e il suo cattolicesimo le avevano s permesso di
rimanere in Cile e di continuare a esercitare la professione, pur nei limiti imposti
dalla dittatura, ma non furono suf cienti a preservarla dal vivere lo stesso dramma
dei familiari dei desaparecidos. Fu probabilmente la condivisione di questa espe-
rienza che le serv a superare qualsiasi barriera ideologica e ad allearsi con donne
di diverse tendenze politiche.
Durante la dittatura, a ispirare la sua religiosit aperta e tollerante fu anche
lattivit della Vicara de la Solidaridad, fondata nel 1976 dal cardinale Ral Sil-
va Henrquez (1907-1999) per aiutare, senza distinzioni di appartenenza politi-
ca, i perseguitati politici
125
. Allapparato legale della Vicara, tra laltro, Patricia
Verdugo fece spesso ricorso per reperire il materiale documentario necessario a
124 Verdugo, P. Golpe in diretta. Lultima battaglia di Salvador Allende e la registrazione clandestina dei
colloqui tra gli alti comandi militari, Milano, Unicopli, 1999.
125 Henriquez, P.S. Memorias, 3 voll., Santiago, Ediciones Copygraph, 1991.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 412 03/05/2013 11:11:25
413
9. Patricia Verdugo (1947-2008). Alla ricerca della verit nel Cile di Pinochet
intessere le sue inchieste. In questo contesto non privo di signifcato il fatto
che la giornalista attribuisse le ragioni della pubblicazione de Los zarpazos allo
stesso sentimento espresso da Aleksander Solenicyn, il quale riteneva suo preciso
dovere, come sopravvissuto al gulag, informare il mondo su quanto era accaduto.
Il richiamarsi al dissidente russo restringeva, dunque, la sua appartenenza a un
campo politico che escludeva il marxismo-leninismo. Ma, contemporaneamente,
lo ampliava, ascrivendolo a ragioni pi universalmente umane ed etiche, con mo-
tivazioni non dissimili da quelle che avevano indotto Primo Levi a scrivere Se que-
sto un uomo. Perci Patricia Verdugo non si astenne dallafrontare temi scottanti
come la connivenza della Casa Bianca nellorganizzazione del complotto contro
Allende e luso della tortura, che, solo nel 2003, quando lincarico di indagare
su tale pratica fu af dato dal governo alla Commissione Valech, divenne oggetto
di preoccupazione istituzionale
126
. In un Paese la cui storiografa ha cominciato
solo recentemente e con fatica ad analizzare non solo la realt politica di unepoca
oscura, ma anche il vissuto di quanti ne subirono le conseguenze, il lavoro di Pa-
tricia Verdugo costituisce quindi un prezioso apporto della memoria alla storia
127
.
La sua testimonianza acquista valore proprio perch scaturisce dal desiderio di
superare il ruolo di vittima per intraprendere quello dellaccusatrice che esige la
punizione del colpevole, con la convinzione che la giustizia, una volta fatta, con-
tribuisca alla ricomposizione di una societ divisa dalluso della violenza. In questo
progetto lassunzione di responsabilit rappresenta piuttosto un fatto individuale
che collettivo, anche se alla giornalista non fecero difetto n lo spirito diniziativa
n la capacit organizzativa necessari per raccogliere in unazione comune donne
di diversa provenienza politica che il dramma personale aveva reso pi combat-
tive
128
. Non a caso, nel 1994, Patricia Verdugo, curando la pubblicazione di una
126 Si vedano Verdugo, P. Allende. Cmo la Casa Blanca provoc su muerte, Santiago, Editorial Sudame-
ricana, 2003 (Salvador Allende: anatomia di un complotto organizzato dalla CIA, Baldini Castoldi Dalai,
Milano, 2003) e Verdugo, P. (a cura di) De la tortura (no) se habla, Santiago, Editorial Catalonia, 2004.
La Comisin Nacional sobre Prisin Poltica y Tortura, conosciuta come Comisin Valech, dal nome del
suo presidente, termin la sua indagine nel novembre 2004, dopo aver ascoltato 35.000 persone.
127 Stabili, M.R. (a cura di) Entre historias y memorias. Los desafos metodolgicos del legado reciente de
Amrica Latina, Madrid-Frankfurt, AHILA Iberoamericana Vervuert, 2007. Tra gli studi recenti di
questo tipo segnaliamo anche Rebolledo, L. Memorias del desarraigo. Testimonios de exilio y retorno
de hombres y mujeres de Chile, Editorial Catalonia, 2006 e Sagredo, R.; Gazmuri, C. (a cura di) Hi-
storia de la vida privada en Chile. El Chile contemporneo. De 1925 a nuestros das, vol. III, Santiago,
Taurus, 2008 e, in particolare, i saggi di Patricia Arancibia e Paulina Dittborn, di Leonardo Len, e
di Elizabeth Lira, ivi contenuti.
128 Come sottolinea Benedetta Calandra (Las palabras para decirlo. Le rappresentazioni della vio-
lenza sessuale nel Cile di Pinochet in Stabili, M.R. (a cura di) Violenze di genere. Storie e memorie
nellAmerica latina di fne Novecento, Roma, Ed. Nuova Cultura, 2009, p. 60) le parenti delle vittime
escono sempre pi allo scoperto e assumono ruoli di responsabilit crescente man mano che si
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 413 03/05/2013 11:11:25
414
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
serie di interviste fatte da studenti a personaggi di diverso orientamento politico
perch raccontassero come avevano vissuto la giornata del golpe del 1973, sot-
tolineava la sua intenzione di produrre, in questo modo, un efetto terapeutico.
Af dava cos al lavoro giornalistico anche il compito di aiutare gli intervistati a
verbalizzare il trauma che avevano vissuto
129
. Ma le interviste, costituendo anche
un singolare punto di incontro tra le giovani generazioni non partecipi dei fatti
(gli intervistatori) e coloro che avevano vissuto il drammatico evento venti anni
prima su fronti opposti (gli intervistati), ben interpretava il compito principale di
ogni giornalismo civile, quello di ofrire al lettore la mediazione necessaria tra la
verit efettuale e la variet delle opinioni pi diverse intorno a essa.
consolida la dittatura.
129 Verdugo, P. (a cura di) As lo viv yoChile 1973. Testimonios y entrevistas editados por Patricia
Verdugo, Santiago, Universidad Nacional Andrs Bello, 1994.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 414 03/05/2013 11:11:25
10. Somos todas Presidentas. Il potere
politico al femminile: Michelle Bachelet,
Presidente del Cile.
Maria Rosaria Stabili
La transizione politica si fnalmente conclusa e oggi entriamo nel nuovo millen-
nio; Comincia un tempo nuovo; Abbiamo ormai chiuso con lautoritarismo.
Ecco alcune afermazioni delle giovani donne che il 15 gennaio 2006 sflano nelle
strade di Santiago per celebrare la vittoria di Michelle Bachelet, prima donna Pre-
sidente nella Repubblica del Cile. Tutte quante indossano la fascia presidenziale
che si vende in migliaia di esemplari e gridano lo slogan: Somos todas Presidentas
130
.
la stessa Bachelet a dare un primo segnale di novit. Subito dopo i risul-
tati del secondo turno che lha data vincente sul candidato della destra Sebastin
Piera con quasi il 54% dei voti
131
, la Presidente eletta appare in pubblico avendo
accanto la madre e i fgli, ma nessun esponente istituzionale e neanche un rappre-
sentante dei partiti della coalizione di centro-sinistra, la Concertacin, che ne ha
appoggiato la candidatura
Sono immagini fortemente simboliche, che pongono alcune domande e suggeri-
scono alcune considerazioni. Innanzitutto, qual il senso del processo che ha reso pos-
sibile la presenza, signifcativa, di una donna al centro della scena politica nazionale?
Si pu davvero sostenere, con qualche fondamento, che un tempo nuovo si
apre con lelezione a Capo dello Stato di Michelle Bachelet, fglia di un generale
dellesercito rimasto fedele ai valori democratici dopo il golpe del 1974 ed eli-
130 El Mercurio, La Tercera, 16 gennaio 2006. I due quotidiani dedicano quasi tutte le pagine ai
risultati elettorali.
131 Cfr. Gerber, E. Comunicacin y Poltica: Anlisis de la Campaa Presidencial de Michelle Bachelet,
Portal digital de la Fundacin Friedrich Ebert en Chile, 2006, http://www.fes.cl/apublicaciones/
pubcommunicacion.html.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 415 03/05/2013 11:11:25
416
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
minato dal regime di Pinochet; lei stessa detenuta e torturata; single con fgli e
dichiaratamente agnostica? Quali sono le tensioni che segnano e attraversano il
tempo nuovo proclamato dalle sue sostenitrici? Cosa rende possibile, dopo una
prima fase di governo segnata dallaf evolirsi dellentusiasmo, un drammatico calo
di consenso che culmina nel dicembre 2007 con unaccusa di non avere polso
132
e poi una sorprendente rimonta che le consentir di arrivare alla fne del mandato
con un favore popolare che sforer l85%?
Come si spiega che la Concertacin para la Democracia, cio la coalizione di
partiti che lha sostenuta (si fa per dire) durante il suo mandato, registri oggi livelli
bassissimi tanto da veder sconftto il proprio candidato presidenziale nel secondo
turno elettorale del 17 gennaio 2010? Sebastian Piera, candidato di una coali-
zione di partiti della destra, gi battuto dalla Bachelet nelle elezioni precedenti,
ora il nuovo Presidente eletto: giunto al potere quale espressione degli interessi
del settore che pi duramente aveva contrastato le politiche della Presidenta e si
proclama portatore della tradizione pi genuina del Paese.
Rispondere a queste domande non agevole. Il governo di Bachelet il frutto
di un lungo processo il cui flo conduttore va ricercato nel lungo periodo e nel
ruolo che le donne hanno giocato nella storia recente del Paese.
Carisma e progetto socialdemocratico
Nello scenario politico gi defnitivamente postmilitarista dei sei anni corrispon-
denti al mandato di Ricardo Lagos (2000-2006) mentre il ricordo del regime di
Pinochet afondava nella vergogna e il Presidente si faceva avanti nellimmaginario
popolare con unimmagine hombre fuerte capace di restaurare le tradizioni e le
istituzioni repubblicane lafermazione di Michelle Bachelet in termini di favore
popolare e la sua scelta come candidata presidenziale da parte della Concertacin
avevano assunto uno straordinario rilievo simbolico.
La sua difusa popolarit si confgurava come lappoggio concesso alla fglia
di un generale democratico torturato sino alla morte dai militari golpisti: a una
giovane studentessa di Medicina e militante socialista clandestina, sopravvissuta
insieme con la madre a uno dei pi terribili centri di tortura del regime; a une-
siliata che rientrata in patria appena possibile si era laureata ed era diventata
madre, partecipando alla resistenza e alla lotta per la difesa dei diritti umani, nello
stesso momento in cui prestava la sua opera come pediatra a favore delle piccole
vittime della dittatura.
132 Si attesta su uno striminzito 33% di poco superiore al consenso registrato dal governo nel suo
insieme.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 416 03/05/2013 11:11:25
417
10. Somos todas Presidentas. Il potere politico al femminile: Michelle Bachelet
Nel primo decennio successivo alla fne del regime signifcava anche appoggio
a un personaggio privo di qualsiasi protagonismo politico: a una donna impegnata
nel settore pubblico come medico, specializzata in problemi della difesa nazionale
grazie a studi post-universitari nel campo delle scienze militari e disponibile alla
riconciliazione della societ cilena. E infne era dimostrazione di soddisfazione
per loperato di un ex Ministro dellamministrazione Lagos che dal dicastero della
Salute pubblica aveva gettato le basi di un programma medico nazionale, mentre
da quello della Difesa aveva collaborato con il Presidente al fne di indurre le Forze
armate a superare il pinochetismo per entrare il contatto con il resto del Paese.
Nello stesso tempo la personalit di Michelle Bachelet era stata assunta come
simbolo di una capacit di resistenza a gravi avversit e di salvaguardia della pro-
pria vitalit, dell proprio ottimismo e disponibilit sino a trasformarsi in un esem-
pio di forza carismatica per tutta la cittadinanza
133
.
Di fronte alla traiettoria vitale e alla determinazione di questa donna, nel-
la quale si riconoscevano milioni di persone, impallidivano le immagini sia del
conservatore Joaqun Lavn (malgrado la sua fama di serio gestore sociale) sia
dellesponente della sinistra radicale Hirsch (cos carente di richiamo epico presso
le masse popolari), malgrado entrambi si presentassero come personalit vitali,
aperte e ottimiste.
Solo Piera le si poteva contrapporre grazie alla sua immagine di leader con-
temporaneamente moderno e tradizionale in virt di una carriera personale cos
diversa dalla sua: quella di un imprenditore di successo, capace di provocare am-
mirazione e invidia presso milioni di elettori sia maschi che femmine.
Va per detto che la candidatura della Bachelet non era prevista dai partiti
della Concertacin, spiazzati e alquanto irritati dalla comparsa del suo nome nei
sondaggi di opinione; e ancor pi dalla crescita inspiegabile della sua popolarit.
Indiscutibilmente aveva svolto bene il suo lavoro quale Ministro della Salute e si
era rivelata anche un ottimo Ministro della Difesa durante il governo Lagos: ma
nella vita politica cilena aveva giocato un ruolo di secondo piano, senza iniziative
eclatanti o contributi teorici di respiro.
La Bachelet considerata dal suo stesso partito fragile politicamente: ma di
fronte al grande consenso popolare di cui ormai gode, Lagos (Presidente in carica e
pertanto non rieleggibile immediatamente), matura la decisione di proporla come
la candidata uf ciale della coalizione di governo: candidatura che viene conferma-
ta dalle elezioni primarie in seno alla Concertacin. Non si pu escludere che nei
133 Durante la campagna presidenziali vengono pubblicate tre biografe di Michelle Bachelet. Cfr.,
Subercaseaux, E.; Sierra, M. Michelle, Santiago, Catalonia, 2005; Guzmn Bravo, R.; Rojas Donoso,
G. La hija del tigre. Bachelet: biografa a fondo, Santiago, RIL, 2005; Insunza, A.; Ortega, J. Bachelet.
La historia no ofcial, Santiago, Debate, 2005.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 417 03/05/2013 11:11:25
418
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
calcoli di Lagos uomo forte e autoritario a cui sono stati attribuiti appellativi
come faraone e imperatore abbia avuto il suo peso la prospettiva, in caso di
successo elettorale di Michelle, di poterne infuenzare e controllare le decisioni po-
litiche al fne di poter agevolmente lavorare a una propria successiva ricandidatura.
Rimangono comunque ancora da spiegare in modo convincente i motivi del
suo successo popolare. Qui si possono per formulare alcune ipotesi. Innanzitutto
necessario andare a ritroso nel tempo.
Organizzazioni di donne di destra e di sinistra hanno animato lo scenario
politico del Paese perlomeno a partire dalla fne dellOttocento; il movimento
emancipazionista (Memch) ha visto anche la creazione, nei primi anni Cinquanta,
di un partito femminile. Nella storia recente va inoltre ricordato il lungo, quoti-
diano impegno sociale delle donne durante tutti i diciassette anni della dittatura
di Pinochet (1973-1990). Esse sono protagoniste di molte iniziative nei quartieri
poveri pi colpiti dalla crisi economica dei primi anni Ottanta e dalle politiche
repressive del regime. Sono le donne che attivano e dirigono le cosiddette orga-
nizzazioni economiche popolari e che danno vita alle associazioni in difesa dei
diritti umani. Agli inizi degli anni Ottanta, in piena dittatura, le attiviste di un
forte movimento femminista, elaborano progetti di ricerca-intervento fnanziati
da organismi e fondazioni internazionali che le vedono impegnate in una molte-
plicit di azioni di empowerment delle donne dei settori popolari. Ed proprio la
rete femminile/femminista sorta in questi anni composta da donne provenienti
da diversi gruppi sociali e portatrici di professionalit molteplici che permetter
pi tardi la candidatura dal basso della Bachelet.
Ovviamente non va trascurato il clima generale creatosi in Cile dopo quindici
anni di transizione democratica. I successi macroeconomici dei primi tre governi
della transizione, in continuit con la politica del regime militare, evidenziano le luci
e le ombre del nuovo ordine economico e sociale. La maggioranza dei cileni prende
coscienza del fatto che ha pagato e continua a pagare un prezzo molto alto per i
successi macroeconomici mentre i risultati personali sono mediocri, lontani dalle
aspettative che il libero mercato faceva sperare. Questa situazione, contraddistinta
da un sordo e crescente malessere genera movimenti che si organizzano attorno a
temi (richiesta di pari opportunit per tutti e lotta contro le disuguaglianze sociali)
che acquisiscono forte visibilit pubblica. Af orano anche altre insoddisfazioni che
hanno a che vedere con il rapido processo di cambiamento vissuto dalla societ
cilena nel suo insieme e dai suoi singoli componenti. Molte di queste inquietudini
sono collegate allerosione della dimensione collettiva e sociale nella vita quotidiana
e al sentimento di solitudine, isolamento e mancanza di protezione che tale erosione
genera. I cileni cominciano a percepire la propria fragilit; aumenta la tristezza per
la mancanza di vincoli disinteressati che mitighino le incertezze e confortino in caso
di dif colt; e si cominciano a porre nuove domande.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 418 03/05/2013 11:11:25
419
10. Somos todas Presidentas. Il potere politico al femminile: Michelle Bachelet
Per primeggiare nel contesto latinoamericano e mondiale devono essere anco-
ra pi fessibili, anche a costo di aumentare il proprio sentimento di insicurezza,
oppure meglio progredire pi lentamente riducendo la pressione che li corrode?
In altri termini il Paese deve seguire il percorso di quei paesi industrializzati nei
quali la prosperit entra in confitto con gli indici di felicit oppure preferibile
tentare un percorso diverso se c il rischio di fnire in una strada senza uscita?
Anche per questo, forse, i cileni si orientano verso una leader pi concreta e
quotidiana, meno dirigista e pi conciliante, meno autoritaria e pi partecipativa,
meno impegnata sul fronte delle politiche strutturali e pi attenta al benessere
delle persone. I gesti informali della Bachelet, il suo volto sorridente e il saluto
amichevole della sua mano, ma soprattutto le promesse di un governo a parte-
cipazione cittadina composto di politici nuovi e rispettoso, nei numeri, della
parit di genere, la connotano come una futura Presidente simpatica e facilmente
avvicinabile, una fgura materna che fa intravedere il possibile soddisfacimento
della richiesta popolare di misure di protezione sociale e di pari opportunit per
tutti. Il fascino di Michelle, soprattutto dopo tre governi di transizione demo-
cratica gestita da uomini che hanno adombrato la fgura del padre autoritario,
fa convergere sul suo nome le preferenze anche di una buona parte delle donne
tradizionalmente di destra.
Cos si esprime:
La mia candidatura si fece avanti spontaneamente grazie allappoggio dei cittadi-
ni. Non nacque grazie a negoziati dietro porte chiuse, n in seguito a un conclave
di partito. Il mio programma rifette lorigine della mia candidatura. [] un
programma elaborato in base alle necessit dei cileni che non si esprimono sui
giornali o alla televisione; che non possono rivolgersi allo studio di un avvocato
importante; che non hanno parenti n entrature nelle strutture pubbliche, in
Parlamento, nei sindacati o nei corridoi del potere. [] Il mio impegno a consul-
tare e coinvolgere la gente comune stato molto criticato. Per le lites ascoltare
considerato un segno di debolezza. Io, al contrario, sono convinta che proprio da
l proviene la forza di quello che stiamo facendo
134
.
In questo modo la candidata si propone sia come la continuatrice delle con-
quiste che avevano caratterizzato i governi precedenti della Concertacin sia come
la rappresentante di una cittadinanza stanca della concentrazione di potere nelle
mani di una lite politica che aveva pesantemente egemonizzato la lunga transizio-
ne verso la democrazia culminata nellamministrazione Lagos.
134 Bachelet, M. Carta a los chilenos, in Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2006-2006.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 419 03/05/2013 11:11:25
420
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
Bachelet colloca la questione sociale al centro della campagna presidenziale,
sino a fare del tema delle disuguaglianze di redditi, risorse e opportunit uno dei
punti qualifcanti del suo futuro programma di governo
135
.
Il Cile continua a essere un paese con molte inaccettabili disuguaglianze: fra
uomini e donne, fra le diverse etnie, fra i ricchi e i poveri, tra le grandi e le piccole
imprese, fra coloro che hanno avuto accesso a unistruzione qualifcata e coloro
che non lhanno avuto, fra le regioni che progrediscono e quelle che restano in-
dietro. Una delle ragioni dessere dei governi della Concertacin stata la dimi-
nuzione di queste disuguaglianze. Ci siamo sforzati di correggere il modello di
crescita, di umanizzarlo e ridurre le incertezze ad esso connesse, al fne di ottenere
un migliore equilibrio fra espansione economica ed equit sociale. Malgrado i
progressi che sono evidenti a tutti, per, lobiettivo non stato totalmente rag-
giunto. Quanto pi abbiamo perseguito la piena integrazione del paese, tanto
pi emersa lurgenza di ridurre le disuguaglianze e di difendere la nostra gente
attraverso una rete di protezione sociale dagli shock che colpiscono leconomia
internazionale.
136
Questa nuova rete di protezione sociale diventa la principale proposta pro-
grammatica della candidata che articola in una serie di priorit necessarie:
1. aumentare gli investimenti nellistruzione pubblica e migliorarne la qualit;
2. compiere un balzo gigantesco nella protezione sociale mediante una riforma
a fondo del sistema assicurativo, destinato a consentire migliori pensioni,
indennit di disoccupazione pi generose e standard minimi di assistenza
medica per tutti;
3. garantire una continuit nella politica economica per procedere con sicurez-
za verso uno sviluppo [] basato sulla seriet e sullequilibrio budgetario;
4. modifcare il sistema elettorale e procedere a una riforma dello Stato orientata
verso la trasparenza e il decentramento.
A tutto questo, si aggiunge un forte impegno in direzione di una tutela dei
diritti delle donne e la promessa di un governo con partecipazione paritaria dei
due generi
137
.
Come abbiamo gi ricordato, le donne cilene scendono in strada nel pome-
riggio del trionfo di Michelle Bachelet, con la banda presidencial sul petto per
135 Ibidem. Il programma della Bachelet era organizzato su tre grandi proposte: un grande sistema
di protezione sociale dalla culla alla terza et, lo stimolo per l innovazione, e il raforzamento di una
democrazia capace di coinvolgere e rappresentare tutti i cileni.
136 Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2006-2006, p. 8.
137 Bachelet, M. Carta a los chilenos cit., pp. 4-5.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 420 03/05/2013 11:11:25
421
10. Somos todas Presidentas. Il potere politico al femminile: Michelle Bachelet
esternare il loro desiderio di un trasferimento di potere dalle lite ai cittadini,
secondo lorientamento che si era andato sempre pi raforzando nel corso della
campagna e per sottolineare la convinzione che la persona sul punto di assumere
il pi elevato incarico istituzionale una di loro.
Le manifestazioni di quel pomeriggio e le successive che avrebbero accompa-
gnato lingresso di Michelle nel palazzo presidenziale sono le espressioni pi en-
tusiastiche di giubilo popolare dopo quelle che celebrarono la fne della dittatura
fra il 1988 e il 1990.
Cominciano cos i quattro anni che avrebbero posto a dura prova la capacit
di Michelle e della Concertacin di conservare quellentusiasmo e quelladesio-
ne popolare mentre il governo impegnato nella dif cile impresa di non venir
meno alle aspettative suscitate durante la campagna presidenziale, a dispetto degli
ostacoli rappresentati dalla persistenza di una struttura socioeconomica ancora
caratterizzata da forti disuguaglianze e da un quadro istituzionale sempre viziato
dal predominio delle vecchie lite.
Un governo al femminile
Sono le prime azioni del nuovo governo che vuole introdurre elementi di disconti-
nuit verso il passato a produrre i primi timori iniziali in una parte dellelettorato
della Presidenta a far riemergere fra i suoi compagni di coalizione rigurgiti di
maschilismo, solo faticosamente tenuti a bada durante la campagna elettorale.
La Bachelet forma il suo primo gabinetto ministeriale senza tener conto dei
suggerimenti e delle pressioni che vengono dalle segreterie dei partiti della Concer-
tacin (che sono informati della lista dei ministri soltanto qualche minuto prima
della conferenza stampa) e senza risparmiare altre sgradevoli sorprese ad alcuni
dei suoi pi vicini sostenitori durante la campagna elettorale (che non ottengono
nessun dicastero). Daltra parte Michelle non sente di dover nulla ad alcun partito
politico della coalizione e mantiene la promessa di una composizione ministeriale
che rispetta nei numeri la parit di genere e la presenza di una nuova generazione.
Purtroppo, tra i ministri, alcuni volti nuovi e alcune fgure femminili non spicca-
no per esperienza politica n per particolari capacit di gestione dei rapporti istitu-
zionali che si proflano inevitabilmente complessi. Il processo di pensionamento
politico di alcuni esponenti di rilievo della coalizione a cui d avvio e la sua presa
di distanza rispetto alle tensioni interne ai partiti di centro-sinistra creano per
subito dif colt e rendono necessario un primo rimpasto dopo soli quattro mesi
dallinsediamento.
Il programma di riforme sociali che prevede numerose iniziative per favorire
una maggiore redistribuzione del reddito e misure incisive di protezione sociale,
non favorisce certo la simpatia dei circoli economici e fnanziari che esprimono
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 421 03/05/2013 11:11:25
422
Capitolo 8. Il protagonismo delle donne nellAmerica Latina del Novecento
senza mezzi termini il loro dissenso e si muovono in modo da rallentare note-
volmente la marcia delle iniziative previste. Lapparente incapacit del governo a
procedere speditamente nella direzione annunciata scatena alla fne anche linsof-
ferenza sociale.
La cosiddetta rivoluzione dei pinguini (ossia la protesta degli studenti delle
scuole secondarie pubbliche, appoggiati dagli studenti di quelle private) esplode
nellautunno del 2006 con forza imprevedibile e sottolinea lurgenza di una rifor-
ma del sistema educativo vigente, che af anca a un settore pubblico per i ragazzi
dei ceti medi e popolari, un sistema educativo privato in mani imprenditoriali che
garantisce ai fgli delle famiglie ricche le migliori universit sia in Cile sia alle-
stero. Si tenta lapertura di un dialogo, ma laccordo tarda ad arrivare, mentre gli
studenti enfatizzano che il problema va al di l dellassegnazione di nuove risorse
fnanziarie e trae alimento soprattutto da un difuso sentimento di vulnerabilit
e disagio.
La vicenda acutizza il malcontento generale e ofre alla destra loccasione,
veramente ghiotta, per scatenare una raf ca di critiche anche su altri temi sociali.
Alcune delle contestazioni pi aspre riguardano lapplicazione del denominato
Plan Transantiago: iniziativa che cambia la struttura del sistema dei trasporti pub-
blici nellarea metropolitana della capitale, progettato dal governo di Lagos ma
non realizzato prima della fne del suo mandato. Ereditato dalla Bachelet, il Plan
Transantiago viene applicato nel febbraio 2007, ma si rivela un auto-gol. Infatti la
realizzazione del progetto che pure, giustamente, accoglie una domanda storica
molto sentita come quella della modernizzazione del trasporto urbano di Santiago
viziata da molti errori. Cos lesordio del nuovo sistema si traduce in lunghissi-
me code alle fermate degli autobus, tempi di percorso doppi e tripli rispetto al pas-
sato e gravi disagi soprattutto per gli abitanti delle zone pi periferiche. In Parla-
mento, esponenti di spicco della Democrazia cristiana votano, assieme alla destra,
contro un ulteriore fnanziamento per correggere gli errori del piano e mettono
in crisi la maggioranza parlamentare. Lassenza di copertura fnanziaria necessaria
per correggere in tempi brevi gli errori del piano, fanno lievitare lo scontento e la
rabbia dei cittadini e spiegano il calo drammatico di consenso nei confronti del
governo. Intanto, lespulsione dalla Democrazia cristiana di esponenti di vecchia
data e assai prestigiosi, mettono in evidenza la profonda crisi che attraversa quel
partito e, di conseguenza, anche il grave deterioramento delle relazioni allinterno
della coalizione di governo la cui responsabilit viene da pi parti addossata alla
presidente della Repubblica. Le si addebitano la mancanza di visione strategica e
lincapacit di far fronte in modo adeguato alla situazione di crisi che si creata.
Laccusa di mancanza di concretezza trova facile eco nella zona grigia della popo-
lazione, e ofre il destro allopposizione ma anche a parte della Concertacin per
dire che, in Cile, non c un governo.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 422 03/05/2013 11:11:25
423
10. Somos todas Presidentas. Il potere politico al femminile: Michelle Bachelet
Cos, da un lato, si chiede alla Bachelet di essere la grande madre del Cile
e dallaltro si esige da lei che si metta i pantaloni e assuma un piglio autoritario
tutto maschile, nello stile del presidente che lha preceduta.. In realt, si alla
presenza di una serie di nodi connessi a una crisi di rappresentativit del sistema
politico, dovuta essenzialmente allorigine autoritaria dello stesso (Costituzione
pinochettista dell80) e agli elementi di continuit profonda con il passato rima-
sti in sonno durante i primi quindici anni di transizione democratica. Bachelet
decide di resistere e afronta di petto i primi due anni di disorientamento non
lasciandosi distogliere dalle pesanti critiche. Cos dopo vari rimpasti della com-
pagine governativa e alcune concessioni alle segreterie dei partiti, riesce a ripren-
dere in mano la situazione e a realizzare tutti i punti del suo programma relativi
alla questione sociale. Loculata gestione degli enormi introiti derivanti dallalto
prezzo del rame sul mercato internazionale (il Cile il primo produttore mondiale
di questa materia prima) le permette, da un lato, di contenere la crisi economica
internazionale (che tocca solo tangenzialmente il Paese) tanto da guadagnarsi il
rispetto dei circoli economici che inizialmente si erano opposti alla sua politica e,
dallaltro, di fnanziare i suoi programmi sociali.
Il riconoscimento del suo ruolo equilibratore in politica estera, soprattutto
a livello regionale, completa il quadro del suo successo sul fnire del mandato, che
spiega laltissimo consenso, quasi plebiscitario, con cui riesce a concludere il suo
periodo presidenziale. per un successo personale, suo e del gruppo di giovani
donne e uomini che lhanno accompagnata; mentre la coalizione di partiti che
costituiva la sua maggioranza annega in una crisi profonda e dopo ventanni di
governo ininterrotto costretta a cedere le redini del potere a quelli che sono de-
fniti i nipotini di Pinochet.
Un passo indietro, dunque. Ma la storia non segue mai un percorso lineare e
progressivo. Ed forse troppo presto per valutare il senso e soprattutto il segno di
genere che il governo di Michelle Bachelet lascia dietro di s e nella storia politica
del Cile.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 423 03/05/2013 11:11:25
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 424 03/05/2013 11:11:25
CAPITOLO 9
Le sde del nuovo millennio in Nord
Africa e Medio Oriente: gender,
dinamiche socio-culturali, processi di
trasformazione politica ed economica
a cura di Anna Maria Di Tolla ed Ersilia Francesca
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 425 03/05/2013 11:11:26
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 426 03/05/2013 11:11:26
Introduzione
Anna Maria Di Tolla ed Ersilia Francesca
Lidea di presentare al Convegno Nuove frontiere per la storia di genere, organizzato
dalla Societ Italiana delle Storiche (Napoli, 28-30 gennaio 2010), un panel sulle
dinamiche socio-culturali di genere e sulle trasformazioni politiche ed economi-
che in Nord Africa e Medio Oriente nasceva dallesigenza di analizzare alcuni
aspetti chiave per la comprensione della condizione femminile in questarea, come
i rapporti allinterno della famiglia, lincidenza del fondamentalismo islamico e
delle politiche dei governi, il lavoro e i processi di migrazione. In questa sezione
degli Atti riprendiamo gli obiettivi e gran parte dei contributi del panel da noi
presentato.
Gli Stati del Nord Africa e del Medio Oriente si trovano oggi ad afrontare
una serie di soferte trasformazioni politiche, sociali ed economiche che implicano
un maggior divario fra ricchi e poveri, laumento della disoccupazione giovanile
e femminile e una rinascita del fondamentalismo islamico. Tutto ci ha fatto ri-
emergere una strisciante discriminazione nei confronti delle donne, bench dal
dopoguerra ad oggi, i governi di tali Stati abbiano implementato politiche per
favorire luguaglianza di genere in ambito civile, politico ed economico e per pro-
muovere la partecipazione attiva delle donne alla vita della societ. La condizione
femminile nel contesto islamico viene descritta, spesso, usando i concetti di mo-
dernit e tradizione, implicando, con il primo, le riforme in senso occidentale
attuate dal dopoguerra in poi e con il secondo, il ruolo di contenimento rappre-
sentato dalla religione islamica e dal modello patriarcale. La situazione , per,
ben pi complessa e sfaccettata di quanto una lettura in termini di dicotomia fra
modernit e tradizione farebbe supporre. Non solo nellambito della tradizio-
ne si possono sviluppare modelli di autodeterminazione femminile, ad esempio
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 427 03/05/2013 11:11:26
428
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
attraverso una rilettura delle fonti, ma alcuni aspetti della modernit, come la
tanto decantata globalizzazione, possono avere ripercussioni sul ruolo femminile
che annullano, in parte, i processi di emancipazione.
Tassadit Yacine nel suo contributo (Donne del Nord Africa: discorsi, pratiche e
rappresentazioni), che apre la prima parte della sezione dal titolo: Stato, famiglia
e religione, si interroga su come le donne berbere algerine interpretIno la mo-
dernit e sul ruolo della mondializzazione nella loro integrazione (o esclusione)
dai processi di creazione e circolazione delle idee a partire dai miti di fondazione
della Cabilia. Lautrice dimostra come le donne sviluppino modelli sociali che
valorizzano la loro identit di genere e che contraddicono, in certe situazioni,
quelli impliciti nei sistemi politici e giuridici dominanti che sono prettamente
maschili. Proprio lo studio delle identit delle popolazioni autoctone del Nord
Africa pu aiutare a comprendere le molteplici ripercussioni della globalizzazione
sulle relazioni di genere. Lidentit berbera percepita come compatibile con i
valori della laicit, dellautodeterminazione della donna, dellaccoglimento della
pluralit e della multiculturalit, laddove lordine predominante monoculturale,
basato su islam e arabismo, un elemento di oppressione e di omogeneizzazione.
Questo lo spunto di partenza del contributo di Anna Maria Di Tolla (Emancipa-
zione, movimenti di protesta femminili e globalizzazione in Nord Africa). Laccento
posto dalle due autrici sullidentit berbera non deve sminuire il ruolo svolto dai
movimenti di liberazione nazionale e dalla formazione degli Stati-Nazione del
Nord Africa che si sono caratterizzati anche per una politica di apertura nei con-
fronti delle donne. Sono stati loro riconosciuti una serie di diritti (partecipazione
politica, istruzione, lavoro) mentre la modernizzazione del diritto di famiglia ha
notevolmente ridotto lincidenza della poligamia e del ripudio, istituti che, tradi-
zionalmente, relegavano la donna in una posizione subalterna rispetto alluomo.
Questa sorta di femminismo di Stato ha fatto s che, sempre pi donne siano
diventate protagoniste attive della vita politica e sociale, contribuendo non poco
alla crescita nazionale.
Tuttavia, questa apertura stata limitata e, come sottolinea Valeria Guasco
nel suo contributo (Le algerine e la guerra di liberazione nazionale: laccesso delle
donne nello spazio pubblico), le stesse donne che hanno partecipato attivamente ai
movimenti di liberazione nazionale, hanno visto riconosciuti solo parzialmente i
loro diritti nella sfera pubblica e continuano a essere discriminate in quella pri-
vata. Questo vale, in special modo, per il diritto di famiglia che, insieme a quello
delle successioni, perpetua un modello familiare in cui le donne sono subordinate
agli uomini. La connotazione islamica di tali ambiti del diritto, che costituiscono
baluardi inaferrabili della legge religiosa, la shara, alimenta la resistenza dei tradi-
zionali dogmi antifemminili e ofre il contesto culturale e legale in cui legittimare
o integrare le pratiche patriarcali che rallentano i mutamenti. Pesa su questo il
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 428 03/05/2013 11:11:26
429
Introduzione
rapporto biunivoco esistente tra famiglia e societ: la famiglia, cellula primaria
della societ, ne rispecchia la struttura gerarchica; daltro canto, lorganizzazione
familiare in grado di condizionare la percezione che gli individui hanno di se
stessi e del loro ruolo allinterno delle formazioni sociali e dei modi in cui i rappor-
ti di potere si costruiscono. Tra i maggiori elementi di dif denza soprattutto per
un occidentale nei confronti del mondo islamico c il complesso rapporto tra
religione, tradizione e cultura patriarcale. Lislam considerato la principale causa
del perpetuarsi di disuguaglianze di genere. Tuttavia, riconoscere la complessit e
leterogeneit del mondo islamico, insieme alluso strumentale e demagogico di
cui lislam, come religione e come discorso politico, sovente fatto oggetto sgom-
bra il campo da conclusioni semplicistiche e approssimative e costituisce il presup-
posto fondamentale per una seria indagine scientifca. Ad esempio, se i movimenti
fondamentalisti islamici si propongono come fautori di un ritorno alla tradizione
e teorizzano una netta diferenziazione di ruoli tra uomini e donne, le femministe
islamiche, soprattutto nellultimo decennio, propongono una diversa analisi in-
terna allislam dei rapporti di genere. Esse sono convinte che il riscatto femminile
passi per una reinterpretazione di norme religiose sfavorevoli alle donne formatesi
nei secoli a causa di un lavoro esegetico di appannaggio esclusivamente maschile.
Luguaglianza di diritti e doveri tra uomini e donne non solo compatibile con il
discorso religioso islamico, ma anzi ne parte integrante. Esse afermano la neu-
tralit del Corano e luniversalit dei suoi principi religiosi e morali di fronte alla
loro applicazione infuenzata dalle pratiche sociali vigenti.
Di femminismo islamico si occupano i contributi di Sara Borrillo (Il femmi-
nismo islamico e il caso delle murshidt in Marocco) e di Leila Karami Nogurami
(Rifessioni sul femminismo islamico in Iran: voci, temi, strategie e fnalit), pren-
dendo in considerazione il primo il caso delle predicatrici marocchine e la vessata
questione se le donne musulmane possano ricoprire la carica di imm, e il secondo
il tema delle teologhe musulmane in Iran che propongono una lettura islamica di
genere diversa da quella uf ciale dello Stato teocratico.
Nella seconda parte Lavoro e immigrazione si esaminano, sotto diversi
punti di vista, limpatto dei processi di globalizzazione economica sui rapporti
di genere negli ultimi decenni e le loro ripercussioni sul mercato del lavoro. Gli
stati arabi, nati dalla lotta contro il colonialismo, non hanno retto allurto con
la globalizzazione e il neoliberismo. Come messo in luce da pi parti, si assiste
oggi al fallimento dellobiettivo primario dei piani di aggiustamento strutturale
in Nord Africa e Medio Oriente (comprese le privatizzazioni e la riduzione delle
sovvenzioni statali) e degli accordi di libero scambio: incentivare gli investimenti
e la creazione di nuove imprese, facendo cos emergere nuove classi medie che, in
simbiosi con altre forze nazionali e internazionali, avrebbero avviato lintera area
sulla strada del dinamismo economico e della democrazia. Sul piano economico,
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 429 03/05/2013 11:11:26
430
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
se le politiche neoliberiste hanno stimolato la crescita, non hanno per trasfor-
mato i Paesi dellarea in elementi dinamici delleconomia mondiale e non hanno
alleggerito n la miseria n le ingiustizie sociali. Se da una parte i Paesi petroliferi
sono estremamente ricchi e fanno sentire il loro peso nei mercati internazionali
con strumenti quali i fondi sovrani, la maggioranza dei Paesi arabi continua a
confrontarsi con il problema della povert e della diseguaglianza.
Come sottolineano gli articoli di Ersilia Francesca (Formale o informale? Di-
namiche delloccupazione femminile nellarea MENA) e di Claudia Corsi (Gender e
riforme economiche in Giordania), il processo di globalizzazione ha avuto rilevanti
conseguenze sulle disparit di genere. Almeno nel breve periodo, le politiche di
aggiustamento strutturale hanno portato alla crescita della disoccupazione femmi-
nile a seguito del maggior peso del settore privato che, tradizionalmente, privilegia
lassunzione maschile. Si assiste dunque a una marginalizzazione delle donne nel
mondo del lavoro, mentre accanto a una proliferazione di associazioni impegnate,
a vario livello, nella promozione del ruolo delle donne, si riscontrano manipola-
zioni delle questioni di gender da parte dello stato, dei partiti politici dominati
dalla presenza maschile, del fondamentalismo islamico, al fne di convogliare le
energie femminili verso i valori tradizionali della famiglia e della religione.
Lingresso delle donne nel mercato del lavoro un tema centrale negli Stati
del Nord Africa e in Medio Oriente e non va sottovalutato, infatti, il rapporto
esistente tra sottoccupazione femminile e povert in questarea, come evidenzia
Valentina Venditti (Economia delloccupazione in Palestina: genere, lavori informali
e Income Generating Projects) esaminando la questione dei territori palestinesi oc-
cupati e dei progetti di riqualifcazione lavorativa destinati alle donne. Nellarea
qui analizzata, come in molte altre regioni del mondo, svariati fattori scoraggiano
lingresso delle donne nel mercato del lavoro. Lassunto che luomo sia tenuto a
provvedere ai bisogni della famiglia, la convinzione che il lavoro femminile abbia
un ruolo secondario nel budget familiare e il peso che si riconosce ai compiti
tradizionali femminili nellambito della famiglia con cui il lavoro extradomestico
deve risultare conciliabile, sono tutti elementi deterrenti per laccesso alle donne
nel mondo del lavoro.
Da sempre, il lavoro ha rappresentato un elemento di riscatto e di cambia-
mento per le donne, soprattutto se si associa allemigrazione e a un contesto socio-
culturale completamente diverso da quello di origine. questo il caso delle donne
turche emigrate in Europa negli anni Sessanta studiato nel contributo di Lea No-
cera (Mani da manicure preparano bobine elettriche: La partecipazione femmini-
le alla migrazione turca in Germania Occidentale). Le motivazioni delle migranti
turche fanno superare lo stereotipo di donne vittime di un sistema patriarcale dai
tratti profondamente arcaici e religiosi, sostituendolo con limmagine di giovani
donne che partono inseguendo il loro sogno, alla ricerca di un futuro migliore.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 430 03/05/2013 11:11:26
431
Introduzione
Nel presentare questa sezione, non ci proponiamo di ofrire un quadro esau-
stivo delle dinamiche di genere in Nord Africa e in Medio Oriente. Gli aspetti
analizzati ci sono sembrati signifcativi per illustrare i processi di rappresentazio-
ne e autorappresentazione e in che maniera, di fronte ai grandi cambiamenti in
atto, le donne reagiscono. La condizione delle donne in Nord Africa e in Medio
Oriente non si pu esemplifcare in termini di discriminazione e di subordinazio-
ne. Si tratta di realt molto pi complesse, poich i fattori che entrano in gioco
sono numerosi: se da una parte, la religione, le strutture patriarcali e le tradizioni
hanno un peso rilevante nelle dinamiche di genere, dallaltra, le politiche degli
Stati ne sono infuenzate ma, contemporaneamente, ne fanno un uso strumentale
per perpetuare un ordine prettamente maschile. Tanto le tradizioni berbere che il
femminismo islamico mostrano come si possono avere approdi diversi allanalisi
di genere, pur avendo radici comuni e utilizzando le stesse fonti e gli stessi stru-
menti. I processi di modernizzazione e di globalizzazione che hanno fatto scaturire
le questioni di genere in Nord Africa e Medio Oriente si prestano a una doppia
lettura. Se da un lato, hanno dato spazio ai diritti delle donne in campo politico,
sociale ed economico, dallaltro, hanno fatto emergere nuove e striscianti forme
di discriminazione nei confronti delle donne. Le prospettive di analisi che cos si
aprono superano le categorie di modernit e tradizione e ofrono nuovi spunti
di rifessione e di ricerca sulle dinamiche di genere e sui processi di trasformazione
socio-politici ed economici in Nord Africa e Medio Oriente.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 431 03/05/2013 11:11:26
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 432 03/05/2013 11:11:26
1. Donne del Nord Africa: discorso, pratiche
e rappresentazioni
Tassadit Yacine
Questa comunicazione sulle donne musulmane deve essere considerata come un
approccio alla conoscenza della civilt piuttosto che lespressione di un dogma.
Partir dallesempio dei berberi (popolazioni del Nordafrica) che sono tra gli abitan-
ti pi antichi dellarea mediterranea (e sahariana) e che hanno conservato la lingua,
nonostante limposizione delle lingue scritte ed erudite, quali il greco, il latino e pi
tardi larabo. Queste ultime sono diventate molto presto le lingue utilizzate dal po-
tere e dalla politica, seguendo lantico modello della lingua punica. Bisogna dire che
le lingue autoctone (e dunque le civilt delle quali erano espressione) sono realmente
scomparse, perch si presumeva non conoscessero la scrittura.
Il berbero stato praticamente trasmesso soltanto oralmente, anche se ha co-
nosciuto un periodo in cui veniva praticata la scrittura. Di questo periodo antico, le
testimonianze attestano, attraverso le incisioni su pietra, che la scrittura era difusa
in tutto il Nord Africa; e ancora oggi tale pratica difusa presso i Tuareg del Sahara.
Lesempio della scrittura in s signifcativo, allo scopo di riformulare le idee
sulla condizione femminile, poich come la lingua e le pratiche di questo terri-
torio, anche le donne hanno da sempre partecipato allo sviluppo delle civilt di
questarea. Lanalisi del loro ruolo nellislam moderno richiede una rivisitazione
del loro lungo percorso storico, che sarebbe interessante analizzare, poich per-
metterebbe di indagare un contesto politico e sociale che non omogeneo, ma
segnato da una pluralit di pratiche
1
.
1 Yacine, T. Les Kabyles. Elments pour la comprhension de lidentit berbre en Algrie, Paris,
AGDM, 1992.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 433 03/05/2013 11:11:26
434
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
Lambiguit e la complessit di questo contesto induce a riconsiderare in ma-
niera diversa lancoraggio storico dellevoluzione dei modi di pensare e di agire in
questo territorio. Se le donne costituiscono una sfda nelle lotte per il potere, ci
che le spinge ad adottare lislam dogmatico, non sempre stato cos. Lislam delle
confraternite, ad esempio, stato pi tollerante, poich, pur contrassegnando gli
spazi (maschili e femminili), aveva concesso un posto di rilievo alla cultura vissu-
ta
2
. In questa comunicazione, cercher di analizzare alcuni aspetti del mito e il
singolare ruolo delle donne nella mitologia berbera. Se, in partenza, questo mol-
to importante e unico, in seguito non lo sar pi. Dunque, ci saranno due tempi:
il primo sarebbe quello del ruolo straordinario delle donne e il secondo, quello in
cui la donna lo concede agli uomini.
Infatti, i miti dorigine della Cabilia collocano la donna nella posizione di
creatore. la madre del mondo, ha partorito luniverso, poich d vita alla sua
progenie. Questo primo mondo un mondo incantato. Tutto magico: gli umani
non lavorano e non conoscono alcuna costrizione. Questo universo coerente e
funzionale, del resto, non tarda a perdere il suo equilibrio. La madre del mondo,
ritornando dalla foresta, si era lasciata sfuggire un peto: grave ingiuria alluniverso
e agli umani. Questo inadempimento della convenienza la releg al rango di vec-
chia strega: simbolicamente, lei ha partecipato a disilludere il mondo.
Un altro mito sullorigine mostra come le posizioni sessuali stesse non siano
prive di signifcato: in partenza, erano le donne ad avere il potere di dare la caccia
agli uomini e sarebbero state le donne ad aver iniziato allamore gli uomini. Sar
sul limite di una fontana che la prima donna prende il primo uomo
3
. Da
quellepisodio si data la loro prima relazione (si dalla parte dellumido, per dirla
con gli strutturalisti). Luomo, preso dal piacere, costru una capanna e invit la
donna a recarvisi (e nella capanna la preg di mettersi sotto di lui); poi, avendo
assaporato il piacere, si rifut di scendere. Le disse: Alla fontana, tu gestivi la
casa e io governavo; da quando gli uomini sono rimasti sopra, non hanno pi
lasciato il potere. Questa posizione preliminare servir, successivamente, a tutto
lambiente: gli oggetti, la natura, ecc. La macina, ad esempio, costituita di due
parti: la parte superiore attiva maschile e la parte inferiore femminile, passiva
e immobile.
Laltro momento quello in cui si vedono le donne punite, a causa dei loro
comportamenti, ed , in un certo qual modo, la loro moralit o la loro assenza di
moralit a costituire la ragione della loro esclusione dal campo sociale: Dio avreb-
be dato tre borse a una ragazza (una di pidocchi, unaltra con la terra e una borsa
2 Yacine, T. Posie berbre et identit: Qasi Udifella hraut des At Sidi Braham, Paris, Maison des
Sciences de lHomme, 1987.
3 Yacine, T. Les voleurs de feu, Paris, La Dcouverte, 1993.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 434 03/05/2013 11:11:26
435
1. Donne del Nord Africa: discorso, pratiche e rappresentazioni
di luigi doro) da af dare, nel seguente ordine, ai francesi, agli arabi e ai cabili.
La ragazza si sbagli e invert lordine. I francesi benefciarono delloro, ed per
questo che sono capitalisti, gli Arabi sono certamente poveri, ma benefciano delle
pianure (coltivano cereali) e i cabili sono molto poveri: non hanno nulla, soltanto
pidocchi. La ragazza fu dipinta di nero e Dio la trasform in corvo, condannata a
errare gridando: mi sono sbagliata, mi sono sbagliata. Le donne, da allora, non
hanno il diritto di andare al mercato ed stata loro ritirata ogni fducia. Le reli-
gioni monoteiste hanno imposto il loro dogma su questa base di credenze. Non
stato dif cile, certo, il terreno era, per cos dire, pronto per le leggende, i racconti
e i miti. Ma bisogna chiedersi: cosa scomparso dallo strato precedente?
Nella pratica, nonostante la presenza ebrea, cristiana e musulmana, le donne
non sono rimaste sulla scena solo come massa indistinta, ma alcune hanno segnato
la storia
4
. avvenuto lo stesso fenomeno con lislam, che, fno agli anni Cinquan-
ta, sar costretto, bene o male, a tener conto dei costumi locali che, in alcune re-
gioni, accordavano uno statuto alle donne che sono potute emergere dalla massa:
le sante locali (numerose in Marocco e nel Sahara), le donne che hanno svolto un
ruolo nelle lotte di liberazione, le guaritrici, le cantanti, le poetesse, le veggenti,
ecc.
5
. ovvio che si tratta di personalit di eccezione; a ogni modo, si tratta di
ruoli lasciati alle donne per esercitare funzioni, come nel caso delle confraternite
religiose. Questo spazio si ridurr con la colonizzazione nonostante laccesso del-
le ragazze a scuola e il ritorno dellislam ai fondamenti profetici. Si esce, dunque,
da una posizione dominata ma sacra a unaltra in cui le donne sono integrate in un
universo che le condanna a riformarsi, rinunciando alle loro credenze e alla loro
storia locale. Le donne algerine, ad esempio, fungeranno da punto dappoggio per
comprendere ci che avviene nei Paesi del Nord Africa. Questa sovrapposizione
non assunta da molte culture ereditate dalla loro storia plurale partecipa non a una
emancipazione delle donne ma, al contrario, fa da pretesto alla loro inferiorit
6
.
Percepite come subalterne soggette alla perfezione agli uomini, le donne de-
vono, in un certo qual modo, rinunciare alla loro identit culturale per raforzare
la comunit maschile (simbolo della comunit nel suo insieme). Questo lavoro di
separazione tra il laico e il religioso, tra la cultura ereditata dal Nord Africa antico
e quella che imporranno i vari poteri, non stato mai fatto. su questa base che
occorre riconsiderare la politica degli islamisti (i quali vorrebbero ritornare al fon-
damento dellislam perch questo corpo quello delle donne in un certo qual
modo snaturato) e quella dei poteri nazionali che, in un certo senso, diversa in ap-
4 Camps, G. LAfrique du Nord au fminin, Paris, Perrin, 1992.
5 Yacine, T. Chacal ou la ruse des domins, Paris, Paris, La Dcouverte, 2001.
6 Yacine, T. Si tu maimes, guris-moi: tudes dethnologie des afects en Kabylie, Paris, Maison des
Sciences de lHomme, 2006.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 435 03/05/2013 11:11:26
436
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
parenza, non riconosce il contributo delle donne nelle citt. In che modo le donne
attualmente gestiscono lo spazio ristretto che loro assegnato? Accettano bene (o
con costrizioni) le decisioni che prendono solo gli uomini? Quale visione hanno le
donne di una modernit in cui esse si sentono escluse dalla cultura e dallambito
economico? Qual il contributo della globalizzazione alla loro integrazione (o
esclusione) nella circolazione delle idee? Queste sono alcune delle questioni alle
quali gli studi attuali dovranno rispondere.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 436 03/05/2013 11:11:26
2. Nuovi movimenti socio-politici e processi
di emancipazione femminile in Nord Africa
Anna Maria Di Tolla
La condizione delle donne basata sulla tradizione mediterranea del patriarcato, i
cui meccanismi sono stati scoperti da G. Tillion
7
, stata al centro delle lotte dei
movimenti femminili per lemancipazione in Tunisia, Marocco e Algeria. Nei tre
Paesi nordafricani, nonostante la storia e un contesto segnati da diferenze e da
similitudini, i movimenti femminili hanno in comune diversi aspetti, tra i quali
quello di avere avuto un rapporto particolare con la politica che, negli ultimi
anni, ha subto dei cambiamenti. Levoluzione della condizione delle donne oggi
, pertanto, ancor pi determinante per comprendere i mutamenti in corso nelle
societ di quei Paesi. Sul piano politico e culturale impossibile dissociare le lot-
te femminili per lautonomia individuale e i diritti delle donne, dalla questione
berbera. Uno dei fondamenti dellidentit nordafricana rappresentato dai ber-
beri che popolano attualmente una decina di Paesi dellinsieme Maghreb-Sahara-
Sahel. Tuttavia, se sono minoritari in Tunisia e totalmente occultati in Libia, i
berberi interessano circa il 25% della popolazione in Algeria e il 40% in Marocco.
In particolare, in questi due ultimi Paesi, la questione della rivendicazione lingui-
stica e culturale alla base dei movimenti berberisti. La presente comunicazione
si propone di mettere in evidenza alcuni tratti del dibattito riguardo ai movimenti
socio-politici delle lotte femminili in Nord Africa, compresi i movimenti berbe-
risti, attraverso lanalisi delle similitudini e delle diferenze che hanno contrad-
distinto le rivendicazioni delle donne per migliorare la loro condizione dopo le
indipendenze.
7 Tillion, G. Le harem et les cousins, Paris, Le Seuil, 1996.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 437 03/05/2013 11:11:26
438
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
I movimenti socio-politici delle lotte femminili
In Nord Africa, la resistenza alla colonizzazione ha trasformato la struttura della
famiglia e la preservazione dellonore delle donne come baluardi di autenticit
appartenenti a unidentit specifca
8
. La conseguenza che ne emersa la con-
traddizione fra il ruolo molto importante delle donne nella resistenza e la capacit
di organizzare autonomamente dei movimenti femminili. Il processo di emanci-
pazione delle donne stato rallentato, poich le prime organizzazioni femminili
credevano che sarebbe scaturito un nuovo statuto delle donne dalla partecipazione
attiva alle lotte per lindipendenza. Ottenuta lindipendenza, il sistema del partito
unico in Algeria e in Tunisia e la monarchia in Marocco non si sono pi occupati
dello statuto delle donne.
Fino a poco tempo fa, il diritto di associazione, seppure inscritto nelle Costi-
tuzioni di quei Paesi, era sottomesso a limitazioni draconiane e le donne potevano
manifestare le loro rivendicazioni attraverso organizzazioni controllate dallo Stato
o dal singolo partito. stato il caso de lUnione National des femmes tunisiennes
creato da Bourguiba nel 1958 in Tunisia; de lUnione National des femmes algrien-
nes, fondato nel 1963 e di organizzazioni nate sotto la supervisione del FLN in Al-
geria; oppure, in Marocco, de lUnione nationale des femmes marocaines nel 1969,
condotta dalla sorella del re Hassan II. In quegli anni, non vi fu un reale cambia-
mento dello statuto delle donne; i miglioramenti riguardarono essenzialmente lo
sviluppo economico dei recenti paesi indipendenti, i quali volevano ampliare i
loro orizzonti oltre la sfera nazionale. In ogni caso, approfttando di alcuni bene-
fci (il miglioramento delle politiche per la salute, linserimento delle donne nel
mondo del lavoro, lintroduzione del salario), le donne si resero conto che avreb-
bero dovuto avanzare le proprie rivendicazioni in maniera autonoma dai partiti
politici. Molte donne intellettuali, tra le quali Fatima Mernissi e Leila Abouzeid in
Marocco, Assia Djebbar e Fadma Amrouche in Algeria, Souad Guellouz ed Emna
Belhaj Yahya in Tunisia, furono accusate di voler imitare i valori dellOccidente. A
met degli anni Ottanta, con la creazione della sezione donne nei partiti, nomi
rappresentativi, quali Raba Naciri e Fatima Mernissi, (Marocco), Khalida Mes-
saoudi e Boutheina Cheriet (Algeria), Bochra Bel Haj Hmidi e Hafdha Chekir
(Tunisia), avanzarono le proprie rivendicazioni, sfdando i conservatori e chieden-
do equit sociale e diritti umani.
Senza entrare nei dettagli sulle modalit di partecipazione ai movimenti fem-
minili, si possono riscontrare un certo numero di caratteristiche comuni ai tre
Paesi. In Marocco e in Algeria, le rivendicazioni femministe furono incentrate sul
8 Charrad, M.M. States and Womens Rights: Te Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco,
Berkeley, University of California Press, 2001.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 438 03/05/2013 11:11:26
439
2. Nuovi movimenti socio-politici e processi di emancipazione femminile in Nord Africa
riesame dei Codici di famiglia promulgati, rispettivamente, nel 1957 e nel 1984.
Entrambi i codici aderivano alla shara musulmana in materia di poligamia e di
eredit. La protesta pi importante avanzata dai movimenti femminili fu caratte-
rizzata dalla denuncia dellincostituzionalit dei codici. Infatti questi apparivano
in contrasto con il principio di uguaglianza di tutti i cittadini afermato dalle
rispettive Costituzioni e con le convenzioni internazionali frmate da entrambi i
Paesi. Le proteste che ne scaturirono si espressero attraverso la stampa, le petizioni,
le marce, le manifestazioni di piazza e le iniziative organizzate da donne intellet-
tuali e studentesse. I movimenti femminili non riuscirono, per, a coinvolgere e
a relazionarsi con la vasta rappresentanza delle donne degli ambienti rurali, poco
scolarizzate e ancor meno politicizzate. Fino ad oggi, le promesse del riesame del
Codice in Algeria sono state regolarmente disattese. Nel 1999, con il governo di
Abdelaziz Boutefika, e dopo la sua rielezione nel 2002, la questione delle donne
rimasta lettera morta.
Risultati diversi si sono registrati in Marocco. Nellottobre 2003, il re Mo-
hammed VI annunci solennemente la riforma del Codice di famiglia. I punti
modifcati corrispondono alle principali richieste avanzate dalle militanti dei mo-
vimenti femminili e riguardano linnalzamento dellet per il matrimonio, labo-
lizione del tutore matrimoniale, la restrizione della poligamia e listituzione del
divorzio legale. Secondo le interviste ad alcune avvocatesse raccolte di recente a
Rabat dallautrice di questo contributo nel corso di una ricerca in Marocco, una
delle prime conseguenze dellapplicazione del Codice, dopo sette anni dalla sua
promulgazione, la diminuzione dei divorzi. Le prospettive attuali del Codice,
riguardo al divorzio legale, riposano, fra laltro, sulle valutazioni obiettive dei giu-
dici, sulla destinazione delle risorse messe a disposizione del governo e sul rafor-
zamento della capacit di mediazione delle famiglie.
In Tunisia, gli esiti, subito dopo lindipendenza, furono molto positivi grazie
alle politiche di Bourghiba, che fece approvare lo statuto personale delle donne
pi avanzato in Nord Africa e in altri Paesi arabo-musulmani. Oggi, perman-
gono problemi riguardanti la questione delleredit femminile e le dif colt che
le militanti incontrano per entrare in politica. Da una parte, le donne e i mo-
vimenti femminili dei diversi Paesi in questione lavorano nellambito della so-
ciet civile, creando un numero sempre crescente di associazioni specializzate in
problemi femminili (alfabetizzazione, assistenza alla povert, violenza domesti-
ca, centres dcoute) e sono stimolate a stringere rapporti con le organizzazioni
non-governative che operano indipendentemente dai gruppi femministi uf ciali.
Dallaltra parte, le militanti lavorano per organismi internazionali che operano
nellambito dei diritti umani, nelle organizzazioni femministe nordamericane ed
europee e nelle fondazioni di assistenza allo sviluppo. Naturalmente, rimane come
obiettivo quello di mettere sotto pressione il sistema politico dei propri Paesi. Tra
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 439 03/05/2013 11:11:26
440
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
i movimenti femminili pi importanti si segnalano lAssociation dmocratique des
femmes du Maroc e lUnion de laction fminine in Marocco; Egalit, mancipation
et promotion e Association pour le triomphe du droit des femmes in Algeria; lAsso-
ciation des femmes universitaires e lAssociation tunisienne des femmes dmocrates in
Tunisia. Negli ultimi anni, tra i risultati positivi va menzionata la partecipazione
di un gruppo di femministe marocchine alla preparazione della bozza del Piano
dintegrazione delle donne allo sviluppo per la Banca Mondiale. Ugualmente
importante stata la collaborazione delle femministe dei tre Paesi nordafricani
iniziata con il Collectif 95 Maghreb-Egalit per rappresentare collettivamente le
donne alla Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne a Pechino nel 1995. In tale
ambito, vanno considerati anche il sostegno allIntifada palestinese fra il 1987 e il
1989, e fno al 2000, e il sostegno alla popolazione irachena durante la Guerra del
Golfo del 1990-1991 e loccupazione americana del 2003. Tali situazioni hanno
fornito alle femministe opportunit ideali per unifcare gli intenti e per ridimen-
sionare le loro diferenze
9
.
Dagli anni Novanta, in diversi Paesi arabo-musulmani emerso un nuovo fe-
nomeno che riguarda il femminismo islamico. Pur richiamandosi alla shara che
va applicata allo statuto personale, questo nuovo movimento ha avanzato alcune
richieste favorevoli allistruzione, al lavoro delle donne e alla partecipazione fem-
minile al processo politico. Le novit di questo movimento vanno inserite nellam-
bito dei cambiamenti socio-politici e culturali che tutto il mondo occidentale
sta attraversando. Nei Paesi musulmani in cui i modelli occidentali sono oramai
compromessi e quindi screditati, la capacit delle femministe islamiche di farsi
ascoltare e di raggiungere ambienti a cui il femminismo laico incapace di accede-
re, sembra essere uno dei fattori chiave nella battaglia delle donne nordafricane
10
.
Rivendicazione identitaria, movimenti berberisti, associazionismo e
presenza femminile
La rivendicazione identitaria berbera ha radici profonde che risalgono almeno agli
inizi del XX secolo e consiste, oggi, in una difusa rete di attivisti organizzati in asso-
ciazioni culturali e partiti politici localizzati in Algeria, in Marocco e nella diaspora
nordafricana in Europa e in Nord America. I movimenti berberisti si richiamano al
concetto di autoctonia dei berberi e contestano la designazione di minoranza che
9 Silverstein, P.A. Political-Social Movements: Ethnic and Minority, North Africa, in Encyclo-
pedia of Women & Islamic Cultures, Leiden, Brill, 2005, II, pp. 641-642.
10 Sadiqi, F. Facing Challenges and Pioneering Feminist and Gender Studies: Women in Post-
colonial and Todays Maghrib, in African and Asian Studies, 7, 2008, pp. 447-470.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 440 03/05/2013 11:11:26
441
2. Nuovi movimenti socio-politici e processi di emancipazione femminile in Nord Africa
deriva dallideologia nazionalista araba dei Paesi nordafricani. Dallindipendenza del
Marocco e dellAlgeria, la lingua e la cultura berbera sono state minacciate dalla
politica di arabizzazione e dal rifuto dei governi che si sono succeduti di prendere
in considerazione il pluralismo culturale e linguistico. Le donne berbere, oggi, si
ritrovano in una duplice dif colt: devono combattere per conquistare i loro diritti
legittimi di donne e di cittadine e, siccome rappresentano il patrimonio
culturale berbero, devono impegnarsi anche contro la cultura dominante
arabo-musulmana.
Se il risveglio della coscienza berberofona sembra recente, la berberofonia co-
stituisce un fatto saldamente ancorato nella storia del Nord Africa. I berberi sono
unanimemente considerati dagli storici le popolazioni autoctone di questo terri-
torio. Sono di origine latina i termini berbero, berbre, berber, berberisch e barbar,
utilizzati nelle lingue europee e in arabo per designare individui e popolazioni che
non appartenevano alluniverso culturale e linguistico greco-latino. Le popolazio-
ni interessate designano la loro lingua tamazight; essi stessi si chiamano Imazighen
e il loro paese chiamato Tamazgha il paese degli uomini liberi. Storicamente,
la lingua berbera ha contribuito allunifcazione politica e religiosa del territorio
nordafricano. Tuttavia, le diverse occupazioni succedute e ladozione delle lingue
esogene come lingue di potere secolare e/o spirituale da parte dei berberi stessi
hanno impedito lo sviluppo endogeno della societ berbera e pertanto quella della
sua lingua e della sua cultura
11
.
Dagli eventi della Primavera berbera in Cabilia del 1980, i berberi afer-
mano chiaramente, per la prima volta nella storia del Nord Africa, il diritto e
la volont di esistere attraverso la richiesta di riconoscimento istituzionale della
loro lingua e della loro cultura sullo stesso piano della lingua araba nella sfera
pubblica (istruzione, amministrazione, media). Da allora, emersa con forza lin-
compatibilit tra la rivendicazione culturale berbera e il potere, poich lideologia
fondatrice del nazionalismo maghrebino rinvia ai concetti di una nuova coscienza
araba e islamica e di unit della Nazione. In Algeria, fno ad oggi, le importanti
manifestazioni per il riconoscimento del berbero nel 1991, lo sciopero scolastico
nel 1994-95 per linsegnamento della lingua berbera, le opposizioni violente nel
1998 dopo lassassinio del cantautore cabilo Louns Matoub, simbolo della ri-
vendicazione culturale e linguistica, fno agli avvenimenti della Primavera nera
del 2001 che hanno contato un centinaio di morti e creato una situazione di
caos in Cabilia, confermano che la questione berbera sempre attuale
12
. Oggi,
11 Boukous, A. La berbrophonie: enjeux dune reconnaissance, in Bistolf, R. Les langues de la
Mditerrane, Paris, LHarmattan, 2002, pp. 268-269.
12 Chaker, S. La langue berbre dans le champ politique maghrbin. Le cas algrien: rupture ou
continuit?, in Chaker, S. (a cura di) Langue et pouvoir, Paris, disud, 1998, pp. 25-26.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 441 03/05/2013 11:11:26
442
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
il potere algerino, con scelte politiche non condivise, rischia di alimentare i con-
fitti, favorendo spinte secessioniste della Cabilia. Anche in considerazione delle
condizioni politiche diverse, in Marocco si generata unevoluzione parziale della
questione berbera. Se non si avuta la stessa linea di ostracismo militante che
si sviluppata in Algeria di fronte alla realt berbera, la politica linguistica del
governo marocchino, comunque, stata molto simile e la lingua berbera era stata
eliminata dal sistema socio-educativo. A seguito dei gravi eventi della Primavera
Nera del 2001 della vicina Algeria, per bloccare le proteste e linasprimento della
questione berbera, nel 2003, in Marocco, inizia la divulgazione dellinsegnamento
del berbero. Secondo le interviste ad alcuni insegnanti recentemente raccolte in
Marocco dallautrice di questo contributo, gli obiettivi fssati per il 2010 dallIR-
CAM (Institut Royal de la Culture Amazigh au Maroc), che ha curato lassetto
socio educativo dellinsegnamento della lingua berbera nelle scuole primarie, non
hanno raggiunto le attese, in ragione della persistenza di alcuni pregiudizi e per il
fatto che linsegnamento del berbero non stato inserito nei collges e nei licei.
Nel campo ideologico, la stigmatizzazione del berberismo e della richiesta
di riconoscimento dellidentit stata ugualmente virulenta come in Algeria. Il
riferimento alla coscienza identitaria berbera stata percepita e condannata come
tentativo di divisione e di attentato allunit della nazione. Oggi, la situazione
sta cambiando; difatti, anche per neutralizzare i confitti potenziali sulla base di
identit regionali, in Marocco, agli inizi del 2010, con lobiettivo di promuovere
la cultura berbera in tutto il Nord Africa stato lanciato un canale radio-televisivo
pubblico in lingua berbera (chane 8 Tamazight, di propriet della Socit nationale
de radiodifusion et de tlvision), fortemente rivendicato da molte associazioni.
Il terreno associativo, a partire dagli anni Novanta, in Marocco e in Algeria, ha
compiuto un lavoro culturale fondamentale che completa il discorso iniziato negli
ambienti universitari e intellettuali, conferendo una legittimit popolare alla que-
stione berbera. Le associazioni hanno costantemente investito nellambito dellin-
segnamento della lingua berbera: a livello locale si svolgono corsi di alfabetizzazio-
ne, sono difusi modesti bollettini e si organizzano stage di formazione; contribui-
scono signifcativamente alla difusione dello scritto in berbero, soprattutto presso
i giovani. Le donne, in tale contesto, svolgono un ruolo signifcativo quali attiviste
impegnate. Le associazioni femminili che lottano per il riconoscimento identi-
tario berbero esistono e ve ne sono alcune in Algeria: Tarwa n Fadma n Soumer
Association, Tighri n Tmettut e Womens Collective de la Black Spring. Lassociazione
Tamaynut Amazigh Women Foundation rappresenta le donne berbere presenti in
alcuni Paesi europei; in Marocco, per qualche anno ha funzionato lassociazione
Femmes Azetta. Molte donne berbere, secondo le testimonianze raccolte sul ter-
reno, si lamentano del fatto che le associazioni siano essenzialmente maschili e
anche se le donne che vi militano sono motivate, devono imporsi in un ambiente
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 442 03/05/2013 11:11:26
443
2. Nuovi movimenti socio-politici e processi di emancipazione femminile in Nord Africa
in cui gli uomini hanno a volte comportamenti sessisti. La maggior parte delle
donne berbere vive in ambiente rurale e conosce poco i propri diritti ritrovandosi,
spesso, impotente di fronte alla supremazia delluomo e alla gerarchia dei sessi.
Lanalfabetismo e la mancanza distruzione sono molto difusi e ci non favorisce
lintegrazione delle donne nella societ. Nei casi in cui le donne berbere si avviano
alla scolarizzazione, si trovano di fronte a due lingue estranee (larabo e il francese)
e ci comporta la svalutazione della propria lingua e della cultura berbera con
la conseguente perdita di valori autoctoni di fronte ai valori importati. Nelle
comunit berbere locali, oramai in disintegrazione, sono soprattutto le donne che
perpetuano e promuovono la cultura berbera. La trasmissione della lingua, della
storia e della cultura orale, della musica, della danza, dei costumi, della conoscenza
artigianale e dellambiente naturale, delle erbe medicinali e delligiene, evidenzia-
no limportanza del loro compito come educatrici. Siccome le donne conoscono e
perpetuano la cultura del loro popolo, possibile sviluppare un movimento eman-
cipatorio per creare unidentit positiva dei berberi. Linserimento della lingua ber-
bera nel tessuto educativo e un miglioramento delle condizioni delle donne sono
fattori benefci per la democratizzazione del Nord Africa e il suo sviluppo globale.
Conclusioni
Dal periodo delle indipendenze in poi, in Nord Africa, le aspirazioni delle donne,
la loro immagine e il loro ruolo nella societ sono evoluti in un tempo relativa-
mente breve, grazie anche alla capacit di cambiamento dei movimenti femminili
che hanno cercato di orientare e indirizzare le rivendicazioni in relazione ai muta-
menti socio-politici. I processi contemporanei di globalizzazione hanno raforzato
lidentit e la cultura dei berberi, poich sono compatibili con i valori della laicit,
dellautodeterminazione della donna, dellaccettazione della pluralit e della mul-
ticulturalit, ma condannano fortemente lordine monoculturale e predominante
basato su islam ed arabismo. Gli efetti dellomogeneit della globalizzazione
sono considerati una reale minaccia per le popolazioni autoctone in genere, poich
mettono in pericolo le identit culturali, inclusa quella berbera. Per tali ragioni,
oggi, lintegrazione di tutti gli attori dinamici delle societ nordafricane: islamisti,
movimenti delle donne, associazioni dei diritti delluomo, movimenti berberisti,
e soprattutto i molteplici movimenti femminili, potrebbero favorire il processo
democratico, in quanto rappresentano ed esprimono le diverse specifcit culturali
alla ricerca dei diritti e del riconoscimento della multiculturalit.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 443 03/05/2013 11:11:26
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 444 03/05/2013 11:11:26
3. Il femminismo islamico e il caso delle
murshida
-
t in Marocco
Sara Borrillo
Nel 2004 il governo del Marocco ha istituito le predicatrici uf ciali dellIslam
(murshidt, sing. murshida, guida)
13
, attribuendo loro il compito di spiegare il
Corano alle altre donne nelle moschee del Paese. Si tratta dellunico caso tra i Paesi
musulmani in cui si concede, in via uf ciale e nello spazio pubblico della moschea,
la difusione al femminile della parola di Allah, mentre le riunioni di preghiera
o di rifessione sulle sure del Corano tra donne sono tradizionalmente relegate al
contesto domestico e organizzate in maniera informale
14
.
La creazione di un corpo di predicatrici uf ciali dellIslam rappresenta, dun-
que, unapparente rivoluzione, perch mette in discussione uno dei capisaldi
del sistema patriarcale dello Stato islamico, vale a dire il monopolio maschile del
discorso e dello spazio religioso, legato al ruolo delluomo di guida della famiglia
e della comunit dei credenti. In tutto il mondo musulmano, infatti, la responsa-
bilit maschile della famiglia e della societ garantisce la reciproca legittimazione
tra Islam e potere (nazionale e familiare), e in Marocco tale legame si manifesta
nella natura teocratica della monarchia, in cui lIslam sia religione di Stato sia
principale sistema di valori cui si ispira lorganizzazione familiare patriarcale
15
.
13 Per la translitterazione dei termini arabi verr usato un sistema semplifcato in cui saranno indi-
cate solo le vocali lunghe e non le consonanti enfatiche.
14 Rosignoli, V. Le nuove tendenze dellIslam contemporaneo: il femminismo islamico, in Cam-
panini, M.; Mezran, K. (a cura di) Arcipelago Islam. Tradizione, riforma e militanza in et contempo-
ranea, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 153-179.
15 La fgura del Re, Comandante della Comunit dei Credenti, inviolabile e sacra, secondo
la Costituzione, in virt della diretta discendenza dal Profeta Maometto della dinastia Alawita, al
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 445 03/05/2013 11:11:26
446
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
In un simile contesto, linclusione delle donne nella predicazione religiosa
rappresenta unevoluzione simbolica signifcativa che apre a possibili margini
dampliamento dei diritti delle donne in un paese dov, peraltro, gi possibile
osservare una serie di segnali favorevoli alleguaglianza di genere. In Marocco li-
stituzione delle predicatrici uf ciali dellIslam segue, infatti, ladozione di diverse
politiche pubbliche a favore dei diritti politici e civili delle donne. Tra queste
vanno segnalate la riforma del sistema elettorale del 2002 (che riserva una quota
rosa del 10% dei seggi parlamentari e dei Consigli locali) e quella del Codice
di Famiglia e dello Statuto Personale del 2004 (che tra le misure pi importanti
riconosce il diritto delle donne al divorzio, abolisce lobbedienza al marito, pur
lasciando invariata la disciplina del diritto ereditario, in base al quale le donne
ereditano la met dei parenti maschi di pari grado, e non abolendo n la poligamia
n il ripudio)
16
.
Se tali misure, nonostante alcuni limiti sostanziali, hanno incorporato alcune
delle istanze del movimento femminista secolare, attivo in continue campagne e
petizioni nazionali (da ultimo la campagna per la rimozione delle riserve apposte
dal governo marocchino alla ricezione della CEDAW nellordinamento naziona-
le), la riforma che apre alle donne il settore della predicazione dellIslam sembra
rispondere a una delle principali rivendicazioni del femminismo islamico, vale a
dire il diritto di tutti i credenti, e dunque anche delle donne, di partecipare al di-
scorso religioso sulla base della ripresa del principio di eguaglianza coranico. Dif-
fuso nellambito del variegato movimento femminista marocchino, grazie allatti-
vit di teologhe e intellettuali ispirate al lavoro di ricerca delletica egualitaria del
Corano della sociologa Fatema Mernissi, lapproccio del femminismo islamico
muove dallassunto secondo cui il fondamento della segregazione delle donne non
risiede nel dettato coranico, quanto piuttosto nel monopolio maschile dellesegesi
religiosa e nel conseguente radicamento di visioni misogine nella giurisprudenza
islamica
17
. Pertanto tale prospettiva di pensiero propone, in primo luogo, una ri-
lettura egualitaria dei testi sacri ispirata allijtihd di genere (metodo interpretativo
volto a decostruire i presupposti teologici del patriarcato attraverso la ripresa del
potere nel Regno sin dal XVII secolo. Daoud, Z. Fminisme et Politique au Maghreb. Soixant ans de
lutte (1930-1992), Casablanca, ditions Eddif, 1993.
16 Il Codice di Famiglia e sullo Statuto Personale marocchino (in arabo, Mudawwana) stato sotto-
posto a una prima riforma nel 1993. Il progetto della seconda riforma, presentato il 10 ottobre 2003
dal Re Muhammad VI durante un discorso alle Camere, stato approvato nel Febbraio 2004 dal
parere unanime del Parlamento marocchino.
17 Mernissi, F. Le Sultane dimenticate. Donne capo di Stato nellIslam, Genova, Marietti, 1992; Sa-
diqi, F. Facing Challanges and Pioneering Feminist and Gender Studies: Women in Post-colonial
and Todays Magrib, in African and Asian Studies, 2008, pp.447-470, in: www.brill.nl/aas.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 446 03/05/2013 11:11:26
447
3. Il femminismo islamico e il caso delle murshida
-
t in Marocco
principio di uguaglianza coranico) e inoltre incoraggia la predicazione femminile
dellislam, intesa come momento costruttivo di scambio di posizioni teologiche e
non come pedissequa tradizione delle interpretazioni religiose prevalenti
18
. Con-
siderato che la trasmissione dellislam rappresenta il canale privilegiato del proget-
to di sovversione cognitiva del femminismo islamico, ho analizzato il caso delle
murshidt marocchine chiedendomi se portasse con s, oltre che unindubbia evo-
luzione simbolica, anche gli elementi di un cambiamento pi profondo, foriero di
accenni di quella coscienza femminile (o femminista?) necessaria alle musulmane
per ofrire un apporto individuale al discorso religioso dominante. Le predicatri-
ci marocchine possono praticare lijtihd di genere? Grazie ad alcune interviste
realizzate durante una ricerca sul campo delineo alcune considerazioni sulla cor-
rispondenza tra il caso delle predicatrici e il femminismo islamico in Marocco
19
.
Riforma delle istituzioni religiose
Nellambito della riforma delle istituzioni religiose in Marocco
20
, che nel 2004
ha promosso linclusione delle donne negli enti e nelle istituzioni islamiche, la
Direzione delle Moschee del Ministero degli Afari Islamici, incaricata della pro-
paganda religiosa su tutto il territorio nazionale, ha emesso il primo bando per il
Programma di Formazione che abilita 50 donne lanno alla professione di pre-
dicatrice, accanto a 150 colleghi aspiranti predicatori (imm). Per partecipare al
concorso necessario possedere i seguenti requisiti: et inferiore ai 45 anni, cit-
tadinanza marocchina, una laurea conseguita presso ununiversit del Paese e una
condotta irreprensibile e conforme alla morale islamica. Per le donne requisito
fondamentale ricordare a memoria almeno la met del Corano, mentre i futuri
predicatori maschi devono conoscerlo tutto.
18 Moghadam, V. Islamic feminism and its discontents: toward a resolution of the debate, in
SIGNS-Journal of Women in Culture and Society, 27, n. 4, Summer 2002, pp. 1135-1171.
19 Durante un periodo di ricerca, nel 2008 ho sottoposto ad alcune murshidt un questionario semi-
strutturato diviso in tre parti: la prima, su dati anagrafci, livello distruzione e formazione professio-
nale, stata utile per raccogliere elementi su background sociale, status economico e culturale delle
intervistate. La seconda, incentrata sulla descrizione del percorso formativo e professionale svolto in
qualit di predicatrice, ha permesso di aggiungere, alle informazioni raccolte dai media uf ciali o da
internet, dettagli sullo svolgimento del programma di predicazione. La terza parte mirava, invece,
a indagare il livello di conoscenza delle predicatrici sul femminismo e leventuale auto percezione
come femminista islamica.
20 Delle questioni religiose si occupano, in Marocco, il Ministero per gli Afari Islamici e i Consigli
dei Dotti della Legge islamica (ulam), al cui vertice vi il Consiglio Superiore, i cui pareri con-
sultivi sono determinanti per lorientamento politico nazionale (tale organo presieduto dal re in
persona).
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 447 03/05/2013 11:11:26
448
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
Il percorso di formazione (che ha luogo nellunica sede nazionale della mo-
schea di Bb al-Shella di Rabat) si articola in corsi, annuali e dalla cadenza quoti-
diana, incentrati su materie religiose e umanistiche: alle classiche scienze del Cora-
no e della Sunna (la tradizione profetica), Sufsmo (la mistica islamica) e salmodia
coranica, si af ancano scienze della politica, della comunicazione e delleducazio-
ne, storia e geografa del mondo musulmano, informatica e lingue. Tale formazio-
ne corrisponde al lavoro di alfabetizzazione religiosa e sociale che le predicatrici,
una volta terminato il corso di formazione, svolgono in un numero variabile di
moschee assegnate loro a seconda della provincia di appartenenza.
Per tale lavoro ricevono un salario di circa 4.000 Dirham mensili (circa 380
euro), con un sussidio di maternit di 200 Dh mensili per ogni fglio, mentre per il
periodo di formazione prevista una borsa di studio mensile di circa 180 euro. La
struttura delle lezioni sullislam consiste generalmente nella spiegazione da parte
della predicatrice di alcuni versetti coranici collegati a uno specifco argomento di
vita quotidiana, e in un successivo dibattito in cui le astanti possono avanzare dub-
bi e richiedere spiegazioni. La predicazione verte non soltanto sullinsegnamento
dei cinque precetti fondamentali del credo musulmano ma anche su argomenti
relativi alla risoluzione di confitti familiari e alleducazione dei fgli, argomenti
trattati secondo il costante riferimento al ruolo di cura femminile (di buona ma-
dre, sposa, sorella) corrispondente ai valori dellislam tradizionale. Il programma
per predicatrici, secondo alcuni dei suoi promotori stato immaginato per ren-
dere pi coeso ed organizzato il messaggio religioso nazionale, messo a dura
prova dalla minaccia alla stabilit interna rappresentata da frange estremiste che
di recente, soprattutto con gli inaspettati attentati suicidi di Casablanca (2003),
hanno destabilizzato il potere centrale
21
.
Il potere della monarchia , inoltre, costantemente messo in discussione dal-
la predicazione islamica non governativa, difusa in Marocco da gruppi islamisti
come il movimento semiclandestino Giustizia e Benevolenza (al-Adl wa l-Ihsn),
fondato nel 1973 dallo shaykh Abd al-Salam Yassine, che mira a instaurare nello
Stato e nella societ i valori dellislam delle origini. Convinta della necessit della
liberazione delle donne dal dominio maschile, fondato sul monopolio dellinter-
pretazione delle fonti dellislam, la leader del movimento e fglia del suo fondatore,
Nadia Yassine, promuove da anni seminari di formazione rivolti a sole donne allo
scopo di educarle a una comprensione autentica dellislam, necessaria al raggiun-
gimento di una coscienza femminile che sia armonica con il contenuto egualitario
del Corano. Il progetto di empowerment attraverso lo sradicamento dellanalfabe-
21 La notte del 16 maggio 2003, diversi aderenti a un gruppo salafta (probabilmente si tratta
dellorganizzazione della Salafyyia Jihadyyia), si sono fatti esplodere in diversi punti della citt di
Casablanca provocando la morte di pi di 20 persone.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 448 03/05/2013 11:11:26
449
3. Il femminismo islamico e il caso delle murshida
-
t in Marocco
tismo religioso femminile, promosso da Giustizia e Benevolenza attraverso il Pro-
gramma Sorelle per lEternit, coincide con quello del femminismo islamico e
allo stesso tempo molto vicino alla strategia dei corsi governativi per predicatrici.
Ed, in efetti, pi volte la Yassine ha dichiarato che il programma per predicatrici
istituzionali deriva da una sua idea, sollevando una polemica con il governo non
ancora sopita. Aldil della corrispondenza strategica che possibile evidenziare
tra monarchia e uno dei suoi principali gruppi dopposizione, va segnalato che la
Yassine ha sottolineato la diferenza tra il proprio progetto (realmente rivoluzio-
nario perch diretto a formare vere dottoresse in Legge islamica) e quello gover-
nativo che non sembra molto innovativo. Infatti, come lei stessa ha dichiarato: i
diplomi rappresentano la tradizione e i corsi sono imperniati su materie afrontate
da un punto di vista classico
22
.
Per quanto provocatorie e supportate da posizioni politiche decisamente an-
tigovernative, queste dichiarazioni non sono poi tanto distanti dalla realt che
ho potuto osservare. Due osservazioni fanno allontanare lidea che le murshidt
abbiano libert di trattare i temi daula secondo un approccio vicino a quello del
femminismo islamico. Innanzitutto va segnalato che quando ho chiesto alle predi-
catrici se si autopercepissero come femministe islamiche, la maggior parte di esse
si rifutata di approfondire il tema femminismo dichiarando di non conoscer-
ne i contenuti, n nella sua veste secolare n in quella musulmana. Alcune hanno
dichiarato di aver sentito parlare del movimento femminista attraverso i media,
ma di non essere interessate allargomento. Altre hanno afermato che nellislam
non c bisogno di femminismo perch i diritti delle donne sono gi contenuti nel
Corano. Soltanto una predicatrice si dichiarata femminista musulmana def-
nendosi una buona madre, una buona moglie e una buona sorella, defnizione
che per in contraddizione con lautodeterminazione femminile promossa dalle
teoriche del femminismo musulmano.
La seconda considerazione riguarda alcuni limiti oggettivi posti alla predi-
cazione, limiti che ridimensionano la possibilit delle predicatrici governative di
adoperare il metodo dellijtihd di genere. Secondo la teologa marocchina Aisha
Al-Ajjami, docente di diritto pubblico allUniversit Qadi Ayyiad di Marrakech,
per svolgere un valido lavoro interpretativo delle fonti sacre del diritto
necessario conoscere: la lingua araba classica (quella del Corano e della Sunna),
utile ad analizzare i signifcati delle parole nei diversi contesti della storia
dellislam; la teologia e la scienza dei fondamenti del diritto islamico, che ha come
oggetto lesegesi e lermeneutica dei testi sacri; e inoltre utile possedere elementi
22 Tra virgolette riporto dichiarazioni di Nadia Yassine, raccolte durante unintervista a Rabat, 28
Settembre 2008.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 449 03/05/2013 11:11:26
450
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
di critica letteraria, storia, sociologia, antropologia ed economia, per avere un
margine danalisi pi ampio della Rivelazione e relazionato ai cambiamenti
storicosociali
23
.
Le murshidt seguono corsi su tali specifche tematiche e teoricamente lat-
tivit di orientamento religioso di cui sono incaricate rappresenta il luogo in cui
realizzare un confronto da cui scaturisca la lettura egualitaria dellislam auspi-
cata dalle femministe islamiche
24
. Tuttavia, la loro preparazione non necessaria-
mente corrisponde a un elevato livello di competenza teologica, eccezion fatta
per le laureate in Scienze islamiche, e la formazione che ricevono senza dubbio
tradizionale. Il margine di libert interpretativa di cui godono le giovani donne
che hanno il compito di islamizzare le marocchine sembra essere alquanto
circoscritto. Infatti, per ci che fno ad oggi ho potuto osservare, le murshidt
non propongono uninterpretazione delle fonti indipendente, ma rispettano le
indicazioni del Ministero degli Afari Islamici che decide, in accordo con il Con-
siglio Superiore degli ulam (dotti della legge islamica) di Rabat, dei contenuti
dei corsi formativi, nonch dei temi che le neo-diplomate andranno a trattare a
loro volta in moschea.
Ogni predicatrice deve, poi, attenersi alle indicazioni contenute in un ma-
nuale di riferimento fornito dal Ministero (la Guida per limm, il predicatore e
lorientatore) che, attraverso esempi concreti e precise citazioni coraniche, vincola
la predicazione ai quattro pilastri dellislam nazionale: la shara (legge islamica),
il malikismo (scuola giuridica sunnita maggioritaria in Marocco), il sufsmo e la
lealt al Re quale Comandante dei Credenti
25
.
Inoltre, le predicatrici devono presentare periodiche relazioni sul lavoro svolto
al Consiglio locale degli ulam del distretto in cui operano e sono chiamate a
partecipare a riunioni di aggiornamento in cui vengono orientate alle questioni
da trattare in moschea. Tali limiti testimoniano lesigenza di controllo governativo
sulla difusione del messaggio islamico, la cui omogeneit elemento costitutivo
dellidentit nazionale e dunque del consenso alla monarchia rappresenta una
priorit dellagenda politica in Marocco. Le murshidt sono, infatti, incaricate di
difondere un islam tollerante, moderato e non violento, capace di ridimensio-
nare la portata di approcci potenzialmente estremisti o comunque distanti dalla
propaganda governativa difusi perlopi tra gli strati sociali pi marginalizzati
23 Intervista ad Aisha Al-Ajjami, raccolta a Marrakech il 30 Settembre 2008.
24 Hafez Barazanji, N. Womans identity and the Quran. A new reading, Gainesville, University Press
of Florida, 2006.
25 Guida per limm, il predicatore e lorientatore (Dall al-imm wa al-khatb wa al-wiz), Rabat,
Ministero per gli Afari Islamici, 2007, p. 18.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 450 03/05/2013 11:11:26
451
3. Il femminismo islamico e il caso delle murshida
-
t in Marocco
(non a caso la predicazione femminile si svolge anche in ospedali, carceri e in aree
periferiche delle citt).
Pi che una rivoluzione, il caso delle murshidt sembra essere il risultato di
una strategia di compromesso tra islam e modernit, in cui le predicatrici rappre-
sentano il prodotto di una duplice mediazione operata dal Regno del Marocco:
tra islamisti ed establishment religioso, intorno a un consenso islamico-politico
comune, da un lato, e tra questi e le forze progressiste, anche femministe (laiche e
islamiche), promotrici di una maggiore partecipazione femminile alla vita civile,
politica e religiosa del Paese, dallaltro. Tuttavia, non vanno trascurati gli aspetti
simbolici del cambiamento che il caso delle murshidt porta con s. Un cambia-
mento che, in prospettiva, potr probabilmente incidere sullimmaginario colletti-
vo innescando dinamiche favorevoli allampliamento dei diritti delle marocchine.
Non escluso, ad esempio, che la convergenza tra le idee del femminismo islamico
e la pratica della predicazione femminile potr aversi in futuro. A tal proposito,
sar interessante osservare se nel processo di apertura alla modernit cui mira la
monarchia marocchina vi sar spazio per le proposte di rivoluzione silenziosa
delle femministe musulmane e se, nel lungo periodo, potranno aprirsi quei margi-
ni di confronto necessari perch le predicatrici contribuiscano, attraverso uninter-
pretazione pi egualitaria dellislam, ai contenuti del messaggio che trasmettono.
Se, cio, avranno la possibilit, e lintenzione, di ricavarsi unautonomia tale da
praticare un metodo interpretativo di genere del Corano.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 451 03/05/2013 11:11:27
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 452 03/05/2013 11:11:27
4. Le algerine e la guerra di liberazione
nazionale: lingresso delle donne
nello spazio pubblico
Valeria Guasco
La guerra dAlgeria (1954-1962) stata allorigine di numerosi cambiamenti so-
cio-economici e culturali che hanno scosso la societ algerina
26
. Le donne, nella
societ algerina tradizionale, agnatica, patriarcale e patrilineare, vengono defnite
quali pilastri della famiglia, guardiane del focolaio domestico e della herma
27
.
Durante la guerra di liberazione nazionale, le donne emergono nello spazio
pubblico e politico fno ad allora riservato agli uomini. In efetti: Impegnata
nella guerra sia direttamente sia indirettamente, sia come attrice sia come vitti-
ma, spinta dalla forza delle cose ad assumere un ruolo nuovo, lAlgerina, donna
sposata o ragazza nubile, ha accesso, nel corso degli ultimi anni a una pi grande
autonomia. Lesplosione del blocco familiare conduce ogni membro del gruppo a
prendere coscienza della propria personalit e responsabilit
28
.
Lobiettivo di questo contributo di evidenziare, attraverso il ruolo della don-
na, i cambiamenti a livello socio-culturale che emergono nella societ algerina
durante e dopo la guerra di liberazione nazionale. A partire dal periodo coloniale,
si tenta di verifcare i mutamenti sociali, con riferimento particolare al mondo ru-
rale, in relazione ai costumi e allabbigliamento delle algerine
29
. Le leggi coloniali
sul Cantonnement (1863;1873) che impongono valori occidentali quali lindivi-
26 Fanon, F. Sociologie dune rvolution, Paris, Maspero, 1968, p. 5.
27 Minces, J. Women in Algeria, Harvard University Press, 1978, p. 165.
28 Bourdieu, P. Guerre et mutation sociale en Algrie, in tudes Mditerranens, n. 7, Anthropos
ed., 1960, pp. 25-27.
29 Fanon, F. op. cit., p. 16.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 453 03/05/2013 11:11:27
454
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
dualismo contro il principio comunitarista dei colonizzati, intaccano il nucleo
della struttura sociale tradizionale algerina, la famiglia. In tal modo, la Francia
svaluta la societ tradizionale e pretende di liberare la donna
30
. Gli etnologi
francesi descrivono il costume delle donne algerine, quello di chiudersi nelle loro
case, velate, inaccessibili e misteriose, quale sinonimo di arretratezza; propongono,
poi, un nuovo modello di donna, quella francese occidentale, alla quale le alge-
rine devono riferirsi. Togliere loro il velo vuol dire violentare le algerine, deper-
sonalizzarle. Se, in efetti, la societ europea algerina e il sistema coloniale basato
sul principio di assimilation, impongono le dvoilement delle donne, la guerra di
indipendenza prescrive in alcune circostanze (si ricordi il caso delle poseuses des
bombes immortalate nel flm di G. Pontecorvo degli anni Settanta, La battaglia di
Algeri) il ripristino del velo, che perde tuttavia la sua connotazione tradizionale,
quale simbolo di integrit, di purezza e di sottomissione della donna alluomo. A
proposito della riapparizione del velo, F. Fanon rileva che: Voile enlev puis re-
mis, voile instrumentalis, transform en technique de camoufage, en moyen de
lutte. Le caractre quasi tabou pris par le voile dans la situation coloniale disparait
presque compltement au cours de la lutte libratrice
31
. Il velo diviene lo stru-
mento politico, lo strumento di lotta e di libert che le donne ostentano in quanto
indicatore della nuova Algeria che vuole rompere con il passato coloniale
32
.
Nelle regioni rurali, in particolar modo in Cabilia, la guerra di indipendenza
ha determinato notevoli cambiamenti a livello sociale, specialmente per quanto
riguarda la gestione dello spazio da parte delle autorit militari. Di tutte le misure
economiche e sociali decise nellambito della pacifcazione delle popolazioni ru-
rali, il raggruppamento delle popolazioni rurali senza dubbio quella che si defni-
sce pi chiaramente quale appendice delle grandi leggi terriere del Cantonnement,
il senato-consulto del 1863 e la legge Warnier del 1873
33
. La politica dei campi
di raggruppamento delle popolazioni rurali a partire dal 1958 aveva lo scopo di
arginare e di controllare la rivolta algerina, evacuando i gruppi dalle proprie abi-
tazioni e raggruppandole in aree circondate da flo spinato: Le nuove abitazioni
non corrispondevano ad alcuna logica poich si assistette alla frammentazione di
intere famiglie []. Con linsediamento dei campi di raggruppamento, la politica
della guerra fniva ci che la politica coloniale aveva iniziato, vale a dire la lacera-
30 Gadant, M. Les femmes, la famille et la nationalit algrienne, in Peuples Mditerranens, n. 15,
Paris, Anthropos ed., 1981, pp. 25-55.
31 Ivi, p.47.
32 Ibrahimi, K. Les Algriennes et la guerre de libration nationale. Lmergence des femmes dans
lespace public et politique au cours de la guerre et laprs guerre, in Harbi, M.; Stora, B. (a cura di)
La guerre dAlgrie 1954-2004, la fn de lamnsie, Paris, Bouchne, 2005, pp. 197-226.
33 Bourdieu, P.; Sayad, A. Le dracinement, Paris, Les ditions de Minuit, 1964, p. 15.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 454 03/05/2013 11:11:27
455
4. Le algerine e la guerra di liberazione nazionale: lingresso delle donne nello spazio pubblico
zione del tessuto economico tradizionale, dei valori e delle rappresentazioni, cos
come del modo di pensare e di vivere
34
.
Gli efetti di tale politica sono stati particolarmente decisivi per quanto ri-
guarda la condizione sociale dei gruppi e in particolar modo circa le relazioni tra
uomini e donne che risultano alterate. Lo studio di P. Bourdieu e di A. Sayad,
Le dracinement
35
, fa luce sulla singolare situazione delle donne cabile durante la
guerra di indipendenza. Le donne appartenenti alla societ cabila tradizionale, si
trovano al centro delle trasformazioni sociali imposte dalle politiche nate in seno
alla guerra dAlgeria. Tali cambiamenti riguardano non solo le donne costrette nei
campi di raggruppamento ma lintera societ algerina: Numerose donne si trova-
no investite di responsabilit e compiti che incombevano fno a poco tempo prima
al marito. [] Lo spazio di vita, sino ad allora estremamente ridotto, si dilata.
La donna si reca nella citt europea, entra nei grandi magazzini, svolge formalit
amministrative. Dal suo universo chiuso e segreto fa irruzione nello spazio aperto,
un tempo lasciato agli uomini
36
.
Nella societ rurale, la comparsa del velo femminile, elemento inesistente, poi-
ch le donne non avevano bisogno di nascondersi di fronte ai membri della loro tri-
b, un fatto eclatante: Dans la socit rurale dautrefois, les femmes, qui navaient
pas se dissimuler aux membres de leur clan, taient tenues de suivre, pour se rendre
la fontaine (et secondairement aux champs), des itinraires carts, des heures
traditionnellement fxes: ainsi protges des regards trangers, elles ne portaient pas
et ignoraient alh ujba (lexistence cloitre dans la maison)
37
. In efetti, creando un
campo sociale di tipo urbano, il raggruppamento determina la comparsa del velo per
permettere gli spostamenti fra gli stranieri
38
: Non potendo, senza rinnegarsi come
contadina, adottare il velo della cittadina, la contadina trapiantata doveva guardarsi
dallapparire sola sulluscio di casa
39
. Durante la guerra, nei raggruppamenti come
nei centri urbani, le donne cabile sono costrette a indossare il velo per sfuggire agli
sguardi degli uomini estranei ai membri del clan di appartenenza. La fne della guer-
ra di indipendenza, sancita dagli accordi di Evian del 1962, comporta una serie di
mutamenti sociali che investono tutto il mondo femminile algerino, sia lambito
34 Yacine, T. Mutamenti sociali e condizione delle donne. Gli efetti della politica dei campi di rag-
gruppamento sulle donne cabile, in Di Tolla, A.M. (a cura di) Studi Berberi e mediterranei. Miscel-
lanea in onore di L. Serra, Studi Magrebini, Numero Speciale, IV, 2006, Napoli, 2006, pp. 271-280.
35 Bourdieu, P.; Sayad, A. op. cit., p. 18.
36 Bourdieu, P. Guerre et mutation sociale en Algrie, in tudes Mditerranens, n. 7, Printemps,
1960, pp.25-37.
37 Bourdieu, P.; Sayad, A. op. cit., p. 22.
38 Yacine, T. cit., pp. 271-280.
39 Ivi, p. 279.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 455 03/05/2013 11:11:27
456
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
rurale che quello urbano. In efetti, dal 1962, le donne, che avevano attivamente
partecipato al maquis in qualit di combattenti
40
, sono costrette dallimperante
politica di arabizzazione e di islamizzazione condotta dal primo governo Ben Bella a
fare ritorno alle proprie case dove avrebbero svolto il ruolo che la societ tradizionale
aveva da sempre af dato loro: di sposa, di madre. Nel corso degli anni Settanta,
nonostante lesclusione dalla vita politica, le donne algerine creano delle associazioni
femminili, legalizzate solo nel 1989, alcune delle quali rappresentano ancora oggi le
principali animatrici contro lislamismo integralista.
Il fondamentalismo islamico promosso dal FIS (Fronte Islamico di Salvezza) e dal
suo braccio armato, GIA (Gruppi Islamici Armati), conduce a una cruenta guerra che,
nel corso degli anni Novanta, avalla una strategia repressiva nei confronti delle donne
che, violate nella loro integrit psico-fsica sono costrette a re-indossare lhidjab che
diviene uno strumento di oppressione da parte del governo. Inoltre, gli islamisti inizia-
no, gi dal 1989, la loro campagna di moralizzazione contro le donne, oltre allobbligo
del velo, cercano di imporre la segregazione dei sessi nelle scuole, impediscono alle
ragazze di fare ginnastica, controllano le studentesse allinterno dei campus universitari
dove per loro, dalle sei in poi, vige una sorta di coprifuoco. I militanti islamisti escono
sempre di pi allo scoperto con azioni violente: una ragazza viene aggredita allinterno
delluniversit perch espone un manifesto di iniziativa culturale
41
.
Aferma O. Carlier:
Dans ce contexte, le voile islamiste devient un signe stratgique, qui replace la
femme comme enjeu, au coeur du rapport sociale et de la morale collective, un
signe et un signal occupant une place essentielle dans la lutte symbolique qui
prcde et prpare la lutte politique. Avec lui, les hommes retrouvent la suprma-
tie naturelle que le Coran leur confre, avec tout dispositif de la charia, la virilit
perdue, ou menace. Avec lui, ils reprennent la tte dune communaut mise en
ordre de bataille, prte pour le combat que leur pres ont laiss inachev
42
.
Allalba del nuovo Millennio, in Algeria, nelle strade delle citt, nelle fab-
briche, nelle scuole, negli ospedali, nelle universit, le donne sono sempre pi
presenti e numerose
43
. La presenza delle donne in tutti i settori della vita sociale
40 Amrane, D. Les femmes algriennes dans la guerre, Paris, Plon, 1991.
41 Sgrena, G. Kahina contro i calif . Islamismo e democrazia in Algeria, Roma, Datanews, 1991.
42 Harbi, M.; Stora, B. La guerre dAlgrie 1954-2004, la fn de lamnsie, Paris, Bouchne, 2004,
p. 373.
43 Ibrahimi, K.T. Les Algriennes et la guerre de libration nationale. Lmergence des femmes dans
lespace public et politique au cours de la guerre et laprs guerre, in Harbi, M.; Stora, B. (a cura di)
La guerre dAlgrie 1954-2004, la fn de lamnsie, Paris, Bouchne ed., 2005, pp.197-226.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 456 03/05/2013 11:11:27
457
4. Le algerine e la guerra di liberazione nazionale: lingresso delle donne nello spazio pubblico
un dato tangibile: sono ingegneri, conducenti di taxi, medici, ministri, amba-
sciatrici, docenti universitarie e nel campo delle arti sono commediografe, pittrici,
musiciste. Lingresso delle donne algerine nella vita pubblica del loro Paese, se da
un lato rappresenta un fattore di evoluzione della societ algerina, dallaltro lato,
suscita reazioni ostili da parte degli uomini che contestano il desiderio delle donne
di emanciparsi
44
.
Le donne algerine sono vittime della seguente contraddizione: hanno com-
battuto e resistito a ogni forma di violenza e si sono imposte in tutti gli ambiti
sociali, ma nella gestione del privato restano dominate, minori a vita, sottomesse
alla legge maschile dopo la promulgazione del Codice della famiglia, il codice
dellinfamia, nel 1984. Durante il decennio della hogra (termine dialettale con
cui si indica la condizione di umiliazione, di arbitrio, di abuso di potere), sono
molteplici le storie di donne algerine che hanno subito violenze psico-fsiche in-
delebili da parte del governo del FIS. Ad esempio, si annovera la storia di una
docente presso lUniversit di Algeri che ha rischiato ogni giorno la vita a causa del
rifuto di indossare il velo; secondo gli integralisti islamici, una donna rispettosa e
perbene deve indossare lhidjab
45
.
NellAlgeria attuale, il paese della concordia civile del presidente A. Bou-
tefika, si nota una certa ambiguit, poich le donne velate e senza velo vivono
fanco a fanco:
sono due societ quella laica e quella islamista che si sono scontrate per anni,
sanguinosamente, e ora sembrano rassegnate a vivere una accanto allaltra senza
sforarsi, senza comunicare. Chi si battuto per decenni ha gi pagato con la di-
fesa del proprio progetto di societ e ora vuole solo vivere in pace, senza nessuno
che imponga comportamenti prestabiliti. Londata islamista ha per lasciato il se-
gno, marcando di fatto una regressione culturale e un arretramento nei costumi
46
.
Il velo impera nella societ algerina del post-2001, in quanto garante del buon
nome di una ragazza che per sposarsi ha bisogno di un tutore maschio, il wali.
Sono tanti i ragazzi in Algeria che per divertimento non disdegnano le coetanee
che non portano lhidjab, ma quando si afrontano tematiche quali il matrimonio,
che ancora oggi secondo il Codice del 1984 relega la donna in una condizione di
subalternit rispetto alluomo, lo scenario cambia e il velo diviene sinonimo di
seriet, di integrit e di docilit della donna, secondo la tradizione.
44 Ivi, p. 198.
45 Moufouk, G. Les femmes algriennes dans la guerre, in Peuples Mditerranens, Paris, Anthropos
ed., n. 70-71, 1995, pp. 25-55.
46 Sgrena, G. Il prezzo del velo. La guerra dellIslam contro le donne, Milano, Feltrinelli, 2008, p. 48.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 457 03/05/2013 11:11:27
458
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
Dal canto loro, le giovani generazioni di algerine scoprono che con il velo
subiscono meno controlli da parte della famiglia, in particolare del padre, e pos-
sono cos uscire di casa pi liberamente. In efetti, se si osservano le donne per le
strade di Algeri, la maggior parte di loro indossa lhidjab per sfuggire al controllo
dei familiari pi che per una convinzione religiosa. Nota la Sgrena: Come pu
essere compatibile un velo, pi o meno rigoroso, con gonne trasparenti e jeans
attillatissimi?. Lesperienza del velo femminile in quanto elemento che rifette
lidentit della societ algerina fa emergere i contrasti tipici della realt dellAlgeria
contemporanea
47
. Nellultimo decennio, rispetto agli anni Novanta si riscontrano
alcuni cambiamenti nella societ algerina: tramontata lideologia dellintegralismo
islamico, il velo diviene un fatto culturale: foulard colorati e abbinati ai vestiti
vengono indossati dalle algerine. Non si pu parlare pi di velo copripovert,
come ai tempi in cui il velo suppliva alla mancanza di abiti decenti. In qualche
modo, si assiste anche alla regressione della segregazione sessuale: molte donne
oggi frequentano locali (bar, ristoranti, negozi di abbigliamento) fno a poco tem-
po fa destinati ai soli uomini.
Bisogna riconoscere che le donne che hanno attivamente partecipato alla lotta
per la liberazione nazionale, grazie al loro coraggio hanno illuminato il cammino
delle algerine che oggi si battono per la conquista dellidentit politica e della cit-
tadinanza; pertanto le ex-combattenti rappresentano oggi una sorta di coscienza
per la nazione algerina. Inoltre, la lotta per afermare i propri diritti si inscrive
allinterno della lotta pi ampia per la secolarizzazione dellislam. Si tratta, per,
di un processo faticoso anche a causa del contesto internazionale, laddove prevale
il fanatismo religioso, non solo islamico.
In conclusione, le rivendicazioni socio-politiche delle donne algerine concer-
nono la lotta per liberare la societ algerina da tutti i dogmatismi, gli arcaismi,
le ingiustizie e gli integralismi e far s che lAlgeria divenga un paese libero e de-
mocratico, un paese dove le donne e gli uomini, in quanto liberi cittadini, siano
uguali per diritti e doveri.
47 Fanon, F. Les damns de la terre, Paris, Maspero, tr.it., I dannati della terra, Torino, Einaudi, 1963.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 458 03/05/2013 11:11:27
5. Riessioni sul femminismo islamico in Iran:
voci, temi, strategie e nalit
Leila Karami Nogurani
Lislam comunemente conosciuto come una religione che conferisce molta at-
tenzione alle norme giuridiche e alle regole sui comportamenti sociali; ci spiega
perch lislam sia inteso sia nel senso universale di dottrina rivelata da Dio alluo-
mo sia nel senso di religione storica, con i suoi riti e le sue pratiche. Lislam per i
musulmani un unicum dogmatico, morale, rituale e giuridico, in cui non ha alcun
senso distinguere la sfera giuridica da quella morale, perch entrambe trovano le
proprie fonti nella shara, la legge religiosa islamica che regola lattivit esterna del
credente verso Dio, verso se stesso e verso gli altri
48
.
Oggi che il riformismo islamico punta sulle radici sociali delle idee, dei diritti
umani e dei processi verso la democrazia, pur nel rispetto dellidentit islamica
della societ e dello stato, anche il tema delle donne, che non il principale mo-
tivo di divergenza tra le forze politiche in campo, si confgura soprattutto come
questione giuridico-teologica. Il legame tra religione, identit culturale e dirit-
ti delle donne, allindomani della rivoluzione islamica del 1979, va collocato in
quel processo di re-islamizzazione della societ dove la posizione delle donne al
centro dellideologia politica dellislam. Tale legame cerca di evidenziare lidentit
48 Castro, F. Il modello islamico, a cura di Piccinelli, G.M., Torino, G. Giappichelli editore, 2007.
Per il presente studio mi sono basata sui seguenti testi: Fathzdeh, F. Zan dar trkh va andsheh-
ye eslm (La donna nella storia e nel pensiero islamico), Qom, Moaseseh bstn-e ketb ed., 2007;
mol, A.J. (yatollh), Zan dar neh-ye jall va jaml Women in the Mirror of Divine Beauty
and Divine Glory, Qom, nashr-e esr ed., 2006/1385; Mehrz, M. Shakhsyat va hoqq-e zan dar
eslm (Personalit e diritti della donna nellislam), Tehran, Sherkat-e enteshrt-e elm va farhang
ed., 2003/1382.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 459 03/05/2013 11:11:27
460
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
islamica della societ e, in particolare, delle donne. La condizione delle donne,
nellIran contemporaneo, comunque il rifesso dei complessi e contraddittori
cambiamenti sociali, culturali e politici. un argomento che fa da unit di valore
sia per individuare le proposte socio-politiche sia per capire il percorso ideologico-
flosofco di ogni singolo intellettuale. Da oltre un secolo le donne hanno scelto di
sfdare il patriarcato e le interpretazioni androcentriche, cio maschiliste (persia-
no zansetz o dedd-e zan), delle istituzioni religiose in merito alla fede islamica. Tali
istituzioni, forti della propria autorevolezza, hanno interpretato il dettato coranico
secondo una lettura anti-femminile che legittima solo la presenza delluomo nella
sfera pubblica e quindi politica, negandone alle donne laccesso. Da qui, non a caso,
la reazione delle donne nellambito del femminismo islamico avviene proprio sul
piano teologico-giuridico. Scopo principale di questo lavoro mettere a confronto
gli approcci che caratterizzano il femminismo islamico e determinare in quale mi-
sura il dato sociologico e culturale del femminismo si intreccia con il dato teologico
e giuridico della religione islamica in riferimento alle donne. Lespressione femmi-
nismo islamico si riferisce a un fenomeno globale di carattere teorico e pragmatico
che, a partire dagli anni Novanta, si fonda sulla rilettura, comprensione e reinter-
pretazione del Corano, dei hadth (tradizioni profetiche) e, per gli sciiti, delle rivyt
(lett. aneddoti) attribuite agli imm sciiti
49
. Il punto di partenza del femminismo
islamico il Corano, allinterno del quale esistono e vanno estrapolati espliciti ver-
setti che rimandano alluguaglianza di tutti gli esseri umani.
In altre parole il femminismo islamico promuove una rilettura dei testi fon-
danti dellislam, prendendo in esame quei versetti dai cui una certa esegesi ha de-
dotto disparit legali tra uomini e donne, e proponendo una loro re-interpretazio-
ne. Il femminismo islamico adotta e usa le scienze linguistiche, le analisi lessicali e
le conoscenze teologico-giuridiche, sociologiche e storiche; in particolare afronta
la storia dei primi secoli dellislam con un atteggiamento di sfda nei confronti
delle interpretazioni patriarcali del Corano,
dei hadth e dellandrocentrismo della shara e rivendica per le donne la li-
bert concessa loro dal Profeta nei primi anni dellislam
50
. Il femminismo islami-
co rifuta sia il femminismo laico occidentale sia il modello femminile dellislam
49 In riferimento al femminismo islamico vengono utilizzati anche i termini movimento o ten-
denza; chi scrive preferisce fenomeno, perch quanto segue risulta dallesperienza umana, soggetta
a indagine sperimentale di una serie di fatti che presentano caratteri individuabili, sia pure con
varianti, basati sulla conoscenza delle realt soggettive interconnesse. Badran, M. Islamic Feminism:
Whats in a Name?, in http://weekly.ahram.org.eg/2002/569/cu1.htm, 2002.
50 Moghadam, V. Towards Gender Equality in the Arab/Middle East Region: Islam, Culture,
and Feminist Activism, in http://hdr.undp.org/docs/publication/background_papers/2004/
HDR2004_Valentine_Moghadam.pdf, 2003.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 460 03/05/2013 11:11:27
461
5. Rifessioni sul femminismo islamico in Iran: voci, temi, strategie e fnalit
ortodosso e, consapevole della subordinazione delle donne in famiglia e nella so-
ciet, critica lo statuto giuridico e legale della donna e la sua condizione socio-
economica. Denuncia, inoltre, i Codici di Famiglia perch sanciti secondo una
visione ingiusta e misogina e fondati sul principio di propriet particolarmente
difuso nellArabia preislamica, che privilegiava gli uomini a danno delle donne
tanto da restringere i loro diritti umani.
Il femminismo islamico denuncia la discrepanza tra il Corano e le leggi sha-
raitiche, che sono state applicate, per secoli, in nome della Parola di Dio sia con-
tro lemancipazione femminile sia contro la richiesta dei diritti delle donne. Le
femministe islamiche sostengono che le leggi misogine della shara e non del
Corano siano dovute alla mancata considerazione: per il dettato contestuale
della rivelazione, per lo spirito egualitario del testo sacro particolarmente rifesso
nei versetti meccani, per il contesto politico-territoriale in cui la neonata comuni-
t musulmana cercava il riconoscimento, in particolare a Medina, e infne per la
soggettivit interpretativa degli ulam.
Perci il femminismo islamico si appella al messaggio del Profeta e, ritenendo-
lo egualitario nei ruoli maschili e femminili nella prima comunit dei fedeli, porta
alla luce aspetti della tradizione religiosa che sono stati ignorati per secoli o poco
sviluppati nella storia del mondo musulmano. Inoltre, sottolineando che la lingua
araba, nella quale rivelato il Corano, usa generalmente il maschile includendo
anche il femminile, invita gli ulam a non considerare in modo esclusivamente
maschile i versetti coranici, quindi cerca di riscoprire momenti della rivelazione
coranica in cui Dio si rivolge sia agli uomini sia alle donne. Il femminismo islami-
co, inoltre, sostiene che la dignit del soggetto femminile debba partire dalla con-
siderazione della donna come persona, riconosciuta tale gi nel Corano, e insiste
per il riconoscimento incondizionato della sua integrit personale. In altre parole
i diritti della donna devono essere collocati allinterno di un quadro religioso dove
la costruzione giuridica pu e deve essere riesaminata e lineguaglianza pu e
deve essere rilevata.
In Iran le relazioni di genere, in seguito alla rivoluzione, si sono focalizzate
sullalleanza di tre elementi: strutture patriarcali, islam e Stato. Sempre pi donne,
le stesse che inizialmente avevano appoggiato orgogliosamente le motivazioni ide-
ologiche dello Stato islamico, si sono rese conto di non poter accettare che il loro
destino venisse determinato dalle interpretazioni degli uomini, e che non poteva-
no raggiungere leguaglianza di diritti senza partecipare attivamente alle riforme
legislative. Si apre una nuova fase della questione femminile e attorno a essa
nasce un movimento per i diritti delle donne del tutto interno al sistema politico
della Repubblica Islamica. Cos lislam tradizionale pre-rivoluzionario lascia il
posto allislam politico post-rivoluzionario. Viene alla luce una tendenza, che
cerca di aprire uno spazio per le donne, basata sulle reinterpretazioni della dottrina
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 461 03/05/2013 11:11:27
462
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
islamica: donne che accedono alle pubblicazioni e agli studi sui testi sacri per ela-
borare un discorso islamico in merito ai diritti delle donne. Unampia alleanza dei
riformisti, tra i quali vengono inclusi islamici e secolari, propone, dalla fne anni
Ottanta, unalternativa democratica alla linea conservatrice. Tra la moltitudine
di individui e movimenti che ha contribuito al tentativo di rinnovamento della
societ civile, ci sono tre principali gruppi di intellettuali e politici che hanno
presentato, o compreso allinterno dei propri studi, una lettura islamica di genere
diversa da quella messa in atto dallo Stato.
Le tre posizioni, giurisprudenza dinamica (feqh-e py, legata alle scuole
teologiche)
51
, intellettualismo religioso (rowshanfekrn-e dn)
52
e coalizione per lo
sviluppo politico (tarafdrne toseeh-ye sys), senza fare registrare in modo espli-
cito unanalisi precisa sulla questione di genere, contribuiscono ad aprire la stra-
da alla nozione di attivismo di genere. Quanto detto funzionale al discorso
che seguir. Le donne, politicamente condizionate dal discorso religioso, trova-
no nellintellettualismo religioso e nel dinamismo della giurisprudenza il terreno
adatto per poter presentare un discorso di genere che possa intervenire sulla teolo-
gia e sul diritto attraverso una serie di strategie complementari che vanno dalla re-
interpretazione dei testi religiosi, allutilizzo delle pagine dei periodici femminili
per veicolare le loro interpretazioni, alle riforme giuridiche, in particolare sul tema
delluguaglianza dei diritti. Dunque, femministe islamiche non sono solo teolo-
ghe, ma possono essere editorialiste, scrittrici, saggiste, sociologhe, parlamentari,
giornaliste, docenti universitarie. Tra le prime femministe islamiche un fattore ca-
ratterizzante lappartenenza a grandi famiglie religiose o un legame matrimoniale
con i principali allievi dei grandi giuristi o teologi. Solo di recente si conoscono i
nomi (sempre in aumento) delle femministe islamiche di formazione laica. Molte
sono le barriere individuali, sociali e culturali che le donne devono superare per
esprimere il proprio pensiero, ci nonostante esistono in Iran molte pubblicazioni
che afrontano le tematiche del femminismo islamico. Ecco le principali:
Paym-e hjar (Messaggio di Agar), bisettimanale, a volte mensile e nellultimo
periodo di pubblicazione anche settimanale, dellAssociazione delle donne della
51 Le basi teoriche della giurisprudenza dinamica risalgono agli anni Settanta con i testi dellya-
tollh Motahar Sistema dei diritti delle donne nellislam e la Questione del hijb. Paidar, P. Gender of
Democracy: the Encounter between Feminism and Reformism in Contemporary Iran, Genve, UNRISD,
2001, p. 19, in www.unrisd.org.
52 Intellettualismo religioso, in Iran, si sviluppa gradualmente, a partire dalla Rivoluzione Costitu-
zionale (1906-1911), vede impegnati flosof, letterati e politici e, in particolare Al Sharat (1933
1977) con il suo discorso ideologico sulla modernizzazione che comprende anche i valori tradizionali
della religione. Jahanbakhsh, F. Te Emergence and Development of Religious Intellectualism in
Iran, in Historical Refections, 30, n. 3, 2004, pp. 469490; Jahanbakhsh, F. Islam, Democracy and
Religious Modernism in Iran (1953-2000). From Bzargn to Soroush, Leiden, Brill, 2001.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 462 03/05/2013 11:11:27
463
5. Rifessioni sul femminismo islamico in Iran: voci, temi, strategie e fnalit
rivoluzione islamica dellIran (Jmeeh-ye zann enqelb-e eslm-ye rn)
53
uscito per la prima volta nel 1981 sotto la direzione di Azam Tleqn, fglia
del noto yatollh Mahmd Tleqn
54
. La rivista si pone come voce dissiden-
te e richiama lattenzione del governo sui problemi economici e sociali delle
donne in quanto soggetti oppressi. I temi sono loccupazione e la forza lavoro
femminile negli ambienti rurali. A ci si aggiungono temi di natura culturale,
sociale, religioso-giuridico e politici. Nel 2000 viene revocato il permesso di
pubblicare la rivista a causa delle critiche contro la linea politica del governo.
Ned (Richiamo), il trimestrale che vede la luce nella primavera del 1990 con
Zahr Mostafav (la fglia di Khomeini) come direttrice responsabile, pubbli-
ca: articoli di argomento socio-culturale, come la posizione della donna nella
societ e nella famiglia, la partecipazione delle donne in politica, le donne e i
diritti umani; rapporti sui seminari internazionali e sulle riunioni riguardanti
i diritti delle donne nellislam e nel mondo islamico; rapporti dei viaggi del
gruppo editoriale nei paesi islamici e resoconti dei loro incontri con donne
di altri paesi; interviste con esponenti di organizzazioni internazionali, pre-
valentemente islamiche. La sua pubblicazione stata sospesa dal luglio 2009.
Zann (Donne), considerato il pi noto mensile femminile post-rivoluzio-
nario. Nasce nel 1992 su iniziativa di Shahl Sherkat, nota giornalista e vinci-
trice di vari premi internazionali. Nel gennaio del 2008/1386 le fu ritirato il
permesso di pubblicazione con la motivazione: minaccia contro la sicurezza
psichica della societ. La rivista pubblica articoli su necessit, dif colt e
diritti delle donne, denuncia violenza e abusi domestici, lancia temi come la
custodia dei fgli per le madri, la difusione del virus HIV e la prostituzione
come problema sociale.
Paym-e zan (Messaggio di donna), il mensile culturale, sociale, politico e
artistico delluf cio di propaganda islamica del centro teologico di Qom.
Nei primi numeri della rivista scrivono i membri del clero riformista di Qom,
sostenitori della giurisprudenza dinamica e attenti alla questione femmini-
le. Gli obiettivi della pubblicazione sono: aumentare la consapevolezza delle
donne e la crescita delle virt morali; consolidare i rapporti allinterno della
famiglia; insistere sulla necessit della partecipazione delle donne nella socie-
t; evidenziare i reali problemi delle donne
55
.
53 Noto come Islamic Womens Institute of Iran; ha un sito internet, www.payamehajar.com, in
cui si possono leggere articoli e interviste fatte agli ulam e alle deputate del parlamento che riguar-
dano la condizione delle donne.
54 Su Mahmd Tleqn vedi Jahanbakhsh, Islam, Democracy and Religious Modernism in Iran cit.,
pp. 69-80.
55 possibile consultare alcuni numeri della rivista sul sito internet www.shareh.com.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 463 03/05/2013 11:11:27
464
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
Farzneh (Saggia), come si pu notare dal titolo in inglese sulla copertina
il Journal of Womens Studies and Research. Farzneh un trimestrale che
pubblica in inglese e in persiano. Nasce nel 1993/1372, ha un comitato di
redazione composto da studiosi e ricercatori residenti sia in Iran sia allestero
e pubblica articoli sui temi giuridici, sui diritti umani e sulla situazione delle
donne musulmane in altri Paesi islamici ed europei.
Reyhneh (Fragranza), nasce nel 1995/1374 come periodico del lUf cio
degli afari delle donne dellistituzione della presidenza, i temi sono preva-
lentemente, la partecipazione delle donne iraniane alla politica, allo sviluppo
sociale ed economico, alle ONG e agli studi religiosi. Non mancano articoli
sulla lotta delle donne iraniane per ottenere i propri diritti durante la Rivolu-
zione Costituzionale (1906-1911) e sulla partecipazione delle donne di altri
paesi islamici in vari settori della societ.
Hoqq-e zann (Diritti delle donne) un mensile e vede la luce nel
1998/1377 con Ashraf Germzdegn come redattrice capo della rivista. La
Germzdegn laureata in giurisprudenza alluniversit di Tehran; non a
caso la rivista si occupa dei temi riguardanti i diritti delle donne cos come la
stessa Germzdegn, che stata anche segretaria generale dellONG, Asso-
ciazione per la difesa dei diritti umani delle donne.
Ketb-e zann (Libro delle donne), nasce nel 1998/1377 ed trimestrale del
Consiglio socioculturale delle donne, si occupa di pubblicare articoli sulla
questione femminile e la presenza di tante donne che collaborano sia con la
rivista sia nel comitato giuridico e sociale del Consiglio
56
.
Ned-ye Sdeq (Richiamo dellimm Sdeq) che appare anche con il titolo in-
glese: Quarterly of Islamic Law and Jurisprudence, under the Scientifc Direction
of the Research Center at Imam Sadeq University, Girls College. Si tratta della
rivista della sezione femminile dellUniversit di Emm Sdeq
57
. I temi sono
di natura legale e giuridica e gli autori sono docenti delle principali facolt
teologiche e giuridiche, spesso con una formazione laica.
Meshkaat al-noor (Lampo di luce), rivista semestrale della sezione femminile
della stessa Universit, inizia la sua attivit nel 1996/1375 e, come si deduce
dal titolo in inglese sulla copertina, un Quarterly of Philosophy and Islamic
Teology. Pubblica articoli di tema flosofco e teologico. Il comitato scien-
tifco e editoriale formato da docenti delle principali universit iraniane.
Banovn-e sheh (Donne sciite), un trimestrale che, come dice anche il ti-
tolo in inglese, si occupa di questioni di genere, cultura e religione nel mondo
56 Vedi il sito internet: http://www.iranwomen.org/ZANAN/english/about.htm.
57 Vedi il sito internet delluniversit: http://www.isuw.ac.ir.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 464 03/05/2013 11:11:27
465
5. Rifessioni sul femminismo islamico in Iran: voci, temi, strategie e fnalit
sciita; quasi tutti gli articoli sono scritti da docenti universitari e ricercatori
con una formazione teologica. Gli articoli vanno dalle interviste alle ricerche
storiche e biografche sulle donne musulmane nellambito dello sciismo
58
.
Haura
59
il mensile scientifco, culturale e sociale dellUf cio di studi e ricer-
che sulle donne di Qom. La rivista vede la luce nel 2003, la maggior parte degli
articoli scritta dagli insegnanti delle scuole teologiche di Qom che pubbli-
cano pezzi sullinterpretazione del Corano, sullislam e sulla conoscenza del
femminismo.
Le principali tematiche del femminismo islamico in Iran
NellIran post-rivoluzionario la questione morale e giuridica delle donne diviene
un tema centrale del dibattito tra teologi e laici. La questione viene afrontata sot-
to due aspetti: luguaglianza di fronte a Dio dellumanit a prescindere dal sesso e
la relazione asimmetrica tra uomo e donna. La rivelazione coranica in merito alla
creazione delluomo conferma luguaglianza degli esseri umani. Gli studiosi pre-
cisano che i versetti che descrivono la creazione parlano genericamente di essere
umano (insn o bashar) oppure utilizzano il termine collettivo ns, umanit, che
comprende sia il maschile sia il femminile. Si potrebbe afermare, nel caso di una
lettura riformista del Corano, che una strategia necessaria insistere sul fatto che
linterlocutore di Dio nella rivelazione lumanit tutta, tutti i fgli della coppia
primordiale, Adamo ed Eva. Il tutto a prova delluguaglianza del genere umano
(uomo e donna) di fronte a Dio. Riconoscendo che il Vicario di Dio lumanit,
le femministe islamiche rivendicano anche prerogative e autorit politiche negate
alle donne. Gli studiosi, laici e religiosi, sottolineano che i doni divini (armonia
di forme, vista, udito, cuore, coscienza e discernimento) sono stati dati agli esseri
umani, uomini e donne, che quindi godono alla pari della generosit divina
60
. Per
gli studiosi riformisti lasse del rapporto tra luomo e Dio incornicia una serie di
valori morali e spirituali che Dio nel Corano prevede sia per gli uomini sia per
le donne. Tra i valori morali e spirituali assegnati allumanit intera si possono
citare: la fede
61
, la buona condotta, la scienza, il timore di Dio e lubbidienza, lo
58 possibile consultare gli articoli dall1 al 16 della rivista sul sito internet www.shistu.org.
59 Signifca donna dagli occhi belli e dalla pelle chiara; anche uno dei soprannomi della fglia del
Profeta, Ftemeh.
60 Corano 95:4, 82:6-7; 16:78, 23:78; 30:30; 33:72. Wadud, A. Quran and Woman: Rereading the
Sacred Text from a Womans Perspective, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 35.
61 Per i riformisti la fede conduce lessere umano a praticare azioni buone; e il Corano nomina
uomini e donne insieme oppure usa il termine insn, vedi Corano, 103:1-3, 3:195, 4:124, 16:97,
17:19, 40:40.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 465 03/05/2013 11:11:27
466
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
sforzo e lo stare sulla retta via
62
. Sono due i temi cruciali che vengono messi
in discussione dal femminismo islamico perch creano disparit giuridica e met-
tono in dubbio la dignit della donna riconosciutale nel Corano. Il primo tema
quello della disparit intellettiva tra uomini e donne, (nqisat al-aql, defcienza
nella mente) che trova base nei versetti coranici sulla testimonianza, sulla premi-
nenza degli uomini (qawwmn, potest e daraja, grado) e sui vezzi delle donne
(helya)
63
. Il secondo tema quello della defcienza nella fede (nqisat al-dn)
che subordina la donna alluomo nellambito religioso e la esclude da una serie di
attivit religiose, a causa dellimpurit attribuita al sangue mestruale, del princi-
pio che Dio non ha mai assegnato la profezia a una donna e dellidea di ftna
(secessione, confusione e guerra civile) che avverrebbe se la comunit religiosa
fosse guidata da una donna. Oltre al dibattito teologico, il femminismo islamico
si muove nella direzione di una ridefnizione moderna della nozione della shara
che diviene elemento di equilibrio nel sistema statuale delle fonti giuridiche. Le
studiose mettono in discussione una serie di articoli dei Codici di Famiglia in
vigore in Iran come quelli che indicano il marito come capo della famiglia
64
,
quelli che regolano il donativo nuziale, lubbidienza al marito, linsubordinazione
della moglie al marito e il mantenimento
65
; le leggi sulla custodia dei fgli
66
, sul
matrimonio della minore
67
, sul ripudio e divorzio
68
, sulleredit della moglie dal
marito; e infne lesclusione delle donne dalla professione di giudice e dalla presi-
denza della Repubblica
69
.
62 Corano 2:151; 58:11; 39:9; 49:13; 4:95; 3:51; 19:36; 43:64; 36:61; 22:54.
63 Corano 2:282; 4:34; 2: 228.
64 Si vedono ad esempio gli artt. 1105, 1114, 1117, 1005, 976, 976, 984, 1043 del Codice Civile
iraniano.
65 Codice Civile artt. 1107-1109, 1085, 1115.
66 Codice Civile artt. 1168-1169.
67 Codice Civile artt. 1041.
68 Codice Civile artt. 1121-1124, 1119, 1129-1130, 1133.
69 Costituzione iraniana art. 115.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 466 03/05/2013 11:11:27
6. Formale o informale? Dinamiche
delloccupazione femminile nellarea MENA
Ersilia Francesca
Larea MENA (Middle East and North Africa) ha registrato negli ultimi decenni no-
tevoli progressi nel campo delluguaglianza di genere: indicatori quali il tasso di
istruzione femminile, laspettativa di vita, il tasso di fertilit dimostrano quanto sia-
no cambiate in meglio la condizione delle donne e le loro opportunit di tutela della
salute e dei diritti. Tuttavia la partecipazione femminile alla sfera economica, anche
se cresciuta di circa il 50% dal 1960 a oggi, rimane ancora scarsa e sensibilmente
inferiore a quella che si registra in altre aree emergenti o in via di sviluppo. Svariati
fattori scoraggiano lingresso delle donne nel mercato del lavoro: lassunto che luo-
mo sia tenuto a provvedere ai bisogni della famiglia e che quindi il lavoro femminile
abbia un ruolo secondario nel budget familiare; il peso che si riconosce ai compiti
tradizionali femminili nellambito della famiglia con cui il lavoro extradomestico
deve risultare conciliabile; lesistenza di norme giuridiche discriminanti nei confron-
ti delle donne (sgravi fscali e assegni familiari riconosciuti solo ai lavoratori maschi).
In alcuni paesi il diritto delle donne al lavoro ancora sottoposto al consenso del
marito. La legge di famiglia giordana, ad esempio, riconosce al marito tale preroga-
tiva, nonostante lart. 6 della Costituzione e lart. 2 della Legge del lavoro del 1966
sanciscano lassoluta parit tra uomini e donne nel campo del lavoro
70
.
Anche nei Paesi in cui le donne godono di migliori opportunit, permane una
divisione tradizionale del lavoro, per cui esse trovano prevalentemente occupazio-
ne nellagricoltura, nellistruzione o nel pubblico impiego, nei campi dellassisten-
70 El-Azhary Sonbol, A. Women of Jordan. Islam, Labor, & the Law, Syracuse, N.Y., Syracuse Uni-
versity Press, 2003, pp. 89-99, 152.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 467 03/05/2013 11:11:27
468
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
za sanitaria e dei servizi, mentre il loro accesso a carriere direttive o manageriali ri-
mane dif cile. La percentuale di donne occupate in settori diversi dallagricoltura
varia dal 7% in Yemen al 27% in Marocco
71
. In Egitto, la distribuzione delle occu-
pazioni in base al sesso, mostra una concentrazione del lavoro femminile in agri-
coltura (37%) e nei servizi (40%); alcune professioni hanno subito, a partire dagli
anni Sessanta, una forte femminilizzazione: sono donne il 68% degli infermieri,
il 40% degli insegnanti, il 27% dei medici; mentre la presenza femminile continua
a essere scarsa in settori considerati maschili, come quello estrattivo e quello
delle costruzioni (0,1 e 0,6%). Le donne tendono a occupare posizioni subalterne,
lasciando agli uomini le posizioni direttive
72
. In Turchia il lavoro femminile si
concentra nel settore dei servizi (56,6%), dellindustria (30,7) e dellagricoltura
(12,7%); le donne svolgono per lo pi mansioni legate alla produzione (23,8%)
o tecnico-amministrative (22,2%), solo una piccola percentuale (3,1%) arriva a
occupare cariche manageriali. La maggioranza delle donne svolge lavori dipen-
denti (76,4%), mentre l8,4% sono libere professioniste e l1,6% imprenditrici
73
.
Negli ultimi decenni, il processo di globalizzazione ha avuto rilevanti conseguenze
sulle disparit di genere. Almeno nel breve periodo le politiche di aggiustamento
strutturale hanno portato alla crescita della disoccupazione femminile a seguito
del maggior peso del settore privato che, tradizionalmente, privilegia lassunzione
maschile. Si assiste dunque a una marginalizzazione delle donne nel mondo del
lavoro, mentre accanto a una proliferazione di associazioni impegnate, a vario
livello, nella promozione del ruolo delle donne, si riscontrano manipolazioni delle
questioni di gender da parte dello stato, dei partiti politici dominati dalla pre-
senza maschile, del fondamentalismo islamico, al fne di convogliare le energie
femminili verso i valori tradizionali della famiglia e della religione. Loccupazione
considerata una delle maggiori sfde economiche che i Paesi dellarea MENA
devono afrontare. Tuttavia la questione delloccupazione, nonostante la sua rile-
vanza sociale ed economica, non ha avuto suf ciente attenzione a livello nazionale
71 Tzannatos, Z.; Kaur, I. Women in the MENA Labor Market: an Eclectic Survey, in Abdella
Doumato, E.; Pripstein Posusney, M. (eds.) Women and Globalization in the Arab Middle East.
Gender, Economy and Society, London, Lynne Rienner Publ., 2002, pp. 63-67; Moghadam, C.M.
Modernizing Women. Gender and Social Change in the Middle East, London, Lynne Rienner Publ.,
1993, pp. 43-53.
72 Dati CAPMAS (Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Egypt): Program of Surveys
for Monitoring Social Development in Egypt, 1992-1995 e Priority Survey, 1995. Nassar, H.
Egypt: Structural Adjustment and Womens Employment, in Doumato, A.; Posusney, P. (eds.)
Women and Globalization in the Arab Middle East cit., pp. 102-107.
73 Dati SIS (State Institute of Statistic, Ankara), 1994. Dayiolu, M. Labor Market Participation
of Women in Turkey, in Acar, F.; Gnes-Ayata, A. (eds.) Gender and Identity Construction. Women
of Central Asia, the Caucasus and Turkey, Leiden, Brill 2000, pp. 51-53.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 468 03/05/2013 11:11:27
469
6. Formale o informale? Dinamiche delloccupazione femminile nellarea MENA
e internazionale, cos da essere trasposta in politiche economiche coerenti con le
scelte macroeconomiche che gli stati hanno implementato. In particolare, non si
tenuto suf cientemente conto dellimpatto della liberalizzazione economica e dei
programmi di cooperazione internazionale sulla crescente forza lavoro disponibile,
sul problema della disoccupazione/sottoccupazione femminile e giovanile (soprat-
tutto di giovani laureati con la conseguente fuga dei cervelli), dellinterazione
tra lavoro formale e informale e della spinta allemigrazione. Secondo lultimo
rapporto del Forum Euro-Mditerranen des Instituts Economiques (FEMISE)
entro il 2020 si dovrebbero creare, nellarea MENA, 22 milioni di nuovi posti di
lavoro (ossia una media di crescita dell1,9% allanno) per scongiurare un aumen-
to del gi alto (15%) tasso di disoccupazione. Entro tale data, il numero stimato
dei disoccupati superer i 12 milioni (di cui la met in Egitto e Turchia) su una
popolazione in et lavorativa di circa 130 milioni. Le cifre indicano chiaramente
che una semplice stabilizzazione del tasso di disoccupazione non suf ciente. Per
agire simultaneamente sui due fattori (crescita dei posti di lavoro e riduzione della
disoccupazione) i Paesi della riva sud del Mediterraneo dovrebbero creare, entro i
prossimi quindici anni, 57,9 milioni di nuovi posti di lavoro, cifra che corrispon-
de a un tasso di crescita medio anno del 4,1%
74
.
Le riforme economiche e legislative implementate soprattutto in Marocco, Pa-
lestina, Egitto e Tunisia hanno portato, secondo la Banca Mondiale, a una crescita
dei posti di lavoro del 37% a partire dagli anni Novanta; tuttavia, tale crescita non
stata suf ciente ad assorbire laumento della forza lavoro dovuto anche al declino
dei posti in agricoltura pari al 30%. Per ottenere risultati signifcativi sarebbe neces-
sario un tasso di crescita economica annuo del 6-7%, mentre questo si attestato
al 5,2%
75
. La riduzione (efettiva o stimata) dei tassi di disoccupazione nei Paesi
dellarea MENA non cambia il dato allarmante secondo cui circa 2/3 delle donne
in et lavorativa continuano a restare fuori dal mercato del lavoro. In tutta larea, la
disoccupazione femminile si attesta intorno al 20-25%; anche nei ricchi paesi pro-
duttori di petrolio, come Oman e Bahreyn, il tasso di disoccupazione tra le giovani
74 Galal, A.; Reifers, J.L. (a cura di) Rapport Femise 2007 sur le Partenariat Euro-Mditerranen,
febbraio 2008, in http://www.femise.org/PDF/Femise_A2007fr.pdf, pp. 18-19; Razmara, S. Em-
ployment Programs: Overview and International Evidence, Presentation made at the World Bank
MENA Regional Conference on Job Creation and Skills Development, Cairo, Egypt, December
2005, in http://info.worldbank.org/etools/docs/library/206981/presentation%20employment%20
programs%20setareh.pdf, pp. 1-26.
75 World Bank, 2005 Economic Developments and Prospects: Oil Booms and Revenue Management.
Middle East and North African Region, Washington, D.C, IBRD, 2005, pp. 6-7, in http://sitere-
sources.worldbank.org/INTMENA/Resources/MENA-EDP2005.pdf. Rafer, K. Macro-economic
Evolutions of Arab Economies: a Foundation for Structural Reforms, in OFID Pamphlet Series, n. 36,
Vienna 2007, pp. 33-37, in http://www.opecfund.org/publications/PDF/pamphlet/ofd_pam36w.pdf.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 469 03/05/2013 11:11:27
470
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
donne in cerca di lavoro supera il 30%. La femminilizzazione della disoccupazione
divenuto un elemento dominante del quadro economico mediorientale gi dal-
la fne degli anni Novanta; le cause sono da ricercare in fattori socio-demografci,
economici e culturali. La crescita della potenziale forza lavoro femminile, dovuta
alle aspirazioni personali di donne sempre pi istruite e autonome, combinata con
lesigenza di una loro partecipazione ai bilanci familiari, si scontrata con linsuf -
ciente sviluppo economico, la mancanza di investimenti e la contrazione del settore
pubblico, che tradizionalmente assorbiva la gran parte della manodopera femminile.
Il settore privato ofre scarse opportunit lavorative women-friendly, mentre tollera
notevoli livelli di discriminazioni tra uomini e donne in termini salariali e di op-
portunit di carriera
76
. Gli stessi diritti delle donne alla protezione della salute, della
maternit, dellimpiego vengono facilmente aggirati.
I cambiamenti economici in atto in molti paesi MENA sono caratterizzati
da persistenti disuguaglianze tra uomini e donne: le donne restano per lo pi
concentrate in un numero di settori molto ristretto, oppure occupano il grosso
del lavoro a tempo parziale che, nei settori dove pi difuso, nasconde la na-
tura sessuale della sottoccupazione. Presentato come mezzo per conciliare vita
familiare e attivit economica, il lavoro a tempo parziale o informale impone alle
donne, soprattutto a quelle che occupano posizioni non qualifcate, orari fessibili
e bassi salari. Nel nuovo scenario economico che si va prospettando, le leggi a
tutela della maternit, lastensione obbligatoria dal lavoro, cos come le norme che
impongono ai datori di lavoro di fornire asili e altre forme di assistenza a partire
da un certo numero di lavoratrici (20 per la Giordania, 50 per Libia e Tunisia, 100
per lEgitto), si rivelano un boomerang per le donne che, a parit di competenze
e livello di istruzione, si vedono preferire i colleghi maschi. Unulteriore conse-
guenza della contrazione del pubblico impiego rappresentata dallo spostamento
del lavoro femminile verso il settore informale che, se da un lato crea nuove e
pi fessibili opportunit di lavoro anche per lavoratrici non qualifcate, dallaltro
pone le donne in una posizione di maggiore vulnerabilit, negando loro stabilit
lavorativa, coperture pensionistiche e assicurative, tutela della maternit, prospet-
tive di carriera a lungo termine. In Nord Africa, il lavoro informale (a esclusione
del settore agricolo) ha assorbito negli anni Novanta il 43,4% della forza lavoro,
di cui un signifcativo 27,3% costituito da donne
77
.
76 Moghadam, V.M.Womens Economic Participation in the Middle East. What Diference Has
Te Neoliberal Policy Turn Made?, in Journal of Middle East Womens Studies, vol. 1, no. 1 (Winter
2005), pp. 128-129. Si veda anche Jadi, L.; Zouaoui, M. Figures de la prcarit: genre et exclusion co-
nomique au Maroc, Secrtariat dtat charg de la famille, de lenfance et des personnes handicapes,
Casablanca, Editions Najah El Jadida, 2006.
77 Charmes, J. Trends in Informal Sector Employment in the Middle East, in Hakimian, H.;
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 470 03/05/2013 11:11:27
471
6. Formale o informale? Dinamiche delloccupazione femminile nellarea MENA
Il settore informale, in particolare nei paesi in via di sviluppo, comprende il
lavoro autonomo e le piccole-medie imprese, spesso a gestione familiare. Le attivit
informali sono caratterizzate da bassi investimenti in termini di capitale, training,
tecnologie, a cui corrispondono bassa redditivit e precarie condizioni di lavo-
ro. Lintroduzione delle QIZ (Qualifed Industrial Zones) in alcuni paesi dellarea
MENA (Egitto, Giordania), considerate una strategia vincente per incentivare gli
investimenti esteri e la cooperazione regionale, ha ampliato lincidenza del lavoro in-
formale, soprattutto in termini di deroghe alla legislazione vigente, anche in settori,
come la media e grande impresa o limpresa ad alto investimento tecnologico, in cui
dominavano contratti di lavoro formali. Lincidenza del lavoro informale aumenta
negli strati della popolazione con un basso livello di istruzione, tra i giovani alla
ricerca di un primo impiego, tra le donne e in agricoltura, settore in cui alta la
presenza femminile (nel 2002, in Marocco il 57,1% delle donne occupate lavorava
in agricoltura). In agricoltura, solo una piccola percentuale di donne titolare di
unazienda, la stragrande maggioranza (in Marocco si stima tra il 69 e l83,9%) lavo-
ra gratuitamente (e quindi senza coperture assicurative, previdenziali o altre forme di
garanzie) in aziende familiari: si tratta di un lavoro sommerso di cui non si riconosce
il contributo in termini di benessere familiare e formazione della ricchezza naziona-
le, che comincia quando le donne sono poco pi che bambine e va a sommarsi ai
gravosi impegni legati alla gestione domestica
78
.
Anche nel tessuto urbano, la concentrazione femminile nel settore informa-
le (lavori a tempo determinato o stagionali, collaborazioni domestiche, micro-
imprenditoria) spesso legata allesigenza di contribuire ai bilanci familiari o di
sostenere la famiglia nel caso delle donne divorziate o vedove che lo smantella-
mento delle strutture patriarcali, pi evidente nelle citt, lascia spesso prive di
aiuto morale o materiale
79
.
Le attivit delleconomia informale vengono svolte per lo pi in casa (parruc-
chiere o estetiste semi-professionali) o in strada (vendita ambulante), da donne
con un basso livello di istruzione, per lo pi sposate e con fgli. A volte, il maggior
ostacolo che esse incontrano laccesso al credito (anche micro-credito) per fnan-
ziare linizio di una piccola attivit. Alla marginalizzazione del lavoro femminile
danno spesso risposta le organizzazioni internazionali attraverso progetti di soste-
gno alla micro-imprenditoria o a cooperative di donne.
Nugent, J.B. (eds.) Trade Policy and Economic Integration in the Middle East and North Africa. Eco-
nomic Boundaries in Flux, London-New York, Routledge, 2004, p. 173.
78 Barkallil, N. Lmigration des Marocaines ou lchange dune prcarit contre une autre prca-
rit, in Mobilits au fminin, Tanger, 15-19 novembre 2005, in http://www.mmsh.univ-aix.fr/
lames/Papers/Barkallil.pdf, pp. 7-8.
79 Ivi, pp. 10-12.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 471 03/05/2013 11:11:27
472
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
Conclusioni
Le conseguenze politico-economiche delle riforme strutturali nei paesi dellarea
MENA rappresentano un costo sociale straordinario per le categorie sociali pi
deboli, non solo si aggrava lo scarto tra gli strati sociali, ma si assiste a una femmi-
nilizzazione della povert. Le donne hanno, in genere, meno diritti degli uomini
e questo le pone in una posizione pi debole di fronte ai cambiamenti economici;
le donne subiscono di pi la privatizzazione dei servizi: i tagli allistruzione e alla
sanit pubblica le espongono maggiormente al peso delle strutture patriarcali, li-
mitando le loro possibilit di emancipazione. La disarticolazione di interi settori
produttivi provoca laumento della disoccupazione femminile e lo spostamento
verso il settore informale che richiede manodopera a buon mercato.
Le donne sono state pi di altri vittime della polarizzazione delle societ che
ha accumulato le risorse nelle mani di unlite dirigente costituita da uomini. Esse
sono state considerate come non-attori, private di soggettivit, defnite tramite
le loro funzioni biologiche piuttosto che per la loro coscienza. Tuttavia, proprio
in questo scenario in cui le disuguaglianze crescono e si intensifca la violenza a
livello locale e internazionale, la dimensione di genere acquisisce unimportanza
strategica nel dibattito politico in corso nei paesi dellarea MENA nella misura in
cui le donne cercano di tenere insieme unit e diversit, innovazione e tradizione.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 472 03/05/2013 11:11:27
7. Gender e riforme economiche in Giordania
Claudia Corsi
La trasformazione del sistema economico giordano ha avuto inizio il 9 marzo del
1989, quando il Consiglio per la Pianifcazione ha deliberato ladozione delle po-
litiche di aggiustamento strutturale. Le riforme economiche si sono articolate in
tre distinti processi (stabilizzazione, privatizzazione e liberalizzazione) condotti in
linea con gli imperativi del Washington Consensus, in seguito sostituiti dalle poli-
tiche neoliberiste del Post Washington Consensus. Queste innovazioni rispecchia-
no anche lintervento della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale
in ambiti non direttamente riconducibili al settore economico, progressivamente
inseriti nel sistema delle conditionalities, quali la good governance e la democra-
tizzazione. I due istituti hanno lavorato coinvolgendo i singoli Governi af nch
riuscissero a presentare laggiustamento strutturale come una politica endogena,
attraverso limposizione di una tolleranza repressiva per incoraggiare i program-
mi di sviluppo locale
80
.
Dopo lapplicazione delle politiche di stabilizzazione macroeconomica e di
privatizzazione, previste dagli accordi conclusi con il Fondo Monetario Interna-
zionale e la Banca Mondiale, la Giordania ha sperimentato una crescita dei tas-
si di disoccupazione e un aumento delle disuguaglianze sociali. Le politiche di
risanamento della spesa pubblica sono state incentrate sulla diminuzione della
sovraoccupazione presente nel settore pubblico. Le spinte innescate dal processo
di globalizzazione e dalle politiche di privatizzazione, imposte dallaggiustamento
80 Cornia, G.A.; Helleiner, G. From Adjustment to Development in Africa: Confict, Controversy, Con-
vergence, Consensus?, London, Macmillan, 1994, pp. 10-11.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 473 03/05/2013 11:11:27
474
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
strutturale, hanno prodotto cambiamenti signifcativi nel mercato del lavoro, che
risulta attualmente caratterizzato da maggiore instabilit per la crescita progressiva
dei subcontratti, direttamente correlati allespansione delle grandi imprese
81
.
Le riforme economiche hanno comportato cambiamenti nei settori produttivi,
cos, mentre il settore agricolo continua ad assorbire una notevole percentuale di for-
za lavoro, sono cresciuti nellarea urbana il settore informale, caratterizzato da bassa
presenza di lavoratori salariati e da una concentrazione considerevole di autonomi,
e il mercato pubblico e privato. La difusione dei contratti a tempo determinato,
giustifcati dalla necessit di dotare il mercato del lavoro di maggiore fessibilit,
ha modifcato profondamente la struttura della forza lavoro giordana. Se, infatti, il
tasso di disoccupazione giovanile ha subito una lieve fessione, loccupazione degli
adulti di et superiore ai trenta anni diminuita. Queste forme di contratto
hanno inoltre contribuito ad accrescere notevolmente la disoccupazione fem-
minile
82
. Secondo recenti studi condotti dalla Banca Mondiale e dal Fondo Mo-
netario Internazionale, lattuale livello di partecipazione femminile al mercato del
lavoro rappresenta solo la met della forza lavoro disponibile
83
. Questa situazione
incide signifcativamente sullintera performance economica del Paese, generando
un alto tasso di dipendenza economica
84
.
Il limitato accesso della popolazione femminile al mercato del lavoro stret-
tamente legato allindice di povert del Paese. Il tasso di povert cronica molto
elevato nelle aree di Maan e Zarqa, mentre unalta percentuale di soggetti a rischio
vive nei distretti di Jarash e Mafraq
85
. Le motivazioni principali che disincentiva-
no laccesso delle donne al mercato del lavoro sono ascrivibili a fattori discrimina-
tori di varia natura. In primo luogo, si rileva la presenza di elevati tassi di segrega-
zione femminile verticale e orizzontale, superiori a quelli riscontrabili in altri Paesi
dellarea MENA
86
. Loccupazione femminile in Giordania quasi interamente
81 Grimshaw, D.P.; Rubery, J. Inter-Capital Relations and the Network Organisation: Redefning
the Work and Employment Nexus, in Cambridge Journal of Economics, n. 29, 2005, pp. 1027-1051,
1037.
82 Doumato, E.A:; Pripstein Posusney, M. Women and globalization in the Arab Middle East,
Boulder, Lynne Rienner Publishers, 2003, p. 69; Karshenas, M.; Moghadam, V.M. Social Policy in
the Middle East., Economical, Political and Gender Dynamics, Palgrave, Houndmills, 2006, p. 222.
83 Gender and Development in the Middle East and North Africa: Women in the Public Sphere, Wa-
shington D. C., World Bank, 2004, pp. 63-64.
84 Shaban, R.A.; Abu-Ghaida, D.; Salam Al Naimat, A. Poverty Alleviation in Jordan: Lessons for the Fu-
ture, Washington D. C., Te International Bank for Reconstruction and Development, 2001, pp. 7-13.
85 Ivi, p. 15.
86 Lindice di segregazione femminile verticale indica la concentrazione delloccupazione femminile
in settori caratterizzati da basse retribuzioni, mentre la segregazione orizzontale concerne lesistenza
di professioni svolte unicamente, o in maniera prevalente da lavoratori di genere femminile.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 474 03/05/2013 11:11:27
475
7. Gender e riforme economiche in Giordania
convogliata nel settore pubblico. Paradossalmente, lintroduzione di normative a
sostegno delle lavoratrici madri ha causato unulteriore riduzione del numero delle
dipendenti assunte dalle imprese private. Inoltre, alcuni studi dimostrano che le
donne percepiscono salari pi bassi e sono impegnate in attivit lavorative che non
consentono progressioni di carriera
87
.
Analogamente, vi sono ambiti in cui la partecipazione femminile molto
limitata, come avviene per la carriera giudiziaria e per quella diplomatica: infatti,
sono donne solo il 2% dei giudici, mentre solo diciassette donne sono entrate
a far parte del corpo diplomatico giordano su un totale di duecentonovantano-
ve rappresentanti
88
. Le ragioni principali di questo insuccesso sono individuabili
nella convinzione, raforzata anche dalle disposizioni del diritto islamico, che le
donne siano per natura pi facilmente infuenzabili e meno imparziali rispetto agli
uomini e dunque inadatte a ricoprire posizioni decisionali e di alta responsabilit.
Unaltra causa ostativa allimpiego della manodopera femminile strettamente
connessa a motivazioni sociali legate allelevato tasso di fertilit e alla preferenza
di nuclei familiari numerosi che relegano le donne essenzialmente ai loro doveri
di spose e madri
89
. Questo importante dato emerge anche dalla comparazione tra
il numero di donne sposate occupate e quello delle nubili, vedove o divorziate
90
.
La subordinazione del lavoro femminile a quello maschile riconosciuta anche
dalla legislazione vigente
91
. Esempio emblematico rappresentato dalla legge 52
del 2002, relativa allerogazione degli assegni familiari, che ha introdotto una di-
sposizione palesemente discriminatoria nei confronti delle donne, decretando che
tali assegni possano essere riconosciuti alla donna lavoratrice per i propri fgli solo
nei casi di decesso o disabilit permanente del coniuge. Un importante strumento
adottato dal governo giordano per ridurre la disoccupazione femminile stata
listituzione delle Qualifng Industrial Zones (QIZ)
92
che hanno attratto molta ma-
87 La maggior parte delle donne occupate impiegata nel settore ausiliario-sanitario, nellistruzione
o nel pubblico impiego.
88 Te Economic Advancement of Women in Jordan: a Country Gender Assessment, Social and Eco-
nomic Development Group Middle East and North Africa Region, May, 2005, p. 52, in http://
siteresources.worldbank.org/INTMNAREGTOPGENDER/Resources/JordanCGA2005.pdf.
89 Il tasso di fertilit femminile, che indica il numero di fgli per donna ed pari a 2,39, mentre let
media delle donne per il primo fglio di ventitre anni. Cfr Hijab, N. Womanpower: Te Arab Debate
on Women at Work, New York, Cambridge University Press, 1998, pp. 15-22.
90 Progress of Arab Women, United Nations Development Fund for Women, Arab States Regional
Of ce, Amman, 2004, p. 214.
91 Hijab, N.; Fawzi El Solh, C. Laws, Regulations and Practices Impeding Womens Economic Parti-
cipation in the Middle East and North Africa, Washington D.C., World Bank, August 2003, p. 12.
92 Le Qualifying Industrial Zones sono state istituite in seguito alla conclusione di un accordo con gli
Stati Uniti, volto alla defnizione di un programma agevolato di importazioni per alcuni prodotti
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 475 03/05/2013 11:11:27
476
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
nodopera proveniente da aree rurali alla sua prima esperienza lavorativa
93
. Si tratta
per lo pi di lavoratrici e lavoratori non qualifcati, in possesso solo di un titolo
di istruzione della scuola primaria, ai quali viene oferta una retribuzione che rag-
giunge appena il salario minimo imposto dalla legge. Secondo le statistiche del
Ministero del lavoro giordano, le QIZ hanno contribuito alla creazione di oltre
quarantacinquemila posti di lavoro; tuttavia, esse non hanno ridotto il tasso di
disoccupazione nazionale, in quanto gli stranieri impiegati in queste aree compon-
gono pi della met della forza lavoro totale. Uno dei fattori di insuccesso emerso
dallanalisi del mercato del lavoro nelle QIZ la durata dei contratti di impiego,
pari a circa diciannove mesi, contro gli ottantuno di una qualsiasi altra industria
94
.
Gran parte della popolazione femminile giordana impiegata nel settore in-
formale. Uno studio della Banca Mondiale stima che gli occupati in questo com-
parto siano circa duecentomila. Tuttavia, la rilevazione dei dati tiene conto unica-
mente delle attivit registrate e non include i lavoratori itineranti e il lavoro svolto
a domicilio, che corrispondono alla met delle prestazioni lavorative
95
. Lampia
difusione di questo settore una conseguenza diretta della carenza di garanzie e di
sussidi a sostegno dei disoccupati. In Giordania, infatti, il sistema degli ammortiz-
zatori sociali completamente assente. LIstituto di Statistica giordano stima che
attualmente circa un terzo della popolazione giovanile sia in cerca di occupazione.
In particolare, il 60% ha unet compresa tra i quindici e i ventiquattro anni (21%
della popolazione), mentre un terzo dei disoccupati rientra nel gruppo di et tra
i venticinque e i trentanove anni. Emergono diferenze sostanziali se si sceglie di
tracciare unanalisi del tasso di disoccupazione in funzione del parametro di gene-
re. Il mercato del lavoro giordano caratterizzato da una situazione anomala. Il
tasso di partecipazione economica molto basso poich gran parte della popola-
zione composta da studenti. Si assiste inoltre a una crescita del prepensionamen-
realizzati in Giordania. Il trattato nasce dallestensione di un precedente accordo commerciale di
libero scambio concluso tra Stati Uniti e Israele, che ha attribuito ad alcune zone del territorio
giordano ed egiziano lo status di border areas in cui consentito il passaggio delle merci in esenzione
doganale. Laccordo commerciale tra Giordania e Israele stato formalizzato nel 1997, in occasione
del summit economico di Doha ed entrato in vigore lanno successivo.
93 Le donne impiegate in queste zone costituiscono il 70% della forza lavoro totale. Cfr. Te eco-
nomic advancement cit., p. 16 e Women Workers in the Textiles and Garments Industries in Jordan: A
Research on the Impact of Globalization, Amman, International Labour Organisation (ILO)Ministry
of Labor, 2002, pp. 13-16.
94 Saif, I. Te Socio-Economic implications of the qualifed industrial zones in Jordan, Amman, Centre
for Strategic Studies, 2006, pp. 34-35; Ministry of Labour, Annual Report 2008, Amman, MoL,
2009, pp. 57-59 in http://www.carim.org/public/polsoctexts/PO3JOR1094_921.pdf
95 Christiaan Haan, H.; Mryyan, N. Skills Acquisition for the Informal Micro-Enterprise Sector in
Jordan, Turin, Background report, European Training Foundation/World Bank, 2003b, pp. 12-15.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 476 03/05/2013 11:11:28
477
7. Gender e riforme economiche in Giordania
to nel settore pubblico e allesistenza di un grande divario tra il livello di istruzione
media della popolazione, che piuttosto alto, e le oferte del mercato del lavoro
96
.
Listruzione costituisce un paradosso delle politiche sociali ed economiche adot-
tate dal governo giordano: da un lato troviamo, infatti, notevoli investimenti nel
settore, che si rifettono nel buon indice di sviluppo umano (HDI) attribuito
alla Giordania, mentre dallaltro la crescita del livello di istruzione, soprattutto
di quella universitaria, non ha contribuito a creare nuovi sbocchi occupazionali,
determinando un eccesso di forza lavoro qualifcata, costretta a trovare impieghi
non corrispondenti ai propri livelli di istruzione o, in alternativa, a emigrare
97
.
Un dato indicativo, che pu mostrare le profonde discriminazioni di genere
presenti sul mercato del lavoro, si deduce dalla presenza o meno di precedenti
esperienze lavorative tra i disoccupati in cerca di impiego: se, infatti, circa l80%
dei disoccupati maschi ha gi unesperienza di lavoro alle spalle, solo il 50% delle
donne si trova nella stessa condizione. Le imprese gestite dalle donne costitui-
scono solo il 3,9% del totale. Il 38,5% delle imprenditrici ha unet compresa
tra i venticinque e i trentaquattro anni e possiede un diploma o una laurea. Pi
di un terzo di esse lavora tra le quaranta e le quarantanove ore settimanali, prin-
cipalmente in imprese acquistate precedentemente o ereditate, nel 50% dei casi
gestendo la propria attivit insieme al coniuge o a un altro familiare. Solo lo 0,9%
delle imprese dirette da donne scaturisce da un investimento ex novo. Un recen-
te studio condotto sullimprenditoria femminile giordana identifca nel limitato
accesso alle risorse fnanziarie il principale freno allo sviluppo del settore. Il 17%
delle imprenditrici considera i meccanismi di accesso ai prestiti troppo complessi,
mentre il 10% confessa di non aver ottenuto fnanziamenti a causa della mancanza
di garanzie adeguate. Il 44% delle imprenditrici che fanno ricorso a prestiti ha
ottenuto erogazioni inferiori a 3540 dinar, segnale chiaro dellistituzione di pic-
cole imprese
98
. Risulta evidente che le imprese femminili possiedano una bassa
capacit di attrarre investimenti nazionali e stranieri. Anche le indagini sulla par-
tecipazione politica delle donne giordane palesano la presenza di meccanismi di
marginalizzazione della componente sociale femminile. Gli impegni istituzionali
delle candidate sono stati circoscritti al conferimento di dicasteri, per cos dire,
tradizionali, con le uniche eccezioni del ministero delle comunicazioni, conferito
a Laila Sharaf e di quello dellindustria, commercio e pianifcazione assegnato a
96 Dalle statistiche emerge che pi della met dei disoccupati (53%) possiede almeno il diploma,
con picchi del 76% perla popolazione femminile.
97 Jordan Human Development Report: Building Sustainable Livelihoods, Amman, s.e., 2004, p. 15.
98 Women Entrepreneurs in the Middle East and North Africa: Characteristics, Contributions and Chal-
lenges, Washington, DC, Te Center of Arab Women for Training and Research and Te Interna-
tional Finance Corporation Gender Entrepreneurship Markets, June 2007, p. 43.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 477 03/05/2013 11:11:28
478
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
Rima Khalaf. Se si considera, per, che ciascun governo comprende tra i venticin-
que e i trenta ministeri, evidente che la percentuale di partecipazione femminile
a incarichi governativi si riduca a circa il 3% del totale.
Una circostanza analoga si rispecchia nella societ civile. Le donne compon-
gono solo il 22% dei membri di associazioni volontarie, il 10% degli iscritti ai
partiti politici e il 23% delle rappresentanze sindacali. Nel 2001 stato presentato
un emendamento alla legge elettorale che ha istituito le quote rosa, stabilendo
che almeno otto seggi in Parlamento fossero attribuiti alle donne. La nuova leg-
ge elettorale, emanata nel 2002, ha aumentato il numero dei seggi da ottanta a
centodieci, modifcando il precedente meccanismo delle quote e imponendo un
sistema aperto che consente alle candidate di partecipare alla competizione con
altri candidati in ciascuno dei quarantacinque distretti, nel rispetto dellulteriore
quota di minoranza attribuita a cristiani, circassi e ceceni. Il sistema delle quote
rosa stato sfruttato dalle minoranze per ottenere rappresentanza in Parlamento,
determinando unincidenza signifcativa del ruolo svolto dalle componenti tribali
e religiose e vanifcando completamente lo scopo della nuova formula elettorale.
Conseguentemente, nonostante gli sforzi compiuti dal Governo, la partecipazione
delle donne alla vita politica del paese risulta falsata. Il principale ostacolo che si
frappone alla partecipazione politica della popolazione femminile in Giordania,
alla luce dei principali studi condotti, riconducibile alla persistenza di logiche
tribali, che impongono gli orientamenti politici delle candidate elette, permeando
il loro programma politico nel rispetto dellonore e degli ideali delle trib domi-
nanti
99
. Il fattore religioso, a diferenza
di quanto avviene in altri paesi dellarea MENA, incide in maniera limitata,
ma continua a condizionare la libert di espressione delle donne.
La scarsa partecipazione della componente sociale femminile al panorama
politico anche dovuta alle limitate capacit fnanziarie delle candidate, che non
sono in grado di sostenere i costi elevati delle campagne elettorali. Questo ele-
mento, sommato alla debolezza dei programmi elettorali proposti e alla limitata
capacit di attrarre consensi tra i votanti, genera reiterati insuccessi elettorali.
99 Al Attiyat, I.; Shteiwi, M.; Sweiss, S. Building Democracy in Jordan: Womens political Participation,
Political Party Life and Democratic Elections, Sweden, Trydells Tryckeri AB, 2005, p. 2.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 478 03/05/2013 11:11:28
8. Economia delloccupazione in Palestina:
genere, lavori informali e
Income Generating Projects
Valentina Venditti
Loccupazione militare, le relazioni economiche di dipendenza nei confronti dello
Stato israeliano e il mancato sviluppo industriale nei Territori Palestinesi Occupati
sono tra le cause principali del basso tasso di partecipazione di donne e uomini
alla forza lavoro formale
100
. Negli ultimi anni, la situazione stata ulteriormente
aggravata a seguito dellintensifcazione delle misure di controllo e di chiusura
imposte dal governo israeliano e dal cambiamento della politica di aiuto da parte
della comunit internazionale dopo le elezioni legislative palestinesi del 2006 che
hanno visto la vittoria di Hams
101
.
Per quanto riguarda le donne, ci sono sostanziali diferenze di genere nel mer-
cato del lavoro e loccupazione militare non fa che rinforzare la discriminazione
sia direttamente che indirettamente
102
. Il tasso di partecipazione delle donne alla
forza lavoro formale molto bassa. Un lieve incremento c stato tra il 2000 e il
2005 con una percentuale che cresciuta dal 12,7% al 14,1% per poi riscendere
al 12,7% nei primi mesi del 2006
103
. Nel 2007 si registrava un tasso del 15,7%,
di cui il 18,3% in Cisgiordania e l11% nella striscia di Gaza
104
. Loccupazione
100 Sabbagh, S. Arab Women: between Defance and Restraint, Massachussetts, Olive Branch Press,
2003, pp. 183-184.
101 Kuttab, E. Social and Economic Situation of Palestinian Women 2000-2006, Economic and Social
Commission for Western Asia (ESCWA), 2007, p. 20.
102 ILO, Te Situation of Workers of the Occupied Arab Territories, Geneva, International Labour Of-
fce, 2007, p. 25.
103 Kuttab, E. Social and Economic cit., p. 20.
104 Al-Tamimi, M. Working Women and the Siege, in Voice of Women, n. 240, 11 Maggio
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 479 03/05/2013 11:11:28
480
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
femminile concentrata nel settore dei servizi (41,4%) e dellagricoltura (45,1%).
Il Palestinian Women Researches and Documentation Center ha riscontrato una co-
stante crescita del lavoro informale femminile non pagato (26,9% nel 2001,
32,5% nel 2003, 33,3% nel 2005) nettamente superiore al tasso di lavoro infor-
male maschile, pari al 6,1% nel 2001, al 7,1% del 2003 e al 6,3% nel 2005. Le at-
tivit informali che molte donne svolgono in casa o in strada, solo raramente sono
incluse nelle statistiche uf ciali
105
. Le pi importanti motivazioni che spingono le
donne a intraprendere unattivit informale, come riscontrato dallindagine della
Birzeit University, sono:
1. supportare la famiglia (41,1% delle intervistate); la maggior parte delle donne
che hanno dato questa motivazione sono sposate e svolgono le loro attivit
in casa;
2. dif colt nel trovare un lavoro formale (30,3%); si tratta soprattutto di donne
che vivono nelle zone rurali;
3. migliori potenzialit attribuite ai lavori informali: il 23,4% delle intervistate
ha afermato di aver iniziato un lavoro informale per realizzare se stessa,
essere indipendenti e per interesse.
Questa motivazione stata data soprattutto dalle donne single e dalle donne dei
campi profughi. Per quanto riguarda la divisione per settori del lavoro informale, pi
di un terzo delle donne intervistate (35,5%) nel commercio. Si tratta soprattutto
di vedove o divorziate, con molti fgli e semi-analfabete. Il secondo settore di im-
piego informale rappresentato dai servizi (34,8%) dove sono occupate soprattutto
donne sposate con un livello di istruzione medio-alto. Circa un quarto delle donne
intervistate impiegato, invece, nel settore manifatturiero con una percentuale pi
alta nella Striscia di Gaza (26%) rispetto alla Cisgiordania (22,7%). Un terzo delle
donne che lavorano in questo settore sono single. Infne, un quinto delle donne in-
tervistate impiegato come parrucchiera ed estetista. La percentuale nella Striscia di
Gaza il doppio di quella della Cisgiordania. Bench la maggior parte delle donne
abbia afermato di aver iniziato da sola lattivit economica, solo una piccola percen-
tuale risultata essere la proprietaria della sede e dei beni.
L89% delle donne intervistate ha afermato di non avere alcun tipo di assi-
curazione o sicurezza sociale
106
. Lostacolo maggiore che incontrano molte donne
2006, WATC, Womens Afairs Technical Committee in http://www.watcpal.org/english/display.
asp?DocID=46.
105 Rubenberg, C. Palestinian Women: Patriarchy and Resistance in the West Bank, London, Lynne
Rienner Publisher, Inc., 2001, p. 193.
106 Esim, S.; Kuttab, E. Womens Informal Employment in Palestine: Securing a livelihood against all
odds, Washington DC, International Centre for Research on Women, mimeo, 2002, pp. 17-26.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 480 03/05/2013 11:11:28
481
8. Economia delloccupazione in Palestina: genere, lavori informali e Income Generating Projects
nellintraprendere un lavoro informale trovare il capitale necessario per iniziare (o
mantenere) unattivit generatrice di reddito. Gli IGP (Income Generating Projects)
sono uno dei mezzi per fornire credito alle donne palestinesi, si tratta soprattutto
di cooperative, progetti di economia domestica, progetti per business individuali o
di gruppo. Tuttavia, numerosi studi, come quello della studiosa palestinese Nahla
Abdo, hanno mostrato come l80% di questi progetti sia fallito. Le cause del falli-
mento vanno ricercate nel fatto che le agenzie che ofrivano credito non fornivano
anche adeguati training su marketing e fnanza; solo raramente veniva preso in
considerazione il contesto socio-economico in cui questi IGP dovevano andare a
operare; la priorit veniva data alla questione nazionale piuttosto che ai bisogni
strategici di genere
107
. Nonostante ci, gli IGP continuano a essere sostenuti da
parte delle agenzie e organizzazioni internazionali nelle loro strategie di sviluppo
spesso senza considerare che il settore informale uno dei settori delleconomia
in cui i livelli di sfruttamento sono pi alti. Inoltre, numerosi studi sullimpatto
delle cooperative sulla vita delle donne hanno dimostrato come un reddito mag-
giore non signifchi automaticamente un cambiamento nei gap di genere e, anzi,
le attivit generatrici di reddito svolte in casa, in alcune circostanze, non sfdano,
bens raforzano le responsabilit e i ruoli tradizionali
108
.
Gli IGP, emersi allinterno delle strategie volte a includere le donne nei progetti
di sviluppo, si inseriscono spesso in un nuovo sistema di ineguaglianza nella sfera
economica, incorporando le donne allinterno del discorso di sviluppo dominato dal
paradigma economico liberale. Inoltre, gli IGP promossi dallesterno e, in particola-
re, i programmi di micro-credito hanno introdotto una logica destabilizzante allin-
terno del movimento delle donne, interrompendo anche i programmi di cooperazio-
ne locale, che sono stati sostituiti da programmi dettati dai donatori internazionali,
ONG e agenzie di micro-credito
109
. Nahla Abdo, analizzando lef cacia e limpatto
dei primi progetti generatori di reddito sulle donne, sostiene che la maggior parte
degli studi efettuati, valutando solo gli aspetti tecnici e prettamente economici,
quali produttivit e livello di integrazione delle donne nelleconomia, ignoravano
il contesto politico, sociale e delle relazioni di genere. Una valutazione prettamente
economica sullef cienza di questi progetti importante, ma sicuramente non suf-
fciente nel contesto palestinese. La maggior parte di essi, infatti, rispondeva a un
discorso politico e nazionale che enfatizzava il boicottaggio del mercato israeliano e
lautosuf cienza come una strategia alternativa alla dipendenza da Israele.
107 Rubenberg, C. Palestinian Women cit., pp. 194-195.
108 Sabbagh, S. Arab Women cit., pp. 111-112.
109 Hanaf, S.; Tabar, L. Te Women and Development Discourse and Donor Intervention in
Palestine Histories Intersecting the Palestinian Womens Movement, in Auga, U.; Von Braun, C. (a
cura di) Gender in Conficts: Palestine-Israel-Germany, Berlino, Lit Verlag, 2006, pp. 199-234.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 481 03/05/2013 11:11:28
482
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
In questo studio intendo illustrare i risultati della mia ricerca sul campo
condotta su operatrici dello sviluppo e donne partecipanti a progetti di Income
Generating. Esse provengono da zone diferenti (Tulkarem, Nablus, Ramallah,
Hebron, Shufat), lavorano o collaborano con diferenti ONG (Sharek Youth
Forum, PWWSD, TAAWON), hanno situazioni familiari diverse, hanno avuto
esperienze di vita ed esigenze diferenti. La PWWSD (Palestinian Working Wo-
man Society for Development) sicuramente la pi militante tra le organizzazioni
che si occupano di donne lavoratrici. La scelta di intervistare le operatrici dello
sviluppo nata dalla voglia di analizzare le relazioni di genere allinterno delle loro
organizzazioni di riferimento, capire la percezione che queste donne, in quanto
donne lavoratrici, hanno di s e della societ in cui vivono.
Per quanto riguarda il lavoro informale sono stati somministrati questionari
individuali a donne delle citt di Jenin, Nablus, del campo profughi di Balata e
campo n. 1 (Nablus) e del villaggio di Kufr Jamml (Tulkarem); sono stati svolti
Focus Group Discussion con le donne dellassociazione femminile caritatevole di
Kufr Jamml e interviste individuali a responsabili di IGP. Accanto alle interviste,
un ruolo importante ha giocato la parte dialogica e libera degli incontri realizzati
che ha permesso di mettere in luce molte pi informazioni rispetto alle interviste
strutturate.
LAssociazione Femminile caritatevole di Kufr Jamma
-
l
Lincontro allassociazione di Kufr Jamml stato organizzato con laiuto della
PWWSD che collabora spesso con essa. Kufr Jamml un piccolo villaggio pa-
lestinese, al confne occidentale della Cisgiordania. Ha una popolazione di cir-
ca 4500 abitanti e la sua economia basata essenzialmente sullagricoltura. Kufr
Jamml, come molti altri villaggi a Nord della Cisgiordania, segnato nella sua
vita economica e sociale dalle conseguenze delloccupazione. La costruzione del
muro, infatti, ha privato la popolazione di gran parte delle sue terre e della possi-
bilit di raggiungere il luogo di lavoro. Questo uno dei motivi che ha spinto le
donne a lavorare nellassociazione. Lassociazione di donne di Kufr Jamml nata
nel 2004 dalla libera iniziativa di 15 donne e dagli sforzi di Maqbule Jaddal, origi-
naria di Tulkarem, che si trasferita al villaggio dopo il matrimonio, presidentessa
dellassociazione. Attualmente, lassociazione ha 180 membri tutti volontari. In
soli cinque anni essa riuscita a diventare un punto di riferimento per il villaggio,
unarea sociale di ritrovo per le donne e un centro di servizi per la comunit. Las-
sociazione ofre diversi tipi di servizi in collaborazione con altre organizzazioni o
ONG (come lUNIFEM, la PWWSD, i comitati agricoli): attivit teatrali con i
bambini sulla corretta alimentazione, supporto psicologico per le donne, training
di sensibilizzazione e cosi di formazione professionale. I training afrontano temi
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 482 03/05/2013 11:11:28
483
8. Economia delloccupazione in Palestina: genere, lavori informali e Income Generating Projects
come: la partecipazione politica delle donne e il processo di decision-making, i
diritti delle donne, la violenza fsica, verbale e psicologica contro le donne, ledu-
cazione sessuale, leducazione alimentare.
Molto importanti sono i corsi di ricamo, di cucina e food-processing che danno
alle donne la conoscenza teorica e pratica per poter poi lavorare autonomamente
in casa. Lassociazione svolge un servizio di catering e si occupa di promuovere
la vendita dei prodotti in occasione di fere e mostre. Unattivit molto interes-
sante quella chiamata network: si tratta di un servizio di microcredito senza
interessi gestito dalle stesse donne. Quando una donna ha necessit di denaro, gli
altri membri dellassociazione fanno una colletta e le danno i soldi in prestito. I
legami di amicizia e parentela garantiscono il pagamento del debito. Le 20 donne
dellorganizzazione intervistate hanno afermato di essere tutte molto soddisfatte
del loro lavoro allassociazione, sia per la formazione professionale che per gli altri
servizi oferti. Alcune ne hanno anche sottolineato limpatto sociale: Il lavoro
allorganizzazione utile per cambiare il pensiero tradizionale. Le donne hanno il
diritto di decidere cosa vogliono fare della loro vita ed hanno il diritto di dire no
quando non sono daccordo su qualcosa (Um Ali, 32 anni, sposata, laureata).
Questa voglia di cambiamento sociale si evince anche dallattivit, dalla mis-
sione e dai progetti dellassociazione che rappresenta per le donne del villaggio
un luogo di incontro e di identifcazione. Unidea rivoluzionaria in tal senso il
progetto di apertura di un caf al femminile. Per questo lassociazione diven-
tata non solo un mezzo per risolvere problemi pratici, ma anche uno strumento
di stimolo allazione e alliniziativa. I training, i momenti di sostegno rispetto ai
carichi familiari e i contatti che le donne creano tramite lassociazione sono dei fat-
tori fondamentali per la sostenibilit dei lavori che esse svolgono individualmen-
te. Per quanto concerne le motivazioni per intraprendere un lavoro informale, la
maggior parte delle donne dellassociazione ha addotto la necessit di supportare
economicamente la famiglia. Tuttavia, non sono mancate risposte diferenti: Ho
iniziato a lavorare perch ero annoiata (32 anni, laureata, sposata, 4 fgli); Ho
deciso di lavorare per costruire la mia vita (42 anni, diplomata, sposata, 2 fgli);
Ho iniziato a lavorare per aiutare la mia famiglia, poi ho scoperto che mi piace
(26 anni, diplomata, single); Ho iniziato a lavorare per far qualcosa che amo e in
cui credo (42 anni, diplomata, sposata, 4 fgli).
Nadia Kittana, coordinatrice della sede di Tulkarem della PWWSD, una del-
le organizzazioni che sostiene lassociazione di Kufr Jamml ha afermato che il
risultato pi importante raggiunto dalle associazioni e dalle cooperative di donne
stato iniziare a difondere nella societ la coscienza dellimportanza del lavoro
femminile: se prima una donna che lavorava era giudicata male, adesso cresce il
numero di ragazzi che preferisce sposare donne economicamente attive, natural-
mente questo anche un efetto della crisi economica.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 483 03/05/2013 11:11:28
484
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
Due esempi di IGP implementati dalla PWWSD
a) La cooperativa per lallevamento di ovini
Bayt Sr un piccolo villaggio agricolo di 2800 abitanti situato a Sud-Ovest di
Ramallah. A seguito delle misure di restrizione di movimento intraprese dal governo
israeliano a partire dalla seconda Intifd#ah e alla conseguente impossibilit per i pa-
lestinesi di raggiungere il loro posto di lavoro, la situazione economica del villaggio
si rapidamente deteriorata. La perdita del posto di lavoro degli uomini impiegati
in Israele ha spinto 15 donne di Bayt Sr ad aprire una cooperativa che permettesse
loro di mantenere la famiglia. La PWWSD ha sostenuto la loro iniziativa e le ha
aiutate nella creazione di una cooperativa per lallevamento degli ovini e la produ-
zione casearia. Le donne hanno proposto allorganizzazione la loro idea, seguito corsi
di formazione professionali e ottenuto credito per iniziare lattivit. Una parte del
credito stato utilizzato per comprare gli ovini, e laltro per comprare foraggio e co-
struire un granaio. La PWWSD ha seguito tutte le questioni fnanziarie e ammini-
strative oltre a organizzare training in contabilit, procedure di credito, management
e informatica per le partecipanti al progetto. Le donne di Bayt Sr hanno afermato
che, dopo aver iniziato a lavorare, la loro posizione sociale cambiata in famiglia e
nella societ. Gli abitanti del villaggio, ad esempio, guardano alla cooperativa con
ammirazione e vogliono imparare dalle donne. Le necessit economiche e il tipo
di lavoro svolto, agricoltura e allevamento, hanno reso sin dallinizio socialmente
accettabile lidea della cooperativa di donne. La cooperativa parte del progetto di
microcredito implementato dalla PWWSD a partire dal 2003.
b) LIGP Lamasa
-
t (tocchi)
Lamast un progetto di Income Generation attraverso il ricamo, di natura prevalen-
temente emergenziale. Nato del 2003, esso mira a sostenere le donne palestinesi pi
marginalizzate nella ricerca di un reddito minimo che consenta loro di soddisfare
i bisogni basilari. Nella visione strategica della PWWSD, questa fase risulta essere
fondamentale nel processo di presa di coscienza dei propri diritti civili e di empower-
ment delle donne che si rifetteranno sullintera societ palestinese. Al tempo stesso,
il progetto partecipa al pi ampio obiettivo di sradicare la povert nella societ pale-
stinese che va aggravandosi ulteriormente anche a causa della costruzione del muro
di separazione e contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale palestinese.
Allinizio erano solo due le donne che facevano parte del progetto, il numero delle
partecipanti poi cresciuto gradualmente nel corso del tempo e oggi se ne contano
trenta. Queste donne hanno tutte tra i 30 e i 45 anni, provengono da vari villaggi
del governatorato di Ramallah, hanno un basso livello di istruzione e condizioni
familiari molto dif cili: sono divorziate, vedove, ex-prigioniere, mogli di martiri o
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 484 03/05/2013 11:11:28
485
8. Economia delloccupazione in Palestina: genere, lavori informali e Income Generating Projects
fanno parte di famiglie numerose. Molte hanno gi avuto unesperienza lavorativa.
Le partecipanti al progetto realizzano lavori di ricamo e di artigianato, attivit molto
comuni tra le donne in Palestina. Lorganizzazione fornisce training sia teorici che
pratici su produzione e marketing e procura il materiale necessario. Questo permette
alle donne di svolgere gran parte del loro lavoro in casa; viene chiesto loro, infatti, di
recarsi presso la sede dellorganizzazione solo per i corsi di formazione e i momenti
di incontro che vengono organizzati una o due volte la settimana. Questi ultimi
rappresentano un importante momento di scambio tra le partecipanti di esperienze
e idee utili al miglioramento della qualit del prodotto. Il lavorare in casa e svolgere
attivit di cucito e ricamo, considerati parte del ruolo naturale della donna, rende
questo tipo di lavoro pienamente accettabile nella societ. Le donne creano tutto o
parte del prodotto e vengono pagate in anticipo dalla PWWSD. Il reddito di cia-
scuna donna viene calcolato in proporzione alla quantit di manufatti realizzati nel
corso di un dato periodo di tempo. Le merci vengono commercializzate attraverso
la show-room dellassociazione a Ramallah, attraverso il sito web dellassociazione
o venduti direttamente dalle donne. Il punto pi debole di questo progetto, de-
rivante dalla sua natura prettamente emergenziale, la sua totale dipendenza dai
fnanziatori stranieri, fattore che non ne garantisce la sostenibilit. La materia prima
necessaria, infatti, molto costosa e spesso deve essere importata dalla Giordania o
dallestero mentre la commercializzazione di questo tipo di prodotti non semplice.
Conclusioni
Linformalizzazione del lavoro stata accompagnata da un aumento dellinsicu-
rezza e della povert e dalla cosiddetta femminilizzazione del lavoro. Nei periodi
di crisi, le donne giocano un ruolo fondamentale nel supportare le famiglie sia
psicologicamente che economicamente. Le risposte alloccupazione e alla costante
instabilit politica comprendono una serie di meccanismi di resistenza alcuni
dei quali possono risultare non sostenibili o avere efetti di lungo termine nega-
tivi. Tra questi meccanismi vi laiuto esterno, gli Income Generating Projects e i
lavori informali. Per quanto riguarda il primo, sebbene ci sia una forte dipendenza
dei territori dallaiuto internazionale, questa soluzione non pu essere considerata
sostenibile. Laiuto, infatti, se fornisce cibo, lavori temporanei e assistenza sociale
alle fasce pi povere della popolazione, non crea vero sviluppo n crescita ma
aumenta, invece, la dipendenza del paese ricevente nei confronti del donatore e
rende il primo vulnerabile ai cambiamenti di politica del secondo. Questo quan-
to si osservato nei TPO a seguito della vittoria di Hams nelle elezioni legislative
del 2006 quando lembargo e le sanzioni imposte dalla comunit internazionale,
assieme al cambiamento nella politica degli aiuti, hanno paralizzato il funziona-
mento dellAutorit Palestinese. Il mercato del lavoro palestinese opera allinterno
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 485 03/05/2013 11:11:28
486
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
di un contesto di occupazione militare con conseguenti restrizioni di mobilit per
uomini e donne. Il tasso di partecipazione femminile alla forza lavoro formale risulta
particolarmente basso a causa di fattori sia strutturali che ideologico-culturali. A
causa delle opportunit limitate nel settore formale e della necessit di far fronte alle
peggiorate condizioni economiche, il tasso di partecipazione delle donne in quello
informale come strategia familiare di sopravvivenza crescente. Bench la relazione
tra lavoro ed empowerment non sia stata dimostrata, la maggior parte delle donne
intervistate crede che lintegrazione nel mercato del lavoro sia un primo passo im-
portante per combattere la discriminazione e acquisire potere decisionale allinterno
della famiglia e della societ. Le organizzazioni internazionali e palestinesi puntano
sulla microeconomia e sugli IGP per supportare lintegrazione delle donne nelleco-
nomia e combattere la povert. Ancora oggi gli IGP continuano a essere le maggiori
componenti delle strategie di sviluppo seguite dalla maggior parte di attori locali e
internazionali, seppure con alcune diferenze rispetto al passato. Il discorso politico e
la questione nazionale sembrano essere passati in secondo piano rispetto alle necessi-
t economiche, mentre la formazione tecnica e professionale su marketing e fnanza,
assente nei primi esperimenti di IGP, oggi viene fornita in modo adeguato; tuttavia
manca ancora unanalisi delle disuguaglianze intra-familiari e dellaccesso disuguale
al reddito, alleredit e alla propriet. Infne, gli IGP che hanno come target le donne
delle fasce pi povere e marginalizzate dipendono in larga misura da fnanziamenti
esterni senza i quali non potrebbero funzionare. Da questo punto di vista, le coope-
rative agricole risultano essere le pi sostenibili perch hanno a disposizione terreni
da coltivare, animali da pascolo o allevamento e macchinari che permettono loro
di lavorare in maniera autonoma. Nel breve termine, lassistenza allo sviluppo e il
microcredito continueranno a essere utilizzati come reti di sicurezza per garantire la
sopravvivenza delle famiglie pi povere ma non sono suf cienti per creare possibilit
di impiego sostenibili.
Alcuni IGP possono rappresentare una sfda ai ruoli di genere, come nel caso
dellassociazione di Kufr Jamml, diventata per le donne del villaggio uno stru-
mento di realizzazione, uno stimolo per lazione e liniziativa. A mio avviso, sem-
brano essere proprio queste iniziative dal basso, queste forme di collaborazione
e reti di solidariet tra donne ad avere maggiore ef cacia sia a livello economico
che sociale. In ogni caso, considerare il lavoro informale e gli IGP come delle
strategie di resistenza alla crisi o come strumenti di liberazione sociale non deve
farci dimenticare la condizione di sfruttamento in cui si trovano coloro che sono
impiegati in questo settore.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 486 03/05/2013 11:11:28
9. Mani da manicure preparano bobine
elettriche: la partecipazione femminile alla
migrazione turca in Germania Occidentale
Lea Nocera
Mani da manicure: in Germania preparano bobine elettriche, cos titolava nel
1964 il quotidiano Tercman
110
. Un gruppo di donne turche, vestite e curate
come mannequin per una sflata, con le mani da manicure e piedi da pedicure, con
i capelli tinti, giovani e istruite, hanno da poco cominciato un corso per operaie
proseguiva larticolo.
Brune, castane, bionde tutte giovani e belle. Inoltre, hanno in media un livello
di istruzione che corrisponde alla scuola media alcune sono anche diplomate.
Queste donne, giovani, belle e istruite si sono presentate come operaie e ora, per
diventarlo, parteciperanno a un corso di 21 giorni. [] Nonostante la bellezza
e leducazione, andranno in Germania come operaie Lavoreranno in una
fabbrica della Siemens.
Tutte per lavoro si occuperanno di transistor, e per mestiere diventeranno elet-
triciste.
Nellarticolo particolare la rilevanza data al fattore estetico che caratterizzava
queste donne, prima di recarsi a lavorare in Germania. Lattenzione a questi dettagli
pu essere letta in relazione al tono con cui la stampa turca si riferiva alle donne che
lasciavano il paese e che corrispondeva alla preoccupazione difusa per cui queste
donne, giovani e belle, andando a lavorare in Europa mettessero a repentaglio il
proprio onore e la propria rispettabilit. Eppure, il dettaglio riguardante le mani di
110 Tercman, 17 ottobre 1964: Manikrl eller, Almanyada elektrik bobini saracak.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 487 03/05/2013 11:11:28
488
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
queste future operaie, e di cui si parla gi nel titolo, non solo un particolare frivolo.
Nelle lettere che i datori di lavoro tedeschi spedivano al Bundesanstalt fr Arbeit,
lEnte federale per il lavoro della Germania occidentale, in cui si richiedeva mano-
dopera femminile, cera sempre una specifca richiesta: che le operaie avessero mani
piccole e abili. La Fingerfertigkeit, la destrezza manuale, legata a dita svelte e agili era,
infatti, uno dei requisiti fondamentali per fabbriche come la Siemens, lAEG-Tele-
funken e la DeTeWe in cui le operaie dovevano montare e saldare piccoli congegni
elettronici per i primi elettrodomestici o intrecciare i cavi elettrici dei primi telefoni
e delle prime televisioni. Si trattava di un lavoro di precisione, da svolgere il pi delle
volte con laiuto di una lente di ingrandimento. Possedere una buona capacit visiva
(Sehvermgen) era, per questultimo motivo, il secondo requisito.
La migrazione turca di massa in Germania occidentale ha inizio nellautunno
1961 quando il governo tedesco occidentale decide di siglare con la Turchia un
accordo bilaterale per lassunzione di manodopera
111
. La Germania occidentale
ampliava in questo modo il bacino di manodopera rappresentato da altri Paesi
dellEuropa mediterranea, tra cui lItalia innanzitutto, primo Paese ad aver frmato
un accordo analogo nel 1955. Da parte turca, lemigrazione era considerata uno
strumento chiave dello sviluppo economico del Paese perch permetteva sia di
ridurre drasticamente la disoccupazione sia di godere delle rimesse dei migranti.
Inoltre, la temporanea esperienza dei lavoratori allestero avrebbe facilitato, nellot-
tica del governo turco, il processo di modernizzazione del Paese. Tra il 1961 e il
1973, periodo in cui in Germania occidentale vigeva tale sistema di immigrazione
regolamentata, migliaia di donne turche
112
partirono per le citt e i principali poli
industriali tedeschi, in diversi casi da sole, precedendo i propri mariti. In altri,
dopo aver ottenuto il ricongiungimento familiare, furono inserite rapidamente
nel mercato del lavoro e poterono in tal modo prendere parte direttamente, sin da
subito, al progetto economico che aveva motivato la loro partenza.
Lassunzione di donne attraverso le commissioni e i centri di reclutamento te-
deschi situati nei paesi vincolati agli accordi per il trasferimento di manodopera
111 Hunn, K. Nchstes Jahr kehren wir zurck. Die Geschichte der trkischen Gastarbeiter in der
Bundesrepublik, Gttingen, Wallstein Verlag, 2005, pp. 29-59; Jamin, M. Die deutsch-trkische
Anwerbevereinbarung von 1961-1964, in DOMiT, 40 Jahre Fremde Heimat. Yaban Slan Olur.
Einwanderung aus der Trkei, 2001, Kln, pp. 69-82.
112 In base alle cifre riportate dalle relazioni annuali (Erfahrungsbericht) del Bundesanstalt fr Ar-
beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (Ente Federale per il reclutamento di manodopera e
per la previdenza, dora in poi BAVAV), le donne turche assunte tramite il sistema di reclutamento
tedesco sono, tra il 1961 e il 1973, oltre 138mila, rispetto ai 509 mila uomini. Le lavoratrici straniere
attive in ordine di rilevanza numerica: jugoslave, turche, greche, italiane, spagnole, portoghesi in
Germania occidentale nel 1973 sono in totale 706 mila. BAVAV, Erfahrungberichten, Nrnberg,
1961-1972/73.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 488 03/05/2013 11:11:28
489
9. Mani da manicure preparano bobine elettriche
incontra numerosi ostacoli e dif colt, soprattutto fno agli anni della recessione del
1966-67. Mentre dal punto di vista tedesco il reclutamento di manodopera femmi-
nile si regolava principalmente secondo le dinamiche della domanda e delloferta,
nella prospettiva del Paese di partenza loferta dipendeva dalle politiche di migrazio-
ne operaia del Paese, dalla legislazione in materia, dalle tradizioni migratorie e, per
quanto riguarda in particolare la migrazione femminile, dalle norme e dal sistema
di valori che regnavano tanto tra le istituzioni quanto nella popolazione
113
. A queste
ragioni si aggiungevano, inoltre, condizioni di lavoro poco qualifcanti e mal remu-
nerate, quindi scoraggianti
114
. Le donne che lasciano la Turchia per lavoro sono per il
37,3% dei casi nubili, per il 44,8% sposate e per unuguale percentuale, pari al 9%,
vedove e divorziate
115
. A diferenza di quanto si crede comunemente, nei primi anni
soprattutto, non si tratta sempre di donne che partono per la Germania al seguito
del marito, ma sono loro, talvolta, le pioniere di una migrazione familiare e a catena
che si consolida nel tempo. Le donne turche decidono di lasciare il Paese, ancor pi
degli uomini, non per motivi economici, ma con la curiosit e la voglia di sperimen-
tare la vita nella societ europea, vivono la migrazione come la tappa di un percorso
individuale di crescita ed emancipazione
116
. In alcuni casi, partono per la Germania
dopo la separazione, il divorzio o la morte del marito, per svincolarsi dalle pressioni
della societ, dalle considerazioni morali che accompagnano lesistenza femminile e
poter continuare a condurre la propria vita in modo autonomo; altre volte la migra-
zione si rivela anche una possibilit di fuga da restrizioni e costrizioni familiari, quale
pu essere spesso il matrimonio.
In alcune pagine dei giornali turchi distribuiti in Germania occidentale com-
paiono decine di fototessere accompagnate da didascalie in cui si chiedono noti-
zie, tracce, risposte. In molti casi si tratta di uomini che cercano le proprie mogli e
sorelle o mariti che promettono il divorzio in cambio di un ritorno
117
.
Come titola un quotidiano turco nel 1964: Le donne vanno in Germania non
per soldi ma per vivere liberamente. In esso si aferma, sulla base dei dati raccolti dal
DPT (Devlet Planlama Tekilati, lOrganizzazione statale di pianifcazione):
113 Mattes, M. Gastarbeiterinnen in der Bundesrepublik, Frankfurt-New York, Campus Verlag, 2005,
pp. 40, 82.
114 Nel 1965 viene stabilito dal governo turco che il salario minimo orario, da accettare per inviare
i lavoratori allestero, deve essere pari a 3 DM per gli uomini e a 2,50 per le donne. BundesArchiv
Koblenz (BAK), B119/3073, Bd. 4, Deutsche Verbindungsstelle in der Trkei an der BAVAV, Min-
deststundenlhne, 7.12.1965.
115 Nermin Abadan, Studie ber die Lage und Probleme der trkischen Gastarbeiter in der BRD. 1964:
Arbeitsplatz Europa, Kln, Bildungswerk Europische Politik, 1966, p. 61.
116 Erylmaz, A.; Mathilde, J. (hrsg.) Fremde Heimat. Eine Geschichte der Einwanderung aus der
Trkei, Essen, Klartext Verlag, 1998.
117 Si veda Hrriyet, marzo 1965.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 489 03/05/2013 11:11:28
490
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
La ragione per cui le nostre ragazze e donne vanno in Germania non risiede nel
desiderio di guadagnare soldi quanto nella voglia di vivere in una condizione di
libert e uguaglianza. Le donne turche che lavorano in Germania in confronto
agli uomini hanno un livello di istruzione pi elevato, appartengono alla classe
media delle grandi citt e decidono di partire con il desiderio di liberarsi delle
pressioni familiari e sociali e di vivere in condizioni di libert e apertura
118
.
In realt, le motivazioni che giustifcano le partenze sono le pi disparate. Il
progetto comune di rimanere qualche anno in Germania, il tempo suf ciente per
mettere da parte un po di soldi e rendere quindi pi rapido un miglioramento della
propria situazione sociale. La Germania ofre lopportunit di fare quel salto quali-
tativo che in Turchia non possibile, per questioni economiche, politiche e sociali.
Aprire unattivit propria, continuare a studiare, imparare il tedesco, comprarsi la
macchina o assicurare un futuro solido alla propria giovane famiglia indipendente-
mente dai suoceri sono solo alcune delle ragioni che indicano i migranti turchi. Un
elemento di attrazione che richiama donne e uomini turchi a Berlino e in Germania
occidentale rappresentato dallacquisto di beni di consumo: lautomobile il vero
oggetto del desiderio, ma anche apparecchi elettronici, come la radio, sono nella lista
dei primi acquisti da realizzare. Attraverso particolari beni di consumo si ha la possi-
bilit di negoziare la propria posizione sociale, di defnire percorsi di soggettivazione
o costruzione identitaria. Non un caso che anche giovani donne giustifchino spes-
so la loro migrazione con il desiderio di possedere e guidare una macchina. Come
spiega Kandiyoti, in un saggio in cui prende in esame gli efetti delle trasformazioni
sociali generate dal processo di modernizzazione in Turchia sulla costruzione delli-
dentit di genere, le donne negli anni Cinquanta si ritrovano a confrontarsi con un
modello di donna moderna la cui libert ed emancipazione ottenuta al prezzo di
rigore morale e manifesta castit. La donna moderna deve poter agire in pubblico
senza correre il rischio di essere importunata o molestata, per far ci deve quindi
riuscire ad amministrare un apparato di codici e segni che rimandino a unimmagine
di s neutrale e di indisponibilit sessuale. Di fronte a questa tensione identitaria,
le donne si adoperano, attraverso diverse modalit a seconda della loro posizione
sociale, in molteplici tentativi per lafermazione di s come persone indipendenti
e come donne. Ci avviene, in particolare per le donne appartenenti alle classi me-
die urbane, trasponendo abitudini di intrattenimento e socialit allinterno di spazi
anonimi, come classi o uf ci, oppure attraverso laccesso a un alto livello di consumi,
anche per esempio guidando una propria macchina.
118 Tercman, 5 dicembre 1964. Larticolo fa riferimento allinchiesta di Abadan, N. Bat Alman-
yadaki Trk iileri ve Sorunlar (I lavoratori turchi in Germania e i loro problemi), Ankara, Babakanlik
Devlet Planlama Tekilati,1964.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 490 03/05/2013 11:11:28
491
9. Mani da manicure preparano bobine elettriche
In Turchia, a partire dalla met degli anni Cinquanta e in modo pi capillare
negli anni Sessanta, negli stessi anni in cui ha inizio il processo di industrializzazio-
ne del Paese e si verifcano grandi spostamenti di popolazione dalle zone orientali
verso le metropoli sulla costa del Mediterraneo, avviene contemporaneamente un
cambiamento nellimmagine di modernit a cui devono ispirarsi i cittadini turchi
e pi di tutti la classe media. Accanto ai pi difusi canoni europei, grazie alle ri-
viste settimanali e alla cinematografa di produzione nordamericana ed europea, si
difonde lidea dellAmerican way of life
119
. In particolare, si detta uno stile di vita
che fa del consumo e del benessere il suo punto principale. Nelle rubriche delle
edizioni turche di alcune riviste americane come Btn Dnya (Readers Digest),
Hayat (Life), Time, Aile, Seksoloji si aggiornano i costumi della popolazione par-
lando di moda e di questioni di genere, di ricette di cucina e turismo, di sessualit
e vita domestica
120
. Le star di Hollywood, dal canto loro, sui grandi schermi, ofro-
no unimmagine diretta e allettante di cosa signifca la vita in un paese moderno.
Il cinema, lintrattenimento culturale di massa pi difuso in Turchia, il luogo in
cui si costruisce limmaginario di molti migranti
121
.
Nellinteresse che suscita la migrazione turca verso la Germania nellopinione
pubblica, nei commenti e nelle cronache della stampa e nei discorsi pubblici, la
migrazione femminile occupa un posto particolare
122
. Le partenze delle donne
sembrano attrarre maggiormente lattenzione da parte della popolazione e delle
autorit. Dalla Germania arrivano richieste continue e specifche di manodopera
femminile che i giornali riportano con regolarit e con non poco senso critico. Le
facilitazioni oferte alle donne perch vadano a lavorare nelle industrie tedesche
119 Sulla difusione dello stile di vita e di modelli di consumo americani: Strasser, S. (ed.) Getting and
Spending. American and European Consumer Society in the Twentieth Century, Washington-New York,
Cambridge University Press, 1998.
120 Yildirim, U. Magazin ierikli dergilerde Amerikan imgesinin inas (La costruzione dellimma-
gine dellAmerica nelle riviste magazine), in Toplum ve Bilim, n. 94, 2002, pp. 211-244.
121 Bker, S. Te flm does not end with an ecstatic kiss, in Kandiyoti, D.; Saktanber, A. (eds.) Frag-
ments of Culture. Te Everyday of Modern Turkey, London-New York, I.B. Tauris, 2002, pp.147- 170.
122 Per avere unidea della mole di articoli dedicati ecco alcuni titoli apparsi sui principali quotidiani
turchi tra il 1961 e il 1965 Tercman, 15 ottobre 1961: Almanyaya 332 kadn ii de gitmek istiyor
(In Germania vogliono andare anche 332 donne) 332 donne su 15.209 domande; Tercman, 2
novembre 1962: Almanya bizden kadn ii istigo (La Germania vuole da noi donne operaie);
Tercman, 26 maggio 1965 Almanya daha ok kadn ii istiyor (La Germania vuole ancora pi
lavoratrici); Tercman, 11 dicembre 1965: Bu yl Almanyaya giden her 3 kiiden 1ikadn 2si erkek
(Questanno su tre persone che partono per la Germania una donna e due uomini); Tercman, 24
giugno 1965: Almanyade i isteyen kadnlar derhal yollanacak (Le donne che vogliono lavorare
in Germania partono subito); Cumhuriyet, 18 agosto 1963: Almanya yeniden kadn ii istiyor (La
Germania chiede ancora lavoratrici); Hrriyet, 25 settembre 1964: Yabanc memleketlerden kadn
iiler isteniyor (I paesi stranieri chiedono donne lavoratrici).
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 491 03/05/2013 11:11:28
492
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
contrastano con le lunghe fle di attesa degli uomini. Per le donne assunzioni e
trasferimenti avvengono in tempi molto pi brevi. Alle donne, inoltre, oferta
spesso la possibilit di scegliere in quale citt andare oppure di ripetere nuova-
mente, in caso di ritorno, la procedura per unaltra partenza. Questi vantaggi non
sono per salutati con favore dallopinione pubblica, come ci si aspetterebbe, dato
il grande consenso e lottimismo dei racconti con cui si parla della migrazione in
Germania in generale. La migrazione femminile suscita piuttosto preoccupazione
e dubbi. Latteggiamento della stampa a proposito delle donne cambia, contrad-
dice quanto si racconta in generale sulla vita in Europa: oltre il confne turco, alle
donne riservato un destino dif cile, pieno di ostacoli e dif colt, rischioso.
Se partendo per la Germania alcune donne fanno la scelta di sottrarsi a un
controllo sociale difuso, con lobiettivo, in parte raggiunto, di sovvertire i clich
sui ruoli sociali
123
, tuttavia si devono confrontare con una continua attenzione nei
loro riguardi da parte dei loro connazionali e della stampa turca. In particolare
sulla loro vita sociale, sul modo in cui trascorrono il tempo libero che si soferma
lo sguardo esterno e si esercita il giudizio morale
124
. In molte delle cronache sulla
vita dei lavoratori turchi in Germania, si racconta di donne che frequentano bar e
club, che bevono e fumano, che trascorrono i fne settimana a ballare con uomini
sconosciuti e compagni occasionali.
Con particolare disappunto, si sottolinea come le donne turche rifutino di
frequentare i propri connazionali, di stringere amicizia con loro mentre prefe-
riscano stare con gli americani e i tedeschi, o addirittura con gli altri stranieri,
soprattutto con gli italiani. Cos facendo si commenta le donne mettono a
rischio la propria rispettabilit e il proprio onore e, quindi, in modo direttamente
consequenziale lonore della Turchia intera. La stampa turca, quindi, contribuisce
in grossa misura nel difondere e promuovere unimmagine della donna turca,
sola, macchiata dalla cattiva reputazione come se, lontano dal controllo sociale
della societ turca e senza uomini al proprio fanco, le donne siano destinate ne-
cessariamente ad una vita sregolata e immorale. I quotidiani forniscono spesso
cronache di avvenimenti e storie spiacevoli di alcune donne, ubriache, tradite,
123 Karakasolu, Y. Geschlechtsidentitten unter trkischen Migranten und Migrantinnen in der Bun-
desrepublik (Beitrag zum 8. Deutsch-Trkischen Symposium der Krber-Stiftung, 19.-21. April
2002, Gstehaus Petersberg, Universitt Essen).
124 Si riportano, tuttavia, con toni di approvazione notizie riguardanti scelte matrimoniali a van-
taggio di uomini turchi con precisione e regolarit si riporta il numero dei matrimoni misti e di
quelli con connazionali. Tercman, 5 aprile 1965: 987 Trk kz Almanlarla izdiva yapt (987
ragazze turche si sono sposate con tedeschi); Hrriyet, 18 agosto 1963: Almanyada 20 trk ii kz
erkek Trk ii ile evlendi (Venti lavoratrici turche si sono sposate in Germania con uomini turchi);
Hrriyet, 19 giugno 1965: Gurbette evlenmeler artyor (Aumentano i matrimoni allestero).
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 492 03/05/2013 11:11:28
493
9. Mani da manicure preparano bobine elettriche
abbandonate
125
. Alle storie di successo di cui sono protagonisti i migranti turchi
corrispondono le storie sfortunate e disperate delle donne. Ma come non tutto
oro quel che luccica per quanto riguarda gli uomini, cos non sempre nera come
la pece lesperienza migratoria delle donne.
Analizzare la migrazione turca in Germania occidentale in una prospettiva di
genere permette di rivalutare il contributo e la partecipazione femminile al feno-
meno migratorio turco. E, innanzitutto, ci signifca non considerare la migra-
zione turca come un processo omogeneo, indiferenziato, assoggettato agli stessi
meccanismi: in altri termini, una migrazione dai tratti profondamente maschili,
di origine rurale e motivata esclusivamente da ragioni economiche, in cui le donne
sono soltanto fgure in secondo piano, mogli a seguito. Osservando il fenome-
no da una prospettiva che parte dal paese di origine dei migranti, la Turchia, si
pu cogliere linsieme di fattori politici e sociali che costituiscono il contesto di
partenza; una serie di variabili caratteristiche, disposizioni e atteggiamenti so-
cialmente determinati di cui gli emigrati sono portatori gi prima del loro arrivo
che intervengono fuori dellemigrazione ma che nondimeno ne determinano
le condizioni e le caratteristiche conclusive. La partecipazione delle donne alla
migrazione racconta molto delle trasformazioni socioculturali (nella famiglia, nei
rapporti di genere e intergenerazionali, nel consumo, in generale nel processo di
individualizzazione) che investono la Turchia negli anni Sessanta e allo stesso tem-
po rivela come si visto brevemente nelle descrizioni della stampa le asperit
che si accompagnano a ogni cambiamento, come in questo caso si pu leggere
nelle dif colt ad accettare nuovi modelli femminili, rappresentati dalle donne in
partenza per la Germania.
In un senso pi ampio, infne, analizzare in modo pi attento le origini, le
motivazioni delle donne che lasciavano la Turchia per emigrare verso le citt tede-
sche suggerisce un atteggiamento critico nei confronti di un discorso sulle donne
turche, non dissimile da quello relativo ad altre donne musulmane in Europa,
basato su una rappresentazione stereotipata della femminilit, che propone lim-
magine della migrante turca come di una donna vittima di un sistema patriarcale
dai tratti profondamente arcaici e religiosi
126
. La donna turca in Germania occi-
125 Ad esempio: Cumhuriyet, 29 dicembre 1965: Trk kadnlar ve baz zc olaylar (Le donne
turche e alcuni episodi incresciosi); Cumhuriyet, 30 dicembre 1965: Manisa nere, Almanya nere
(Quale Manisa, quale Germania). Si veda anche Hatice Yurtda, Pionierinnen der Arbeitsmigration
in Deutschland. Lebensgeschichtliche Analysen von Frauen aus Ost-Anatolien, Hamburg, Lit, 1996, p.
51; Hunn, Nchstes Jahr cit., p. 77.
126 In tal senso, appaiono rilevanti alcuni paralleli e convergenze che si riscontrano con la rappresen-
tazione che viene oferta di altre donne straniere allinterno di altre societ europee: unimmagine
analoga della donna turca proposta, infatti, per le donne algerine in Francia, le donne pachistane in
Gran Bretagna, le marocchine o le stesse donne turche in Belgio e in Olanda. Si vedano a riguardo
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 493 03/05/2013 11:11:28
494
Capitolo 9. Le sfde del nuovo millennio in Nord Africa e Medio Oriente
dentale appariva in una rappresentazione che tuttora persiste come il classico
esempio della cosiddetta femminilit orientale, di una femminilit che si produ-
ceva allinterno di un sistema di valori dettati dalla religione islamica ed era diretta
espressione di una condizione di subalternit e oppressione maschile. Una sifatta
rappresentazione della donna turca si giustifcata per anni con una descrizione
univoca e omogenea dellesperienza migratoria femminile turca in Germania oc-
cidentale che, come si detto, si vuole unicamente rurale e motivata dal ricon-
giungimento familiare, e si alimenta di fatto del silenzio che per lungo tempo ha
messo in ombra il percorso migratorio di migliaia di donne che, spesso alla ricerca
di unesperienza diretta della modernit europea, partirono come operaie ingros-
sando le fla della cosiddetta prima generazione di migranti turchi in Germania,
contribuendo allelaborazione di percorsi soggettivi e collettivi che caratterizzano
oggi la comunit turca tedesca per la sua eterogeneit.
gli studi sulle donne pachistane in Gran Bretagna: Werbner, P. Te Migration Process: Capital, Gifts
and Oferings among British Pakistanis, Oxford, Berg Publishers, 1993; sulle donne turche in Belgio:
Mano, A:; Mano, U. (sous la direction de) Turcs de Belgique, Identits et trajectoires dune minorit,
Bruxelles, Info Trk et Cesrim, 1992.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 494 03/05/2013 11:11:28
CAPITOLO 10
Impegno e militanza femminile tra le due
rive del Mediterraneo:il caso della Tunisia
a cura di Lucia Valenzi
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 495 03/05/2013 11:11:28
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 496 03/05/2013 11:11:28
Introduzione
Lucia Valenzi
La Tunisia rappresenta un caso particolare nel panorama dei paesi del Nord
Africa. Da sempre caratterizzata dallincontro di diverse popolazioni e culture
(berberi, arabi, ebrei, italiani, francesi, maltesi), protettorato francese dalla fne
dellOttocento, ma con una comunit italiana molto numerosa e per una parte
anche economicamente forte, conosce una realt multiculturale e multireligiosa,
per nulla rinchiusa in s stessa, niente afatto provinciale, ma invece proiettata
verso lEuropa. Il Paese ha spesso ospitato fuoriusciti per motivi politici, anche
per la sua vicinanza geografca allItalia, luogo di transito prima di anarchici e
poi di antifascisti evasi dal carcere e dal confno. Tra le due guerre, con lafermarsi
dei movimenti indipendentisti la Tunisia un luogo di tensioni, ma anche di
vivace vita politica.
Non a caso il Neo Destour e il padre della patria, Habib Bourghiba, hanno
attuato una politica negli anni Cinquanta piuttosto aperta verso le donne. Dai
contributi di carattere storiografco qui presentati emerge come, proprio per la
sua storia, la Tunisia non si presta ad avvalorare gli abituali stereotipi oggi in voga
su paesi arabi e donne. Il confronto stereotipato tra le immagini della donna
dellIslam, con i suoi veli e la sua condizione di moglie tra le mogli in poligamia,
e della donna occidentale progredita ben lontano da una conoscenza reale
della cultura di genere nelluno e nellaltro mondo. Le tunisine hanno ottenuto
nel 1956, subito dopo la proclamazione dellindipendenza, per via legislativa la
parit dei diritti. Sempre per legge stata abolita la poligamia e istituito il di-
vorzio che pu essere chiesto sia dalla donna che dalluomo. Esiste anche laborto
legale. Certo non si intende sottovalutare il peso della mentalit e della tradizione
in quella riva del Mediterraneo, ma gli ostacoli che impediscono alle donne di
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 497 03/05/2013 11:11:28
498
Capitolo 10. Impegno e militanza femminile tra le due rive del Mediterraneo:il caso della Tunisia
raggiungere pienamente i loro diritti sono molto forti anche nella nostra riva.
Mi sono concessa questa breve attualizzazione per sottolineare la complessit e
lintreccio dei problemi che emergono dal contributo di Daniela Melfa. Raccon-
tandoci delle Suore Bianche, infatti, ci descrive come siano contemporaneamente
presenti un obbiettivo missionario di azione civilizzatrice occidentale rivolto alle
donne mussulmane e una condizione di silenzio e di subordinazione delle Suore,
che quellazione erano incaricate di compiere. Per legittimare moralmente il colo-
nialismo si strumentalizza unazione modernizzatrice rivolta alle donne, ma nello
stesso tempo si toglie alle Suore ogni visibilit e capacit di essere protagoniste.
Emblematico il fatto che siano seppellite nel cimitero nella parte che accoglie i
mussulmani convertiti, mentre i Padri bianchi sono sotterrati nella parte eu-
ropea. Una contraddizione non rara nella politica coloniale se il console inglese
in Egitto Cromer, citato nel testo, contemporaneamente per labolizione del
velo islamico e contro il voto alle donne in Inghilterra.
Emerge da questo contributo anche la presenza discreta delle istituzioni
cattoliche in Tunisia, latteggiamento prudente dei Padri e delle Suore bianche che
agiscono in un primo tempo prevalentemente nei confronti delle donne conver-
tite. Un comportamento adatto a quella che ho defnito una realt multireligiosa,
dove unaltra istituzione signifcativa, specifcamente rivolta alle donne tra le due
guerre il convento delle suore di Notre Dame de Sion. La scuola delle monache
di Notre Dame de Sion, frequentata anche da Nadia Gallico, come leggiamo nel
contributo di Leila El Houssi, un istituto di grande prestigio creato da un ebreo
convertito, dove non si esercita alcun proselitismo invadente. Le Suore di Sion
hanno avuto un ruolo essenziale durante la guerra, salvando la vita di molti ebrei,
tra cui le bambine di Nadia Gallico Spano.
I contributi presentati rivestono un interesse anche dal punto di vista me-
todologico e delle fonti: Daniela Melfa ha utilizzato le relazioni periodiche delle
Suore, mentre per Leila El Houssi molto importante un uso non timido della
memorialistica. Una delle due donne da lei studiate, Nadia Gallico Spano, ha pro-
dotto un vero e proprio libro autobiografco, mentre per altre abbiamo soltanto
brevi articoli o sparsi frammenti inediti, conservati presso le famiglie. Signifcative
anche le interviste e le testimonianze orali registrate.
Dal punto di vista femminile, gi le madri o le zie delle donne oggetto del
lavoro di Leila El Houssi hanno iniziato un percorso, innanzitutto di istruzione, e
aperto la strada alla generazione successiva. Infatti la madre di Nadia Gallico, Ket-
ty Sinigaglia, stata la prima donna laureata in farmacia in tutta lAfrica del Nord.
Le due donne vengono da un ambiente che ha vissuto intensamente lespe-
rienza antifascista, approdando alla militanza comunista. Nella Tunisia degli
anni Trenta e Quaranta, un laboratorio politico di varie presenze politiche an-
Nelloriginale era tut-
to in corsivo. Si trat-
ta di una citazione?
Sarebbe necessario
inserire il rimadno
bibliografco
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 498 03/05/2013 11:11:28
499
Introduzione
tifasciste e di diverse nazionalit, nel piccolo ma agguerrito partito comunista
collaborano donne e uomini francesi, italiani, arabi. Le donne non sono mol-
tissime, ma svolgono un ruolo signifcativo. Le antifasciste italiane in Tunisia
di cui esiste un dossier presso lArchivio Centrale di Stato sono tredici. Ma
ognuna di quelle biografe ha un valore. Una militanza che per alcune rim-
balzata dalluna allaltra riva del Mediterraneo, con limpegno politico e sociale
nellItalia del dopoguerra, a partire da Nadia Gallico, una delle poche elette alla
Costituente italiana.
Come lei anche altre donne, insieme ai loro mariti e compagni, con i quali,
come osserva Leila El Houssi, hanno condiviso ideologie e militanza politica, han-
no condotto la lotta antifascista in Tunisia, vissuto il carcere, realizzato il sostegno
ai militanti clandestini. In qualche testimonianza maschile c un omaggio al con-
tributo delle donne alla Resistenza in Tunisia, soprattutto nella rete di fancheg-
giamento. Signifcativa quella di uno dei componenti del gruppo degli antifascisti
italiani, arrestato, evaso e latitante nel 1942, Ferruccio Bensasson, che nelle sue
memorie Utopie perdute scrive: il partito visse in quel periodo dellamore materno
di queste compagne che crearono una rete di solidariet e di assistenza intorno ai
compagni latitanti e carcerati
1
.
Una Unione femminile viene creata nel 1938 sul modello dellUnion des fem-
mes in Francia: lUnione delle donne italiane di Tunisia. Ne fanno parte Nadia e
Diana Gallico, Litza Cittanova, Maria Provvedi, Gilda Meimon, Clelia Barresi,
questultima giovanissima, defnita dalla polizia nella documentazione di archivio
la pasionaria di Tunisi.
Non mancano le dif colt per queste donne anche allinterno del partito.
Indispensabile per delle militanti comuniste in epoca stalinista limpegno a stu-
diare i classici, ma scrive Nadia nella sua autobiografa: Diana, Clelia, Gilda e
io formiamo un piccolo gruppo per studiare il Manifesto del partito comunista di
Marx sotto la guida di Velio, ci che non manca di suscitare le critiche dei compa-
gni, i quali ci giudicano piuttosto presuntuose per averlo impegnato. Non osano
esprimere il loro pensiero: Per voi soltanto, uno spreco
2
.
Per molte altre gli anni Cinquanta in Italia hanno rappresentato un rientro
nella dimensione familiare, il cosiddetto rifusso, un problema che qui sarebbe
troppo complesso analizzare, ma che pu e deve costituire uno spunto di rifes-
sione per la conoscenza innanzitutto delle motivazioni e la valutazione di quanto
questa scelta sia stata realmente personale e convinta o indotta dallesterno.
1 Bensasson, F. Utopie perdute. Per un domani allaltezza dei nostri sogni, Roma, Aracne editrice,
2008, p. 214.
2 Gallico Spano, N. Mabrk. Ricordi di uninguaribile ottimista, Cagliari, AM&D Edizioni, 2005,
p. 134.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 499 03/05/2013 11:11:28
500
Capitolo 10. Impegno e militanza femminile tra le due rive del Mediterraneo:il caso della Tunisia
Ma in ogni caso lintensa partecipazione attiva alla Resistenza e lavere vissuto
una dimensione internazionale, con il decisivo rapporto col Centro Estero del Pci
a Parigi, ha dato loro una marcia speciale nel momento in cui, raggiunta lItalia,
hanno continuato a militare. Tra di esse vorrei anche ricordare Simone Bessis, cui
Leila El Houssi accenna, sposata con Marco Vais, che, dopo essere stata arrestata
in Tunisia dal governo di Vichy mentre incinta e con una bambina di cinque
mesi, con il marito raggiunge lItalia dove sia a Torino sia a Roma continua a im-
pegnarsi politicamente, sia pure al livello di base.
Quello di Simone Bessis un esempio non solo di impegno ma di coraggio
tutto femminile. il marito a ricordarlo in alcune note inedite che ho potuto
leggere per concessione delle fglie. Marco Vais ricorda che Simone, per venire a
vedermi, quando ero al campo di concentramento del Kef, faceva un viaggio di
cinque ore, in una corriera fetida, con la nausea della gravidanza. In una intervi-
sta Simone stessa racconta cosa volesse dire essere arrestata con una bambina lat-
tante o afrontare sempre con la bambina i bombardamenti, quando clandestina
non poteva scendere con gli altri nei rifugi antiaerei.
Eppure mi sembrano illuminanti le espressioni di ottimismo, come osserva
anche Leila El Houssi, da parte di queste donne, che hanno attraversato dure
prove e anche la delusione del rifusso, restando sempre, anche con lavanzare
dellet, cariche del loro spirito combattivo. Nadia Gallico Spano manifesta questo
spirito anche nel titolo e nel sottotitolo delle sue memorie: Mabrk (una parola
araba che vuol dire buona fortuna) e Ricordi di uninguaribile ottimista. E le fa
eco Gladys Adda, unaltra militante comunista la cui biografa stata studiata in
altra sede da Leila El Houssi, che ha afermato in unintervista: Moi je reste opti-
miste, malgr tout ce qui sest pass.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 500 03/05/2013 11:11:28
1. Per una politica al femminile nella Tunisia
tra le due guerre
Leila El Houssi
La liceit delluso dellautobiografa come fonte storiografca oggetto di ampio
dibattito tra gli studiosi. In un lavoro su questo tema, Giovanni Contini sostiene
che le autobiografe scritte e le interviste audio o videoregistrate possano fornire
importanti informazioni
3
. Si tratta di suggestioni ampiamente condivise da Lucia
Sorbera che rivela quanto, anche negli studi di genere, lautobiografa in generale
denota, innanzitutto una profonda elaborazione del proprio vissuto e della propria
storia e per altri versi rappresenta il canale stesso attraverso il quale il carattere
proprio e peculiare del soggetto si defnisce e si aferma
4
.
Nellambito della storia dellemigrazione antifascista femminile, Patrizia Ga-
brielli sottolinea limportanza del metodo biografco sostenendo che costituiscono
parte integrante della bibliografa sullemigrazione anche le memorie e le autobio-
grafe che, in pi di un caso, hanno rappresentato lesaltazione di un noi collettivo
piuttosto che unesplorazione dei territori della soggettivit, pur aprendo spiragli,
talvolta veri e propri squarci sulla dimensione di quellesperienza
5
. Ne consegue
che lutilizzo dellautobiografa e della memorialistica come fonti storiografche si
conferma un utile strumento di lavoro e favorisce lo sviluppo della ricerca anche
3 Cfr. Contini, G. Memorie di guerra e di guerra civile, in La memoria che resiste, Padova, Cierre
edizioni, 2007, p. 27.
4 Cfr. Sorbera, L. Dal harim allo spazio pubblico. Letteratura e storia nelle Mudhakkirrat di Huda
Sharawi, in Melfa, D.; Melcangi, A.; Cresti, F. (a cura di) Spazio privato, spazio pubblico e societ
civile in Medio Oriente e Africa del Nord. Atti del convegno di Catania della Societ degli studi sul Medio
Oriente SeSaMO, 23-25 Febbraio 2006.
5 Cfr. Gabrielli, P. Col freddo nel cuore, Roma, Donzelli, 2004, p. 8.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 501 03/05/2013 11:11:29
502
Capitolo 10. Impegno e militanza femminile tra le due rive del Mediterraneo:il caso della Tunisia
in un ambito a cui gli storici, salvo alcuni recenti contributi, hanno prestato scarso
interesse: quello delle comunit italiane nella riva sud del Mediterraneo
6
.
Il silenzio storiografco sulle collettivit italiane che, come giustamente sotto-
linea Nicola Labanca, va ricercato nella mancanza di una storia sociale del colonia-
lismo italiano in Africa
7
, ha determinato lacune anche sul fronte della storia delle
donne che vivevano queste realt e in particolar modo sul versante della militanza
politica femminile.
Partendo da queste considerazioni nel mio saggio afronto la ricostruzione
del vissuto di due fgure femminili: Nadia Gallico Spano e Litza Cittanova Va-
lenzi, protagoniste dellantifascismo italiano nella Tunisia tra le due guerre. In
modo totalmente volontario queste donne decisero di partecipare allattivit poli-
tica allinterno del Partito Comunista avendo cognizione di vivere una restrizione
della propria dimensione privata. Erano donne resistenti che si inserivano in un
universo in cui la percezione della propria diversit rispetto al resto della societ
produceva un punto di non ritorno.
Ma quali erano in realt le motivazioni profonde per cui queste donne scelse-
ro di afrontare limpegno politico? Si tratta della maturazione di una coscienza al
femminile o di una volont indotta?
Forse n luno n laltro, bens la profonda consapevolezza dellafermazione
di una propria autonomia e di un proprio impegno. Come suggerisce Patrizia Ga-
brielli, il mettersi alla prova e lattestarsi di una nuova autopercezione diveniva
un passaggio quasi obbligato per le donne militanti. Indubbiamente lemergere di
tali elementi nelle memorie di Nadia Gallico Spano e di Litza Cittanova Valenzi
costituisce un tassello importante nella ricostruzione delle loro vite.
Attraverso le loro memorie queste donne ci hanno fornito delle risposte metten-
do in luce come il ruolo svolto dallelemento femminile nella Tunisia dagli anni Ven-
ti fno allindipendenza del Paese non sia da considerare afatto complementare.
Nadia Gallico Spano: una comunista italiana di Tunisia
Nadia Gallico, unitaliana di Tunisia conosciuta anche come la moglie del diri-
gente comunista Velio Spano, si sempre battuta per i diritti, per lemancipazione
femminile e per la libert
8
.
6 Cfr. Natili, D. Una parabola migratoria, Viterbo, Settecitt, 2009, p. 6.
7 Cfr. Labanca, N. Italiani dAfrica, in Del Boca, A. (a cura di) Adua. Le ragioni di una sconftta,
Roma-Bari, Laterza, 1997.
8 Pochi sanno della storica presenza di una rilevante comunit italiana nel paese nordafricano, inse-
diata sin dallepoca delle repubbliche marinare. Una comunit in cui hanno convissuto nel corso dei
secoli due anime: luna di origine toscana, con la comunit dei Grana o Qrana, gli immigrati ebrei
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 502 03/05/2013 11:11:29
503
1. Per una politica al femminile nella Tunisia tra le due guerre
Nata a Tunisi il 2 giugno 1916, Nadia era fglia di Ketty Sinigaglia la prima
donna a laurearsi in farmacia in tutta lAfrica del nord
9
. Cresciuta in un contesto
familiare in cui listruzione rappresentava un aspetto fondamentale, Nadia Gallico
fu educata con un senso di profonda laicit dalla famiglia nonostante avesse fre-
quentato la scuola di Notre Dame de Sion di Tunisi. Dunque lelemento religioso
non si poneva come elemento identitario, ma era la dimensione dellappartenenza
alluniverso culturale a determinare la soggettivit di Nadia.
Efettivamente la sua adolescenza e quella dei suoi fratelli, Loris, Ruggero
e Diana, fu allinsegna del multiculturalismo in quanto, come ella stessa soste-
neva, viveva in un paese in cui erano apprezzati i riti, le tradizioni, le feste e le
religioni
10
.
Protagonista allinterno della comunit italiana in Tunisia, la famiglia Gallico
ebbe un ruolo importante per il forte impegno antifascista nel periodo tra le due
guerre. Nadia, ad esempio, simpegn con altre donne in iniziative forse limitate
ma capaci comunque di far sentire la presenza antifascista
11
. Si trattava di eventi
fortemente ostacolati dal Consolato Italiano come nellinverno 1938 lorganiz-
zazione della Festa del giornale fondato dal fratello Loris LItaliano di Tunisi
12
e
lAlbero di Natale per i bambini.
Limpegno antifascista si increment soprattutto a partire dalla promulgazione
delle leggi razziali che, come riferiva Nadia Gallico, ha diviso e condotto a dramma-
tiche scelte. Tuttavia la frattura vera e propria della comunit italiana si era prodotta
gi nel 1937 con lomicidio del giovane falegname ventiduenne segretario del Circo-
lo Garibaldi, Giuseppe Miceli
13
. Come ha ricordato Nadia Gallico:
livornesi, che risiedevano stabilmente dal XVIII secolo e laltra, che ebbe un sensibile incremento
a partire dal XIX secolo, composta da un forte contingente di emigranti come contadini, artigiani,
operai e soprattutto pescatori di origine meridionale, che la disoccupazione aveva progressivamente
allontanato dal proprio paese di origine. Una comunit talmente importante e numerosa che fu
tenuta costantemente sotto locchio vigile della stessa Francia, che nel 1881 instaur in Tunisia il
regime di protettorato. In efetti, il timore di uneventuale opera di disturbo da parte della collettivit
italiana non fu cos infondato. La nascita in Tunisia di idee di tipo socialista e rivoluzionario si deve
agli italiani anarchici, socialisti e sindacalisti residenti nella Reggenza di Tunisi.
9 Cfr. Gallico Spano, N. Mabruk-Ricordi di uninguaribile ottimista, Cagliari, AM@D edizioni,
2005, p. 83.
10 Cfr. ivi, p. 87.
11 Cfr. ivi, p. 131.
12 LItaliano di Tunisi, diretto dal fratello di Nadia, Loris Gallico, riconosciuto a livello internazio-
nale, divenne il centro di reclutamento antifascista italiano in Tunisia.
13 Giuseppe Miceli fu ucciso il 20 settembre 1937 durante una spedizione punitiva ad opera di una
cinquantina di cadetti della nave scuola Vespucci. guidati dagli agenti locali del consolato dItalia.
Su questo episodio, scriver venti anni dopo Maurizio Valenzi Era, si pu dire oggi, la prima vittima
in Africa del nord della guerra che le forze dellasse andavano preparando. La notizia dellassassinio
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 503 03/05/2013 11:11:29
504
Capitolo 10. Impegno e militanza femminile tra le due rive del Mediterraneo:il caso della Tunisia
Tutti parlarono di questo terribile assassinio che oper come catalizzatore per
gli italiani. Difatti pur avendo ideologie diverse, e quindi non necessariamente
comunisti, gli italiani antifascisti si riunirono nella lotta contro il regime, che
attraverso lOVRA (Organizzazione per la vigilanza e la repressione dellantifasci-
smo) conduceva unopera di repressione
14
.
Lomicidio di Miceli fu un tipico esempio della violenza squadrista fascista e
sollev lo sdegno generale. Pur tuttavia, il dolore e la soferenza per la morte di un
giovane militante e la paura della persecuzione non intimidirono Nadia Gallico
che continu nel suo impegno antifascista al fanco di Velio Spano, autorevole
dirigente comunista che raggiunse Tunisi nel 1938 per risiederci fno al 1943. Su
questa esperienza egli ha scritto nel 1943
Gli anni di Tunisi sono in verit molto pi che un episodio o una parentesi: essi
sono come una specie di ipoteca sulla mia vita. Ci pu sembrare strano ma io
credo di non aver mai amato un luogo vero come ho amato la citt dove vivono
le persone che pi mi sono care. La nostalgia di Tunisi non passer mai, spero
15
.
La sua permanenza nella citt nordafricana fu dedicata allorganizzazione e al
coordinamento dei compagni che agivano nel Paese. Nonostante le dif cili con-
dizioni nelle quali lavorava, il suo attivismo negli organi di stampa LItaliano di
Tunisi e Il Giornale (giornale antifascista fondato da Spano e Giorgio Amendola),
fu encomiabile. Ma con lagosto del 1939 qualcosa cambiava per quel gruppo di
italiani comunisti di Tunisia. Nadia Gallico, quasi tormentata dal ricordo della
frma del patto Ribbentrop-Molotov, ribadiva
la nostra attivit non si arrestava, noi antifascisti continuavamo nella lotta []ma a
un certo punto la frma di quel patto non fu cos comprensibile[] Noi prendemmo
la posizione che presero tutti i partiti comunisti nel mondo [] cera la guerra e poi
se lhanno fatto una qualche ragione ci doveva essere e noi siamo andati alla ricerca
di queste ragioni [] indubbiamente lunit delle forze antifasciste venne meno, e
questo fu per me, Velio e gli altri compagni un momento di grande dif colt
16
.
compiuto dalla squadra punitiva fascista in terra straniera sollev unenorme indignazione. Cfr.
Valenzi, M. Lassassinio di Giuseppe Miceli, in La Rinascita, n. 16, 16 aprile 1966.
14 Intervista di Leila El Houssi a Nadia Gallico Spano, novembre 2004.
15 Cfr. Mattone, A. Velio Spano, vita di un rivoluzionario di professione, Cagliari, Della Torre, 1978,
p. 56.
16 Cfr. El Houssi, L. Gli antifascisti italiani in Tunisia tra le due guerre, in Altreitalie, n36-37,
2008, pp.189-204.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 504 03/05/2013 11:11:29
505
1. Per una politica al femminile nella Tunisia tra le due guerre
Fu un momento critico, che si aggrav con la chiusura de Il Giornale e con
lespulsione dei comunisti dalla LIDU. Con il 1940, e lentrata in guerra dellItalia,
il marito di Nadia, Velio Spano, cerc di fuggire clandestinamente per rientrare nel
proprio Paese di origine, ma non vi riusc. Procedette allora alla riorganizzazione del
partito con i propri compagni e con il prezioso aiuto della moglie, ma la politica di
repressione e la divisione degli antifascisti, non lo aiutarono. Velio Spano fu invia-
to insieme ad altri italiani al Campo di Sbeitla, una localit nel sud della Tunisia.
Con larresto nel 1941 prima di Ruggero Gallico e in seguito di Diana e di Nadia,
condannate rispettivamente a diciotto e sei mesi di reclusione per aver partecipato
ad attivit comuniste, le dif colt crebbero. Nadia Gallico fu rilasciata quasi subito
per motivi familiari, poich in quel momento i suoi bambini erano molto piccoli.
Velio Spano nel 1943 riusc a rientrare in Italia e Nadia lo raggiunse qualche
tempo dopo nellaprile del 1944.
E cos la famiglia Spano non rientrer pi in Tunisia, ma lapertura di Velio al
terzomondismo fu sicuramente frutto di quel periodo cos importante passato nel
Paese nordafricano. Nadia Gallico si rec ancora in Tunisia a rivisitare quei luoghi
cos fondamentali nella sua vita, anche dopo la morte del compagno.
Le dif colt di una donna antifascista fera della propria identit lha fatta di-
ventare una protagonista della nostra Repubblica: una delle ventuno donne elette
allAssemblea Costituente della Repubblica Italiana. In unintervista, nel novembre
del 2004, le chiesi Quando hai smesso di fare attivit politica? mi rispose Smesso?
Non ho mai smesso di fare attivit politica e non nelle mie intenzioni smettere
[] In questo momento mi sto battendo per la Costituzione e vado nelle scuole a
spiegare ai giovani limportanza di difenderla oggi dalle aggressioni che riceve.
Litza Cittanova Valenzi: una compagna discreta
Discendente dai Qrana, Litza Cittanova era nata a Tunisi il 1 gennaio 1917 in una
famiglia borghese.
Di cittadinanza francese, nonostante lorigine italiana, Litza frequent le
scuole francesi e si laure in lingua italiana alla Sorbona di Parigi. Come ben
descrive la fglia Lucia Valenzi:
Una prima parte della sua vita era stata quella di una fglia di buona famiglia,
studiosa, seria anche nelle lezioni di pianoforte. Spesso ricordava con orgoglio di
essere stata primo premio dopo dodici anni al Conservatorio di Tunisi
17
.
17 Cfr. Valenzi, L. Qualcosa su mia madre, Napoli, ed Assessorato pari opportunit- Regione Cam-
pania, 2007, p. 13.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 505 03/05/2013 11:11:29
506
Capitolo 10. Impegno e militanza femminile tra le due rive del Mediterraneo:il caso della Tunisia
Sono gli anni in cui Tunisi si presentava come una citt aperta dal punto di
vista culturale e indubbiamente lelemento italiano aveva contribuito non poco a
tale sviluppo
18
. in questo contesto che Litza Cittanova conduceva la propria vita:
la vita indubbiamente agiata di chi apparteneva alla borghesia coloniale di Tunisi.
Tuttavia, lincontro a Parigi con Maurizio Valenzi, personalit di spicco
dellantifascismo italiano e del Partito Comunista in Tunisia, condusse Litza ad
accorgersi di orizzonti pi vasti rispetto a quelli conosciuti sino ad allora. Essa
prese la decisione di abbandonare quel nido agiato nel quale era sempre vissuta,
sotto gli occhi di un padre che non approvava per nulla la scelta di Litza di impe-
gnarsi nella lotta antifascista.
La scelta di iscriversi al Partito Comunista nel momento pi dif cile, quello
della clandestinit, fu indubbiamente dettata dallincontro con Valenzi ma anche
da una serie di eventi che infammarono la Tunisia in quegli anni, come limpatto
della promulgazione delle leggi razziali del 1938. In questo frangente sinserisce
un episodio signifcativo della vita di Litza. A causa delle leggi razziali le fu tolta
la possibilit di continuare a insegnare in un liceo dove aveva preso servizio poco
tempo prima. Come disse Maurizio Valenzi nel corso di unintervista: Litza si era
laureata alla Sorbona in Lettere, ma quelle carogne non le avevano mai concesso
di insegnare
19
.
Litza si trov cos al fanco di altre giovani donne, tra cui le sorelle Nadia e
Diana Gallico e la militante Simone Bessis, impegnate attivamente nella causa an-
tifascista. Il loro status di mogli e di madri si coniugava perfettamente con quello
della militanza.
Anche per Litza la politica divenne una sconvolgente scoperta. Le regole della
militanza comunista la resero una donna capace di assumersi responsabilit in
maniera totale
20
.
Durante il periodo in cui il marito era in carcere Litza, consapevole della
responsabilit verso la propria famiglia e nonostante il disagio emotivo che in-
dubbiamente provava, riorganizz la vita quotidiana grazie alla compagnia di altre
donne che a loro volta si trovavano nelle sue medesime condizioni.
18 Basti pensare alla nascita del primo teatro costruito a Tunisi: il Teatro Tapia, in rue Zarqun che
portava il nome di un qrana. Alla comparsa del primo teatro segu un proliferarsi di sale in cui si assi-
steva ad opere liriche come Rigoletto, La forza del Destino, La Traviata, lAida o il Barbiere di Sevilla.
Naturalmente comparvero altri teatri destinati alla prosa come il Teatro Italiano, in via Sidi Zahmul e
quello di via Sidi Al Banna, destinato all opera dei Pupi, il Gran Teatro e il Teatro Cohen, entrambi
destinati alla musica sinfonica. Nel folto pubblico che seguiva le opere e le pices teatrali vi erano
naturalmente esponenti della comunit italiana.
19 Cfr. Sannino, C. I girasoli di Napolitano, in la Repubblica, 7 luglio 2006.
20 Crf. Valenzi, L. Qualcosa su cit., p. 19.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 506 03/05/2013 11:11:29
507
1. Per una politica al femminile nella Tunisia tra le due guerre
Allimmagine della donna che proveniva dalla buona borghesia coloniale
abituata a uno stile di vita piuttosto agiato, in cui ad esempio i viaggi a Parigi per
acquistare abiti alla moda erano allordine del giorno, si contrappose unimmagine
diversa, ossia quella di una militante comunista che per attaccamento al partito
condivise la vita con persone di diversa estrazione e cultura
21
. Larresto e il car-
cere non mutarono la sua immagine che ormai si presentava come sicura e consa-
pevole di s. Si pone davanti ai nostri occhi la rappresentazione di una donna con
unemotivit controllata capace di arrivare a non parlare col padre durante una sua
visita in carcere, per obbedire alle indicazioni ricevute dal partito che considerava
Jacques Cittanova nemico dellURSS in quanto console onorario di Finlandia.
La nostra giovane militante stata spesso vittima di eventi in cui una rigida
disciplina del partito ha pesato fortemente
22
. Nonostante ci, la politica assunse
per Litza una dimensione centrale e queste dure esperienze non infuirono sulla
sua vita futura. Si pu afermare che nessuna forma di protagonismo compare
nella rielaborazione della sua memoria o nelle sue scelte di vita.
La capacit di essere una compagna discreta si riveler nel suo vissuto italia-
no, quando nel 1943 giunger a Napoli e af ancher per tutta la vita il marito,
riuscendo a essere una donna indipendente al fanco di un uomo che stato def-
nito ingombrante per il suo ruolo pubblico
23
.
Conclusioni
Somiglianze e diferenze si alternano nel vissuto di queste donne. Grazie allaspetto
socializzante della politica, Nadia e Litza prendono coscienza di una realt assai di-
versa in cui erano abituate a misurarsi. La militanza in chiave antifascista, per queste
donne provenienti dalla borghesia, si confgurava come qualcosa di anticonven-
zionale. Ma proprio la rottura con la tradizione consente alle nostre protagoniste
dintraprendere un percorso attraverso il quale si realizzano anche come persone.
21 Ibidem.
22 Ad esempio, degno di nota fu lepisodio in cui Litza aveva avuto lincarico di comunicare un
messaggio del partito nel corso di un brevissimo incontro con Maurizio Valenzi, mentre questi era
prigioniero su un treno. Emozionata per quellincontro, dimentic tutto e il Partito non ebbe remore
nel defnire ci che aveva compiuto Litza un atto indegno.
23 Maurizo Valenzi, fu senatore eletto nel PCI per tre legislature dal 1953 al 1968, in particolare
viene nominato segretario alla Presidenza del Senato e in altra occasione vicepresidente della Com-
missione Esteri. In quegli stessi anni ricoper diversi altri ruoli istituzionali e di partito, diventando
vicepresidente della Commissione di Vigilanza sulla RAI, segretario del Gruppo Comunista al Se-
nato e membro della Commissione Centrale di Controllo del PCI. Consigliere comunale a Napoli
dal 1970 al 1975, ne divenne sindaco fno al 1983.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 507 03/05/2013 11:11:29
508
Capitolo 10. Impegno e militanza femminile tra le due rive del Mediterraneo:il caso della Tunisia
Indubbiamente si trattava di un percorso favorito dallambito familiare che
aveva spinto queste donne a frequentare le scuole. A emergere con forza nelle loro
esperienze laspetto dellanticonformismo, in una societ e in un periodo storico
in cui la condizione femminile era ben diversa da quella attuale. Tuttavia le nostre
protagoniste agiscono in piena coscienza nellambiente che le circonda, trasfor-
mando leccezionalit della loro natura in normalit. Anche qui risulta peculiare
lagire in gruppo che consente la condivisione del sacrifcio, della responsabilit
e fa maturare la coscienza di essersi misurate in campi di prerogativa prettamente
maschile. Ma il ruolo di queste donne che si presentano come mogli di non
sminuisce lo spazio rilevante che si erano create. Anzi, la nostalgia e il dolore della
separazione dal proprio compagno durante i momenti della detenzione inducono
le nostre militanti a coniugare egregiamente le esigenze dellorganizzazione per-
sonale con quelle di carattere politico. Questo duplice impegno rivela un senso
di identit che ha sempre contraddistinto il vissuto delle nostre protagoniste. La
dimensione privata dunque diviene pubblica tanto da scompaginare il ritmo della
quotidianit. La solidariet del gruppo e soprattutto il contesto familiare aiutano
fortemente ad adeguarsi ai ritmi imposti dalla militanza.
Dal ritratto di queste donne ci che traspare, infne, indubbiamente la con-
sapevolezza del ruolo assunto e la volont di spaziare in un territorio nuovo, in cui
la spinta razionale prevale su quella emotiva, promuovendo di fatto limmagine di
donne sicure e ottimiste.
Ed infatti un ottimismo che non si atrofzza quello che emana dalle memo-
rie delle protagoniste prese in esame: un ottimismo che ha prevalso nonostante la
drammaticit della clandestinit e della guerra.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 508 03/05/2013 11:11:29
2. Nello spazio pubblico per vocazione.
Suore bianche nella Tunisia coloniale
Daniela Melfa
Nel corso dellOttocento lOccidente matur lidea di una missione civilizzatrice
da compiere presso i popoli colonizzati. A farsi carico del fardello secondo
la nota espressione di Joseph Rudyard Kipling (1865-1936), autore del poema
Te White Mans Burden (1899) non fu soltanto luomo bianco, ma anche la
donna bianca. Certamente meno coinvolte nelle barbare guerre della pace o
nel custodire in pesante assetto, gente irrequieta e sfrenata, popoli truci da poco
soggetti, mezzo demoni e mezzo bambini, le donne non rimasero indiferenti
allappello a servire ai bisogni dei sottoposti: riempite la bocca della Carestia, e
fate cessare la malattia, esortava Kipling. Le religiose, in particolare, risposero con
solerzia e umilt allinvito, che tuttavia non prospettava gratitudine e accoglienza,
ma fatica di servo e di spazzino
24
.
Con lobiettivo precipuo di operare in terra di missione, Charles Lavigerie
(1825-1892) fond nel 1869 un ordine, divenuto in seguito la Congrgation des
Surs Missionnaires de Notre Dame dAfrique, noto (sulla falsariga dellappellativo
della branca maschile dei Padri bianchi) come le Suore bianche. Attive, in un
primo tempo, principalmente in Algeria e in Tunisia, le Suore bianche erano rite-
nute per natura particolarmente adatte a occuparsi delle donne nella societ
musulmana, in primo luogo nel campo delleducazione e della salute.
Levoluzione femminile rappresentava una priorit per i missionari e i colo-
nizzatori in genere, sia in Africa del Nord sia in altre parti dei vasti imperi coloniali.
24 La traduzione della poesia tratta da Giardina, A.; Sabatucci, G.; Vidotto, V. Let contemporanea.
Storia, documenti, storiografa, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 412-413.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 509 03/05/2013 11:11:29
510
Capitolo 10. Impegno e militanza femminile tra le due rive del Mediterraneo:il caso della Tunisia
Vi furono [] memorabili campagne morali condotte da missionari, donne eu-
ropee, e riformatori delle colonie per migliorare il destino femminile in queste
societ. [] Questi riformatori tentarono di difondere listruzione, il cristianesi-
mo e ligiene fra le donne segregate nelle famiglie ind e musulmane. Listruzione
femminile divenne una parola magica per le potenze coloniali europee quando
cercavano di giustifcare limperialismo di fronte agli atteggiamenti scettici dello-
pinione pubblica interna. Vi furono memorabili campagne, ancora chiaramente
su questioni femminili, sullinfanticidio delle bambine e i matrimoni infantili in
India, sul concubinaggio forzato e la fasciatura dei piedi in Cina o sulle mutila-
zioni genitali in Africa
25
.
Nellambito della promozione femminile giocarono un ruolo di primordine
le donne europee. Bench lambiente urbano fosse maggiormente interessato dai
cambiamenti, la modernizzazione nelle campagne non si arrest alla costruzione
dinfrastrutture e alla razionalizzazione del lavoro agricolo. Le religiose, in primo
luogo, come vedremo nel primo paragrafo, si sentirono chiamate a svolgere una
missione.
Sebbene fossero riconosciute come fgure preziose, le donne (religiose e non)
si muovevano per allinterno di un sistema gerarchizzato. Infatti, la comunit re-
ligiosa, come esporr nella seconda parte, sispirava a una emancipazione femmi-
nile mitigata e, al contempo, riconosceva alle Suore una condizione di limitata
visibilit e di subordinazione rispetto alla branca maschile della congregazione.
Uno sguardo al vissuto delle Suore, rilevabile tra le righe, chiuder la rifessione.
Le Suore bianche, presenti con diverse postazioni nel protettorato tunisino,
si distinsero particolarmente a Saint-Joseph-de-Tibar, nella regione nord-occi-
dentale della Tunisia, dove, arrivate nel 1902, rimasero insieme ai confratelli, su
richiesta del presidente Habib Bourghiba, fno al 1975, ovvero ben oltre lindi-
pendenza del Paese (1956)
26
. La propriet di Saint-Joseph-de-Tibar (2.300 ettari
circa), situata in un territorio di primaria importanza per lo sviluppo agricolo, era
stata acquistata a fne Ottocento dai Padri bianchi con lobiettivo principale di
creare una fattoria-modello e ricavare introiti per le opere missionarie. Liniziativa
non rispondeva per soltanto a un bisogno di sostentamento, ma rivelava anche
una visione del lavoro agricolo come fattore di rigenerazione. Non a caso la loca-
lit divenne pure centro per la formazione dei novizi e meta privilegiata per i ritiri
25 Bayly, C. Te Birth of the Modern World (1780-1914). Global Connections and Comparisons, Ox-
ford, Blackwell Publishers, 2004, trad.it. di Marchetti, M.; Mobilia, S. La nascita del mondo moderno
(1780-1914), Torino, Einaudi, 2007, p. 497.
26 Lattivit delle Suore bianche descritta in Dornier, F. Pres Blancs, Surs Blanches. Tibar, 1895-1975,
testo dattiloscritto, s.d., e Dornier, F. La vie des catholiques en Tunisie au fl des ans, s.l., Tunis, 2000.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 510 03/05/2013 11:11:29
511
2. Nello spazio pubblico per vocazione. Suore bianche nella Tunisia coloniale
spirituali. Lesperienza di Saint-Joseph-de-Tibar rientrava, insomma, nellutopia
conservatrice di un idillio rurale
27
.
A causa della dif colt di accesso allarchivio delle Suore Missionarie di No-
stra Signora dAfrica a Roma, ho condotto la ricerca basandomi sui rapporti pe-
riodici redatti dalle religiose di stanza a Saint-Joseph-de-Tibar, disponibili presso
larchivio della branca maschile della congregazione, e sugli articoli pubblicati
sulla rivista dellInstitut des belles-lettres arabes. Le voci pi altisonanti restano co-
munque quelle maschili, in particolare dei superiori religiosi, rivelatrici di visioni
del mondo e rapporti di potere. Signifcativi spunti mi ha infne oferto la ricerca
sul campo a Saint-Joseph-de-Tibar.
Le Suore bianche e la promozione della donna
Lavigerie raccomandava ai missionari un gran riserbo nei rapporti con le don-
ne tunisine ed europee, religiose comprese. La castit rappresentava una virt da
proteggere strenuamente e il distacco fsico e afettivo era dunque considerato
doveroso: tous les autres ennemis, on les combat en face, celui-l, en fuyant
28
.
Cos, i sacerdoti dovevano, al confessionale, rivolgersi alle Suore senza lappellativo
cara
29
, mentre per quanto riguarda Tibar, fu prevista la creazione di un hotel
per evitare lingresso delle donne, eccetto le parenti, nel monastero
30
, cos come
fu imposto ai religiosi di non entrare nelle case private in assenza del marito
31
.
Un pericolo enorme era costituito, naturalmente, anche dalla nudit. La cura dei
malati imponeva dunque alcune precauzioni per evitare ogni tentazione. Perci,
les femmes indignes ne doivent pas tre soignes par nous, et pour les soins des
hommes, vitons tous pansements qui ofenseraient notre chastet, la puret de
nos regards
32
. Un analogo pudore andava osservato nei confronti dei bambini.
Le restrizioni imposte ai missionari lasciavano ampi spazi vuoti per lintervento
femminile. Anzi, nellottica della gerarchia ecclesiastica, le donne erano le fgure pi
idonee a entrare in contatto con lintimit dei corpi e dello spazio domestico
33
. In Afri-
27 Shorter, A. Cross and Flag in Africa: the White Fathers in the colonial scramble 1892-1914, Ma-
ryknoll (New York), Orbis Books, 2006, pp. 176-179.
28 Instructions de son minence le cardinal Lavigerie ses missionnaires, Maison Carre (Alger), Impri-
merie des Missionnaires dAfrique (Pres Blancs), 1927, p. 394.
29 Ivi, p. 292.
30 Cahiers de visite, Pre Paul Voillard, Saint-Joseph-de-Tibar 18/12/1909.
31 Cahiers de visite, Pre Paul Voillard, Saint-Joseph-de-Tibar, s.d.
32 Instructions de son minence le cardinal Lavigerie ses missionnaires cit., p. 404.
33 Renault, F. Le cardinal Lavigerie, 1825-1892. Lglise, lAfrique et la France, Paris, Fayard, 1992,
p. 500.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 511 03/05/2013 11:11:29
512
Capitolo 10. Impegno e militanza femminile tra le due rive del Mediterraneo:il caso della Tunisia
ca sub-sahariana, scrive Aylward Shorter, i Padri bianchi si sentirono incapaci di com-
battere i matrimoni precoci e forzati e la poligamia senza limpareggiabile supporto
delle Suore
34
. In Tunisia i missionari, di fronte a quel nocciolo duro che era lIslam, ri-
nunciarono a unevangelizzazione spinta e a intaccare istituti legittimati religiosamen-
te. Nondimeno parecchio bisognava fare per combattere malattia, miseria e ignoranza.
A Saint-Joseph-de-Tibar i Padri bianchi avevano allevato alcuni orfani ma-
ghrebini che erano stati battezzati e in seguito accolti in un villaggio appositamen-
te creato. Per assicurare la continuit della vita religiosa, i missionari si preoccupa-
rono di facilitare i giovani nella scelta della consorte. Cos, al fne di formare foyers
cristiani, le Suore gestivano un orfanotrofo femminile e, al momento opportuno,
approntavano i fatidici incontri:
Les maisons des futurs maris sont presque termines, et pourtant ils ne se
connaissent pas encore. Le Pre Barthlemy vient donc aujourdhui avec deux
garons, Lon et Pierre. On leur prsente trois flles, Rosa, Adrienne et Todore,
pour quils puissent causer un peu ensemble et faire ensuite leur choix
35
.
Anche per la reticenza incontrata inizialmente presso la popolazione musul-
mana, lattivit di formazione si indirizz principalmente alle donne convertite.
Propense a formare delle spose e madri perbene, le Suore si preoccuparono di
assicurare listruzione primaria, come pure un mestiere compatibile con i compiti
domestici. Col tempo limpegno delle religiose si estese alle donne musulmane.
Estimatrici delle tradizioni artigianali indigene, le Suore avviarono laboratori di
cucito, nonch atelier per la tessitura di coperte, burnus e tappeti, per il pizzo e il
ricamo, e ancora per la costruzione di panieri. Lopportunit di un ricavo anche
modesto per le donne era oferta, inoltre, dal lavoro in lavanderia che divenne par-
ticolarmente oneroso con lapertura negli anni Trenta dellimponente scolasticato.
Le Suore erano, infne, impegnate nellassistenza sanitaria fornita sia attraverso
visite periodiche nei douars indigeni, sia nel dispensario del villaggio, una struttura
privata dipendente dallospedale di Bja. Al dispensario, inizialmente riservato
alle donne ma poi aperto anche agli uomini, lavoravano riferisce Franois Dor-
nier una suora infermiera, supportata da unaiutante, mentre un medico veniva
settimanalmente per le consultazioni. In seguito a unerronea somministrazione di
farmaci che caus la morte di un bambino nel 1962, un contratto fu stipulato nel
1964 con la Salute pubblica, contratto che ridusse i margini di autonomia delle
Suore per dare pi spazio ai titolari di una qualifca legalmente riconosciuta.
34 Shorter, A. Cross and Flag in Africa cit., p. 182.
35 Rapport trimestriel des Surs, Saint-Joseph-de-Tibar, 11/10/1902.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 512 03/05/2013 11:11:29
513
2. Nello spazio pubblico per vocazione. Suore bianche nella Tunisia coloniale
Le Suore bianche e la gerarchia religiosa
Lemancipazione femminile esportata nei possedimenti coloniali non aveva ri-
scontro, curiosamente, nei rapporti interni alla societ europea. Emblematico
loperato di Evelyn Baring Cromer (1841-1917) che, console britannico in Egitto
dal 1882 al 1907, si fece paladino dellabolizione del velo nel Paese islamico, men-
tre osteggi il diritto di voto alle donne in patria
36
. Dinamiche simili si riscontrano
pure in Tunisia, dove alle donne europee non sono riconosciuti spazi di autono-
mia e responsabilit analoghi a quelli maschili, cos come la loro individualit
molto sacrifcata in una prospettiva comunitaria.
Non appare irrilevante osservare, anzitutto, come le Suore bianche, e le donne
in genere, assumano un proflo deflato sia nella storiografa sia nella letteratura.
Lazione silenziosa delle Suore bianche si tramuta, infatti, in una non-menzione
nel titolo del libro di Joseph Cuoq, Lavigerie, les Pres Blancs et les musulmans ma-
ghrbins
37
, nelle cui pagine peraltro il loro contributo non trascurato. Le Suore
bianche sono assenti anche nelle poche righe dedicate a Saint-Joseph-de-Tibar nel-
la guida turistica Les guides bleus. Algrie, Tunisie, mentre le religiose di Ghardaa in
Algeria sono ricordate come assistenti dei Padri
38
. La scarsa visibilit assume poi la
forma dellanonimato nelle pagine della rivista Ibla, fondata nel 1937 dai Padri bian-
chi, dove alcuni articoli sono appunto frmati Une Sur Blanche o Surs Blanches.
La personalit delle religiose subiva, in verit, una limitazione gi al momento
dellordinazione, in quanto, a diferenza dei Padri bianchi, le Suore (come i Fra-
telli), non mantenevano nome e cognome originari, ma assumevano una nuova
identit. Di conseguenza, le ricorrenze festeggiate erano quelle dei santi patroni di
cui portavano il nuovo nome (nei rapporti puntualmente menzionato lonoma-
stico della madre superiora) e il giubileo di attivit allinterno della congregazione.
interessante, inoltre, rilevare che nel cimitero cristiano di Saint-Joseph-de-Ti-
bar le date riportate nella tomba delle Suore non corrispondono, come per i Padri
e i Fratelli, a quella di nascita e morte, ma a quella dordinazione (considerata
come la vera nascita) e di morte
39
. Sempre nel cimitero, appare rivelatrice lor-
36 Ahmed, L. Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, New Haven and
London, Yale UP, 1992, trad.it. di Graziosi, G.; Baccianini, M. Oltre il velo. La donna nellIslam da
Maometto agli ayatollah, Firenze, La Nuova Italia, 1995, p. 176.
37 Cuoq, J. Lavigerie, les Pres Blancs et les musulmans maghrbins, Rome, Socit des missionnaires
dAfrique, 1986.
38 Les guides bleus. Algrie, Tunisie, Paris, Hachette, 1927, pp. 394, 78.
39 Sur Marie Camille de Lellis nacque nel 1909, mentre sulla tomba scritto: 29 oct. 1933-13
dc. 1942; analogamente Sur Laurence nacque nel 1885, mentre liscrizione riporta: 25 oct.
1912-25 avril 1954 (cfr. Notices ncrologiques).
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 513 03/05/2013 11:11:29
514
Capitolo 10. Impegno e militanza femminile tra le due rive del Mediterraneo:il caso della Tunisia
ganizzazione dello spazio: le pietre tombali delle Suore sono, infatti, disposte nella
parte che accoglie anche le spoglie dei musulmani convertiti, mentre le sepolture
dei Padri e dei Fratelli giacciono accanto al monumento ai caduti della seconda
guerra mondiale e ai loculi dei pi abbienti coloni europei
40
.
In realt Charles Lavigerie si premur di prevedere per le novizie un percor-
so di formazione e dunque lacquisizione di una professionalit. Eppure, ai suoi
occhi, le donne rimanevano il sesso debole
41
bisognoso di una guida. Cos
fno al 1894 la congregazione delle Suore rimase sotto la tutela del superiore dei
missionari che presiedeva le riunioni del Consiglio e doveva approvare tutte le de-
cisioni prese
42
. Similmente, a Saint-Joseph-de-Tibar la direzione materiale della
missione era af data ai Padri
43
, mentre le Suore non sfuggivano a incombenze do-
mestiche come occuparsi della biancheria dei religiosi. Ai Padri competeva, inol-
tre, la guida spirituale della comunit, e i momenti deputati allopera dindirizzo
erano principalmente la confessione e la predica. Uninfuenza non trascurabile si
esercitava poi tramite le letture. interessante rilevare che, sebbene lintervento nel
campo della promozione femminile fosse riservato in via privilegiata alle donne
europee, la defnizione delle linee guida dellazione educativa e flantropica rima-
neva un ambito di competenza maschile.
In sintesi, il modello di femminilit, nonch le strategie dazione cui le donne
europee ispiravano il loro impegno nel sociale, rimanevano in larga parte creazione
degli uomini della loro razza e cultura. A dispetto, dunque, della volont deman-
cipazione femminile nei possedimenti doltremare, le donne europee vivevano in
una condizione di subalternit. Lungi dallessere unanomalia, questo paradosso si
confgura come una tendenza generale, o un elemento di uniformit, in epoca
moderna. Secondo Christian A. Bayly nel mondo moderno, a dispetto delle idee
liberali proclamate, persistono, anzi si raforzano, le gerarchie del passato, ovvero
forme di dominazione e subordinazione economica e sociale
44
.
40 Una separazione, in termini gerarchici, dello spazio parimenti percepibile nelle postazioni scelte
per la missione maschile e femminile. Su unaltura che domina il villaggio cristiano costruita,
infatti, a Saint-Joseph-de-Tibar labitazione dei Padri, ai quali i superiori raccomandavano in genere
la scelta di un luogo elevato e aerato per assicurare salubrit e sicurezza (Instructions de son minence
le cardinal Lavigerie ses missionnaires cit., p. 159).
41 Renault, F. Le cardinal Lavigerie cit., p. 514.
42 Ivi, pp. 507, 517.
43 compito del Padre superiore, per esempio, sovrintendere allampliamento delle strutture e allac-
quisto delle attrezzature da lavoro: Le R.P. Suprieur a dcid de faire lever une salle de patronage
pour les flles, la suite de notre maison (Rapport trimestriel des Surs, Saint-Joseph-de-Tibar,
18/01/1915); Le R.P. Suprieur profte dune bonne occasion pour acheter de grands mtiers de
tissage quil a lintention de placer louvroir (Ibidem, 15/10/1917).
44 Bayly, C. Te Birth of the Modern World cit., pp. 494-498.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 514 03/05/2013 11:11:29
515
2. Nello spazio pubblico per vocazione. Suore bianche nella Tunisia coloniale
La volont europea di far progredire lAltro, o meglio la donna dellAltro,
senza mettere in discussione le relazioni di genere nella societ europea, nondi-
meno un controsenso soltanto apparente, in quanto nasconde lopportunismo del
colonizzatore che non esita a usare la questione femminile per legittimare la pre-
senza coloniale. In altri termini, lidea delloppressione delle donne nelle societ
colonizzate o in quelle oltre i confni dellOccidente civilizzato, venne usata reto-
ricamente dal colonialismo per rendere moralmente giustifcabile il suo progetto
di smantellamento delle culture dei popoli soggiogati
45
. Leila Ahmed parla in
questo senso del femminismo occidentale come ancella del colonialismo.
Dif cile trovare intime espressioni di disagio e contestazione in scritti (rap-
porti periodici e articoli) destinati al pubblico, in cui inevitabile lenfasi sul lato
edifcante dellattivit missionaria. Tuttavia, nelle trame di vite obbedienti e rispet-
tose dellordine costituito af orano sensibilit non estranee ad aneliti di leggerez-
za. In particolare, nelle pagine redatte dalle Suore si coglie il piacere dellumori-
smo, dellironia, interpretabile come una strategia volta ad alleviare il peso della
dura vita di campagna e delle gerarchie sociali. Diversi sono gli aneddoti divertenti
riguardanti i bambini del villaggio, ma frequente anche lautoironia. Gi nel
resoconto dellavventuroso viaggio da Algeri a Saint-Joseph-de Tibar delle prime
Suore, accompagnate da tre ragazzine, sironizza sul fatto che una di loro scambi i
posacenere dei vagoni per acquasantiere:
Certainement les employs de chemin de fer sont de bons catholiques comme
nous, car Catherine a bientt dcouvert un bnitier chaque porte du wagon;
seulement on ny avait pas encore mis de leau bnite ce matin; dans lun se trou-
vait par hasard le reste dun cigare. Quelle horreur!
46
Persino lincidente incorso durante il tragitto, quando una Suora scivola nel
fango, unaltra incastrata nellautomobile geme per i dolori, e unaltra ancora non
si riprende dal mal di mare, riportato con una nota di buon umore: On dirait
presque que nous sommes en route pour fonder un hpital, ou que le diable veut
tout prix nous empcher darriver vivantes
47
. E lepisodio suscita sarcasmo ancora
per qualche giorno: Un Pre jsuite monte avec nous dans la voiture des Pres
(cette fois en cas daccident, nous aurons du moins labsolution)
48
.
Lo stile ironico delle Suore allevia dunque certamente la routine quotidiana
e lordine costituito. Forse innova anche rispetto a compassati schemi di espres-
45 Ahmed, L. Oltre il velo cit., p. 174.
46 Rapport trimestriel des Surs, Saint-Joseph-de-Tibar, 25/08/1902.
47 Ibidem.
48 Rapport trimestriel des Surs, Saint-Joseph-de-Tibar, 11/09/1902.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 515 03/05/2013 11:11:29
516
Capitolo 10. Impegno e militanza femminile tra le due rive del Mediterraneo:il caso della Tunisia
sione. Tuttavia appare unironia contenuta, che non sprigiona appieno il suo po-
tenziale dirompente e corrosivo, la sua forza irriverente capace di sovvertire verit
acquisite, credenze e valori ritenuti universali
49
.
49 Forcina, M. Ironia e saperi femminili. Relazioni nella diferenza, Milano, FrancoAngeli, 1998, pp.
29-34.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 516 03/05/2013 11:11:29
CAPITOLO 11
Donne israeliane e palestinesi fra critica,
protesta e rappresentazioni
a cura di Maura Palazzi
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 517 03/05/2013 11:11:29
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 518 03/05/2013 11:11:29
Introduzione
Maura Palazzi
Il complesso rapporto fra genere, nazione e nazionalismo, nello scenario dram-
matico del confitto israelo-palestinese il nodo di fondo con cui le studiose im-
pegnate in questo panel si trovano, in modi diferenti, a confrontarsi. Lintreccio
fra tali categorie analitiche si infatti dimostrato di grande importanza per inda-
gare e interpretare, nelle diverse societ dellet contemporanea, aspetti cruciali
della specifcit dellesperienza femminile. Ha, fra laltro, contribuito a mettere
in discussione la dicotomia privato/pubblico individuando per esempio forme
di nazionalizzazione del privato; e a far luce su una presenza e un protagoni-
smo femminili nei processi di creazione degli Stati nazionali e di cambiamento
sociale rimasti per lungo tempo invisibili o interpretati come semplice pro-
lungamento dei ruoli tradizionali: madri della nazione, madri degli eroi, ecc.
Tale specifcit, peraltro, non univoca ma si connota diversamente a seconda del
modo in cui si interseca con altre appartenenze come classe, etnia/ razza, religio-
ne, generazione, cultura; e assume caratteristiche ancora pi complesse quando
riguarda donne appartenenti a comunit nazionali in contesti di confitto.
Gli studi su genere e nazione hanno cominciato a svilupparsi soprattutto negli
anni novanta del Novecento, quando lavvio sia di importanti rifessioni di carattere
teorico sia di indagini di carattere antropologico, sociologico e storico, ha contri-
buito in modo signifcativo ad arricchire gli womens study e a innovare le ricerche
su nazione e nazionalismo, riguardanti soprattutto il lungo Ottocento europeo e,
nellambito di quelli che vengono chiamati Subaltern Study
1
, il contesto postcolonia-
1 Una delle studiose pi importanti a questo riguardo Gayatri C. Spivak interessante ricordare
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 519 03/05/2013 11:11:29
520
Capitolo 11. Donne israeliane e palestinesi fra critica, protesta e rappresentazioni
le del XX secolo
2
. Non un caso, credo, che una delle pioniere degli studi su genere
e nazione sia stata Nira Yuval-Davis, studiosa ebrea israeliana vissuta fno agli anni
dellUniversit in Israele, poi emigrata nel Regno Unito, in polemica con lorienta-
mento sionista dei governi del suo Paese, e divenuta una delle massime esperte di
questi temi. Nel suo volume Gender and Nation, pubblicato nel 1997
3
ancora oggi
uno dei punti di riferimento importanti su questi argomenti viene fra laltro messa
a fuoco la concezione di Transversal politic come strumento metodologico per un
dialogo e una cooperazione fra parti diversamente posizionate nei confitti etnici
e nazionali, nel rispetto delle diferenze (mai gerarchiche) e delluguaglianza. Uno
strumento, scrive Yuval-Davis, che ha avuto applicazioni importanti nei rapporti fra
organizzazioni femministe e pacifste di Paesi in confitto
4
.
Una forma particolare e importante di confronto fra donne collocate in dife-
renti posizionamenti rispetto a una situazione di confitto anche quella realizzata
dalle studiose e attiviste israeliane e palestinesi che, attraverso racconti autobio-
grafci, hanno contribuito alla pubblicazione del volume Women and the Politics
of Military Confrontation. Palestinian and Israeli Gendered Narrative of Dislocation.
La scelta di Nahla Abdo e Ronit Lentin di raccontare nellintroduzione una sorta
di diario del lavoro di cura del volume durata due anni pone in evidenza in modo
molto signifcativo le dif colt di un percorso, messo duramente alla prova dagli
eventi politici e militari intervenuti nel frattempo
5
.
come fra i punti di riferimento dei Subatern Studies nati in gruppi di ricerca indiani, ci siano i lavori
dello studioso palestinese Edward Said, in particolare il volume Orientalism (Pantheon Books, New
York 1978)
2 Per quanto riguarda la ricerca storica ricordiamo che negli anni novanta alcune delle pi importanti
riviste di storia delle donne e di genere dedicarono a questi temi importanti numeri monografci. In
Gran Bretagna Gender and History si occup, per esempio, di Gender, nationalisms and national
identity (1993,2), incentrando lattenzione su temi come etnicit, razza e colonialismo in contesti
prevalentemente extraeuropei; in Spagna Arenal (1996 vol. 2, n. 3) pubblic un numero mono-
grafco su Gnero y costruccin nacional: una perspectiva; in Austria LHomme nel 1999 (n. 1)
si occup di Citizenship, cio di modi di acquisizione della cittadinanza da parte delle donne; in
Francia Clio(2000, n. 12), concentr lanalisi sulla distinzione fra Le genre de la nation e genre de
ltat, soprattutto nella Francia postrivoluzionaria; in Italia Genesis dedic il suo primo numero, nel
2002, a Patrie e appartenenze. Per quanto riguarda il contesto degli Studi subalterni e le ricerche di
storia post-coloniale, cfr., inoltre, Sayigh, R. Gendering the Nationalist Subject.. Palestinian Camp
Womens Life History, in Subaltern Studies, n. 10, Delhi, Oxford University Press 1999, pp. 234-
254; e Chatterje, P.; Jeganathan, P. (eds.) Community, Gender and Violence, in Subaltern Studies,
n. 11, New York, Columbia University Press, 2000.
3 Cfr. Yuval-Davis, N. Gender and Nation, London, Sage, 1997, capp. 4, 6.
4 Id. What is transversal politics?, in Soundings, issue 12 (1999), p. 97.
5 Nei quasi due anni in cui si realizzata la cura del volume per esempio scoppiata l Intifada
al- Aqsa, provocando problemi come la defezione di alcune autrici, il coinvolgimento di altre. La
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 520 03/05/2013 11:11:29
521
Introduzione
Associazioni di donne
In questo panel vengono afrontati due temi principali. Il primo riguarda lattivit
delle donne israeliane e palestinesi che nelle associazioni femminili/femministe
si battono per la pace e dunque la loro lotta per la fne delloccupazione e per
una soluzione del confitto che escluda la violenza e rispetti condizioni di equit
e giustizia
6
.
La nascita dei primi gruppi pacifsti costituiti da sole donne avvenne in Israele
nel periodo in cui nei territori della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dopo
ventanni di occupazione israeliana e di politica di insediamenti, era scoppiata la
prima Intifada, una forma di lotta di resistenza e di disobbedienza civile che aveva
visto entrare sulla scena pubblica, come nuovi protagonisti, non solo i ragazzi
delle pietre, ma anche le donne di tutti i ceti sociali e di tutte le aree, sia agricole
sia urbane.
Il periodo che prende avvio dalla fne del 1987 costituisce dunque non solo
una fase importante nella storia del confitto israelo-palestinese che fno al falli-
mento degli accordi di Oslo sembr dare alle speranze di pace prospettive molto
pi concrete che nel passato, ma anche in quella delle donne israeliane e palesti-
nesi. Per inquadrare meglio questo tema vale la pena ricordare che le associazioni
di donne non erano nuove nei due contesti, e che nuova non era nemmeno la pre-
senza femminile in associazioni pacifste. Nelle citt, e nei pi importanti villaggi
palestinesi, fn dagli ultimi anni del dominio ottomano avevano cominciato a
difondersi associazioni flantropiche femminili di ispirazione sempre pi spiccata-
mente nazionalista. Fondate e dirette da esponenti istruite del ceto medio urbano,
esse svolgevano soprattutto attivit assistenziali nei confronti delle donne dei ceti
pi poveri e delle loro famiglie, prevalentemente contadine, le pi colpite dagli
decisione delle curatrici stata quella di portare a termine il loro progetto, mettendo le lettrici/i
lettori a conoscenza delle dif colt intervenute. Cfr. Abdo, N.; Lentin, R. Writing Dislocation,
Writing the Self. Bringing (Back) the Political into Gendered Israeli-Palestinian Dialoguing, in
Abdo, N.; Lentin, R. (eds.) Women and the Politics of Military Confrontation. Palestinian and Israeli
Gendered Narrative of Dislocation, New York-Oxford, Berghahan Books, 2002, pp.1-36
6 Afrontando questi temi vale la pena ricordare che dal 1948, cio dalla proclamazione dello Stato
di Israele, quando ci si riferisce alle donne palestinesi e ovviamente anche agli uomini- impor-
tante specifcare quale sia la loro dislocazione, perch da essa dipendono forti diversit di status. Ci
sono infatti le donne che sono rimaste sul territorio divenuto Stato di Israele e ne hanno assunto la
cittadinanza; coloro che fno al 1967 hanno vissuto nella West Bank o nella Striscia di Gaza luna
annessa alla Giordania, laltra sotto il controllo egiziano , poi sottoposte alloccupazione israealiana;
coloro che abitano nei paesi confnanti Giordania, Siria e Libano, molte delle quali come avviene
anche in Cisgiordania e Gaza hanno ancora lo status di rifugiate e vivono nei campi profughi. In
questa sede il riferimento sar principalmente alle donne palestinesi della Cisgiordania e di Gaza e a
quelle con cittadinanza israeliana.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 521 03/05/2013 11:11:29
522
Capitolo 11. Donne israeliane e palestinesi fra critica, protesta e rappresentazioni
insediamenti sionisti. J.M. Peteet ha scritto che quelle esperienze costituiscono un
primo tentativo di infondere allattivit sociale e flantropica un valore nazionale
di carattere laico e urbano
7
. La difusione di queste esperienze diminu dopo la
fondazione, nel 1948, dello Stato di Israele e ricominci a svilupparsi soprattutto
dopo loccupazione del 1967. Liniziativa pi importante in questa fase fu lAsso-
ciazione per il rinnovamento della famiglia (Inaash al-Usrah), nata nel 1965, su
iniziativa di Samiha Khalil, una donna che fu a lungo una delle protagoniste della
scena pubblica palestinese. Alla fne degli anni Settanta, nella Palestina occupata
erano inoltre nati, su iniziativa di un gruppo di donne progressiste, giovani e istru-
ite, i Comitati delle donne e i Comitati per il lavoro delle donne. Lobiettivo era
quello di realizzare miglioramenti sociali e maggiore coinvolgimento femminile
nella lotta di liberazione nazionale. Lattivit svolta non era dunque semplicemen-
te assistenziale ma tendeva a coinvolgere le contadine e le lavoratrici urbane anche
nellattivit delle sezioni dei comitati aperte nellambito delle varie comunit e
a formare competenze che aumentassero le loro capacit (attraverso lalfabetiz-
zazione, listruzione e laddestramento al lavoro, lattivazione di asili). Nel corso
degli anni Ottanta i comitati aferirono non uf cialmente, perch era proibito
allOLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) e si divisero in quattro
sottogruppi, ognuno aderente a una diversa componente di quella organizzazione.
Ladesione delle donne palestinesi a questi gruppi rester tuttavia limitata fno
allIntifada che esplose nel dicembre 1987.
Rappresentazioni
Nei saggi che costituiscono la seconda parte di questo panel lattenzione concen-
trata su temi che mettono in luce importanti aspetti della rappresentazione delle
donne nelle societ palestinese e israeliana.
Eleonora Lotti afronta questo argomento attraverso una ricerca sui manuali
scolastici pubblicati fra il 2000 e il 2010 dal Ministero dellIstruzione dellAutorit
Nazionale Palestinese per le dieci classi dellobbligo di tutte le scuole della Cisgior-
dania e di Gaza. Dal 2000 infatti questi nuovi testi, i primi e gli unici fno a ora
destinati esplicitamente alle scuole palestinesi, sostituirono gradualmente i ma-
nuali utilizzati dopo il 1948 giordani in Cisgiordania ed egiziani a Gaza solo in
piccola parte modifcati dopo loccupazione israeliana del 1967. I testi analizzati
da E. Lotti, dunque, sono a tuttoggi in uso sia nelle scuole pubbliche sia in quelle
gestite dallUNRWA (Agenzia ONU per il soccorso e il lavoro dei rifugiati pale-
7 Cfr. Peteet, J.M. Gender in Crisis: Women and Te Palestinian Resistence Women, New York, Co-
lumbia University Press, 1991.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 522 03/05/2013 11:11:29
523
Introduzione
stinesi nel Vicino Oriente)
8
e nelle private (gestite da istituzioni religiose o laiche,
sia arabe che di diversa nazionalit)
9
.
Come la ricerca ha ampiamente dimostrato, i sistemi educativi e i manuali
scolastici hanno sempre rappresentato uno strumento di grande importanza nella
formazione delle giovani generazioni. Naturalmente questa importanza assume
aspetti peculiari in una situazione di confitto e di occupazione coloniale come
quella in cui si trovano i territori palestinesi da lunghissimo tempo. La ricerca di
Eleonora Lotti focalizza lattenzione sui modelli di famiglia e di donna propo-
sti in testi riguardanti diferenti discipline, mettendo innanzitutto in luce la non
omogeneit delle rappresentazioni. Il confronto fra i libri di religione non solo
islamica ma anche cristiana e quelli di Educazione civica rivela, per esempio,
che mentre i primi valorizzano modelli di famiglia patriarcali e molto tradiziona-
li, i secondi sottolineano la necessit, nelle societ attuali, del riconoscimento di
nuovi diritti, citando in proposito la Convenzione dellONU per lEliminazione
di tutte le forme di discriminazione contro le donne
10
. Ma laspetto pi interes-
sante riguarda il modo in cui i manuali rappresentano sia il mutamento dei ruoli
familiari durante loccupazione sia latteggiamento delle donne in particolare le
madri rispetto al martirio dei loro congiunti. Come accade in molte societ in
situazioni di guerra o confitto emergono fgure femminili che assumono ruoli di
solito riservati agli uomini: per sostituire il capofamiglia ucciso o carcerato, o per
necessit inedite della famiglia e della comunit, queste donne allargano il loro
impegno anche fuori dellambiente domestico e in generale degli spazi privati. Le
donne assumono in questi casi compiti lavorativi, caritativi, sociali che non vengo-
no per mai interpretati come fattori di trasformazione della loro identit sociale,
ma come un semplice prolungamento del loro ruolo familiare verso lesterno. I
manuali dunque ofrono alle ragazze e ai ragazzi uninterpretazione della vita che
scorre sotto i loro sotto occhi e che stanno vivendo. Lo fanno descrivendo una
situazione in trasformazione, probabilmente transitoria, che non va a intaccare so-
stanzialmente le relazioni di genere. In questo quadro la fgura della madre che ha
perso un fglio nella lotta per la liberazione assume la funzione di icona nazionale:
8 Lattivit dellUNWRA per i rifugiati si svolge oltre che nella West Bank e a Gaza in Giordania,
Libano e Siria; e si diferenzia a seconda dei paesi: in Giordania e in Siria per esempio, dove i rifugiati
possono liberamente accedere alle scuole pubbliche, comprende solo le primarie; in Libano, invece,
dove quellaccesso sottoposto a pesanti restrizioni, comprende anche le secondarie. I manuali sco-
lastici adottati sono ovunque quelli in uso nel paese ospitante
9 Nelle scuole private, accanto ai libri di testo pubblicati dallAutorit palestinese, ne vengono
utilizzati altri, mutuati di solito, da quelli adottati nei paesi dorigine.
10 Si tratta del documento adottato dallAssemblea generale dellONU nel 1979 ed entrato in vigore
a livello internazionale nel 1981.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 523 03/05/2013 11:11:29
524
Capitolo 11. Donne israeliane e palestinesi fra critica, protesta e rappresentazioni
mentre il suo dolore e le sue lacrime verranno infatti confnati alla sfera privata,
allinterno della sfera pubblica la sua immagine verr elaborata come madre di
eroe subendo un vero e proprio processo di nazionalizzazione.
Come vedremo, di un processo di nazionalizzazione che interviene nel rap-
porto fra madri e fgli maschi si parla anche nellintervento di Raya Cohen, dedi-
cato ad aspetti delle rappresentazioni delle donne israeliane nella letteratura e nella
flmografa di autori, uomini. Cohen sceglie come punti di riferimento per la sua
rifessione le opere di due importanti intellettuali israeliani che, pur se con diversa
radicalit, si pongono in modo critico rispetto al processo di militarizzazione su-
bito dal loro Paese; un processo che, scrive Cohen fa del soldato combattente la
maggiore incarnazione del cittadino israeliano, quello che mostra la maggiore fe-
delt allo Stato, pronto a obbedire, a uccidere e a farsi uccidere, [] e per questo
merita di essere privilegiato. Le opere analizzate in questa ricerca sono il romanzo
di David Grossman, A un cerbiatto somiglia il mio amore
11
, e il flm-documentario
Z32 di Avi Mograbi, entrambi usciti in edizione originale nel 2008.
Al centro di queste opere ci sono soggetti la cui vita scandita, spesso devastata
da eventi violenti legati alle guerre e alla militarizzazione della societ, eventi che
segnano pesantemente le loro anime e spesso anche i loro corpi. In una intervista lo
stesso Grossman ha dichiarato che il suo intento stato quello di raccontare come la
storia di Israele infuisca sulla vita di una piccola famiglia e come la violenza estrema
penetri nella sua intimit. Protagonista principale del racconto una donna, che de-
cide di intraprendere un viaggio attraverso Israele: a piedi, senza telefono, lontana da
radio e giornali. Quel viaggio laveva progettato con il fglio Ofer, che avrebbe dovu-
to congedarsi defnitivamente in quei giorni e che invece aveva chiesto di partecipare
a una ulteriore missione nei territori occupati. La decisione di compiere ugualmente
quel lungo cammino, nel quale Orah trascina anche Awram, il padre del ragazzo
che non aveva mai voluto conoscere il fglio n sapere niente di lui dipende dalla
volont di allontanare nel tempo il verifcarsi di un suo presentimento atroce: la
comunicazione della morte del fglio. Ma diventa anche unoccasione per rileggere il
passato, un passato nel quale c un marito dal quale si era separata e che adesso in
viaggio in Paesi lontani con il loro fglio; per far conoscere ad Avram suo fglio che,
forse attraverso il suo ricordo, potr continuare a vivere. Z32, stando a quanto di-
chiarato dallo stesso regista, la sigla che nellArchivio dellassociazione Breaking the
Silence composta da ex soldati che raccolgono testimonianze di colleghi impegnati
nelle zone occupate identifca giovani come quello da lui intervistato.
Nella societ palestinese la presenza femminile era stata signifcativa anche
nelle lotte degli anni Venti e Trenta del Novecento contro gli insediamenti ebraici
11
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 524 03/05/2013 11:11:29
525
Introduzione
e le truppe britanniche che li difendevano. Si era trattato per di un fenomeno pi
contenuto e riguardante soprattutto le aree rurali, che rappresentavano la grande
maggioranza del territorio. Nelle citt il fenomeno pi rilevante a quel tempo
era stato, invece la nascita di associazioni flantropiche di ispirazione nazionalista.
Presenti in numerosi centri urbani
12
, queste istituzioni erano fondate e dirette da
esponenti istruite del ceto medio urbano e svolgevano soprattutto attivit di tipo
assistenziale nei confronti delle donne di condizione sociale pi povera e delle loro
famiglie, prevalentemente contadine: le pi colpite dagli insediamenti sionisti.
Fra le attivit pi importanti cerano infatti, oltre a corsi di alfabetizzazione per
le donne delle campagne e di istruzione per le giovani ragazze, lassistenza agli
orfani dei caduti e agli invalidi, e il sostegno ai combattenti imprigionati e alle
loro famiglie
13
.
Diminuita considerevolmente nel periodo successivo al 1948 quando, dopo
la creazione dello Stato di Israele, la Cisgiordania venne annessa alla Giordania e
Gaza sottoposta al controllo egiziano la presenza di associazioni flantropiche,
come si detto, torn a svilupparsi soprattutto dopo il 1967, cio in seguito alloc-
cupazione israeliana di quei territori.
12 Le prime due associazioni sono segnalate durante la dominazione ottomana: ad Acri nel 1903 e
ad Haifa nel 1910.
13 Cfr. Dajani, S. Between National and Social Liberation. Phe palestinian womens mouvement
in the Israeli Occupied West Bank and Gaza Streep, in Mayer, T. Women and Israeli Occupation: the
Politics of Change, London and New York, Routladge, 1994 pp. 31 ss., 73-75.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 525 03/05/2013 11:11:29
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 526 03/05/2013 11:11:30
1. La coesistenza possibile tra palestinesi e
israeliani? Una lettura di genere
Giulia Daniele
Introduzione
A partire dallinizio degli anni Novanta nelle realt di confitto e post-confitto
linterazione tra genere e nazionalismo ha avuto un rifesso fondamentale sul
ruolo giocato dalle donne allinterno dei movimenti di resistenza nazionale. Paral-
lelamente, intrecciando la sfera pubblica con quella privata, la cosiddetta transver-
sal politic
14
ha creato le basi per stabilire forme appropriate di interazione e dialogo
tra donne appartenenti a societ in confitto
15
. Nella specifcit israelo-palestinese,
lo scoppio dellIntifadah al-Aqsa nellottobre 2000 ha, seppure con notevoli dife-
renze, inasprito enormemente le condizioni di vita dei settori pi vulnerabili nelle
due societ, ponendo interrogativi problematici alla sfda proposta dalle principali
esperienze congiunte tra donne palestinesi e israeliane. In un contesto in cui, sul
versante della popolazione oppressa, le palestinesi hanno continuato a essere vit-
time delloccupazione esterna militare israeliana e del costume patriarcale tradi-
zionale, mentre su quello dello Stato occupante, le israeliane, assoggettate al mito
della sicurezza nazionale, hanno dovuto fronteggiare un clima ideologicamente
sempre pi aggressivo e militarizzato, due sono gli interrogativi di fondo, che
14 Tale defnizione stata coniata da un gruppo di intellettuali femministe, tra cui Nira Yuval-Davis,
con lo scopo di problematizzare lomogeneit dei movimenti di donne e di rinforzarne lapproccio
femminista. stata principalmente utilizzata per descrivere le esperienze congiunte tra donne pa-
lestinesi e israeliane fnalizzate ad andare oltre alle divergenze etno-nazionali attraverso un processo
democratico e partecipativo.
15 Anthias, F.; Yuval-Davis, N. (eds.) Woman-Nation-State, London, Macmillan, 1989.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 527 03/05/2013 11:11:30
528
Capitolo 11. Donne israeliane e palestinesi fra critica, protesta e rappresentazioni
saranno oggetto di questa rifessione. Il primo : in dicotomie ormai consolidate
quali noi e loro, occupato e occupante, oppresso e oppressore, lidentit di
genere costituisce un fondamento cruciale nella costruzione di un legame eguali-
tario tra palestinesi e israeliani, senza pi disparit di potere e privilegi tra le due
parti? Il secondo: la transversal politic rappresenta una strategia politica fnalizzata
a superare le brutalit del confitto e a creare ponti alternativi in vista di una futura
coesistenza in Palestina/Israele?
Dopo il fallimento degli accordi di Oslo e la sconftta attuale della proposta
due Stati per due popoli, un numero crescente di intellettuali, accademici e atti-
visti ha riportato alla luce la discussione riguardante la creazione di uno stato uni-
co la cosiddetta soluzione One State dal mar Mediterraneo al fume Giordano,
in cui ogni cittadino potr vivere con eguali diritti sulla terra di Palestina e Israele.
Seguendo una narrazione storica intrecciata, la proposta di uno stato unico, egua-
litario e democratico da un lato e lanalisi dellidentit etno-nazionale in una pro-
spettiva di genere dallaltro ofrono un approccio critico volto alla de-costruzione
di una delle principali barriere allidea di una terra in cui auto-determinazione, li-
bert e uguaglianza possano essere garantite a tutti i cittadini: palestinesi, israeliani
o appartenenti a ogni altro gruppo minoritario. Il progetto della One State avanza
una visione pluralistica alternativa alla risoluzione del confitto israelo-palestinese,
mentre la prospettiva di genere evidenzia come le donne identifchino se stesse con
il nazionalismo da angolature diferenti rispetto a quelle proposte dagli uomini.
Donne palestinesi e israeliane: sde e miti etno-nazionali
In quanto settori pi deboli della societ, le donne palestinesi e israeliane sono
state costrette a prendersi carico dei peggiori efetti sociali, politici, economici
e psicologici che incombono sulle vite delle loro famiglie. Le donne palestinesi
hanno avuto, specialmente nei decenni passati, ruoli centrali nella lotta sociale e
nazionale per lauto-determinazione del proprio popolo; le donne israeliane han-
no preso parte, pi o meno criticamente, al discorso opprimente della sicurezza
nazionale
16
. In entrambi i casi, pur con diferenze legate alla notevole disparit di
potere e privilegi, loccupazione militare israeliana ha generato un cosiddetto im-
patto di genere, il quale ha rinforzato i confitti interni a ognuna delle comunit:
dei palestinesi della West Bank e della Striscia di Gaza, dei palestinesi cittadini di
Israele, degli ebrei israeliani.
Linizio della prima Intifadah nel dicembre 1987 ha avviato consistenti cam-
biamenti nella politica del movimento delle donne palestinesi, che pure sin dagli
16 Mayer, T. (ed.) Women and the Israeli Occupation, London, Routledge, 1994.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 528 03/05/2013 11:11:30
529
1. La coesistenza possibile tra palestinesi e israeliani? Una lettura di genere
anni Venti aveva partecipato attivamente alla lotta nazionale: uno dei suoi prin-
cipali obiettivi si espresso fno ad oggi nella volont di trasformare le strutture
di genere presenti nel sistema patriarcale. Questa presa di posizione ha infuen-
zato lintera societ
17
, se teniamo conto che, come ha scritto Rita Giacaman, la
coscienza femminista parte integrante della coscienza nazionale generale, poi-
ch esiste simultaneamente a essa in uno scambio dialettico costante
18
. In modo
parallelo, nei primi anni Novanta le donne ebree israeliane (fno allora dipinte
dal discorso sionista come fulcro necessario per la sopravvivenza della collettivit)
hanno compiuto, insieme alle palestinesi israeliane
19
, i primi passi verso un rico-
noscimento graduale: ci ha implicato che le questioni di genere non sono potute
rimanere estranee rispetto alle strutture militarizzate della politica dei propri go-
verni e alle oppressioni continue nei confronti del popolo palestinese.
Lesperienza del Jerusalem Link: una speranza illusoria?
Come nella soluzione One State che prevede ununit statale israelo-palestinese,
cos nelle narrative delle donne ebree e arabe prima, israeliane e palestinesi poi, il
concetto di coesistenza evidenzia la sfda principale nei confronti di entrambe
le identit nazionali. Nei decenni precedenti la formazione dello Stato di Israele e
lespulsione dei palestinesi dalle proprie terre, il contatto quotidiano tra le native
arabe e le pioniere ebree raf gura uno degli esempi pi forti della capacit delle
donne di oltrepassare separazioni etniche e territoriali. Le prime testimonianze
risalgono agli anni Venti e Trenta quando forti alleanze tra lavoratrici arabe ed
ebree, in particolare nelle fabbriche, si sviluppano fno a unirsi in lotte comuni per
ottenere uguali diritti salariali rispetto agli uomini
20
. Dopo la nascita dello stato
ebraico, soltanto allinizio degli anni Novanta, i movimenti di donne di entrambe
le parti hanno cominciato ad analizzare, dallinterno della propria specifca realt,
la complessit di esperienze di coesistenza che richiedono una cura e un ag-
giustamento costante
21
. La cosiddetta transversal politic, attraverso la formula di
17 Taraki, L. (ed.) Living Palestine: Family Survival, Resistance and Mobility under Occupation, New
York, Syracuse University Press, 2006.
18 Rita Giacaman in Sabbagh, S. (ed.) Arab Women: Between Defance and Restraint, New York,
Olive Branch Press, 1996.
19 Come minoranza allinterno dello stato ebraico, le donne palestinesi cittadine di Israele hanno
dato vita ad azioni congiunte (anche con le palestinesi della West Bank e di Gaza) fnalizzate a pre-
venire ogni ulteriore discriminazione etno-nazionale e di classe.
20 Bernstein. D.S. (ed.) Pioneers and Homemakers: Jewish Women in Pre-State Israel, Albany NY,
State University of New York Press, 1992.
21 Emmet, A.H. Our Sisters Promised Land: Women, Politics and Israeli-Palestinian Coexistence, Ann
Arbor, University of Michigan Press, 2003, p. 16.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 529 03/05/2013 11:11:30
530
Capitolo 11. Donne israeliane e palestinesi fra critica, protesta e rappresentazioni
cambiamento e radicamento
22
, diventa, in tale contesto, un passaggio nodale per
andare oltre lidea di Altro come nemico e per costruire un riconoscimento reci-
proco delle parti in confitto, in cui diventa fondante linclusione della diferenza
allinterno delluguaglianza
23
.
Numerose tematiche afrontate in unottica di genere (alcune delle quali han-
no fatto emergere forme simili di oppressione, discriminazione e ingiustizia) sono
state al centro del confronto politico tra attiviste pacifste israeliane e palestinesi
in vista di una condivisione delle proprie battaglie quotidiane. Valendosi di una
prospettiva di cooperazione egualitaria, le donne palestinesi hanno nutrito la spe-
ranza di una trasformazione radicale delle posizioni politiche della controparte,
mentre dallaltro le israeliane hanno aumentato la loro fducia nella costruzione di
relazioni interpersonali. Ma la transversal politics riuscita davvero a creare, attra-
verso le esperienze condivise di donne legate a forti identit nazionali, uno spazio
capace di proporre linee di lettura e azioni innovative nellambito di un progetto
di coesistenza tra le due popolazioni?
A partire dalla prima conferenza uf ciale incentrata sul dialogo tra donne isra-
eliane e palestinesi, intitolata Give Peace a Chance Women Speak Out e tenutasi a
Bruxelles nel 1989, numerosi incontri internazionali sono stati organizzati al fne
di proporre una visione di genere nelle relazioni di potere e una diferente perce-
zione socio-politica degli argomenti in questione. Nel 1993, un gruppo di donne
israeliane e palestinesi ha dato vita al Jerusalem Link, uno dei progetti congiunti
pi famosi e internazionalmente riconosciuti, grazie ai fnanziamenti dellUnione
Europea. Attraverso unazione che prevedeva sia una politica dal basso che il
coinvolgimento delle leadership, le donne partecipanti hanno richiamato lurgenza
di conquistare un livello di empowerment tale da poter prospettare un modello di
cooperazione tra israeliane e palestinesi, che facesse maturare, in accordo con il di-
ritto internazionale, una visione condivisa su questioni quali il riconoscimento del
diritto allauto-determinazione del popolo palestinese, la creazione di uno stato
palestinese indipendente a fanco di Israele, e la divisione della capitale Gerusa-
lemme, oggetto come noto della disputa pi delicata
24
.
Se a livello teorico i punti di interesse comune sembrano essere stati ben de-
lineati e sostenuti sia dalle palestinesi sia dalle israeliane, il tema dellappartenen-
za nazionale e quello connesso alla sicurezza sono divenuti le priorit sostenute
22 Lespressione stata defnita da alcune femministe italiane (in particolare appartenenti al net-
work delle Donne in Nero e alla Casa delle Donne di Bologna e Torino) lavorando con altre donne
di zone in confitto, soprattutto dai Balcani e Palestina/Israele.
23 Yuval-Davis, N. What is Transversal Politics?, in Soundings, XII, Summer 1999, p. 95.
24 Cockburn, C. From Where We Stand: War, Womens Activism and Feminist Analysis, London, Zed
Books, 2007, pp. 112-115.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 530 03/05/2013 11:11:30
531
1. La coesistenza possibile tra palestinesi e israeliani? Una lettura di genere
durante le riunioni congiunte tra le due parti. Ne dimostrazione lafermazione
della coordinatrice israeliana Molly Malekar, la quale spiega: ogni volta che ci
incontriamo il primo punto messo sul tavolo quello legato al tema nazionale,
e succeder lo stesso fno a quando non si porr fne alloccupazione militare e
potremo diventare due partner che discutono partendo da uno stesso livello
25
.
Sebbene i propositi iniziali avessero ottenuto un appoggio univoco, la costruzione
di un dialogo egualitario tra i diversi punti di vista ha subito complicazioni tali
da far fallire in parte, se non totalmente, il progetto della coalizione. Negli ultimi
anni, infatti, le strategie di lavoro comune si sono imbattute in unimpasse dovuta
allimpossibilit di raggiungere una posizione unica sulle questioni centrali, come
il diritto al ritorno o limpatto della violenza strutturale del confitto nei confron-
ti della vita quotidiana delle donne
26
. Allo stato attuale, sembra impraticabile
instaurare un dialogo giusto e paritario a causa dellasimmetria nellinfuenza po-
litica che la parte israeliana usa in modo forzato nei confronti delle palestinesi,
attuando disparit di potere e privilegi tra le partecipanti.
Analizzando la prospettiva macro del confitto, la condizione illegale e tragica
di occupazione dei territori palestinesi produce uno squilibrio profondo tra le
due parti e il dialogo diventa soltanto apparente: le donne israeliane, in quan-
to cittadine del paese occupante, hanno uno Stato mentre le donne palestinesi,
appartenenti al popolo sotto occupazione militare, non hanno ancora raggiunto
questo diritto. La cosiddetta normalizzazione dello status quo sta portando a una
legittimazione assoluta delle responsabilit coloniali dello Stato di Israele, come se
la questione palestinese fosse ormai stata risolta
27
. Nonostante venga riconosciu-
to che le esperienze condivise stanno attraversando una dif cilissima transizione,
entrambe le parti sostengono limportanza di non mettere la parola fne al proget-
to, ed esplicitano la volont di continuare a coltivarlo, quando saranno superati gli
ostacoli attuali. Lo sostiene Rula Salemeh, a capo del consiglio direttivo del Jeru-
salem Center for Women, secondo la quale abbiamo bisogno di designare nuove
strategie con le nostre sorelle di Bat Shalom, ma in questo momento dobbiamo
concentrare le nostre forze sul lavoro interno alla societ palestinese nella West
Bank e nella Striscia di Gaza
28
. E lo aferma anche la coordinatrice israeliana
Molly Malekar che sottolinea: ora necessario ricostruire una base di fducia su
cui riprendere in mano la relazione: dobbiamo riportare lattenzione sullobiettivo
25 Intervista in data 19 ottobre 2009, Gerusalemme.
26 Powers, J.M. Blossoms on the Olive Tree: Israeli and Palestinian Women Working for Peace,
Westport, Praeger, 2006, pp. 6-13.
27 Golan, D. Separation, Normalization and Occupation, in Palestine-Israel Journal of Politics,
Economics and Culture, II, n. 2, 1995.
28 Intervista in data 21 ottobre 2009, Ramallah.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 531 03/05/2013 11:11:30
532
Capitolo 11. Donne israeliane e palestinesi fra critica, protesta e rappresentazioni
della fne delloccupazione e della risoluzione dei principali punti critici come la
questione di Gerusalemme, il diritto al ritorno e gli insediamenti
29
.
Conclusione
Riconoscimento e coesistenza tratteggiano il percorso parallelo di due narrative: la
proposta politica della soluzione One State e le esperienze storiche congiunte di
donne palestinesi e israeliane, volte a prospettare una realt ancora inedita rispetto
a quella vissuta fnora in cui i due popoli potranno seguire principi di coopera-
zione e condivisione. Elemento comune ai due sentieri diventa la necessit di de-
costruire entrambe le identit etno-nazionali, in particolare la politica esclusivista
israeliana improntata sullideale sionista. Sia la critica di genere sia il modello
alternativo di Stato unico, seppure con i fallimenti e le insuf cienze incontrati nel
tentativo di raggiungere un reale livello egualitario tra le parti, testimoniano come
lunico punto di partenza nella riconciliazione tra palestinesi e israeliani possa
essere lammissione dellesistenza dellAltro, senza negare alcuna narrazione sto-
rica, a partire dalla conditio sine qua non di riconoscere ogni dramma storico e ogni
rappresentazione identitaria
30
.
Anche se un processo come quello delineato costituisce uno scoglio dif cile
da superare, la ri-problematizzazione di politiche alternative, come la soluzione
One State nel livello generale del confitto e la critica di genere nel contesto specif-
co delle esperienze condivise tra donne palestinesi e israeliane, pu aprire la strada
nella direzione di una coesistenza duratura e giusta, senza pi disparit di potere
e privilegi. In questo senso, lideale della transversal politic, emergente in una delle
zone di confitto pi problematiche al mondo, ha permesso di ridefnire, per mez-
zo di network formali e non, le relazioni interne insidiate dalle sfde pericolose del
nazionalismo e dellautorevolezza secolare del patriarcato, attraverso una nuova
agenda femminista in grado di far coesistere realt inevitabilmente legate tra loro,
seppur diferenti e ancora ostili. Seguendo il tracciato della narrativa collettiva
formatasi in questi decenni, linestricabilit delle storie e memorie condivise, in
primis quelle tra donne, rimane una delle poche immagini di speranza nel futuro
della terra di Palestina/Israele.
29 Intervista in data 19 ottobre 2009, Gerusalemme.
30 Ilan Papp in Hilal, J.; Papp, I. (a cura di) Parlare con il nemico, Torino, Bollati Boringhieri,
2004.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 532 03/05/2013 11:11:30
2. Le donne di Machsom Watch
tra normalizzazione e sda al mito
della sicurezza nazionale
Laura Aletti
Questa relazione la breve sintesi di un lavoro di ricerca che ha avuto come og-
getto il movimento pacifsta israeliano Machsom Watch (MW), composto da
sole donne e impegnato in quotidiani monitoraggi presso i check-point della West
Bank. Fonti principali del mio lavoro sono state: larchivio dei report redatti dalle
attiviste; unindagine sul campo nei mesi di novembre e dicembre del 2008
nelle aree di Gerusalemme, Betlemme e Ramallah, attraverso la quale ho potuto
osservare direttamente loperato delle attiviste durante i loro monitoraggi, racco-
gliendo testimonianze e interviste. Infne, ho difuso due questionari on-line: il
primo, in inglese, destinato a tutte le attiviste del movimento, il secondo, in arabo,
per un campione ristretto di potenziali benefciari dellorganizzazione.
Il termine machsom in ebraico moderno signifca posto di controllo, checkpoint:
costruiti dallesercito israeliano allinterno dei territori palestinesi, questi scenari
sono diventati luoghi-simbolo per entrambe le popolazioni. Per gli israeliani i
checkpoint sono strumenti indispensabili per la sicurezza dello Stato e dei suoi
cittadini. Per i palestinesi, invece, rappresentano il simbolo concreto delloccu-
pazione e il luogo dove i rapporti tra forza occupante e popolazione occupata si
manifestano esplicitamente. Questi luoghi militarizzati sono il punto di incontro
concreto tra israeliani (nella veste di soldati) e palestinesi: qui che la costruzione
stereotipata dellaltro trova conferma.
In questo contesto di aspro e quotidiano confitto, a partire dal febbraio del
2001 ha cominciato a muovere i suoi primi passi Machsom Watch donne con-
tro loccupazione e per i diritti umani, con tre obiettivi: monitorare il compor-
tamento dei soldati e della polizia ai checkpoint; assicurare che i diritti umani e
civili dei palestinesi nei territori occupati siano garantiti; registrare e raccontare
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 533 03/05/2013 11:11:30
534
Capitolo 11. Donne israeliane e palestinesi fra critica, protesta e rappresentazioni
i risultati delle osservazioni, dal livello di decision-making a quello dellopinione
pubblica
31
.
Come rivela larchivio informatico dellorganizzazione, disponibile su inter-
net, verso la met del 2001 il neonato gruppo contava una trentina di donne
in grado di efettuare due o tre osservazioni alla settimana
32
. Un anno dopo, a
met del 2002, le attiviste erano ancora meno di cento
33
. Fu solo nel 2003, grazie
allapertura di una sezione a Tel Aviv e a un articolo intitolato Many Mothers
34
,
apparso sul quotidiano Yediot Ahronot, che il movimento registr un boom di
adesioni che permise di garantire una maggiore copertura del territorio: se nel
dicembre del 2003 le attiviste erano 230, nel gennaio del 2004 diventarono 300 e,
a fne febbraio, circa 400
35
. Durante il 2004, il movimento port a termine quasi
3000 osservazioni
36
. Gli anni compresi tra il 2003 e il 2005 rappresentano sicura-
mente il momento doro del movimento, non solo per il numero di adesioni, che
arriv a circa 500 attiviste, ma anche per la copertura mediatica di cui fu oggetto
sia in Israele sia allestero.
Se analizziamo il proflo sociale medio delle attiviste, cos come emerge dal
questionario a cui ha risposto il 15% delle attiviste scopriamo come la maggior
parte si defnisca di origine ashkenazita (79%) e abbia tra i 50 e 70 anni. Si tratta
di donne lavoratrici (o in pensione), con una buona educazione scolastica (oltre
l80% ha una laurea)
37
. Pi della met sono, inoltre, sposate; il 72% ha fgli e il
41% ha nipoti: la stragrande maggioranza non si considera ebrea osservante. Per
quanto riguarda limpegno sociale, pi della met delle intervistate ha alle spalle
altre esperienze di attivismo in gruppi pacifsti contrari alloccupazione. Il 30%
del campione ha inoltre risposto di essere contemporaneamente attivo, oltre che
in MW, anche in altre organizzazioni.
Nonostante sia da registrare un calo nel numero delle attiviste a marzo del
2009 erano circa 350 MW continua, anche in questo periodo, a condurre rego-
31 Da: http://archive.machsomwatch.org (questo link rimanda alla prima versione del sito internet
di Machsom Watch, rimasta on-line fno alla fne del 2009. Per la versione attualmente in uso si veda
invece: www.machsomwatch.org visitato il 10.7.2010).
32 Keshet, Y. Machsom Watch Brief History, s.l., s.e., s.a., p. 2. Testo reperibile allindirizzo internet:
www.machsomwatch.org.
33 Ivi, p. 3.
34 Kadmon, S. Many Mothers, in Yediot Ahronot, 21 novembre 2003.
35 Dai report mensili di Machsom Watch: novembre 2003, gennaio 2004 e febbraio 2004. (Testi
reperibili nellarchivio on-line dellorganizzazione. Cfr. nota 1).
36 Watch, M. A Counterview Checkpoints 2004, s.l., s.e., 2005, p. 8. (Testo reperibile allindirizzo
internet: www.machsomwatch.org/en/summaries/bysubject).
37 Vd. anche: Keshet, Y. Checkpoint Watch Testimonies from Occupied Palestine, Londra, Zed
Books, 2006, p. 37.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 534 03/05/2013 11:11:30
535
2. Le donne di Machsom Watch tra normalizzazione e sfda al mito della sicurezza nazionale
lari osservazioni presso sessantadue posti di controllo dislocati dal nord al sud della
West Bank, visita sei corti militari e numerosi DCO
38
.
Oltre che nellattivit di monitoraggio, le donne di MW sono anche impe-
gnate nella redazione dei cosiddetti report, nei quali registrano e documentano le
loro osservazioni: una sorta di diario della vita sotto occupazione ai checkpoint.
Questi resoconti sono oggi raccolti nel sito internet dellorganizzazione dove ven-
gono quotidianamente pubblicati, in ebraico e in inglese. I dati raccolti sono uti-
lizzati anche da altre organizzazioni israeliane con le quali lassociazione collabora,
come ad esempio Physicians for Human Rights-Israel, e costituiscono un archivio
di fonti documentarie senza precedenti.
La particolarit dello scenario scelto dalle attiviste come teatro della prote-
sta rappresenta di per s una rivoluzione, non solo allinterno delle tradizionali
tipologie di manifestazione adottate dal campo pacifsta israeliano, ma anche per
quanto riguarda il pensiero comunemente condiviso dallopinione pubblica in
Israele rispetto alla questione della sicurezza nazionale.
Le attiviste di MW hanno il merito di aver spostato, per la prima volta
nella storia delle contestazioni in Israele, lo spazio della protesta lontano dalle
piazze delle citt, calandosi in una zona di confitto. Spostamento non privo di
signifcati.
Come noto, la formula di contestazione pi comunemente adottata dal
campo pacifsta in Israele consiste nelle manifestazioni di piazza. I movimenti
pacifsti femminili hanno sempre cercato, in tale contesto, vie di protesta alter-
native, con lo scopo di attirare lattenzione dellopinione pubblica. Lesempio pi
famoso rappresentato dallo movimento storico delle Donne in Nero. Nato a
Gerusalemme nel gennaio del 1988, esso riuscito a dare vita a una nuova forma
di protesta che ha rappresentato una frattura nella tradizionale divisione di genere
della societ israeliana. Le Donne in Nero (posizionandosi, vestite di nero e in
silenzio, presso gli incroci stradali delle citt) usarono il proprio corpo per mettere
in discussione la struttura sociale della divisione dei ruoli e uscire dallo spazio
privato per calarsi fsicamente in quello pubblico
39
. In questo quadro, la scelta
operata da MW di inserirsi in un contesto nuovo, militare, violento, e di dominio
prettamente maschile come i checkpoint, rappresenta unulteriore frattura
40
nella
comune concezione della divisione dei ruoli fra i generi in Israele, che vede luo-
38 District Coordination Of ce. Uf ci dellamministrazione civile israeliana dove la popolazione
palestinese deve recarsi per richiedere i permessi necessari a viaggiare, lavorare, ricevere cure mediche,
etc
39 Helman, S.; Rapoport, T. Women in Black: Challenging Israels Gender and Socio-Political
Orders, in British Journal of Sociology, vol. 48, n. 4, 1997, pp. 682-700.
40 Keshet, Y. Checkpoint Watch cit., p. 36.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 535 03/05/2013 11:11:30
536
Capitolo 11. Donne israeliane e palestinesi fra critica, protesta e rappresentazioni
mo impegnato nella difesa della nazione e la donna nel ruolo sociale di madre o
moglie di un soldato
41
.
Con i loro turni di osservazione, le attiviste di MW puntano inoltre il dito
verso quelle che considerano essere le responsabilit di Israele nella questione pa-
lestinese; cos facendo, assumono una posizione chiara allinterno del discorso mi-
litare. Pur essendo parte della societ israeliana, la posizione presa dalle donne di
MW rispetto alla politica dei checkpoint, messa in piedi dal loro stesso Stato, rap-
presenta una profonda cesura allinterno del pensiero comune. Distaccandosi in
modo netto dallideologia della sicurezza e mettendo in discussione il fondamento
stesso della politica a essa collegata, MW contesta infatti non solo le modalit di
comportamento adottate ai checkpoint da parte dei soldati, ma lesistenza stessa di
queste strutture
42
.
Se, come si visto, per lopinione pubblica israeliana i checkpoint sono stru-
menti essenziali per la sicurezza di ciascun cittadino, le attiviste di MW guardano
questa politica da un punto di vista opposto e la considerano unarma a doppio
taglio. Sostengono infatti che, nel danneggiare sistematicamente la popolazione
palestinese, i posti di controllo da una parte contribuiscono ad alimentare lodio
nei confronti degli israeliani; dallaltra intaccano la morale e le coscienze dei gio-
vani soldati, corrodendo la societ intera e le future generazioni
43
.
Unulteriore prova del carattere innovativo del movimento, data dal fatto
che le attiviste sono osteggiate sia sul piano sociale che su quello della sfera pri-
vata, come raccontato da una cinquantasettenne, attivista di MW dal 2007:
stata dura quando sono tornata a casa dopo [la mia prima osservazione]. Sentivo
il bisogno di raccontare, ma nessuno era interessato ad ascoltare. Nel peggiore dei
casi diventavi il loro nemico
44
.
Tali frizioni a livello familiare rispecchiano su scala ridotta quella che essen-
zialmente la percezione a livello nazionale dellattivismo di MW ai checkpoint: un
pericolo per la vita degli israeliani. Queste donne sono rappresentate come tradi-
trici e amiche dei terroristi e un ostacolo al duro lavoro dei soldati ai checkpoint
45
.
41 Helman, S. From Soldiering and Matherhood to Citizenship: A Study of Four Israeli Peace
Movements, in Social Studies, vol. 6, n. 3, 1999, pp. 292-313; Herzog, H. Gendering Politics
Women in Israel, Ann Arbor, University of Michigan, 1999, pp. 55-56.; Herzog, H. Homefront
and Battlefront: Te Status of Jewish and Palestinian Women in Israel, in Israel Studies, vol. 3, n.
1, 1998, pp. 61-84; McKeown, L.; Sharoni, S. Formations and Trasformations of Masculinity in the
North of Ireland and in Israel-Palestine, s.l, s.e., 2002, p. 9.
42 Watch, M. A Counterview Checkpoints 2004 cit., pp.7- 28.
43 Ivi, p. 28.
44 Anonima. intervista con lA., marzo 2009
45 fr. ad esempio il sito internet www.ngo-monitor.org alla voce Machsom Watch.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 536 03/05/2013 11:11:30
537
2. Le donne di Machsom Watch tra normalizzazione e sfda al mito della sicurezza nazionale
La loro azione considerata talmente pericolosa e dannosa da suscitare la reazione
di gruppi composti da donne appartenenti alla destra nazionalista
46
. Anchesse si
recano ai chekpoint, ma per manifestare la loro gratitudine ai soldati, in dichiarata
opposizione al movimento pacifsta.
Nonostante la chiara presa di posizione di MW nei confronti della politi-
ca dei posti di controllo, lattivit pratica non priva di contraddizioni. Seb-
bene il principale obiettivo di MW sia quello di protestare contro lesistenza
dei checkpoint, lincontro con le condizioni a cui i palestinesi sono sottoposti
ha prodotto in gran parte delle attiviste lurgenza di alleviare, nei limiti delle
loro possibilit, le dif colt di cui sono testimoni. Se da un lato molte attiviste
non vogliono cooperare con le autorit militari, nei fatti MW si trova oggi di
fronte a un dilemma: essere solo voce di protesta o svolgere anche una fun-
zione di tramite tra i soldati israeliani e la popolazione palestinese? La linea di
confne tra contatto con i militari e collaborazione con essi si assottigliata e le
posizioni si sono diferenziate: alcune di loro non vogliono avere nessun tipo
di relazione con lesercito, altre sono disposte a confrontarsi con i soldati per
ottenere benefci per i palestinesi, mentre altre ancora considerano i giovani
militari come semplici strumenti del sistema e destinatari a pieno titolo del
loro attivismo. Lassenza di un codice di comportamento comune da adottare
durante le osservazioni ha fatto s che alcune attiviste abbandonassero la posi-
zione di semplici osservatrici per passare ad aiutare la popolazione con piccole
azioni, come ad esempio portare acqua durante le lunghe attese o seguendo
le vicende e gli esiti di singoli casi. Tali azioni, del tutto spontanee, non ot-
tenevano lapprovazione di tutte le attiviste. Per alcune tali attivit aiutavano
lesercito a ignorare le proprie responsabilit derivanti da circostanze che esso
stesso aveva imposto
47
. MW ha cos iniziato a contestare allesercito la man-
canza di alcuni servizi basilari, come quelli igienici o forme di riparo dal sole
e dalla pioggia. Da parte loro, le autorit militari hanno cominciato a confor-
marsi a queste richieste, rendendo i checkpoint non pi ostacoli provvisori, ma
costruzioni permanenti, ricche di infrastrutture. Certamente MW non stato
lunico attore coinvolto in questo processo, tuttavia paradossale riscontrare
come uno degli efetti dellagire di un movimento, il cui principale scopo
era quello di porre fne al sistema dei checkpoint, diventi (o possa divenire)
il potenziamento di quello stesso sistema e la base della sua normalizzazione.
A questo proposito, alcune delle attiviste sostengono che i vantaggi pratici
derivanti da questo processo superino gli svantaggi, per altre invece rimane il
46 Si tratta, in particolare, dei movimenti Women in Blue and White e Women in Green.
47 Kotef, H.; Amir, M. (En)Gendering Checkpoints: Checkpoint Watch and the Repercussions
of Intervention, in Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 32, n. 4, 2007, pp. 974-996.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 537 03/05/2013 11:11:30
538
Capitolo 11. Donne israeliane e palestinesi fra critica, protesta e rappresentazioni
timore e la sensazione di essere usate dallo Stato per mostrare la sua tolleranza
in materia di diritti umani
48
.
Per quanto riguarda il rapporto con i palestinesi e i soldati israeliani, va ri-
cordato che le attiviste sono parte integrante e prodotto della societ israeliana.
Con due conseguenze: la prima che le donne hanno dovuto intraprendere un
personale percorso per superare limmagine stereotipata, che nella loro societ vie-
ne proposta, sia dei palestinesi sia dei soldati ai checkpoint. La seconda riguarda il
fatto che, soprattutto negli ultimi anni, i palestinesi hanno cominciato a vedere
in MW uno strumento di normalizzazione dei chekpoint, senza distinguere tra
civili e militari, e vedono nelle attiviste solo le madri e le mogli di chi li occupa.
Per i palestinesi, i checkpoint non sono solo un ostacolo lungo la strada, ma il sim-
bolo delloccupazione. In questottica quindi considerano pi importante, in un
processo a lungo termine, lattivit originaria del movimento, losservazione e la
scrittura dei report, piuttosto che i vari tentativi di aiuto umanitario fatti in scala
ridotta e con conseguenze a breve termine.
A conclusione di questo breve intervento, mi sembra interessante far nota-
re unosservazione emersa dalla mia ricerca. Nonostante MW sia percepito dalla
stragrande maggioranza degli israeliani come traditore e nonostante il luogo della
sua protesta si sia fsicamente dislocato presso i simboli concreti delloccupazio-
ne, avvicinandosi ai palestinesi, questo movimento vuole mantenere uno stretto
contatto con la societ israeliana. Cos come le Donne in Nero, con le loro veglie,
volevano ricordare agli israeliani loccupazione, anche MW con i suoi report vuole
informare i cittadini israeliani sugli aspetti concreti di una drammatica realt: gli
interlocutori che MW intende raggiungere non sono solo i palestinesi, ma anche
i cittadini ebrei israeliani. Un altro risultato di questa attivit tuttavia quello di
mostrare ai palestinesi un volto a loro sconosciuto.
48 Naaman, D. Te Silenced Outcry: A Feminist Perspective from the Israeli Checkpoints in
Palestine, in NWSA Journal, vol. 18, n. 3, 2006, pp. 168-180.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 538 03/05/2013 11:11:30
3. Le donne nei manuali delle scuole
pubbliche palestinesi
Eleonora Lotti
Introduzione
Questo intervento riassume i principali risultati di una ricerca sui manuali per la
scuola dellobbligo pubblicati dallAutorit Palestinese a partire dal 2000 e si pro-
pone di analizzare quali modelli di donna vengano presentati alle giovani genera-
zioni. Il tema coinvolge aspetti importanti dellintricato rapporto tra educazione,
famiglia, genere e nazionalismo nella societ palestinese.
Prima di afrontare largomento utile ricordare, tuttavia, che il sistema sco-
lastico palestinese prevede dieci classi di scuola dellobbligo (un primo ciclo ele-
mentare che va dalla prima alla sesta e un ciclo intermedio che va dalla settima alla
decima) e che nella sua storia il 2000 rappresenta un momento fondamentale: da
quellanno prende infatti avvio il primo e unico curriculum che si pu defnire in-
teramente palestinese. In precedenza, gli studenti della Cisgiordania studiavano su
testi mutuati dal curriculum giordano, mentre quelli di Gaza seguivano il curricu-
lum egiziano. A partire dal 2000, invece, gli studenti di Gaza e della Cisgiordania,
grazie alladozione di un nuovo curriculum comune, sono inseriti in un sistema
scolastico unifcato e non mutuato da quello di altri Paesi..
Questo studio si basa dunque su un campione di 55 manuali adottati per i
dieci anni dellobbligo nella scuola pubblica, nel periodo 2000-2010. Essi riguar-
dano un gruppo di materie selezionate per lalta probabilit che in esse vengano
afrontati temi riguardanti la famiglia e i ruoli privati e pubblici svolti dalle donne.
Poich nel periodo in esame stata adottata ununica edizione di libri di testo per
ogni materia, quelli presi in esame sono i soli utilizzati nelle scuole di Cisgiordania
e Gaza per le materie selezionate.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 539 03/05/2013 11:11:30
540
Capitolo 11. Donne israeliane e palestinesi fra critica, protesta e rappresentazioni
Attraverso la traduzione, lanalisi e la contestualizzazione di brani tratti da questi
testi e la rifessione sulle immagini in essi contenuti ho cercato dunque di ricostruire
quali tipologie di famiglia vengano presentate alle giovani generazioni di palestinesi
e quali modelli femminili ne emergano. Ci stato possibile perch, nei ritratti di
famiglia proposti, alle donne riservata unattenzione particolare: divise tra famiglia e
societ esse appaiono, nellambito intimo e domestico, come il fulcro di quel processo
di resistenza e costruzione nazionale che passa anche attraverso la trasmissione inter-
generazionale della memoria e la circolazione quotidiana di discorsi e narrative a essa
legati. Ma il contributo delle donne alla resistenza contro loccupazione e al processo
di costruzione nazionale non esclusivamente limitato allambito quotidiano e alla
dimensione simbolica. C anche un ruolo pubblico e attivo che esse sono incoraggiate
ad assumere, contribuendo cos in prima persona alla lotta contro loccupazione isra-
eliana e a un vero progetto di costruzione nazionale e statale: in tale contesto vanno
inquadrati, come si vedr, i temi riguardanti la resistenza e il martirio.
In questa sede potr naturalmente solo riasumere in sintesi alcuni risultati del
mio lavoro.
I diritti delle donne: fra tradizione e modernit
I testi adottati nel curriculum palestinese dimostrano sensibilit nei confronti dei
diritti delle donne. Essi rimandano a una pluralit di modelli, che sono per spes-
so semplicemente giustapposti, senza essere discussi criticamente. In particolare,
la valorizzazione di un modello rispetto a un altro sembra dipendere soprattutto
dalla materia allinterno della quale scritti e immagini sono collocati. Un confron-
to fra i manuali di educazione islamica e quelli di educazione civica pu essere
ef cace a questo proposito. Se i primi propongono infatti la valorizzazione del
ruolo tradizionale in base ai dettami della religione, i secondi considerano i diritti
della donna in una prospettiva universalistica e laica.
I manuali di educazione islamica sottolineano il progresso rappresentato per
le donne dallavvento dellIslam, mettendo poi in evidenza i limiti che allesercizio
dei singoli diritti sono previsti dalla stessa legge islamica:
Nel manuale per la classe quinta si aferma fra laltro:
La donna prima dellIslam era oppressa, non le venivano riconosciuti i propri
diritti. LIslam lha valorizzata, lha onorata come fglia, moglie e madre e le ha
insegnato i suoi diritti e doveri. (La donna) ha quindi iniziato a partecipare assie-
me alluomo alladempimento delle necessit della vita e alla realizzazione della
missione islamica
49
.
49 Educazione islamica, 5 (b), p. 42.
Queste citazioni nel
fle originale erano
sempre in corsivo.
Come da norme re-
dazionali le abbiamo
messe in tondo fuori
testo in quanto cita-
zioni lunghe. Va bene
cos?
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 540 03/05/2013 11:11:30
541
3. Le donne nei manuali delle scuole pubbliche palestinesi
E il manuale per la decima classe si apre con lafermazione che la venuta
dellIslam ha segnato una cesura fondamentale nella storia delle donne. Rispetto
alla condizione precedente, si legge, esse hanno cominciato a godere di sempre
maggiori diritti, che vengono cosielencati:
1) libert di disporre del proprio denaro come luomo nei limiti di ci che lecito
e illecito. [];
2) diritto di scegliere il compagno di vita;
3) diritto alleducazione e alluguaglianza nel trattamento [];
4) diritto alla nafaqa
50
;
5) diritto allistruzione; lIslam considera listruzione una delle necessit fonda-
mentali dellindividuo, sia esso maschio o femmina [];
6) diritto al lavoro.
51
Rispetto allultimo punto, il testo prosegue elencando le restrizioni a cui la
donna musulmana deve attenersi sul posto di lavoro:
1) le vietata la promiscuit con gli uomini
2) non pu farsi bella per recarsi al lavoro, ma deve attenersi allabbigliamento
previsto dalla sharia e adornarsi (solamente) della morale dellIslam e dei suoi
buoni costumi;
3) deve trovare un equilibrio tra i diritti di suo marito e dei suoi fgli e il suo
lavoro, in modo che questultimo non la conduca a prestar loro cure inadeguate
e a recar loro danno
52
.
A questa visione del ruolo e dei diritti delle donne fssati nel tempo dalle leggi
religiose, nei manuali di educazione civica se ne contrappone una che rappresenta
gli stessi come oggeto di trasformazioni profonde nel corso del tempo. Alle ragazze
e ai ragazzi della classe ottava viene insegnato infatti che:
Le societ moderne si dirigono oggi verso una maggiore valorizzazione del ruolo
fondamentale della donna nella vita: come fondatrice di una famiglia ed educa-
trice delle generazioni future, e in relazione al suo ruolo sociale, come lavoratrice
partecipe allo sviluppo della sua societ
53
.
50 Nel diritto islamico, si tratta degli alimenti dovuti dal marito alla moglie.
51 Educazione islamica, 10 (b), p. 93.
52 Ivi, pp. 96-97 poetessa araba e una delle prime donne che si convertirono allIslam poetessa
araba e una delle prime donne che si convertirono allIslam.
53 Educazione civica, 8, p. 6.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 541 03/05/2013 11:11:30
542
Capitolo 11. Donne israeliane e palestinesi fra critica, protesta e rappresentazioni
Importante a questo proposito ricordare il riferimento fatto nel manuale
per la classe nona alla Convenzione per lEliminazione di tutte le Forme di Di-
scriminazione Contro le Donne (CEDAW)
54
, riferimento che rifette ladesione a
quelle concezioni di tipo occidentale. Il manuale, sottolinea in particolare alcuni
contenuti della Convenzione relativi alla condizione della lavoratrice madre:
Divieto di licenziamento a causa della gravidanza o del congedo di maternit, e
divieto di discriminazione e licenziamento sulla base dello stato matrimoniale;
diritto al congedo di maternit retribuito e garanzia di ritorno al proprio posto di
lavoro; protezione particolare per la donna durante la gravidanza nei lavori che
sono ritenuti a lei nocivi; parit di retribuzuione
55
.
Ma se da un lato il manuale di educazione civica per la classe nona fa riferi-
mento a un documento riconosciuto internazionalmente, dallaltro la rappresen-
tazione che risulta dalla trattazione generale dellargomento basata sullidea che i
compiti di moglie e madre costituiscono per la donna un destino irrinunciabile e
necessario. Nella societ moderna il suo ruolo non cambia, si amplifca: la donna
non sar solo fondatrice di una famiglia ed educatrice delle generazioni future
ma anche, qualora lo desiderasse o ne avesse necessit, lavoratrice partecipe allo
sviluppo della sua societ. Nella selezione dei diritti garantiti dalla Convenzione
e delle loro violazioni, infatti, il manuale di educazione civica insiste soprattutto
su esempi legati al matrimonio o alla gravidanza. Se da un lato ci sembra sotto-
lineare quanto sia ancora considerato secondario in quella societ il fatto che una
donna abbini al suo ruolo di moglie e madre una occupazione extradomestica,
dallaltro lidea che emerge dalla selezione degli argomenti che essa non pu
che essere (anche) madre e moglie ed soprattutto in questa veste che deve essere
protetta
56
.
Visioni quali quelle esposte nei manuali di educazione islamica e posizioni di
stampo occidentale coesistono dunque allinterno dello stesso curriculum senza
54 Si tratta di un accordo della Commissione delle Nazioni Unite sullo Status delle Donne (CWS)
in vigore dal 3 settembre /1981. Gli Stati frmatari al momento sono 185 (il 90% degli Stati membri
delle Nazioni Unite), lAutorit Palestinese, che ha espresso la volonta di aderirvi, non essendo
formalmente uno Stato non fgura tra i Paesi frmatari. Il testo della Convenzione consultabile su
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/; accesso del 30/08/2008.
55 Educazione civica,, 9, p. 36.
56 Uno studio quantitativo da me realizzato sulle immagini che rappresentano uomini e donne in
relazione alle professioni svolte, mostra come i primi vengano abbinati a unampia variet di profes-
sioni, che comprendono posizioni di rilievo, mentre le donne sono presentate quasi esclusivamente
come maestre, infermiere e contadine, lavori che altro non sono che lestensione naturale delle man-
sioni a cui sono state tradizionalmente associate.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 542 03/05/2013 11:11:30
543
3. Le donne nei manuali delle scuole pubbliche palestinesi
essere discusse criticamente. Se ladozione di una presa di posizione organica e coe-
rente in relazione a un tema tanto dibattuto risulta piuttosto problematica, laspet-
tativa che un curriculum scolastico che si defnisce integrato e comprensivo
57
dovrebbe soddisfare la trasmissione di quegli strumenti che permettono allo
studente di conoscere e di scegliere tra i vari punti di vista insiti nel discorso isla-
mico e in quello secolare della societ in cui vive. Come sottolineato dal teologo
austriaco Wolfram Reiss, invece, mentre i manuali di educazione islamica sembra-
no non riconoscere n le componenti pi liberali dellIslam n le comunit non
musulmane in Palestina, i testi di educazione civica ignorano lIslam tradizionali-
sta e conservatore
58
. Anche i testi di educazione cristiana presenti nelle scuole
private religiose cristiane pur non trattando in maniera dettagliata il tema dei
ruoli familiari e sociali delle donne, prediligono un approccio conservatore, basato
sulla valorizzazione della famiglia e dei ruoli tradizionali dei suoi componenti.
Questa variet di modelli di donne in cui identifcarsi o identifcare chi appar-
tiene al proprio mondo pu avere il merito di invitare alla rifessione, al confronto
e alla discussione in classe. Si pu tuttavia immaginare come in contesti in cui la
libert delle donne fortemente limitata, come a Gaza dopo lavvento al potere di
Hamas, questo vuoto venga colmato da interpretazioni di carattere tradizionalista,
dominanti a casa come a scuola, e lontane dallincoraggiare la liberazione della
condizione femminile.
La rappresentazione delle donne nel contesto delloccupazione
israeliana
Alcuni studi socio-antropologici relativi alla societ palestinese contemporanea
hanno messo in luce il temporaneo empowerment (in ambito domestico e sociale)
di cui le donne hanno potuto benefciare in alcune fasi del confitto, come per
esempio nel contesto dellintifada.
Lassunzione di maggiori responsabilit a cui esse hanno dovuto far fronte
nellambito famigliare in conseguenza dei meccanismi messi in atto dalloccupa-
zione viene cos descritta dal manuale di educazione nazionale per la classe quinta:
La donna palestinese si assume da sola la completa responsabilit della famiglia
quando il marito subisce il martirio o imprigionato, e persino quando trat-
tenuto (ai posti di blocco). Inoltre, essa provvede alla famiglia nel caso in cui il
57 Cfr. PCDC, First Palestinian Curriculum Plan, 1998, prefazione.
58 Reiss, W. Palestinian Textbooks on the Subject of Islamic Religion, Langen, 2004; consultabile su
www.gei.de, accesso al 02/07/2008.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 543 03/05/2013 11:11:30
544
Capitolo 11. Donne israeliane e palestinesi fra critica, protesta e rappresentazioni
marito perda il lavoro per cause connesse alla condizione di occupazione vissuta
dalla societ palestinese durante la quale un grande numero di lavoratori sono
diventati disoccupati
59
.
Nonostante la partecipazione femminile sia stata vitale per gli esiti della lot-
ta nazionale, stato in pi occasioni sottolineato come essa non abbia in realt
portato a una diversa defnizione dei ruoli di genere. Le responsabilit femmi-
nili nei confronti della resistenza, per quanto indispensabili, erano infatti per lo
pi rappresentate come estensioni dei ruoli di genere tradizionali (includevano
ad esempio cure ai feriti, visite alle famiglie dei martiri o dei prigionieri, pro-
tezione e rifugio agli shebab, partecipazione in manifestazioni per il rilascio dei
detenuti e cos via)
60
. Confermando ampiamente la visione ricorrente nel discorso
nazionalista in relazione alle responsabilit sociali delle donne descritta negli studi
socio-antropologici citati, il manuale di educazione nazionale per la classe quinta
menziona cos i campi in cui la donna palestinese manifesta il suo contributo allo
sviluppo della societ:
(Il suo impegno sociale) consiste nella partecipazione alle associazioni caritative
e alle istituzioni che si occupano di ofrire dei servizi alla societ come [] la
cura delle famiglie dei martiri, dei prigionieri e il trattamento dei feriti e degli
ammalati.
Anche a livello uf ciale, le donne palestinesi vengono celebrate o menzionate
soprattutto in relazione al ruolo sociale di madre e moglie (di martiri o prigionieri)
e alle capacit riproduttive. Un esempio signifcativo riguarda la proclamazione,
nel 1988, del 21 maggio come festa della mamma e festivit nazionale. Lungi
dallessere un gesto di riconoscimento del valore della maternit, questo giorno
celebrava esplicitamente il ruolo delle madri nel generare eroi e militanti per lin-
tifada
61
. Due anni dopo, il 21 maggio del 1980, lUNLU si congratulava con le
madri palestinesi considerando le loro soferenze e pene come fonte della nostra
forza e determinazione. Quasi contemporaneamente, la stessa istituzione onorava
le palestinesi per aver fatto la storia attraverso il sangue dei loro fgli
62
.
59 Educazione nazionale, 5, p. 20.
60 Johnson, P.; Kuttab, E. Where Have All Te Women (and Men) Gone? Refections on Gender
and the Second Palestinian Intifada, in Feminist Review, 69, 2001, pp. 21-43.
61 In quel giorno, infatti, le delegazioni locali dei comitati femminili e delle organizzazioni giovanili
facevano appello alle famiglie dei ragazzi incarcerati, uccisi, feriti nellambito di azioni di resistenza
alloccupazione.
62 Jean-Klein, I. Mothercraft, Statecraft, and Subjectivity in the Palestinian Intifada, in American
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 544 03/05/2013 11:11:30
545
3. Le donne nei manuali delle scuole pubbliche palestinesi
Questa resistenza al femminile, che si esprime soprattutto nella capaci-
t di sopportazione, nellabnegazione di s a favore della famiglia e della socie-
t e nellattitudine al sacrifcio, emerge cos nel testo dello scrittore palestinese
Rudwan Abu Ayyash:
Alla madre palestinese richiesto di piangere con un sorriso, di penare dalla culla
alla tomba, di sostituire il padre o il fratello nel caso fossero assenti e di compiere
incessantemente un sacrifcio dopo laltro.[] Ai cancelli della prigione o alla
porta di uno spietato tribunale essa innalza lemblema della libert. Solleva le
pene dei feriti, accende la luce dei libri, lasse della famiglia ed ha imparato dalla
nostra grande madre, la Palestina, cos la maternit
63
.
La donna e il martirio
La questione del martirio in relazione al nuovo curriculum palestinese stata sol-
levata da organizzazioni, quali lisraeliano Center for Monitoring the Impact of
Peace, che allindomani della loro pubblicazione, accusarono i manuali scolastcci
palestinesi di incitare allodio nei confronti di Israele, alla resistenza e al martirio.
In questo contesto appare interessante verifcare loccorrenza di questi temi da
unottica di genere.
Tra i generici riferimenti al martirio da me analizzati in un precedente stu-
dio
64
, si trova la storia di al-Khansa, celebre poetessa araba, una delle prime donne
convertite allIslam
65
. Si legge:
Prima che al-Khansa si convertisse allIslam, suo fratello Sakhr fu ucciso e lei lo
pianse molto e compose per lui molti elogi funebri. Poi si convert allIslam ()
In questa battaglia
66
i suoi quattro fgli caddero da martiri. Al-Khansa ricevette
la notizia del loro martirio e disse: Sia lodato il Signore che mi ha onorato del
loro martirio in Suo nome e spero che Egli mi ricongiunga a loro nel luogo della
Sua misericordia
67
.
Ethnologist, 27, n. 1, 2000, pp. 100-127.
63 Dallopera di Abu Ayyash, E. La nostra bella lingua cit., 5, (b), p. 31.
64 Lotti, E. Occupazione e Nazione nel Nuovo Curriculum Palestinese, in ComPol-Comunica-
zione Politica, luglio 2009.
65 Si tratta di Tumader bint Amru, soprannominata al-Khansa (575-664 d. C. circa).
66 Si tratta della battaglia di al-Qadisiya (637 d. C.) combattuta sul fronte mesopotamico-persiano.
Essa fa parte dei confitti intrapresi dalla giovane umma musulmana al di fuori della penisola arabica.
67 Ibid, pp. 43-44
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 545 03/05/2013 11:11:30
546
Capitolo 11. Donne israeliane e palestinesi fra critica, protesta e rappresentazioni
Al-Khansa, accogliendo di buon grado il martirio dei fgli, ha anteposto la
fede in Dio a qualsiasi attaccamento terreno e sentimento umano. I libri di testo
stessi in un esercizio successivo invitano cos a rifettere, sulla base di quellesem-
pio: Il legame della fede (lett. dellIslam) pi forte del legame di parentela
68
.
Mentre la donna piange la morte del fratello, nel momento del martirio dei fgli
il suo atteggiamento cambia. Illuminata dal dono della fede, comincia a considerare
la loro morte non solo sopportabile ma persino una benedizione di cui rallegrarsi.
Il riferimento ai martiri della storia islamica assume un doppio signifcato:
da un lato costituisce un semplice completamento della formazione religiosa dei
ragazzi, dallaltro e ci evidente nei manuali di materie non religiose agisce in
modo strumentale nellevocare signifcati riconducibili al confitto in cui il popolo
palestinese coinvolto. Lenfasi posta su aneddoti di questo tipo in un contesto
quale quello palestinese si carica dunque di signifcati che oltrepassano la dimen-
sione religiosa e la cornice storica in cui sono inseriti. Non si pu dimenticare
che le narrative con cui i bambini palestinesi sono in contatto fn dalla tenera et
comprendono anche discorsi di gruppi cosiddetti islamisti che proprio nella
tradizione islamica, spesso utilizzata in modo strumentale, traggono la loro stessa
legittimit. Limmagine di una madre che gioisce per il martirio dei fgli potrebbe
subire nella mente dei giovani lettori una trasposizione di epoca e contesto e farsi
veicolo di messaggi a loro gi famigliari che non contribuiscono alla costruzione
di una cultura della pace. Questa trasposizione di signifcati ben esemplifcata
da un esercizio che compare nel manuale di lingua e letteratura araba per la classe
sesta che recita: Esprimiamo in una lettera i sentimenti di una madre il cui fglio
morto da martire sul suolo della Palestina
69
.
In questo caso lo slittamento di signifcati particolarmente evidente. Questo
esercizio non compare, come si potrebbe pensare, a supporto di un brano di let-
teratura contemporanea palestinese. Al contrario, si inserisce in ununit didattica
incentrata sulla fgura di Hamza Bin Abd al-Mutallib, personaggio della prima
epoca islamica, soprannominato il signore dei martiri. Il martire che muore per
la sua nuova fede diventa nellesercizio relativo al brano un giovane che sacrifca
la propria vita per la Palestina
70
. Le emozioni della madre che gli alunni sono
incoraggiati a immaginare saranno a questo punto pi o meno simili a quelle che
al-Khansa espresse nel momento del martirio dei fgli.
68 Ibid, p. 44.
69 Abu Ayyash, E. La nostra bella lingua cit., 6, p. 45.
70 Tra laltro la lettera sulle emozioni della madre accompagnata da un altro esercizio che invita
gli alunni a raccontare la storia del martirio di un eroe palestinese.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 546 03/05/2013 11:11:30
547
3. Le donne nei manuali delle scuole pubbliche palestinesi
Dagli esempi sopra analizzati e dal messaggio che ne emerge, si deduce che il
rapporto tra le donne palestinesi e la delicata questione del martirio consiste nel
confnamento del dolore scaturito da eventi di questo tipo alla sfera privata. La
morte di un fglio verr costruita come sacrifcio per la patria e la sua memoria
sar dispiegata dai viventi come una bandiera per fni nazionalistici. Le emozioni
di una madre il cui fglio morto da martire sul suolo della Palestina sono rico-
nosciute. Daltra parte, in nome del sumud, il suo dolore nella sfera pubblica sar
oscurato: questesperienza diventa strumentalmente un catalizzatore di sentimenti
nazionali e, attraverso un processo di ricostruzione collettiva, la morte della perso-
na viene letta e presentata come uno straordinario esempio di eroismo
71
.
Conclusioni
Lapproccio dei libri di testo alle questioni di genere si manifesta dunque come
una combinazione di insegnamenti di carattere religioso, in cui la donna inco-
raggiata ad assumere il ruolo di moglie e madre, e di riferimenti a una visione pi
sensibile alla costruzione di nuove e pi complesse identita femminili, che trovano
sostegno in documenti riconsociuti internazionalmente. Questa ambivalenza si
rifette anche nella rappresentazione dei soggetti femminili nel contesto delloccu-
pazione israeliana.. I manuali scolastici valorizzano infatti le donne nel contesto
della resistenza, spesso rappresentando nuclei famigliari al femminile. Questo,
tuttavia, non scardina le tradizionali logiche di genere e la rappresentazione dei
ruoli femminili nella famiglia e nella societ. La partecipazione delle donne alla
resistenza infatti descritta come allargamento delle reponsabilit di loro compe-
tenza (il che non signifca negare o limitare quelle gi af date da costrutti culturali
tradizionali), realizzazione dellattitudine allaccudimento anche al di fuori delle
mura domestiche (come la cura dei feriti, le visite alle famiglie dei martiri etc.)
e dimostrazione di capacit di sopportazione. Questa si estende fno a includere
il possibile martirio di un fglio. proprio nel suo rapporto con la resistenza e il
martirio che le responsabilit della donna nei manuali scolastici arrivano a sforare
la sfera simbolica, contribuendo cos a trasmettere discorsi e immagini colletti-
vamente elaborati, elementi fondamentali nella costruzione dellidentit e della
nazione.
71 I meccanismi di strumentalizzazione della morte nel nazionalismo israeliano (simili in molti
altri nazionalismi) sono analizzati da Zertal, I. Israele e la Shoah, Torino, Einaudi, 2007.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 547 03/05/2013 11:11:30
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 548 03/05/2013 11:11:30
4. Israele: rappresentazioni dellidentit di
genere tra militarismo e societ civile
72
Raya Cohen
Il ruolo femminile di cura della famiglia nella vita quotidiana e il suo signifcato
nazionale di sostegno al combattente trovano, nel discorso uf ciale e nella cultura
israeliani, una rappresentazione molto difusa che li raforza.
La stessa costruzione
della minaccia militare come quadro politico e culturale, che integra la famiglia
come struttura sociale di sostegno quotidiano al soldato combattente, raforza
tale rappresentazione delle identit di genere. Questo ruolo speciale della famiglia
viene, paradossalmente, riconfermato anche in un contesto di protesta come nel
caso del movimento delle quattro madri (di combattenti) a favore del ritiro dal
Libano o in quello per la liberazione del soldato Gilad Shalit rapito il 25 giugno
2006, la cui famiglia diventata una importante leva di pressione sul governo per
uno scambio di prigionieri. Ma come in altre guerre nuove, limmagine del com-
battente israeliano che rischia la propria vita al fronte si ormai frantumata e ci
ha fatto nascere nuove domande che ricadono nelle retrovie
73
. Inoltre, la lunga
esperienza delloccupazione e, dopo il fallimento degli accordi di Oslo, il sempre
pi grande coinvolgimento della societ intera negli aspetti violenti del confitto
mettono in discussione la vecchia divisione di genere in cui la fgura del solda-
72 Per una versione pi ampia, cfr. Cohen, R. Narrative e occupazione: il caso israeliano, in
Floriani, S.; Siebert, R. Letterature e Scienze Sociali. Un percorso di studi, Cosenza, Pellegrini ed. (in
corso di pubblicazione).
73 Cohen, R. Israele: la legittimazione della guerra, in La guerra giusta, concetti e forme storiche
di legittimazione dei confitti, in 900, Per una storia del tempo presente, n. 2, 2009, pp. 131-149,
numero monografco; Id., Israele: guerra, memoria, sacrifcio, in Ago, R. (a cura di) Il Sacrifcio,
Roma, Biblink ed., 2004, pp. 141-165.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 549 03/05/2013 11:11:30
550
Capitolo 11. Donne israeliane e palestinesi fra critica, protesta e rappresentazioni
to combattente si propone in prima linea per la gloria della nazione e le donne,
pur partecipando alla lotta nazionale, rimangono nelle retrovie e fanno nasce-
re nuove rappresentazioni femminili, ma anche di altre fgure, tutte intrappolate
nella violenza del confitto: omosessuali, ortodossi, palestinesi ecc. La fgura del
soldato combattente rimane per egemonica, non tanto perch la realt concreta
costituita da un confitto permanente ma perch costruita come la migliore
incarnazione del cittadino israeliano: quello che mostra la massima fedelt allo
Stato, pronto a obbedire, a uccidere e farsi uccidere, e merita di essere privile-
giato in rapporto a coloro che non sono combattenti: gli altri, uomini e donne. Il
suo corpo disciplina tutti gli altri corpi, quelli dei maschi non combattenti, delle
donne combattenti e di chi non presta servizio militare, come gli Arabi palestinesi
e gli ortodossi
74
. Il soldato combattente diventa dunque una fgura militare che
allo stesso tempo quella del vero cittadino repubblicano.
in questo contesto che si colloca lultimo romanzo di David Grossman, A un
cerbiatto somiglia il mio amore
75
. Grossman racconta la fuga da questo ruolo nazio-
nale di una donna, Orah. La sua fuga nel passato (in ebraico il romanzo si intitola
Una donna in fuga dallannuncio
76
) per spostare in avanti il presente diventa un pae-
saggio storico che descrive lalto prezzo pagato da tutta la societ israeliana per anni
di guerre e di confitto con i Palestinesi, un prezzo che si incarna non solo nei corpi
morti e feriti, ma anche nella vita quotidiana delle donne che li accompagnano per-
ch dice Orah hanno nazionalizzato ogni suo istante e ogni suo fglio (p. 725).
Il romanzo di David Grossman e il docu-flm di Avi Mograbi, Z32, su cui ri-
fetter in questo intervento, sono due esempi di un complesso pi ampio di opere
letterarie, cinematografche e di altri generi artistici, che mettono in discussione
il modello di genere dominante del maschio combattente in quanto cittadino
repubblicano da un lato, occupante e oppressore dallaltro.
Israele, giugno 1967, guerra dei Sei Giorni: nelle lunghe e buie ore del co-
prifuoco tre ragazzi sedicenni, Avram, Orah e Ilan, ricoverati in un piccolo ospe-
dale di Gerusalemme, si uniscono in unamicizia che porter Orah a sposarsi con
74 Sasson-Levy, O. Zehuyot be-madim; gavriyut ve-nashiyut bazava ha-israeli (ebraico), Gerusalemme,
Magnes, 2006.
75 Grossmann, D. A un cerbiatto somiglia il mio amore, Milano, Mondadori, 2008 (in originale:
Isha borashat mi-bsora, Bnei Brak, Hakubutz Hameuchad, 2008. Grossman, D. A un cerbiatto so-
miglia il mio amore, Milano, Mondadori 2008, (in originale: Isha borachat mi-bsora, Bnei Brak,
Hakubutz Hameuchad, 2008).
76 Grossman cominci a scrivere il romanzo nel maggio 2003, sei mesi prima della data in cui
il suo primo fglio avrebbe dovuto fnire il servizio militare e sei mesi prima che il secondo, Uri, si
arruolasse. Uri morto nella Seconda Guerra del Libano, e la versione fnale del romanzo stata
scritta appena fnita la settimana di lutto.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 550 03/05/2013 11:11:31
551
4. Israele: rappresentazioni dellidentit di genere tra militarismo e societ civile
Ilan da cui avr il fglio Adam e ad avere un altro fglio, Ofer, da Avram. A
distanza di molti anni da quel primo incontro, al tempo della seconda Intifada,
Orah una donna separata, madre di due fgli. Ofer, che sta svolgendo il servizio
di leva, accetta di partecipare a unincursione nei Territori Palestinesi Occupati,
nonostante siano ormai i suoi ultimi giorni di ferma. Orah, che aveva progetta-
to una gita con lui per festeggiare la fne del servizio militare, decide di partire
comunque, trascinando con s Avram, il padre di Ofer. oppressa da un oscuro
presentimento da cui non sa liberarsi: di quando loro, gli incaricati dellesercito,
seguendo il consueto rigido cerimoniale, busseranno alla sua porta per annunciare
la morte di Ofer.
Il viaggio nella Galilea, in cui ha vissuto, a piedi e staccando il telefonino,
dunque ogni comunicazione dal mondo diventer cos anche il modo per rac-
contarci la vita di una famiglia distrutta da 40 anni di guerra: Orah cammina e
parla senza sosta, nel tentativo di creare un tempo magico, un momento infni-
to, teso a evitare il bussare alla porta (p.107). Si tratta di un viaggio tra paesaggi
reali e fuga interiore, fatto di ricordi storici che hanno i contorni delle allucinazio-
ni, un viaggio che porta i lettori a vivere un tempo di sospensione tra lattesa che
arrivi la notizia della morte del fglio e la narrazione dellepopea del romanzo, la
cui chiusura non metter fne allattesa, perch levento della morte non narrato.
Orah, che tutta sua vita da adulta (dal 1967) si confronta con corpi danneggiati
e anime invalide che lesercito le ha lasciato, questa volta fugge per paura e resta
intrappolata, perch la paura impietrisce chi la guarda, anche prima che succeda
realmente ci che si teme.
Grossman racconta dunque una fgura femminile che sfugge alla costruzione
nazionale del ruolo della donna come accompagnatrice dei soldati, educatrice di
combattenti e poi contenitore delleventuale lutto; e lo fa rovesciando il model-
lo perch lui uomo a scriverlo in un linguaggio femminile, materno, un
linguaggio concreto che cura i corpi e ne porta i segni, in opposizione a quello
del modello maschile e glorifcante che nazionalizza la memoria dei caduti. Orah
cerca di ricomporre relazioni spezzate e di rianimare anime traumatizzate: la
sua storia, non quella dei suoi combattenti, che Grossman mette al centro del
romanzo, rendendola vittima principale.
Avi Mograbi, nel suo docu-flm Z32
77
, sceglie, come Grossman, un dramma
legato alla Seconda Intifada, ma mette al centro un giovane combattente, il cui
pseudonimo Z32, la cui unit ha assassinato due poliziotti palestinesi, dopo
aver ricevuto lordine di vendicare lassassinio di sei soldati israeliani morti in un
posto di blocco il giorno prima. Anche Ofer era coinvolto in un crimine di guerra
77 Mograbi, A. Z32, Francia e Israele, Les Film dIci, 81 minuti, 2008.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 551 03/05/2013 11:11:31
552
Capitolo 11. Donne israeliane e palestinesi fra critica, protesta e rappresentazioni
per aver rinchiuso un vecchio palestinese dentro una cella frigorifera per qualche
giorno. Ma lui, ci racconta Grossman, aiutato dal fratello e da Ilan, aveva assolto
la sua cattiva coscienza: solo Orah ne era rimasta molto turbata. Il protagonista di
Z32, invece, nascondendo il suo vero nome, decide di confessare in un docu-flm
la sua esperienza. Ma appena comincia a raccontare, scopre che in realt il suo vero
obiettivo quello di giustifcarsi con la fdanzata che, presente alla registrazione,
considera luccisione di due poliziotti palestinesi innocenti un assassinio. Lui so-
stiene di non aver avuto scelta; lei non daccordo. un vecchio dibattito tra di
loro. Ma Z32 ha deciso, dopo qualche anno, di raccontare alla societ israeliana
questa vicenda, proprio perch ha capito di aver partecipato a un crimine, anche
se senza possibilit di scelta, secondo lui. Attraverso il docu-flm si domanda come
si possano rivelare in pubblico questi crimini.
La storia principale si svolge nella casa di Z32 e della sua fdanzata, i due
sono seduti a terra su dei materassi con la camera fssata in alto di fronte a loro:
lui chiede alla sua fdanzata di condividere la sua esperienza e di raccontarla con
parole sue, in prima persona. Lei riascolta la sua storia, chiede di nuovo alcuni
dettagli, come per capirla meglio, ma non riesce a raccontarla come se fosse la sua
esperienza. Spiega che nonostante capisca che lui cambiato, avendo riconosciuto
la partecipazione a un crimine, non riesce a immaginarsi in questa situazione, non
pu dunque raccontare lassassinio in prima persona e non pu perdonarlo; forse
solo i parenti dei due poliziotti potrebbero farlo. Il flm fnisce quando la fdanzata
ferma la registrazione; forse perch capisce che Z32 pensa che, se lei raccontasse
la vicenda in prima persona, potrebbe perdonarlo; forse perch sono arrivati al
punto di partenza: per lei si tratta di un assassinio. Questo modo brusco di mettere
fne alla registrazione rende chiaro che la confessione non ha prodotto nessuna
assoluzione, nonostante la lunga discussione e la buona volont dei personaggi:
lex-soldato, la fdanzata e il regista. Il regista interpretato dallo stesso Mograbi
che, turbato dalla consapevolezza di stare aiutando a nascondere un criminale di
guerra, lo perdona; la moglie del regista, invitata anche lei a partecipare nel docu-
flm, rifuta ogni contatto con un soldato criminale e interviene solo per dire che
si oppone alla produzione del flm.
Al centro del racconto cinematografco si trova dunque il combattente: il suo
corpo, la sua faccia, la sua esperienza di autocontrollo e di forte coinvolgimento
davanti al pericoloso gioco con la morte. La sua narrazione dif cile, secca, piena
di espressioni tipiche del linguaggio maschilista e militare in cui ha vissuto la sua
esperienza. Le donne, la sua fdanzata e la moglie del regista, costituiscono una pre-
senza molto signifcativa, ma mantengono un ruolo passivo, tagliandosi fuori dalla
collaborazione artistica e politica che rimane cos confnata ai rapporti tra i maschi.
Il docu-flm ci racconta quanto sia dif cile per un combattente discutere i
crimini di guerra a causa della solidariet con i commilitoni, oltre che della paura
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 552 03/05/2013 11:11:31
553
4. Israele: rappresentazioni dellidentit di genere tra militarismo e societ civile
di essere giudicato in quanto criminale di guerra o di essere oggetto di vendetta
da parte dei Palestinesi. Solo dopo aver superato questi ostacoli, il crimine pu
essere narrato e a quel punto, in una societ che si aggrappa al mito della purezza
delle armi dellesercito israeliano, si incontra anche la dif colt di trovare chi
disposto ad ascoltare.
Conclusione
Lorizzonte dellesplorazione delle contraddizioni interne alla societ dipende dun-
que dai segni che il corpo del combattente porta con s. Grossman riempie il
romanzo di tanti corpi combattenti ma invalidi, soferenti di traumi, morti-vivi
e morti, ed espone tramite la fgura femminile una societ israeliana potente e
allo stesso tempo molto danneggiata e soferente. Orah si sente sola ed estranea al
mondo dei suoi uomini, caratterizzato dalle esperienze militari e dai sentimenti
che si sono prodotti davanti alla messa in gioco della propria vita e della vita degli
altri, e insiste nel ragionare in modo diverso, umano. Ma tutti i suoi ragionamen-
ti critici si spezzano, cos ci racconta Grossman, di fronte al suo fglio e il suo
corpo robusto (p. 730). Anche le accese discussioni in famiglia sulla violenza
della repressione contro la popolazione civile palestinese rimangono secondarie
nella trama che si svolge intorno a Ofer, un combattente ideale, che poi sparisce,
e forse muore. Il corpo di Ofer accompagna il lettore verso la principale tensione
narrativa rappresentata dalla tragedia di sua madre e lascia il lettore addolorato
davanti allabisso che si creato tra lordine nazionale, che comincia con il bussare
alla porta, e quello privato. Come Antigone
78
, Orah rifuta il suo posto di donna
nellordine nazionale, mette in luce la contraddizione tra lordine dello Stato e
la famiglia, ma non si rende un soggetto indipendente e non tenta di costruire
unalternativa politica a quellordine. Il lettore piange piuttosto il sacrifcio che fa
Abramo di suo fglio, un Sabra innocente, sullaltare nazionale, e non le vittime
palestinesi della repressione militare.
La scelta di Avi Mograbi invece quella di un combattente che ricorda con
rammarico la propria azione: nonostante sia un corpo intatto piegato, seduto
per terra accanto alla sua compagna, fatta eccezione per gli occhi le linee del volto
sono sfumate, espone a chiunque lo ascolti la contraddizione interna alle respon-
sabilit morali di ogni israeliano. La donna accetta che il suo compagno possa aver
capito come arrivato a compiere quel crimine, eseguito in quanto parte dellor-
dine nazionale, ma nega la possibilit che un tale crimine possa essere assolto da
78 Butler, J. Antigones Claim: Kinship Between Life and Death, New York, Colombia University
Press, 2000.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 553 03/05/2013 11:11:31
554
Capitolo 11. Donne israeliane e palestinesi fra critica, protesta e rappresentazioni
lei, segnando cos una divaricazione permanente nei loro rapporti. Per lei, infatti,
c un solo corpo sia che obbedisca allordine militare di uccidere sia che ritorni
a casa con rammarico per aver compiuto un crimine un corpo pieno di contrad-
dizioni, che n lordine simbolico n unaltra persona, tranne forse i parenti delle
vittime, pu perdonare. In tal modo Mograbi rompe la matrice dello sparano
e piangono, che segna da oltre quarantanni il discorso dei soldati israeliani: la
cattiva coscienza che, dopo aver eseguito atti di violenza eccessiva, si autoassolve
con la scusa di non avere unalternativa reale in quella situazione.
Se il corpo, forse morto, di Ofer porta lattenzione sulla tragedia della societ
occupante, rappresentata da Orah, il corpo di Z32 che si autodenuncia sposta
lobiettivo sulla responsabilit della societ israeliana per i suoi crimini. Si pu af-
fermare in conclusione che, nonostante la rappresentazione delle donne israeliane
costituisca in queste opere un modo per uscire dalla dicotomia classica femminile-
debole-passivo, maschile-forte-attivo, e per ripensare loccupazione da un punto
di vista della societ civile e del quotidiano, quello che defnisce lorizzonte della
narrazione resta la fgura maschile del combattente, segnato dal suo coinvolgimen-
to diretto nel confitto. E la rappresentazione del femminile operata dagli autori,
porta in ambedue i casi le donne a fuggire dal modello di carattere nazionale per
difendere invano gli aspetti individuali e privati della vita. Esse sono costrette
a scontrarsi con legemonia del corpo del combattente tramite i loro uomini e
anzich vederli come cittadini idealizzati li criticano per la loro partecipazione ai
crimini di guerra: ma non creano uno spazio politico alternativo. Perch? Perch
sono donne create da autori maschi? Perch queste rappresentazioni di donne
rispecchiano una realt nella quale i valori umanisti di Orah, come delle altre
donne, rimangono irrealizzabili? O perch sono gli autori, nascosti dietro loro,
che non vedono unalternativa alla situazione? E allora usano le fgure femminile,
le loro capacit pi profonde di capire, di sentire e di urlare un basta, per poi in-
trappolarle in stati di allucinazione o in rifuti integralisti?
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 554 03/05/2013 11:11:31
CAPITOLO 12
La rappresentazione del femminile nei
piani e programmi dazione europei
per le pari opportunit e la non
discriminazione
a cura di Silvia Niccolai
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 555 03/05/2013 11:11:31
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 556 03/05/2013 11:11:31
Introduzione.
Tra strumentalizzazione e imprevisto: la
politica delle donne nella stagione dei piani e
programmi dazione europei in materia di pari
opportunit e non discriminazione
Silvia Niccolai
1. Le politiche europee per le donne
Questo panel propone di rifettere su quella pagina di storia delle donne che si
sviluppa intorno allincontro tra le donne (attive nel movimento femminista, e
non) e i piani e programmi europei che fnanziano azioni nel campo sociale. un
tema che merita una certa attenzione; e per dire perch, opportuna forse, prima,
qualche notazione introduttiva, che chiarisca il nostro tema. Esso infatti riguarda
questioni con cui abbiamo a che vedere tutti i giorni, e che proprio perci, forse,
tendono un poco a sfuggire, e rimangono vaghe.
La Comunit europea, oggi Unione, assume la parit tra i sessi e la non discri-
minazione tra i suoi obiettivi fondamentali. Uno dei modi attraverso i quali lU-
nione persegue i suoi obiettivi quello di fnanziare azioni, progettate e realizzate
da attori sociali e istituzionali (associazioni, fondazioni, imprese, chiese, sindacati,
da un lato, enti locali e regionali e in genere soggetti pubblici, dallaltro lato), volte
al raggiungimento di essi. Prevalentemente lUnione, che nata per creare un mer-
cato comune concorrenziale, collega la propria competenza in materia di parit e
non discriminazione al lavoro e alloccupazione; perci, i piani e programmi euro-
pei hanno inizialmente, e per lungo tempo, fnanziato azioni volte alla formazione
e riqualifcazione professionale delle donne. Lavoro peraltro un ambito assai
ampio: il tema dellinserimento delle donne nel mercato del lavoro ne ha gemmati
altri, dalla conciliazione dei tempi al ripensamento dei trasporti pubblici e delle
strutture urbanistiche della citt, alle azioni educative volte a promuovere una
mentalit aperta allo scambio dei ruoli tra i generi, ossia a favorire una maggiore
partecipazione degli uomini nella vita familiare (e delle donne nella vita pubblica).
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 557 03/05/2013 11:11:31
558
Capitolo 12. La rappresentazione del femminile nei piani e programmi dazione europei
A rendere molto ampia la gamma di temi su cui la programmazione europea inci-
de, intervenuto, in un secondo momento, il crescere delle competenze europee
verso materie non direttamente riconducibili al mercato (ambiente, salute, ricerca,
in particolare). I piani e i programmi hanno cos promosso iniziative come la lotta
contro la violenza di genere o la tutela della salute delle donne. Beninteso, i piani
e programmi hanno sempre avuto anche obiettivi diversi dalle pari opportunit e
non discriminazione, dalla riqualifcazione di aree industriali dismesse alle fonti di
energia alternative, alla ricerca scientifca. In questultima forma tutte noi, come
studiose, ormai li conosciamo, abituate come siamo a fare fund raising anche attra-
verso domande di fnanziamento nel quadro dei programmi europei.
Il legame tra donne e azioni sociali europee cambiato nel tempo. I primi pro-
grammi dazione in materia di parit e non discriminazione (i NOW, degli anni Ot-
tanta) potevano essere attuati solo da gruppi di donne che gi avessero una storia di
impegno nelle politiche femminili. A partire dai primi anni Novanta, i soggetti che
possono partecipare ai bandi europei non devono pi presentare questa caratteristica
e lUnione si accontenta di imporre il rispetto di un equilibrato bilancio di genere
tra i componenti dei gruppi operativi. Questo importante cambiamento intervenu-
to tra i primissimi programmi e i successivi legato a un cambio di passo nelle poli-
tiche europee. Inizialmente, la Ue aveva limitatissime competenze in campo sociale.
Intervenire in materia di parit e non discriminazione delle donne nel lavoro stato
un battistrada che ha permesso alla Ue di accrescere il novero delle proprie compe-
tenze in questo campo. Quando questo ampliamento avvenuto, per la Ue non
stato pi necessario ancorare le proprie politiche sociali alle sole donne. Lobiettivo
delle pari opportunit si , cos, esteso a tutti i soggetti in potenziale condizione di
svantaggio; in parallelo, tutte le politiche sociali promosse dalla Ue hanno dovuto
rispondere ai requisiti del gender mainstreaming (cio tener conto delle loro ricadute
per le donne). Dallinizio degli anni 2000, la Ue non ha pi politiche dedicate alle
sole donne, ma politiche di pari opportunit e sociali che annoverano la parit di ge-
nere e il gender mainstreaming tra le proprie fnalit e modalit: per esempio, azioni
di lotta alla marginalit sociale che tra i soggetti considerati contemplano anche le
donne, ma non pi azioni di lotta alla segregazione lavorativa come si diceva un
tempo delle donne.
Ora, perch interessante occuparsi di tutto questo, perch tutto questo in-
teressa la storia delle donne?
2. Strumentalizzazione
abbastanza chiaro, in primo luogo, che limportanza rivestita dalle politiche di pari
opportunit e non discriminazione nel quadro della Ue di per s un segnale storico
eloquente circa linfuenza che lemersione della soggettivit femminile negli anni
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 558 03/05/2013 11:11:31
559
Introduzione
Sessanta e Settanta in Europa ha espresso sui modi di agire, sui contenuti, sul lin-
guaggio e sulle modalit di intervento delle istituzioni, un segnale che spinge, daltro
canto, a interrogarsi su come la presa in carico istituzionale di temi risalenti al movi-
mento femminista abbia, a sua volta, inciso sui percorsi del femminismo in Europa,
alleandosi e raforzando alcune visioni, marginalizzandone altre. Esiste gi da tempo,
specialmente nella letteratura europea sopranazionale, quella cio che si esprime in
lingua inglese, un flone piuttosto ampio di discussione e di studio, prevalentemente
giuridico, sociologico e di scienza della politica, che analizza le politiche europee di
pari opportunit e non discriminazione da un punto di vista di genere e ne discute
i contenuti, le scelte e i risultati sotto il proflo della loro capacit, o meno, di ofrire
concrete opportunit di promozione e tutela degli interessi femminili concrete
opportunit il cui contenuto viene di volta in volta, inevitabilmente, individuato a
partire dalle convinzioni e preferenze delle interpreti. Molto spesso, queste ricerche
lamentano una perdita di ef cacia delle politiche europee nel momento in cui esse
hanno cessato di assumere i gruppi di sole donne come referenti dei programmi
dazione e, successivamente, hanno stemperato le azioni per le donne nel pi ampio
quadro di una politica sociale europea che pare troppo spesso rivolta soltanto a salva-
guardare gli interessi del sistema economico. Di questa lettura in chiave strumentale
delle politiche femminili in Europa un esempio molto chiaro ed eloquente, nel
nostro panel, lintervento di Maria Grazia Rossilli sul tema del lavoro.
La lettura in chiave strumentale interessante perch obbliga a misurarsi con
il tema della scelta delle parole e del loro uso allinterno dei piani e programmi
europei, da un lato, e del loro (possibile) ri-uso da parte delle donne che in con-
creto un singolo piano, una singola azione, fanno funzionare. Questo il punto
di osservazione messo in pratica dallindagine di Alessandra Vincenti che, nel suo
intervento sul tema della conciliazione, adotta un metodo di indagine peculiare,
dove il senso attribuito dalle istituzioni europee e nazionali ai bisogni delle
donne (come la conciliazione) viene fatto reagire col senso che le donne stesse a
quelle parole, a quei bisogni attribuiscono e che viene ricostruito anche tenendo
conto di interviste, rese a loro volta possibili da un programma pubblico di inter-
venti per le donne che si modella sulle modalit europee di fnanziamento.
3. Imprevisto
Avere soldi da spendere per le donne pu generare, in altri termini, efetti impre-
visti, ed su che cosa avvenuto e avviene in questo crinale, in cui la normativit
strumentalizzante del piano e limprevisto della pratica posta in essere dalle donne
si incrociano, che il panel si proponeva di indagare.
Non c dubbio, in efetti, che il linguaggio dei piani e dei programmi euro-
pei ofra una rappresentazione di come lEuropa abbia visto e inteso ricostruire la
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 559 03/05/2013 11:11:31
560
Capitolo 12. La rappresentazione del femminile nei piani e programmi dazione europei
soggettivit femminile, che racchiude forti elementi normativi, prescrittivi, disci-
plinanti. I piani e i programmi europei compongono, nel loro succedersi, una nar-
razione del ruolo che listituzione europea si attende che le donne giochino nella
societ e, con ci, essi compongono la rappresentazione delle modalit considerate
normali e desiderabili della organizzazione del lavoro e delle responsabilit e degli
spazi della vita familiare e dei rapporti tra uomini e donne. Quando i piani e i
programmi europei individuano le proprie fnalit, e le descrivono, essi esprimono
una valenza altamente condizionante sul modo in cui determinati temi sono desti-
nati a essere percepiti. Negli anni Ottanta, per esempio, lo ricordavo poco sopra,
i piani per la formazione chiamavano la tendenza delle donne a concentrarsi su
certi tipi di lavori una forma di segregazione contro cui lottare e che, allepoca,
si pensava di estirpare insegnando alle donne i lavori degli uomini. Vi sono fem-
minismi disposti a condividere questa visione e che probabilmente, anzi, hanno
contribuito a dettarla, attraverso la rete di esperte e di esperti che collabora con
la Commissione europea nella redazione degli studi e delle analisi su cui i piani e
programmi dazione si basano salvo poi dichiararsi delusi dai risultati concreti di
questi interventi, perch le donne continuano a patire svantaggi e ad avvertire per-
ci, in modo particolarmente stridente, il carattere strumentale dellinvestimento
da parte dellEuropa. Altri femminismi, hanno radicalmente contestato questa vi-
sione, ci vero soprattutto in Italia, dove la forte infuenza del pensiero della dif-
ferenza sessuale, vale a dire del movimento che ha ruotato e che ruota intorno alla
Libreria delle Donne di Milano, ha difuso un modo di leggere i comportamenti e
le azioni delle donne in una chiave, anzich vittimistica, valorizzante, per cui, per
esempio, se le donne di fatto svolgono certi lavori, anzich altri, in questo sarebbe
da vedere lespressione di un orientamento del desiderio, anzich la sola pressione
condizionante degli stereotipi di genere e delle tradizioni culturali come lEuro-
pa immancabilmente suggerisce. Un orientamento del desiderio che sfdante, e
perci da comprendere e promuovere, perch mette in discussione la gerarchia di
valori e lidea del normale e del giusto che si costruita nel patriarcato, mettendo
al mondo una diversa esperienza.
Data lestraneit che il femminismo italiano della diferenza ha a suo tempo
dichiarato verso le istituzioni e la politica, stupisce e fa pensare che vi siano moltis-
sime donne, in Italia, che sono cresciute dentro il pensiero della diferenza sessua-
le, abituate cio a pensare la libert femminile nella dimensione del simbolico (e
non dellavere dei diritti) e che si sono impegnate e si impegnano allinterno dei
piani e dei programmi dazione europei, in alcuni casi facendone impresa e me-
stiere, in altri casi con incursioni pi episodiche, qualche volta occasionate sem-
plicemente dal lavoro svolto, come il caso di molte insegnanti che si sono avvalse
anche di fondi europei per la costruzione di cicli educativi basati su proiezioni di
flm o letture, o delle molte donne che, lavorando in centri di documentazione, si
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 560 03/05/2013 11:11:31
561
Introduzione
sono avventurate e si avventurano nel mondo dei piani e programmi per reperire
quei fnanziamenti che sono importanti per mandare avanti la propria opera, e che
diventano libri, ricerche, archivi, conferenze, incontri.
4. Politica
Quando si considera questo, ci si rende conto che seguire le vicende dei piani
e programmi europei in tema di parit e non discriminazione non serve solo a
vedere che cosa listituzione ha fatto delle donne, forse sulle donne (il tema del-
la strumentalizzazione) ma anche che cosa le donne hanno fatto dellistituzione
(dove si insinua, qualche volta, limprevisto), in un tempo storico che stato il pri-
mo a segnare una concentrazione dattenzione cos forte sul femminile, come sono
gli ultimi trentanni in Europa. Studiare i piani e i programmi dazione in materia
di pari opportunit e non discriminazione , allora, un modo per cercare una
risposta alla domanda su dove sia fnito il femminismo degli anni Settanta, su che
cosa sia successo alle donne quando il femminismo come movimento ha iniziato
a scemare ma le donne hanno continuato a far politica in dimensioni e spazi mol-
teplici, a esplorare quellessere dappertutto, in cui si esprime la trasformazione
pi sfdante del femminile in Europa oggi. Molto di quel femminismo, andato
a dare vita (e intanto si alimentato) alle azioni fnanziate dallUnione europea.
Il racconto di Simonetta De Fazi su come un gruppo di donne romane ha saputo
interpretare il primo NOW dando vita a un corso di formazione per donne docu-
mentaliste esperte nella conservazione e catalogazione dei documenti della storia
delle donne un esempio eloquente di un incrocio che ha avuto valenze formida-
bili di creativit e di libert, dove lidea di formazione professionale delle donne
stata, al tempo stesso, presa alla lettera e trascesa, a partire dallimmaginare che il
lavoro, il lavoro delle donne, non potesse essere lo stesso del lavoro degli uomini.
Ogni volta che le donne hanno fatto questo, hanno fatto molto di pi, e
molto di diverso, di quello che i progettisti europei, nello stilare i programmi e
indicarne le fnalit, avevano probabilmente in testa: ogni casa delle donne, ogni
cooperativa, ogni centro di documentazione, ogni corso di formazione che si
aperto, ogni libro che si pubblicato intercettando un fondo europeo stato spes-
so lespressione di una capacit di approfttare di una opportunit, di reinterpre-
tarla e rilanciarla, in cui la libert femminile si saputa dispiegare, nella forma
pratica, piccola e dif cile della mediazione con le istituzioni, del divenire esperte
degli aspetti burocratici, del sapersi giostrare con le restrizioni imposte dai fnan-
ziamenti e dalle voci di spesa. In questa chiave, che la chiave in cui il piano e il
programma europeo diventa parte di pratiche politiche in cambiamento, perch
della politica cambiano le dimensioni e le forme di espressione, c da interrogare
lesperienza delle donne che dei piani e dei programmi europei per le pari oppor-
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 561 03/05/2013 11:11:31
562
Capitolo 12. La rappresentazione del femminile nei piani e programmi dazione europei
tunit e la non discriminazione hanno fatto impresa e mestiere, come il caso
delle donne che a Cagliari, sul fnire degli anni Ottanta, hanno dato vita allIfold
(Istituto per la formazione professionale donne), la cui esperienza, oggi una delle
pi signifcative nelleconomia dellIsola, stata raccontata da Maria Giovanna
Piano nel nostro panel (ma non ha potuto purtroppo essere ricompresa nella ver-
sione che qui si pubblica), con un movimento sempre consapevole di come la
chiave di lettura imposta dal piano e dal programma europeo potesse e dovesse
essere mobilitata da una re-interpretazione del desiderio e del bisogno delle donne
reali incontrate nel lavoro. Una re-interpretazione alimentata da unattenzione al
contesto di esperienza di quelle donne che in concreto al programma di formazio-
ne di volta in volta si rivolgono. E vi lesperienza delle donne che si sono mosse
allinterno delle politiche europee anti-violenza, esposta da Marcella Pirrone, e
che mostra una traiettoria emblematica: dal momento iniziale, in cui listituzione
si rivolge alle donne che lavorano nel campo della lotta alla violenza, si apre alla
loro esperienza trasformativa, al momento della piegatura istituzionalizzante, della
fase fortemente burocratizzata in cui domina il linguaggio neutro e lattenzione
alla diferenza femminile si riduce a una formalistica quantifcazione del bilancio
di genere dei componenti di un gruppo di lavoro. Una traiettoria che potrebbe
essere ascritta in tutto e per tutto alla vittoria della logica strumentalizzante e
che pure, a pensarci bene, non lo : perch a farsi paladine del linguaggio neu-
tro, nellesperienza raccontata da Marcella Pirrone, non sono tanto le istituzioni,
quanto le donne componenti del gruppo di ricerca che per et, e per il tipo di
cultura e di femminismo in cui sono cresciute, si sentono in dovere di sostituire la
parola persona alla parola donna in un manuale di istruzione per il personale
medico e paramedico che opera in casi di violenza. Ed con queste donne, prima
che con listituzione, che Marcella dialoga sforzandosi di far loro cambiare punto
di vista. Questa dinamica non ci parla pi della forza della sola istituzione, che
dirige e schiaccia il desiderio femminile, ma di donne divenute protagoniste di
politiche, la cui partita si gioca tra loro, e dove pesano diverse storie personali,
diverse esperienze, diverse culture, dove il senso impresso al movimento dellisti-
tuzione dipende in larga misura da quale storia, quale esperienza, quale cultura,
riesce a risultare la pi persuasiva, la pi congrua, la pi sensata, e dove la partita
tra strumentalizzazione e imprevisto rimane aperta e diventa materia della politica
contemporanea delle donne.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 562 03/05/2013 11:11:31
1. Lavoro e occupazione: legislazione e
politiche dellUnione europea per la parit
tra uomini e donne
Mariagrazia Rossilli
La legislazione e le politiche di parit tra uomini e donne in ambito lavorativo
hanno occupato e occupano un posto di rilievo nellazione dellUE situandosi
agli albori della costruzione del mercato comune e delle politiche sociali europee.
Questo scritto troppo breve per poter anche solo accennare alle controverse
interpretazioni sui motivi e gli attori che hanno dato vita a questa centralit nella
storia di stop and go della costruzione europea. Esso intende solo fornire una sintesi
critica delle politiche di parit in ambito lavorativo e occupazionale.
Legislazione e politiche di parit: uno sguardo dinsieme
Con la Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea, divenuta giuridi-
camente vincolante grazie alla ratifca del Trattato di Lisbona (2009), il diritto
alluguaglianza sostanziale tra uomini e donne fa il suo ingresso nel novero dei
diritti fondamentali riconosciuti dallUE. Lart. 23 aferma, infatti, che la parit
tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi e prescrive, quindi,
uno specifco impegno propulsivo da parte delle istituzioni pubbliche al fne
di conseguire lobiettivo delluguaglianza efettiva. A questo scopo il secondo
comma dellarticolo stabilisce che il principio della parit non osta al mante-
nimento o alladozione di misure che prevedano vantaggi specifci a favore del
sesso sottorappresentato, ossia legittima ladozione di azioni positive in tutti gli
ambiti, non solo in ambito professionale, e dunque anche ladozione di azioni
positive contro gli ostacoli di fatto che limitano le opportunit delle donne
nellaccesso alle cariche elettive per la promozione del riequilibrio tra i generi
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 563 03/05/2013 11:11:31
564
Capitolo 12. La rappresentazione del femminile nei piani e programmi dazione europei
nella rappresentanza politica. Stabilendo il diritto alluguaglianza sostanziale,
lart. 23 dovrebbe permettere uninterpretazione delle azioni positive pi ampia
di quella stabilita nella giurisprudenza comunitaria, che stata eccessivamente
sbilanciata verso il divieto di discriminazione e luguaglianza formale. Le azioni
positive, infatti, bench legittimate in ambito professionale nellart 141 del Trat-
tato di Amsterdam, sono state oggetto di orientamenti molto travagliati da parte
della Corte di giustizia anche in conseguenza dellassenza, fno alla Carta di
Nizza, di un chiaro riferimento nel diritto comunitario al diritto alleguaglianza
sostanziale tra uomini e donne
1
.
Il Trattato di Amsterdam (1999) ha esteso le competenze comunitarie con-
ferendo al Consiglio il potere di adottare provvedimenti per combattere le di-
scriminazioni fondate sul sesso anche al di fuori dellambito del lavoro (art. 13),
ponendo leliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parit tra i sessi
tra i compiti e le fnalit dellazione della Comunit (principio di gender main-
streaming) e, innanzi tutto, ampliando nellart. 141 la nozione di uguaglianza di
trattamento e di pari opportunit in ambito professionale anche mediante la legit-
timazione delle azioni positive. Lart. 141 riformula quindi lart. 119 del Trattato
di Roma del 1957 il quale, stabilendo pionieristicamente la parit di retribuzione
fra i lavoratori di sesso maschile e femminile per uno stesso lavoro, stato il mo-
tore originario da cui s sviluppato il divieto di discriminazione sulla base del
sesso in ambito lavorativo come parte integrante del processo di costruzione del
mercato comune. Dallart. 119/141 Trattato CE ha avuto, infatti, origine una
cospicua normativa, un corpus di direttive sul divieto di discriminazione di sesso e
le pari opportunit nellaccesso e in tutte le condizioni di lavoro, negli schemi di
sicurezza sociale e negli schemi pensionistici privati, disciplina recentemente rifusa
in larga parte in ununica Direttiva 2006/54
2
.
Di questo corpus di direttive fanno parte anche quella dedicata alla tutela
della salute delle lavoratrici incinta e ai congedi di maternit e quella sui congedi
parentali che fssano degli standard minimali, permettono, in nome del principio
1 Roccella, M La Carta dei diritti fondamentali: un passo avanti verso lUnione politica, in
Lavoro e Diritto XV, n. 2, 2001, pp. 329-343; Costello, C. Gender Equalities and the Charter of
Fundamental Rights of the European Union, in Hervey, T.; Kenner, J. (eds) Economic and Social
Rights under the EU Charter of Fundamental Rights. A legal Perspective. Portland Oregon, Hart Publi-
shing, 2003, pp. 111-138.
2 La Direttiva 2006/54/CE abroga sette Direttive precedenti: Direttiva 75/117/CEE sulla parit
retributiva tra lavoratori e lavoratrici; Direttiva 76/207/CEE sulla parit di trattamento nellaccesso
e nelle condizioni di lavoro; Direttiva 86/378/CEE sulla parit di trattamento nei regimi professio-
nali di sicurezza sociale; Direttiva 96/97/CE che modifca la direttiva 86/378/CEE sulla parit di
trattamento nei regimi professionali di sicurezza sociale; Direttiva 97/80/CE sullonere della prova,
emendata dalla Direttiva 98/52; Direttiva 2002/73/CE che modifca la Direttiva 76/207/CEE.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 564 03/05/2013 11:11:31
565
1. Lavoro e occupazione: legislazione e politiche dellUnione europea per la parit
di sussidiariet, una larga discrezionalit agli stati membri e spesso richiedono solo
pochi adeguamenti da parte delle legislazioni nazionali
3
.
Oltre al divieto di discriminazione e alla legittimit delle azioni positive in
ambito professionale che la Corte di giustizia ha fssato in termini abbastanza
ristretti basati su un esile equilibrio tra le istanze di uguaglianza sostanziale e quel-
le di uguaglianza formale
4
, il terzo principio ispiratore delle politiche dellUE
quello di gender mainstreaming. Questo principio, fondato giuridicamente negli
art 2 e 3.2 del Trattato di Amsterdam, impone di realizzare, oltre alle politiche
specifche a favore delle donne, lintegrazione della prospettiva della diferenza di
genere in tutti gli ambiti e le politiche di azione comunitaria, coinvolgendo, di
conseguenza, anche gli uomini nella promozione della parit e dei relativi cam-
biamenti sociali.
Le pari opportunit nella Strategia Europea per lOccupazione
La strategia di mainstreaming ha iniziato a prendere corpo nel quadro dallambi-
zioso progetto fssato nellagenda di Lisbona (2000), che prevede per il 2010 il tra-
guardo di trasformare leconomia europea nelleconomia basata sulla conoscenza
pi competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita econo-
mica sostenibile con alti livelli occupazionali e una maggiore coesione sociale.
Secondo questo progetto lo sviluppo delleconomia europea dipende in larga parte
dalle capacit di produrre sfruttare e difondere conoscenze scientifche: da qui gli
obiettivi di aumentare per il 2010 la spesa degli stati membri per la ricerca fno
al 3% del PIL, creare a livello europeo circa 700.000 nuovi ricercatori e trattare,
quindi, il gap derivante dal fatto che nellUE le donne sono circa il 60% dei laure-
ati ma solo il 30% dei ricercatori, promuovendo le pari opportunit nella ricerca
scientifca e la valorizzazione delle risorse intellettuali delle donne.
soprattutto allinterno delle politiche europee per loccupazione nel quadro
degli obiettivi dellAgenda di Lisbona (per il 2010 obiettivi occupazionali cor-
rispondenti al 70% della popolazione e al 60% delle donne in et lavorativa) e
della programmazione del FSE che la strategia di gender mainstreaming stata pi
3 Direttiva 92/85/CEE e Direttiva 96/34/CE del 1996. Cfr. Adinolf, A.; Bertone, R. Tutela
della salute e lavoratrici madri dopo la direttiva 92/85, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni
industriali, n. 62, 1994, 2, pp. 361-381.
4 Cfr. De Simone, G. Dai principi alle regole: uguaglianza e divieti di discriminazione nella disci-
plina dei rapporti di lavoro, Torino, Giappichelli, 2001; Barbera, M. Leccezione e la regola, ovvero
luguaglianza come apologia dello status quo, in Beccalli, B. (a cura di) Donne in quota, Milano,
Feltrinelli 1999, p. 91-130; Palici di Suni Prat, E.Le ragioni delle donne e le donne nelle Regioni,
in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2001, II, pp. 605-620.
Manca il rimando
bibliografco della
citazione
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 565 03/05/2013 11:11:31
566
Capitolo 12. La rappresentazione del femminile nei piani e programmi dazione europei
estesamente applicata. infatti nellambito della Strategia Europea per lOccupa-
zione (SEO) che politiche di pari opportunit tra uomini e donne hanno iniziato
a fuoriuscire dalla marginalit che le aveva fno ad allora caratterizzate.
Alle origini della SEO c la situazione economico-sociale dellEuropa a parti-
re dalla fne degli anni Ottanta, caratterizzata da dif colt strutturali quali debole
crescita economica, elevata disoccupazione specie di lunga durata, bassi tassi di
occupazione tra giovani anziani e donne, problemi demografci relativi ai bassi
tassi di fecondit e al progressivo invecchiamento della popolazione.
Linsieme di questi fattori pone dif cili sfde ai modelli occupazionali e ai
sistemi di welfare europei.
Sia a livello politico sia in ambito accademico si difonde la convinzione
che la crisi occupazionale europea sia principalmente da ricondurre alle rigidit
strutturali del mercato del lavoro che rendono dif cili gli adattamenti alle nuove
condizioni del mercato globalizzato. Per mantenerne la sostenibilit fnanziaria
dei sistemi pensionistici, sanitari e assistenziali si ritiene cruciale lallargamento
delloferta di lavoro e laumento delloccupazione complessiva. Un innalzamento
del tasso di occupazione, in grado di produrre laumento di risorse attraverso
lallargamento della base fscale e contributiva, visto come condizione necessaria
per la preservazione e la riforma del modello sociale europeo
5
. Alla SEO viene
dunque af dato il compito di riformare i mercati del lavoro e traghettare le socie-
t europee verso gli elevati tassi doccupazione fssati per il 2010. Per raggiungere
questi obiettivi necessario incentivare la popolazione inattiva in et da lavoro
(15-64 anni) a entrare nel mercato del lavoro e a rimanervi pi a lungo. Le donne
rappresentano la componente principale di questa forza lavoro potenziale. Lau-
mento della loro partecipazione al mercato del lavoro e della loro occupazione
indispensabile per migliorare il tasso di crescita del sistema economico europeo,
favorire la sostenibilit del modello sociale europeo, ridurre il rischio di pover-
t ed esclusione sociale, fronteggiare i cambiamenti nella struttura demografca,
riequilibrare il rapporto numerico tra lavoratori e pensionati e mantenere la so-
stenibilit dei sistemi pensionistici anche riducendo la spesa per pensioni sociali
e di reversibilit di cui le donne costituiscono le maggiori benefciarie. La piena
utilizzazione del potenziale produttivo della risorsa donne la chiave per realiz-
zare la ripresa della competitivit delleconomia e la modernizzazione del sistema
sociale europeo disegnati nellAgenda di Lisbona: da qui le scelte che portano le
politiche di pari opportunit nel mainstream delle politiche occupazionali con-
cordate a livello europeo.
5 Villa, P. La Strategia Europea per lOccupazione e le pari opportunit tra uomini e donne, in
Rossilli, M. (a cura di) I diritti delle donne nellUnione Europea, Roma, Ediesse, 2009 pp. 163-198.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 566 03/05/2013 11:11:31
567
1. Lavoro e occupazione: legislazione e politiche dellUnione europea per la parit
Le linee guida per loccupazione previste nella SEO si sono basate originaria-
mente su quattro pilastri: promozione delloccupabilit di disoccupati e inattivi,
rimuovendo i disincentivi alla partecipazione al mercato del lavoro e migliorando
la formazione professionale; promozione dellimprenditorialit incoraggiando lo
sviluppo delle piccole e medie imprese; promozione delladattabilit sia da parte dei
datori di lavoro che dei lavoratori, fessibilizzando condizioni, organizzazione e orari
di lavoro anche mediante contratti non standard; promozione delle pari opportunit
tra uomini e donne anche mediante lintegrazione orizzontale della prospettiva di
genere nellinsieme delle politiche occupazionali. Le linee guida hanno quindi pro-
mosso la pari occupabilit, ossia lingresso e il reingresso nel mercato del lavoro delle
inattive, delle donne che non vi sono mai entrate o ne sono uscite in seguito alla
maternit (studentesse, casalinghe), nonch ladozione di misure positive di orienta-
mento al lavoro, formazione e riqualifcazione professionale. Al fne di ridurre il gap
di genere nei tassi di disoccupazione e di raggiungere lobiettivo occupazionale del
60% delle donne in et lavorativa, le linee guida hanno raccomandato lincentiva-
zione dellimprenditoria femminile, il sostegno alla presenza delle donne nei settori
professionali in cui sono sottorappresentate e soprattutto la promozione di politiche
di conciliazione delle responsabilit professionali e familiari. Oltre alladozione della
legislazione sui congedi parentali, sono stati raccomandati lo sviluppo dei servizi di
cura per linfanzia (per il 2010 si fssato lobiettivo di garantire la disponibilit di
posti nella scuola materna al 90% dei bambini sopra i 3 anni e quella di posti nei
nidi ad almeno il 33% dei bambini da zero a 3 anni) e le politiche di adattamento
delle condizioni di lavoro alle esigenze familiari di lavoratori e lavoratrici, mediante
lincentivazione della fessibilit di contratti, tempi e condizioni di lavoro con lo
sviluppo di una vasta gamma di contratti atipici (part-time, tempo determinato, job
sharing, telelavoro, lavoro a chiamata, ecc). Le politiche per la conciliazione di lavoro
e famiglia hanno poi acquisito, a partire dalla riformulazione della strategia di Lisbo-
na nel 2005, il massimo di enfasi nella SEO a scapito delle stesse politiche di pari
opportunit che hanno invece perduto rilevanza. da notare a proposito dei servizi
raccomandati per la conciliazione che stato completamente ignorato, in unEuropa
che invecchia, il problema delle politiche pubbliche per lassistenza agli anziani il cui
peso ricade principalmente sulle spalle delle donne.
Nelle linee guida della SEO, la promozione di contratti condizioni e tempi di
lavoro fessibili e del part-time risponde contemporaneamente a pi scopi: creare
posti di lavoro per sviluppare loccupazione, innanzi tutto femminile, e adattare il
lavoro sia alle esigenze dellef cienza economica e della produttivit delle aziende
sia a quelle familiari di lavoratori e lavoratrici.
Se lespansione dei lavori atipici deve servire a sviluppare loccupazione fem-
minile, come nellassunto delle linee guida, non solo il problema della qualit
dei lavori viene posto in secondo piano rispetto alla quantit delloccupazione
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 567 03/05/2013 11:11:31
568
Capitolo 12. La rappresentazione del femminile nei piani e programmi dazione europei
ma ne consegue anche che la divisione di genere del lavoro e i relativi svantaggi
risulteranno riprodotti. Fin dalle prime formulazioni delle linee guida occupazio-
nali sono dunque evidenti le tensioni tra le politiche di conciliazione fnalizzate
innanzi tutto a promuovere la crescita quantitativa delloccupazione femminile,
adattando le condizioni di lavoro allesistente divisione di genere del lavoro, e la
promozione delluguaglianza dei sessi.
Nelle linee guida si assume, inoltre, che la domanda di fessibilit fnalizzata
alla produttivit delle imprese possa incontrarsi con la domanda di fessibilit da
parte di lavoratori e lavoratrici, sottovalutando il fatto che tra le due domande di
fessibilit vi pi spesso contraddizione che non convergenza.
LUE ha inoltre regolamentato i lavori non standard solo mediante direttive
deboli e lacunose cosicch i governi membri hanno potuto utilizzare i contratti
atipici nella competizione a ridurre il costo delle prestazioni di sicurezza sociale,
erodendo i relativi diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Daltra parte, la fexicu-
rity e ladeguamento delle forme della sicurezza sociale alla fessibilit del mercato
del lavoro, raccomandati nelle politiche dellUE, si sono scontrati con ostacoli
insormontabili, dovuti a dif colt intrinseche e al permanere dellesclusiva com-
petenza nazionale in materia di legislazione sui sistemi di previdenza sociale (lUE
pu approvare delle leggi in materia soltanto allunanimit e perci ogni paese
mantiene il diritto di veto). La fessibilit si dunque accompagnata, dove pi
dove meno nei paesi membri, con la precarizzazione del lavoro.
Le pari opportunit nella Strategia Europea per lOccupazione: le
politiche dei paesi membri
La strategia di Lisbona, fallita in quanto al raggiungimento degli obiettivi ambi-
ziosi che si prefggeva, per servita, come sottolinea la Commissione nella sua
valutazione del 2010
6
, a promuovere negli stati membri processi di riforma simili
secondo quelli che erano i suoi scopi originari.
In seguito a questi processi di riforma e pi in generale alle politiche dellUE,
oggi pi dif cile che in passato classifcare i paesi dellUE a 15 entro le diver-
se tipologie classiche di welfare (scandinavo-universalistico, liberale anglosassone,
continentale corporativo, mediterraneo), anche se le diferenze storiche nei mo-
delli sociali e di genere degli stati membri permangono.
Misure di incentivazione della presenza nel mercato del lavoro delle donne,
anche madri e anche ai livelli di professionalit pi bassi, hanno visto la luce, dove
6 Commissione Europea, Documento di valutazione della strategia di Lisbona, SEC (2010) 114
DEF del 2.2.2010.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 568 03/05/2013 11:11:31
569
1. Lavoro e occupazione: legislazione e politiche dellUnione europea per la parit
pi dove meno, in tutti i Paesi membri, cos come delle politiche di conciliazione
tra lavoro nel mercato e responsabilit familiari sono state adottate anche nei Paesi
tradizionalmente meno inclini come quelli mediterranei. Anche se accompagnato
da forti diferenze tra gli Stati membri (da meno del 40% a Malta a pi del 70%
nei paesi Bassi e nei paesi nordici), il tasso doccupazione femminile ovunque cre-
sciuto, toccando nel 2008 il 59,1%, nella media UE, e avvicinandosi allobiettivo
di Lisbona che, dunque, prima dellattuale crisi, poteva dirsi pressoch raggiunto
7
.
Forme di congedi parentali sono ormai presenti in tutti i paesi, anche se con notevoli
diferenze rispetto a durata, statuto e retribuzione che ne incentivano o meno luso
da parte dei padri. A diferenza dei Paesi mediterranei, il regime nordico, che pure ha
visto notevoli riduzioni nelle prestazioni a sostegno delle famiglie e diversifcazioni
al suo interno, ha per mantenuto il tratto distintivo dellincitamento alle responsa-
bilit dei padri anche mediante la disponibilit di veri e propri congedi di paternit.
Tuttavia, dal momento che i servizi per linfanzia e i congedi parentali im-
plicano un costo per i governi e/o per le imprese, la fessibilizzazione del lavoro
stata la misura maggiormente implementata negli stati membri per bilanciare
responsabilit professionali e familiari, con la moltiplicazione di lavori atipici, che
spesso, peraltro, rispondono pi alle esigenze delle imprese che non a quelle fami-
liari delle lavoratrici.
Come risultato di queste politiche oggi in tutti i Paesi dellUE le donne sono
sovrarappresentate nei lavori atipici e nei contratti precari
8
, sicch in alcuni
casi si confgura una sorta di vera e propria segregazione occupazionale, come
nel caso del part-time all83% femminile nella media UE. Inoltre pi di un terzo
delle lavoratrici part-time in Europa dichiara di farlo su base non volontaria ma
in quanto costretta dalla mancanza di altre opzioni lavorative, mentre la percen-
tuale di donne che dichiara di avere scelto il tempo parziale perch costretta dalle
responsabilit familiari elevata, specie nei paesi anglo-sassoni, Lussemburgo, Au-
stria e in Olanda, dove, caso unico in Europa, addirittura trequarti delle donne,
specie delle fasce sociali a basso reddito, lavora part-time.
La sovrarappresentazione delle donne nel part-time e nei lavori temporanei
riproduce e conserva il carattere secondario del salario femminile nella famiglia e
la declinazione tutta femminile dei compiti di cura
9
.
Nellinsieme, le politiche di pari opportunit promosse dalla SEO hanno
messo in moto a livello nazionale riforme che hanno incentivato i tassi di attivit
7 Commissione Europea, Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Co-
mitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni- Parit tra donne e uomini-2010, COM
(2009)694 DEF del 18.12.2009.
8 Commissione Europea, ibidem.
9 Commissione Europea, ibidem.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 569 03/05/2013 11:11:31
570
Capitolo 12. La rappresentazione del femminile nei piani e programmi dazione europei
e di occupazione femminile in tutti i Paesi membri, a scapito per dei diritti del
lavoro e delle prestazioni di sicurezza sociale per la grande massa di lavoratrici
(e lavoratori) atipici. Con la precarizzazione del lavoro nuove forme di disugua-
glianza rispetto alle possibilit di carriera e alle retribuzioni accompagnano oggi
in Europa il lavoro delle giovani donne, causando crescenti dif colt a progettare
scelte di vita familiare, fnanche scelte di maternit, e ampliando enormemente le
diferenze sociali tra le donne.
Se la diferenza media retributiva tra uomini e donne a livello dellUE rimane
oggi al 17%, essa si lega direttamente al gap nelle pensioni e alla femminilizza-
zione della povert, rappresentando le donne la maggioranza degli 85 milioni di
poveri dellEuropa in una percentuale che ha continuato a crescere negli ultimi
10 anni
10
.
A fronte di questo quadro, ulteriormente aggravato dalla crisi in corso che,
dopo aver colpito pi pesantemente il lavoro degli uomini (industria e costruzio-
ni), si sta allargando anche al settore dei servizi per cui il tasso di disoccupazione
femminile sta ultimamente crescendo allo stesso ritmo di quello maschile
11
, pro-
spettive nuove di tutela potrebbero dischiudersi grazie alla Carta dei diritti fonda-
mentali dellUE che contiene garanzie rispetto a tutti i diritti economico-sociali
fondamentali, incluso il diritto daccesso a tutte le prestazioni di sicurezza sociale,
nonch il diritto universalistico allassistenza sociale per unesistenza dignitosa di
tutti coloro che non dispongano di risorse suf cienti (art. 34), che pu costituire
la base per lintroduzione di una misura di basic income, necessaria per limitare i
danni della precarizzazione del lavoro.
10 Cfr. European Parliament, Committee on Womens Rights and Gender Equality, Motion for
a European Parliament Resolution on assessment of the results of the 2006-2010 Roadmap for Equality
between women and men, 2009/2242 (INI).
11 Commissione Europea, Relazione della Commissione cit.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 570 03/05/2013 11:11:31
2. Il tempo delle donne nelle politiche di
conciliazione: verso una rilegittimazione
di un modello sociale familistico?
Alessandra Vincenti
Quale idea di societ si sta delineando alla luce delle riforme, annunciate o avviate
attraverso la tabella di marcia illustrata dai documenti, che delineano il nostro
futuro sistema di protezione sociale? Uno dei caratteri del processo di riforma
dato dalla cosiddetta de-istituzionalizzazione accompagnata da una forte enfasi
sullassistenza nella comunit
12
. La convinzione che la comunit possa rim-
piazzare le istituzioni, semplifcando una complessit data dallintersezionarsi del
genere, della classe e della nazionalit e lasciando sullo sfondo la relazione privato-
pubblico. Il cambiamento sostenuto dallidea che le comunit possano rispon-
dere ai bisogni sociali delle persone meglio delle burocrazie
13
.
Le comunit, per, sono in grado di far fronte a bisogni vecchi e nuovi? E chi
sono coloro che allinterno delle comunit sostituiranno le burocrazie del vecchio
modello di welfare?
Da una parte una grande enfasi posta sullincremento del tasso di occupa-
zione femminile, dallaltro lo slancio verso le relazioni comunitarie, di vicinato,
tra persone, pongono le donne al centro di un ventaglio di attivit da compiere
giornalmente. La conciliazione non vissuta come questione problematica per
gli uomini, ma riguarda primariamente le donne. La sua rappresentazione sem-
pre univoca e non sembra guardare alla pluralit delle declinazioni possibili nella
ricerca di un equilibrio tra vita e lavoro, defnendo un ordine sociale di genere
12 Beck, U. Respect in a World of Inequality, New York, Norton & Company, 2003, trad.it. di
Falcioni, R. Rispetto, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 158.
13 Beck, U. Rispetto cit., p. 160.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 571 03/05/2013 11:11:31
572
Capitolo 12. La rappresentazione del femminile nei piani e programmi dazione europei
che da sempre prevede per le donne una porosit del confne tra produzione e
riproduzione sociale.
La conciliazione interroga quel passaggio dalle politiche di pari opportunit,
frutto di una prospettiva femminista, alle politiche che, neutralizzando il genere
come categoria, descrivono semplicemente i ruoli attribuiti a uomini e donne. Si
pu dire che dalla rivendicazione della diferenza si passati allafermazione on-
tologizzante dellesistenza del diferente
14
. Sono le donne, in quanto diferenti,
a ricoprire in esclusiva il ruolo di prestatrici di cura e loblativit da loro attesa
non viene messa in discussione in quellordine sociale di genere che d forma ai
rapporti concreti tra uomini e donne.
Il 26 marzo 1988 a Roma una grande manifestazione delle donne del sindaca-
to reclam, fra le altre cose, una legge sulle azioni positive. Nel 1991 questa spinta
produsse la L.125/91. Le politiche di pari opportunit nascevano perci dalla
richiesta di politiche per le donne (meglio se pensate e realizzate dalle donne).
Nei ventanni trascorsi queste politiche sono diventate prevalentemente azio-
ni di conciliazione. La spinta di allora verso la politicizzazione di questioni che
segnavano la diseguaglianza tra uomini e donne si esaurita in un processo di
burocratizzazione malcelato dietro letichetta di politiche di genere. Ma cosa
successo? Perch le politiche di pari opportunit convergono da circa dieci anni
dentro il tema della conciliazione, depotenziando il confitto tra i generi in un
processo accelerato di regenderizzazione?
Lutilizzo di un approccio critico come quello reso possibile dalla categoria
di genere aiuta a guardare ai processi per disvelarne gli efetti discriminanti, ma
allo stesso tempo per far emergere lambivalenza che informa le aspettative di
costruzione biografca delle donne, in particolare delle generazioni di donne pi
giovani che guardano allintreccio tra vita e lavoro in maniera meno deterministi-
ca, mischiando aspetti espressivi e funzionali (il lavoro s, ma che lasci tempo per
s; limportanza della famiglia senza che questa conduca alla scelta del ritiro dal la-
voro). Il processo di regenderizzazione che enfatizza una concezione tradizionale
dei sessi mette in secondo piano questa realt della pluralit dei comportamenti
femminili e una cornice di senso sempre pi complessa e ambivalente.
Levoluzione semantica subita dal concetto di pari opportunit ne ha ri-
mosso lorigine, mentre ritengo sia importante sottolineare che il quadro relativo
alle pari opportunit ha preso avvio dal lavoro. La partecipazione delle donne al
mercato del lavoro deve quindi essere ricondotta e analizzata allinterno di uno
spazio simbolico in cui si incontrano le politiche del lavoro, le politiche di pari
14 Cruz, M. Hacerse cargo, Paids, Barcellona, 1999, trad.it. di Bedogni, U. Farsi carico. A proposito
di responsabilit e di identit personale, Roma, Meltemi, 2005.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 572 03/05/2013 11:11:31
573
2. Il tempo delle donne nelle politiche di conciliazione
opportunit e le misure di conciliazione dei tempi di lavoro e tempi di vita. La-
nalisi di questo spazio mostra che le misure di conciliazione non rientrano nelle
politiche di pari opportunit, ma si tratta di due insiemi che si intrecciano e non
si sovrappongono, o meglio la conciliazione come insieme pi piccolo non
interamente ricompreso in quello delle politiche di pari opportunit.
Se la bassa spesa sociale per le misure di conciliazione ha certamente un im-
patto sulle scelte delle donne, il quadro pi complesso. Sarebbe riduttivo an-
che alla luce delle ricerche
15
dividere il tempo tra lavoro produttivo e quello
riproduttivo, non considerando il tempo per s: questa complessit fa registrare
una maggiore reattivit a un sistema di incentivi sulla gestione dei tempi di lavoro
(e sulla loro prevedibilit) piuttosto che a incentivi monetari
16
.
Stiamo quindi osservando il superamento del modello della doppia presenza
a favore di una diversa aspettativa di costruzione temporale della propria vita, in
un quadro che vede sempre pi forte la compenetrazione tra lavoro e vita privata.
Ecco che la fessibilit pensata come mera opportunit per far quadrare i tempi
(primariamente delle organizzazioni lavorative), e non per rimettere in discussione
le attivit previste nelle diverse sfere, e soprattutto una distribuzione pi equa del
lavoro di riproduzione sociale
17
.
Queste aspettative si intrecciano a regressi che guardano a quel quadro di
protezione sociale in costruzione che intende basarsi fortemente sulle risorse co-
munitarie, e quindi sulle donne. Ma quali sono le risorse comunitarie? E i rischi
dellelogio della comunit? Da una ricerca realizzata in un piccolo centro (imma-
ginato come meno individualizzato e pi solidali) emergono invece reti corte e al
retrocedere del welfare lazione individuale delle donne a supplire
18
.
15 Farina, F; Vincenti, A. Tessere e ritessere la conciliazione: una ricerca nel territorio della Pro-
vincia di Pesaro-Urbino, in Autonomie locali e servizi sociali, 2, 2009, pp. 511-524.
16 Isfol, Fiscalit e oferta di lavoro: una prospettiva di genere, in Indiretto, G.; Belmonte, S.;
Addabbo, T. (a cura di) Studi Isfol Coesione sociale, n. 2, Roma, 2008.
17 Bettio ricorda che ofrire dei servizi di cura ad orario ridotto ma soprattutto rigido signifca
limitare la fessibilit dellorario di lavoro invece che assecondarla (Bettio, F. Servizi allinfanzia: quale
idea di famiglia?, in www.nelmerito.com, 15 ottobre, 2008).
18 stato chiesto alle intervistate di indicare rispetto a una serie di attivit il proprio impegno,
quello del partner e leventuale ricorso a nonni o a persone pagate. Un primo gruppo di attivit
rappresentato dal lavoro di cura per la casa, gli acquisti per la famiglia e la preparazione dei pasti.
Un secondo insieme di attivit riguarda la cura dei fgli a cominciare dallinserimento scolastico,
la vita scolastica, il tempo libero, le visite mediche. Infne le attivit di relazione con gli uf ci pub-
blici (banche, poste, uf ci comunali) e lamministrazione delle fnanze familiari. La partecipazione
dei partners molto limitata e si concentra rispetto ad alcune attivit rapporto con gli uf ci e
il bilancio familiare mentre sulle donne ricade la maggior parte delle attivit (Farina Vincenti
cit. pp. 517 ss.).
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 573 03/05/2013 11:11:31
574
Capitolo 12. La rappresentazione del femminile nei piani e programmi dazione europei
Ed questo il dato empirico che sparisce dal quadro da cui i promotori delle
riforme partono per pensare a politiche di intervento (e la conciliazione entra in
agenda, anche se nella versione ridotta di politiche per le donne
19
) che neutra-
lizzano la carica di cambiamento delle politiche per le donne facendo registrare
lassenza di pratiche confittuali. Lea Melandri individua quella che oggi appare
vistosamente come una contraddizione: un movimento che ha dato alle donne
una circolazione e una cittadinanza nel mondo fnora sconosciute, ma che le ritro-
va inspiegabilmente adattabili, poco inclini ad aprire confitti, acrobate protese
a sorreggere limpossibile conciliazione tra due realt fatte per restare separate, la
casa e la polis
20
.
Lassenza di pratiche confittuali fa registrare una mancata ricontrattazione
dei tempi di cura a fronte di una demercifcazione della cura stessa che aumenta il
carico di lavoro femminile.
Il Libro Bianco
21
quando parla di donne, parla di conciliazione
22
come ri-
chiesta avanzata alle organizzazioni da parte delle donne stesse (mai dagli uomini)
di tempi diversi, riducendo la questione a come il tempo del lavoro produttivo
possa permettere alla donne di svolgere il lavoro di cura, raforzando una visione
essenzialista dei sessi.
In questo processo di backlash sparisce la parola potere che sappiamo essere
costitutivo del concetto di genere
23
. Ecco che in un glossario uf ciale il genere
viene descritto come un concetto che esprime le diferenze sociali tra le donne
e gli uomini che sono state apprese. Esse cambiano col tempo e variano allin-
19 Lo stato sociale, poggiando sulla famiglia per il proprio funzionamento, poggia in realt anche
su una precisa struttura dei rapporti tra i sessi. Non a caso molte volte si usa in modo interscam-
biabile il termine servizi per la famiglia e servizi per le donne, alludendo al fatto che si rivolgono
a bisogni e attivit che riguardano una sfera di competenza e lavoro in linea di principio af data
alle donne adulte nella famiglia: che si tratti dei nidi o dei tempi pieni scolastici per i fgli di madri
lavoratrici, o della assistenza domiciliare per gli anziani che non possono contare su una moglie, una
fglia o una nuora che si occupi di loro quando non sono autosuf cienti. (Saraceno, C. Sociologia
della famiglia, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 239)
20 Melandri, L. Lo spazio pubblico si femminilizza, ma scompare il confitto tra i sessi, ottobre 2009,
www.zeroviolenzadonne.it.
21 La vita buona nella societ attiva. Libro bianco sul futuro del modello sociale, Ministero del Lavoro,
della salute e delle Politiche sociali, maggio 2009.
22 Intanto le pari opportunit sono stare ridotte a una questione di donne, con una schizofrenia
rispetto ai temi afrontati: mi chiedo perch il Ministero delle Pari Opportunit ad occuparsi di
endometriosi piuttosto che quello della salute.
23 Scott, J.W. Gender: A Useful Category of Historical Analysis, in Te American Historical
Review, vol. 91, n. 5, dicembre 1986, pp. 1053-1075, trad.it. Il genere: unutile categoria di analisi
storica, in Di Cori, P. (a cura di) Altre storie. La critica femminista alla storia, Bologna, Clueb, 1996
pp. 307 347.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 574 03/05/2013 11:11:31
575
2. Il tempo delle donne nelle politiche di conciliazione
terno delle singole culture
24
. Non solo il genere viene depotenziato a variabile
descrittiva, ma spesso diventa sinonimo di donne (le politiche di genere sono
cose di donne) perch una defnizione che si basa sulla diferenza implica che
dove non possiamo vederla, non possiamo vedere nemmeno il genere
25
, e quindi
il potere quale fattore primario della relazione tra i sessi
26
. Avviene quello che si
potrebbe defnire il passaggio dal neutro al neutrale. Se fnalmente si era arrivati
al superamento del neutro ovvero a unidea maggiormente condivisa che il mon-
do poteva/doveva essere declinato al maschile e al femminile e quindi anche nel
processo di policy making, si progressivamente giunti a una prospettiva neutrale
o, meglio, a un processo di neutralizzazione. Nel pensare e realizzare pratiche che
tenessero conto della diferenza di genere, si cominciata a difondere lidea che
queste rispondessero a una soluzione che potesse costituire lone best way per tutti,
uomini e donne. Questo ha fatto s che le politiche di pari opportunit si siano
difuse molto velocemente innescando un processo di burocratizzazione, distante
dalla prospettiva femminista. Un processo spesso non accompagnato, quindi, da
una volont di cambiare i rapporti di genere anche nella sfera privata, bens da
strumenti e pratiche plasmate in unottica di genere che diventa spesso unottica
che neutralizza la capacit performativa della stessa categoria di genere perch si
ferma alla mera descrizione della realt
27
.
Non c stato quindi un processo di politicizzazione attraverso le azioni realiz-
zate in nome del genere e questa burocratizzazione fa s che i processi si possano
invertire in mancanza di risorse (del resto molte azioni sono state fatte solo perch
sono stati stanziati fnanziamenti ad hoc).
Molto si normato, poco stato ripoliticizzato, ma la presenza femminile
non pone solo una questione quantitativa rispetto a come le pratiche delle donne
si diferenzino da quelle maschili: Se non si pone il problema anche di un sogget-
to femminista di massa, la pratica del 50 per cento si riduce alla fne a un espedien-
24 Commissione Europea (1996) Glossario di termini sulla parit tra le donne e gli uomini, 100
parole per la parit, 1996, p. 22. Il glossario stato realizzato nellambito delliniziativa comunitaria
Occupazione promossa dalla Commissione Europea con la comunicazione 94/C 180/10 del 1 Lu-
glio 1994 e modifcata a seguito della comunicazione 96/C 200/06 del 10 Luglio 1996, che intende
contribuire allo sviluppo delle risorse umane migliorando le prospettive occupazionali delle categorie
considerate a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
25 Connell, R.W. Gender, Cambridge, Polity Press, 2002, trad. it., Ghigi, R. Questioni di genere,
Bologna, Il Mulino, 2006, p. 38.
26 Scott, J.W. op. cit., p. 333.
27 La semplice descrizione rischia di essenzializzare le diferenze, cio di ricondurre a fattori
naturali la diferenza tra uomini e donne, occultando la pluralit di comportamenti e stili di vita,
sottacendo i processi storici e gli aspetti relativi alla struttura sociale che nel tempo hanno costruito
quella diferenza.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 575 03/05/2013 11:11:31
576
Capitolo 12. La rappresentazione del femminile nei piani e programmi dazione europei
te per la costruzione di una burocrazia femminile, di cui non si avverte davvero il
bisogno
28
. Lazione della pubblica amministrazione ha spesso coinvolto donne
senza un background femminista e questo un elemento che ha contribuito alla
burocratizzazione.
Non parlare di potere non fa parlare delle diseguaglianze, bens alimenta una
prospettiva diferenzialista che ha sempre pi i contorni di un processo di essenzia-
lizzazione dei ruoli di genere (cos evocato nel dibattito sulla conciliazione). Viene
alimentata una cultura che diferenzia e stereotipizza fortemente i sessi, producen-
do efetti sia sul sex typing del mercato del lavoro, che sulla qualit dellinclusione:
dalle donne si attende la disponibilit alla fessibilit, dagli uomini un modello di
maggior continuit nel mercato.
Si compone cos un contesto culturale ostile, in cui la dialettica di genere
archiviata, perch facendo coincidere la femminilit con la capacit di essere
madre, si defnisce la donna per ci che , non per ci che decide di essere
29
.
28 Cirillo, L. La luna severa maestra. Il contributo del femminismo ai movimenti sociali e alla costru-
zione dellalternativa, Milano, Il dito e la luna, 2003, p. 41.
29 Badinter, E. Fausse route, Paris, Odile Jacob, 2003, trad.it. Dornetti, E. La strada degli errori. Il
pensiero femminista al bivio, Milano, Feltrinelli, 2004, p. 123.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 576 03/05/2013 11:11:32
3. Lincontro tra il pensiero femminista
e i programmi europei: attraversamenti
e interpretazioni. Unesperienza
Simonetta De Fazi
La questione ormai e gi da molto tempo evidente su cui le politiche di pari
opportunit rivolte alle donne e i programmi di azioni positive hanno mostrato il
loro limite costitutivo che le forme di intervento che si proponevano avevano un
carattere aggiuntivo e non trasformativo.
Nate per riequilibrare e dunque favorire la partecipazione femminile al mer-
cato del lavoro si sono interrogate e hanno agito su fattori ostativi oggettivi, espun-
gendo dallanalisi del fenomeno, o comunque trattando in modo inadeguato, ci che
la stravaganza dei comportamenti femminili nel mercato del lavoro rendeva eviden-
te e che era gi stato denunciato nelle analisi di molte sociologhe, storiche ed econo-
miste che per brevit chiamer femministe: linadeguatezza delle teorie sociologiche,
storiche ed economiche classiche di rendere ragione dei fenomeni, a motivo della loro
riconduzione a un modello unico di comportamento, ancorch in grave crisi.
La necessit di accrescere e mantenere stabile la partecipazione femmini-
le al mercato del lavoro legata a quella di allargare e rendere stabile la platea
contributiva
30
, ovvero di mantenere in vita dapprincipio senza interventi strut-
turali il sistema di protezione sociale.
Listanza di giustizia sociale cui fa riferimento il principio di uguaglianza
viene cos in secondordine, anche se non e non pu essere eluso dalle politiche
di pari opportunit che anzi ne riscrivono in qualche modo il paradigma, adot-
tando ricette maschili per soggetti femminili: laccanimento terapeutico delle
politiche di pari opportunit.
30 PM: Dal diferenziale salariale al diferenziale pensionistico.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 577 03/05/2013 11:11:32
578
Capitolo 12. La rappresentazione del femminile nei piani e programmi dazione europei
Ciononostante, soprattutto a livello europeo e per un certo, breve, periodo
anche a livello nazionale, le politiche di programmazione sembrano aver
recepito listanza trasformativa che la partecipazione femminile al MdL si trascina
dietro, e aver posto attenzione al dibattito politico che le donne portavano avanti
fuori e dentro le istituzioni (ne sono testimonianza due orientamenti successivi,
il primo riguardante la necessit di porre in campo la valutazione di impatto dei
provvedimenti rispetto al genere, il secondo con la defnizione di una strategia
duale e del gender mainstreaming, evidentemente collegata alla elaborazione
politica che avviene attorno allevento di Pechino del 1995).
Nelle analisi come nelle proposte programmatiche, fno al linguaggio, le po-
litiche sembrano cominciare ad avere contezza della diferenza di genere come
qualcosa che non va sanato ma va giocato, negli svantaggi che produce rispetto
al piano delle opportunit sociali.
Lesperienza a cui faccio riferimento si colloca allinizio degli anni Novanta.
Allinizio cio della programmazione comunitaria in materia di azioni positive,
con il programma NOW; sono gli anni del libro bianco di J. Delors. Gli anni in
cui nel nostro Paese veniva emanata, dopo una lunga gestazione, la legge 125/91
sulle azioni positive per la realizzazione della parit uomo donna nel lavoro e, su-
bito dopo ma frenata dalla ritardata emanazione dei decreti attuativi la legge
215/92 sullimprenditoria femminile.
Due provvedimenti nati vecchi per un movimento e un pensiero femminile
che nel decennio precedente si molto diversifcato e molto ha prodotto in ter-
mini di analisi (mettendo in campo il taglio della diferenza sessuale), mentre da
una parte si avviava massicciamente il processo di istituzionalizzazione delle pari
opportunit (con la nascita di Commissioni e Comitati a tutti i livelli territoriali
e aziendali) e dallaltra si creavano spazi di interlocuzione inediti tra il movimento
femminista e le donne dei partiti.
Cernobyl, il movimento Le donne con le donne possono, ma anche la pro-
posta di legge sui tempi e lavvio di un importantissimo discorso sullorganizzazio-
ne della vita comunitaria, dei tempi e degli spazi della citt, a cui molto devono
le migliori politiche e forme regolative che ne sono derivate (la legge 53/2000
sullequilibrio dei tempi, ma anche la risoluzione EU del 29 giugno dello stesso
anno sulla partecipazione equilibrata di uomini e donne alla vita familiare e alla
vita pubblica), dopo circa tre lustri.
La seconda met degli anni Ottanta anche il periodo che vede nascere e
prolifcare, per efetto della trasformazione di gruppi politici e per raccoglierne
leredit, un gran numero di Centri di documentazione delle donne, per iniziativa
di dieci dei quali nacque alla fne del decennio la Rete informativa di genere fem-
minile Lilith, al cui interno maturata lesperienza di cui riferisco
31
.
31 E sulla quale v. anche, se vuoi, De Fazi, S. La rete Lilith: una storia, DWF 2/3 2007.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 578 03/05/2013 11:11:32
579
3. Lincontro tra il pensiero femminista e i programmi europei: attraversamenti e interpretazioni
Nella considerazione delle pi, [la nascita dei Centri] era una sorta di esito na-
turale e lattivit che nei centri si svolgeva era considerata senzaltro seconda e secon-
daria (di servizio?) rispetto allattivit politica vera e propria. Ci che aveva portato
alla costituzione degli archivi del Novecento era gi un dato acquisito, la critica storica
grazie soprattutto alle donne aveva spietatamente messo in luce la costruzione
intenzionale della storia e dei suoi documenti. Ciononostante, anche le stesse donne
che a questo avevano contribuito non prendevano pi di tanto sul serio la noiosissima
attivit svolta dai centri, che raccoglievano, catalogavano, ordinavano
I centri di documentazione comunque continuavano a nascere e a difondersi,
guardati sempre con qualche sospetto (forse quello di rappresentare unevoluzione
in senso impolitico o di servizio del femminismo)
Nel 1986, il Coordinamento dei centri documentazione, biblioteche e libre-
rie delle donne nato a Bologna appena un anno e mezzo prima promuove a
Siena, il convegno nazionale Le donne al centro, ma gi nella primavera dello
stesso anno, si era tenuto a Roma un incontro presso la sede del Centro Studi
DonnaWomanFemme che aveva messo a tema la politica delle donne e la realt
dei centri di documentazione.
Ripensandoci, mi verrebbe da dire che forse la difusione dei centri acceler la
messa in campo di alcune questioni che fno ad allora erano rimaste sullo sfondo
o che erano senzaltro inedite per i gruppi politici del femminismo.
I centri svolgevano unattivit che per certi versi era di servizio e per altri di
ricerca, avevano bisogno di e spesso sviluppavano competenze professionali
specifche, possedevano un patrimonio fsicamente consistente. Dunque, per farla
breve, avevano bisogno di stabilit, spazio e risorse. Il tutto, in un periodo in cui
levoluzione delle tecnologie cominciava ad avere un impatto pi difuso (il Com-
modore 64, il pi difuso home computer del mondo allepoca, usc nel 1982, lo
stesso anno del primo pc IBM 8088, il cui costo si aggirava attorno ai 6 milioni).
I rapporti con le istituzioni locali, gli enti di ricerca e le organizzazioni profes-
sionali; lopzione tra autofnanziamento e fnanziamento pubblico; limpostazione
del lavoro per progetti; la ricerca di fnanziamenti stabili; lacquisizione di com-
petenze informatiche e lo sviluppo di interventi formativi specifci. Erano queste
alcune delle questioni che i centri si trovarono ad afrontare e che rappresentavano
delle scommesse assolutamente inedite rispetto allesperienza dei collettivi politici.
Il movente che diede inizio alla Rete e allidea di realizzare un catalogo unico
fu il desiderio di mettere in condivisione i materiali raccolti dai centri e di trovare
le soluzioni tecniche e tecnologiche per farlo, anche promuovendo la ricerca e la
formazione sui linguaggi e le metodologie di trattamento dei documenti.
La Rete Lilith, alcuni dei centri promotori, decidono dunque di partecipare
al programma NOW con progetti specifci, intravedendo in esso la possibilit di
mettere in campo alcune interpretazioni rispetto alla descrizione/formazione delle
competenze professionali e degli strumenti di analisi e descrizione.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 579 03/05/2013 11:11:32
580
Capitolo 12. La rappresentazione del femminile nei piani e programmi dazione europei
Per la Rete cerano in campo due sfde corrispondenti ad altrettante necessit,
tra loro come sempre accade collegate: la prima era quella di formare docu-
mentaliste, concorrendo anche alla descrizione delle competenze professionali del
proflo; la seconda era quella di difondere insieme alla nuova descrizione di quel
proflo un pensiero critico sugli strumenti professionali, e proponendone di
nuovi. Lattenzione al linguaggio come luogo di produzione e riproduzione sim-
bolica, la sua non neutralit, hanno segnato profondamente e trasversalmente il
pensiero delle donne, in ogni campo.
I Centri di documentazione si trovarono sin da subito in questa contraddizio-
ne: di avere a che fare con documenti, quelli prodotti dal femminismo, attentis-
simi al linguaggio e doverli trattare secondo degli standard internazionali neutri e
come sempre non neutrali che li rendevano opachi quando non irrecuperabili, ne
riducevano il contenuto, ne azzeravano la maternit.
La Rete Lilith sin da subito cominci a lavorare sugli strumenti, avanzando la
proposta di revisione a una comunit che mano a mano si fece sempre pi vasta,
con delle opzioni decise: software open source; thesaurus vs soggettario per lindiciz-
zazione; liste di autorit.
Non posso e non ha qui senso entrare nel dettaglio del lavoro svolto. Voglio
per sottolinearne la valenza politica, di costruzione di mondo. La Rete Lilith, at-
traverso il NOW, cre consenso e adesione attorno alle due proposte:quella legata
alla descrizione del proflo professionale e quella legata agli strumenti.
Laver formato documentaliste esperte nel trattamento informatizzato dei
fondi documentari delle donne voleva dire pi cose, ma fondamentalmente che
quella fgura, pur lavorando allinterno di convenzioni e standard internazionali,
non avrebbe applicato la standardizzazione come tappeto sotto il quale nascondere
la spazzatura, sarebbe stata in grado a partire dallesperienza maturata sui fondi
delle donne di trattare fondi stravaganti, come quelli prodotti dalla storia del
Novecento e dai cosiddetti nuovi soggetti sociali.
Le ragazze che seguirono il nostro corso a Roma (830 ore in un solo anno),
lavorarono molto al trattamento di materiali come volantini, striscioni, manifesti,
foto, documenti ciclostilati, ecc. che e questo ci riporta al tema del linguaggio
venivano defniti NMB (non book material), ovvero individuati per diferenza.
Secondo noi si fa cos. Perch se non si fa cos, una parte consistente di mon-
do scompare
In estrema sintesi era questa la questione con cui ci siamo messe al lavoro, in-
contrando peraltro il favore di moltissimi dei soggetti che nel frattempo avevamo
coinvolto nel nostro percorso: dallAIB allAIDA, dalle Universit alle Fondazioni,
dalle scuole alle associazioni.
Sottolineo questo aspetto perch credo che esso anticip quella che poi diven-
ne una domanda ineludibile, un prerequisito per la presentazione di progetti: il
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 580 03/05/2013 11:11:32
581
3. Lincontro tra il pensiero femminista e i programmi europei: attraversamenti e interpretazioni
coinvolgimento attorno e a sostegno delle attivit formative di un gran numero di
soggetti (dalla Scuola popolare di musica di Testaccio, allIstituto di cultura Italo-
Americano, alla biblioteca della Camera dei Deputati, al centro di documentazio-
ne dellEnel, alla Mediateca del Palazzo delle Esposizioni.).
Negli obiettivi e nel metodo: mettere al mondo il mondo, fare rete, creare
contatti, interrogare se stessi e il proprio lavoro, lavorare con cura, mi verrebbe
da dire per mettere in campo senza svolgerla una questione importante.
Nelle maglie strette di quel primo NOW labbiamo potuto fare. Il nostro
lavoro stato segnalato successivamente dallIsfol come buona pratica.
Nessun altro progetto ci stato pi approvato.
Per scelte precise e non per nostra insipienza.
Ci non cambia il mio giudizio sulla permeabilit che con efetti visibili
anche se non certamente oggettivi almeno fno allinizio del 2000 le politiche
europee hanno avuto con il pensiero femminile e con il fatto di aver compreso la
questione fondamentale.
Altro poi capire dove e perch questo percorso si sia fermato. Su che cosa e
perch sia tornato a essere comunitariamente sconveniente. Possiamo anche qui
invocare la crisi come spiegazione suf ciente a un rovesciamento facile di priorit,
in cui prevale la ragioneria politica invece che la ragione, la quantit invece che
la qualit?
Qualcosa interrompe il cambiamento atteso e, per certi versi, il cammino
intrapreso in Europa e nel nostro Paese. Facendo rovina di alcune piccole ma
dif cili modifcazioni che pure si erano andate a inscrivere nei documenti di pro-
grammazione, magari senza diventare azioni ma solo attenzioni, cautele, riguardi.
Guidi-Pelizzari_txt - I tomo.indd 581 03/05/2013 11:11:32
Potrebbero piacerti anche
- AA42 2nd Manuale Italiano 1.1 by TonewitzDocumento32 pagineAA42 2nd Manuale Italiano 1.1 by TonewitzAntonio Bruni80% (5)
- Libri Raccolta SkyrimDocumento2 pagineLibri Raccolta SkyrimJan GrisantiNessuna valutazione finora
- Graffite RomaDocumento54 pagineGraffite RomaSilvia Cortellesi100% (1)
- Storia ValenzaDocumento222 pagineStoria ValenzabertydjNessuna valutazione finora
- Il Campionato Di TopazioDocumento5 pagineIl Campionato Di TopazioLuca CorNessuna valutazione finora
- Il Cinema Della Convergenza. Industria - Racconto - AudienceDocumento289 pagineIl Cinema Della Convergenza. Industria - Racconto - AudienceJavier BenitoNessuna valutazione finora
- Giovanna Campani - Antropologia Di GenereDocumento205 pagineGiovanna Campani - Antropologia Di GenereNoemi Fiocco100% (1)
- Jules Verne - Il Castello Dei CarpaziDocumento164 pagineJules Verne - Il Castello Dei Carpazifulvix880% (1)
- Runa Bianca - Giugno 2011 n.0Documento147 pagineRuna Bianca - Giugno 2011 n.0La Porta del TempoNessuna valutazione finora
- IncastRIMEtrici Vol.1 A Cura Di Marco Borroni e Paolo Ornaghi - Indice e BibliografiaDocumento14 pagineIncastRIMEtrici Vol.1 A Cura Di Marco Borroni e Paolo Ornaghi - Indice e BibliografiaLuciano DuòNessuna valutazione finora
- J. L. Bourne Diario Di Un Sopravvissuto Agli ZombieDocumento164 pagineJ. L. Bourne Diario Di Un Sopravvissuto Agli ZombieMariaLuisaSogusNessuna valutazione finora
- Leonardo 09Documento31 pagineLeonardo 09Gav Lv0% (1)
- Storie Di Strada Dipendenze, Tossicodipendenze Tra Prevenzione, Riduzione Del Danno e Percorsi TerapeuticiDocumento218 pagineStorie Di Strada Dipendenze, Tossicodipendenze Tra Prevenzione, Riduzione Del Danno e Percorsi TerapeuticiRoberto MucelliNessuna valutazione finora
- BonomiDocumento13 pagineBonomidiana_ferro_1989Nessuna valutazione finora
- Per Il Potere Di Grayskull - Alessandro-Apreda-Docmanhattan PDFDocumento126 paginePer Il Potere Di Grayskull - Alessandro-Apreda-Docmanhattan PDFRiccardo MeggioriniNessuna valutazione finora
- Nuvole Di PassaggioDocumento186 pagineNuvole Di PassaggioGm WilloNessuna valutazione finora
- L'Opera Al NeroDocumento1 paginaL'Opera Al NeroMatteo BrenciNessuna valutazione finora
- William Shakespeare MacbethDocumento61 pagineWilliam Shakespeare MacbethSirio LongoNessuna valutazione finora
- Fantasmi e Fenomeni Paranormali -La Maledizione di Ondine-Da EverandFantasmi e Fenomeni Paranormali -La Maledizione di Ondine-Nessuna valutazione finora
- Locri, Divinità Al FemminileDocumento17 pagineLocri, Divinità Al FemminilePino Blasone100% (1)
- Cruciverba DifficileDocumento4 pagineCruciverba DifficilePhilippeNessuna valutazione finora
- Leonetti Geografia IDocumento155 pagineLeonetti Geografia IanonymousNessuna valutazione finora
- (Ebook - ITA - NARR - Fantasy) Jack Vance - I Signori Dei DraghiDocumento230 pagine(Ebook - ITA - NARR - Fantasy) Jack Vance - I Signori Dei DraghiAxia AuroraNessuna valutazione finora
- Personaggi Pregenerati Sardegna MacabraDocumento5 paginePersonaggi Pregenerati Sardegna MacabraUmberto PignatelliNessuna valutazione finora
- Mondello - Il NeonoirDocumento16 pagineMondello - Il NeonoirwiriumNessuna valutazione finora
- Il Codice D'ArrigoDocumento182 pagineIl Codice D'ArrigomarcotrainitoNessuna valutazione finora
- Tolkien PDFDocumento20 pagineTolkien PDFImBot100% (1)
- COLOSSEODocumento28 pagineCOLOSSEOMrsSheperdNessuna valutazione finora
- Verifica Carlo Magno 1Documento3 pagineVerifica Carlo Magno 1Vittorio AnginiNessuna valutazione finora
- SchedeAnLogica PDFDocumento26 pagineSchedeAnLogica PDFGiovanni D'espositoNessuna valutazione finora
- Sher Lock Hol MesDocumento16 pagineSher Lock Hol MesPierNessuna valutazione finora
- Storia AutovalutazioneDocumento21 pagineStoria AutovalutazioneCarlos Fernández LlanasNessuna valutazione finora
- Sujets Bac 2019 Liban LV2 ItalienDocumento8 pagineSujets Bac 2019 Liban LV2 ItalienAnonymous atWs5JLwNessuna valutazione finora
- Verbanus34nuovo DefinitivoDocumento440 pagineVerbanus34nuovo DefinitivoAISUassociazione100% (1)
- Caulonia Tra Crotone e Locri. Atti Del Convegno Internazionale I PDFDocumento316 pagineCaulonia Tra Crotone e Locri. Atti Del Convegno Internazionale I PDFLycophron100% (1)
- Prima Lezione Di Italiano Per Studenti C PDFDocumento26 paginePrima Lezione Di Italiano Per Studenti C PDFIleana AronNessuna valutazione finora
- Scacchi Partite CommentateDocumento29 pagineScacchi Partite CommentateGabriele Viozzi100% (1)
- Gazzetta Del Menagramo #1 - ITADocumento20 pagineGazzetta Del Menagramo #1 - ITA678ojyhiopNessuna valutazione finora
- Mangi Italiano PDFDocumento28 pagineMangi Italiano PDFGinevra VINessuna valutazione finora
- Tipografia Delle Relazioni Logiche / Rappresentazione Tipografica Della Struttura Del RagionamentoDocumento35 pagineTipografia Delle Relazioni Logiche / Rappresentazione Tipografica Della Struttura Del RagionamentoSaria Digregorio100% (2)
- Manuale ArcanumDocumento183 pagineManuale ArcanumMichelangelo MerisiNessuna valutazione finora
- Ciro Il Grande A Persepoli - Archeologia Viva, Aprile 2017Documento5 pagineCiro Il Grande A Persepoli - Archeologia Viva, Aprile 2017Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Oltre La Soglia Della Città PerdutaDocumento19 pagineOltre La Soglia Della Città PerdutaMalloc17Nessuna valutazione finora
- La Sottana Della NonnaDocumento65 pagineLa Sottana Della NonnaGuido MuscoNessuna valutazione finora
- Augusta Universalis - Avventure in Destino OscuroDocumento7 pagineAugusta Universalis - Avventure in Destino OscuroMarco GalloNessuna valutazione finora
- Avventura 003 - Brancalonia - L'Ultimo Viaggio Della Balorda (2023) - ITADocumento24 pagineAvventura 003 - Brancalonia - L'Ultimo Viaggio Della Balorda (2023) - ITAWalter MazzaNessuna valutazione finora
- Aquila DragoDocumento107 pagineAquila DragoArjacRockfistNessuna valutazione finora
- Vitae Dei Dogi Di Marin Sanudo (1423-74) - Vol. 2Documento381 pagineVitae Dei Dogi Di Marin Sanudo (1423-74) - Vol. 2nicocicoNessuna valutazione finora
- Osteria BruciataDocumento17 pagineOsteria Bruciatafausto giovannardiNessuna valutazione finora
- Raccolta Fotografica Della Brera Degli Anni '50-'60Documento105 pagineRaccolta Fotografica Della Brera Degli Anni '50-'60Federica RanghettiNessuna valutazione finora
- Atlante Del MondoDocumento76 pagineAtlante Del MondoaperissuttiNessuna valutazione finora
- BladesInTheDark - Ita MqcghyDocumento328 pagineBladesInTheDark - Ita MqcghyEttoreNessuna valutazione finora
- Mare NostrumDocumento26 pagineMare NostrumSaturas92Nessuna valutazione finora
- Sindarin - La Lingua NobileDocumento59 pagineSindarin - La Lingua NobileJan GrisantiNessuna valutazione finora
- La Natura in Leopardi e in PascoliDocumento26 pagineLa Natura in Leopardi e in PascolisaroNessuna valutazione finora
- Vecce CarloDocumento13 pagineVecce CarloWomEntourageNessuna valutazione finora
- Ricordando Enrico CombaDocumento18 pagineRicordando Enrico CombaSofia VenturoliNessuna valutazione finora
- Struttura e Processo: Sofia Venturoli Antropologia Politica, 2023 UnitoDocumento13 pagineStruttura e Processo: Sofia Venturoli Antropologia Politica, 2023 UnitoSofia VenturoliNessuna valutazione finora
- Foucault: Le Discipline: Sofia VenturoliDocumento9 pagineFoucault: Le Discipline: Sofia VenturoliSofia VenturoliNessuna valutazione finora
- La Favela Di Paraisópolis (SP) - Dinamiche Sociali Di Cambiamento Urbano Fra Esclusione e IdentitàDocumento268 pagineLa Favela Di Paraisópolis (SP) - Dinamiche Sociali Di Cambiamento Urbano Fra Esclusione e IdentitàSofia VenturoliNessuna valutazione finora
- Riccardo Badini - Elisa Galli "Miti" Occidentali e Pensiero Indigeno ContemporaneoDocumento18 pagineRiccardo Badini - Elisa Galli "Miti" Occidentali e Pensiero Indigeno ContemporaneoSofia VenturoliNessuna valutazione finora