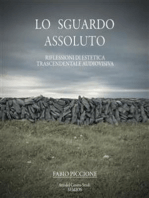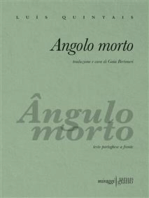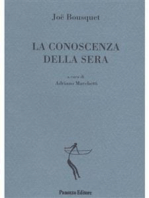Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Masini, Metacritica Dell'aura (In Gli Schiavi Di Efesto, 1981)
Caricato da
bartalore42690 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
1 visualizzazioni16 pagineTitolo originale
Masini, metacritica dell'aura (in Gli schiavi di Efesto, 1981)
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
1 visualizzazioni16 pagineMasini, Metacritica Dell'aura (In Gli Schiavi Di Efesto, 1981)
Caricato da
bartalore4269Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 16
Metacritica dell’«aura» *
Das Kind im Herzen des Unmenschen.
W. Benjamin
«La crisi della riproduzione artistica [...] si può
considerare come parte integrante di una crisi della
percezione stessa — scriveva Walter Benjamin nel suo
saggio su Baudelaire. — Ciò che rende insaziabile il piacere
del bello, è l’immagine del mondo anteriore che Baudelaire
dice velato dalle lacrime della nostalgia.» 1 Già nello scritto
sull'Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica
— la cui prima stesura è del ’35 — Benjamin aveva indicato
nel Verfall der Aura i termini di una crisi colta nel suo
significato positivo appunto in quanto radicalizzata fino alle
sue estreme conseguenze. Positivo questo significato non
solo perché in essa si riflette lo sfaldamento di quel
soggetto umanistico-borghese a cui si richiama e su cui fa
perno la ricezione individuale dell’opera d’arte, ma anche
perché è attraverso questa crisi che si possono rintracciare
le connotazioni di quel mutamento di funzioni dell’opera
d’arte in generale alla luce delle quali viene opposta al
fascismo una strategia di lotta sul terreno propriamente
estetico.
Queste connotazioni trovano nella corretta valutazione
di due elementi tradizionalmente estranei al conchiuso
universo estetico, la massa e la tecnica, il punto di
riferimento necessario per rovesciare nella politicizzazione
dell’estetico la fascistica esteticizzazione del politico. Ma la
questione che mi propongo di mettere a fuoco in questa
sede non riguarda tanto la teoria benjaminiana del cinema
nella quale appunto l’oltrepassamento dell’aura e delle sue
costellazioni (creatività e genialità, eternità e mistero) tutte
inscritte nel suo valore cultuale (Kultwert), si realizza
mercé la tematizzazione del valore espositivo
(Austeilungswert) dell’opera d’arte e quindi del carattere
tecnico-sperimentale dei suoi orocedimenti riproduttivi-
costitutivi. Mi domando invece se al di là dell’immediata
finalità politico-rivoluzionaria, nella quale va collocato il
saggio benjaminiano sull’Opera d’arte, non sia da elaborare
anche l’altra ipotesi, più coerente con la fisiognomica
dialetticamente ambigua del pensiero di Benjamin,
riguardante una teoria dell’aura che non si risolve
puramente e semplicemente in una critica dell’aura, ma sia,
per così dire, una metacritica nella quale proprio il
momento distruttivo dell’aura coincide con quello
sperimentale. Si tratta di verificare l’ipotesi che sottrae
l’aura alla seduzione della Stimmung, al cerchio concluso
dell'Erlebnis, alle costellazioni tipiche della soggettività per
dislocarla sul terreno dell’esperienza (Erfahrung) e della
«povertà» dell’esperienza, su quello — per usare termini
benjaminiani — del «carattere distruttivo» e della
«barbarie positiva». A mio parere la Zertrümmerung
dell’aura non comporta eo ipso la sua scomparsa: o meglio:
nel suo dissolversi l’aura lascia una zona d’ombra, il
suo negativo, quello spectrum di un Erlebnis che si è
andato dislocando nell’ottica della Erfahrung proprio per la
perdita di un centro di gravità soggettivo, di una reductio
ad unum in termini di soggettività. Su questa zona d’ombra
configurata come un «estremo» lavora il pensiero
dialettico.
Nel saggio sull’Opera d’arte Benjamin intende l’aura
non già come una proprietà delle cose, ma come un
contenuto di coscienza visualizzato nel «medium della
percezione» (im Medium der Wahrnehmung). Questo
concetto viene illustrato sia riguardo agli oggetti storici che
agli oggetti naturali. A quest’ultimo proposito Benjamin
definisce l’aura: «einmalige Erscheinung einer Ferne, so
nach sie sein mag»2 («apparizione irripetibile di una
lontananza, per quanto vicina questa possa essere»).
La definizione è chiarita ulteriormente in una nota:
«Definire l’aura un’“apparizione irripetibile di una
lontananza” altro non significa se non formulare, usando i
termini delle categorie della percezione spazio-temporale, il
valore cultuale dell’opera d’arte. La lontananza è il
contrario della vicinanza. Ciò che è nella sua essenza
[wesentlich] lontano è l’inavvicinabile. Di fatto
l’inavvicinabilità è una delle proprietà principali della
immagine cultuale. Essa rimane, per sua natura,
“lontananza, per quanto vicina”. La vicinanza che si può
strappare alla sua materia non elimina la lontananza che
essa conserva dopo il suo apparire»3.
Il lontano viene dunque «avvicinato», pur restando
lontano. Pur restando inviolabilmente sigillato nella
lontananza esso si fenomenizza (Erscheinung) come
«vicino», ma proprio perché la modalità del suo apparire è
einmalig, resta inattingibile. Il lontano in tanto è vicino, in
quanto si manifesta. Appare come se cessasse di essere, in
questo modo, lontano, ma questo modo irripetibile del suo
apparire non fa altro che confermare la lontananza come
lontananza. In realtà è il piacere della lontananza (come
non ricordare la musiliana Fernliebe?) a costituire il
proprio dell’aura nel suo riflettersi come Stimmung.
L’avvicinarsi del lontano è un rimandare lontano la
lontananza: per quanto essa possa sembrare abolita dal suo
apparire, essa è sempre la più lontana delle lontananze.
Sono state colte alcune oscillazioni nelle considerazioni
benjaminiane sull’aura nel senso che una netta antitesi tra
valore cultuale e valore espositivo, aura e ratio, così come
si delinea nel saggio sull’Opera d’arte non sembra
corrispondere pienamente ad una più articolata e fluida
definizione dell’aura e del suo Verfall presente in altri
luoghi degli scritti di Benjamin, tanto più che proprio
questa contrapposizione comporterebbe l’oblio di «quel
più, nel quale l’arte possiede la sua sola raison d’étre»4. In
realtà queste oscillazioni si riconnettono precisamente a
quel modificarsi della percezione che non si determina uno
actu col modificarsi delle funzioni strutturali dell’opera
d’arte, ma avviene per momenti, in un arco di
determinazioni dialettiche. Si tratta, in altre parole, di un
processo per il quale la distruzione dell’aura, il suo
sgretolarsi, la sua Zertrümmerung non possono essere
ricondotti ad un univoco ordine di grandezza.
Benjamin parla di un’esperienza vissuta di choc. «Egli
[Baudelaire] ha mostrato il prezzo a cui si acquista la
sensazione della modernità: la dissoluzione dell’aura
nell’“esperienza” dello choc [ «die Zertrümmerung der
Aura im Chockerlebnis» ].» 5 Questo Erlebnis non è
evidentemente più quello dell’aura, ma neppure del suo
opposto: è solo l’Erlebnis del suo infrangersi, del
disincantamento, e implica non già la passività di una
Stimmung, bensì un intervento attivo, un accordo, un
Einverständnis con questa distruzione. È un prezzo da
pagare non tanto per introdurre la ratio nell’esperienza
estetica, quanto per acquistare die Sensation der Moderne
(«la sensazione della modernità»)6. Del resto questo
perdersi dell’aura all’estremo della sua parabola, questo
svanire ultimo, questo struggente congedo in un attimo
fuggevole viene catturato nelle prime
fotografie: «Nell’attimo fuggevole di un volto umano si
sprigiona per l’ultima volta l’aura dalle prime fotografie. È
ciò che costituisce la loro bellezza carica di malinconia e
inconfrontabile con qualsiasi altra»7. In questo passo
l'Erlebnis del dissolversi dell’aura è fermato nella
fotografia, ma proprio questa espressione fuggevole in cui
l’aura effonde il suo incantesimo per l’ultima volta sembra
dilatarne la suggestione fino a un cerchio estremo e
indicibile di risonanze. La malinconica bellezza
«inconfrontabile con qualsiasi altra» non era certo presente
nella pace contemplativa dell’aura, ma lo è solo quando
l’aura si sta estinguendo. È in questo momento che la sua
labilità diventa quella stessa della bellezza e se v’è ancora
un brivido dell’irripetibile, questo nasce dalla coscienza di
una perdita irrevocabile, dalla magia di un tramonto che
non potrà più essere goduto ma che proprio per questo è
carico di una sconfinata seduzione.
Ma cos’altro è questo momento se non quello di uno
status disgregationis in cui lo spectrum dell’aura rivela le
sue valenze negative? Ma v’è ancora un passo in cui la
caduta dell’aura viene tematizzata in guisa particolare: qui
essa è ricondotta al rapporto tra mémoire involontaire e
dagherrotipia. «Se si scorge il contrassegno — scrive
Benjamin nel suo saggio su Baudelaire — delle immagini
che affiorano dalla mémoire involontaire nel fatto che
possiedono un’aura, bisogna dire che la fotografia ha una
parte decisiva nel fenomeno della “decadenza dell’aura”.
Ciò che nella dagherrotipia doveva essere sentito
come inumano, e starei per dire micidiale, era lo sguardo
rivolto (e per giunta a lungo) all’apparecchio, mentre
l’apparecchio accoglie l’immagine dell’uomo senza
restituirgli lo sguardo.»8 Quell’attesa che è presente nello
sguardo di chi ancora non è guardato, ma vuole essere
guardato a sua volta, è andata delusa. Il fallimento di
quell’attesa è la morte dell’aura. «Avvertire l’aura di una
cosa — notava ancora Benjamin — significa dotarla della
capacità di guardare.»9 Ma non c’è rimando speculare,
l’oggetto guardato è cieco, il mistero di uno sguardo
che ritorna e ti riconosce è distrutto. Il mondo è fatto di
cose che non guardano, che non ti guardano: sono occhi
calcinati, pupille vuote come quelle che creavano l’orrenda
vertigine del Chandos hofmannsthaliano. Purtuttavia chi
guarda, aspetta ancora uno sguardo che incontri il suo:
implora che la cecità veda e che il silenzio parli. Siamo
ancora una volta nella zona spettrale dell’aura
configurabile, in questo e negli altri passi citati, come
un’impossibilità di conchiudere l'Erlebnis nella sua
specularità, nel cerchio dell’aura, per cui esso gode di sé e
della sua pienezza contemplativa. La rottura della
circolarità implica la caduta di quel rimando che
sospendeva l'Erscheinung del lontano alla sua irripetibilità.
Lo sguardo che non ci viene più incontro da un mondo
divenuto cieco, quello sguardo negato per sempre è lo choc
disgregante la compattezza di un Erlebnis dominato dalla
Einfühlung, cioè da quella compenetrazione simpatetica
per cui il soggetto s’identifica nell’oggetto e viceversa. Vien
meno anche quella durata — propria dell’opera d’arte
auratica — in cui si risolve l’irripetibilità dell’apparizione:
perché solo ciò che dura è irripetibile. L’autenticità
dell’opera d’arte stava appunto in quel suo essere
ricompresa nel contesto della tradizione — la sua durata —
e al tempo stesso nel suo individuarsi hic et nunc in un
evento che non potrà mai trasformarsi in una serie
quantitativa di eventi. Ma tutti quei momenti che hanno
accompagnato, per così dire, il declino dell’aura
dislocandola a livelli sempre più bassi fino ad un ipotetico
«grado zero», vale a dire la secolarizzazione del rituale fino
alla dimensione di una «teologia negativa», quella dell’arte
pura, e fino alla stessa desemantizzazione dei significati
sono attraversati da un movimento distruttivo, quello stesso
di cui Benjamin parlava nel suo saggio del ’31, Der
destruktive Charakter. Il rarefarsi dell’«aura» si presenta
come un processo sincrono alla accelerazione di questo
movimento. La fenomenologia negativa dell’aura è appunto
l’ombra che la sua distruzione lascia apparire. L’ombra non
è ancora un tipo di «esponibilità» nuova dell’opera d’arte
offerta dai mezzi di riproduzione tecnica, ma uno stato
intermedio: gli antichi dèi non sono ancora del tutto
scomparsi e i nuovi non sono ancora interamente rivelati. È
una fase di passaggio in cui la fascinazione dell’aura è
soltanto quella della sua ombra. Alla paradossale
lontananza di un’apparizione «per quanto vicina questa
possa essere» è subentrato il divergere di lontananza e
vicinanza. L’inaccessibile lontananza sembra sprofondata
nelle tenebre dell’indicibile o dell’afasia, mentre le cose
hanno acquistato una vicinanza schiacciante e paurosa. È
la «malattia» del Chandos hofmannsthaliano per il quale le
parole sono coagulate in «occhi che mi fissavano e in cui io
sono costretto a fissarmi a mia volta», «vortici» che «a
guardarli mi danno le vertigini, che girano e girano senza
posa e, traversatili, si giunge al vuoto». Quanto alla
vicinanza delle cose, la loro è una unheimliche Nähe: «[...]
come una volta avevo visto in una lente d’ingrandimento un
lembo di pelle del mio dito mignolo, che somigliava a una
pianura con solchi e caverne, così ora m’accadeva con gli
uomini e i loro affari» 10.
Quella lontananza che si rendeva «respirabile» 11
nell’aura, si trova ora come affondata nell’incalzante
vicinanza di un’immagine divenuta impenetrabile, che non
può essere articolata. Lontananza e vicinanza sono due
segmenti spezzati. Per questo la contemplazione propria
dell’aura nel suo carattere affermativo si è lacerata. A
lacerarla è stata l’ebbrezza che come forma di una
«illuminazione profana» comporta — come aveva scritto
Benjamin nel saggio sul surrealismo (1929) —
«il superamento vero, creatore dell’illuminazione religiosa»
12. Dunque il primo momento distruttivo dell’aura non
coincide affatto con uno stato di impassibilità e di distacco
razionali, bensì, all’opposto, con la straripante violenza di
un’ebbrezza le cui forze «devono essere conquistate per la
rivoluzione» 13. «La dialettica dell’ebbrezza — scrive
Benjamin in questo stesso saggio — ha un carattere
peculiare.» 14 La sua peculiarità sta appunto in quella
distruzione del «mummificato ideale moralistico-umanistico
di libertà del liberalismo»15 alla quale tendevano i
surrealisti.
Ma non è proprio l’aura a riflettere, nella compattezza
del suo piano di civiltà, la progettualità universalizzante, le
garanzie di totalità, le autoassicurazioni razionali del
soggetto borghese? Non è essa la sedimentazione della
Erlebniswelt propria di quello che Benjamin chiama
Bildungshumanismus? L’autonomia dell’arte viene così
rovesciata da quel vortice dell’ebbrezza da cui sono
trascinati i portatori di una «barbarie positiva» i quali
consacrano il luogo della loro esistenza avvenire attraverso
la distruzione. È in questi Unmenschen che si delinea quel
«reale umanismo» nel quale l’elemento fanciullesco (das
Kindliche) e cannibalico (Menschenfresserische)
s’incontrano. «Affinché il collettivo — afferma Benjamin —
porti tratti umani, il singolo deve poter portare tratti
disumani. L’umanità deve essere sacrificata sul piano
dell’esistenza singola per poter venire in luce su quello
dell’esistenza collettiva.» 16 Se è vero che propria del
declino dell’aura è 'ambiguità, è altrettanto vero che
Benjamin chiama «ambiguità» «l’apparizione per immagini
della dialettica, la legge della dialettica allo stato di quiete»
(die bildliche Erscheinung der Dialektik, das Gesetz
der Dialektik im Stillstand 17). Ma potremmo dire che
questa ambiguità è ancora del tutto connessa alla dialettica
dell’ebbrezza, per la quale appunto si rende possibile, nel
linguaggio, il ricupero di una «erotica relazione originaria
tra vicino e lontano [...] come rima» 18. Al fondo del
vortice, del movimento, cioè, dell’ebbrezza, in cui vicinanza
e lontananza appaiono divaricate, si rivela una relazione
dialettica che congela, per così dire, in un’immagine
(«dialettica allo stato di quiete») l’interscambia-bilità degli
opposti. È la stessa trasparenza dell’umano nel «carattere
distruttivo», quale viene dischiusa da un’«ottica dialettica»
capace di cogliere, al fondo dell’ambiguità, l’eros:
quello stesso che fa riconoscere l’impenetrabilità del
quotidiano e il segno quotidiano dell’impenetrabile ”. Ma è
appunto in questo modo che il declino dell’aura può essere
visto come il profilarsi di una regione esposta
all’illuminazione profana, dove si ha il rovesciamento
dell'’Erlebnis nell'Erfahrung. Se l'Erlehnis appartiene
all’auratico, l'Erfahrung appartiene al distruttivo; il primo è
impregnato di durata, la seconda di povertà, «la povertà dei
costruttori». Il carattere distruttivo ha questa necessaria
povertà: «Il carattere distruttivo — scrive Benjamin — non
vede nulla di durevole. Ma proprio per questo vede
dappertutto delle vie» 20. La mancanza di Dauer equivale
alla perdita della Einmaligkeit. Tutte le connotazioni del
carattere distruttivo si riducono ad un’assenza di modelli.
Esso ha di fronte a sé uno spazio vuoto che è appunto
quello che ho chiamato la zona d’ombra dell'aura. Nota
ancora Benjamin: «Ha [il carattere distruttivo] pochi
bisogni e questo gli basterebbe: sapere cosa subentra al
posto di ciò che è stato distrutto. In un primo momento,
almeno per un attimo, lo spazio vuoto, il luogo dove stava la
cosa, dove la vittima ha vissuto. Si troverà certamente
qualcuno che lo usa, senza prenderne possesso». Questo
spazio vuoto è la trasparenza del senza-possesso, la
trasparenza del vetro. «Non per niente il vetro è un
materiale così duro e liscio, a cui niente si attacca. Ma
anche un materiale freddo e sobrio. Le cose di vetro non
hanno aura. Il vetro è soprattutto il nemico del segreto. È
anche il nemico del possesso.»21 La zona d’ombra dell’aura
è la zona della povertà, del non-possesso, dell’impossibilità
di possesso. Uno spazio in cui non esistono tracce, in cui
non è possibile lasciare tracce. Benjamin ricorderebbe a
questo punto il Verwisch die Spuren brechtiano, gli spazi
senz’aura creati da Scheerbart con il suo vetro e dal
Bauhaus con il suo acciaio. Il rapporto con lo straniamente
è evidente: lo Chockerlebnis con cui si cancellano le tracce
dell’aura ancora persistenti nei moderni è analogo
all’effetto di choc che è proprio dello straniamento
brechtiano. Il mercante dell’ottone che vuole comprare a
peso — come dirà Brecht nel suo Messingkauf — gli
strumenti musicali, produce uno choc in cui si aspetta di
fargli ascoltare della buona musica. La Verfremdung sta
appunto alla Einfühlung come il concetto di Erfahrung a
quello di Erlebnis. Non a caso Benjamin riconduce alla
gestualità il teatro epico (Das epische Theater ist
gestisch22): infatti l’interruzione dell’azione mediante il
gesto equivale alla rottura dell’aura attraverso lo choc della
fotografia. Mentre l’aura spegne la coscienza e trasferisce
il flusso vitale fuori di essa, nell’incantesimo della durata-
irripetibilità e quindi al di qua del gesto, «il carattere
ritardante dell’interruzione», la semantica del gesto che
spezza l’azione, trasferisce questo flusso nella coscienza,
costruisce l’esperienza critica di un evento non
semplicemente vissuto, ma esposto, indicato, citato,
commentato.
L’approdo del momento distruttivo si precisa dunque nei
termini di un’esperienza del «dialettico» la cui condizione
di base in tanto comporta l’oltrepassamento dell’estetica
dell’aura e quindi il riconoscimento di un modificarsi della
percezione dovuto alla presenza di nuovi fattori storico-
sociali, le masse e la tecnica, in quanto esprime altresì una
reale liquidazione di quella cultura che proprio per
l’assenza del momento distruttivo, anche se «accresce il
peso dei tesori che gravano sulle spalle dell’umanità», non
riesce a dare a quest’ultima «la forza di scuoterseli di dosso
e farli suoi» 23.
La morte dell’arte inerisce, secondo Vattimo, alla sua
essenza non eterna, ma certo, com’egli dice, «vigente nella
nostra costellazione storico-ontologica». Ancora una volta
Vattimo dà al problema una risposta da par suo. Ma questa
risposta presuppone il problema della morte dell’arte
presentato in guisa antinomical da un lato l’arte senz’aura,
l’arte riproducibile (esteticizzazione dell’arte di massa) e
politicizzata, dall’altro l’arte come pratica della negazione,
come testimonianza di un mondo disumano con cui non è
possibile più alcuna forma superiore di conciliazione. Ma
sono veramente questi i termini dell’antinomia in cui
consiste la morte dell’arte? Secondo me c’è
una preoccupazione eccessiva, in Vattimo, di liquidare le
antinomie della totalità (una totalità buona: Marcuse; una
totalità cattiva: Adorno) semplicemente mettendole a
confronto con una realtà storica attuale che sembra
confutare l’una e l’altra dal momento che l’irriducibilità
delle differenze, dei valori specifici sia dell’arte come
negazione che dell’«arte di massa», non consentirebbe una
perfetta coincidenza degli schemi teorici con le
fluttuazioni empiriche tutt’altro che irrelate e univoche.
Credo che si dovrebbe tentare almeno di reinterpretare i
termini di quest’antinomia in un’ottica diversa: quella, per
esempio, del valore d’uso. Benjamin come Brecht si
domanda: a che cosa serve l’opera d'arte? Non mi pare che
questa domanda debba di per sé implicare una chiusura del
senso dell’arte nel circolo della totalità, sia pure quella, in
ipotesi, utopico-rivoluzionaria. Valore d’uso può significare
considerare l’opera d’arte nella sua adattabilità o meno non
solo all’orizzonte del Potere, ma anche agli appaiati
produttivi funzionali alla logica del Potere. È possibile
una Umfunktionierung di questi apparati e quindi una
distruzione delle basi materiali dell’ideologia già nel modo
con cui si concepisce il fatto estetico? Tutto questo non
equivale certo a instaurare una cultura di massa
manipolata dal potere, dal momento che ci si muove,
almeno intenzionalmente, nella direzione opposta, vale a
dire non in quella di una «esteticizzazione della vita
sociale» (Vattimo), ma di una politicizzazione dell’estetico.
Tuttavia Vattimo potrebbe rispondermi che anche questa
direzione è senza sfondo c naturalmente Adorno potrebbe
fornirgli non una, ma molte buone ragioni di scetticismo. La
questione resta pur sempre quella di accettare o no un
valore d’uso dell’arte in alternativa a un suo valore
contemplativo («cultuale» sia pure fino al limite estremo
della secolarizzazione). Fissare i termini di questo valore
d’uso è indubbiamente problematico: rischia di restringere
ad un programma d’azione determinata, ad uno statuto
politico rivoluzionario quello sterminato campo di
possibilità in cui si esercita sperimentalmente,
senza fissarlo in definizioni progettuali, il valore d’uso
dell’arte. Ma d’altro canto ancorare ad un’ontologia
dell’arte di stampo heideggeriano, come fa Vattimo, la
permanenza del tramonto (non è questo un implicito
richiamo al nascondimento heideggeriano dell’essere?),
significa retrocedere al valore contemplativo-cultuale, sia
pure con la problematicità e i salti di tensione aporetica
dell’avanguardia. Io credo che non dobbiamo temere di
lasciare il nostro discorso privo d’indicazioni positive e
quindi di sottrarre anche il valore d’uso dell’opera d’arte ai
suoi codici umanistico-razionali. Questo valore d’uso
potrebbe benissimo avere qualcosa a che fare con il
carattere paradossale dell’esperienza estetica e quindi con
la paradossale ambiguità del suo simultaneo porsi
all’interno e all’esterno di questo valore
d’uso. Fondamentale mi pare, a questo riguardo, il discorso
di Benjamin sul declino dell’aura. Questo declino, questo
Verfall der Aura, non comprende tanto in sé la
degradazione della comunicazione estetica a fenomeno di
costruzione del «consenso sociale», — come direbbe
Vattimo, — quanto piuttosto il sintomo di una
decentralizzazione irreversibile del significato, vale a dire
una distruzione di un’autonomia del significato (e quindi
dell’«ideologia» estetica) riconducibile ai codici umanistici
della soggettività e del valore. La caduta dell’aura è quindi
solo la figura ex negativo della possibilità costitutiva di
un’esperienza in cui le connotazioni trascendentali della
esteticità sono rovesciate e a cui appartengono
precisamente le antinomie che sembrano negare
quest’esperienza alla sua radice. Anche il valore d’uso,
quindi, che sembra cancellare l’estetico, diventa
paradossalmente una sua segnatura. La cosiddetta
morte dell’arte riguarda dunque la morte di un’esperienza
auratica dell’arte e il tramite per l’esperibilità di un valore
d’uso senza valore. Se si modificano le modalità di
percezione di un’esperienza, si modifica anche il suo
carattere costitutivo. La perdita dell’aura ci fa intendere
che non v’è nulla di costitutivo dell’esperienza estetica al di
fuori del suo valore d’uso, a cui manca ogni carattere di
finalità e d’esemplarità, nel senso che non si definisce in
un telos e neppure aspira a porsi semplicemente come
condanna o giustificazione metafisica dell’esistente. Le
totalità non sono più praticabili e in questo Vattimo ha
ragione. Ma è praticabile lo spazio della morte dell’arte,
lo spazio lasciato libero da questa morte, uno spazio
disumano-distruttivo aperto dal dissolversi dell’aura, la
zona d’ombra dell’aura. In questo senso la morte dell’aura
equivale allo stato alchemico della nigredo necessario alla
trasmutazione ermetica: solo che la direzione a cui tende il
trapasso non può essere preordinata in termini di statuto
estetico o di normatività metaestetica (filosofica,
sociologica ecc). Ciò è dovuto al fatto che l’esperienza
estetica già nel suo destrutturarsi come aura si pone in
rapporto ad un eterno «altrove» di cui esistono solo figure,
funzioni, cifre, proiezioni: essa è il metalinguaggio
paradossale di questo altrove. Questo altrove non può
essere cercato né nel mondo di ieri né in quello di domani e
neppure nel novum incomprensibile di una trasformazione
assoluta dell’esistente. Questo altrove è solo uno strato più
profondo del presente dove si cela l’originario
rapporto erotico — come direbbe Benjamin — tra ciò che è
stato dimenticato e ciò di cui la stessa speranza è
inconcepibile. Vattimo propone con molta sottigliezza di
sostituire al termine «morte» dell’arte il termine
«tramonto». Ritengo che pensi alla parola tedesca
Untergang che si richiama semanticamente al suo opposto
Aufgang. Ma alla luce di quanto ho detto credo che il
termine forse più appropriato potrebbe essere Vergehen: la
morte dell’arte è in realtà il Vergehen, il trapassare
dell’aura, un trascorrere che è proprio di tutte le cose
effimere. Tuttavia l’arte, che è una di queste cose, afferra
in questo trapassare, in questo suo porsi come ciò che
trapassa e che muore senza morire (ma muore sempre)
l’insopprimibilità delle sue postulazioni immanenti e delle
sue proposizioni antinomiche, la sua esigenza di far valere
l’impossibile come suo valore d’uso. Si
potrebbe comprendere di qui come il carattere affermativo
dell’opera d’arte sia fatto di negazioni e come anche la
stessa testimonianza del dolore sia solo la maschera di un
desiderio inconsumabile di felicità. La morte dell’arte o
meglio il suo trapassare, per cui ogni declino o caduta
dell’aura genera altre figure, è solo un modo indiretto
per sottolineare la costitutiva paradossalità di
un’esperienza che nella sua gratuità ci lega a una
responsabilità immensa non verso i mondi iperurani, ma
verso la nostra realtà storica, e che nel suo «qui» e «ora»
rimanda insistentemente a un «altrove», ad un eterno,
sconfinato «altrove».
* Comunicazione tenuta al seminario Situazioni e intenzioni della
ricerca estetica oggi in Italia, Istituto Antonio Battìi, Reggio Emilia, 16-17
novembre 1979.
1 W. Benjamin, Baudelaire a Parigi, in Angelus Novus, trad. it. di R.
Solmi, Torino, 1962, p. 120.
2 W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit (d'ora innanzi K.Z.t.R.), in Gesammelte Schriften, 6
vv., a cura di R. Tiedemann e H. Schweppenhauser, Frankfurt a.M., 1972
sgg., 1-2, p. 479.
3 Ivi, p. 480, n. 7; W. Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua
riproducibilità tecnica, trad. it. di E. Filippini, Torino, 1966, p. 49, n. 8 (si
cita questa traduzione con qualche ritocco).
4 R. Tiedemann, Studien zur Philosophie Walter Benjamins,
Frankfurt a.M„ 1973, pp. 117418.
5 W. Benjamin, Über einige Motive bei Baudelaire, in G.S., 1-2, p.
653; W. Benjamin, Baudelaire e Parigi cit., 126.
6 Über einige Motive bei Baudelaire, cit., ivi; Baudelaire a Parigi cit.,
ivi.
7 W. Benjamin, L’opera d’arte, cit., p. 28; K.Z. t. R., p.23.
8 Baudelaire a Parigi, cit., p. 120.
9 Ibidem.
10 H. V. Hofmannsthal, Ein Brief, in Gesammelte Werke, Prosa II,
Frankfurt a.M., 1959, p. 13; La lettera di Lord Chandos, in Viaggi e
saggi, trad. it. di L. Traverso, Firenze, 1958, pp. 45-46.
11 «Seguire, in un pomeriggio d’estate, una catena di monti
all’orizzonte oppure un ramo che getta la sua ombra sopra colui che si
riposa — ciò significa respirare l’aura di quelle montagne, di quel ramo»,
L’opera d’arte, cit., p. 25.
12 W. Benjamin, Il surrealismo. L’ultima istantanea sugli intellettuali
europei, in Avanguardia e rivoluzione, trad. it. di A. Marietti, Torino, 1973,
p. 13. La traduzione italiana a causa della mancanza della virgola è quanto
mai equivoca: il testo tedesco è peraltro chiarissimo: «Die wahre,
schöpferische Überwindung religiöser Erleuchtung [...]», Der
Surrealismus, in G.S., II-1, p. 197.
13 Il surrealismo, cit., p. 23.
14 Ivi, p. 15.
15 Ivi, p. 22.
16 W. Benjamin, G.S., 11-3, p. 1102. Cfr. il commento di B. Lindner
a questo passo: Technische Reproduzierbarkeit und Ruiturindustrie
Benjamins «Positives Barbarentum im Kontext», in Links hatte noch alles
sich zu enträtseln... Walter Benjamin im Kontext, a cura di Burkhardt
Lindner, Frankfurt a.M., 1978, p. 197.
17 W. Benjamin, Schriften, 2 vv., a cura di Th. W. Adorno e G.
Adorno, Frankfurt a.M., 1955, I, p. 418.
18 W. Benjamin, Illuminationen, Frankfurt a.M., 1961, p. 402.
19 Il surrealismo, oit., ρ. 23.
20 W. Benjamin, Il carattere distruttivo, trad. it. di Piera Di Segni,
in Metaphorein, 3 (1978), p. 11.
21 W. Benjamin, Esperienza e povertà, ivi, pp. 14-15 (trad. it. di
F. Desideri).
22 W. Benjamin, Versuche über Brecht, a cura di R. Tiedemann,
Frankfurt a.M., 1971, p. 9.
23 W. Benjamin, Eduard Fuchs, Il collezionista e lo storico, in 1,'opere
d'arte, cit., p. 92.
Potrebbero piacerti anche
- (Saggi) Benjamin, Walter - L'opera D'arte Nell'epoca Della Sua Riproducibilitã Tecnica. Con Un Saggio Di Massimo Cacciari (Einaudi) - Libgen - LiDocumento137 pagine(Saggi) Benjamin, Walter - L'opera D'arte Nell'epoca Della Sua Riproducibilitã Tecnica. Con Un Saggio Di Massimo Cacciari (Einaudi) - Libgen - LiNiccolòNessuna valutazione finora
- Opera D'arte Riproducibilità TecnicaDocumento23 pagineOpera D'arte Riproducibilità Tecnicaaurora.sanfeliciNessuna valutazione finora
- Il Silenzio Dell'arte, Tra Mistica e InterpretazioneDocumento9 pagineIl Silenzio Dell'arte, Tra Mistica e InterpretazionebritocostaNessuna valutazione finora
- Sindrome CineseDocumento7 pagineSindrome Cinesedavide ranesiNessuna valutazione finora
- Atque 5 5Documento12 pagineAtque 5 5Giuseppe Pan Di StellaNessuna valutazione finora
- Termini Da COSTELLAZIONI (Walter Benjamin)Documento12 pagineTermini Da COSTELLAZIONI (Walter Benjamin)davide ranesiNessuna valutazione finora
- Forma e Forza: Cinema, soggettività, antropologiaDa EverandForma e Forza: Cinema, soggettività, antropologiaNessuna valutazione finora
- Il Fantasma Dell'OperaDocumento30 pagineIl Fantasma Dell'Operastryc9Nessuna valutazione finora
- Dove Lei Non È. L'indirizzo Utopico Della Nostalgia AutoritrattisticaDocumento4 pagineDove Lei Non È. L'indirizzo Utopico Della Nostalgia AutoritrattisticaGiacomo CoggiolaNessuna valutazione finora
- Aesthetica in Nuce Benedetto Croce 1928 PDFDocumento9 pagineAesthetica in Nuce Benedetto Croce 1928 PDFThomas RamírezNessuna valutazione finora
- De Santi - ALBERTO SUGHI E LO SCHERMO DANTESCODocumento6 pagineDe Santi - ALBERTO SUGHI E LO SCHERMO DANTESCORoberto MonachesiNessuna valutazione finora
- Teoria EsteticaDocumento29 pagineTeoria EsteticaGiuseppe FrasceNessuna valutazione finora
- Aprire Venere - RiassuntoDocumento6 pagineAprire Venere - RiassuntosilviaNessuna valutazione finora
- Genet Teatro ParadossoDocumento18 pagineGenet Teatro ParadossoPierrot le FouNessuna valutazione finora
- 13 Fanta - JINDRICH PILECEKDocumento3 pagine13 Fanta - JINDRICH PILECEKFantafestivalNessuna valutazione finora
- ANAMORFOSIDocumento2 pagineANAMORFOSILeonardo CappucciniNessuna valutazione finora
- MalinconiaDocumento34 pagineMalinconiaugglorNessuna valutazione finora
- A Occhi ChiusiDocumento5 pagineA Occhi ChiusicarolinaNessuna valutazione finora
- FLORENSKIJ L'Icona Come Metafisica Concreta-2011Documento84 pagineFLORENSKIJ L'Icona Come Metafisica Concreta-2011brunomorabito100% (1)
- La Poetica Del BaroccoDocumento8 pagineLa Poetica Del BaroccoMarco MillucciNessuna valutazione finora
- Aesthetica in Nuce Benedetto Croce 1928 PDFDocumento9 pagineAesthetica in Nuce Benedetto Croce 1928 PDFGeovani ParenteNessuna valutazione finora
- Agamben Uomo Senza ContenutoDocumento87 pagineAgamben Uomo Senza Contenutolakosepamti1911100% (2)
- Agamben Juan de La CruzDocumento4 pagineAgamben Juan de La CruzMélanie HallNessuna valutazione finora
- Leopardi TestiDocumento14 pagineLeopardi TestiRosannaNessuna valutazione finora
- Fra Oscurità e Autocoscienza. Nota Su Montale Poeta - CriticoDocumento9 pagineFra Oscurità e Autocoscienza. Nota Su Montale Poeta - CriticoMatteo Veronesi100% (2)
- Testo#1. Bazin - Ontologia Dell'immagine FotograficaDocumento10 pagineTesto#1. Bazin - Ontologia Dell'immagine FotograficaisaNessuna valutazione finora
- Arthur RimbaudDocumento2 pagineArthur RimbaudJoshua CrucianoNessuna valutazione finora
- Carmelo Bene Laddove L Atto Strazia L AzDocumento10 pagineCarmelo Bene Laddove L Atto Strazia L AzDitirambi di DionisoNessuna valutazione finora
- Immagini X SchopenhauerDocumento67 pagineImmagini X SchopenhauerbrunomorabitoNessuna valutazione finora
- Appunti Sul BaroccoDocumento4 pagineAppunti Sul BaroccoVittorio VelucciNessuna valutazione finora
- Bachelard Gaston La Poetica Dello SpazioDocumento279 pagineBachelard Gaston La Poetica Dello SpazioSeraveer100% (1)
- G. Di Giacomo Nietzsche e La Cultura Del Novecento, in Medicina Nei Secoli. Arte e Scienza, 31, 2, 2019, Pp. 299-318Documento20 pagineG. Di Giacomo Nietzsche e La Cultura Del Novecento, in Medicina Nei Secoli. Arte e Scienza, 31, 2, 2019, Pp. 299-318Giulia SicilianoNessuna valutazione finora
- MariopezzellaDocumento13 pagineMariopezzellaMario PezzellaNessuna valutazione finora
- L Occhio e Lo Spirito Dell Utopia ErnstDocumento9 pagineL Occhio e Lo Spirito Dell Utopia Ernstlukas englaroNessuna valutazione finora
- Carmelo Bene o Lo Splendore Del Vuoto Di C.DumouliéDocumento5 pagineCarmelo Bene o Lo Splendore Del Vuoto Di C.DumouliéRosarioNessuna valutazione finora
- Spazi Metafisici Di Giorgio de ChiricoDocumento8 pagineSpazi Metafisici Di Giorgio de ChiricoElisa TrivelliniNessuna valutazione finora
- Beierwaltes Werner AtteoneDocumento6 pagineBeierwaltes Werner AtteonenirgunaNessuna valutazione finora
- Un'arte Per I SensiDocumento37 pagineUn'arte Per I SensiCarmelo PierroNessuna valutazione finora
- Decadentism oDocumento7 pagineDecadentism omartaNessuna valutazione finora
- Spettri Di Cage PDFDocumento8 pagineSpettri Di Cage PDFAntonello ColimbertiNessuna valutazione finora
- Come Si Legge Un'opera D'arteDocumento57 pagineCome Si Legge Un'opera D'arteSilvia Stefanini100% (1)
- Vitilio Masiello: Pirandello: L'Identità NegataDocumento9 pagineVitilio Masiello: Pirandello: L'Identità NegataBruna GulinoNessuna valutazione finora
- Kierkegaard - Estetica Del Don GiovanniDocumento4 pagineKierkegaard - Estetica Del Don GiovannikierkegardNessuna valutazione finora
- Gérard Genette - Immanenza e Trascendenza - RiassuntoDocumento44 pagineGérard Genette - Immanenza e Trascendenza - RiassuntoLauraNessuna valutazione finora
- Heidegger - Dell'origine Dell'opera D'arteDocumento76 pagineHeidegger - Dell'origine Dell'opera D'arteGianricoGualtieriNessuna valutazione finora
- Il Ready Made Di Marcel Duchamp - Teoria Dell'Indifferenza VisivaDocumento21 pagineIl Ready Made Di Marcel Duchamp - Teoria Dell'Indifferenza VisivaLeonardo Shark-Ind PedronNessuna valutazione finora
- Arte e FilosofiaDocumento2 pagineArte e FilosofiaSofia TapinassiNessuna valutazione finora
- L'Opera D'arte Nell'Epoca Della Sua Riproducibilità TecnicaDocumento12 pagineL'Opera D'arte Nell'Epoca Della Sua Riproducibilità TecnicaAngela SahidNessuna valutazione finora
- Presentazione 7Documento19 paginePresentazione 7danaelNessuna valutazione finora
- 1Documento7 pagine1Erika TemperinoNessuna valutazione finora