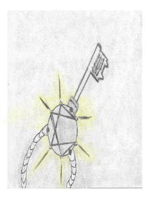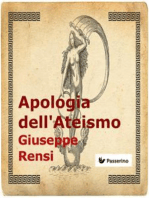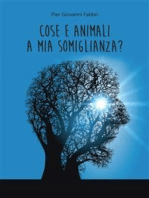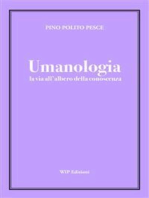Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Riassunti Libri Estetica
Caricato da
Raffaella Vitale0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
82 visualizzazioni20 pagineTitolo originale
riassunti libri estetica
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
82 visualizzazioni20 pagineRiassunti Libri Estetica
Caricato da
Raffaella VitaleCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 20
“Pensare il nulla”
La genitura, il nulla, l’essere
A questo punto del discorso dovremo chiarire il significato delle seguenti parole:
pensiero, senso e genitura.
SENSO
La dizione “senso” vuol dire: “aver già preso una direzione” “stare già su un
cammino”. Il senso non è soltanto ridotto ad un valore semantico, ma innanzitutto è
l’elemento entro cui quel qualcosa si stanzia per essere ciò che é; si tratta però di un
elemento che non è mai indipendente dall’essere dell’uomo. Anzi, è proprio l’uomo
ad avere il compito di custodire il senso, pena la devastazione del suo essere. La
parola “senso”, quindi, permette di capire la relazione fra l’essere pensante e le res,
intese come essenti già affrancati da ogni forma di contingenza (definiti perciò
speranti). Quando diciamo uomo non intendiamo l’isola soggetto fra gli oggetti, ma
ogni volta ciascuno di noi nel suo essere, per indole nativa, con gli altri (in un mondo,
con un mondo e per un mondo).
Ogni sperante, anche la res più insignificante, sta sul proprio cammino, ha il proprio
senso e anche noi stiamo su un cammino, lungo il quale presagiamo ogni volta uno
spazio-di-tempo in cui abitare.
Quindi abbiamo capito che l’uomo è, per indole, colui che non può ritrarsi dal
compito di custodire il senso: potremmo proprio dire che è il sentimento senso a
concedere il senno all’uomo (dove sentire significa cogliere una res in modo da
poterla custodire come sperante lungo il suo cammino).
Comprendiamo subito che il senso non è qualcosa di chiaro e flagrante; anzi, esso è
normalmente ritratto, tende a restare “sullo sfondo”: in altre parole, non è nulla di
ordinario o quotidiano, nulla di contingente.
PENSIERO
Pensare significa innanzitutto “sentire il senso”, ma per sentire il senso bisogna
prima accorgersi del suo ritratto integro attendibile vigore e questo accorgersi sta
nella dimensione dello scorgimento. Infatti, che vi “sia” del senso (e che esso vi sia
unicamente là dove si stanzia l’essere-uomo), ebbene questa è una circostanza che
per sussistere ha bisogno unicamente di uno scorgimento originario.
Il sentimento, libero dal sentimentale, è per noi l’azione propria del sentire. Così
l’uomo è l’essere pensante in quanto è innanzitutto l’essere del sentimento. Non vi
potrebbe essere alcuna pura sensazione corporea, né soggetti, né oggetti, né
giudizi, né risorse se non si stanziasse per l’uomo, nell’uomo e con l’uomo,
quell’originario sentimento consistente nel libero sentire il senso.
GENITURA
Con la parola “genitura” si intende l’originarsi del senso, libero da ogni relazione fra
soggetto e oggetto (non vi sono infatti cause ed effetti, né soggettivazioni ed
oggettivazioni). Piuttosto, la genitura flagra come un’improvvisa ricchezza, una
singolare ricchezza di senso: insomma la sorgente di ogni attendibile relazione tra
noi e l’ente. La vicinanza tra noi e le res si genera, ossia è generata per indole e
quindi è ab origine generosa e generante. Se ci chiediamo da dove si generi quella
vicinanza, non troviamo “nulla”: è una vicinanza genuina, è la grazia stessa, è
l’indole che dona senza chiedere niente in cambio, se non il più libero
ringraziamento (completamente slegato dall’utile e dall’efficace). In altre parole, la
genitura è nulla: questo nulla che caratterizza il generarsi, però, non è quello del
nichilismo (che mai si interroga circa la provenienza del suo nihil), ma è il nulla
stagliante al quale ci affidiamo quando diveniamo ciò che sempre siamo, ovvero
quando diventiamo degli esseri pensante.
Il senso-mondo si genera nell’uomo, per l’uomo e con l’uomo, così che egli si trovi
già sempre nella genitura; ora, però, questo trovarsi che non può non rispondere al
gratuito generarsi può restare non considerato. Infatti, la perenne necessaria gratuita
genitura del senso, come tratto di fondo dello stanziarsi dell’uomo, può essere
interamente trascurata dall’uomo stesso, fino a quanto la stessa trascuratezza della
genitura è trascurata. Si parlerà allora di oblio: un oblio in cui l’uomo e come scisso
proprio da ciò che lo concerne intimamente. L’oblio del senso-mondo si accompagna
al misconoscimento del nulla: infatti, là dove si genera un tale oblio, il nulla appare
definitivamente come la mera negazione di tutto. La genitura, invece, non scompare,
non viene annientata, ma subisce una deformazione.
L’odierna genitura è tale per cui i suoi abitanti sono potentemente spinti ad
assumere, sempre più decisamente, una posizione per la quale il senso stesso sia
escluso da ogni considerazione, e resti non pensato, e quindi non sentito. La natura
appare solo come una riserva d’energia, un fondo di risorse, lasciandosi quindi
cogliere come un campo tecnicamente controllabile: la grazia, dunque, non ha più un
luogo entro cui mostrarsi e splendere. Ciò che si genera è una sorta di enigmatica e
violenta dissensione fra la natura tecnicamente controllabile e la natura del
soggiorno abituale, il quale resta necessariamente improntato alla gratuita genitura
del senso. Genitura ora significa il generarsi del senso sia nella modalità dell’intima,
sorgiva rigenerazione, sia nella modalità della devastante degenerazione.
Il nulla, nell’odierna genitura, deve restare via dal sapere, deve apparire o come uno
scandalo o come una follia nichilista (e ricordiamo che con nichilismo intendiamo il
completo misconoscimento del niente e del nulla).
Indichiamo ora alcuni tra i capisaldi dell’odierna genitura del senso:
1. l’uomo nel format della risorsa umana.
2. il dominio del pensiero computante e il carattere computabile della natura.
3. la verità in termini di performatività.
4. la lingua come strumento di informazione e mezzo di comunicazione.
5. Dio come bisogno di spiritualità.
6. la genitura odierna come occasione per esperire l’insidia e la tentazione che
minacciano il senso.
Alla fine del nostro discorso possiamo capire che, anche nella nostra epoca, bisogna
restare figli del senso, capaci di insistere e resistere in esso, e di tentare, quando
necessario, le parole per la grazie, le parole di gratitudine nei confronti del nulla.
Pensare, infatti, significa ringraziare.
L’intesa greca dell’essere
L’essere, in senso greco, non è affatto l’idea più ovvia e scontata, o il più generico e
generale concetto, ma è ciò che resta sempre degno del più ampio interrogare. Dire
che qualcosa è accaduto in grazia di qualcos’altro crea un rapporto di gratuità-
gratitudine, un rapporto senza crediti e debiti. “In grazia” significa allora “per
concessione costituente-temprante”. Che un ente ringrazi l’essere vuol dire che
nella sfera d’integrità in cui abita l’uomo, l’ente ha potuto raggiungere la capacità di
manifestare la propria gratitudine nei confronti dell’essere.
L’ente-utensile ci può venire incontro in tre modalità:
- come oggetto contingente, se assume l’aspetto del constatabile;
- come vero e proprio utensile se viene effettivamente adoperato;
- come un interrogandum qualora sia pensato in quanto utensile.
Nell’interrogare l’essere, miriamo all’elemento che più originariamente governa e
regola il nostro intendere e agire. Il materiale di costruzione e il meccanismo hanno
solo l’apparenza dell’originarietà; essi, infatti, possono mutare a seconda della
modalità in cui l’elemento originario fa già da guida e dà la misura. Così materiale e
meccanismo, visto che sono a loro volta degli enti, appartengono all’essere, senza
mai poterlo costituire. Inoltre, ridurre lo stato d’essere alla servibilità dell’ente-
utensile è un risposta estremamente insufficiente. L’utilità o la servibilità non sono
affatto i tratti originari dell’essere; essi sono piuttosto dei tratti derivati, dei tratti che
trovano la loro attendibilità nell’essere originario. Siamo giunti quindi ad un punto
chiaro: mediante l’ente-utensile, siamo affidati alla parola e, così affidati, possiamo
fidarci l’uno dell’altro e fare affidamento sul nostro mondo, sull'intesa che in esso
ogni volta raggiungiamo o non raggiungiamo, sul dialogo o sul colloquio che
riusciamo noi stessi a d ergere. Alla luce dello scisma, e guardando ora un ente-
utensile qualsiasi si può dire che l’essere, al di là di ogni utilità ed efficacia, se ne sta
lontano dall’ente-utensile stesso. Solo che tale lontananza non è una distanza
concreta, ma il segno che l’essere in quanto tale rimane libero e fermo nella sua
gratuità. Possiamo chiamare tale essere fidatezza: la fidatezza si fonda sulla
simultaneità costitutiva che intercorre tra il potersi fidare del proprio mondo e il
reciproco affidamento. Tra ente-utensile e fidatezza si stanzia un’originaria armonia,
che nessuna fattuazione potrà mai annientare.
L’utensile, in quanto essente, è la fidatezza stessa. La fidatezza quindi è l’essere
dell’utensile poichè guida, con gratuità, il senso dell’utile e del servibile. L’utilità
improntata alla fidatezza, cioè l’utilità per fidatezza, non può essere confusa con
l’utilità incondizionata, l’utilità per l’utilità, l’utilità fondata in se stessa. La fidatezza
caduta sotto il giogo dell’utilità assoluta si trasforma nell’affidabilità (dove vigono i
tratti dell’assicurazione, della potenza e della funzionalità). L’utilità usurpa la
fidatezza e la perverte in affidabilità.
Un ente naturale si configura variamente, ma resta sempre affidato all’indole nativa:
se non si stanziasse quest’indole incline a configurarsi, non sussisterebbe l’ente.
Questa configurarsi dell’indole è un moto, una motilità, di cui noi uomini siamo
esperti. L’essere viene da noi scorto come un’indole indolicamente incline a
configurarsi; l’ente poi si stanzia per noi proprio in grazia di tale essere. Parliamo
allora di affidamento indolico perché l’affidarsi insito nell’ulivo consiste proprio nel
fatto che esso non può mai superare tale sua semplice indole. Chiamiamo quindi il
moto consistente nell’inclinazione-a-configurarsi “motilità configurativa
dell’affidamento indolico”.
Alla luce della motilità dell’affidamento indolico, un utensile si mostra come qualcosa
che non si muove per indole nativa, ma piuttosto sta nella e per la fidatezza
dell’abitare. Se si guarda in profondità, però, in tale stare vigono due movimenti
costitutivi. Quindi lo stare dell’ente-utensile nella e per la fidatezza non è uno stato di
quiete, ma è una motilità, la quale consiste nella fugacità originaria di questi due moti
(uno produttivo e l’altro esecutivo). Chiamiamo tale fugacità originaria, che si stanzia
ogni volta sotto forma di un fidato utensile per l’uomo, la motilità produttivo-esecutiva
della fidatezza.
Abbiamo quindi individuato due motilità: esse sono costitutive (perché costituiscono i
cardini di ogni abitare umano), ma tra loro si trovano in una contesa che non può mai
essere né risolta, né annientata. Essere-uomo significa insediarsi nella contesa per
ricavarne ogni volta uno spazio-di-tempo per l’abitare.
“Lingua pensiero canto”
La lingua sparge sempre dei semi che il pensiero custodisce affinché germoglino. La
parola non è solo linguaggio: in essa sentiamo soprattutto l’affidare, il progettare, ma
anche il tralasciare e il gettare nella minaccia; la benedizione e la maldicenza.
Guardiamoci, però, dal confondere la lingua madre con la lingua di tutti i giorni.
Goethe ricorda la scissura tra la lingua quotidiana e la lingua poetica: la lingua
stessa è incline a parlare su un piano e in una dimensione che non le si addicono. Il
“vivere d’impatto” affronta sempre contingenze che assumono il carattere
dell’effettivo e del reale; tuttavia non appena l’uomo sia costretto a tornare là dove
già sempre abita (nello scisma d’essere), allora non può che incontrare la lingua
madre nella sua originaria versione poetico-dettatica. La lingua si staglia innanzitutto
nella poesia. La lingua poetica è lingua madre: solo nel canto, infatti, essa si mostra
in piena trasparenza di tempra.
Lingua nel pensiero del canto.
“Il dictum di una parola viene quasi sempre infirmato, spento e soffocato proprio
mediante i suoi significati”.
La lingua e l’informazione
L’ESSENZA E L’INDOLE
L’essenza è solo l’astratto contrapposto al concreto? L’essenza sembra essere quel
quid che l’uomo strappa alle cose incontrate e percepite nel vissuto per poi
ricostruirlo in un concetto generale, il quale sarebbe sempre soltanto un mero
riflesso del flusso della vita. Tuttavia resta la questione del come, del dove e del
quando accadrebbe tale astrarre dell’umano conoscere.
Tuttavia Platone insegna che possiamo incontrare e percepire alberi e montagne
poiché conosciamo già l’essenza “albero” e l’essenza “montagna”: semplicemente
dimentichiamo questo “aver già conosciuto” e così crediamo di ottenere tali essenze
per astrazione dai singoli impatti vissuti.
Ma cosa significa “essenza” a livello originario?
“Essenza” è formata sul participio essente, e ne indica lo stato nel suo modus.
“Essenza” è il modus di stanzietà dell’essente, ma il modus è la misura e la
moderazione (dove udiamo i ratti della tempra geniturale). “Essenza” significa
geniturale tempra d’essere cui l’uomo, adergendola, è intraneo qualunque sia il
senso d’essere. In altri termini: “essenza” parla l’essere, intonandolo come l’alimento
e il nutrimento d’origine del sostante aver luogo degli speranti. Comunque per poter
assumere questo significato originario, l’essere deve sempre essere inteso
dall’uomo. L’essenza dice dunque l’attesa della verità dell’essere sul fondamento
della sua previa intesa.
Fino ad ora abbiamo delineato il senso iniziale e originario dell’essenza, ma è
importante sottolineare che dal punto di vista metafisico, invece, l’essenza è l’essere
dell’essente. “Essenza” comprende due dizioni libere dall’impronta metafisica: il
sostantivo “indole” e il verbo “stanziarsi”. Entrambe le parole indicono l’essere senza
alcun riferimento all’ente.
L’essenza è l’indole e l’indole è lo stanziarsi dell’intesa d’essere per l’attesa della sua
verità. Seguendo il filo di questi scorgimenti, notiamo che la loro attendibilità è offerta
dalla lingua madre. La lingua, nell’essenza, pensa l’indole e, nell’indole, sente
l’essenza. L’indole della lingua madre si stanzia dunque come lingua d’attesa della
verità dell’essere. Nella forma “lingua madre” sentiamo dunque innanzitutto il tocco
d’essere verso gli speranti.
IL FORMAT DELLA LINGUA
Nel concetto ordinario, è posta in forma l’indole stessa della lingua nel senso della
contingenza; essa è insomma contingentata, addotta in un format basato
sull’attestarsi dell’essere in valore alla luce del suo affermarsi come potenza.
In questi termini, la lingua rinvia all’articolazione vocale del linguaggio, termine che
indica un’attitudine essenziale della mente umana e quindi del cervello. La lingua è il
sistema strutturato dei processi linguistico-comunicativi. Tale processo funziona nel
seguente modo: il mittente formalizza dei significati, contestualizzati, del codice di
una data lingua, in un messaggio, che egli, attraverso un contatto, trasmette al
destinatario.
La lingua, in quanto indirizzata al processo comunicativo, impone che il parlare sia
efficace. Emergono così le cosiddette funzioni costitutive del linguaggio: l’espressiva
o l’emotiva, la referenziale e la conativa (cosiddette funzioni base), la fàtica, la
metalinguistica e la poetica. Tutte queste funzioni poi operano, secondo diverse
proporzioni, in ogni atto linguistico efficace; è raro che un messaggio assolva a
un’unica funzione.
La lingua, in quanto sistema comunicativo-fattoriale-funzionale, presenta una varietà
di forme e di modalità. La lingua sarà intesa quindi come un sistema di elementi,
combinabili secondo opportune leggi accettate e condivise dai membri di una data
collettività; la parola sarà invece il modo in cui ciascun membro parla e articola il
comune codice linguistico. Così ogni elemento della lingua sarà per l’appunto un
segno: quel farsi suono di un’idea che ogni volta il singolo fa suo e usa. Ogni segno
linguistico consiste nella relazione tra il significante e il significato.
La lingua e la parola costituiscono un apparato simbolico. Il carattere più essenziale
del linguaggio è infatti proprio la capacità di simbolizzare la realtà, ossia la sua
attitudine a rappresentarla e a riprodurla. Il segno linguistico diventa quindi il
fondamento e l’origine di ogni umana pratica simbolica.
L’odierno forma della lingua può allora enunciarsi così: la lingua è la facoltà di
esprimersi per mezzo della parola. Tale linguaggio è il complesso di segni linguistici,
elaborato convenzionalmente nell’ambito di una comunità umana, al fine di palesare
il nesso tra un’immagine fonica o grafica e il significato di un dato reale o/e ideale.
LA PRESTANZA DEL SEGNO
La lingua è quella facoltà espressiva che, mediante un’opportuna notazione segnica,
serve agli esseri umani per comunicare tra loro. La lingua è un mezzo alla
soddisfazione dell’umano bisogno di comunicazione. La comunicazione deve ora
apparire innanzitutto solo come trasmissione e scambio di impatti vissuti mediante
messaggi codificati in segni.
Così, nel regime dell’incoalescenza, il segno non è più l’indice che afflagra l’indole e
la custodisce in luce per l’uomo, ma è ciò che fissa la fattuale datità del contingente
per l’impatto e quindi la rinforza, la conferma, la assicura, nel suo spettare, in quanto
valore, unicamente alla potenza.
Chiamiamo “prestanza” tale modalità degenerativa del segno: la prestanza del
segno, la sua disponibilità a prestarsi al potenziamento è il tratto di fondo e quindi il
vero nome dell’odierno concetto della lingua madre. Si può parlare di una
incondizionata formatazione del dire: una disputa destinata all’inattendibilità in cui i
dibattiti non potranno mai toccare e scuotere la forma del conoscere propria di ogni
disciplina. Chiamiamo le scienze e le discipline linguistiche “le fabbriche del
linguaggio”.
Per queste scienze umane, l’uomo è un tipo particolare di essere vivente: l’uomo si
distinguerebbe dagli altri viventi perché ha la facoltà del linguaggio articolare, ormai
inteso non solo come la capacità di esprimere e simbolizzare la realtà ma
innanzitutto come un mezzo del pensiero.
La formatazione della lingua mediante la prestanza del segno richiede che la lingua
stessa sia assunta come un arto dell’uomo, come una protesi dell’impatto vissuto:
chiameremo questo impatto “ominazione”.
La lingua ominizzata diviene un oggetto della scienza cognitiva: essa è una sub-
super-scienza che costituisce una tecnica di indagine destinata a superare le
fabbriche del linguaggio effettuando l’estremo asservimento dell’uomo alla
fattuazione.
L’INFORMAZIONE
La sub-super-scienza implementa all’estremo la cogenza informatica e i tre format
della cibernetica: il pilotaggio, il retro-abbinamento e l’informazione. La cogenza
contiene una decisione: vale come effettivo solo ciò che è scientificamente
dimostrabile e legittimabile, ossia computabile. La cogenza del metodo scientifico
(che non è altro che la computabilità di tutto ciò che è accessibile e verificabile
nell’esperimento) si dispiega oggi nelle sue estreme attendibilità e potenze nella
forma della cibernetica.
Nel mondo addotto in senso cibernetico svanisce la scissura tra le macchine
automatiche e gli esseri viventi. A tale uniformità del mondo cibernetico viene istruito
anche l’uomo.
La scienza cognitiva diviene dunque l’accennata sub-super-scienza grazie al senso
compiutamente cibernetico del suo format guida: l’informazione.
La lingua, come arto dell’uomo, come protesi dell’impatto vissuto, diviene adesso un
“fenomeno naturale”: la normale esternazione di un organismo, la spontanea
espressione di un essere vivente.
Possiamo esplicitare quindi che la lingua è informazione.
L’informazione, nella sua originaria accezione, è il lasciar crescere l’uomo nella
flagranza dell’essere entro la lingua madre. Nel senso dell’ominazione, invece,
“informazione” significa sagomatura di un certo contenuto, già dato anche
indipendentemente dalla lingua, in modo che sia immediatamente scambiabile e
trasferibile.
L’informatizzazione della lingua, ultimo stadio della sua formatazione in linguaggio,
comporta alcune assunzioni sull’essenza del concepire e sull’attendibilità del dire. Il
concetto, prima di tutto, deve essere inteso come un computo cognitivo-cerebrale
avente la proprietà di assumere differenti sagome fonetiche al variare delle lingue. I
concetti vengono presentati quindi come delle costanti pre-linguistiche. La lingua, in
questi termini, diventa una scorta di valori, di segni, di simboli sempre pronti all’uso.
Un segno, quindi, appare come attendibile solo quando sia determinatamente
riferibile a un certo dato.
La scienza cognitiva e la lingua
Nel nome “scienza cognitiva”, i significati dei termini “scienza” e “cognizione” sono
mutuati dalla fisica matematica e dalla teoria dell’informazione: “scienza” significa
osservazione del dato e adduzione del suo funzionamento contingente; “cognizione”
invece significa elaborazione delle informazioni.
Scienza cognitiva vuol dire “computante modellamento dell’informazione quale dato
già colto nel suo causare effetti vitali e psichici. Tutto questo si basa su una serie di
format molto forti: la verità intesa come performatività, l’essere inteso come
potenza…
L’INFORMAZIONE E IL SENSO
La scienza cognitiva è al servizio della fase estrema del decorso geniturale
dell’epoca. Essa, senza poterne avere alcuna consapevolezza, sperimenta e
conosce la lingua come la primaria forma umana della volontà per la potenza. La
lingua è qui progettata come attuazione della funzione biologica del linguaggio,
inteso come mezzo di potenziamento della forza vitale. In questi termini, ciò che
distingue l’uomo dagli altri essere viventi è un “sovrappiù di linguaggio”: “sovrappiù”
significa maggiore potenza nella conservazione e nell’accrescimento
dell’informazione.
Se ogni significato è informazione allora, l’intero senso è assunto nel circuito della
potenza quale suo mezzo di implementazione. Solo la potenza ha senso: questo
dice in verità il termine “informazione”. Quel senso che non sia immediatamente
formatabile sarà allora privo di verità, sarà solo un senso apparente, un non-senso o
un’insensatezza.
LA MENTE E IL PENSIERO
La scienza cognitiva tratta la lingua come un fenomeno della mente. In questo
discorso il pensiero è la risposta allo stimolo, o meglio, è la reazione bio-fisico-
mentale all’impatto dell’informazione. Si afferma allora l’idea che il pensiero, già
affrancato dalla lingua madre, non abbia una “natura concettuale”. Sotto le
sembianze di una battaglia culturale o di una comprensione della diversità bio-
cognitiva, si nasconde un format: l’uomo e l’animale devono essere assicurati come
bio-programmi esecutivi dell’informazione. Tale format sta alla base dell’altro format
necessario: quello dell’uomo inteso come animale sociale attivo, come animale da
lavoro, ossia come “risorsa umana”.
IL PRE-LINGUISTICO
La scienza cognitiva si sostiene sull’assunto della “cognizione pre-linguistica”,
assunto che fossa la lingua in linguaggio, in mezzo o protesi dell’impatto. Una delle
modalità di tale cognizione è la cosiddetta cognizione sociale, il cui principale
elemento è la mentalizzazione.
Nella cognizione sociale, alcuni dei tratti costitutivi dello stanziarsi dell’uomo sono
contingentati in modo che ogni rinvio all’indole “essere” sia infirmato e così
mantenuto nell’oblio. La mentalizzazione infirma l’umana preintesa d’essere quale
condizione d’attendibilità di ogni contegno con l’ente e quindi con la contingenza;
essa lascia infatti supporre che l’ente sia innanzitutto un costrutto cerebrale che
deve essere letto e decodificato informaticamente.
Ma le infirmazioni più gravi si consumano nell’autocoscienza: essa sfigura quel
modo d’essere dell’uomo che consiste nell’adergere esplicitamente la nativa
preintesa d’essere, nell’esistere all’interno della lingua madre. Si mostra così ancora
più nettamente l’infirmazione della lingua perpetrata dalla sua riduzione a linguaggio:
in essa l’uomo cibernetico, incline alla potenza, diventa un animale sociale attivo, o
meglio una risorsa umana.
LA NATURALIZZAZIONE
La scienza cognitiva è oggi guidata da una teoria che persegue un obiettivo di fondo
chiamato “naturalizzazione del pensiero” e retto dall’assunto che la mente sia un
centro di calcolo e di computo. Avere una mente significherebbe allora disporre di un
apparato capace di computare delle rappresentazioni informative. Così la mente non
è niente di spirituale o di immateriale: essa è il farsi e il disfarsi della materia, cioè,
nel caso dell’animale “uomo”, del corpo cerebrale nell’impatto con la contingenza. La
naturalizzazione è in questo modo una definitiva resa dei conti con la filosofia.
Secondo chi porta avanti la teoria rappresentazionale-computazionale della mente,
crede che in questo modo scompare il mistero del rapporto tra la mente e il corpo e
che parlare della mente non è altro che parlare del modo in cui il cervello funziona.
Tuttavia, non ci si libera certo della metafisica deformando, in senso storico, i suoi
concetti guida per poi affermarli, ancora più deformi, nel computo di un qualche
modello delle funzioni cognitive.
La definitiva resa dei conti con la filosofia ha infatti un’essenza diversa da quella
divulgata dagli scienziati cognitivi. Naturalizzazione significa originariamente
“riportare nell’ambito naturale ciò che è stato indebitamente sottratto al suo dominio”:
per le scienze cognitive, la natura è una riserva di energia costantemente leggibile in
rappresentazioni valoriali che non può sussistere quando il contingente non sussiste.
Tuttavia il non sussistere del contingente è un modo d’essere del niente: sul piano
dell’attendibilità, il niente non è il no della negatività bensì è più essenti di qualunque
ente. L’essere, infatti, tramite l’indole “niente”, dona al pensiero la capacità di
scorgere il proprio tratto più recondito e prezioso ovvero lo stanziarsi dello scisma
verso l’ente.
L’intesa del niente come nullità informativa invece potenzia in negativo il niente
filosofico, cioè lo azzera e lo porta verso il malverso nichilismo. La definitiva resa dei
conti con la filosofia non è dunque l’inizio della libertà, ma l’avvento della dittatura
della potenza.
“Naturalizzazione” vuol dire allora snaturare la mente e la natura togliendo loro
l’indole. La scienza cognitiva è quindi una sub-super-scienza perché subentra alla
filosofia, superando, di potenza per la potenza, l’ultimo richiamo del niente e getta le
fondamenta per una nuova cecità geniturale.
LA COARTAZIONE CIBERNETICA
Il format basilare della scienza cognitiva è costruito sulla tacita assunzione che la
natura sia la stabile predisposizione al computo. In questi termini la realtà, avulsa
dalla concretezza dell’indole nel suo riguardare l’uomo, è l’accumulo dei dati
potenziabili secondo diverse prospettive valoriali. L’insieme di questi dati così
prospettati linguisticamente prende il nome operativo di senso comune: esso è
dunque il senso addetto all’incoalescenza (“mal senso”).
Da tutto questo derivano una serie di conseguenze: ogni lingua è assunta come un
sistema convenzionale di prospezioni valoriali; ogni dire è concepito come la
capacità di un certo parlante di combinare tali prospezioni in complessi espressivi
allo scopo di catturare l’interesse e la considerazione degli altri parlanti.
La coartazione del senso d’essere nel mal senso costituisce l’unica realtà ammessa
nel circuito della potenza: chiamiamo questo processo “coartazione cibernetica”.
L’OCCHIO STORICO
La coartazione cibernetica stabilizza l’uomo nella postura in cui ogni indole mostra
d’impatto il suo verso contingente, cioè si fa cogliere in una prospezione valoriale.
Nel circuito di avvistamento di tale postazione, niente potrà mai apparire come uno
sperante d’essere: ogni indole è una cosa e ogni cosa ha il tratto del factum brutum.
In questo contesto, tutto si muove e diviene entro una scena e una cornice già
stabilite e note: chiamiamo quindi questo appostamento “occhio storico”.
L’occhio storico è il prospettico appostamento universale addetto dalla coartazione
cibernetica e reso ormai definitivamente operativo dalle sue potenze. Esso non può
ammettere altro sentire se non il proprio. L’intero dell’ente è già in esso sempre
prospettato e pre-valutato come la totalità storico-contingente dei fatti e degli eventi,
la cui flagranza non si fa mai scorgere nella sua genituralità. L’occhio storico è cieco
alla genitura: non per un suo difetto ma perché esso costituisce la più potente
contraffazione del colpo d’occhio geniturale.
La filosofia, il pensiero senziente, ora, sarà un corpus di testi e discorsi che trattano
razionalmente dell’uomo, del mondo e di Dio; oppure un fenomeno del passato
ormai inadeguato ai bisogni e alle istanze del presente; oppure una preparazione
culturale delle scienze moderne; oppure un insieme di dottrine e teorie illusorie;
oppure una disciplina inutile, incapace di progettare e perseguire scopi pratici
socialmente riconoscibili.
Resta da esaminare l’articolazione dell’occhio storico attuata dalla scienza cognitiva
nei riguardi del pensiero senziente. Il format da essa addotto, considerato il suo
carattere geniturale di sub-super-scienza, non può che costituire la più avanzata e
potente infirmazione della filosofia.
Lo statuto del filosofare è esibito mediante un’analogia (una somiglianza) tra il suo
gioco linguistico e la lingua della schizofrenia e dell’autismo. Esse sono simili
perché, catturato in entrambe, un uomo finisce con l’infrangere l’evidenza naturale e
quindi con il produrre illusioni cognitive: infatti, il conio della dizione pensante può
fare pensare al neologismo autistico, il tentativo e l’erranza scismatici rimandano al
paralogismo schizoide e così via.
Tacito esecutore dell’impatto è il lettore anonimo universale, ovvero quel profilo
preformato che chiunque può addestrarsi a far suo e a vivere, in modo che siano
escluse ogni tensione d’intesa. L’uomo, infatti, se assume questa postura, arriva
sempre a trovarne la chiave, che, lungi dall’introdurlo nella filosofia, gli aprirà invece
il varco di una sicura via di fuga dal pensiero.
Il format del pensiero senziente, elaborato nella scienza cognitiva, potenzia il grado
di assicurazione contro la flagranza dell’essere: in forza della “constata” somiglianza
con la follia, si lascia intendere che la filosofia costituisce una grave insidia per
l’essere umano poiché può catturare una mente sana e condurla all’estraneazione
dai fondamenti semantici del senso comune.
Il format è subdolo poiché deturpa la scismaticità dell’essere. Non vi è dubbio, infatti,
che il pensiero senziente sia estraneo all’evidenza naturale. Tuttavia tale estraneità
va intesa come la liberante scissura dal senso comune dell’occhio storico della
coartazione cibernetica e non come somiglianza con la demenza e la follia. Il
pensiero senziente asseconda l’extraneum dell’essere e lo staglia in quanto scisma
verso l’ente.
Il pensiero senziente non ha affinità con la follia: la sua dissennatezza è il riferimento
al niente come avvento dell’essere.
La dittatura del valore
La diagnosi filosofica può contribuire alla nascita e al rafforzamento di un’allerta
davanti a una vera e propria minaccia: essa consiste nel pericolo che prenda
ovunque il sopravvento il distruttivo estremismo dei militanti della dittatura del valore.
“Estremismo” indica lo stato esistenziale di coloro che, informati unicamente
sull’utile, si propongono come attivisti dell’estremo progetto del mondo: quello di
ideare, apprestare, regolare e pianificare tutte le condizioni e tutte le prospettive
affinché l’utilità si ovunque affermata e imposta come fonte universale di verità. Gli
estremisti distruttivi sono quegli uomini che, mentre sono sul punto di smarrire la
propria umanità, devono ormai distruggere l’essere stesso. In una simile temperie,
l’unico farmaco, l’unico bene, è il richiamo della verità.
In ogni comunità accademica del pianeta vigono procedure di misura sia dell’attività
didattica siadella ricerca scientifica, le quali si basano sul format della valutazione. Il
valutare regge e dirige ogni azione istituzionale. La valutazione però non si fonda
nella capacità di fondare il genuino divenire dell’esistenza universitaria nella sua
interezza, ma nel deciso rifiuto a ogni interrogazione di senso.
L’imposizione agli umani pensare, costruire e abitare, del solo carattere
dell’operatività (del fare improntato al continuo incremento della potenza) è il plus-
potenziamento. Nella nostra epoca, quindi, si sviluppa un pensiero improntato
soltanto al computo della performance, senza alcun riguardo per la verità e per
l’essenza di ciò che accade sotto il suo comando.
L’idea che il valutare costituisca la più concreta essenza del giudicare ci appare
ovvia, ma il vero giudicare non ha nulla da spartire con il valutare. Il predominio del
valutare come forma certa del giudizio è una fatale conseguenza dell’odierna
autocrazia del pensare per valori. Questa mentalità si impone oggi come l’unica
guida in grado di indicarci le vie per sapere chi siamo e che vogliamo nel nostro
lavoro di docenti e di studiosi.
Il pensare per valori, visto che riduce l’uomo a un mero soggetto operativo, resta
imprigionato e recluso nel far valere ogni ente solo quale risorsa. Nulla ha senso se
non in quanto afferrabile entro la relazione soggetto-oggetto confinata nell’unica
dimensione valoriale. Il pensare per valori rimane cieco rispetto alla propria peculiare
infondatezza, cioè al fatto che esso non ha in sé alcun metro per autovalutarsi in
senso principale.
Il pensare per valore è quindi l’insufficienza eretta a norma universale,
quell’insufficienza, insomma, che usurpa la sufficienza stessa, l’ordine dei liberi
fondamenti e delle strette costitutive del quale essa, in quanto appunto insufficienza,
costituisce la destituzione. Sufficienza, letteralmente, infatti, significa capacità di
determinare e donare un fondamento.
Sotto l’unica norma dell’insufficienza, niente può avere senso o sussistere se non
risponde al comando del plus-potenziamento. (“Insufficienza” significa quindi
crescente urgenza di potenza.) Tale norma riconosce valore e validità nell’oblio di
origini e provenienze; il pensare per valori costituisce così la più violenta rinuncia alla
facoltà del giudizio. Mentre l’autentico giudicare consiste nell’impegnarsi a dire la
sufficienza del giusto, il giudicare ridotto al valutare si risolve sempre nel dare la
parola all’insufficienza e nel rinnegare la parola stessa.
La valutazione dell’insegnamento
IL FORMAT DIDATTICO
Ogni sapere scientifico, libero e autonomo nella ricerca, accetta di inquadrarsi,
laddove debba tradursi in insegnamento, entro un comune format didattico.
Il modello didattico ci sembra chiaro e naturale, ma proprio questa “chiarezza” che
non richiede alcuna riflessione deve farci sospettare di essa. Qualcosa può essere
chiamato e apparire naturale, ma essere allo stesso tempo interamente falso e
fuorviante.
Ad ogni disciplina scientifica è preclusa la capacità di conoscere, a partire da se
stessa e dalle sue procedure, la propria forma di sapere: nessun sapere scientifico
può accedere, servendosi delle sue metodiche conoscitive, alla natura delle proprie
metodiche di insegnamento.
Ma quindi qual è il sapere che può reperire? Sul piano tecnico-operativo, che vi sia o
meno un tale sapere essenziale non ha alcuna importanza. Infatti, se anche fosse
vero questo discorso della mancanza di un sapere essenziale ed originario, la
semplice fattibilità di un modello didattico (quale schema generale di regole e criteri
entro cui attivare un addestramento multidisciplinare, ha ormai colmato qualunque
vuoto, reale o presunto.
Nell’epoca della tecnica, quando il modello diviene quindi efficiente, ogni questione
appare superflua. Eppure, finché nell’uomo-funzionario rimane ancora l’essere-
uomo, il richiamo del senso e della verità non perde la sua attendibilità.
LA SCORTA DELLA VERITÀ
Abbiamo capito che alla disciplina scientifica è negato l’autonomo accesso alle sue
due essenze di ricerca e di insegnamento. Tuttavia, solo se è lasciata libera di
giocare in tale sua doppia limitazione, una disciplina resta un sapere problematico, e
quindi disposto a lasciarsi fondare sulla propria essenza scientifico. Il libero lavoro
didattico è uno dei modi costitutivi in cui allo studioso si mostra il limite della propria
disciplina, cioè la nascosta sorgente della sua scientificità.
Ricerca e insegnamento: nessuno dei due può essere senza l’altro, mentre
entrambi, perfettamente uniti, riposano nel loro limite interno. Solo il senso del limite
mantiene sveglio, in essi, l’impegno per il vero. Chiamiamo allora la dimensione
d’origine di tale restare esposti “scorta della verità”.
Possiamo quindi dire che l’adozione di un modello didattico mina alle fondamenta
proprio la scorta della verità: allora su un’istituzione, che affidi la propria formazione
multidisciplinare alle procedure di un modello, grava la minaccia di un progressivo
impoverimento spirituale.
L’IMPATTO PERFORMANTE
A causa della presenza del modello didattico, ora l'insegnamento è indotto a non
lasciarsi più guidare dalla problematicità di ciò che è in causa nella scienza da cui
proviene, ma a servire innanzitutto l’operatività del modello. In questi termini “vero
insegnamento” vuol dire “insegnamento efficace”: si ha quindi un forte scontro tra la
tensione alla scorta della verità e la tendenza alla performatività modulare. Più
l’impatto performante si stabilizza (fino a diventare sempre meno percepito e
avvertito), più la minaccia si consolida e si estende, fino a permeare ogni attività
dell’istituzione.
LA COGENZA DEL METODO
La scienza moderna è performante, ovvero capace di imporre a ogni cosa il format
dell’efficienza modulare, e consiste in un sistema di conoscenze che si lasciano
guidare dalla progressività dei loro risultati teorici. Tale progressività è il segno che la
ricerca teorica è già sempre orientata all’utilità e al tornaconto. La scienza moderna
è un sistema di sapere il cui principio di coesione non proviene in linea retta dal
sapere filosofico, ma dalla capacità di computo e di controllo.
Ciò si deve alla circostanza che, proprio nella scienza moderna, si afferma la
supremazia del metodo e della procedura: in altri termini, la potenza del metodo
costituisce l’origine della tecnicizzazione e della specializzazione scientifiche.
Le scienze moderne intendono le categorie che delimitano e articolano ogni volta i
loro campi tematici come dei concetti operativi, assunti in forma esclusivamente
strumentale e privi di ogni consistenza ontologica.
L’obiettivo è quindi quello di progredire: un modello sarà produttivo quando
permetterà un effettivo avanzamento; solo allora si porrà il problema della
verificazione. La verità scientifica diventa così una verità performativa: che la
performatività debba essere il tratto guida della verità, questa necessità non potrà
mai costituire, in se stessa, l’oggetto di una qualche verificazione.
La verità performativa è solo un modo della tradizionale verità scientifica (intesa
come corrispondenza tra proposizione e cosa), la quale, a sua volta, è solo un modo
dell'originaria scorta della verità. L’incontrollata tendenza alla performatività, insita
nelle moderne tecniche scientifiche, insidia lo stare all’erta nella verità: quindi in
questo contesto la tentazione della verità è trascurata.
Ma se è vero che là dove la tentazione sia scorta in quanto tale, cresce già una
salvezza, dobbiamo supporre che proprio nelle scienze riposi il seme di un risveglio
del rispetto per la verità come problema: se viene alla luce la minaccia che grava sul
vero, allora la verità è già salva.
Ogni vero scienziato, in quanto essere pensante, non può non sapere degli abbagli,
degli equivoci che possono generarsi proprio a causa del buon funzionamento delle
procedure scientifiche. Egli sa che proprio là dove tutto è in ordine può annidarsi la
più perfida contro-verità. Le vie di scampo delle verità sono dunque dentro i saperi
scientifici: per questo motivo possiamo dire che finché vi è scienza, la verità fa il suo
gioco.
IL CONFLITTO VALORIALE
L’analisi fin qui svolta ci permette di discernere l’intima costituzione del primato del
modello didattico: esso è un riflesso della supremazia e della cogenza del metodo e
quindi del pensare per modelli nel senso delle scienze. La performatività modulare,
infatti, ignora proprio il tratto di fondo del suo originale, ossia il riferimento
problematico alla verità. La performatività modulare, spacciandosi per una evoluta
congenere della performatività scientifica, dà l’impressione di essere l’unica sicura
unità di misura della verità, mentre diffonde e consolida una forma mentis in base
alla quale l’avvenire dell’educazione scientifica e professionale sembra ormai
dipendere interamente dalla sua capacità di trasformarsi in un congegno
multifunzionale di decorsi computabili.
A tutti gli stili e modi didattici è celatamente imposto un unico statuto: l’ordinata e
compatta trascuratezza della tentazione della verità. Si mostra allora l’essenza
dell’impatto performante: dalla performatività modulare, contro la scorta della verità,
fino alla soppressione di ogni problematicità, in modo che sia ovunque garantita e
assicurata la totale assenza della spaesatezza generata dalla verità in tentazione.
Capiamo allora che il pensare per modelli non è nient’altro che un pensare per valori
e chiamiamo questo campo di ostilità “conflitto valoriale”. Il conflitto valoriale è retto
dal principio della scambiabilità di ruolo logistico tra valori: un valore può essere
giocato come un fine, ma poi anche come un mezzo, così come un valore-mezzo
può assumere, in una certa fase, le sembianze di un valore-fine. Il regime di scambio
è necessariamente improntato all’inarrestabilità: il conflitto valoriale si dispiega allora
come dominio di un’incessante mediazione, cioè come privazione di ogni vera
finalità e quindi di ogni genuina decisione.
La stessa verità è uno strumento dell’incondizionato dominio della mediazione.
Laddove sia anche soltanto citata o accennata, tale scorta assume presto l’aspetto
di un non-valore da rigettare come qualcosa di irrisorio o di “debole”. Così, finché si
resta sul piano del conflitto valoriale, l’impatto performante va sempre più a regime,
lasciando che la trascuratezza della verità si rinsaldi in se stessa fino a scomparire
nel generale oblio.
Ma quando in un’istituzione di alta cultura si perde la fiducia nel libero operare della
verità, allora inizia il crollo dell’istituzione stessa in quanto comunità del sapere,
dell’insegnare e dell’imperare.
IL VUOTO INVISIBILE
La progettazione e l’implementazione di un modello per il governo della didattica
costituiscono il sintomo del fatto che l’istituzione scientifico-formativa si è ormai
risolta a espellere, dalla propria esistenza, il campo di gioco della verità e con esso
la verità dell’insegnamento. In questo modo, ogni sapere viene sradicato dalla
proprio tempra filosofica. Tuttavia, nessuna singola disciplina scientifica è in grado di
mettere a fuoco il vuoto creato dall’espulsione della verità e quindi questo vuoto
rimane invisibile. La sua completa invisibilità è poi assicurata grazie a quella potente
copertura generata dall’apparenza della funzionalità delle procedure modulari.
IL PESO DELLA RISPOSTA
In ogni università, la valutazione detta legge e impone la sua potenza. La
valutazione è il costante riferimento su cui si basa l’intera prassi pedagogica: è il
criterio ultimo per tutte le questioni che riguardano l’insegnamento. In ultima istanza,
la valutazione deciderà su tutto: essa infatti è la sostanza dell’insegnamento. Il
senso resta oscuro, privo di riferimento ad altro da sé: pur nella completa cecità in
merito al dove stia andando è indubitabile che si debba procedere “in tal senso”;
resta solo da decidere quali siano le procedure migliori per implementare il percorso.
La dittatura della valutazione dispensa sì dalla gravezza della responsabilità, ma
impone, in compenso, il peso della risposta. Il clima valutativo è pesante, poiché in
esso l’unico elemento alleviante (la verità) non ha corso.
IL CONTEGNO SCIENTIFICO
Per contegno scientifico intendiamo la disponibilità a imparare nel senso della
problematicità del sapere. Tale contegno resta per altro il fondamento di ogni
professione esercitata responsabilmente.
Parliamo di “alterazioni di fondo”, poiché esse, in quanto perni su cui gira il modello,
generano varie conseguenze capaci ogni volta di distorcere il giusto senso delle
cose. In quest’ottica un insegnamento che sia non modularmente performante,
apparirà come superato o inadeguato e si cercherà subito un rapido “cambiamento
di rotta”. Il modello quindi impone un assoggettamento subdolo che provocherà una
metamorfosi all’interno dell’insegnamento: il docente si adeguerà al cambiamento
convinto che quello sia il prezzo da pagare per salvare il suo ruolo accademico e la
sua disciplina. Si tratta invece di un disagio, di un disturbo della verità in cui il prezzo
richiesto dal modello è l’intero insegnamento.
Infine il modello deve assicurarsi l’arruolamento degli studenti, il cui feedback è
assunto come un dato incontrovertibile da immettere nelle procedure del pilotaggio.
LA SCIENZA E IL METODO
Lo scopo di un sapere scientifico è quello di raggiungere una dimensione del
costruire e dell’abitare in cui sia attendibile fidarsi gli uni degli altri per poter fare
affidamento sul proprio mondo e avere così lo spazio-di-tempo di un avvenire.
Tuttavia la preminenza del metodo, la quale corrisponde al prospettarsi del reale
nella nuova forma dell’oggettività effettiva, muta l’indole del sapere scientifico.
Ogni scienza, grazie alle procedure metodiche della ricerca, inizia ora a disporre di
una straordinaria capacità di tematizzazione del proprio campo e quindi di
penetrazione nell’effettività stessa dei suoi oggetti. “Sapere metodico” vuol dire
potenziamento della conoscenza nella modalità della tematizzazione penetrante.
L’ente indagato, l'oggetto della tematizzazione penetrante, è assunto a priori come
un meccanismo via via traducibile in un codice che ne permetterà il controllo
operativo. L’attuale prassi scientifica non cerca più solo la chiave dell’ente per
svelarne la legge nascosta e custodirla in un sapere al servizio della polis; essa
piuttosto forza l’ente stesso a parlare entro un codice che permette di mostrare l’ente
come un processo pilotabile e riducibile a una risorsa.
Nella scienza odierna è proprio l’operatività tecnica ciò che dà il tono alla teoria.
Ogni teoria è necessariamente un modello, vale a dire un quadro ipotetico in attesa
di conferma sperimentale, dove però l’esperimento e i suoi risultati non potranno mai
andare oltre il quadro del modello stesso.
Nel pensare per modelli e nella sua tendenza a divenire assoluto, la scienza è
tentata di trascurare quel limite fino a non vedere altro che ipotesi ed effetti. Il
modello si impone come l’unico accesso all’essere dell’ente, per apparire infine esso
stesso come verità, nel senso dell’unico essere attendibile. Ora l’ente è l’oggetto di
cui servirsi mediante valutazioni: l’odierna scienza metodica quindi non sa più nulla
del suo originario carattere di servizio per l’abitare.
LA VERITÀ IN TENTAZIONE
Nel nostro mondo è del tutto naturale affidare la verità alla ricerca scientifica. Questo
riflesso condizionato costituisce però il più chiaro sintomo dello stato di trascuratezza
in cui essa versa. Nel nostro discorso ci riferiamo infatti alla verità come problema,
come originaria stretta umana, come quell’elemento di cui ci accorgiamo solo
quando è sul punto di venire meno. La verità non è un contenuto universale
nascosto in qualche sede sopraceleste e neppure il “mistero della vita”, ma ciò che è
sempre in causa quando, per l’uomo, diviene ineludibile la determinazione del senso
dell’ente e di se stesso. Quindi la parola “verità” designa, per così dire, un campo di
gioco, che spetta all’uomo istituire e poi curare.
Il campo di gioco della verità è proprio ciò che è sempre presupposto (sebbene in
modo inconsapevole e implicito) nella genuina ricerca scientifica.
Al nostro discorso si può opporre un’obiezione: la performatività costituisce da
sempre uno dei tratti della verità. Nella nostra epoca, tale tratto satura l’intero campo
del vero e quindi se oggi si ritiene che il vero sia innanzitutto l’utile, perché non
impariamo a interpretare questa determinazione come un arricchimento e
un’evoluzione della verità? Certo tutto è possibile, ma non tutto può essere
attendibile. Resta infatti la questione che la performatività, nel presentarsi come
un’evoluzione della verità e riconoscendo implicitamente quest’ultima come la sua
provenienza, tende poi a oscurarla?
IL PENSARE PER MODELLI E IL PENSARE PER VALORI
Nel pensare per modelli, “vero” è unicamente il misurabile, ma misurabile è solo
l’effettuale. L’effettuale è ciò che si impone come fattualità, come pura capacità di
esiti, realizzazioni, risultati. L’effettuale è allora l’effettivo, la contingenza, ovvero ciò
che ha piena validità. L’effettivo è quindi il valido, che a sua volta è ciò che ha valore.
Se pensiamo invece al procedimento inverso, il computo in valori è un modo del
misurare, è un misurare valutante. La verità performativa, perciò, consiste nella
verità valoriale e viceversa.
Nel pensare per valori, vero è solo il valore. Il pensare per valori risponde quindi alla
necessità di assicurarsi contro la tentazione della verità ed è per questo che nasce
l’esigenza del modello. Il pensare per valori ha la medesima natura del pensare per
modelli e quindi l’uno non può sussistere senza l’altro.
Vi è dunque una reciproca inerenza tra pensare per modelli e pensare per valori.
IL DOMINIO DELLA MEDIAZIONE
“Mediazione” significa porre in azione sotto forma di mezzo. Là dove ogni cosa è
solo nella misura in cui resiste come mezzo, regna la transitorietà come unico
riferimento del vero. Il dominio della mediazione improntata al regime della
transitorietà dell’indaffaramento è insomma il gioco delle mezze decisioni e quindi
delle mezze verità, cioè del più tenace diversivo dalla scorta della verità.
Detto in altri termini: nel dominio della mediazione, non accade più che il mezzo sia
giustificato dal fine; piuttosto sarà sempre un certo fine a doversi immediatamente
“giustificare”. Esso si rivelerà “giusto” solo se è aggiustabile come mezzo, un mezzo
che deve far transitare la mediazione stessa.
LO STIGMA ZETETICO
Delle contraffazioni, su cui si regge la forzatura modulare dell’insegnamento fanno
parte un traviato apparato di diritto, un codice etico, un deforme canone estetico…
Sia l’apparato di diritto sia il codice etico implicano la colpevolizzazione di ogni prassi
didattica riconducibile alla verità, la quale viene vista come una perdita di potenza.
In tale atmosfera si genera necessariamente un preventivo senso di colpa di chi
ancora insista e giochi nella doppia limitazione della propria disciplina, con il risultato
che il genuino senso scientifico, messo alle strette, si rifugerà, nel bel mezzo
dell’istituzione nominalmente preposta a salvaguardarlo e alimentarlo, in una sorta di
clandestinità.
LA DIAGNOSI FILOSOFICA
Il fatto che la messa a fuoco del vuoto di verità possa riuscire alla filosofia non
dipende da una sua particolare intelligenza. per essa, i termini sono dunque netti: o
l’ordine, nascostamente caotico, del modello didattico, o la libertà della verità.
La filosofia è irriducibile al pensare per valori e per modelli: essa è invece pensiero
interrogante. Il fatto che proprio la disposizione all’interrogazione costituisca il primo
requisito della scientificità di un sapere mostra come ogni scienza determinata sia
inevitabilmente filosofica.
Il sapere metafisico-filosofico raccoglie così il poter-donare e il dover-donare in un
unicum, che è poi istituito come la capacità fondamentale del pensiero. Proprio in
tale capacità di dono riposta l’originaria tempra della filosofia.
La vera sfida forse è quella di far entrare nell’industria e nell’azienda, intesa in senso
lato, la passione della verità e la tentazione del vero.
La valutazione della ricerca: l’istituto del peer
IL PEER
Indipendentemente dal fatto che un sistema di valutazione appaia, di volta in volta,
funzionante ed efficace, oppure difettoso e inefficace, si deve al ruolo fondamentale
che in esso svolge il pari. Il pari è il garante dell’attendibilità della valutazione della
ricerca.
L'ATTENDIBILITÀ
Il sapere scientifico è per sua natura autonomo: esso trova soltanto in se stesso la
propria sorgente e la propria legge, sebbene non possa conoscerle. Tuttavia, resta
vero che soltanto lo scienziato si intende di scienza: il giudizio di scientificità allora
spetta agli scienziati, mentre nessuna istanza esterna può arrogarsi un giudizio sulla
fondatezza scientifica di un tentativo compiuto nella sfera di un determinato sapere.
Gli scienziati sono, a loro volta, essenzialmente pari, e ciò in virtù del loro costitutivo
crescere insieme nella scorta della verità.
La giurisdizione in ambito scientifico deve dunque necessariamente essere fondata
sul giudizio tra pari: il giudizio tra pari, e solo esso, è in linea di principio attendibile.
LA MUTAZIONE DEL PEER
Il pari, nel senso proprio, è la persona che ha diritto di essere giudicata da persone
del suo grado. Questa nozione si applica dunque perfettamente a coloro che,
essendo pari nella scorta della verità, hanno diritto di essere giudicati, in quanto
ricercatori, soltanto da chi, a sua volta, tragga la misura del giudizio dalla medesima
istanza conoscitiva, mentre devono restare intatti da giudizi che attingono il loro
metro da una diversa sorgente.
Nei regimi di valutazione della ricerca, questa nozione di pari si riferisce in primo
luogo a chi ha il diritto di giudicare, ovvero, più precisamente, a chi è investito del
mandato di valutare i suoi pari. Ora quindi il peer adesso appare innanzitutto come il
portatore di un’istanza di controllo.
Lo scienziato, mentre è costitutivamente singolo nel suo essere impegnato nella
verità, resta il singolo di un’attendibile coalescenza in cui tale verità è innanzitutto
custodita. Il singolo si costituisce dunque per attendibile coalescenza.
Il diritto di essere giudicati dai pari non funge soltanto da garanzia a fronte di
eventuali azioni inquisitorie, ma è innanzitutto costitutivo dello stesso essere
scienziati in coalescenza. All’interno del regime dei peer ognuno è, a seconda dei
casi, indifferentemente giudice e giudicato: ognuno esercita una funzione di controllo
sui pari e ognuno resta tutelato, in quanto ricercatore del vero, del fatto che sarà
sempre e soltanto un pari a giudicarlo.
Eppure, l’analogia tra il peer nel giudizio e il peer nella valutazione è soltanto
formale: la sostanza invece muta perché il tono di incoraggiamento che risuona nella
parola pari si rimodulo in uno scoraggiante accento di minaccia e di aggressione
(mediante una scansione parametrica che isola ognuno in un set di valori).
Il sistema della valutazione ottiene e mantiene la propria attendibilità proprio grazie
alla copertura offerta dalla non scorta mutazione del pari.
L’INATTENDIBILITÀ
L’attendibilità del sistema della valutazione imperniato sul peer si fonda su ciò che
possiamo chiamare un vitium subreptionis (un inganno). Poiché l’attendibilità è
ottenuta in virtù di tale vizio, essa resta senza fondamento e diventa inattendibilità.
Là dove la verità sia divenuta mera operatività, efficacia operativa, l’uomo non è più
chiamato a scortare la verità stessa quale indole a cui appellarsi; egli è ora preteso a
favore dell'implementazione della crescita di performatività.
La trasformazione del senso della verità fa sì che quest’ultima si configuri ormai
come un’offensiva contro l’ente ridotto a risorsa. Proprio a favore di tale offensiva
deve essere arruolata la conoscenza in cui l’uomo radica e tempra il proprio agire
(agire che deve essere interamente informato al plus-potenziamento).
Insieme al senso del pari, e sotto la copertura del suo presunto restare il “pari nella
scorta”, mutano di segno tutti i tratti e i momenti costitutivi in cui si invera
un’autentica coalescenza scientifica tra separati, cioè una genuina parità: la critica, il
dialogo, l'esortazione, la solidarietà, l’aiuto, la responsabilità.
Chi non percepisce, chi non tocca con mano, ormai quotidianamente, come vigano,
nelle istituzioni preposte alla “promozione” e al “sostegno” della ricerca, la mancanza
di ogni fiducia e ogni affidamento; l'indifferenza e l’inerzia riguardo a ogni istanza di
verità; il perentorio prevalere delle esigenze procedurali sugli spazi e sui tempi
necessari alla ricerca?
IL VILIPENDIO E LA DIAGNOSI
L’istituto del peer valutante si fonda sul vilipendio della verità, che proprio mediante
quell’istituto si attua e si dispiega. “Vilipendere” significa non solo pesare e stimare,
giudicando e riconoscendo che una cosa vale poco, bensì rendere vile, invilire
qualcosa già riducendolo a oggetto di stima e di valutazione, ovvero a cosa che si
compra e si vende a un prezzo. Sicché la trasformazione della verità in
performatività è sufficiente a configurare il vilipendio. Tuttavia, quella trasformazione
e quel vilipendio non sono causati dall’uomo: essi appartengono all’essenza stessa
della verità, come sua costitutiva tentazione.
Il peer valutante è il portatore del vilipendio, in forza del quale l’accortezza della
verità, trasformata in computo di performance, si spende come valore di ogni valore.
Originariamente giudice del vero, il peer diviene ora il referente della volontà per la
volontà, dell’estenuante computo.
UNA SINTESI FENOMENOLOGICA
Il peer valutante è costitutivamente anonimo, giacché ha veramente nome e
rinomanza soltanto chi parla in nome della verità. Il peer valutante è per essenza
irresponsabile, nel senso che infirma la responsabilità in quanto tale, poiché agisce
senza dover mai, a sua volta, rispondere della verità del suo operato, mentre
collabora a orientare verso la negligenza del vero i pari. Il peer valutante è
intrinsecamente fanatica: è necessariamente orientato all’eliminazione di tutto ciò
che può opporsi al dominio della performatività nel sistema della conoscenza.
Insomma è l’anonimo militare della dittatura del valore. Egli è l’operatore scienziato
dell’unica volontà che vuole trasformare la scienza nella performatività.
Tutto il discorso deve però essere inteso come una sintesi fenomenologica e non
come una condanna morale inflitta a una data categoria di studiosi ed esperti.
Gli odierni peer, infatti, sono “come noi” e in un senso essenziale, tutti noi. I “pari”
siamo noi fin dal momento in cui ognuno semplicemente soggiace a tali pratiche. O
vi soggiace senza levare, almeno per un istante, la voce in avvertimento.
LA COMUNITÀ DEI PARI
Il gruppo dei pari è definito dalla comune appartenenza a una disciplina scientifica.
Si ritiene che il giudizio scientifico debba restare circoscritto alle comunità così
definite, poiché al di fuori di esse non è garantita la competenza necessaria. Il
singolo rientra necessariamente in una comunità di pari: tale obbligatorietà risponde
all’esigenza operativa che il singolo sia trasparente, leggibile, monitorabile, ovvero in
una parola, valutabile secondo uno standard.
Il pari non è innanzitutto “il mio pari”, quanto piuttosto colui che controlla in quale
misura io sia un pari, ovvero un parificato nello standard.
L’UTILITÀ PER LA VITA
Chi potrebbe negare che sia inaccettabile e quasi non etica una ricerca senza
riscontri concreti e tangibili risultati, i quali ripaghino delle risorse impegnate in
questo settore piuttosto che in altri?
I fini ultimi delle procedure della valutazione dei pari restano confinati interamente
entro la cerchia dell’operatività. Mai tale procedure agiscono a partire dalla verità
ontologica della conoscenza. Nessuno dei concetti e degli indicatori di utilità,
mediante i quali si implementano i vari metodi di programmazione e valutazione
della ricerca, si mostra sensibile all’unica cosa che conta (ovvero appunto la verità
ontologica).
Un’obiezione al nostro discorso potrebbe suonare: lo scopo della peer review è
quello di evitare in ciò che giunge a pubblicazione definitiva, errori e palesi
insufficienza o il mancato rispetto di standard, minimi e condivisi, di scientificità.
Anche qui è necessario discernere: infatti, l’eventuale errore corretto dal revisore
ancora una volta maschera la mano intrusiva della performatività.
LA PEER REVIEW ANONIMA
La peer review anonima è un mezzo di addestramento performativo: essa istituisce
un gioco nel quale si tratta, per i valutanti come per i valutati, di interiorizzare il
principio operativo come principio guida, ovvero di regolarsi su di esso. La volontà di
eliminare ogni elemento di “soggettività” da questo gioco valoriale nasconde la
volontà di surrogare il giudizio in quanto tale con il computo della performatività.
L’eliminazione del fattore soggettivo nella valutazione mira, da un lato, a eliminare
l’errore umano in un computo standardizzato; dall’altro mira ad espellere la vera
parità tra studiosi. Infatti, per il singolo, la parità, ovvero l’amicizia nella verità, non è
mai un bene acquisito, ma una condizione sofferta e mantenuta in una lotta
incessante. Un elemento essenziale di questa lotta è costituito dalla tentazione della
dimestichezza, la quale attenta alla scorta della verità.
L’anonimato del peer è una maschera che, mentre dà a intendere di voler
correggere le distorsioni dovute alla dimestichezza, implementa, invece,
l’anonimizzazione essenziale di cui si è detto. Lo stesso gesto che offre l’aiuto
dell’anonimato, in una sorta di gioco delle tre carte, sottrae la verità, lasciando al suo
posto un surrogato operativo. In questo modo, i pari sono privati dell’unico elemento
che può in maniera genuina affrancare l'amicizia dalla morsa della dimestichezza,
ovvero appunto l’orientamento verso la verità.
L’anonima peer review toglie dunque le basi alla vera parità, mentre corrode la
coalescenza tra studiosi.
Postilla sull’inutile
La filosofia e la scienza, così come l’arte e ogni tecnica, non hanno per natura alcun
bisogno di essere valutate; esse chiedono solo di essere coltivate, esercitate e
insegnate, ciascuna in base alla propria essenza, da uomini che, oltre a possedere il
genio necessario e gli indispensabili strumenti, abbiano a cuore innanzitutto il vero.
Finché siamo uomini, cioè esseri liberi, nulla può vietarci di pensare, ovvero di
frenare la nostra corsa per soffermarci criticamente sulle nostre prassi.
Che una prassi funzioni e proceda e sia perciò apprezzata e avvalorata dall’opinione
prevalente, non può mai assumersi come prova della sua fondatezza.
Potrebbero piacerti anche
- Heidegger - Lettera Sull'Umanismo - SintesiDocumento4 pagineHeidegger - Lettera Sull'Umanismo - Sintesimariospalla100% (1)
- Buddismo - La VacuitàDocumento10 pagineBuddismo - La VacuitàSherab Zangpo - Silvio100% (1)
- Metafisica - Sem2 - by Don RosarioDocumento28 pagineMetafisica - Sem2 - by Don RosarioAndrea StradaNessuna valutazione finora
- Lettera Sull Umanismo Note e Citazioni M. HeideggerDocumento1 paginaLettera Sull Umanismo Note e Citazioni M. HeideggerDavide ValentiNessuna valutazione finora
- Una verità da valutare: opinione vera non erronea: Introduzione al problema della conoscenzaDa EverandUna verità da valutare: opinione vera non erronea: Introduzione al problema della conoscenzaNessuna valutazione finora
- Che Cos'è Pensare?Documento10 pagineChe Cos'è Pensare?Rodrigo MeirelesNessuna valutazione finora
- Raphael Fuoco Dei FilosofiDocumento3 pagineRaphael Fuoco Dei FilosofirenatocanoneNessuna valutazione finora
- Gino CoralloDocumento2 pagineGino CoralloMatch JosephNessuna valutazione finora
- HeideggerDocumento6 pagineHeideggerMarco StoroniMazzolani Di MaioNessuna valutazione finora
- Essere e TempoDocumento4 pagineEssere e TempoVeronica PeregoNessuna valutazione finora
- Buddismo - Le Cinque Saggezze TrascendentiDocumento6 pagineBuddismo - Le Cinque Saggezze TrascendentiSherab Zangpo - SilvioNessuna valutazione finora
- Dall'avere all'Essere: ritorno attraverso la comprensioneDa EverandDall'avere all'Essere: ritorno attraverso la comprensioneNessuna valutazione finora
- Hegel: Sintesi Fenomenologia SpiritoDocumento5 pagineHegel: Sintesi Fenomenologia SpiritoGianfranco Marini100% (3)
- Essere e TempoDocumento50 pagineEssere e TempoFeL987100% (1)
- Il Concetto Di TempoDocumento5 pagineIl Concetto Di TempoMatteo RonziniNessuna valutazione finora
- Schopenhauer VolontàDocumento2 pagineSchopenhauer VolontàValeria GabrielliNessuna valutazione finora
- 2017 - 70363 Psicologia Della Sessualità - Binasco - Scan LibroDocumento21 pagine2017 - 70363 Psicologia Della Sessualità - Binasco - Scan LibroStrokers sTkNessuna valutazione finora
- Adolf Reinach - Che Cos'è La FenomenologiaDocumento24 pagineAdolf Reinach - Che Cos'è La FenomenologiaLibricusNessuna valutazione finora
- Schopenhauer e NietzscheDocumento6 pagineSchopenhauer e NietzscheMichelaNessuna valutazione finora
- Essere Coscienza BeatitudineDocumento3 pagineEssere Coscienza BeatitudineEsonet.orgNessuna valutazione finora
- HEIDEGGERDocumento3 pagineHEIDEGGERAnna AgolinoNessuna valutazione finora
- Croce 10Documento7 pagineCroce 10Leonardo MecocciNessuna valutazione finora
- CarabelleseDocumento4 pagineCarabelleselunabrizzi666Nessuna valutazione finora
- FILOSOFIA DELL'ESSERE - Non CompletoDocumento8 pagineFILOSOFIA DELL'ESSERE - Non CompletoDaniele Pietro ErcoliNessuna valutazione finora
- Heidegger Glossario Di Essere e TempoDocumento3 pagineHeidegger Glossario Di Essere e TempoFabio SacconeNessuna valutazione finora
- Schopenauer - Il Mondo È VolontàDocumento4 pagineSchopenauer - Il Mondo È VolontàRoberto BaldiniNessuna valutazione finora
- Hegel Fenomenologia Dello SpiritoDocumento4 pagineHegel Fenomenologia Dello SpiritoAlessio AvasilcaiNessuna valutazione finora
- Gorgia Sul Non EssereDocumento3 pagineGorgia Sul Non EssereFederica100% (1)
- FilosofiaDocumento8 pagineFilosofiaagata.randon11Nessuna valutazione finora
- Tabella Autori FilosofiaDocumento4 pagineTabella Autori FilosofiaAriannaNessuna valutazione finora
- La Soggettività Tra Etica e NaturaDocumento17 pagineLa Soggettività Tra Etica e NaturajoelelodieNessuna valutazione finora
- Le Virtù Cardinali: La PrudenzaDocumento7 pagineLe Virtù Cardinali: La PrudenzaCarlos GiraldoNessuna valutazione finora
- La Via Dello Zen - Alan W. Watts PDFDocumento49 pagineLa Via Dello Zen - Alan W. Watts PDFgian100% (2)
- Emozioni e CoscienzaDocumento9 pagineEmozioni e CoscienzaPaolo PascucciNessuna valutazione finora
- HumeDocumento5 pagineHumeElena della VellaNessuna valutazione finora
- Gli Oracoli Caldaici PDFDocumento160 pagineGli Oracoli Caldaici PDF1979Nessuna valutazione finora
- Sintesi Di Metafisica - by Don RosarioDocumento9 pagineSintesi Di Metafisica - by Don RosarioAndrea StradaNessuna valutazione finora
- Buddismo - L'Ingoranza e Gli Altri Difetti MentaliDocumento5 pagineBuddismo - L'Ingoranza e Gli Altri Difetti MentaliSherab Zangpo - SilvioNessuna valutazione finora
- Tempo in HeideggerDocumento4 pagineTempo in HeideggerKevin GozziNessuna valutazione finora
- Il Pensare Come Amore. Verso Un Nuovo Paradigma CulturaleDocumento19 pagineIl Pensare Come Amore. Verso Un Nuovo Paradigma Culturaledanaka01Nessuna valutazione finora
- Stanghellini. Psicologia FenomenologicaDocumento7 pagineStanghellini. Psicologia Fenomenologicalucatinaro1997Nessuna valutazione finora
- Estratti Da Scritti Di GurdjieffDocumento9 pagineEstratti Da Scritti Di GurdjieffoneenoNessuna valutazione finora
- Krishnamurti - Su DioDocumento106 pagineKrishnamurti - Su DiospynacchiaNessuna valutazione finora
- Le 7 Leggi UniversaliDocumento15 pagineLe 7 Leggi Universalihar58Nessuna valutazione finora
- David Hume Sull'identitàDocumento2 pagineDavid Hume Sull'identitàLorenzo Maria CerviNessuna valutazione finora
- Verità e FlagranzaDocumento2 pagineVerità e FlagranzaRaffaella VitaleNessuna valutazione finora
- Scisma D'essereDocumento1 paginaScisma D'essereRaffaella VitaleNessuna valutazione finora
- Il Pensiero GenituraleDocumento2 pagineIl Pensiero GenituraleRaffaella VitaleNessuna valutazione finora
- Il Circolo Della Plus PotenzaDocumento1 paginaIl Circolo Della Plus PotenzaRaffaella VitaleNessuna valutazione finora