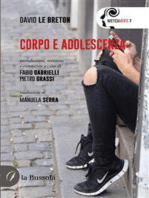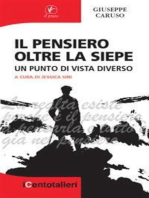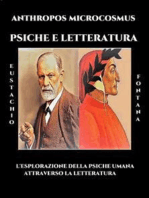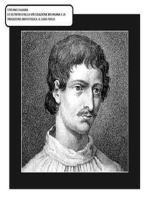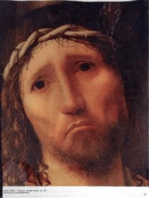Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Stanghellini. Psicologia Fenomenologica
Caricato da
lucatinaro19970 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
4 visualizzazioni7 pagineScienze e Tecniche Psicologiche, università di Chieti
Titolo originale
stanghellini. Psicologia Fenomenologica
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoScienze e Tecniche Psicologiche, università di Chieti
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
4 visualizzazioni7 pagineStanghellini. Psicologia Fenomenologica
Caricato da
lucatinaro1997Scienze e Tecniche Psicologiche, università di Chieti
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 7
Le parole di Roland Barthes arrivano come passi di danza che muovono
un’improvvisazione e da essa si lasciano condurre: là dove il Leib del
danzatore esiste autentico e libero da uno schema, da qualcosa che pre-
definisce, che circoscrive, che riduce.
È un momento trasformativo, quello annunciato da queste parole, un
tempo dinamico, un movimento verso… È il tempo dell’incontro. Un
incontro che, ci lascia intendere Barthes, è apertura di possibilità altre,
occasione di significazioni nuove (rilancia), è ampliamento delle
reciproche prospettive, opportunità di dialogo, è una danza…. Di
esplorazione e dispiegamenti.
Quello dell’incontro è un tema caro alla pratica fenomenologica che da
sempre è impegnata a far luce sulla relazione clinico-paziente come
primariamente e imprescindibilmente una relazione tra due persone che
si pongono l’una di fronte all’altra. L’etre-à-deux, la reciprocità, sostiene
Callieri (1999) designa in maniera quasi perentoria l’appartenenza come
categoria primaria dell’umano, un Tra che costituisce un vero e proprio
dominio primordiale della realtà umana. Un’interrelazione che si
costruisce continuamente nella danza degli incontri. Entro il contesto che
viene delineandosi si colloca quella irrinunciabile dimensione
dialogica dell’incontro clinico-paziente, cuore e motore della relazione
psicoterapeutica.
“In un dialogo vero”, sostiene Callieri riprendendo Wyss (1977), “ciò che
vi è di essenziale non si compie o nell’uno o nell’altro dei partecipanti,
non si attua in un mondo e in un modo neutro ma, in modo molto preciso
e puntuale, tra i due, in una dimensione che non è accessibile che a quei
due”.
Il tema della psicopatologia, secondo Callieri (1998), non si articola su un
“modello” di uomo, ma è l’uomo, con il suo esser apertura,
progetto, storia in fieri. Il pensare psicopatologico dev’esser, dunque,
perentoriamente dialettizzato per articolarlo sul nodo essenziale
dell’intersoggettività, che costituisce il registro propriamente umano.
Nodo, questo, che si fonda ineludibilmente sulla singolarità della persona.
Se la coscienza è essenzialmente intenzionalità, prosegue Callieri, e se
l’esserci è sempre esserci-nel-mondo, l’Io si pone sempre e soltanto in
relazione. L’incontro rivela l’altro a me come un’esistenza, come una
sorgente di senso: “la «presenza» rivela l’altro a me come «like-me-in-
the-world»; in questa accezione si può dire con Lujipen (1960) che l’altro
è il mio «compagno-verso-il-mondo» e che tale richiamo è ineludibile
proprio perché ha i caratteri del «fondamento»”. Il vasto compito
della psicologia fenomenologica è dunque indagare e cogliere la
moltitudine di forme che questo «noi» può rivestire, laddove
alla psicopatologia compete più propriamente lo studio di quelle che
Callieri definisce distorsioni del coesistere.
Già Ferdinando Barison (1990) aveva fatto luce sull’essenza ermeneutica
del dialogo clinico-paziente. In tale dialogo, sostiene Barison, non ci sono
un soggetto ed un oggetto, ma c’è l’incontro di due orizzonti che si
fondono in un orizzonte nuovo, dando vita ad un “aumento di essere”:
“Non dunque Einfühlung, immedesimazione, mettersi nei panni dell’altro,
ma viverlo in quanto si apre a me, nell’aprirsi che è nuovo anche per lui in
quanto inerisce all’evento nuovo dell’incontro” (Barison, 1990)
Il dialogo ermeneutico è qui inteso come presentificazione e posto in
analogia, riprendendo Gadamer (1960), al teatro, alla musica, all’opera
d’arte in generale. L’ermeneutica, infatti, suggerisce che dal dialogo
clinico debba sorgere quella verità che è il nuovo orizzonte, così come
l’incontro con un’opera d’arte consiste nel riconoscere il nuovo, che
emerge tra gli elementi della tradizione, presentificandosi proprio
nell’atto della fruizione.
L’incontro è allora accettare di essere spiazzati dalla soggettività dell’Altro
che si dà a noi in un movimento di feconda reciprocità. Incontro è
stupore, possibilità, occasione di sentire con l’altro la densità del qui ed
ora. Di sentire un tempo nel tempo, di costruire uno spazio, di danzare in
esso.
È proprio il dialogo a costituire la cifra del metodo psicoterapeutico
proposto da Giovanni Stanghellini (2017): “La nostra identità personale”,
sostiene lo stesso, “è un’identità narrativa che deriva dalla dialettica tra
ciò che già siamo e sappiamo di essere e l’alterità che incontriamo nella
nostra esistenza”. Essere umani significa in essenza essere in dialogo:
dialogo della persona con sé stessa e con le altre persone. Incontro,
dunque, con ciò che altro, con ciò che è altro in noi e con ciò che è altro
nel mondo esterno. Due domini di alterità che costantemente intonano il
nostro esistere. Un primo dominio relativo alla dimensione involontaria di
noi stessi: il nostro carattere non scelto, i nostri bisogni e desideri, le
emozioni e le abitudini; un secondo inerente invece al mondo esterno:
l’alterità che si dà negli eventi e negli incontri con le altre persone. Il
nostro corpo, prosegue Stanghellini, è uno dei fattori principali
dell’alterità che costituisce la persona che sono. Esso è cardine della mia
ipseità, parte più intima della mia identità di persona e, tuttavia, anche
quella più estranea in quanto corpo tra i corpi, ossia corpo biologico che
condivide con tutti gli altri corpi pulsioni e bisogni che io non ho scelto. Il
bisogno si pone, in ciò, come primordiale spontaneità del corpo.
Attraverso il bisogno, si dispiegano, a partire dal mio corpo, valori senza
che io li abbia posti: “Prima che io lo voglia, un valore già mi chiama
solamente per il fatto che io esisto nella carne” (Stanghellini, 2017, p. 42).
In virtù, tuttavia, della condizione eccentrica dell’essere umano (quella
caratteristica fondamentale per cui egli vive costantemente a una certa
distanza da sé e dal proprio ambiente), l’uomo può prendere posizione
rispetto a sé stesso, inclusa la dimensione involontaria che lo costituisce,
quindi le proprie pulsioni, le proprie emozioni, la propria storia e così via.
L’alterità, ci mostra Stanghellini, è estranea e familiare allo stesso tempo:
come due lati di una piega, l’estraneo e l’essenziale si pongono su un
piano di continuità. Si fa riferimento qui al tema del
perturbante: Unheimliche. Tale parola si colloca chiaramente all’opposto
di heimlich che significa ‘casa’, in quanto ciò che è ‘familiare’. Il
perturbante, sostiene Freud, fa segno all’incontro con il doppio. “È
il doppio segretamente familiare ciò di cui faccio esperienza nel
perturbante […In tale esperienza,] il doppio precede l’Individuum, il tutto
precede la parte. Incontrare il proprio doppio è fare esperienza di sé
come solo imperfettamente individuato, separato rispetto all’Altro.
Incontrare nell’Altro una possibilità di sé stesso prima che avvenga il
processo di individuazione” (Stanghellini, 2017, p. 47).
L’alterità e la persona si co-appartengono. Una vita che possa dirsi sana è
fondata sul dialogo con l’alterità. La salute mentale è l’esito della
dialettica equilibrata tra sedimentazione e innovazione, tra l’alterità che si
rende manifesta attraverso l’incontro con la propria dimensione
involontaria interna ed esterna e la capacità della persona di far fronte,
modulare e dar senso a questo. La patologia mentale, di converso, è
intesa come crisi del dialogo della persona con l’alterità che la abita e con
l’alterità incarnata nelle altre persone. Il sintomo, infatti, è qui inteso
come esito della mancata integrazione di ciò che è Altro nella nostra
identità narrativa. Il sintomo rende tangibile la crisi della capacità di
integrare l’alterità in una trama di significato coerente e si pone, al
contempo, come ultima opportunità, per la persona, di riconoscere
l’alterità in sé stessa.
La relazione Io-Tu, ci mostra Stanghellini, influenza in modo radicale
lo status ontologico dell’Io e dell’Altro, modificando profondamente le
strutture della soggettività dei due partner. Buber (1923) parla di “mondo
primario” della relazione Io-Tu, alludendo al fatto che il modo in cui
ciascuno è in relazione con l’Altro configura il mondo che i due andranno
ad abitare. In tale relazione vige la reciprocità:
“Nella relazione Io-Tu la soggettività è dislocata: non si può controllare
l’evoluzione del rapporto tra Sé e Altro. Entrambe le parti sono allo stesso
tempo attive e passive, causate e causanti; entrambe scelgono e sono
scelte. La relazione Io-Tu non può aver luogo solo attraverso una mia
azione o una mia scelta, né può realizzarsi senza di me, senza il mio
consenso” (Stanghellini, 2007, pp. 30-31).
Paradigma della dialettica tra persona e alterità è la mia esperienza
emotiva. Non ho la possibilità di scegliere le mie emozioni, ciononostante
esse sono una parte essenziale di me. Stanghellini ci mostra come le
emozioni siano dispositivi che svolgono un ruolo essenziale nel rapporto
tra la persona e la realtà. Esse mi consentono infatti di sentirmi coinvolto
nelle situazioni mondane e di selezionare peculiari possibilità di azione,
fanno sì che possa sintonizzarmi con le altre persone e comprendere il
senso delle azioni altrui. La conoscenza di me stesso, inoltre, passa
proprio attraverso la riflessione sulle mie emozioni. Per comprendere al
meglio la dialettica tra le emozioni e la persona è necessario far
riferimento alla distinzione tra le due forme che l’esperienza emozionale
può assumere: affetti e umori (Smith, 1986 in Stanghellini, 2017): l’umore
è un’emozione che non ha un oggetto intenzionale è vissuto come
immotivato è sostanzialmente inarticolato e tende a prolungarsi nel
tempo, l’affetto è un’emozione diretta a un oggetto intenzionale è vissuto
come motivato da qualcosa, si focalizza su un oggetto è articolato e
generalmente ha una durata più breve.
“L’ansia è un umore che ha carattere globale, non essendo focalizzata su
uno specifico oggetto, mentre la paura è un affetto che prende di mira
aspetti particolari del mondo. Su un piano pragmatico, non è difficile
cogliere la differenza: se ho paura di qualcosa, per rassicurarmi basta che
mi allontani da ciò di cui ho paura; se sono in ansia, non serve che mi
allontani, perché (finché non rendo esplicito il perché della mia ansia),
l’ansia mi seguirà ovunque” (Stanghellini, Rossi Monti, 2009 in
Stanghellini, 20017)
Ecco dunque che la trasformazione dell’umore in affetto costituisce
un’attività umana fondante e caratterizzante. La persona, infatti, può
assumere un atteggiamento attivo nei confronti delle proprie emozioni,
interrogandosi sul significato che esse hanno.
La persona è movimento, per essenza. Essa è mossa dalle proprie
emozioni, rispetto a cui può prendere posizione e muove il mondo
intorno a sé, sintonizzandosi con esso e con le altre persone. E allora
accade che ci muoviamo verso un incontro e attraverso di esso creiamo
un tempo e in questo tempo viviamo una dimensione intima unica e
irripetibile. Eterna nella sua istantaneità.
Nel 2011 Dominique Dupuy pubblica in Francia un libro dal titolo “La
Sagesse du Danseur”, La Saggezza del Danzatore, un libro che è stato
definito prezioso e intimo, essendo un libro di danza scritto da un
danzatore e che si dà nudo al mondo di chi si appresta ad incontrarlo
attraverso la lettura.
Dominique Dupuy (Parigi 1930) è considerato un Maestro, una figura
emblematica della danza contemporanea, impegnato da sempre a
condurre la danza verso un oltre, verso una dimensione sempre ancora da
raggiungere. Il suo insegnamento si rivolge in tal senso sia ai danzatori sia
a coloro che si interessano all’arte del movimento in tutte le sue forme.
Nel fornirci l’immagine del danzatore come di una presenza nello spazio
che disegna figure, accordando loro un tempo, accenti, sospensioni,
accelerazioni ed arresti, Dupuy ci parla, ad un certo punto, di un altro che
entra nel campo d’azione di colui che danza. Ecco allora che quel che egli
sta facendo si altera, prende un altro andamento, quasi inconsapevole… E
ad una iniziale sensazione di disordine, segue poi un piacere improvviso
che indica al danzatore che qualcosa in lui sta cambiando. A questo punto
Dupuy descrive ciò che accade all’altro che sta facendo ingresso in questo
campo d’azione e utilizza queste parole:
“L’altro, che succede di lui in questo tempo tutto nuovo? Come un legame
che sta tessendosi tra ciò che scopre e se stesso; tra il suo corpo in riposo
e quello dell’uomo in azione. Strano legame, non senza affetto; non è il
colpo di fulmine e tuttavia c’è nell’aria qualcosa come dell’amore.
S’allaccia un’intimità, il visitatore è visitato, come sospeso a questa cosa
che ha sorpreso e che lo sorprende, alla quale egli ha poco a poco
l’impressione di partecipare attivamente corpo e anima. Qualcosa è sorto.
Egli non resiste…. Si apposta…. Si posa…..
Quell’istante, io lo chiamo ‘la dansée’, la danzata.
La dansée appartiene alla famiglia di quelle parole che evocano
un’azione; non un risultato, ma uno slancio, una traiettoria” (Dupuy,
2014)
Ecco, questa danséè così essenzialmente resa da Dupuy potrebbe aiutarci
a cogliere quell’intimità dai tratti unici e sempre nuovi che è propria
dell’incontro tra clinico e paziente: tra persona e persona che si
apprestano a compiere un viaggio, a condividere uno slancio, a disegnare
una traiettoria, a muoversi in due entro una relazione esclusiva che ha
nel tra quella sua imprescindibile ragion d’essere.
Potrebbero piacerti anche
- Tristezza: Dalla rassegnazione alla creatività fragileDa EverandTristezza: Dalla rassegnazione alla creatività fragileNessuna valutazione finora
- La musica che guarisce: Esperienze e considerazioni all'interno dei laboratori di musicoterapia didatticaDa EverandLa musica che guarisce: Esperienze e considerazioni all'interno dei laboratori di musicoterapia didatticaNessuna valutazione finora
- La comunicazione nel Counseling: Non occorre star male per poter stare meglioDa EverandLa comunicazione nel Counseling: Non occorre star male per poter stare meglioNessuna valutazione finora
- Occultismo e filosofia - magnetismo, spiritismo e magia nella visione di un grande filosofoDa EverandOccultismo e filosofia - magnetismo, spiritismo e magia nella visione di un grande filosofoNessuna valutazione finora
- L' Altrove della mancanza nelle relazioni di esistenzaDa EverandL' Altrove della mancanza nelle relazioni di esistenzaNessuna valutazione finora
- Il pensiero oltre la siepe: Un punto di vista diversoDa EverandIl pensiero oltre la siepe: Un punto di vista diversoNessuna valutazione finora
- Noi Siamo Un Dialogo: L'alteritàDocumento14 pagineNoi Siamo Un Dialogo: L'alteritàlucatinaro1997Nessuna valutazione finora
- L'attore oltre l'arte: Esplorazioni non convenzionali della scienza della recitazioneDa EverandL'attore oltre l'arte: Esplorazioni non convenzionali della scienza della recitazioneNessuna valutazione finora
- L’unificazione della Trinità. La ragazza di Hare KrishnaDa EverandL’unificazione della Trinità. La ragazza di Hare KrishnaNessuna valutazione finora
- Schopenhauer e NietzscheDocumento6 pagineSchopenhauer e NietzscheMichelaNessuna valutazione finora
- Risveglio: manuale di consapevolezza e conoscenzaDa EverandRisveglio: manuale di consapevolezza e conoscenzaNessuna valutazione finora
- Con l'altro e per l'altro: Una filosofia del dono e della condivisioneDa EverandCon l'altro e per l'altro: Una filosofia del dono e della condivisioneNessuna valutazione finora
- La Vita NON finisce qui: Itinerario di filosofia metapsichicaDa EverandLa Vita NON finisce qui: Itinerario di filosofia metapsichicaNessuna valutazione finora
- Dio in noi. Lo Spirito nel corpo: Saggio sulla sopravvivenza della percezione. Itinerario di filosofia metapsichicaDa EverandDio in noi. Lo Spirito nel corpo: Saggio sulla sopravvivenza della percezione. Itinerario di filosofia metapsichicaNessuna valutazione finora
- Empatie-Sintesi Libro Sentire L'altroDocumento8 pagineEmpatie-Sintesi Libro Sentire L'altrogiuseppe liniNessuna valutazione finora
- SchopenhauerDocumento3 pagineSchopenhauerMattia GilardiNessuna valutazione finora
- Il Mistico: un “luogo” interiore. Riflessioni sull’esperienza mistica secondo Edith SteinDa EverandIl Mistico: un “luogo” interiore. Riflessioni sull’esperienza mistica secondo Edith SteinNessuna valutazione finora
- Bergson Sartre JaspersDocumento3 pagineBergson Sartre JaspersGloria GhiottoNessuna valutazione finora
- Gestazione per altri: Pensieri che aiutano a trovare il proprio pensieroDa EverandGestazione per altri: Pensieri che aiutano a trovare il proprio pensieroMorena PiccoliNessuna valutazione finora
- Autocoscienza e Persona. Sintesi. 2023Documento3 pagineAutocoscienza e Persona. Sintesi. 2023Jardel de oliveiraNessuna valutazione finora
- Il confronto tra il "De caelo" aristotelico e la nuova speculazione brunianaDa EverandIl confronto tra il "De caelo" aristotelico e la nuova speculazione brunianaNessuna valutazione finora
- Nuova Rivista di Counseling Filosofico 19/2023: Rivista Ufficiale della Scuola Superiore di Counseling FilosoficoDa EverandNuova Rivista di Counseling Filosofico 19/2023: Rivista Ufficiale della Scuola Superiore di Counseling FilosoficoNessuna valutazione finora
- HeideggerDocumento5 pagineHeideggernicolasgueraNessuna valutazione finora
- ANTROPOS MICROCOSMO PSICHE E LETTERATURA: L'Esplorazione della Psiche Umana attraverso la LetteraturaDa EverandANTROPOS MICROCOSMO PSICHE E LETTERATURA: L'Esplorazione della Psiche Umana attraverso la LetteraturaNessuna valutazione finora
- Sognare la Terra - Il troll nell'AntropoceneDa EverandSognare la Terra - Il troll nell'AntropoceneNessuna valutazione finora
- SchopenhauerDocumento6 pagineSchopenhauerSilvia FerrariNessuna valutazione finora
- Vangelo pratico: Dalla spiritualità alla fisica quantistica - quando nulla è impossibileDa EverandVangelo pratico: Dalla spiritualità alla fisica quantistica - quando nulla è impossibileNessuna valutazione finora
- Uomo & Donna a confronto nel pensiero di F. Nietzsche: Un approccio socio-cognitivo ad una questione non esclusivamente filosoficaDa EverandUomo & Donna a confronto nel pensiero di F. Nietzsche: Un approccio socio-cognitivo ad una questione non esclusivamente filosoficaNessuna valutazione finora
- Il confronto tra la "Fisica" aristotelica e la nuova speculazione brunianaDa EverandIl confronto tra la "Fisica" aristotelica e la nuova speculazione brunianaNessuna valutazione finora
- Solo l'amore potrà salvare l' uomo Perchè non possiamo dirci cristianiDa EverandSolo l'amore potrà salvare l' uomo Perchè non possiamo dirci cristianiNessuna valutazione finora
- Un muro di parole: L'arte di parlare senza dire niente di séDa EverandUn muro di parole: L'arte di parlare senza dire niente di séNessuna valutazione finora
- Emozioni e CorporeitàDocumento73 pagineEmozioni e Corporeitàcadar17fNessuna valutazione finora
- Heidegger - Lettera Sull'Umanismo - SintesiDocumento4 pagineHeidegger - Lettera Sull'Umanismo - Sintesimariospalla100% (1)