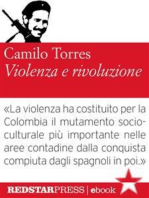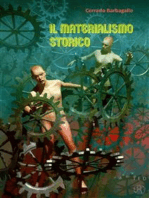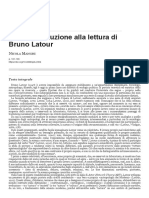Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Cap V Burke Microstoria
Caricato da
Silvia SamperiCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Cap V Burke Microstoria
Caricato da
Silvia SamperiCopyright:
Formati disponibili
Cap.
5 Burke
“A proposito di Microstoria”
Il saggio in oggetto è stato elaborato da G. Levi, il quale cerca di identificare i principali elementi
che caratterizzano la “Microstoria”.
La microstoria è una pratica storiografica che si può sintetizzare nella riduzione della scala di
osservazione dell'oggetto studiato per arrivare a chiavi di lettura più generali e scoprire fenomeni
prima non considerati.
( detto in parole semplici, la MICROstoria è una pratica storiografica che analizza le realtà micro,
quegli elementi che appaiono quasi insignificanti ma possono significare molto; è una pratica
storiografica che tende ad evitare il più possibile la generalizzazione estrema, le semplificazioni
eccessive preferendo pratiche descrittive assai complesse e articolate ma che diano un quadro
completo dell’oggetto di ricerca).
Per capire meglio cosa sia la microstoria, Jacques Revel la definisce come la volontà di studiare il
sociale non come un oggetto dotato di proprietà ma come un insieme di interrelazioni mobili (non
statiche) entro configurazioni in costante adattamento; inoltre, la microstoria ha l’obiettivo di
provare a costruire una concettualizzazione più mobile e meno rigida e gerarchizzata rispetto alla
ricerca storiografica tradizionale, una classificazione del sociale e del culturale meno
pregiudiziale, un quadro d’analisi che rinunciasse alle semplificazioni, alle ipotesi dualistiche e
alle polarizzazioni, alle tipologie rigide, e tutti quegli altri elementi che caratterizzano la ricerca
storiografica tradizionale. Jacques Revel, sostanzialmente, asseriva che gli storici hanno sempre
avuto la tendenza a semplificare la realtà; egli sostiene che gli storici dovrebbero riuscire a
descrivere la complessità del reale anche ricorrendo a tecniche descrittive, argomentative più
articolate e complesse, rispetto alle modalità sinora utilizzate che, sicuramente, rendevano il tutto
più semplice ma forse fin troppo riduttivo.
L’autore del saggio in questione, fa un “passo avanti” rispetto alla teorizzazione di Jacques Revel,
sottolineando in modo particolare (come leggeremo di seguito) la volontà antirelativistica e
l’aspirazione formalizzante che il lavoro dei microstorici ha.
La pratica storiografica della microstoria riguarda innanzitutto le procedure del lavoro dello storico.
Giovanni Levi, nel saggio in questione, analizza alcuni degli elementi distintivi della microstoria:
a. Riduzione di scala
b. Critica del funzionalismo
c. Discussione sulla razionalità
d. Carattere indiziario del paradigma scientifico
e. Ruolo dell’indivudale non in contrapposizione con quello del sociale
f. Attenzione agli aspetti argomentativi e narrativi
g. Definizione specifica del contesto
h. Rifiuto del relativismo
- La nascita della microstoria:
La pratica storiografica in oggetto nacque negli anni 70 come parte di un dibattito culturale e
politico; quegli anni furono caratterizzati dal progressivo abbandono dell’idea di una società
immutevole e statica e l’avvicinamento all’idea che la trasformazione sociale non è prevedibile,
diversamente da quanto sostenevano i modelli ottimistici delle teorie marxiste o funzionalistiche.
(Funzionalismo: concezione sociologica secondo la quale
Questo processo portò anche gli storici a rivalutare i loro stessi strumenti di lavoro e di
interpretazione;
In tal senso la pratica della microstoria è riconducibile ad una moltitudine di risposte possibili in cui
si accentuava il carattere di ridiscussione concettuale, di analisi estrema degli strumenti del
mestiere.
La microstoria richiedeva uno sforzo di rinnovamento problematico implicando un preciso
schieramento all’interno della NEW HISTORY si tratta non solo correggere ciò che sembrava
non più funzionale nella storiografica accademica, ma anche RIFIUTARE il RELATIVISMO e
IRRAZIONALISIMO, la riduzione dell’attività degli storici ad un’attività puramente retorica che
interpreta testi e non eventi. (come accennatto sommariamente all’inizio di questo riassunto). Si
trattava, quindi, di riconoscere i limiti del sapere e il funzionamento della ragione per costruire una
scienza in grado di organizzare e spiegare il mondo del passato. Il conflitto principale non è fra
nuova storia e storia tradizionale ma all’interno della storia come pratica interpretativa.
- Riduzione della scala di osservazione, su una analisi microscopica e su una lettura
intensiva della documentazione.
Questo è un altro elemento caratteristico della pratica storiografica della microstoria. Quando
parliamo di “riduzione della scala di osservazione” facciamo riferimento all’analisi del fenomeno
oggetto di ricerca non da un punto di vista macro, generale, “dall’alto” ma da un punto di vista
micro.
La scala è un oggetto di analisi e misura la dimensione reale dei campi di relazione, non la
prospettiva e la procedura dell’analisi.
N.B.: un esempio interessante che il testo riporta è quello secondo cui anche nelle relazioni minute
di chi va a comprare il pane è incluso il sistema mondiale del mercato granario e solo una
pradossale esasperazione della storia delle idee potrebbe suggerire che il mercato di un villaggio
non abbia interesse perché il suo significato è solamente locale. Con questo cosa vogliamo
intendere? Vogliamo intendere che studiare le realtà micro, come quella ad esempio di un piccolo
villaggio, di una piccola comunità, non significa né pretendere di poter generalizzare i risultati al
sistema mondo più generico né considerare i micro-sistemi come dei sistemi a sé stanti poiché,
come espresso nell’esempio del panificio, anche un piccolo sistema è incluso in un sistema macro.
Eppure, la pratica microstorica è stata assai criticata. E’ importantissimo sottolineare come siano
strettamente collegate la microstoria con le ricerche antropologiche. In particolar modo, il testo cita
numerose volte Geertz, un antropologo molto importante per le ricerche da lui condotte e le
teorizzazioni proposte.
Quindi, per sintetizzare questo passaggio, si tratta di identificare scale dimensionali differenti MA
compresenti nei fenomeni sociali. Ci si potrebbe chiedere, ma a che serve analizzare questi
fenomeni micro? La risposta è molto semplice ed importante: potremmo considerare l’analisi micro
come un’analisi fatta su esempi, una procedura semplificativa di analisi; una selezione che consente
di esemplificare i concetti generali in un punto specifico della vita reale. La dimensione del mondo
sociale di differenti categorie di persone e la dimensione dei vari campi strutturati di relazioni
mostrano proprio la scala operante nella realtà, consentono cioè di definire le diverse articolazioni
delle società complesse senza dover ricorrere (come gli storici tradizionali) a quadri teorici e
paradigmi assunti a propri.
Ma in tutto questo, il vero problema è la scelta sperimentale della diminuzione di scala
nell’osservazione. La possibilità che un’osservazione microscopica ci mostri cose che prima non
erano state osservate è il carattere unificante della ricerca microstorica. Una procedura
INTENSIVA. (ad es, l’introduzione del telaio meccanico osservata in una piccola vallata tessile può
essere utile per spiegare il tema generale dell’innovazione, delle sue cadenze, dei suoi effetti; il
mercato della terra in un villaggio per scoprire le regole sociali di uno scambio mercantile in un
mercato non ancora impersonale;)
Quindi, fondamentalmente, nei vari esempi riportati nel testo, l’obiettivo è quello di far capire come
attravverso la pratica della microstoria, attraverso la diminuzione della scala di osservazione a una
situazione estremamente localizzata, si possono mettere in luce aspetti e meccanismi sottesi molto
importanti. Cioè, fenomeni dati per sufficientemente descritti e compresi, mutando scala di
osservazione assumono significati del tutto nuovi, in grado di essere generalizzati, almeno nel loro
carattere formale di interrogazione della realtà, anche se costruiti su dimensioni relativamente
piccole, adottate sperimentalmente e non in quanto esempi.
- Nonostante sia nata nell’ambito della ricerca storica, molte delle caratteristiche della
microstoria mostrano un forte legame, come accennavamo prima, tra storia e antropologia;
soprattutto si fa riferimento alla THICK DESCRIPTION DESCRIZIONE DENSA
con cui Geertz ha definito la propria prospettiva di lavoro antropologico.
La descrizione densa non è altro che quella pratica di osservazione e ricerca che, invece di
cominciare con osservazioni e tentare di sottoporle ad una legge che le governi, comincia da
una serie di segni significanti per collocarli entro una struttura intellegibile.
“La descrizione densa viene definita come la fissazione in uno scritto di quell’insieme di
fatti significanti, interpretati attraverso l’inserimento in un contesto che è il flusso del
discorso sociale, in un lavoro microscopico che da conoscenze molto approfondite di
faccende estremamente piccole giunge alle più interpretazioni e alle analisi astratte”. La
descrizione densa corrisponde alla procedura adottata dall’etnologo.
E’ importante soffermarci sul lavoro dell’antropologo: l’antropologo studia ciò che è
estraneo ai nostri occhi, studia i mondi lontani, le culture dei popoli e l’interpretazione
rappresenta un elemento fondamentale; la cultura, infatti, consiste in una “ragnatela di
significati” l’analisi di questi significati non è una scienza sperimentale in cerca di leggi
ma una scienza interpretativa in cerca di significato.
Ma ciò non vuol dire, secondo Gerrtz, che gli approcci interpretativi debbano rinunciare ad
una formulazione/sviluppo di teorie; ma, ovviamente, date le caratteristiche
dell’interpretazione culturale, lo sviluppo teoretico è certamente difficile (n.b.:
l’interpretazione di ciascun antropologo, ricercatore è soggettiva, pur sempre a rischio di
inferenze, di giudizi soggettivi ecc… per cui la formulazione di teorie è assai difficoltosa;
non si tratta di una scienza come le altre).
L’obiettivo quindi non è di creare postulati e paradigmi astratti ma di rendere la descrizione
densa possibile e non di generalizzare attraverso i casi, ma al loro interno.
Infatti, nell’etnografia, il compito della teoria è di fornire un vocabolario in cui si può
esprimere quello che l’azione simbolica ha da dire su di sé, cioè il ruolo della cultura nella
vita umana.
Più che creare una teoria a partire dai dati dell’esperienza interpretativa, i concetti e le teorie
fanno parte proprio della descrizione densa, nella speranza di rendere scientificamente
eloquenti dei semplici eventi, ma non di creare concettualizzazioni astratte nuove.
- Rifiuto del relativismo
Nonostante i numerosi elementi in comune tra l’antropologia interpretativa e la microstoria,
2 sono le differenze più rilevanti:
1. Diversa attenzione al funzionamento della razionalità: secondo l’approccio
antropologico, il ragionamento umano dipende da certi tipi di risorse culturali in modo
da produrre stimoli ambientali necessari all’organismo; il ragionamento umano è una
ricerca di informazioni. Queste informazioni però avvengono tramite una raccolta
SELETTIVA gli stimoli vengono organizzati sia da un punto di vista intellettivo sia
un’organizzazione emotiva delle informazioni stesse; ma, i il significato dei simboli è il
loro essere condivisi, essere comunicabili in un gruppo di uomini, quindi il pensiero si
organizza secondo l’accessibilità delle strutture simboliche pubbliche; solo
secondariamente diventa una questione privata.
Il punto fondamentale da analizzare è quello del RELATIVISMO CULTURALE:
l’antropologo Geertz, sebbene accetti le considerazioni sulla mente come
sostanzialmente uguale, a livello biologico, in tutti gli uomini, egli sostiene fortemente
che la mente degli uomini dipenda fortemente dalle proprie risorse culturali. In tal modo
però si sfocia in un eccessivo relativismo culturale Approccio antropologico
sviluppato dalla scuola di F. Boas che contrappone l'analisi delle singole culture,
storicamente e spazialmente determinate, alla loro analisi comparativa, finalizzata a
individuare l'esistenza di principi comuni. Il riconoscimento della molteplicità culturale
e delle differenze si traduce in un riconoscimento dell'importanza dei costumi (o della
cultura) nell'organizzazione della vita e della società umana.
Geertz si dichiara ANTI ANTIRELATIVISTA.
L’autore del saggio, Levi, asserisce che è proprio l’identificazione di processi cognitivi
uniformi quello che consente di accettare il relativismo culturale ma di respingere il
relativismo assoluto di chi limita la conoscenza della realtà sino a farne il gioco infinito
e gratuito dell’interpretazione delle interpretazioni.
Una differenza fondamentale tra antropologia interpretativa e microstoria sta nel fatto
che l’antropologia ritiene significativi in modo OMOGENEO simboli e significati
pubblici la microstoria si sforza proprio di definire i simboli e significati pubblici in
base alle molteplicità delle rappresentazioni sociali che producono e con cui si misurano.
Secondo la prospettiva microstorica, la quantità e la qualità delle informazioni non sono
socialmente uniformi bisogna esaminare la pluralità di modelli di razionalità limitata
operanti nella realtà che si analizza, frutto di meccanismi protettivi di fronte all’eccesso
di informazioni; pensiamo a tutti quei processi di semplificazione, agli slogan
semplificati nelle scelte politiche, alle tecniche di persuasione pubblicitaria, ecc.
Date queste variabili di informazioni, diversamente manipolate, non sembra possibile un
discorso generale sul funzionamento simbolico di fronte ad una informazione che è
continuamente ricercata. E’ importante invece cercare di misurare i meccanismi
operativi della razionalità limitata per consentire la lettura differenziale delle culture di
invidividui, gruppi, società in luoghi o tempi differenti secondo diversi modi di accesso
all’informazione. Questa sorta di “comparazione” è possibile attraverso i repertori di
descrizioni dense nelle quali si possono pescare informazioni importanti per chiarire,
secondo regole non esplicitate, altri casi; quindi non si tratta di costruire una scienza
comparativa.
2. L’antropologia rinuncia alla costruzione di modelli e alla enunciazione delle stesse
regole formali del gioco interpretativo e comunicativo;
Geertz piuttosto inserisce un repertorio di concetti e teorie all’interno di un repertorio di
eventi interpretati sperando di renderli scientifici.
la microstoria non ha rinunciato alla costruzione di teorie e modelli; la microstoria ha
ritenuto essenziale una lettura più formale possibile di atti, comportamenti, strutture
sociali, ruoli e relazioni. Il vero oggetto di analisi risulta essere proprio la dinamica, il
cambiamento che investe gli individui, i quali creano continuamente le loro identità, e i
gruppi che si definiscono in base a conflitti e solidarietà e non in base ad assunti a priori
ma frutto della dimanica, oggetto dell’analisi stessa.
- Il problema della comunicazione con il lettore nella microstoria: la narrazione.
La microstoria si è posta il problema che la ricerca storica non coincide con la
comunicazione dei risultati in un libro.
Ecco che attraverso la NARRAZIONE la comunicazione con il lettore può risultare
ottimale, in quanto la narrazione ha due funzioni:
1. La narrazione di fatti concreti permette di mostrare il reale funzionamento di aspetti
della società che sarebbero deformati da operazioni di generalizzazione o
formalizzazione quantitativa (tali operazioni sicuramente non considererebbero e
descriverebbero il ruolo centrale del mutamento sociale e le dinamiche interne).
2. Uno degli oggetti della narrazione è il racconto delle procedure della ricerca, dei limiti
documentari, delle tecniche persuasive e di costruzione dell’interpretazione.
Si passa quindi da un modo argomentativo assertorio e autoritario della tradizionale pratica storica,
in cui lo storico descrive oggettivamente la realtà ad una pratica storiografica in cui vengono
descritti tutti gli strumenti adottati nella ricerca, i limiti, il punto di vista del ricercatore.
- Critica del funzionalismo
Attenzione alle incoerenze dei sistemi normativi e frammentarietà di punti di vista che
rendono qualunque sistema mobile e aperto; i microstorici si pongono in netto contrasto con
i funzionalisti ( per spiegare il comportamento la causa è da ricercare nel contesto, inteso
come un sistema coerente che può spiegare quel dato comportamento in modo perfetto).
Diversamente i microstorici si focalizzano sulla frammentarietà del sociale. Dei punti di
vista diversi, della dinamicità del tessuto sociale e l’impossibilità di generalizzazione bensì
asseriscono che il lavoro di ricerca da mettere in atto è quello di partire dall’analisi del
particolare, un particolare caratterizzato spesso dal suo aspetto individualizzato ed unico, per
normalizzarlo poi, interpretarlo alla luce del suo specifico contesto.
Ed ecco che richiamiamo il concetto di riduzione di scala: la riduzione di scale è un
operazione sperimentale che permette di mostrare le incoerenze nascoste in un sistema
sociale apparentemente, e solo apparentemente, unitario e statico. La riduzione di scala
assume l’artificiosità delle delimitazioni del contesto e delle sue coerenze, mostrandone le
contraddizioni che appaiono quando si muta l’ambito di riferimento.
La microstoria pone l’accento su diverse accezioni di contesto: contesto inteso in senso
funzionalista (come abbiamo spiegato prima); contesto sociale ricco di incoerenze nascoste
in un sistema solo apparentemente unitario; concetto di contesto che si riferisce al contesto
culturale inteso come inserimento di un pensiero nell’ambito limitato dei linguaggi a
disposizione; concetto di contesto inteso in senso formale, comparativo, fatto
dall’inserimento di un avvenimento, comportamento o concetto nella serie di avvenimenti,
comportamenti e concetti simili, anche se lontani nello spazio e nel tempo il contesto
viene visto come l’identificazione sia dell’insieme di cose che condividono un carattere
comune, sia come area di un’analogia, area della similarità perfetta di relazioni tra cose
anche molto diverse, tra sistemi di relazioni in cui sono inserite cose differenti. E proprio
quest’ultimo concetto di contesto è uno dei due filoni che la microstoria ha percorso: da una
parte la microstoria pone l’attenzione sulla contestualizzazione sociale per mostrare le
incoerenze dei contesti, e dall’altro ha cercato di identificare alcune strutture elementari
della realtà.
Attenzione: la microstoria non ha come obiettivo la generalizzazione dei risultati di un caso
singolo; essa pone l’accento sulle vicende di persone o singoli avvenimenti considerati come
possibili rilevatori di fenomeni più generali.
Potrebbero piacerti anche
- La nascita dell'approccio quantitativo alla conoscenzaDa EverandLa nascita dell'approccio quantitativo alla conoscenzaNessuna valutazione finora
- Architettura PostDecostruttivista (Vol. 1): La linea della complessitàDa EverandArchitettura PostDecostruttivista (Vol. 1): La linea della complessitàNessuna valutazione finora
- Tattiche Di Mitopoiesi. Guida Impossibile Al Luther Blissett ProjectDocumento148 pagineTattiche Di Mitopoiesi. Guida Impossibile Al Luther Blissett ProjectMarco TomassiniNessuna valutazione finora
- Riassunto - Interpretazioni Di CultureDocumento19 pagineRiassunto - Interpretazioni Di CultureGiuseppe TruglioNessuna valutazione finora
- Fabbri vs5 PDFDocumento39 pagineFabbri vs5 PDFterriblefunkNessuna valutazione finora
- Sociologia - Domande AperteDocumento41 pagineSociologia - Domande AperteFederica TrittoNessuna valutazione finora
- Salvatore Abbruzzese - Sociologia Delle ReligioniDocumento63 pagineSalvatore Abbruzzese - Sociologia Delle ReligioniDaniel MoranNessuna valutazione finora
- Daniel BertauxDocumento12 pagineDaniel BertauxMaelström ArzachNessuna valutazione finora
- Renato de Fusco - Storia e StrutturaDocumento6 pagineRenato de Fusco - Storia e Strutturacamilla.priviteraNessuna valutazione finora
- Dottrina Di KantDocumento145 pagineDottrina Di KantBhaiBehenchodNessuna valutazione finora
- Quad ErnoDocumento112 pagineQuad ErnoNatalia MenottiNessuna valutazione finora
- Niklas Luhmann Osservazioni Sul ModernoDocumento133 pagineNiklas Luhmann Osservazioni Sul ModernoGiovanni BalzanoNessuna valutazione finora
- Manuale Di Sociologia - Ferrarotti (Boris)Documento37 pagineManuale Di Sociologia - Ferrarotti (Boris)Mario Dottor BlueNessuna valutazione finora
- Soggettività, relazione sociale, costruzione sociale: Elementi per un nuovo paradigma del lavoro socialeDa EverandSoggettività, relazione sociale, costruzione sociale: Elementi per un nuovo paradigma del lavoro socialeNessuna valutazione finora
- MONGARDINIDocumento83 pagineMONGARDINIEleonora MosettiNessuna valutazione finora
- L'analisi Della Narrazione: Aspetti Teorici e Di MetodoDocumento19 pagineL'analisi Della Narrazione: Aspetti Teorici e Di MetodoPier Cesare Rivoltella100% (10)
- Violenza e rivoluzione: Per una sociologia dell'insurrezione popolareDa EverandViolenza e rivoluzione: Per una sociologia dell'insurrezione popolareNessuna valutazione finora
- Capitolo Primo Introduzione Psicologia PDFDocumento97 pagineCapitolo Primo Introduzione Psicologia PDFraffaella1968Nessuna valutazione finora
- Il Grande Mosaico Della SocietàDocumento35 pagineIl Grande Mosaico Della SocietàDiego BorroniNessuna valutazione finora
- Marrone, Efficacia Simbolica Dello SpazioDocumento12 pagineMarrone, Efficacia Simbolica Dello SpazioFrancesco PassarielloNessuna valutazione finora
- Navarini La Spirale Della RiflessivitàDocumento12 pagineNavarini La Spirale Della RiflessivitàTommaso GazzoloNessuna valutazione finora
- Narratologia 1Documento4 pagineNarratologia 1Jose ColonNessuna valutazione finora
- Manuale Di Sociologia - F.ferrarottiDocumento19 pagineManuale Di Sociologia - F.ferrarottiSara GentileNessuna valutazione finora
- Content20120201 APHEx5TemiTorrengoFilosofiadelTempoDocumento25 pagineContent20120201 APHEx5TemiTorrengoFilosofiadelTempoluxfidesNessuna valutazione finora
- Archeologie del dispositivo: Regimi scopici della letteraturaDa EverandArcheologie del dispositivo: Regimi scopici della letteraturaNessuna valutazione finora
- Loggetto Della MetafisicaDocumento33 pagineLoggetto Della MetafisicaJakimovski NenadNessuna valutazione finora
- Che cos’è la vita?: Indagini epistemologiche e implicazioni eticheDa EverandChe cos’è la vita?: Indagini epistemologiche e implicazioni eticheNessuna valutazione finora
- Sociologie e sociologi nella pandemia: Teoria, analisi e confronti nel Servizio Sanitario NazionaleDa EverandSociologie e sociologi nella pandemia: Teoria, analisi e confronti nel Servizio Sanitario NazionaleNessuna valutazione finora
- Maurizio Bazzoli - Il Pensiero Politico Dell'assolutismo IlluminatoDocumento552 pagineMaurizio Bazzoli - Il Pensiero Politico Dell'assolutismo IlluminatoOjax12Nessuna valutazione finora
- Angelo Turco - Geografie DisugualiDocumento8 pagineAngelo Turco - Geografie DisugualiTommaso CaprarelliNessuna valutazione finora
- Filosofia dell'Ottocento. Dall'Idealismo al PositivismoDa EverandFilosofia dell'Ottocento. Dall'Idealismo al PositivismoNessuna valutazione finora
- Niklas Luhmann - Osservazioni Sul Moderno PDFDocumento133 pagineNiklas Luhmann - Osservazioni Sul Moderno PDFLu Ca100% (1)
- F. Valcchi. Archivistica Parola PluraleDocumento24 pagineF. Valcchi. Archivistica Parola PluraleAlessandra MariottiNessuna valutazione finora
- Le Tipologie Del Fenomeno Rave in Un Ottica AntropologicaDocumento130 pagineLe Tipologie Del Fenomeno Rave in Un Ottica AntropologicaIsabella Venusia CarliNessuna valutazione finora
- Il Tao Della Fisica - RecensioneDocumento5 pagineIl Tao Della Fisica - RecensioneGiuseppe LiniNessuna valutazione finora
- Convegno Dottorati Di FilosofiaDocumento31 pagineConvegno Dottorati Di FilosofianadjamoNessuna valutazione finora
- Dal Pra - Sommario Di Storia Della Filosofia - 1 La Filosofia Antica e Medievale - 1990Documento385 pagineDal Pra - Sommario Di Storia Della Filosofia - 1 La Filosofia Antica e Medievale - 1990auloagerioNessuna valutazione finora
- Aspetti Della Filosofia ModernaDocumento18 pagineAspetti Della Filosofia ModernaAnonimoNessuna valutazione finora
- Sistemica, Voci Nella Complessità, U.Telfener e L.CasadioDocumento64 pagineSistemica, Voci Nella Complessità, U.Telfener e L.Casadioumberta telfener100% (1)
- Charles Taylor Gli Immaginari Sociali MoDocumento182 pagineCharles Taylor Gli Immaginari Sociali MoDomenico IannoneNessuna valutazione finora
- Biagio de Giovanni - Hegel e Il Tempo Storico Della Società Borghese (1970, de Donato) PDFDocumento214 pagineBiagio de Giovanni - Hegel e Il Tempo Storico Della Società Borghese (1970, de Donato) PDFzaadig100% (1)
- Natura e Origine Del Linguaggio - Piaget, Chomsky, TomaselloDocumento18 pagineNatura e Origine Del Linguaggio - Piaget, Chomsky, Tomasellogirellibruni100% (1)
- Filosofia Della StoriaDocumento4 pagineFilosofia Della StoriaGiulia TuratoNessuna valutazione finora
- Manuale Di Sociologia FerrarottiDocumento42 pagineManuale Di Sociologia FerrarottiFrancesco Zanca0% (1)
- Microanalisi - GrendiDocumento26 pagineMicroanalisi - GrendiingridbignNessuna valutazione finora
- Laudisa - CausalitàDocumento25 pagineLaudisa - CausalitàEster VigilantiNessuna valutazione finora
- RCR Arquitectes. Esplorando I Limiti Dell'Architettura.Documento7 pagineRCR Arquitectes. Esplorando I Limiti Dell'Architettura.Fra RanNessuna valutazione finora
- METODOLOGÍA 4AyB - 1TPDocumento7 pagineMETODOLOGÍA 4AyB - 1TPLaura Cecilia Quiroga IturraldeNessuna valutazione finora
- Why UnthinkDocumento23 pagineWhy UnthinkAnna CirilloNessuna valutazione finora
- Basso - Fenomenologia, Semiotica Ed Estetica PDFDocumento12 pagineBasso - Fenomenologia, Semiotica Ed Estetica PDFMichelle CabralNessuna valutazione finora
- Breve Introduzione Alla Lettura Di Bruno LatourDocumento4 pagineBreve Introduzione Alla Lettura Di Bruno Latourluca.valzanoNessuna valutazione finora
- Afat 30 MalrauxDocumento20 pagineAfat 30 MalrauxChildeHarisNessuna valutazione finora
- Manfredo Tafuri Progetto e Utopia Architettura e Sviluppo CapitalisticoDocumento185 pagineManfredo Tafuri Progetto e Utopia Architettura e Sviluppo CapitalisticorrrhfffanNessuna valutazione finora
- UD1 - Approccio All'UrbanisticaDocumento56 pagineUD1 - Approccio All'UrbanisticaPerseo VianelloNessuna valutazione finora
- La Performance Retorica: L'encomio Di Elena Di Gorgia Tra Improvvisazione e Metalinguaggio Di Mauro SerraDocumento14 pagineLa Performance Retorica: L'encomio Di Elena Di Gorgia Tra Improvvisazione e Metalinguaggio Di Mauro SerraMaddalena MorettiNessuna valutazione finora
- Riassunto (Parziale) - Emergentismo Di Andrea ZhokDocumento8 pagineRiassunto (Parziale) - Emergentismo Di Andrea ZhokAaron AllegraNessuna valutazione finora
- Teorie Della Ricezione Il Caso Di CalvinDocumento43 pagineTeorie Della Ricezione Il Caso Di CalvinAnna MoNessuna valutazione finora