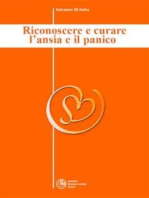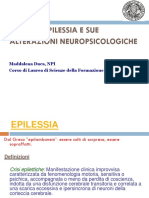Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Articolo Balsamo PCC 2007 Review Scale Depressione
Caricato da
oneoonineTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Articolo Balsamo PCC 2007 Review Scale Depressione
Caricato da
oneoonineCopyright:
Formati disponibili
Teoria
Test per lassessment della
depressione nel contesto italiano:
unanalisi critica
Michela Balsamo e Aristide Saggino
Dipartimento di Scienze Biomediche,
Universit degli Studi G. dAnnunzio di Chieti-Pescara
Riassunto
La depressione rappresenta la malattia mentale pi diffusa al mondo. Si calcola, infatti, che il 10,4%
dei pazienti che afferisce ai setting di salute mentale sia affetto da depressione (World Health Organization, 1998; 1999). Le misure self-report di depressione sono strumenti particolarmente importanti
nella diagnosi e nella distinzione tra diversi livelli di depressione e sono ampiamente usate nella
ricerca clinica per la valutazione dellefcacia dei farmaci antidepressivi e della psicoterapia. In questo
articolo presentiamo una rassegna critica delle pi importanti misure di autovalutazione della depressione disponibili nel nostro Paese, sottolineando per ognuna di esse i punti di forza e di debolezza
sotto il prolo psicometrico. Lo scopo quello di aiutare a far chiarezza nella complessit delle misure
esistenti di depressione, al ne di evitare confusioni nella pratica clinica e nella ricerca rispetto a
quale scala usare e per quale scopo. In particolare, lo studio approfondisce le propriet psicometriche di sei scale self-report di depressione: Beck Depression Inventory-II (BDI-II; Beck, Steer e Brown,
1996), Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D; Radloff, 1977), Zung Self-Rating
Depression Scale (ZSDS; Zung, 1965), Clinical Depression Questionnaire (CDQ; Krug e Laughlin, 1976),
Questionario D della batteria Cognitive Behavioural Assessment 2.0 (CBA 2.0; Sanavio, Bertolotti, Michielin, Vidotto e Zotti, 1997; Sanavio, 2002) e scala D del Minnesota Multiphasic Personality Inventory
(MMPI; Hathaway e McKinley, 1940; 1942; 1989).
Parole chiave: depressione, diagnosi, assessment, questionari, propriet psicometriche.
Summary
Depression assessment questionnaires in the Italian context: a critical analysis
Depression represents the most pervasive mental illness worldwide. In fact, depression accounts for
10,4% of all patients seen in mental healthcare settings (World Health Organization, 1998, 1999). Selfreport measures of depression are particularly important tools in the diagnosis of and discrimination
between different levels of depression, and are widely used in clinical research to assess the efcacy
Edizioni Erickson - Trento
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale - Vol. 13 - n. 2 2007 (pp. 167-199)
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
167
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale - Vol. 13 - n. 2 2007
of antidepressant drugs and psychotherapy. In this paper, we present a critical review of the most important self-report measures of depression currently available in Italy, while emphasizing the points of
strength and points of weakness of each measure from the psychometric point of view. The aim is to
help clarify the complexities of the existing depression measures in order to avoid confusion in clinical
practice and in research work in terms of which scale is to be used and for what purpose. To this end,
this study investigated the psychometric properties of six self-report depression scales: Beck Depression Inventory-II (BDI-II; Beck, Steer & Brown, 1996), Center for Epidemiological Studies Depression
Scale (CES-D; Radloff, 1977), Zung Self-Rating Depression Scale (ZSDS; Zung, 1965), Clinical Depression
Questionnaire (CDQ; Krug & Laughlin, 1976), Cognitive Behavioural Assessment 2.0, Depression Questionnaire (CBA 2.0; Sanavio, Bertolotti, Michielin, Vidotto & Zotti, 1997; Sanavio, 2002) and Minnesota Multiphasic Personality Inventory, scale D (MMPI - Hathaway & McKinley, 1940; 1942; 1989).
Keywords: depression, diagnosis, assessment, questionnaires, psychometric properties.
INTRODUZIONE
La depressione rappresenta la malattia mentale pi diffusa al mondo. Secondo le pi recenti stime dellOrganizzazione Mondiale della Sanit, il 10,4% dei pazienti che afferiscono
ai setting di salute mentale in tutto il mondo ne sono affetti (World Health Organization, 1998;
1999). La situazione sembra destinata a peggiorare, poich si prevede che per lanno 2020 la
depressione clinica risulter seconda solo alla malattia cardiaca cronica per il suo peso sulla
salute internazionale, peso identicato dallesame delle cause di morte, dalla disabilit, dallincapacit a lavorare e dalle risorse mediche impiegate (World Health Organization, 1998;
Blackburn e Moorhead, 2002). In Italia, i disturbi depressivi sono tra i disturbi mentali pi
comuni, con un tasso di prevalenza a 12 mesi del 13,5% (De Girolamo et al., 2005). Per una
disamina teorica pi approfondita, si rimanda a Saggino (2005).
Storicamente la depressione stata uno dei primi disturbi psichiatrici identicati come
unit distinta (Krug e Laughlin, 1976). La diagnosi di depressione non sempre facile, a
meno che il paziente non presenti lintera costellazione dei sintomi depressivi. Il pi delle
volte, invece, il paziente presenta una depressione mascherata, soprattutto nei casi in cui
lamenta solo malesseri sici. Alcuni sintomi sici ed emotivi riferiti dai pazienti depressi
sono identici a quelli dellansia: una delle lamentele pi comuni dei depressi, infatti, riguarda i disturbi del sonno, che sono massicciamente presenti anche nei sintomi prodotti
dallansia. Con pazienti di questo tipo facile sbagliare diagnosi e intervenire con farmaci
o altre terapie che a nulla giovano o che possono addirittura aggravare la sintomatologia,
come succede nel 75% dei casi. Poich i possibili esiti della depressione possono essere
molto gravi comportando un notevole deterioramento del funzionamento psicosociale,
sino ad arrivare al suicidio nel 15% dei casi (Goldston, Reboussin e Daniel, 2006) ,
importante fare una diagnosi differenziale afnch si possano intraprendere appropriati
trattamenti psicoterapeutici e/o farmacologici.
Dunque, il problema di una diagnosi precisa molto importante per il medico e per lo
psichiatra: la scelta del farmaco pi efcace o ladozione di altri metodi di trattamento richie-
168
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
M. Balsamo e A. Saggino Test per lassessment della depressione nel contesto italiano: unanalisi critica
de, infatti, unaccurata diagnosi differenziale. Daltra parte, la crescente sosticazione dei
criteri scientici impiegati nella ricerca obbliga alluso di strumenti di misura dei fenomeni
sempre pi accurati. necessario, allora, che sia i ricercatori sia i clinici conoscano a fondo
vantaggi e limiti degli strumenti che hanno a disposizione per la diagnosi e la discriminazione
tra diversi livelli di gravit della depressione. In assenza di strumenti di valutazione attendibili
e validi, sarebbe estremamente difcile valutare accuratamente i sintomi e la severit della
depressione, denire gli obiettivi del trattamento o valutarne lefcacia (Katz, Shaw, Vallis e
Kaiser, 1995). Una delle pi diffuse e utili modalit per la valutazione dei sintomi depressivi
rappresentata dal ricorso agli inventari di autovalutazione.
Il presente lavoro offre una rassegna dei vari strumenti self-report disponibili nel contesto italiano per la valutazione della depressione negli adulti e fornisce raccomandazioni
pratiche per i clinici, alla luce dellanalisi delle loro propriet psicometriche e dei punti di
forza e di debolezza di ciascuno.
In letteratura sono state identicate circa 25 misure self-report della severit della
depressione. Di queste, 17 sono questionari specicamente sviluppati per misurare la
severit dei sintomi depressivi nelle popolazioni adulte, mentre 8 sono stati creati per
limpiego con popolazioni speciali, ad esempio, depressione nella schizofrenia, depressione nei bambini, depressione nei setting di pronto soccorso (Nezu, Ronan, Meadows
e McClure, 2000). Nezu e colleghi (2000) hanno classicato ogni misura disponibile di
depressione in termini di utilit clinica e di ricerca. stata assegnata una valutazione di
elevato agli strumenti frequentemente usati nella ricerca o nella pratica clinica e un
valore di limitato a quelli che hanno un impiego ristretto nei setting clinici o che sono
proibitivi in termini di costi o di tempo richiesti o che, relativamente allutilit di ricerca,
presentano dati empirici insufcienti.
La tabella 1 illustra le caratteristiche formali degli strumenti di autovalutazione della
depressione per adulti che hanno unelevata utilit clinica e di ricerca secondo la classicazione di Nezu et al. (2000), di cui disponibile ladattamento italiano.
Dei 6 questionari, i primi quattro costituiscono misure speciche di depressione, mentre
gli ultimi due fanno parte di batterie pi ampie, volte a individuare le diverse aree della
patologia psichica.
Proveremo a tracciare un prolo psicometrico analitico per ciascuna scala. Nelle conclusioni, tenteremo di fornire un quadro globale della complessit e dei limiti dellautovalutazione della depressione e presenteremo la nostra proposta di costruzione di una nuova
scala self-report di misura della depressione.
SCALE DI AUTOVALUTAZIONE DELLA DEPRESSIONE
Beck Depression Inventory-II (BDI-II)
Il Beck Depression Inventory-II (BDI-II; Beck, Steer e Brown, 1996) lo strumento di
misura della presenza e della severit della depressione pi utilizzato al mondo, sia nella
popolazione normale che nei pazienti psichiatrici (Steer, Clark, Beck e Ranieri, 1998),
169
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
Affermazioni
Affermazioni
Zung Self-Rating
Depression Scale
(ZSDS)
Clinical Depression
Questionnaire dellIPAT
(CDQ)
Scala D del Minnesota
Multiphasic Personality
Inventory-2 (MMPI-2)
Affermazioni
Affermazioni
Affermazioni
Center for
Epidemiological
Studies Depression
Scale (CES-D)
Questionario di
Depressione del
Cognitive Behavioural
Assessment 2.0 (CBA)
Affermazioni
Beck Depression
Inventory-II (BDI-II)
Scala
Tipo
di item
57
24
40
20
20
21
N
di
item
24+
33 -
22+
2-
20+
20 -
10+
10 -
16+
4-
Item ipsativi
Formulazione
degli item
(positivo/
negativo)
Vero/Falso
S/No
Scala con 3
risposte
secondo gradi di
intensit crescenti
Scala Likert a 4
passi
12
10
10-20
5-10
5-10
Scala con 4
risposte
secondo gradi di
intensit crescenti
Scala Likert a 4
passi
Range
dei tempi di
somministrazione
Formato
di risposta
Tabella 1 Caratteristiche formali delle scale self-report di depressione pi diffuse in Italia
Hathaway
e McKinley
(1989)
Sanavio,
Bertolotti,
Michielin,
Vidotto e
Zotti (1997)
Krug e
Laughlin
(1976)
Zung
(1965)
Radloff
(1977)
Beck, Steer
e Brown
(1996)
Riferimenti
bibliograci
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale - Vol. 13 - n. 2 2007
170
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
M. Balsamo e A. Saggino Test per lassessment della depressione nel contesto italiano: unanalisi critica
tanto da essere inserito nella classica dei top 10 dei test psicologici pi frequentemente
usati (Camara, Nathan e Puente, 2000). Esso rappresenta un aggiornamento dellinventario
originale, il Beck Depression Inventory (BDI; Beck, Ward et al., 1961) e della sua parziale revisione (BDI-IA; Beck, Rush, Shaw e Emery, 1979), sviluppati a partire dagli anni
Sessanta con lo scopo di misurare le manifestazioni comportamentali della depressione,
senza riettere alcuna teoria riguardante leziologia o i processi psicologici sottostanti
(Sanavio e Sica, 1999). Sebbene il Beck Depression Inventory mostrasse caratteristiche
psicometriche adeguate in termini di attendibilit test-retest, consistenza interna e validit
di costrutto (vedi Beck, Steer e Garbin, 1988), la sua validit di contenuto apparsa via
via pi dubbia con il susseguirsi delle varie edizioni del Manuale Diagnostico e Statistico
dei Disturbi Mentali (DSM) e delle conseguenti modiche apportate nei criteri che deniscono i disturbi depressivi.
Dunque, il Beck Depression Inventory-II stato adattato ai criteri diagnostici dellEpisodio Depressivo Maggiore (EDM) della quarta versione riveduta del DSM (DSM-IV-TR;
APA, 2000) e, coerentemente con questi, il frame temporale di riferimento della sintomatologia descritta stato esteso da 1 a 2 settimane (Beck, Steer, Ball e Ranieri, 1996).
Bench la nuova versione della scala faccia riferimento a un sistema di classicazione
categoriale, qual quello alla base del DSM, il modello cognitivo della depressione segue
sostanzialmente un approccio dimensionale, considerando la depressione come collocabile
lungo un continuum di gravit alle cui estremit si trovano, da una parte, i sintomi affettivi
pi lievi e non clinici e, dallaltra, i disturbi affettivi clinici pi gravi (Beck, 1991; Clark,
Beck e Alford, 1999).
Propriet psicometriche e norme
Le propriet psicometriche della scala nella seconda edizione sono riassunte nella
tabella 2, sia per la versione originale che per quella italiana, recentemente pubblicata ad
opera di Ghisi, Flebus, Montano, Sanavio e Sica (2006).
Le norme della versione originale del Beck Depression Inventory-II si basano su un
campione di 120 studenti universitari e di 500 pazienti psichiatrici ambulatoriali, tratti da
4 istituti clinici statunitensi, di cui il 53% con diagnosi di disturbi dellumore, il 18% con
disturbi dansia, il 16% con disturbi delladattamento e il 14% con vari altri tipi di disturbi.
Le norme della versione italiana sono basate su un campione di taratura italiano, composto
da 723 studenti universitari, 354 adulti tratti dalla popolazione generale e un campione
clinico, composto da 135 soggetti con disturbi depressivi come problema principale e un
gruppo di controllo di 135 soggetti tratti dalla popolazione generale, selezionati in maniera
randomizzata dal campione precedente (Ghisi et al., 2006).
Attendibilit
Sia nella versione originale che nella versione italiana, gli indici di coerenza interna e
di attendibilit test-retest sono ottimi, aggirandosi intorno a 0,92. Nella versione italiana,
sono altres pi che soddisfacenti, andando da 0,76 a 0,87 (tabella 2).
171
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
0,87t
Versione originale
0,93
Versione originale
Versione italiana
Versione originale
Scale self-report
di depressione
Struttura
bifattoriale:
1. fattore
somaticoaffettivo
2. fattore
cognitivo
Struttura
bifattoriale:t
1. fattore
somaticoaffettivo
2. fattore
cognitivo
Struttura
bifattoriale:
1. fattore
cognitivoaffettivo
2. fattore
somatico
Versione italiana
Struttura
bifattoriale:
1. fattore
cognitivoaffettivo
2. fattore
somatico
0,71
con
HRSD
0,84
con BDI;
Versione originale
0,76
ad 1
mese
Validit
convergente
0,73
con QD
0,70t
con QD
0,60t
con CES-D
0,77
con QD
Versione italiana
0,93
a7
giorni
Validit
fattoriale
Validit
discriminante
0,47
con
HARS-R
0,60
con
BAI
Versione originale
BDI-II
0,80
Attendibilit
test-retest
(continua)
0,55
con STAI
0,57
con BAI
0,60t
con BAI
0,66
con STAI
Versione italiana
0,87
Versione italiana
0,92
Coerenza
interna
(_ di
Cronbach)
Tabella 2 Caratteristiche psicometriche delle scale self-report di depressione pi diffuse in Italia
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale - Vol. 13 - n. 2 2007
172
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
(continua)
Versione originale
Versione originale
Scale self-report
di depressione
0,32t
ad 1
anno
0,54t
a6
mesi
Versione italiana
0,48t
a3
mesi
Versione originale
n.r.
Versione italiana
Struttura
quadrifattoriale:t
1. disforia
2. benessere
3. sintomi somatici e di rallentamento
4. difcolt interpersonali
0,83
con
SCL-90
0,51t
e 0,70
con
scala di
depressione di
Lubin
Versione originale
n.r.
Validit
convergente
0,47 con
scala D del
MMPI
0,61 e
0,65t
con HRSD
Versione italiana
0,57t
in
media
da 2
a 8 settimane
Validit
fattoriale
Validit
discriminante
0,19t
e
0,24
con
una
scala
di Funzionamento
Sociale
0,26t
e
0,21
con
una
scala
di Aggressivit
Versione originale
CES-D
n.r.
Attendibilit
test-retest
(continua)
n.r.
Versione italiana
0,85t
Versione italiana
0,90
Coerenza
interna
(_ di
Cronbach)
M. Balsamo e A. Saggino Test per lassessment della depressione nel contesto italiano: unanalisi critica
173
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
(continua)
0,75
Attendibilit
test-retest
Versione italiana
Versione originale
Versione italiana
Versione originale
Scale self-report
di depressione
Struttura
trifattoriale:t
1. sintomatologia
positiva
2. sintomatologia
negativa
3. sintomatologia
somatica
Versione originale
0,57t con
scala D del
MMPI-2
0,62t con
scala DEP
del MMPI-2
0,60 con
HRSD
0,90t
con
CES-D
0,41t
con
HRSD
0,61t
con GDS
0,74 con
BDI
0,54 con
WDRS
0,77t con
CDQ
0,73t
con BDI
Versione originale
Struttura
trifattoriale:
1. sintomi
cognitivi
2. sintomi
affettivi
3. sintomi
somatici
Versione italiana
n.r.
Validit
convergente
Validit
discriminante
88%
di sensibilit
Versione originale
n.r.
Validit
fattoriale
(continua)
0,61t
con scala ANX
(Ansiet) del
MMPI-2
0,70t
con ASQ
Versione italiana
ZSDS
Versione italiana
0,82
Coerenza
interna
(_ di
Cronbach)
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale - Vol. 13 - n. 2 2007
174
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
(continua)
Versione originale
Scale self-report
di depressione
QD del
CBA-2.0
Versione originale
0,82t
Versione italiana
0,85t
0,72t a 30 giorni
0,88t a 7 giorni,
Versione originale
Struttura
monofattorialet
Struttura
bifattoriale
n.r.
Versione italiana
Struttura
monofattorialet
0,56
con il BDI
0,26 con la scala
Depressione tediosa del CAQ
0,70 con la scala Colpa
e risentimento
0,63 con la scala Bassa
energia
0,36 con la scala
Depressione ansiosa
0,75 con la scala
Depressione suicida
0,58 con la scala Ipocondria
0,31 con la scala D
del MMPI
Versione originale
n.r.
Validit
convergente
n.r.
Versione italiana
0,93t in
media a
distanza
di un giorno
Validit
fattoriale
Validit
discriminante
0,71
con
ASQ
(continua)
1 falso positivo
e 3 falsi negativi
0,51 con
la scala Si
del MMPI
0,32 con
la scala Sc
del MMPI
48 con
la scala Pt
del MMPI
0,34 con
la scala Pd
del MMPI
Versione originale
CDQ
0,46
Attendibilit
test-retest
Versione italiana
0,91
Versione italiana
0,93
Coerenza
interna
(_ di
Cronbach)
M. Balsamo e A. Saggino Test per lassessment della depressione nel contesto italiano: unanalisi critica
175
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
(continua)
Versione originale
Scale self-report
di depressione
0,77t a 7
giorni per
le femmine
Versione italiana
struttura
bifattorialet nelle
femmine
struttura
bifattorialet nelle
femmine
n.r.
n.r.
n.r.
= campione clinico
= campione tratto dalla popolazione generale
= campione di studenti universitari
Tipologia di campione su cui stato calcolato
il dato riportato:
n.r.
Validit
discriminante
I dati riportati sono tratti dagli studi pi rappresentativi per ogni scala. In particolare, per le versioni originali, da Beck, Steer e Brown (1996) e
da Steer, Ball, Ranieri e Beck (1999) per il BDI-II; da Radloff (1977) per la CES-D; da de Jonghe e Baneke (1989) e Sakamoto, Kijma, Tomoda
e Kambara (1998) per la ZSDS; da Krug e Laughlin (1976) per il CDQ, da Bertolotti, Zotti, Michielin, Vidotto & Sanavio (1990) e da Sanavio
(2002) per il QD del CBA 2.0, da Hathaway e McKinley (1989) per il MMPI-2. Per le versioni italiane, da Ghisi, Flebus, Montano, Sanavio e Sica
(2006) per il BDI-II; da Pierfederici et al. (1982) e da Fava (1983) per la CES-D; da Faravelli, Albanesi e Poli (1986) e Innamorati, Lelli, Aiello, Di
Lorenzo del Casale, Russo e Ferrari (2006) per la ZSDS; da Ciof, Balsamo e Saggino (in corso di stampa) per il CDQ e da Sirigatti e Pancheri
(1995) per il MMPI-2.
ASQ = Anxiety Scale Questionnaire dellInstitute for Personality and Ability Testing (IPAT);
BAI = Beck Anxiety Inventory; BDI = Beck Depression Inventory; CAQ = Clinical Analysis
Questionnaire; CDQ = Clinical Depression Questionnaire dellIPAT; CES-D = Center for
Epidemiological Studies Depression Scale; GDS = Geriatric Depression Scale; HARS-R
= Revised Hamilton Anxiety Rating Scale; HRSD = Hamilton Rating Scale of Depression;
MMPI = Minnesota Multiphasic Personality Inventory; MMPI-2 = Minnesota Multiphasic
Personality Inventory-2; QD = Questionario di Depressione del Cognitive Behavioural
Assessment-CBA- 2.0; SCL-90 = Symptom Check List-90-Revised; STAI = State-Trait
Anxiety Inventory; WDRS = Wechsler Depression Rating Scale; ZSDS = Self-Rating
Depression Scale di Zung; n.r.= dato non rinvenuto nella letteratura di riferimento
0,70t per
le femmine
Versione originale
0,64t per
le femmine
Versione originale
Struttura
bifattorialet nei
maschi
Versione italiana
Struttura
trifattorialet nei
maschi
Versione originale
n.r.
Validit
convergente
Versione italiana
0,75t
a 7 giorni
per i maschi
Validit
fattoriale
Versione originale
Legenda
0,61t per
i maschi
Attendibilit
test-retest
Versione italiana
Scala
D del
MMPI-2
Versione italiana
0,59t per
i maschi
Coerenza interna
(_ di Cronbach)
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale - Vol. 13 - n. 2 2007
176
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
M. Balsamo e A. Saggino Test per lassessment della depressione nel contesto italiano: unanalisi critica
Validit
Per la versione originale del Beck Depression Inventory sono state rinvenute diverse
soluzioni fattoriali, che spaziavano in un range da 3 a 7 fattori, a seconda della procedura
di estrazione di analisi fattoriale impiegata e della patologia del campione esaminato
(Weckowicz, Muir e Cropley, 1967; Beck e Lester, 1973; Golin e Hartz, 1979; Louks,
Hayne e Smith, 1989; Whisman, Perez e Ramel, 2000). Tuttavia, molteplici analisi fattoriali confermatorie (Clark, Cavanaugh e Gibbons, 1983; Tanaka e Huba, 1984; Steer,
Ball, Ranieri e Beck, 1999; Storch, Roberti e Roth, 2004) suggerivano lesistenza di una
generale sindrome sottostante di secondo ordine di depressione, composta da tre fattori di
primo ordine altamente intercorrelati: sintomi cognitivo-emotivi, sintomi comportamentali
e sintomi somatici (Beck e Steer, 1987). Il Beck Depression Inventory-II sembrerebbe,
invece, avere una struttura fattoriale pi forte, in cui emergono due fattori principali,
altamente correlati: sintomi cognitivi e sintomi somatico-affettivi nel campione clinico;
sintomi cognitivo-affettivi e somatici nel campione di studenti universitari, come illustrato
nella tabella 2 (Beck, Steer e Brown, 1996).
Nel contesto italiano, questi risultati sono stati confermati da diverse analisi fattoriali confermative. Nello studio di Montano e Flebus (2006), il modello a due fattori
(cognitivo-affettivo e somatico), altamente correlati (0,80), risultato avere buoni indici
di t [Comparative Fit Index (CFI) = 0,915, Root Mean Square Error of Approximation
(RMSEA) = 0,068; r2 = 251,57, gl = 89] in un campione italiano di 574 adulti sani.
Nel campione di taratura italiano, il modello a due fattori risulta quello che risponde
meglio alla struttura fattoriale del Beck Depression Inventory-II sia tra gli studenti
universitari (CFI = 0,92, RMSEA = 0,055; rapporto r2/gl = 3,08), sia nel campione di
adulti provenienti dalla popolazione generale (CFI = 0,90, RMSEA = 0,085; rapporto
r2/gl = 3,5), sia nel campione clinico (CFI = 0,95, RMSEA = 0,062; rapporto r2/gl =
1,52). Generalmente il fattore somatico-affettivo raccoglie le manifestazioni somatiche
e affettive della depressione, quali perdita di interessi, perdita di energia, agitazione,
pianto, modicazioni del sonno e dellappetito, perdita di piacere, difcolt di concentrazione, irritabilit, affaticamento; il fattore cognitivo riguarda le manifestazioni
cognitive della depressione, quali pessimismo, senso di colpa, autocritica, mancanza di
autostima, mancanza di valore, indecisione, pensieri o desideri di suicidio, fallimenti
passati, sentimenti punitivi.
La differenziazione di fattori allinterno del Beck Depression Inventory-II potrebbe
rivelarsi utile per lidenticazione di diversi tipi di depressione (endogena versus reattiva)
e per la valutazione della severit (intensit e cronicit), della prognosi e delle risposte
al trattamento dei soggetti depressi: i soggetti con punteggi pi elevati nella dimensione
cognitivo-affettiva, con una sintomatologia siologica lieve o nulla, potrebbero beneciare
maggiormente del trattamento cognitivo-comportamentale e rispondere meno bene agli interventi farmacologici (Endler, Rutheford e Denisoff, 1999). Alla luce di queste suggestive
implicazioni, non risulta chiara la scelta degli autori di riferirsi unicamente a un punteggio
totale per linterpretazione dei risultati, ignorando la potenziale multidimensionalit di
questa misura (Farmer, 2001).
177
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale - Vol. 13 - n. 2 2007
Utilit clinica e di ricerca
Pur costituendo attualmente lo standard di riferimento di ogni scala self-report per la
misura della depressione, il Beck Depression Inventory-II presenta alcuni limiti, sia dal
punto di vista clinico che psicometrico.
1. Dal punto di vista clinico, la diagnosi di Episodio Depressivo Maggiore risulta molto
pi complessa di quanto non sembri a prima vista con lausilio del Beck Depression
Inventory (Sanavio e Sica, 1999). Il pericolo di falsi positivi (circa il 18%) ha condotto gli autori del test a rivolgere precise raccomandazioni ai somministratori circa la
necessit di una corretta somministrazione dello strumento (Kendall, Hollon, Beck,
Hammen e Ingram, 1987). Va, inoltre, considerato che il sintomo perdita di peso,
incluso nel IV criterio del DSM-IV-TR, non rappresentato nellinventario.
2. Dal punto di vista psicometrico, Gibbons, Clark, VonAmmon Cavanaugh e Davis
(1985) osservano che gli item del Beck Depression Inventory consistono di un gruppo
di affermazioni graduate, o opzioni, che riettono gradi diversi di gravit del dominio
sintomatologico misurato da quellitem. Infatti, per ogni item vi sono 4 opzioni, cui
sono stati assegnati dei pesi su una base intuitiva e aprioristica, con un range che va
da 0 a 3. Lo scoring del Beck Depression Inventory secondo questa modalit assume
che: a) gli item siano egualmente efcaci nel misurare la depressione e b) gli intervalli
tra le opzioni siano psicologicamente identici. N gli item n le opzioni di risposta
sono ponderati in base a quanto gli item siano efcaci o discriminativi rispetto alle
differenze nella gravit della depressione e le risposte alle opzioni sono usate senza
considerare se le differenze tra le opzioni riettono una sottostante scala a intervalli
o ordinale. Se gli item e le opzioni sono ugualmente efcaci e se i pesi assegnati alle
opzioni sono appropriati discutibile e dovrebbe comunque essere vericato empiricamente (Gibbons et al., 1985). Contrariamente al gran numero di studi che indagano
le propriet psicometriche del BDI, non ci sono ricerche che esaminino esplicitamente
lappropriatezza delle ponderazioni assegnate alle opzioni di risposta.
3. Scarsa capacit discriminativa tra depressione e ansia, com dimostrato dalle correlazioni di 0,71 con la sottoscala di Ansia della Symptom Check List-90-Revised (SCL-90;
Steer, Ball, Ranieri e Beck, 1997), di 0,60 con il Beck Anxiety Inventory (BAI; Beck e
Steer, 1990) e di 0,47 con lHamilton Rating Scale for Depression (HDRS; Hamilton,
1960).
4. Mancanza di controllo del response set della desiderabilit sociale. Come fa osservare Arbisi (2001) nella recensione critica al Beck Depression Inventory-II nel The
Fourteenth Mental Measurements Yearbook: Quelli tra noi impegnati nella pratica
clinica si trovano spesso di fronte a pazienti che alterano la loro presentazione per
promuovere una personale agenda che pu non essere condivisa dal clinico. Il manuale
menziona indirettamente questo problema con una modalit piuttosto ambivalente ed
evitante (p. 2). Si impone cautela, dunque, qualora si usi tale strumento con persone
che potrebbero desiderare di nascondere le proprie intenzioni suicide o, di contro,
sovrastimare la loro depressione (Conoley, 1978). Nella valutazione delle risposte,
si deve tenere, altres, conto della tendenza, tipica di alcuni pazienti con depressione
178
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
M. Balsamo e A. Saggino Test per lassessment della depressione nel contesto italiano: unanalisi critica
severa, a dicotomizzare ogni cosa in maniera estremamente positiva o negativa. Si
tratterebbe, infatti, di un importante sintomo cognitivo di depressione piuttosto che di
uno stile di risposta (Beck, Steer e Brown, 1996).
Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D)
La Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D; Radloff, 1977) una
breve scala di valutazione self-report, sviluppata dal Center for Epidemiological Studies
del National Institute of Mental Health (NIMH) a partire da un pool di item di questionari
per la depressione validati intorno agli anni Settanta, tra cui il Beck Depression Inventory,
la Zung Self-Rating Depression Scale (ZSDS; Zung, 1965) e la scala D del Minnesota
Multiphasic Personality Inventory (MMPI; Hathaway e McKinley, 1940), che furono sottoposti ad analisi fattoriali atte a identicare le componenti maggiori della sintomatologia
depressiva (umore depresso, hopelessness, ovvero senso di disperazione, helplessness,
ovvero senso di impotenza, sentimenti di colpa e di inutilit), con lo specico scopo di
studiare la distribuzione della depressione nella popolazione generale.
Propriet psicometriche e norme
Le propriet psicometriche della forma originale appaiono adeguate e riconfermate nel
tempo (Radloff, 1977; Knight, Williams e Olaman, 1997), come illustrato nella tabella 2.
Le norme si basano sui seguenti campioni (Radloff, 1977): 2514 adulti bianchi normali, 1060 adulti bianchi normali, 1422 adulti bianchi normali e 70 pazienti psichiatrici
bianchi adulti.
Attendibilit
Per lattendibilit, Radloff (1977) ha riportato indici di consistenza interna piuttosto
alti e correlazioni test-retest modeste.
Validit
La validit convergente accettabile, dato che sono riportate correlazioni elevate con
altri indici di sintomatologia depressiva, quali il Beck Depression Inventory e la Zung
Self-Rating Depression Scale (Radloff, 1977). La validit di costrutto appare solo in parte
supportata dalla struttura fattoriale emergente. Sebbene la Center for Epidemiological
Studies Depression Scale sia stata costruita per porre lenfasi essenzialmente sullumore
depresso (Radloff, 1977) e sia da sempre considerata e utilizzata come test monodimensionale, con un unico punteggio totale (Gotlib e Hammen, 2002), nelle analisi fattoriali delle
componenti principali emergono generalmente 4 fattori, che spiegano mediamente il 48%
della varianza: 1) umore depresso; 2) benessere; 3) sintomi somatici e di rallentamento; 4)
sintomi interpersonali (Radloff, 1977). Il fattore benessere sembrerebbe legato alla formulazione in positivo di quattro item della scala, inseriti allo scopo di rompere uneventuale
tendenza a rispondere in modo unidirezionale (acquiescence response set).
La scala risulta, inoltre, avere una buona sensibilit (che la capacit di identicare
correttamente individui con disturbo depressivo), ma la sua specicit (ovvero, la sua
179
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale - Vol. 13 - n. 2 2007
capacit di identicare correttamente individui senza il disturbo) e il suo potere predittivo positivo (ossia, il numero di individui identicati dal test come depressi che sono
diagnosticati come tali) sono altamente insoddisfacenti, pur considerando che, in quanto
strumento di screening, il suo scopo principale dovrebbe essere quello di massimizzare la
sensibilit (Dozois e Dobson, 2002).
Utilit clinica e di ricerca
Particolarmente utile nelle valutazioni epidemiologiche e nei procedimenti di screening,
ha doti di brevit, semplicit e moderata intrusivit, che la rendono adatta allimpiego nella
ricerca e nello screening nella popolazione generale anziana, in campioni istituzionalizzati
o con disabilit, essendo stata anche adattata per luso nelle interviste computerizzate o
telefoniche.
Nel complesso, i limiti della Center for Epidemiological Studies Depression Scale sono
diversi e riassumibili come segue.
1. Tendenza alla sovrastima della depressione e, conseguentemente, alla produzione di
un largo numero di falsi positivi. Per la sua scarsa capacit discriminativa, met
degli studenti esaminati nelle varie ricerche viene classicata come depressa (Robert,
Lewinsohn e Seeley, 1991). Analogamente, Fechner-Bates, Coyne e Schwenk (1994)
hanno trovato che il 72% dei soggetti con elevati punteggi al test non incontrava i
criteri diagnostici di depressione con la Structured Clinical Interview for DSM-III-R
(SCID; Spitzer, Williams, Gibbon e First, 1990). Ci risiede probabilmente nel fatto
che il punteggio di cut off standard, che discrimina fra presenza/assenza di depressione, individuato in 16 punti, risulta eccessivamente basso, perci sarebbe preferibile
sostituirlo con un punteggio di allarme clinico di 23 punti (Pierfederici et al., 1982;
Fechner-Bates et al., 1994; Santor e Coyne, 1997). Proprio per questa ragione, secondo
Roberts e Vernon (1983) il test andrebbe usato con cautela anche nelle fasi preliminari
di screening.
2. Limitato potere discriminativo tra depressione e ansia. Elevate correlazioni con misure
di psicopatologia generale e, in particolare, di ansia, conducono a una tipica tendenza dello strumento a segnalare un numero eccessivo di casi che, pur presentando un
interesse psicopatologico, non soffrono di depressione maggiore. I sintomi esplorati
dalla CES-D potrebbero, in effetti, far parte di altre sindromi o di unaspecica demoralizzazione, per cui sarebbe irrealistico attendersi diagnosi differenziali da questo
strumento (Myers e Weissman, 1980).
3. Scarsa validit di contenuto, attribuibile alla copertura solo parziale dei criteri
diagnostici del DSM per lEpisodio Depressivo Maggiore. Gli item della Center for
Epidemiological Studies Depression Scale coincidono poco con i criteri dellEpisodio Depressivo Maggiore dellattuale versione del DSM (DSM-IV-TR; APA, 2000).
Mancano item che valutino lideazione suicidaria, i pensieri di morte, la colpa, lagitazione e la perdita di interessi (Zimmerman, 1983) e sono inclusi item che non corrispondono ai criteri diagnostici, che possono essere meglio visti come sintomi di
sindromi non depressive. La mancanza di item corrispondenti ai criteri diagnostici
180
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
M. Balsamo e A. Saggino Test per lassessment della depressione nel contesto italiano: unanalisi critica
contribuisce alla riduzione della sensibilit dello strumento, mentre linclusione di
item non corrispondenti ai criteri diagnostici riduce inevitabilmente la sua specicit
per la depressione clinica.
La validit di contenuto compromessa, altres, dalla mancata corrispondenza delle
istruzioni e del formato di risposta ai criteri diagnostici per lEpisodio Depressivo
Maggiore previsti dal DSM-IV-TR, che chiede di riferire la frequenza con cui stato
esperito il sintomo descritto nellultima settimana, anzich nelle ultime due settimane.
Ci contribuisce a ridurre ulteriormente la specicit della scala.
4. Presenza di bias di genere in almeno due item (Stommel, Given, Given, Kalaian, Schulz
e McCorkle, 1993).
5. Assenza di un manuale vero e proprio delladattamento italiano, che pone problemi
per un suo corretto impiego.
La traduzione stata curata da Pierfederici, Fava, Munari, Rossi, Baldaro, Pasquali
Evangelisti, Grandi, Bernardi e Zecchino (1982), supportata dalle back-translation
di cinque italo-americani residenti in Italia. Nel campione italiano di validazione la
CES-D discrimina signicativamente, e meglio di altri strumenti, i pazienti depressi
dai soggetti di controllo, sebbene sui punteggi medi inuiscano signicativamente let
(pi anziani sono i soggetti pi alto il punteggio) e il sesso (le donne hanno punteggi
medi pi alti).
Dunque, lontano dallessere un test di ausilio diagnostico o una misura dei cambiamenti della gravit dei sintomi depressivi nel tempo, come osservano Sanavio e Sica
(1999), la CES-D pu essere considerata al massimo solo un grossolano indicatore
di depressione nella popolazione generale, come fanno notare Myers e Weissman
(1980).
Zung Self-Rating Depression Scale (ZSDS)
Considerata il prototipo delle scale di autovalutazione per la sua semplicit, la Zung
Self-Rating Depression Scale (ZSDS; Zung, 1965) stata messa a punto per ottenere
una rapida valutazione quantitativa dei sintomi psicologici (10 item), affettivi (2 item) e
somatici (8 item) nei soggetti depressi. Rispetto al Beck Depression Inventory presenta
uno spettro sintomatologico pi ampio, dando molto peso anche allansia e ai sintomi
accessori.
Gli item sono stati ricavati sottoponendo ad analisi fattoriale un insieme di sintomi
raccolti dalla letteratura e integrati da interviste con pazienti. La met di essi formulata
e codicata allinverso, per il controllo delleffetto acquiescenza.
Un punteggio di cut off di 50 conduce a una corretta classicazione diagnostica nell88%
dei casi (sensibilit = 88%, specicit = 88%) (Basco, Krebaum e Rush, 1997).
Propriet psicometriche e norme
Sorprendentemente, nonostante la sua lunga storia di impiego nella clinica e nella ricerca, esistono pochi dati relativi alle caratteristiche psicometriche di questo strumento.
181
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale - Vol. 13 - n. 2 2007
Le norme del test furono inizialmente sviluppate su un campione di 56 pazienti psichiatrici ricoverati con una prima diagnosi di depressione: di questi, 31 furono trattati come
disturbi depressivi e 25 ricevettero diagnosi diverse in una successiva valutazione. Tuttavia,
importanti informazioni aggiuntive sono state fornite nello studio condotto da Gabrys e
Peters (1985) su un campione di 587 pazienti, di cui 369 depressi e 218 non depressi, di
et compresa tra i 12 e i 69 anni.
Attendibilit
La consistenza interna sembra adeguata, con un coefficiente split/half che varia
da 0,79 a 0,94 e un _ di Cronbach di 0,82 nello studio pi ampio (Sakamoto, Kijma,
Tomoda e Kambara, 1998), condotto su 2187 studenti universitari, riportato in tabella 2.
Generalmente, essa oscilla tra 0,71 e 0,88 in altri studi (Knight, Waal-Manning e Spears,
1983; Gabrys e Peters, 1985; de Jonghe e Baneke, 1989).
Validit
Lesame della validit convergente mostra correlazioni da moderate a elevate con altri
strumenti di depressione, come illustrato nella tabella 2 (Carroll, Fielding e Blashki, 1973;
Faravelli, Albanesi e Poli, 1986; Plutchik e van Praag, 1987). Di contro, la validit discriminante risulta molto pi sospetta: sebbene la Zung Self-Rating Depression Scale appaia
distinguere tra depressi e soggetti normali, sia in psichiatria che in medicina generale
(Gabrys e Peters, 1985; Thurber, Snow e Honts, 2002), essa meno capace di distinguere
tra depressione e ansia (Di Marco et al., 2006) o tra diversi livelli di gravit del disturbo
depressivo (Rabkin e Klein, 1987). In uno studio su un campione italiano di 140 soggetti
normali (Innamorati et al., 2006), sono riportati, infatti, indici di correlazione di 0,70 con
la scala per lansia dellInstitute for Personality and Ability Testing (IPAT), denita pi
specicamente Anxiety Scale Questionnaire (ASQ; Krug, Scheier e Cattell, 1976), e di
0,61 con la scala di contenuto ANX del MMPI-2 (Hathaway e McKinley, 1989), com
possibile notare nella tabella 2.
La struttura fattoriale della scala stata oggetto di indagine in diverse culture, da
quella olandese a quella giapponese, e ha portato allidenticazione di un numero ampio
di fattori, da uno a sette. Ad esempio, Sakamoto, Kijma, Tomoda e Kambara, (1998), in
un campione di 2187 studenti universitari giapponesi, hanno trovato tre fattori che hanno
interpretato come sintomi cognitivi, sintomi affettivi e sintomi somatici. Tale struttura
stata supportata da una analisi fattoriale confermativa (Goodness of Fit Index, GFI = 0,92).
Anche Kivelae e Pahkala (1987) hanno trovato tre fattori, che hanno, tuttavia, classicato
come Umore depresso, Perdita di autostima e Irritabilit e agitazione.
Utilit clinica e di ricerca
Gli studi condotti su questa scala inducono a ritenere che la Zung Self-Rating Depression
Scale, a dispetto della sua popolarit nei paesi anglosassoni, non pu essere utilizzata come
strumento per la misura della gravit della depressione o dei suoi cambiamenti nel corso
del trattamento (Gotlib e Cane, 1989; Basco, Krebaum e Rush, 1997; Dozois e Dobson,
2002). Possiamo identicare i limiti della scala in quelli che seguono.
182
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
M. Balsamo e A. Saggino Test per lassessment della depressione nel contesto italiano: unanalisi critica
1. Copertura parziale dei criteri del DSM-IV-TR per lEpisodio Depressivo Maggiore:
sono inclusi solo 5 dei 9 criteri, mentre sono coperti da un solo item e, quindi, inadeguatamente sondati i rimanenti 4 (anedonia, disturbi del sonno, sentimenti di inadeguatezza
o di colpa eccessivi, idee e tentativi di suicidio).
2. Mancanza di univocit dei dati sulla validit (Mayer, 1977; Ponterotto, Pace e Kavan,
1989) e, quindi, una dubbia validit di costrutto. Schotte, Maes, Cluydts e Cosyns
(1996) hanno contestato dal punto di vista empirico lassunto secondo cui gli item
formulati in positivo e in negativo riettano lo stesso costrutto. In un campione di 338
depressi, infatti, gli stessi autori trovarono che il punteggio ricodicato della Zung
Self-Rating Depression Scale gonava la media dei punteggi agli item. Inoltre, la
maggior parte degli item formulati in positivo e in negativo presentava saturazioni
salienti su diversi fattori. Sebbene questi risultati non siano stati trovati solo in questa
scala, essi gettano dubbi sulla sua validit di costrutto come misura di sintomi depressivi. La struttura fattoriale sembrerebbe, infatti, identicare, almeno in parte, le polarit
degli item del test piuttosto che valutare le componenti cognitive o psicomotorie della
depressione (Dozois e Dobson, 2002).
3. Limitata capacit discriminativa tra i vari livelli di depressione.
4. Scarsa validit discriminante (Dobson, 1985; Tanaka-Matsumi e Kaneoka, 1986;
Innamorati et al., 2006).
Una possibilit di impiego di questa scala quale strumento di screening ne prevede luso in associazione con uno strumento psicometricamente pi rafnato, come il
Beck Depression Inventory-II. Sebbene siano riportate alte correlazioni tra le due scale
(Plutchik e van Praag, 1987), esse sembrerebbero fornire informazioni complementari:
il Beck Depression Inventory-II si focalizza sullintensit dei sintomi depressivi, la
Zung Self-Rating Depression Scale enfatizza la loro frequenza. Tuttavia, alcuni autori
italiani (Innamorati et al., 2006) escluderebbero anche questa ipotesi, prevedendone
il ritorno nelloblio senza rimpianti (Sanavio, 2006).
Clinical Depression Questionnaire (CDQ)
Il Clinical Depression Questionnaire (CDQ; Krug e Laughlin, 1976), altrimenti denito
IPAT Depression scale, conserva unimportanza essenzialmente storica, dato che trova il
suo progenitore (Krug e Laughlin, 1976) in un test importante, quale il Clinical Analysis
Questionnaire (CAQ; Delhees e Cattell, 1975), a sua volta costituito da una forma abbreviata del Questionario dei 16 Fattori della Personalit (16 PF; Cattell, Eber e Tatsuoka,
1970) e da 12 scale per la valutazione di tratti patologici, di cui 7 rispecchiano altrettanti
fattori di depressione, correlati tra loro, e 5 corrispondono a fattori clinici scoperti da
Cattell e Bolton (1969).
Attraverso unaccurata fusione di due strategie di costruzione dei test (lanalisi fattoriale
e il metodo empirico dei gruppi contrapposti), furono selezionati 36 item, che dimostrarono
uneccellente validit per la misura del fattore puro della depressione. Tuttavia, dato che
nel corso della selezione degli item si and formando un sotto-raggruppamento di item
183
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale - Vol. 13 - n. 2 2007
connessi allansia, e data la correlazione di circa 0,80 con lASQ (Krug, Scheier e Cattell,
1976), in linea con lesperienza clinica che da sempre confermava la stretta connessione
tra i sintomi dellansia e della depressione, fu inserito un fattore di correzione, costituito
da quattro item moderatori che presentavano correlazioni trascurabili con la depressione
ed elevate con lansia, riducendo cos la correlazione tra il CDQ e lASQ e migliorando
il potere discriminativo del CDQ.
La decisione di includere o no questi quattro item nel punteggio totale della depressione
come fattore di correzione lasciata a chi fa uso del test: nel manuale del test, infatti, sono
indicate le norme per entrambe le possibilit.
Propriet psicometriche e norme
Le norme sono basate su poco pi di 2000 casi, reclutati da oltre 60 localit diverse
degli USA e del Canada. Il punteggio del soggetto viene confrontato con quello di un adulto
normale di 30 anni di et circa. Sono state, inoltre, fornite norme per sei gruppi speciali
(458 studenti universitari, 211 carcerati, 728 casi clinici la cui diagnosi principale non
la depressione, 195 alcolizzati, 69 tossicomani) (Krug e Laughlin, 1976).
Attendibilit
Lattendibilit della scala, calcolata sui gruppi clinici di cui sopra, inclusi i 67 depressi,
e su 632 adulti di controllo, alta, con stime di coerenza interna di circa .90 in media
(Krug e Laughlin, 1976).
Validit
La validit del test stata esaminata sotto diversi aspetti. emersa una correlazione
di circa 0,88 tra il punteggio del test e un fattore puro di depressione, in un campione
di 1904 casi, composto da persone normali e da soggetti clinici. Lindagine sul potere
discriminativo del test, ossia su come il test identica la differenza tra soggetti normali e
soggetti depressi, ha chiarito che un punteggio sten di 8, 9 o 10 al test si verica allincirca
da 4 a 30 volte pi spesso tra i depressi e tra i casi clinici piuttosto che tra i soggetti normali
(Krug e Laughlin, 1976).
Utilit clinica e di ricerca
Sebbene il test abbia avuto unindubbia importanza storica, attualmente esso non possiede pi una validit pratica rispetto al criterio diagnostico, dato che successivamente
i criteri per la diagnosi di depressione sono stati in parte modicati, soprattutto con la
pubblicazione delle pi recenti edizioni del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi
Mentali. Ulteriori limiti del questionari sono i seguenti.
1. Il formato di risposta molto discutibile perch introduce esso stesso una fonte di variabilit non controllabile; 5 item richiedono una risposta corrispondente a: a) quasi
sempre, b) qualche volta (o talvolta), c) quasi mai; 20 item richiedono una risposta corrispondente a: a) vero, b) incerto, c) falso; un item richiede una risposta
del tipo: a) s, b) forse, c) no.
184
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
M. Balsamo e A. Saggino Test per lassessment della depressione nel contesto italiano: unanalisi critica
2. La validit di criterio dovrebbe essere sottoposta a ulteriori indagini, dato che, come
riportato nella tabella 2, emerge una correlazione di entit modesta tra il CDQ e la
scala D del Minnesota Multiphasic Personality Inventory (r = 0,31, n.s.), comunque
pi bassa di quella ottenuta con altre scale del MMPI, quali Deviazione Psicopatica,
Psicastenia, Schizofrenia e Introversione Sociale (Krug e Laughlin, 1976).
3. In Italia presente ladattamento a cura di Novaga e Pedon (1979), ma il campione di
standardizzazione, che assomma a oltre 2000 casi, , tuttavia, statunitense e in parte
canadese. Tuttavia, in uno studio recente (Ciof, Balsamo e Saggino, in corso di stampa), la scala stata sottoposta a un campione italiano di 240 studenti universitari, in
cui stata valutata ladeguatezza di una versione con un formato di risposta a cinque
alternative in luogo di tre.
SCALE INSERITE IN BATTERIE PSICODIAGNOSTICHE
Tracceremo ora un prolo psicometrico delle scale self-report di depressione disponibili in versione italiana, che fanno parte di batterie pi ampie, destinate a misurare la
psicopatologia ad ampio spettro: il Questionario D della batteria Cognitive Behavioural
Assessment 2.0 (CBA 2.0; Sanavio et al., 1997; Sanavio, 2002) e la scala D del MMPI
(Hathaway e McKinley, 1940; 1942; 1989). Lutilizzo di una batteria ha evidenti vantaggi
ai ni diagnostici.
Questionario D del Cognitive Behavioural Assessment 2.0
Il Questionario D stato costruito appositamente per essere inserito nella batteria
Cognitive Behavioural Assessment 2.0 (Bertolotti et al., 1985; Sanavio, 2002), che un
insieme di strumenti autodescrittivi utile per ottenere un primo screening su un ampio
ventaglio di aree psicologiche disfunzionali (ansia, disturbi psicosiologici, tratti di personalit, ossessioni e compulsioni, sintomi depressivi) e per vericare lefcacia dellintervento cognitivo-comportamentale. La batteria nata allinterno di un modello di
assessment concepito come processo clinico-psicologico, integrato sia orizzontalmente
(multidimensionale) sia verticalmente (organizzato gerarchicamente per approfondimenti
successivi) (Mucciarelli, Chattat e Celani, 2002).
Il questionario, che costituisce la scheda 8 della batteria, misura manifestazioni disforiche e depressive di rilievo sub-clinico, di frequente associate con altri disturbi (Sanavio
et al., 1997), attraverso 21 item, ispirati prevalentemente alle scale di Beck (Beck et al.,
1961; Beck, Rush, Shaw ed Emery, 1979) e di Zung (1965), da cui sono stati sistematicamente esclusi i contenuti psicosomatici, data la presenza di un apposito questionario
nella stessa batteria.
Ogni item costituito da una serie di descrizioni che fanno riferimento a diversi aspetti
del soggetto, disposti in ordine crescente di difcolt, e da un formato di risposta dicotomico (s/no). Bassi punteggi indicano lassenza di manifestazioni depressive; alti punteggi
indicano, invece, lesistenza di una condizione disforica non necessariamente depressiva.
185
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale - Vol. 13 - n. 2 2007
Uno stato depressivo, inoltre, potrebbe essere secondario a numerosi altri disturbi sia di
carattere medico che psicologico. Ci pu essere chiarito attraverso luso del colloquio
e delle scale secondarie, tra cui il Beck Depression Inventore (Sanavio e Sica, 1999;
Sanavio, 2002).
Propriet psicometriche e norme
Il Cognitive Behavioural Assessment 2.0 dispone di un campione normativo, aggiornato nel 1992, che comprende pi di 2300 soggetti, divisi per sesso e per tre fasce det.
Per la popolazione ultrasettantenne sono presentate norme separate che fanno riferimento
a uno studio epidemiologico condotto su 583 anziani normali, divisi per sesso e cinque
classi det (Della Sala e Zotti, 1994; Sanavio e Vidotto, 1996). Sono, inoltre, disponibili
norme, divise per sesso e fasce det, relative a pi di 6000 pazienti ricoverati per trattamento riabilitativo nellarea cardiologica, pneumologica, neurologica/siatrica, della
tossicodipendenza, delle distonie e malattie professionali (Bertolotti, Michielin, Sanavio
e Zotti, 1994).
Attendibilit
stata, successivamente, indagata la consistenza interna, risultata pari a 0,82, in un
gruppo di riferimento formato da 1722 soggetti (87,6% maschi), di et compresa tra i 16 e gli
80 anni, appartenenti alla popolazione normale di tutto il territorio nazionale. Per la misura
dellindice di fedelt test-retest, sono state effettuate due rilevazioni a 7 (0,88) e 30 giorni
(0,72), su due gruppi di soggetti rispettivamente di 124 e 76 unit (Sanavio, 2002).
Validit
Il questionario stato sottoposto a una validazione preliminare su piccoli campioni,
in base alla quale si caratterizza come una misura monofattoriale omogenea (_ = 0,86)
e stabile (r = 0,88, a distanza di sette giorni, r = 0,72 a un mese), sensibile a variazioni
di et (i punteggi medi tendono ad aumentare con let, in modo congruo con quanto
noto dalla letteratura psicologica) e di genere (le donne hanno punteggi medi pi elevati)
(Sanavio e Sica, 1999).
Per valutare la validit di costrutto dello strumento, i punteggi del Questionario D sono
stati confrontati con quelli della versione italiana del Beck Depression Inventory in 46
pazienti psichiatrici depressi.
La correlazione tra i due strumenti risultata pari a 0,56, ovvero abbastanza forte da
considerare il costrutto valido, e abbastanza bassa da permettere di concludere che lo strumento misura taluni aspetti che il Beck Depression Inventory non considera. Lesame della
validit discriminante ha portato a rinvenire un falso positivo e tre falsi negativi, usando un
cut off di 15 in un campione di 46 pazienti psichiatrici depressi (Bertolotti et al.,1990).
Utilit clinica e di ricerca
Lobiettivo che ha mosso il gruppo CBA verso la costruzione di una nuova scala di
depressione nato dallesame dei limiti delle scale precedenti, individuati nelleccessiva
186
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
M. Balsamo e A. Saggino Test per lassessment della depressione nel contesto italiano: unanalisi critica
lunghezza, nella modesta utilit clinica e validit discriminante, nellinadeguata validazione
sulla popolazione italiana, nella limitata utilit con popolazioni con depressione subclinica,
nelle scarse traduzioni o nelluso limitato in Italia.
Il questionario D del CBA 2.0 effettivamente supera questi limiti, offrendo diversi altri
vantaggi: il campione normativo italiano molto ampio, le norme speciche risultano un
utile elemento di riferimento a chi applica la batteria in ambito ospedaliero, lo scoring
computerizzato consente un notevole risparmio di tempo e risorse.
Il limite principale di questa scala in ambito clinico che il suo uso rientra allinterno
della batteria completa, che richiede tempi di somministrazione piuttosto lunghi. Tuttavia,
non infrequente luso, in ambito clinico, di una versione autonoma della scheda 8, che,
unita alla scheda 2 (corrispondente allo State-Trait Anxiety Inventory per la misura dellansia), nota con il nome di Scale A-D (per lo studio di validazione si veda Vedana et
al., 2001).
Nei setting di ricerca lo strumento fornisce utili linee guida per un sistematico processo
decisionale diagnostico, che ne incrementa sia la validit diagnostica che lattendibilit
(Nezu et al., 2000).
Scala D del Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
La scala D corrisponde alla scala 2 del Minnesota Multiphasic Personality Inventory,
sia nella prima edizione (MMPI-I; Hathaway e McKinley, 1940; 1942), sia nella seconda
(MMPI-2; Hathaway e McKinley, 1989; Pancheri e Sirigatti, 1995) e non dovrebbe mai
essere somministrata al di fuori dellintera batteria.
La procedura di costruzione della batteria consiste nel metodo orientato al criterio,
in base al quale si scelgono gli item che discriminano uno o pi gruppi criterio (individuati
clinicamente attraverso luso di categorie psichiatriche correnti) da quelli di controllo.
Dunque, la logica per la scelta degli item non di tipo teorico, n intuitivo, bens pragmatico (Kline, 1993). La scelta degli item per costruire la scala D fu operata sulla base
della loro capacit di discriminare tra pazienti psichiatrici con diagnosi di depressione,
pazienti psichiatrici non depressi e due gruppi di soggetti normali. Nel MMPI-2, 3 item
sono stati eliminati, cosicch la scala risulta composta da 57 item, che si riferiscono a
disturbi dellumore, del pensiero, a sintomi psicosici, nonch ad aspetti di personalit di
base riguardanti eccessivo senso del dovere, standard personali elevati e intrapunitivit.
Nellinsieme, dei 9 criteri diagnostici del DSM-IV-TR, quello che riguarda idee o tentativi
di suicidio non contemplato da nessun item e quello che si riferisce a variazioni nel peso
corporeo e nellappetito denito da un solo item.
Propriet psicometriche e norme
Il campione impiegato per la standardizzazione del Minnesota Multiphasic Personality
Inventory-2 pi ampio e ben distribuito rispetto a quello originario, includendo 1138
maschi e 1562 femmine, divisi per area geograca, razza ed et. La taratura italiana si
avvalsa di un campione di 1375 soggetti, di cui 403 maschi e 972 femmine, di et media
187
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale - Vol. 13 - n. 2 2007
pari a 27 anni, con scolarit media pari a 12 anni. I punteggi grezzi sono stati trasformati
in punti T, con media = 50 e DS = 10. In Italia, la versione computerizzata del Minnesota
Multiphasic Personality Inventory-2, denita MMPI-2 Panda, stata tarata su un campione
di 2686 soggetti normali, di cui 1336 maschi e 1350 femmine, residenti in varie regioni
italiane (De Fidio e Pancheri, 2007).
Attendibilit
Si tratta di una misura alquanto stabile (attendibilit test-retest 0,75 a distanza di una
settimana). Secondo Anastasi (2002), invece, la scala valuta un comportamento cos
variabile nel tempo da far apparire fuori luogo qualsiasi discorso sulla sua attendibilit
(p. 656).
Validit
Le critiche alla validit riguardano vari aspetti e portano alla conclusione che la scala
sia un dubbio indicatore di depressione (Ancona et al., 1985; Boncori, 1993). Per quel che
riguarda il contenuto degli item, stato evidenziato sia il fatto che item di altre scale del
MMPI sono indicatori altrettanto buoni di depressione (Calonghi e Espinosa, 1965), sia la
loro eterogeneit allinterno della scala. Proprio sulla base di questa critica stata costruita
la scala di contenuto depressione e apatia, composta di 28 item, di cui solo 10 presi dalla
scala D. Secondo altri autori, questa scala misura non tanto uno stato patologico, quanto
fattori di personalit (Mayer, 1977), il che potrebbe essere in rapporto con la sua modesta
sensibilit agli effetti dei trattamenti farmacologici (McNair, 1974).
Recentemente, il problema della sensibilit e del potere predittivo della scala stato
connesso alla sua mancanza di unidimensionalit. In uno studio recente (Chang, 1996),
stata esaminata la struttura dimensionale sottostante della scala D del MMPI-2 sia con il
modello di Rasch dicotomico (Rasch, 1960-1980) sia con lanalisi fattoriale in un campione
di 2600 soggetti normali (dai 18 agli 84 anni). Sono emerse 2 sottoscale dal contenuto
omogeneo, denite depressione mentale e depressione sica. Tali metodologie di Rasch
hanno fornito cos una base per una migliore comprensione della struttura sottostante.
Utilit clinica e di ricerca
In accordo con Nezu et al. (2000), riteniamo che sia lutilit clinica che di ricerca della
scala siano limitate. Nella pratica clinica, il tempo richiesto per la somministrazione dellintera batteria (composta da 567 item) e per linterpretazione di gran lunga superiore
se raffrontato ai potenziali vantaggi offerti dallapplicazione della batteria stessa (Nezu
et al., 2000).
Boncori (1993) suggerisce di interpretare i punteggi della scala, ponendoli in relazione
con quelli di altre scale, magari ricorrendo a codici a 2 o 3 punte, che si sono rilevati abbastanza stabili. Nella ricerca il ricorso a questa scala generalmente subordinato alluso
dellintera batteria, il cui metodo di costruzione presenta evidenti limiti strutturali, secondo
Kline (1993). Infatti, la scelta dei gruppi criterio risente dellinattendibilit dovuta alla
diagnosi psichiatrica, nonch allo scarso accordo rispetto a quali categorie andrebbero
usate; la mancanza di signicato psicologico delle scale cos costruite limita inoltre la
188
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
M. Balsamo e A. Saggino Test per lassessment della depressione nel contesto italiano: unanalisi critica
generalizzabilit dei risultati. Alla luce di queste obiezioni psicometriche, secondo Kline
sarebbe stato meglio costruire un questionario fattorializzato completamente nuovo
(1993, p. 499).
Pertanto, le elevazioni della scala D non sono facilmente interpretabili dato che la scala
non riette un costrutto unidimensionale (Chang, 1996).
CONCLUSIONI
Sia i ricercatori sia i clinici dovrebbero conoscere bene le propriet psicometriche e
lo sviluppo degli inventari self-report per la misura della depressione, in modo da essere
consapevoli di quali aspetti possono non essere attendibilmente e validamente indagati
attraverso lo specico strumento di assessment usato (Endler, Macrodimistris e Kocovski,
2000).
Pi precisamente, dato che strumenti diversi misurano aspetti diversi della depressione
(cognitivi, affettivi e siologici, ecc.), importante conoscere quali aspetti della depressione capace di identicare una scala e compensare appropriatamente gli aspetti che
non sono stati indagati con luso di altri inventari di autovalutazione o con le domande di
unintervista diagnostica.
Lautovalutazione della depressione presenta in s indubbi vantaggi, che vanno dalla
velocit alla facilit di somministrazione, particolarmente importanti nella psicoterapia
cognitivo-comportamentale, che include un periodico automonitoraggio (Nezu et al., 2000).
Tuttavia, essa porta con s anche una serie di limiti, che tenteremo di sintetizzare qui di
seguito.
1. La distribuzione dei punteggi totali delle scale self-report ha evidenziato che quasi
tutte hanno una distribuzione unimodale. Tuttavia, mentre le scale di eterovalutazione
mostrano unasimmetria verso sinistra, le scale di autovalutazione, eccetto il Beck
Depression Inventory, sono sbilanciate verso destra (Faravelli, Albanesi e Poli, 1986).
La ragione di ci pu risiedere in due ordini di fattori: a) il paziente tende mediamente
a fornire una valutazione cognitiva del suo stato emotivo e della sua condizione come
pi grave rispetto alla valutazione obiettiva effettuata da un osservatore esterno, in
quanto ha come unico riferimento le proprie precedenti esperienze interne, a differenza
dello psichiatra che lo valuta in relazione ad altri casi con cui venuto a contatto; b) la
depressione una condizione che porta il paziente al peggiore pessimismo, inciandone le capacit critiche, per cui il proprio stato attuale vissuto generalmente come
la condizione peggiore possibile. Non a caso, quando il paziente non costretto da
ancoraggi precisi, tende a posizionarsi nella fascia di gravit estrema (Conti, Ruggeri
e Faravelli, 1999).
2. Inadeguatezza dei criteri e del metodo di scoring: opportuno che una scala self-report
preveda criteri di scoring ben deniti; in questo senso, il Beck Depression Inventory
si rivelato superiore alle altre scale di autovalutazione, risultando lunica fra le scale
di questo tipo a correlare abbastanza bene con le misure di valutazione del clinico (Faravelli, Albanesi e Poli, 1986). Inoltre, il metodo tradizionale di scoring delle
189
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale - Vol. 13 - n. 2 2007
scale di autovalutazione della depressione prevede luso del punteggio grezzo totale
(dato dalla somma algebrica dei punteggi ai singoli item) come indice di gravit della
depressione. Questo metodo risulta incongruo, in quanto il punteggio assunto come
diagnostico deriva anche da sintomi presenti a livelli di frequenza o di gravit tali che
non sarebbero stati presi in considerazione da unintervista diagnostica, che prende in
considerazione per la diagnosi solo sintomi che vanno da un certo livello di gravit in
poi (Zimmerman, 1983). In questo senso, il punteggio totale esprimerebbe pi la pervasivit del quadro clinico che non la sua gravit. Inoltre, questo metodo pu rivelarsi
fallace poich si basa su una serie di assunzioni che potrebbero essere false (Gibbons,
Clark, Von Ammon Cavanaugh e Davis, 1985): a) attribuendo lo stesso peso a ogni
item, si assume che ogni item o sintomo su una scala rappresenti un uguale livello di
gravit psichiatrica, laddove ci si verica raramente. Alcuni sintomi sono presenti solo
nei pazienti pi gravemente depressi, mentre altri si trovano sia in pazienti con bassi
livelli di depressione che in quelli con alti livelli di depressione; b) si assume che ogni
sintomo sulla scala sia ugualmente correlato con la dimensione clinica di interesse. In
realt, alcuni sintomi possono discriminare bene tra individui depressi e non, mentre
altri possono essere correlati a un fenomeno differente, come una malattia sica; c) il
confronto dei punteggi totali tra popolazioni diverse (ad esempio, i punteggi del Beck
Depression Inventory in pazienti con disturbi sici e mentali) assume che i singoli item
abbiano caratteristiche identiche nei diversi campioni. Un sintomo che discrimina attendibilmente livelli alti e bassi di depressione nei pazienti psichiatrici pu non essere un
reale discriminante di livelli alti e bassi di depressione in pazienti con disturbi sici.
Dunque, dal punto di vista teorico, luso dei punteggi totali sotteso da una logica molto
carente, non dissimile da quella che muove un geografo a valutare una determinata area
geograca sommando il numero degli abitanti, la lunghezza dei umi e laltezza delle
montagne (Conti, Ruggeri e Faravelli, 1999). Da un punto di vista pratico, una diminuzione dei sintomi accessori, che pu ottenersi per un insieme di fattori del tutto aspecici,
si riette in una diminuzione del punteggio totale, dando lillusione di un miglioramento
clinico anche quando i sintomi nucleari rimangono inalterati (Conti, 2002).
Daltra parte, occorre considerare che nella prassi ladditivit dei punteggi porta a
risultati meno astrusi di quanto non sia lecito attendersi in base alle considerazioni
teoriche. Il pi delle volte, infatti, limpressione clinica sostanzialmente concorde con
il punteggio globale di una scala di valutazione, probabilmente perch anche i nostri
comuni atti di giudizio sono in buona parte additivi (Poli e Faravelli, 1981).
Quindi, se appare improponibile luso del punteggio totale di una rating-scale come
termometro psichico per caratterizzare un paziente, possibile che tale punteggio
possa avere una certa validit nel caratterizzare un gruppo. Ad esempio, il dato che
in una certa ricerca il campione presenta una media X e una DS Y a una data scala,
probabilmente contiene pi informazioni per il lettore che abbia pratica di quella scala
che il sapere che i pazienti erano moderatamente gravi (Poli e Faravelli, 1981).
3. Scarsa validit di contenuto, se si usa come criterio la diagnosi di Episodio Depressivo
Maggiore del DSM-IV-TR. In effetti, come sostengono Clark, Beck e Alford (1999),
190
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
M. Balsamo e A. Saggino Test per lassessment della depressione nel contesto italiano: unanalisi critica
se davvero esiste un insieme di sintomi unanimamente considerati caratteristici della
depressione sia dagli psicologi che dagli psichiatri, questo il gruppo dei sintomi che
caratterizza lepisodio depressivo maggiore (p. 2).
4. Mancanza di omogeneit nei contenuti delle varie scale, che, riettendo le diverse teorie
degli autori che le hanno costruite, misurano aspetti diversi dello stesso costrutto. Questo
dato emerge da molteplici fonti: a) losservazione del peso relativo assegnato alle singole
componenti del quadro depressivo nelle diverse scale di valutazione evidenzia unestrema
difformit tra esse, come emerge nello studio di Faravelli, Albanesi e Poli (1986), in cui
vengono confrontate sei scale di valutazione della depressione, di cui quattro autocompilate. Ad esempio, i sintomi nucleari della depressione, nel loro insieme, pesano fra il 40
e il 50% nellHamilton Rating Scale for Depression, circa il 70% nella Zung Self-Rating
Depression Scale e oltre il 70% nel Beck Depression Inventory; b) la bassa concordanza tra i punteggi totali delle diverse scale evidenzia ancora di pi questo fenomeno. I
coefcienti rinvenibili in letteratura variano tra 0,14 e 0,77: pur presumendo di misurare
la stessa entit, nel migliore dei casi due scale di depressione avrebbero solo il 59%
della varianza comune (Conti, Ruggeri e Faravelli, 1999); c) lanalisi fattoriale, tecnica
statistica multivariata che permette di individuare le dimensioni comuni a un insieme di
variabili, applicata allo studio della struttura interna delle singole scale self-report, ha
evidenziato differenze considerevoli tra i vari strumenti, ad ulteriore dimostrazione che
concezioni diverse della depressione stanno alla base delle differenti scale. Questo limite
renderebbe luso di una scala di depressione in luogo di unaltra tuttaltro che irrilevante,
con la possibilit di ottenere risultati diversi e limpossibilit di generalizzare i risultati
da uno studio allaltro (Endler et al., 2000).
5. Mancanza di controllo del response set della desiderabilit sociale. Una controversia
importante riguardante luso degli inventari di autovalutazione consiste nella loro falsicabilit e nel rapporto con la desiderabilit sociale (Conoley, 1978; Arbisi, 2001;
Wood, Garb, Lilienfeld e Nezworski, 2002). La tipica facilit di somministrazione
li espone, infatti, a uno stile deliberato di risposta e alla distorsione dei risultati. Gi
Davis (citato in Beck, Steer e Garbin, 1988) riferiva che i pazienti dei reparti di salute mentale sono in grado di descriversi come depressi o non depressi a seconda del
setting di valutazione. La cautela , dunque, imperativa nelluso di tali strumenti con
persone che potrebbero desiderare di nascondere le proprie intenzioni suicide o, di
contro, sovrastimare la loro depressione (Conoley, 1978). Per giunta, come dimostra
Schwartz (1999), nellinteressante lavoro Self-reports: how the questions shape the
answers, le differenze pi piccole nel formato del questionario, incluso lordine degli
item, potrebbero inuenzare sostanzialmente non solo i livelli medi di risposta agli
item, ma anche le intercorrelazioni tra gli item.
6. Inapplicabilit in popolazioni di depressi gravi: in una ricerca di Faravelli, Albanesi e
Poli (1986), 24 dei 100 pazienti con diagnosi di Episodio Depressivo Maggiore secondo
i criteri del DSM-III (APA, 1980), cui sono state somministrate sei scale self-report di
depressione, non sono stati in grado di completare autonomamente i questionari per
difcolt di comprensione e/o per mancanza di collaborazione. Dunque, se la praticit
191
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale - Vol. 13 - n. 2 2007
duso delle scale self-report maggiore in certi casi (ad esempio, screening di massa,
casi ambulatoriali), essa si riduce drasticamente rispetto alle scale di eterovalutazione
nel caso di pazienti gravi in degenza ospedaliera.
7. Scarsa validit discriminante rispetto allansia. Come riportato nella review di Dobson
(1985), gli indici di correlazione tra i diversi strumenti per la misurazione della depressione e dellansia sono elevati, aggirandosi intorno a 0,61. Ci potrebbe essere attribuito
al fatto che le scale di depressione misurano un fattore depressivo generale di ordine
pi elevato e diversi fattori specici di ordine inferiore, alcuni dei quali condividono
parte della loro variabilit con la sintomatologia ansiosa.
8. Problematiche relative alla standardizzazione e alla validazione di strumenti tradotti
da una lingua allaltra (Fava, 1983; Behling e Law, 2000). Ladattamento di una scala,
che ha per oggetto di misura una dimensione soggettiva e complessa della patologia
psichica come la depressione, presuppone: a) la risoluzione di problemi metodologici di
ordine semantico, relativi alle difcolt di traduzione, che rendono necessario procedere
ad accurate back-translations, per vericare se stato realmente colto il signicato
originale del costrutto misurato dallo strumento nei suoi aspetti pi sottili; b) la necessit di effettuare studi di standardizzazione e validazione, con le dovute modiche da
effettuare per rendere la scala compatibile con la realt socio-culturale con cui si va a
confrontare, date le note differenze transculturali nella misura della depressione (ad
esempio, Crittenden et al., 1992; Zung, 1972).
Tra gli strumenti attualmente pi diffusi nel nostro Paese non vi nessuna misura di
depressione singola (ovvero non inserita in questionari pi ampi) nata nel contesto
italiano che abbia raggiunto un ampio impiego nella ricerca e/o nella clinica. Inoltre,
se si eccettuano quelle incluse in batterie pi ampie, nessuna di quelle tradotte da altre
lingue presenta un manuale vero e proprio delladattamento italiano.
Proprio per colmare questa lacuna, attualmente siamo impegnati in un progetto di
ricerca che prevede la costruzione di un nuovo inventario self-report di depressione,
che tenter di superare i limiti psicometrici di quelli gi esistenti, e che verr adattato
e standardizzato sulla popolazione italiana (Balsamo, 2006).
Lobiettivo generale di questo lavoro sar quello di costruire uno strumento di misurazione dellentit della depressione negli adulti che garantisca al clinico facilit e
velocit duso e che sia, al tempo stesso, rafnato dal punto di vista psicometrico, cio
il pi possibile valido e attendibile.
A partire dai limiti summenzionati delle scale gi esistenti, stiamo mirando a costruire
uno strumento che si dovrebbe congurare come nuovo essenzialmente per tre caratteristiche peculiari: a) copertura dellintero spettro sintomatologico previsto dal DSM-IVTR per la diagnosi di depressione maggiore e della relativa durata della sintomatologia;
b) analisi degli item attraverso un modello di Item Response Theory; c) controllo del
response set della desiderabilit sociale.
La presentazione dei risultati preliminari di questo progetto, attualmente in corso, esula
dagli scopi del presente lavoro e, pertanto, sar auspicabilmente fornita in un prossimo
articolo.
192
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
M. Balsamo e A. Saggino Test per lassessment della depressione nel contesto italiano: unanalisi critica
Bibliografia
American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Fourth Edition, Text Revision. Washington, DC: Author. Tr. it. DSM IV-TR;
Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. Milano: Masson, 2001.
Anastasi, A. (2002). I test psicologici. Milano: Franco Angeli.
Ancona, M., Torre, E., Jaretti Sodano, A., De Lorenzo, C. e Matta, F. (1985). LInventario della
Depressione di Beck nella ricerca in psicosomatica. Minerva Psichiatrica, 26, 41-45.
Antony, M.M., & Barlow, D.H. (2002). Handbook of assessment and treatment planning
for psychological disorders. New York: the Guilford Press.
Arbisi, P. (2001). Review of the Beck Depression Inventory-II. In B.S. Plake & J.C. Impara
(Eds.), The fourtheen mental measurements yearbook (pp. 452-468). Lincoln, NE:
Buros Institute of Mental Measurements.
Balsamo, M. (2006). Costruzione di un nuovo strumento self-report di depressione. Tesi
di Dottorato, Universit G. dAnnunzio di Chieti-Pescara, a.a. 2006-07.
Basco, M.R., Krebaum, S.R., & Rush, A.J. (1997). Outcome measures of depression. In
H.H. Strupp, L.M. Horowitz e M.J. Lambert (Eds.), Measurement patient changes in
mood, anxiety, and personality disorders: toward a core battery (pp. 191-245). Washington, DC: American Psychological Association.
Beck, A.T. (1991). Cognitive therapy: a 30-year retrospective. American Psychologist,
46, 368-375.
Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for
measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561-579.
Beck, A.T., & Lester, D. (1973). Components of depression in attempted suicides. Journal
of Psychology, 85, 257-260.
Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., & Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression.
New York: Guilford Press. Tr. it. Terapia cognitiva della depressione. Torino: Bollati
Boringhieri, 1987.
Beck, A.T., & Steer, R.A. (1987). Beck Depression Inventory. Manual. San Antonio, TX:
The Psychological Corporation.
Beck, A.T., & Steer, R.A. (1990). Manual for the Beck Anxiety Inventory. San Antonio,
TX: The Psychological Corporation.
Beck, A.T., Steer, R.A., & Garbin, E. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression
Inventory: twenty-ve years of evaluation. Clinical Psychology Review, 8, 77-100.
Beck, A.T., Steer, R.A., Ball, R., & Ranieri, W.F. (1996). Comparison of the Beck Depression
Inventories-IA and II in outpatients. Journal of Personality Assessment, 67, 588-797.
Beck, A.T., Steer, R.A., & Brown, G.K. (1996). Beck Depression Inventory-Second Edition
manual. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.
Behling, O., & Law, K.S. (2000). Translating questionnaires and other research instruments. London: Sage.
Bertolotti, G., Michielin, P., Sanavio, E., Simonetti G., Vidotto G., & Zotti, A.M. (1985).
CBA 2.0. Cognitive Behaviuoral Assessment 2.0. Scale Primarie. Firenze: Organizzazioni Speciali.
193
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale - Vol. 13 - n. 2 2007
Bertolotti, G., Zotti, A.M., Michielin, P., Vidotto G., & Sanavio (1990). A computerized
approach to cognitive behavioural assessment: An introduction to CBA 2.0 Primary
Scales. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 21, 21-27.
Bertolotti, G., Michielin, P., Sanavio, E., & Zotti, A.M. (1994). Un modello di valutazione psicologica in medicina riabilitativa. Uso della batteria CBA-2.0 Scale Primarie.
Pavia: PIME.
Blackburn, I.M., & Moorhead, S. (2002). Depressione. In W.J. Lyddon & J.V. Jones,
Lapproccio evidence-based in psicoterapia. Milano: McGraw-Hill.
Boncori, L. (1993). Teoria e tecniche dei test. Torino: Bollati Boringhieri.
Calonghi, L., & Espinosa, J. (1965). La depressione nel Multiphasic Minnesota Personality
Inventory (MMPI). Orientamento pedagogico, 12, 1099-126.
Camara, W.J., Nathan, J.S., & Puente, A.E. (2000). Psychological testing usage: Implications in professional psychology. Professional Psychology: Research and Practice,
31, 141-154.
Cattell, R.B., Eber, H.W., & Tatsuoka, M.M. (1970). Handbook for the Sixteen Personality
Factor Questionnaire (16 PF). Champaign: IPAT.
Chang, C. H. (1996). Finding two dimensions in MMPI-2 depression. Structural Equation
Modeling, 3, 41-49.
Ciof, R., Balsamo, M., & Saggino, A. (in press). Psychometric characteristics of the Italian
Depression Questionnaire using a 5-point rating scale with undergraduate. Submitted
to Psychological Reports.
Clark, D.C., Cavanaugh, S.V., & Gibbons, R.D. (1983). The core symptoms of depression in medical and psychiatric patients. Journal of Nervous and Mental Disease, 171,
705-713.
Clark, D.A., Beck, A.T., & Alford, B.A. (1999). Scientic foundations of cognitive theory
and therapy of depression, John Wiley & Sons Inc. Trad. it. Teoria e terapia cognitive
della depressione. Milano: Masson.
Carroll, B.J., Fielding J., & Blashki T. (1973). Depression rating scales: a critical review.
Archives of General Psychiatry, 28, 361.
Conoley, C.W. (1978). Review of the Beck Depression Inventory (Revised Edition). In
O.K. Buros (Ed.). The eight mental measurements yearbook. Highland Park, N.J.: The
Gryphon Press.
Conti, L. (2002). Repertorio delle scale di valutazione in psichiatria. Firenze: SEE Editore.
Conti L., Ruggeri M., & Faravelli, C. (1999). Strumenti di valutazione e di misura. In
G. Cassano e P. Pancheri, Trattato Italiano di Psichiatria (pp. 829-855). Milano:
Masson.
Crittenden, K.S., Fugita, S.S., Bae, H., Lamug, C.B., & Un, C. (1992). A cross-cultural
study of self-report depressive symptoms among college students. Journal of CrossCultural Psychology, 2, 163-178.
De Fidio, D., & Pancheri, P. (2007). La taratura italiana del MMPI-2 www.psychomedia.
it/pm/inftel/informatic/mmpi2-panda.htm.
194
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
M. Balsamo e A. Saggino Test per lassessment della depressione nel contesto italiano: unanalisi critica
De Girolamo, G., Polidori, G., Morosini, P.L., Mazzi, F., Serra, G., Scarpino, V., Reda, V.,
Vison, G., Falsirollo, F., & Rossi, A. (2005). Prevalenza dei disturbi mentali comuni in
Italia, fattori di rischio, stato di salute ed uso di servizi sanitari: il progetto ESEMEDWMH. Epidemiologia e Psichiatria Sociale, 14 (Suppl.4).
de Jonghe, J. F., & Baneke, J.J. (1989). The Zung Self-Rating Depression Scale: a replication
study on reliability, validity and prediction. Psychological Reports, 64, 833-834.
Della Sala, S. e Zotti, A.M. (1994). Psicologia dellinvecchiamento ed epidemiologia della
demenza: uno studio di popolazione. Pavia: PIME.
Delhees, K.H., &, Cattell, R.B. (1975). Handbook for the Clinical Analysis Questionnaire.
Champaign, Ill.: IPAT.
Di Marco, F., Verga, M., Reggente, M., Casanova, F., Santus, P., Blasi, F., Allegra, L., &,
Centanni, S. (2006). Anxiety and depression in COPD patients: the roles of gender and
disease severity. Respiratory Medicine, 100, 1767-74.
Dobson, K.S. (1985). The relationship between anxiety and depression. Clinical Psychology Review, 5, 307-324.
Dozois, D.J.A., & Dobson, K.S. (2002). Depression. In M.M. Antony & D.H. Barlow
(Eds), Handbook of assessment and treatment planning for psychological disorders
(pp. 173-184). New York: the Guilford Press.
Endler, M.S., Rutheford, A., & Denisoff, E. (1999). Beck Depression Inventory: exploring its dimensionality in a nonclinical population. Journal of Clinical Psychology, 55,
1307-1312.
Endler, N.S., Macrodimistris, D.S., & Kocovski, N.L. (2000). Depression: the complexity
of self-report measures. Journal of Applied Biobehavioral Research, 5, 1, 26-46.
Faravelli, C., Albanesi, G., & Poli, E. (1986). Assessment of depression: a comparison of
rating scales. Journal of Affective Disorders, 11, 245-253.
Farmer, R.F. (2001). Review of the Beck Depression Inventory-II. In B.S. Plake & J.C.
Impara (Eds.), The fourtheen mental measurements yearbook (pp. 452-468). Lincoln,
NE: Buros Institute of Mental Measurements.
Fava, G. A. (1983). Assessing depressive symptoms across cultures: Italian validation of
the CES-D self-rating scale. Journal of Clinical Psychology, 39, 2, 249-251.
Fechner-Bates, S., Coyne, J.C., & Schwenk, T.L. (1994). The relationship of self-reported
distress to depressive disorders and other psychopatology. Journal of Counsulting and
Clinical Psychology, 62, 550-559.
Gabrys, J.B., & Peters, K. (1985). Reliability, discriminant and predictive validity of the
Zung Self-rating Depression Scale. Psychological Reports, 57, 1091-1096.
Ghisi, M., Flebus, G.B., Montano, A., Sanavio, E., & Sica, C. (2006). Beck Depression
Inventory-II. Manuale italiano. Firenze: Organizzazioni Speciali.
Gibbons, R., Clark, D.C., VonAmmon Cavanaugh, S., & Davis, J.M. (1985). Application of modern psychometric theory in psychiatric research. Journal of Psychiatric
Research, 19, 43-55.
Goldston, D.B., Reboussin, B.A., & Daniel, S.S. (2006). Predictors of Suicide Attempts:
State and Trait Components. Journal of Abnormal Psychology, 115, 842-849.
195
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale - Vol. 13 - n. 2 2007
Golin, S., & Hartz, M. (1979). A factor analysis of the Beck Depression Inventory in a
mildly depressed population. Journal of Clinical Psychology, 35, 322-325.
Gotlib, I.H., & Cane, D.B. (1989). Self-report assessment of depression and anxiety. In
P.C. Kendall e D. Watson (Eds.), Anxiety and depression: distinctive and overlapping
features. Personality, psychopathology, and psychotherapy (pp. 131-169). San Diego,
CA: Academic Press.
Gotlib, I.H., & Hammen, C.L. (2002). Handbook of depression. New York: the Guilford
Press.
Hamilton, M. (1959). The assessment of anxiety states by rating. British Journal of Medical Psychology, 32, 50-55.
Hamilton, M. (1960). A rating scale for depression. Journal of Neurology and Neosurgical
Psychiatry, 23, 56-62.
Hathaway, S.R., & McKinley, J.C. (1940). A multiphasic personality schedule (Minnesota):
I. Construction of the schedule. Journal of Psychology, 10, 249-254.
Hathaway, S.R., & McKinley, J.C. (1942). A multiphasic personality schedule (Minnesota):
III. The measurement of symptomatic depression. Journal of Psychology, 14, 73-84.
Hathaway, S.R., & McKinley, J.C. (1989). Minnesota Multiphasic Personality Inventory
2: Manual. Tr. it. Manuale del Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 (a cura
di) P. Pancheri & S. Sirigatti. Firenze: Organizzazioni Speciali, 1995.
Hughes, J. R., OHara M.W., & Rehm, L.P. (1982). Measurement of depression in clinical
trials: an overview. Journal of Clinical Psychiatry, 43, 85-88.
Innamorati, M., Lelli, M., Aiello, S., Di Lorenzo del Casale, F.L., Russo, S., & Ferrari, V.
(2006). Validazione convergente e discriminante della versione italiana della Zunf SelfRating Depression Scale. Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, 12, 343-353.
Kats, R., Shaw, B.F., Vallis, T.M., & Kaiser, A.S. (1995). The assessment of severity and
symptom patterns in depression. In E.E. Beckham & W.R. Leber (Eds.), Handbook of
depression (2nd ed.) (pp. 61-85). New York: the Guilford Press.
Kendall, P.C., Hollon, S.D., Beck, A.T., Hammen, C.L., & Ingram, R.E. (1987). Issues and
recommendations regarding use of the Beck Depression Inventory. Cognitive Therapy
and Research, 11, 289-299.
Kivelae, S., & Pahkala, K. (1987). Factor structure of the Zung Self-Rating Depression
Scale among a depressed elderly population. International Journal of Psychology, 22,
289-300.
Kline, P. (1993). The handbook of psychological testing. Londra: Routledge. Trad. it.
Manuale di psicometria. Roma: Astrolabio, 1996.
Knight, R. G., Waal-Manning, H.J., & Spears, G.F. (1983). Some norms and reliability
data for the State-Trait Anxiety Inventory and the Zung Self-Rating Depression Scale.
British Journal of Clinical Psychology, 22, 245-249.
Krug, S.E., & Laughlin, J.E. (1976). Handbook for the IPAT Depression Scale. Champaign,
Ill.: Institute for Personality and Ability Testing. Trad. it. Questionario di autovalutazione
CDQ. Adattamento italiano a cura di M. Novaga e A. Pedon. Firenze: Organizzazioni
Speciali, 1979.
196
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
M. Balsamo e A. Saggino Test per lassessment della depressione nel contesto italiano: unanalisi critica
Krug, S.E., Scheier, I.H., & Cattell, R.B. (1976). Handbook for the IPAT Anxiety Scale.
Champaign, Ill.: Institute for Personality and Ability Testing.
Mayer, J.M. (1977). Assessment of Depression. In P. McReynolds (Ed), Advances in Psychological Assessment, vol. IV (pp. 358-425). Palo Alto: Science and Behavior Books.
McNair, D.M. (1974). Self-evaluations of antidepressants. Psychopharmacologia, 37,
281-302.
Milani, P., Caniatti, L., & Tola, M.R. (2006). Valutazione della depressione in persone
affette da sclerosi multipla: limiti dei principali questionari. Psicoterapia Cognitiva e
Comportamentale, 12, 355-364.
Montano, A., & Flebus, G.B. (2006). Presentazione del Beck Depression Inventory-Seconda
edizione (BDI-II): conferma della struttura bifattoriale in un campione di popolazione
italiana. Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, 12, 67-82.
Mucciarelli, G., Chattat, R., & Celani, G. (2002). Teoria e pratica dei test. Padova: Piccin.
Myers, J.K., & Weissman, M.M. (1980). Use of a self-report symptom scale to detect depression in a community sample. American Journal of Psychiatry, 137, 1081-1089.
Nezu, A.M., Ronan, G.F., Meadows, E.A., & McClure, K.S. (2000). Clinical assessment
series: Vol. 1. Practitioners guide to empirically-based measures of depression. New
York: Kluver/Plenum.
Novaga, M., & Pedon, A. (1979). Questionario di autovalutazione CDQ. Firenze: Organizzazioni Speciali.
Pierfederici, A., Fava, G.A., Munari, F., Rossi, N., Baldaro, B., Pasquali Evangelisti, L.,
Grandi, S., Bernardi, M., & Zecchino, F. (1982). Validazione italiana del CES-D per la
misurazione della depressione. In R. Canestrari (a cura di), Nuovi metodi in psicometria
(pp. 95-103). Firenze: Organizzazioni Speciali.
Plutchik, R., & van Praag, H.M. (1987). Interconvertability of ve self-report measures
of depression. Psychiatric Research, 22, 243-256.
Poli, E., & Faravelli, C. (1981). La valutazione dei sintomi psichiatrici. III: Problemi
connessi alla misurazione. Rassegna di Studi Psichiatrici, 70, 228-238.
Rabkin, J.G., & Klein, D.F. (1987). The clinical measurement of depressive disorders. In
A.J. Marsella & R.M.A. Hirschfeld (Eds.), The measurement of depression (pp. 30-83).
New York: the Guilford Press.
Radloff, L.S. (1977). The CES-D Scale: A self-report depression scale for research in the
general population. Applied Psychological Measurement, 1, 385-401.
Rasch, G. (1960-1980). Probabilistic models for some intelligence and attainment tests.
Chicago: the University of Chicago Press.
Robert, R.E., Lewinsohn, P.M., & Seeley, J.R. (1991). Screening for adolescent depression: a comparison of depression scales. Journal of the American Academy of Child
and Adolescent Psychiatry, 30, 58-66.
Roberts, R. E., & Vernon, S.W. (1983). The Center for Epidemiologic Studies Depression
scale: its use in a community sample. American Journal of Psychiatry, 140, 41-48.
Saggino, A. (2005). La depressione. In A. Galeazzi e P. Meazzini (a cura di), Mente e
Comportamento. Trattato italiano di psicoterapia cognitivo-comportamentale. Firenze:
Giunti editore.
197
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale - Vol. 13 - n. 2 2007
Sakamoto, S., Kijima, N., Tomoda, A., & Kambara, M. (1998). Factor structures of the
Zung Self-Rating Depression Scale (SDS) for undergraduates. Journal of Clinical
Psychology, 54, 477-487.
Sanavio, E., Bertolotti, G., Michielin, P., Vidotto, G., & Zotti, A.M. (1988). CBA-2.0
Cognitive behavioral assessment: Scale primarie. Manuale. Firenze: Organizzazioni
Speciali.
Sanavio, E., & Vidotto, G. (1996) (a cura di). Batteria CBA: dieci anni di ricerche. UPSEL, Torino.
Sanavio, E., & Sica, C. (1999). Depressione. In E. Sanavio e C. Sica, I test di personalit
(pp.217-235). Bologna: Il Mulino.
Sanavio, E. (a cura di) (2002). Le Scale CBA. Milano: Raffaello Cortina Editore.
Sanavio, E. (2006). Editoriale. Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, 12.
Sanavio, E., Bertolotti G., Michielin, M., Vidotto G., & Zotti, A.M. (1997). CBA 2.0. Cognitive
Behavioural Assessment. Scale Primarie. Manuale. Firenze: Organizzazioni Speciali.
Santor, D.A., Ramsay, J.O., & Zuroff, D.C. (1994). Nonparametric item analyses of the
Beck Depression Inventory: evaluating gender item bias and response option weights.
Psychological Assessment, 6, 255-270.
Santor, D.A., & Coyne, J. C. (1997). Shortening the CES-D to improve its ability to detect
case of depression. Psychological Assessment, 9, 233-243.
Schotte, C.K.W., Maes, M., Cluydts, R., & Cosyns, P. (1996). Effects of affective-semantic
mode of item presentation in balanced self-report scales: biased construct validity of
the Zung Self-Rating Depression Scale. Psychological Medicine, 26, 1161-1168.
Schwartz, N. (1999). Self-reports: how the questions shape the answer. American Journal
of Psychology, 54, 93-105.
Shafer, A.B. (2006). Meta-analysis of the factor structures of four depression questionnaires:
Beck, CES-D, Hamilton, and Zung. Journal of Clinical Psychology, 1, 123-146.
Sirigatti, S., & Pancheri, P. (1995). Ladattamento italiano del MMPI-2. In S.R. Hathaway
& J.C. McKinley, Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2: Manual. Firenze:
Organizzazioni Speciali.
Spitzer, R.L., Williams, J.B.W., Gibbon, M., & First, M.B. (1990). Users guide for the Structured Clinical Interview for DSM-III-R. Washington, DC: American Psychiatric Press.
Steer, R.A., Ball, R., Ranieri, W.F., & Beck, A.T. (1997). Further evidence for the construct
validity of the Beck Depression Inventory-II with psychiatric outpatients. Psychological Reports, 80, 443-446.
Steer, R.A., Clark, D.A., Beck, A.T., & Ranieri, W.F. (1998). Common and specic dimensions of self-reported anxiety and depression: the BDI-II versus the BDI-IA. Behaviour
Research and Therapy, 37, 183-190.
Steer, R.A., Ball, R., Ranieri, W.F., & Beck, A.T. (1999). Dimensions of the Beck Depression Inventory-II in clinically depressed outpatients. Journal of Clinical Psychology,
55, 117-128.
Storch, E.A., Roberti, J.W., & Roth, D.A. (2004). Factor structure, concurrent validity, and
internal consistency of the Beck Depression Inventory-Second Edition in a sample of
college students. Depression & Anxiety, 19, 187-189.
198
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
M. Balsamo e A. Saggino Test per lassessment della depressione nel contesto italiano: unanalisi critica
Stommel, M., Given, B.A., Given, C.W., Kalaian, H.A., Schulz, R., & McCorkle (1993).
Gender bias in the measurement properties of the Center For Epidemiological Studies
Depression Scale (CES-D). Psychiatry Research, 49, 239-250.
Tanaka, J.S., & Huba, G.J. (1984). Conrmatory hierarchical factor analysis of psychological distress measures. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 621-635.
Tanaka-Matsumi, J., & Kaneoka, V.A. (1986). Relabilities and concurrent validities of
popular self-report measures of depression, anxiety, and social desirability. Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 54, 328-333.
Thurber, S., Snow, M., & Honts, C.R. (2002). The Zung Self-Rating Depression Scale:
Convergent validity and diagnostic discrimination. Assessment, 4, 328-333.
Vedana, L., Baiardi, P., Sommaruga, M., Galli, M., Neri, M., Pedretti, R.F., Tramarin, R.,
& Bertolotti G. (2001). Clinical validation of an anxiety and depression screening test
for intensive in-hospital rehabilitation. Monaldi Arch Chest Dis, 56, 101-06.
Weckowicz, T.E., Muir, W., & Cropley, A.J. (1967). A factor analysis of the Beck Inventory
of Depression. Journal of Consulting Psychology, 31, 23-28.
Whisman, M.A., Perez, J.E., & Ramel, W. (2000). Factor structure of the Beck Depression
Inventory-Second Edition (BDI-II) in a student sample. Journal of Clinical Psychology, 56, 545-551.
Wood, J.M., Garb, H.N., Lilienfeld, S.O., & Nezworski, M.T. (2002). Clinical assessment.
Annual Review of Psychology, 53, 519-543.
World Health Organization (1998). Well-being measures in primary healthcare/The Depcare
project. Copenhagen: WHO Regional Ofce for Europe.
World Health Organization (1999). Press Release. World Health Report 1999 Making a
difference. Geneva: WHO Regional Ofce for Europe.
Zimmerman, M. (1983). Self-report depression scales. Archives General of Psychiatry,
40, 1035-1042.
Zung, W.W.K. (1965). A self-rating depression scale. Archives of General Psychiatry, 12,
63-70.
Zung, W.W.K. (1972). A cross-cultural survey of depressive symptomatology in normal
adults. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2, 177-183.
Corrispondenza
Michela Balsamo
presso Laboratorio di Psicometria,
Dipartimento di Scienze di Scienze Biomediche,
Universit degli Studi G. dAnnunzio di Chieti-Pescara
Via dei Vestini 31 (Blocco A)
66013 Chieti (CH)
Tel. 0871/3554202
e-mail: michela.balsamo@libero.it; mbalsamo@unich.it
199
Edizioni Erickson Copia concessa allautore. Ogni riproduzione o distribuzione vietata
Potrebbero piacerti anche
- Riconoscere e curare l'ansia e il panico - Collana di Psichiatria Divulgativa Vol. IIIDa EverandRiconoscere e curare l'ansia e il panico - Collana di Psichiatria Divulgativa Vol. IIINessuna valutazione finora
- I Test Di PersonalitàDocumento75 pagineI Test Di Personalitàfabiola arcidiaconoNessuna valutazione finora
- Il medico dell'anima: Critica ragionata alla psichiatria contemporanea - Nuovi approcci ad ansia, depressione, panico, psicosi, fobie, stress da covid e disturbi di personalità per clinici e familiariDa EverandIl medico dell'anima: Critica ragionata alla psichiatria contemporanea - Nuovi approcci ad ansia, depressione, panico, psicosi, fobie, stress da covid e disturbi di personalità per clinici e familiariNessuna valutazione finora
- Diagnosi in Psicologia Clinica - Pdffare Bene Disturbi D'ansiaDocumento58 pagineDiagnosi in Psicologia Clinica - Pdffare Bene Disturbi D'ansiaSabaDubaNessuna valutazione finora
- I farmaci antidepressivi, nozioni basilari per psicologi: nozioni basilari per psicologiDa EverandI farmaci antidepressivi, nozioni basilari per psicologi: nozioni basilari per psicologiNessuna valutazione finora
- Fonagy e La MentalizzazioneDocumento8 pagineFonagy e La MentalizzazioneAlessandra FinazzoNessuna valutazione finora
- Congresso PsicoterapiaDocumento463 pagineCongresso PsicoterapiaFrancesco MatteoliNessuna valutazione finora
- Depressione, ansia e panico domande e risposteDa EverandDepressione, ansia e panico domande e risposteValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Schemi Psichiatria Senza Disturbi SomatoformiDocumento81 pagineSchemi Psichiatria Senza Disturbi SomatoformiMilady UgeniaNessuna valutazione finora
- LA SALUTE MENTALE E IL DISTURBO PSICOLOGICO: cosa sono e come funzionanoDa EverandLA SALUTE MENTALE E IL DISTURBO PSICOLOGICO: cosa sono e come funzionanoNessuna valutazione finora
- Il Discontrollo Degli Impulsi e L'espressione Dell'aggressivita': Confronto Tra Pazienti Con Disturbo Borderline Di Personalita' e Disturbo BipolareDocumento1 paginaIl Discontrollo Degli Impulsi e L'espressione Dell'aggressivita': Confronto Tra Pazienti Con Disturbo Borderline Di Personalita' e Disturbo BipolareState of MindNessuna valutazione finora
- La Psicoanalisi - Manuale di Psicologia comparata per medici e psicologiDa EverandLa Psicoanalisi - Manuale di Psicologia comparata per medici e psicologiNessuna valutazione finora
- Danno Psichico VecchioneDocumento19 pagineDanno Psichico VecchionejaverianaNessuna valutazione finora
- Social cognition e aggressività. Disamina del modello socio-cognitivo di Kenneth A. DodgeDa EverandSocial cognition e aggressività. Disamina del modello socio-cognitivo di Kenneth A. DodgeNessuna valutazione finora
- Riassunto Tra Rischio e Protezione La Valutazione Delle Competenze ParentaliDocumento67 pagineRiassunto Tra Rischio e Protezione La Valutazione Delle Competenze ParentaliElena SantarelliNessuna valutazione finora
- Manuale Diagnostico PsicodinamicoDocumento22 pagineManuale Diagnostico PsicodinamicoAnnarita Morabito100% (1)
- Osservare, Valutare e Sostenere La Relazione Genitori-Figli Riassunto DefinitivoDocumento25 pagineOsservare, Valutare e Sostenere La Relazione Genitori-Figli Riassunto DefinitivoChiara VigneriNessuna valutazione finora
- Dissociazione PDFDocumento17 pagineDissociazione PDFKarolinaMaślakNessuna valutazione finora
- AnamnesiDocumento53 pagineAnamnesilulujolieNessuna valutazione finora
- Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione CognitivaDocumento35 pagineValutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione CognitivaAlessandra ToniNessuna valutazione finora
- Cognitive Behavioural Assessment: Behavioral Assessment È Stata Sviluppata Nella Prima Metà Degli Anni 80Documento25 pagineCognitive Behavioural Assessment: Behavioral Assessment È Stata Sviluppata Nella Prima Metà Degli Anni 80Alberto BoniventoNessuna valutazione finora
- Empatia e Riconoscimento Del Dolore Negli Autori Di ReatoDocumento26 pagineEmpatia e Riconoscimento Del Dolore Negli Autori Di ReatoState of MindNessuna valutazione finora
- Valutazione Del Danno PsichicoDocumento13 pagineValutazione Del Danno PsichicoAmbra Capelli100% (1)
- La DepressioneDocumento27 pagineLa DepressioneFederica IezziNessuna valutazione finora
- Lez Sante de Sanctis - Dissociazione in Ipnosi-Short1Documento36 pagineLez Sante de Sanctis - Dissociazione in Ipnosi-Short1giuliaNessuna valutazione finora
- NEUROPSICOLOGIADocumento21 pagineNEUROPSICOLOGIABeatrice Sciotto100% (2)
- Aa. Vv. - Aut Aut 375. La Diagnosi in Psichiatria PDFDocumento269 pagineAa. Vv. - Aut Aut 375. La Diagnosi in Psichiatria PDFElenoireshNessuna valutazione finora
- Resilienza e Creativita Teorie e Tecniche Nei Contesti Di VulnerabilitaDocumento37 pagineResilienza e Creativita Teorie e Tecniche Nei Contesti Di VulnerabilitaFederica Di ChioNessuna valutazione finora
- Mucci SIRP 2016 Rimedio-Cognitivo PDFDocumento126 pagineMucci SIRP 2016 Rimedio-Cognitivo PDFFrancesco CitinoNessuna valutazione finora
- Primo Capitolo Carattere e NevrosiDocumento14 paginePrimo Capitolo Carattere e NevrosiEleonoraNessuna valutazione finora
- 09 La Valutazione NeuropsicologicaDocumento14 pagine09 La Valutazione NeuropsicologicaMonica CatastrofeNessuna valutazione finora
- Linee Guida Per L'Accertamento E La Valutazione Psicologico Giuridica Del Danno Biologico Psichico E Del Danno Da Pregiudizio EsistenzialeDocumento38 pagineLinee Guida Per L'Accertamento E La Valutazione Psicologico Giuridica Del Danno Biologico Psichico E Del Danno Da Pregiudizio EsistenzialeMassimo BottiNessuna valutazione finora
- Psichiatria e Dsm-5Documento405 paginePsichiatria e Dsm-5Ale cNessuna valutazione finora
- Corso Psicodiagnosi GiuridicaDocumento6 pagineCorso Psicodiagnosi Giuridicaadry36Nessuna valutazione finora
- I Giochi Del Familiare DipendenteDocumento51 pagineI Giochi Del Familiare Dipendentem0r9anNessuna valutazione finora
- Lo Sviluppo Della PsicopatologiaDocumento40 pagineLo Sviluppo Della PsicopatologiamariottoalbertoNessuna valutazione finora
- Il DSM 5 e La Diagnosi Dimensionale Dei Disturbi Di PersonalitaDocumento3 pagineIl DSM 5 e La Diagnosi Dimensionale Dei Disturbi Di PersonalitaAndrea MinelliNessuna valutazione finora
- I TestDocumento21 pagineI TestCarlos ReyesNessuna valutazione finora
- Battistutta - Islam e AnarchiaDocumento5 pagineBattistutta - Islam e AnarchiaandreaNessuna valutazione finora
- Psichiatria Forense PDFDocumento6 paginePsichiatria Forense PDFalbertuNessuna valutazione finora
- Dottorato ValeriaCrisafulliXXIVcicloDocumento196 pagineDottorato ValeriaCrisafulliXXIVcicloIvana VastolaNessuna valutazione finora
- I Test Proiettivi in Ambito Giudiziario PDFDocumento31 pagineI Test Proiettivi in Ambito Giudiziario PDFjaverianaNessuna valutazione finora
- Gallese, Simulazione IncarnataDocumento38 pagineGallese, Simulazione IncarnataValeria VaccaNessuna valutazione finora
- RIASSUNTO Il Soggetto NascostoDocumento42 pagineRIASSUNTO Il Soggetto NascostoMartina ArmeniNessuna valutazione finora
- Psicopatologia e Neuroscienze CognitiveDocumento16 paginePsicopatologia e Neuroscienze CognitiveStefano Bussolon100% (7)
- Epilessia Clinica Ed ImplicazioniDocumento49 pagineEpilessia Clinica Ed ImplicazioniMichela ColaioriNessuna valutazione finora
- Dodici Dimensioni Per Orientare La Diagnosi Sistemica Matteo SelviniDocumento22 pagineDodici Dimensioni Per Orientare La Diagnosi Sistemica Matteo SelviniMarica SpitaliNessuna valutazione finora
- Tecniche Di Ricerca Ed Analisi Dati VIRGINIA BOLCIONIDocumento60 pagineTecniche Di Ricerca Ed Analisi Dati VIRGINIA BOLCIONIDario Brizi100% (1)
- UmiltàDocumento6 pagineUmiltàCecix Masselli100% (1)
- Lineamenti Di Neuropsicologia ClinicaDocumento78 pagineLineamenti Di Neuropsicologia ClinicaSharon Piccirillo100% (2)
- La Sindrome FrontaleDocumento7 pagineLa Sindrome FrontaleNeuroscienze.netNessuna valutazione finora
- ESTRATTO Lutto PDF Cover NuovaDocumento22 pagineESTRATTO Lutto PDF Cover NuovaEbook EcmNessuna valutazione finora
- Teoria Psicosociale - CloningerDocumento3 pagineTeoria Psicosociale - CloningersarkogassNessuna valutazione finora
- Manuale Difesa PsichiatriaDocumento58 pagineManuale Difesa Psichiatriamilian__tNessuna valutazione finora
- Trattato Di Psichiatria Forense PDFDocumento153 pagineTrattato Di Psichiatria Forense PDFsimoneNessuna valutazione finora
- Esame NeuropsicologicoDocumento71 pagineEsame Neuropsicologicodaniele la bella100% (1)
- Craving - Alla Base Di Tutte Le DipendenzeDocumento1 paginaCraving - Alla Base Di Tutte Le Dipendenzeamalia6274Nessuna valutazione finora
- Lezioni - Psico. ClinicaDocumento19 pagineLezioni - Psico. ClinicaAmbra BerettiNessuna valutazione finora
- Deficit Del Controllo Inibitorio Nel DOC e Nel GAP - Dal Forum Di ASSISI 2015Documento1 paginaDeficit Del Controllo Inibitorio Nel DOC e Nel GAP - Dal Forum Di ASSISI 2015State of Mind100% (1)
- Il Sitema Di Valutazione QFMDocumento2 pagineIl Sitema Di Valutazione QFMbarra_marcoNessuna valutazione finora
- Benis Catene MuscolariDocumento38 pagineBenis Catene MuscolariCipriano D'Ambrosio100% (1)
- Pulizia Fegato TesiDocumento106 paginePulizia Fegato TesiLuca FiorucciNessuna valutazione finora
- Sbobinature Microbiologia 2012-13Documento195 pagineSbobinature Microbiologia 2012-13Antonio Rizzone100% (1)
- Scheda Allevamento Rhacodactylus AuriculatusDocumento5 pagineScheda Allevamento Rhacodactylus AuriculatusMatteo PaganiNessuna valutazione finora
- PS3 ReumatologiaDocumento54 paginePS3 ReumatologiaArtiola KoxherriNessuna valutazione finora
- Le BiotecnologieDocumento2 pagineLe BiotecnologieAlessio NardinNessuna valutazione finora