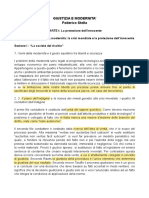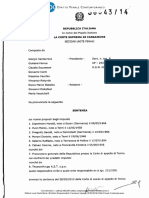Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Cass. Porto Marghera
Caricato da
Dario Sella0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
46 visualizzazioni58 pagineCopyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
46 visualizzazioni58 pagineCass. Porto Marghera
Caricato da
Dario SellaCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 58
TRIBUNALE DI VENEZIA; sentenza, 02-11-2001
Giudicante: TRIBUNALE DI VENEZIA; sentenza, 02-11-2001
Magistrati: Pres. Salvarani, Est. Salvarani, Manduzio, Liguori
Parti e avvocati: imp. Cefis e altri.
TRIBUNALE DI VENEZIA; sentenza, 02-11-2001
(Omissis). — La causalità. Secondo il codice vigente in tanto sussiste il rapporto causale in quanto
la condotta (azione o omissione) sia condizione necessaria dell’evento.
Il modello deterministico del nostro codice, emanato in epoca preindustriale, ha subìto le tensioni e
le torsioni derivanti dai problemi che nei decenni recenti gli venivano posti dall’industrializzazione,
dall’evoluzione tecnologica e scientifica, dalla produzione di sostanze pericolose.
La produzione di sostanze pericolose, nell’ambito di un rischio consentito (che viene a individuare
e a regolare un bilanciamento tra l’utilità sociale di una determinata attività e il livello di rischio ad
essa connessa) o di un rischio sconosciuto, ha più generalmente messo in crisi le tradizionali
categorie giuridiche relative alla responsabilità penale colposa di chi è tenuto a controllare,
contrastare, circoscrivere gli effetti nocivi alla salute.
È emersa in tutta la sua evidenza la difficoltà di applicare ai nuovi pericoli connotati da ampia
diffusività e da genesi causale complessa o ignota non solo le regole elaborate per imputare eventi
lesivi di struttura più semplice e riconducibili a singole azioni individuali, ma altresì la stessa
nozione di colpa.
Colpa che, ove non consista in violazione di norme cautelari specifiche, deve avere riferimento al
livello di conoscenze acquisito dalla comunità in un dato momento storico e in un determinato
ambiente (c.d. criterio dell’agente modello) ai fini di individuare e di specificare la misura della
diligenza richiedibile sulla base di standard di sicurezza generalmente acquisiti e praticati per
evitare gli effetti dannosi.
Nell’ambito del reato colposo d’evento il profilo attualmente più controverso della responsabilità
colposa è quello della causalità, sotto il duplice profilo della sua definizione concettuale e del suo
accertamento.
Il modello condizionalistico, tradizionalmente legato alle leggi universali che sono in grado di
affermare che la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verificazione di
altro evento, ha subìto interventi correttivi da parte della giurisprudenza che lo ha ritenuto
inadeguato a offrire spiegazioni causali laddove non sussista una legge di copertura universale, ma,
piuttosto, leggi scientifiche anche di carattere probabilistico-statistico, che sono in grado di spiegare
l’esistenza del rapporto di condizionamento non invariabilmente e necessariamente, ma solo in una
certa percentuale di casi, e, quindi, non in termini di piena certezza, ma in termini di probabilità.
Il ricorso alle leggi statistiche e/o scientifiche/probabilistiche ha posto innanzitutto il problema se
esse siano compatibili con il modello deterministico-condizionalistico del nostro ordinamento
penale e, in ipotesi affermativa, a quali condizioni ed entro quali limiti. Si è infatti affermato con
forza che le esigenze di certezze e garanzia, il rispetto dei principî di legalità e di personalità della
responsabilità penale, di rango costituzionale, devono essere soddisfatti mediante il mantenimento
di un rigoroso modello causale, ove il rapporto di condizionamento sia spiegato o da leggi
universali o da leggi di copertura scientifico-statistiche che siano in grado di spiegarlo con un grado
di certezza elevato e, al tempo stesso, si possa razionalmente escludere che l’evento si sia verificato
nel caso concreto per cause esclusive diverse dalla condotta dell’agente.
Queste esigenze espresse dalla migliore dottrina e dalla giurisprudenza della Suprema corte più
recente, a fronte di decisioni, affermatesi in origine nel campo della colpa medica ed estesesi
nell’ambito della responsabilità dell’imprenditore per infortuni sul lavoro e malattie professionali,
che tendevano ad appagarsi di un basso grado di probabilità nella ricostruzione del nesso causale,
così da erodere la struttura tipica del reato di evento, hanno provocato reazioni anche a livello di
elaborazione legislativa.
La commissione Grosso, nella relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale —
parte generale — «ha preso atto con preoccupazione che la causalità e, in particolare, il modello
nomologico-deduttivo (integrato dal rinvio alle leggi di copertura) sta attraversando una fase critica.
Vi sono infatti materie in cui l’erosione da parte della giurisprudenza di tale paradigma causale
appare evidente e con riferimento alle quali tende ad affermarsi una ricostruzione della causalità
ancorata a fattori di tipo prognostico-probabilistico, se non addirittura consistenti nella rilevazione
del rischio o dell’aumento del rischio connesso all’esercizio di una determinata attività».
Settori tra i quali, oltre all’attività medica e alle alterazioni ambientali, si annovera anche «la
fenomenologia del danno da prodotto nei cui confronti è ricorrente l’impossibilità di identificare
con certezza, o anche soltanto con una elevata probabilità, quale sia stato il fattore produttivo del
nocumento». È pur vero — continua la relazione — che «nella società moderna una flessibilità
applicativa delle norme sulla causalità consente di raggiungere livelli di intervento penali altrimenti
impensabili in ragione della difficoltà della prova, ma il costo di scelte di questo tipo è elevato sul
terreno della salvaguardia del principio di legalità e di tipicità delle fonti di responsabilità penale,
rischiando di offuscare il principio della personalità della responsabilità penale. Mentre la causalità
ricostruita con ricorso a leggi di copertura ancorata al metodo dell’accertamento nomologico-
deduttivo svolge una importante funzione delimitativa della punibilità, consentendo di selezionare
nell’ambito della fattispecie causalmente orientata le condotte tipiche, il superamento di questo
modello allarga la sfera di applicabilità del precetto, attraendo nella sua orbita anche eventi che non
possono essere ritenuti, dal punto di vista logico-scientifico, conseguenza della condotta».
Si deve osservare in proposito che è ben vero che queste tendenze si sono manifestate con riguardo
a materie in cui sono in gioco esigenze di tutela di beni fondamentali quali la salute e la vita umana,
ma ci si deve chiedere se queste specifiche esigenze di giustizia possano condizionare una corretta
ermeneutica del nesso causale, che deve fondarsi su parametri logico-scientifici oggettivi.
Infatti perseguendo questa strada dominata dal criterio probabilistico di grado difficilmente
determinabile ancorché qualificato «alto» o «elevato» si incorre nel pericolo di introdurre
nell’accertamento della sussistenza del nesso causale un libero convincimento del giudice, sia pur
nobilitato dallo scopo di soddisfare esigenze ed attese di giustizia, che viene a sopperire la
mancanza di certezze scientifiche o comunque di consenso generalizzato nella comunità scientifica.
La causalità, essendo necessaria una spiegazione oggettiva dell’accadimento dell’evento, non può
che essere affidata, oltre che a leggi universali, a leggi scientifiche di copertura anche statistiche, ma
in grado di spiegare un rapporto di regolarità tra determinati eventi con un elevato grado di
frequenza e comunque sempre corroborati da elementi circostanziali oppure da ulteriori dati
desumibili da apporti di altre scienze che siano tra loro coerenti nel contesto considerato.
Questa premessa era necessaria perché nel processo che ci occupa vi è stata l’insistita tendenza a
sostituire il modello classico di causalità con la causalità generale, intesa come idoneità della
sostanza chimica a produrre certi tipi di evento, oltre tutto senza preoccuparsi di verificare tutti gli
apporti scientifici e forzando i passaggi con ipotesi di default o presunzioni o assimilazioni e,
soprattutto, trascurando di verificare l’effettiva incidenza della sostanza sul singolo caso.
Impostazione che non può trovare consenso posto che, in via di principio, la causalità generale non
può essere ritenuta di per sé sufficiente a spiegare il nesso causale tra la malattia che ha colpito il
singolo soggetto e l’idoneità della sostanza a causarla.
Tra gli stessi epidemiologi vi è largo consenso nel ritenere che i loro studi, che riguardano
popolazioni generali e si propongono scopi preventivi di tutela della salute pubblica, non sono in
grado di spiegare la causalità specifica e cioè di attribuire i singoli eventi lesivi a singoli
comportamenti.
Anche perché gli studi epidemiologici non si basano su un censimento di casi provatamente causati
dall’esposizione a sostanze tossiche (soprattutto quando la pluralità dei casi dipende da una pluralità
di fattori eziologici), ma solo di differenze tra i casi osservati e i casi attesi: in tale ambito la
causalità generale ha un significato ancor più circoscritto nei confini di tale scienza e indica più
propriamente un eccesso di rischio senza costituire in sé una prova dell’idoneità della sostanza a
provocare la malattia.
È per questa ragione che non c’è alcuna possibilità di distinguere tra i casi esposti chi non si
sarebbe ammalato in assenza di esposizione e chi invece si sarebbe ammalato egualmente.
Infatti, salvo rari casi (tra cui rientra oltre che il mesotelioma da asbesto, l’angiosarcoma per
esposizione a cvm) le neoplasie professionali non hanno carattere di specificità e non sono
distinguibili neppure istologicamente sotto il profilo morfologico da quelle extraprofessionali;
inoltre, data la natura multifattoriale delle neoplasie è impossibile, salvo casi eccezionali per
l’appunto, attribuire il singolo caso di tumore a una singola esposizione.
L’incertezza domina sul caso singolo proprio perché la quasi generalità dei tumori ha cause in
elevatissima percentuale extraprofessionali ignote e gli scienziati non hanno ancora compreso
appieno il modello molecolare nella carcinogenesi e formulano pertanto ipotesi per cui qualsiasi
dichiarazione riguardo al ruolo di qualsivoglia agente in quanto cancerogeno trova un limite nella
sua ipoteticità.
In termini generali appare opportuno sgomberare il campo dalla falsa credenza che la maggior
parte dei tumori sia dovuta all’uso o all’esposizione diretta a sostanze chimiche prodotte
nell’industria: eminenti epidemiologi (Peto e Doll e altresì un’agenzia come l’Epa) hanno messo in
rilievo che solo una piccolissima parte è in realtà ricollegabile all’attività industriale (il quattro per
cento secondo i primi e dall’uno al tre per cento secondo l’agenzia) mentre la percentuale residua è
dovuta a cause diverse, cioè all’esposizione a inquinanti diffusi nell’ambiente o all’ingestione di
inquinanti che passano nella catena alimentare il cui uso è normalmente consentito.
Alcuni esempi: negli Usa è stato calcolato che il quarantacinque per cento dell’esposizione al
benzene (noto cancerogeno) è dovuta al fumo, il trentasei per cento all’inalazione di vapori di
benzina, il sedici per cento a fonti domestiche (colle, vernici); nel caso di malattie e tumori per
esposizioni ad amianto (cancerogeno a basse dosi, la cui produzione è stata abolita) in
considerazione della molteplicità dei suoi usi e dell’ampia diffusione nell’ambiente una percentuale
non irrilevante colpisce anche la popolazione generale.
Negli stessi studi epidemiologici cui si è fatto riferimento in questo processo è stato rilevato per lo
più un maggior numero di tumori per tutte le cause nella popolazione generale che non tra gli
esposti, a ulteriore dimostrazione che i fattori di rischio possono essere al di fuori dei luoghi di
produzione delle sostanze chimiche.
Queste sono le ragioni per cui a fronte di una potenza statistica sempre più limitata gli studi
epidemiologici, che si devono confrontare non più con le alte esposizioni del passato ma con i
livelli più bassi delle epoche recenti e con una contaminazione ambientale sempre più diffusa,
ricercano nuovi approcci e nuove strade per integrare i propri dati con quelli derivanti da altre
scienze e al tempo stesso prestano la massima attenzione nella determinazione del rischio
attribuibile all’esposizione in considerazione della multifattorialità dell’insorgenza dei tumori.
Gli stessi consulenti dell’accusa pubblica e privata hanno concordemente affermato che lo studio
epidemiologico non può bastare, perché suggerisce inferenze eziologiche senza però poterle
dimostrare in rapporto ai singoli individui.
Al quesito se a una determinata esposizione si possa far risalire con certezza o con un alto grado di
probabilità la causa di una determinata patologia, dai consulenti dell’accusa si è risposto:
«L’attribuzione del rischio a livello individuale comporta la predizione, rivolta al futuro, e
l’attribuzione causale rivolta al passato; [...] data la natura multifattoriale del cancro, oltre al
carattere probabilistico del legame causale, è impossibile — se non in casi eccezionali — attribuire
il singolo caso di tumore ad una singola esposizione» (così VINEIS, La causalità tra diritto e
medicina, 1991). In termini suggestivi l’autore citato afferma: «il paradigma dell’epidemiologia può
essere definito come metodo della scatola nera nel senso che la ricerca epidemiologica mira
abitualmente a mettere in relazione qualche evento esterno (esposizione) con il rischio di malattia
senza addentrarsi nei meccanismi patogenetici.
L’epidemiologia delle malattie croniche prescinde da un’assunzione forte circa la relazione causale:
per causa si intende qualunque esposizione che preceda l’insorgenza della malattia,
compatibilmente con un periodo di induzione biologica, che aumenti la probabilità di contrarre la
malattia.
Da un lato vi è un’ovvia rinuncia ad un’interpretazione della causa in senso deterministico (o
quanto meno come causa necessaria); dall’altro lato storicamente l’epidemiologia delle malattie
croniche è stata poco interessata sia al riscontro di lesioni, come substrato anatomico del legame
causale (per esempio lo studio di eventi intermedi nella sequenza patogenetica della cancerogenesi)
sia a problemi classificativi per la semplice constatazione che uno stesso tipo di cancro ha cause
multiple e i casi dovuti ad un’esposizione non sono materialmente distinguibili, sul piano
morfologico, da quelli dovuti ad un’altra esposizione; [...] data la natura multifattoriale del cancro,
oltre al carattere probabilistico del legame causale, è impossibile — se non in casi eccezionali —
attribuire il singolo caso di tumore ad una singola esposizione».
Aggiunge ancora l’autore che a seguito di esposizioni a livelli sempre più bassi ma ad un numero
nettamente maggiore di sostanze che caratterizza l’epoca più recente, «la ricerca epidemiologica è
divenuta sempre più difficoltosa e la potenza statistica degli studi epidemiologici disperatamente
limitata: di fronte ai modesti incrementi di rischio attesi per esposizioni a bassi livelli, la varianza di
errore sommata a piccoli errori sistematici (piccole distorsioni nel disegno dello studio) è
proporzionalmente sin troppo elevata rispetto alla misura dell’effetto».
E indica una nuova strada, che sta emergendo per superare questi problemi: «accanto
all’integrazione fra dati epidemiologici e conoscenze sperimentali, anche una rivalutazione di un
approccio metabolico e biochimico alla eziologia dei tumori».
L’altro consulente del p.m. dott. Comba, come già detto coautore dello studio epidemiologico su
Porto Marghera, sulla problematica in questione così si esprime:
«L’attribuzione al caso singolo è incerta ma si regge su di una conoscenza certa (una catena
argomentativa valida e fondata) e l’incertezza può essere diminuita acquisendo ulteriori
informazioni che facciano passare la probabilità condizionata a livelli via via più alti (o più bassi se
vi sono spiegazioni alternative). Tutti i ragionamenti scientifici funzionano in questo modo e il
cento per cento di probabilità non si raggiunge mai. Nell’affermazione di Vineis in cui si parla di
casi eccezionali si fa riferimento specificamente a quelli in cui c’è un fattore di rischio fortemente
associato ad una particolare patologia (ad esempio cvm e angiosarcoma epatico): in questi casi si
può valutare il nesso causale a livello individuale una volta escluse con ragionevole certezza altre
cause note dell’angiosarcoma epatico quali l’esposizione professionale ad arsenico e l’uso di
thorotrast.
I casi più frequenti in epidemiologia sono tuttavia quelli in cui i rischi relativi in gioco sono meno
elevati, ad esempio compresi fra 1 e 2, e si configurano come associazioni deboli e, comunque, la
malattia ha una eziologia multifattoriale, per cui si tratta allora di sviluppare una riflessione che
poggi sia sul metodo epidemiologico sia sull’approccio medico legale; [...] il dato epidemiologico,
ove disponibile e applicabile, concorre alla valutazione del nesso causale a livello individuale anche
senza esaurirla.
Non è sicuramente proponibile un approccio che implichi un passaggio automatico e acritico dei
risultati di uno studio dal livello di popolazione a livello individuale, ma non è neppure
condivisibile un’applicazione dei dati epidemiologici rigidamente circoscritta al livello collettivo o
che prescinda dalla ovvia considerazione che ogni popolazione è costituita da individui» (COMBA,
Relazione 30 ottobre 1998: indagine epidemiologica e nesso di causalità).
Un altro consulente epidemiologo di parte civile (Medicina democratica), il prof. Duca,
sull’argomento così si è pronunciato (pur prendendo le distanze dalle tesi estreme dei consulenti
della difesa che affermavano l’incapacità o comunque l’inidoneità dell’epidemiologia ad esprimere
una valutazione a proposito di quello che succede nel singolo individuo):
«I dati epidemiologici possono essere utili nel segnalare l’esistenza di fattori di rischio e quindi
preziosi anche quando si tratta di procedere al riconoscimento di un nesso causale a livello
individuale [...] ad esempio se il rischio relativo di tumore polmonare fra i soggetti mediamente
esposti a fumo di sigarette è pari a 8, il Rae (rischio attribuibile per gli esposti) indica che di tutti i
casi di tumore del polmone che insorgono fra i medi fumatori una percentuale pari all’87,5 per
cento è da attribuire proprio all’esposizione a fumo di sigaretta e se fra i fumatori accaniti il rischio
relativo è pari a 20 e, quindi, il Rae = novantacinque per cento, ciò sta a indicare che il
novantacinque per cento di tumori polmonari insorti in fumatori accaniti sono da attribuire al fumo.
Un fattore molto fortemente associato alla malattia come il fumo di sigaretta al tumore del polmone
non permette di effettuare anch’esso un’attribuzione causale all’esposizione del singolo caso
esposto con una probabilità che superi il novantacinque per cento.
Una volta chiarito il contributo che l’epidemiologia, attraverso il calcolo del rischio attribuibile,
può dare alla soluzione del problema, stabilire una soglia di probabilità alla quale concludere per
un’attribuzione causale all’esposizione del caso individuale non si può ridurre a problema tecnico,
ma a questione che va argomentata e decisa in questo tribunale, tenendo conto del contesto più
ampio e complesso, considerando tutte le implicazioni e considerazioni che vanno ben oltre quelle
epidemiologiche, con tutte le imprecisioni che queste ultime comportano».
Più oltre, nelle sue conclusioni, l’epidemiologo ribadisce su tale problematica il suo pensiero
affermando che «l’accertamento dell’esistenza di una relazione causale non può fondarsi solo sui
metodi statistici applicati agli studi epidemiologici, anche se un uso appropriato di indicatori
statistici (Rr e Rae) può servire a sostenere una tale interpretazione; [...] l’accertamento
dell’esistenza di una relazione causale deve avvalersi della valutazione completa di tutti i dati
scientifici disponibili, inclusi quelli sperimentali su animali, colture cellulari o batteriche e sul
giudizio di plausibilità biologica dei meccanismi di azione noti o ipotizzati» (Il contributo del
metodo statistico allo studio della relazione causale, relazione 5 giugno 1999 prodotta agli atti dalla
parte civile).
Tutti i consulenti dell’accusa pubblica e privata sono dunque concordi nel ritenere che l’approccio
epidemiologico non basta anche quando l’associazione è forte, situazione del tutto eccezionale
rispetto alla realtà, cui si trova di fronte l’epidemiologia, di rischi relativi oscillanti fra 1 e 2 e di
fattori confondenti per la multifattorialità della maggior parte delle patologie.
Le valutazioni delle agenzie internazionali (Oms-Iarc-Epa) in ordine alla cancerogenicità di una
sostanza e agli eccessi di rischio conseguenti ad un’esposizione alla stessa si riferiscono alla
causalità generale intesa come idoneità a produrre un certo tipo di neoplasia negli esposti.
Tali valutazioni si basano perlopiù su studi epidemiologici e, ad integrazione e supporto, su studi
sperimentali su animali o in vitro così da aggiungere all’ipotesi epidemiologica quella ausiliaria
della somiglianza o della comparazione degli effetti sull’uomo e sull’animale.
Si può riconoscere che in genere i criteri utilizzati dalla Iarc per valutare l’evidenza di
cancerogenicità espressa da studi epidemiologici sono quelli stessi individuati da Hill come linee
guida per valutare la qualità degli studi e confrontarli e quindi considerano la forza
dell’associazione, la relazione fra entità dell’esposizione ed effetto, la specificità dell’associazione
con riferimento a determinati organi bersaglio che possono anche contenere considerazioni e
valutazioni su studi sperimentali.
Ma è di tutta evidenza, anche per le ragioni riferite dai consulenti dell’accusa, che le valutazioni di
tali agenzie sono circoscritte nell’ambito della causalità generale e le relazioni causali affermate
tengono anche conto di una rilevante preoccupazione precauzionale essendo in esse insita una
funzione preventiva.
Afferma ancora Vineis: «Vi sono considerazioni extra-scientifiche che portano a pesare
diversamente l’evidenza scientifica quando si tratta di mettere in atto un programma preventivo; [...]
un motivo etico forte per essere più restrittivi nel caso delle esposizioni professionali è la
diseguaglianza di distribuzione: essendo gli esposti una minoranza della popolazione ed essendo
l’esposizione di natura involontaria, è opportuno essere molto severi nella regolamentazione [...]
conseguentemente, di fronte ad una incertezza scientifica per le esposizioni professionali, è
preferibile incorrere più facilmente in un errore di primo tipo (regolamentare inutilmente una
sostanza innocua), piuttosto che di secondo tipo (assolvere una sostanza tossica)» (ibid.).
La causalità in epidemiologia, anche quando affermata dalle agenzie, non solo riguarda sempre e
solo il livello di popolazione e non del singolo, ma può essere soddisfatta da evidenze scientifiche
ancora deboli e incerte dovendo assolvere a finalità precauzionali.
Sarebbe pertanto errato affidarsi, al fine di ritenere assolto ogni compito accertativo della causalità
generale, alle valutazioni e alle enunciazioni delle stesse: eppure i consulenti medico-legali
dell’accusa pubblica e privata hanno assunto come dato indiscusso proprio le indicazioni di Iarc
1987, senza neppure tener conto degli studi successivi e in particolare degli aggiornamenti del 1991
e del 2000 illustrati in aula dai loro coautori dott. Simonato e dott. Boffetta.
Si può certamente condividere l’assunto che l’epidemiologia debba fare «due passi verso
l’individuo, dialogando con i clinici perché, pur essendo due mondi con metodologie e procedure
diverse, hanno tuttavia finalità comuni»: ma il confronto deve avvenire, perché possa raggiungere lo
scopo, in termini critici e dialettici.
Il mondo della clinica può integrare il mondo dell’epidemiologia solo se riesce ad esplicare il caso
singolo attraverso un’indagine anamnestica, diagnostica ed eziopatologica approfondita e corretta e
non si attesti invece su un giudizio di mera idoneità della sostanza a cui il soggetto è stato esposto.
Non si faccia cioè solamente ricorso alla criteriologia della capacità lesiva, della continuità
fenomenologica, dell’idoneità di sede, ecc.
Neppure può bastare un ricorso acritico all’oncogenesi ritenendo di potere da essa avere risposte
concludenti ed esaustive: innanzitutto perché — come riconosce il prof. Colombatti, consulente
dell’accusa — «i dati non sono ancora sufficienti per suggerire che esista una modalità specifica che
permetta di identificare l’azione del cloruro di vinile»; in secondo luogo perché le modificazioni ai
ritenuti biomarcatori (p53 e Kras) non sono specifiche dell’esposizione al cloruro di vinile perché
sono state individuate anche in non esposti e neppure sono sempre state indotte da cause esogene.
Comunque sono e rimangono dati orientativi per un approfondimento della ricerca e per un
auspicabile progredire della conoscenza sull’associazione: del resto l’approccio dell’accusa in
questo ambito è sempre stato del tutto teorico perché nessuna indagine è stata effettuata sulle parti
offese ai fini di accertare sulle stesse la presenza o meno di mutazioni di tali enzimi e quindi nessun
contributo è stato apportato allo studio del caso singolo.
Devesi aggiungere che anche il dott. Simonato nel corso della sua audizione (udienza 12 luglio
2000) ha affermato che «nel programma di lavoro dello studio multicentrico europeo c’era anche la
parte sperimentale per meglio studiare i meccanismi di tipo biologico, così da combinare la parte
epidemiologica con quella biologica, cosa che non si è riusciti a portare avanti perché è risultato
troppo complesso».
Bisogna prendere atto che le aspirazioni degli epidemiologi, espresse anche da Vineis, di integrare i
loro dati con le conoscenze sperimentali, così da pervenire ad un approccio che tendenzialmente
approdi ad individuare almeno una parte dei meccanismi eziologici delle catene causali, non sono
ancora attuabili.
È interessante conoscere l’orientamento della giurisprudenza e della dottrina americana,
ampiamente citate dalle difese nel presente processo, in ordine all’idoneità della causalità generale a
costituire prova sufficiente in ambito processuale.
Nel processo penale non sussiste alcun contrasto in ordine all’inidoneità della causalità generale di
superare la prova dell’«oltre il ragionevole dubbio» e di conseguenza viene prescelta la strada del
processo civile dove comunque si ritiene sia necessaria la prova particolaristica della causalità
individuale e tuttavia il criterio valutativo dell’accertamento si attenua al «più probabile che no».
Alcuni esempi significativi: la Corte d’appello per il circuito di Columbia con sentenza del 1997 ha
affermato che non è stata provata neppure la causalità generale in ordine alle malformazioni legate
all’uso del farmaco e altresì la diagnosi differenziale non è stata in grado di escludere ogni altra
causa potenziale; la Corte d’appello per il quinto circuito con sentenza del 1998 ha affermato che la
causalità generale non consente di formulare conclusioni sulla causalità individuale neppure nei casi
di esposizione ad asbesto «perché una stima di probabilità basata su una popolazione non ci parla di
una probabilità di causalità in nessun singolo caso».
In proposito il giudice Brennan ha affermato: «la prova statistica non può dimostrare la causalità»;
nel caso Miller è stata intentata una causa per decesso in seguito a fatto illecito per conto di un
lavoratore esposto al benzene che morì di leucemia. La corte osservò che «l’unica base d’appoggio
utile per fare delle deduzioni a favore del ricorrente sarebbero delle statistiche che indicano che in
molti casi la leucemia insorge in seguito all’esposizione al benzene, senza sapere perché. La
convinzione della corte è che si può sapere qualcosa solo quando si sia individuata una catena
causale meccanicistica».
Si può convenire che questo è un orientamento indubbiamente rigido, che si rifà a un modello
epistemologico neopositivista carnapiano, tanto che ha lasciato spazio ad una versione c.d. debole,
che ritiene la prova della causalità individuale assai difficile da raggiungere perché è di norma
sconosciuta scientificamente la catena causale meccanicistica e pertanto si ricorre a modelli causali
disancorati della prova della causalità individuale per soddisfare le esigenze di risarcimento delle
vittime.
Paradigmatica di questo orientamento è la sentenza della Corte suprema del Texas del 1997 la
quale dapprima sottolinea la distinzione tra causalità generale e causalità individuale:
«La causalità è generale quando una sostanza è in grado di causare un danno o una condizione
particolare in una intera popolazione, mentre la causalità è specifica quando una sostanza ha causato
il danno del singolo individuo [...] in molti casi di esposizione a sostanze tossiche non si può fare
una sperimentazione diretta e non vi sarà una prova affidabile della causalità specifica. In assenza di
una prova diretta, scientificamente affidabile, di causalità, i ricorrenti possono tentare di dimostrare
che l’esposizione alla sostanza tossica aumenta il rischio del loro danno particolare; [...] se il rischio
dovuto all’esposizione è più elevato che nella popolazione generale, allora il danno dell’attore è
stato più probabilmente che no causato dalla sostanza.
Questo ordine di idee che la versione debole prende in considerazione riconosce che la scienza non
può dirci cosa abbia causato un particolare danno, ma si fonda su ragioni di politica generale e cioè
sulla considerazione che quando l’incidenza di una malattia o di un danno sia stata sufficientemente
elevata a seguito dell’esposizione, chiunque sia stato esposto a quella sostanza dimostri di aver
contratto quella malattia o quel danno può sollevare una questione di fatto sulla causalità. [...]
Mentre la versione forte richiede che l’attore offra sia l’evidenza epidemiologica sul fatto che la
probabilità di causazione è superiore al cinquanta per cento nella popolazione esposta, sia la prova
particolaristica che la sostanza ha recato un danno all’individuo, invece la versione debole permette
di giungere a sentenze basate solo su studi epidemiologici e però l’evidenza epidemiologica deve
dimostrare che il rischio di danno nella popolazione esposta è più che il doppio del rischio della
popolazione non esposta [...] in tal caso, quando il rischio relativo è maggiore di due, c’è una
probabilità maggiore del cinquanta per cento che il danno sia stato causato dalla sostanza».
Nell’ambito del processo civile pertanto si è andato delineando un orientamento più flessibile del
c.d. raddoppio del rischio che segna un punto di equilibrio tra le esigenze del sistema legale e i
limiti della scienza, anche se nell’ambito di tale orientamento si richiede che la prova probabilistica
dell’efficienza causale debba essere corroborata da altri fattori.
L’accenno agli orientamenti della giurisprudenza americana non sembri estemporaneo. Essi
mettono in rilievo, pur nell’ambito del processo civile, le spinte che tendono a superare il modello
meccanicistico di causalità, definito «ingenuo e arcaico» dall’accusa (e addirittura incostituzionale
perché contrario al principio di obbligatorietà dell’azione penale) e che sono state di continuo
evocate: l’esigenza di una tutela delle vittime, dei beni della salute e della vita umana.
Beni che indiscutibilmente devono essere tenuti senz’altro in alta considerazione, senza però
trascurare che nell’ambito del processo penale vi sono altri beni da tutelare, che sono quelli della
responsabilità personale e della libertà.
Al di là dell’enfasi posta dal p.m. nel ruolo assegnatosi di tutore esclusivo dei beni della salute e
della vita umana (che ha inteso anche sottolineare come la scelta di questi valori costituisca uno
spartiacque etico rispetto a chi invece ha sposato «la cultura del mercante, che ritiene di poter
comprare tutto con il denaro, anche la salute e la vita umana» — così nella replica finale), non si
può trascurare che queste sono le motivazioni più o meno esplicite che spingono a orientamenti che
introducono nel processo ricostruttivo del nesso causale istanze di prevenzione generale.
Tale è l’esplicito tenore della sentenza della Suprema corte richiamata dal p.m. (Cass., sez. IV, 12
luglio 1991, Silvestri, Foro it., 1992, II, 363) secondo cui «quando è in gioco la vita umana, anche
solo poche possibilità di successo di un immediato e sollecito intervento sono sufficienti; [...] il
rapporto causale sussiste anche quando l’opera del sanitario [...] avrebbe avuto non già la certezza
ma soltanto serie e apprezzabili possibilità di successo [...] limitate nel caso di specie al trenta per
cento».
Peraltro devesi sottolineare che gli orientamenti più recenti della Cassazione sono ben più rigorosi
e si fanno carico delle preoccupazioni della commissione Grosso cui sopra si è fatto riferimento.
Non solo la sentenza 1688/00 ha sostenuto che «in tanto il giudice può affermare il rapporto di
causalità, nei reati omissivi, in quanto, pena il rinnegamento del principio di personalità della
responsabilità, abbia accertato che, con probabilità vicina a cento quella condotta, azione od
omissione, è stata causa necessaria dell’evento verificatosi hic et nunc».
Ma anche la sentenza 13 settembre 2001 richiamata dallo stesso p.m. afferma che «non essendo
possibile nella causalità omissiva accertare il rapporto naturalistico di causazione tra la condotta
omessa e l’evento, il giudice dovrà accertare attraverso un ragionamento adeguato e coerente,
basato su criteri scientifici certi e su regole di natura probabilistica, tali da consentire una
generalizzazione sul nesso di condizionamento, che se l’azione doverosa omessa fosse stata
realizzata si sarebbe impedito l’evento di reato, che in tal caso può essere oggettivamente imputato
alla condotta dell’agente. [...] Lo spostamento dell’indagine dal piano deterministico a quello
probabilistico rappresenta per il giudice una complicazione nella formulazione del giudizio causale,
ma ciò non esclude la necessità di una sua formulazione analitica che pervenga, senza affrettate
approssimazioni, alla conclusione che l’omissione costituisce l’antecedente necessario, anche se
non da solo sufficiente, del processo reale e non ipotetico che ha condotto all’evento».
Il problema che si pone al tribunale, al di là dell’individuazione del grado di probabilità o della
percentuale che si ritiene sufficiente ai fini dell’accertamento del nesso causale, è piuttosto quello di
individuare un modello causale al tempo stesso compatibile con il nostro ordinamento e idoneo a
includere non solo le spiegazioni nomologico-deduttive provviste di certezza, ma anche le
spiegazioni offerte dalla scienza secondo un modello statistico-induttivo che colloca l’approccio
nomologico nello specifico contesto che valorizza la ricerca e l’analisi di tutti i fattori presenti e
interagenti (Hempel): in tale modo anche le leggi statistiche sarebbero in grado di spiegare che un
evento si è verificato a patto che la frequenza consenta di inferire l’explanandum con quasi certezza
sulla base di una relazione logico-probabilistica.
Questo modello nomologico-deduttivo temperato dal modello statistico-induttivo sembra essere
quello assunto dagli orientamenti giurisprudenziali da ultimo citati in cui si fa riferimento, ai fini
dell’accertamento del nesso causale, a «criteri scientifici certi» o a «regole di natura probabilistica
tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento».
Modello idoneo a comprendere le spiegazioni dell’indagine causale nell’ambito delle scienze cui si
è fatto ricorso in questo processo: non solo l’epidemiologia, la biologia molecolare e la tossicologia
di cui si è sinora parlato, ma in particolare anche la medicina legale strettamente dipendente dalle
conoscenze generali, ma relative, sulla natura della causa, sulla sua modalità di azione, sulle
caratteristiche delle sue conseguenze attraverso un processo di confronto delle conoscenze
scientifiche con i dati dell’osservazione clinica, anatomopatologica, di laboratorio, ecc.
È infatti di comune esperienza che diagnosi eziologiche che possono avvalersi di criteri di certezza
sono confinate in un numero limitato di casi mentre negli altri casi è necessario collegare tutti i dati
disponibili per giungere comunque a valutazioni probabilistiche.
Se — come è stato detto — per il filosofo del diritto o per il penalista teoretico il rapporto causale
si muove seguendo un ragionamento deduttivo, per il medico legale il ragionamento muove da un
fatto concreto (evento) che consente di risalire con rigore induttivo al fenomeno che lo ha
determinato (causa) che, ancorché fondato su osservazioni di valore statistico-probabilistico, può
fornire risultati apprezzabili e rigorosi.
Non è contestabile che le spiegazioni cliniche siano prevalentemente spiegazioni probabilistiche,
soprattutto nell’ambito della diagnostica eziopatogenetica che si prefigge di ricostruire l’intera
sequenza causale del processo morboso e che si trova pertanto ad individuare quale fra le talvolta
molte condizioni iniziali possono essere intervenute e hanno veramente agito.
Anche il giudizio diagnostico è pertanto gravato da probabilità di errore, ma neppure da esso si può
prescindere per l’accertamento eziologico.
Insomma dalle scienze e dai limiti di conoscenza che esse pongono non si può prescindere: si può
solo pretendere l’adozione dei rigorosi criteri dettati dagli statuti epistemologici propri e una
valutazione coerente di tutti gli elementi di conoscenza disponibili.
La propensione alla certezza dell’accertamento sia dei nessi relativi alla causalità generale che di
quelli della causalità individuale deve avere fondamento e nel rigore metodologico ed
epistemologico con cui le varie scienze e discipline conducono le loro indagini, nella potenza del
risultato raggiunto desumibile dall’ampiezza dello studio, nel grado di consenso ricevuto nella
comunità scientifica, nella coerenza complessiva che i risultati raggiunti nelle diverse scienze e
discipline debbono esprimere nello specifico contesto, così da valorizzare per l’appunto la ricerca e
l’analisi di tutti i fattori presenti e interagenti.
Queste conclusioni, da un lato, allontanano dalle «secche» di un modello condizionalistico puro
legato a criteri di indagine nomologico-deduttivi che si era arenato dimostrando di non riuscire a
dare risposte, se non totalmente negative, alle esigenze poste da una società del rischio ove le
spiegazioni causali sono offerte da scienze non solo sperimentali e, dall’altro, consentono di
rifuggire dagli orientamenti che forzano il criterio causale per ragioni di prevenzione generale
collocandolo nell’area dell’aumento del rischio o confondendolo con l’elemento soggettivo della
colpa, introducendo l’elemento della prevedibilità dell’evento.
È forse una scelta che non offre anche una risposta appagante alla «questione cruciale» che dalla
difesa è stata posta e secondo cui «poiché nelle scienze non vi è alcuna certezza, essendo le leggi
della scienza null’altro che delle ipotesi di cui non si saprà se sono vere o false e perché le ipotesi
scientifiche che ieri potevano sembrare confermate oggi possono risultare falsificate, si corre il
rischio inaccettabile di condanne infondate».
Ma la risposta può essere trovata nel rigore dell’accertamento sulla base dei seguenti criteri:
1) le inferenze causali devono essere tratte dalle scienze che attraverso un rigoroso e corretto
metodo scientifico apportino un’effettiva e affidabile conoscenza scientifica;
2) l’affidabilità delle conoscenze, sia pure suscettibili in futuro di ulteriori apporti che possono
modificarle o addirittura falsificarle, è determinato dalla validazione che ricevono e
dall’accettazione generale o preponderante nella comunità scientifica nonché dalla verifica empirica
delle loro spiegazioni mediante il controllo dell’ipotesi attraverso la confutazione, così da
raggiungere una «corroborazione provvisoria»;
3) le conclusioni debbono essere comunque verificate nel loro progressivo evolversi e sempre
confrontate con quelle di altre discipline per accertare la coerenza complessiva del risultato
raggiunto;
4) l’incertezza scientifica che dovesse, comunque, residuare va risolta sia nell’ambito del rapporto
causale sia nell’ambito dell’imputabilità soggettiva secondo la regola di giudizio che la
responsabilità deve essere provata «oltre il ragionevole dubbio», regola di giudizio che ormai fa
parte del nostro ordinamento.
La causalità generale da esposizione a cloruro di vinile: introduzione. La causalità generale con
l’introduzione di studi epidemiologici, tossicologici e sperimentali cui si è fatto riferimento negli
aspetti di maggior rilievo, è stata utilizzata dall’accusa ai fini di mostrare non solo l’idoneità lesiva
della sostanza, ma altresì per indicare gli indici di rischio relativo per ciascuna neoplasia che si è
ritenuta in qualche misura, forte o debole, associata all’esposizione.
Una causalità generale tuttavia debole, per lo più al di sotto non tanto del raddoppio del rischio,
come almeno pretende la giurisprudenza civilistica americana del più probabile che no, ma
addirittura della significatività statistica, ma ciò nonostante sempre e comunque assunta come
ineludibile presupposto della causalità individuale anche di fronte a fattori di rischio alternativi di
alta potenza esplicativa che sono stati valutati come concausa della malattia e mai come fattori
causali di per sé sufficienti e necessari.
Vero che Iarc 1987, che ha costituito il punto di partenza per le imputazioni e di approdo per le
conclusioni del p.m., salvo alcuni aggiustamenti quantitativi dell’ultimo momento, indicava
un’associazione tra esposizione a cvm e tumori al fegato (angiosarcomi e carcinomi epatocellulari),
tumori polmonari, tumori cerebrali, tumori del sistema emolinfopoietico, melanomi.
Ma è altrettanto vero che quelle valutazioni si fondavano prevalentemente su studi epidemiologici e
su conoscenze ancora in larga parte risalenti agli anni settanta e primi anni ottanta, che hanno subìto
rivisitazioni critiche e ampi aggiornamenti per la maggior parte incorporati nei due studi
multicentrici americano ed europeo (Wong 1991; Simonato 1991), ulteriormente aggiornati di
recente (Ward 2000 e Mundt 2000) e ampiamente discussi in sede dibattimentale.
Sulla base di un’osservazione per l’intanto di carattere generale questi studi rilevano che non vi è
alcun eccesso di mortalità globale per tumore nei lavoratori del cloruro di vinile: infatti nella coorte
americana (Mundt) si sono osservati 895 decessi per tutti i tumori rispetto a 935,35 attesi (Rsm
0,96) ed escludendo i 55 angiosarcomi, i decessi scendevano a 840 (Rsm 0,88); nella coorte europea
(Ward) si sono osservati 883 decessi per tutti i tumori maligni rispetto a 889 attesi (Smr 0,99) ed
escludendo gli angiosarcomi il rapporto scende a 0,96.
Nella coorte di Porto Marghera i decessi totali per tumore sono 88 rispetto ai 110,9 attesi (Rsm
0,79).
Si riportano di seguito sinteticamente, riservando al prosieguo un loro approfondimento, anche i
dati aggiornati relativi ai tumori indicati da Iarc 1987 e alle patologie neoplastiche e non considerate
nel presente processo, per svolgere talune considerazioni preliminari. (Omissis)
Sulla base di tali dati, i consulenti epidemiologici dell’accusa avevano escluso o comunque
espresso dubbi e perplessità in ordine alla correlabilità con le sostanze in considerazione dei tumori
del cervello, del sistema emolinfopoietico, dei melanomi, ma si potrebbe aggiungere anche del
tumore del laringe.
Invero rispetto a queste patologie, sulla base degli studi epidemiologici complessivi e più
aggiornati esaminati nel corso del dibattimento e considerando anche i risultati dello specifico
studio sulla coorte di Porto Marghera può affermarsi che non sussiste la prova di una causalità
generale e cioè a dire dell’idoneità del cvm e del pvc a provocare tali tumori.
Gli eccessi talvolta presenti in talune coorti, nonostante tutte le evidenze, sono stati invece ritenuti
statisticamente significativi dall’accusa senza neppure verificare, applicando i corretti criteri
epistemologici vigenti in epidemiologia, la validità dello studio sia con riferimento all’andamento
dell’effetto doserisposta, che nel caso che ci occupa è fondamentale per supportare la tesi della
causalità di un’associazione, sia con riferimento ai dati relativi alla durata dell’esposizione e ai
tempi di latenza della malattia.
Andavano invece colte le indicazioni che nell’ultima relazione presentata dai consulenti Comba-
Pirastu erano pur presenti: per i tumori al sistema emolinfopoietico si affermava che «l’insieme
dell’evidenza epidemiologica non documenta in modo definitivo l’associazione tra cvm e questa
causa di morte, anche se i risultati degli studi nel loro insieme non documentano in modo univoco
un’assenza di rischio»; per il tumore dell’encefalo si rilevava che «l’assenza di andamenti per
variabili temporali e di esposizione, insieme al fatto che il numero degli osservati è spesso esiguo,
sono i principali limiti dei dati disponibili ai fini dell’attribuzione di un ruolo causale
dell’esposizione nello sviluppo di questo tumore»; per il tumore del laringe, premesso che la
mortalità non è il migliore indicatore di rischio per un tumore per il quale la sopravvivenza è stata
stimata pari all’ottantacinque per cento, si affermava che «l’evidenza epidemiologica suggerisce un
aumento di rischio e però l’assenza di informazione sulla localizzazione deve essere accompagnata
dalla valutazione dell’evidenza clinica e patologica»; infine per i melanomi si affermava che «la
ripetuta osservazione di incrementi di rischio, seppur concentrata in alcuni paesi (Norvegia, Italia,
Gran Bretagna) rende plausibile l’esistenza di un’associazione».
Sono valutazioni caute, ma indicative di un’assenza di significatività, talvolta espressa in termini
più espliciti (tumori del sistema emolinfopoietico e tumori dell’encefalo), talora indicando i limiti
degli eccessi riscontrati (confinati in talune coorti e ridotti a casi esigui) ovvero prospettando
l’esigenza di approfondimenti medico-legali.
Ancora più perentorie erano state le conclusioni cui erano pervenuti gli autori dello studio
multicentrico europeo e del successivo aggiornamento, nel corso della loro audizione all’udienza
del 12 luglio 2000.
Il dott. Simonato con riferimento ai tumori del cervello e ai sarcomi (oltre che al polmone) ha
affermato: «le analisi di dose-risposta sono state applicate a tutte queste sedi e per nessuna di queste
sedi abbiamo visto una dose-risposta, cioè un rapporto costante e significativo tra le dosi alle quali
sono stati esposti i membri della coorte e gli effetti e quindi questo gruppo di patologie [...] non
mostra una similarità di questi effetti e quindi siamo in presenza di una situazione di minor rischio
per queste sedi».
Più specificamente, per quanto riguarda il melanoma della pelle affermava: «abbiamo un eccesso
all’interno di uno dei paesi e all’interno di questa sottocoorte c’è anche un effetto dose-risposta, che
però non si riproduce negli altri paesi [...] questo è un aspetto che rimane aperto e del quale non
sappiamo dare una spiegazione convincente: se la sostanza è cancerogena, lo è indipendentemente
dal paese dove avviene l’esposizione che dovrebbe dare un effetto». E più avanti ribadisce: «i
risultati dello studio norvegese che mostrano un effetto dose-risposta per il melanoma presi in sé
sono un’evidenza che però manca di consistenza».
Per quanto riguarda i tumori del cervello rilevava che gli osservati sono quanto gli attesi (Smr 1,07)
e concludeva: «formalmente significa un piccolo eccesso, che però è molto piccolo [...] queste sedi
poi sono state analizzate come dose-risposta e per nessuna di queste sedi abbiamo trovato un effetto
dose-risposta e quindi l’insieme dell’evidenza, è un poco questo, deve tenere conto dei vari aspetti».
Per quanto riguarda i linfosarcomi esprimeva le stesse considerazioni pur rilevando che vi era un
eccesso.
Rispondendo più avanti ad una domanda di un difensore di parte civile che gli chiedeva di dare una
risposta sugli eccessi comunque riscontrati, a prescindere dal mancato rilievo di un effetto dose-
risposta, chiariva meglio il suo pensiero in proposito e rispondeva: «lasciare fuori la dose-risposta
come lei chiede, un epidemiologo non lo fa perché è parte integrante dell’evidenza sulla quale poi
cerca di basare una valutazione complessiva che deve tendere a dire se fra questi due fatti, cioè
l’esposizione e la malattia, è plausibile un legame causale. Nel momento in cui ci troviamo di fronte
ad una patologia in cui la risposta cresce con la dose ci sentiamo sicuri di affermare che c’è un
rapporto ben stretto tra questi due fenomeni; nel momento in cui troviamo una situazione in cui
questo dose-effetto non c’è, risulta più difficilmente credibile la presenza di un’azione causale».
E a una seconda domanda dello stesso difensore chiariva: «l’osservazione dell’effetto dose-risposta
si fa all’interno di qualunque categoria di osservati-attesi anche se non c’è un eccesso [...] l’assenza
di un eccesso non significa in sé assenza di rischio [...] così come la presenza di eccesso non
significa necessariamente presenza di rischio: se questo eccesso si riproduce in più studi, nel tempo
si conclude che effettivamente è un eccesso [...] dipende dall’accumulo dell’evidenza».
Finiva col dire che per i tumori del sistema linfatico le conclusioni dell’aggiornamento erano
sovrapponibili a quelle dello studio precedente del 1991 ove si affermava che non era stata
individuata, pur in presenza di un eccesso, un’associazione significativa con la sostanza, ribadendo
che «c’è un eccesso e però non c’è una dose-risposta e quindi non è associata all’esposizione».
Il dott. Boffetta rispondeva in termini analoghi.
Per quanto riguarda il tumore del cervello osservava che nell’aggiornamento non è stato rilevato
alcun tipo di associazione: «il risultato è stato considerato sostanzialmente negativo nel senso di
mancata evidenza di un eccesso» e, pur rilevando che talune categorie di esposizione presentavano
degli eccessi, ciononostante faceva rilevare che proprio le fluttuazioni nei rischi relativi all’interno
delle categorie e, in particolare, il diminuire degli stessi con un aumentare dell’esposizione
cumulativa, lo portava a concludere che «si era molto lontano dal livello di significatività per
quanto riguarda il tumore al cervello».
Le considerazioni dei due epidemiologi, peraltro comuni a quelle dei consulenti del p.m., mettono
in rilievo l’importanza, ai fini di una valutazione, del dato statistico presente in studio, e quindi, ai
fini dell’accertamento di un rischio dipendente dall’associazione tra una determinata patologia e
l’esposizione a una sostanza, della scrupolosa analisi di tutte le variabili, per verificarne la coerenza.
Il dott. Simonato ha dato anche una risposta alla domanda se riteneva coerenti i risultati della
coorte di Porto Marghera con quelli più complessivi da lui esaminati nello studio multicentrico
affermando: «ho sempre avuto tendenza a non considerare l’evidenza di Porto Marghera diversa dal
resto dell’evidenza [...] andare a cercare nel dettaglio si capisce sempre meno [...] lavorare invece
sull’insieme dei dati si hanno dei risultati un po’ più robusti. All’interno si può andare a vedere e
però scendendo di dettaglio in dettaglio molte volte si rischia di perdersi [...] io non darei una
valutazione di un sottoinsieme della coorte italiana che a sua volta è un sottoinsieme della coorte
europea».
Questo rapido excursus consente di affermare che l’evidenza globale degli studi epidemiologici più
recenti e più significativi individua un’associazione forte tra esposizione a cvm e angiosarcoma
epatico ed eccessi di rischio nello svolgimento di talune mansioni (autoclavisti e insaccatori)
esposte ad elevate concentrazioni per l’epatocarcinoma e per il tumore polmonare, mentre le altre
associazioni, pure ipotizzate negli studi passati cui aveva fatto riferimento Iarc, non sono state
confermate.
Ma il p.m. non ne ha tratto le logiche e conseguenti conclusioni.
Con il decreto di rinvio a giudizio e con le successive contestazioni suppletive nel corso del
dibattimento, il p.m. ha introdotto 721 patologie riferite a 542 parti offese così suddivise:
acrosteolisi/Raynaud: 103; linfomi: 19; malattie del fegato neoplastiche e non: 295; malattie
polmonari neoplastiche e non: 194; adenocarcinomi gastrici: 16; carcinomi squamosi e del laringe:
23; altre neoplasie: 48; altre patologie: 23.
Tuttavia al termine della requisitoria il p.m. ha presentato le schede, riferite a 263 parti offese,
relative a 311 patologie.
Non ha ritenuto di fornire una spiegazione di questa modificazione della contestazione originaria,
limitandosi ad affermare che i casi non ripresentati avrebbero avuto comunque un loro rilievo
nell’ambito dei reati di strage e di disastro contestati.
Mentre appare evidente che sono stati eliminati tutti i tumori gastrici e del pancreas che erano stati
associati all’esposizione a dicloroetano, prendendo atto il p.m. che anche Iarc 1999 concludeva per
la «inadeguata evidenza di carcerogenicità nell’uomo», dall’altro lato deve ritenersi che le altre
patologie (neoplastiche e non) siano state ritenute o non sussistenti, a seguito dell’esame della
documentazione medica e dell’anamnesi generale e lavorativa, ovvero non correlate all’esposizione.
Con la conseguenza che essendo insussistenti o comunque non causalmente riconducibili, esse non
possono avere rilievo neppure nelle fattispecie più ampie di pericolo per la pubblica incolumità cui
il p.m. ha fatto riferimento.
Di seguito viene riportato il quadro sinottico che rappresenta il confronto tra le patologie contestate
e quelle indicate nelle schede depositate al termine della requisitoria.
———————————————————————————————
Patologie Numero diagnosi Numero diagnosi
iniziali nelle schede finali
———————————————————————————————
Malattie epatiche
Angiosarcomi 7 7 (8)
Epatocarcinomi 21 21
Cirrosi 39 44
Epatopatie (comprese le regredite) 225 73
Malattie polmonari
Neoplasie 94 87
Bronchiti 85 0
Broncopneumopatie croniche ostruttive
Pneumoconiosi 13 1
Tumori del sistema emolinfopoietico 24 21
Tumori gastrici 16 0
Tumori del laringe 23 18
Melanomi 7 5
Tumori cerebrali 6 6
Altre neoplasie 31 0
Altre patologie non neoplastiche 23 0
Fenomeni di Raynaud 103 26
Totale 717 309
———————————————————————————————
È rilevante notare sin da ora che sono state altresì eliminate le broncopatie e le broncopneumopatie
(87), nonché le pneumoconiosi collegate all’esposizione a pvc e, soprattutto, queste ultime indicate
come predittive del tumore polmonare di cui dagli studi epidemiologici è stato rilevato un eccesso
nella mansione di insaccatore che supporterebbe l’associazione.
Stupisce davvero che il p.m. neppure alla fine del dibattimento, quando ha dovuto considerare la
consistenza dei dati epidemiologici con riferimento agli organi bersaglio in considerazione, non sia
riuscito ad abbandonare le indicazioni di Iarc 1987 oramai superate dagli studi che per conto della
stessa Iarc avevano condotto il dott. Simonato e il dott. Boffetta.
Anzi abbia insistito cercando di corroborare la non evidenza dell’associazione con il ricorso a
incerti e contraddittori dati che gli provenivano dalla biologia molecolare, nonostante che lo stesso
Simonato avesse detto che «l’interesse da parte dei colleghi della parte sperimentale presenti a
Lione per poter studiare meglio anche i meccanismi di tipo biologico [...] per vedere cioè di
combinare la parte epidemiologica con quella biologica [...] non si è riusciti a portare avanti perché
è risultata troppo complessa».
Da parte loro i consulenti medico-legali del p.m. nell’esaminare tali patologie tumorali si sono
anch’essi essenzialmente riferiti, ai fini di associarle all’esposizione, alle indicazioni contenute nella
monografia di Iarc 1987, che, come si è già detto, sono state ampiamente ridimensionate dagli
aggiornamenti successivi e dalle analisi stratificate in essi contenute.
Nessun riferimento invece hanno fatto alla casistica specifica che avevano esaminato ai fini di
verificare se i tumori insorti nelle parti offese avevano una plausibilità epidemiologica, e cioè
rispondevano a quei criteri da cui consegue la validità dell’assunto che sussiste un’associazione con
l’esposizione: in particolare ai gradienti dose-rischio e durata-rischio e alle sequenze temporali
concernenti la data iniziale dell’esposizione, la sua durata, il periodo di latenza, rimanendo
esclusivamente attestati a un riferimento autorevole ma oramai superato.
Tanto più era necessaria un’analisi approfondita in ordine alla sussistenza di una coerenza tra tali
criteri di valutazione nell’ambito della casistica della coorte considerata rispetto a tumori di
eziologia ignota e per di più riscontrati in un numero limitato di casi tra gli addetti alla lavorazione
del cvm.
Diversamente — come hanno affermato gli epidemiologi — il semplice riferimento ad un eccesso,
per di più rilevato o in coorti diverse o comunque in numero assai ridotto di casi, non può avere
alcun significato rilevante ai fini della ritenuta associazione.
Alla debolezza delle evidenze epidemiologiche il p.m. ha cercato di supplire facendo ricorso alla
biologia molecolare e ai risultati ancora incerti, contraddittori e lacunosi che allo stato è in grado di
offrire, in particolare sostenendo la tesi dell’azione sinergica tra i fattori di rischio noti (alcool,
epatiti, fumo) e le sostanze in discussione che in tal modo assumerebbero il ruolo di concause
potenzianti gli effetti lesivi: non considerando che nel nostro ordinamento la concausa ha lo stesso
statuto epistemologico della causa, con la conseguenza che se non è dimostrato che un fattore è
causa di un evento, neppure può assumere la veste di concausa.
Il p.m. nessun rilievo ha invece dato all’evidenza epidemiologica e sperimentale che
indiscutibilmente individua negli effetti del cvm un rapporto dose-risposta la cui considerazione, da
un lato, avrebbe ricollegato gli eventi alle esposizioni di un lontano passato e, dall’altro, lo avrebbe
indotto ad escludere la rilevanza causale delle esposizioni successive al 1974.
Infatti in tutte le coorti, anche in quella in considerazione in questo processo, i tumori rilevati e in
particolare l’angiosarcoma, ma anche l’epatocarcinoma in coloro che hanno svolto la mansione di
autoclavisti e il tumore al polmone in coloro che hanno svolto solo la mansione di insaccatori, sono
tutti riconducibili ad elevate o elevatissime esposizioni che erano quelle proprie degli anni
cinquanta/sessanta e primi anni settanta, sino alla scoperta della cancerogenicità della sostanza.
In proposito nello studio multicentrico europeo (Simonato e altri 1991) si pone in rilievo
relativamente al cancro al fegato:
1) che l’analisi dei decessi da cancro del fegato basata sull’esposizione cumulativa rivela un rischio
crescente con l’aumento dell’esposizione e con una consistente relazione esposizione-risposta: si
verifica un aumento della mortalità al crescere dell’esposizione cumulativa e della durata
dell’esposizione;
2) che la caratteristica comune per tutti i soggetti morti per cancro del fegato è l’anno di
assunzione, soprattutto ricompreso nell’ambito degli anni cinquanta, mentre due sono stati assunti
negli anni quaranta e sei negli anni sessanta; le analisi basate sulle variabili temporali hanno rivelato
eccessi statisticamente rilevanti nei periodi di assunzione 1945-1954 e 1955-1964 mentre è stata
osservata una diminuzione del rischio per quelli assunti negli ultimi anni sessanta e nei primi anni
settanta, ancorché si osservi che il tempo di osservazione è ancora troppo breve per poter valutare il
rischio per i lavoratori assunti recentemente (il follow-up era allora limitato al 1986);
3) la categoria di esposizione 500-2.000 ppm presenta un rischio relativo di 1,20 sensibilmente
inferiore a quello delle categorie più elevate, e poiché in tale categoria è inserito un angiosarcoma
ad un’esposizione cumulativa di 288 ppm non si può affermare che in detta categoria non vi sia
senz’altro un’assenza di rischio, anche se non vi è certezza che si tratti effettivamente di un
angiosarcoma (essendo stato registrato come un generico tumore del fegato) e neppure vi è certezza
sul dato relativo all’esposizione cumulativa, poiché si trattava di lavoratore addetto alle autoclavi in
anni di elevata esposizione.
Nell’aggiornamento dello studio di tale coorte (Ward 2000) si rilevava che la categoria di
esposizione più bassa (0-735 ppm) aveva un rapporto standardizzato di 1,07 e presentava due casi di
angiosarcoma di cui uno era quello a 288 ppm di tipologia incerta già segnalato nello studio
precedente.
Gli studi della coorte statunitense, a partire da quelli di Cooper (1981) per giungere a quelli di
Wong (1991) e per finire a quelli di Mundt (2000), indicano anche essi un rapporto dose-risposta e
nell’ultimo studio si afferma che «lo studio ha confermato una forte associazione tra durata
dell’esposizione lavorativa prima del 1974 e tumori del fegato per la gran parte dovuta ad un
elevato eccesso di angiosarcomi».
Nella coorte di Porto Marghera il consulente dell’accusa prof. Martines mette in rilievo:
1) che i sette soggetti affetti da angiosarcoma erano tutti addetti alle mansioni a più elevata
esposizione (addetti alla pulizia di autoclavi) ed erano stati esposti a dosi comprese tra 3.600 e
9.000 ppm annui;
2) che tutti gli angiosarcomi si sono manifestati in quei lavoratori che subirono la prima
esposizione in un arco di tempo molto ristretto compreso fra il 1955 e il 1967;
3) che dei 16 casi di epatocarcinoma 13 si erano manifestati in quei lavoratori che erano stati
esposti a dosi cumulative comprese tra 1.651-10.125 ppm, 1 esposto a dosi cumulative comprese tra
301-1.650 ppm e 2 esposti a dosi cumulative da 0 a 300 ppm: precisava peraltro che l’unico caso di
carcinoma rilevato tra i soggetti a media esposizione presentava un’infezione cronica da virus e che
il ruolo dell’esposizione nei due pazienti esposti a basse concentrazioni non era precisabile;
4) che i 13 casi di epatocarcinoma ricompresi nella categoria ad alta esposizione presentano un
tempo di latenza medio dalla prima esposizione pari a trentuno anni e la prima esposizione si è
verificata in un arco ristretto di tempo compreso tra il 1952 e il 1961;
5) che dei 32 casi di cirrosi ben 22 risultavano essere stati esposti a dosi cumulative comprese tra
1.651-10.125 ppm e questo era l’unico gruppo che presentava un rischio relativo (odds ratio)
superiore all’unità (2,38) mentre nelle categorie a esposizione media e bassa il rischio relativo era
inferiore a 1.
Per quanto concerne i tumori del polmone i dati desumibili dagli studi epidemiologici
relativamente al rapporto dose-risposta, ai fini di verificare l’incidenza di tale tumore rispetto
all’esposizione cumulativa, sono senz’altro più incerti e contraddittori ma evidenziano anch’essi
una tendenza in tal senso.
Nello studio multicentrico di Simonato non è stata notata relazione esposizione-risposta con
l’aumento dell’esposizione cumulativa: l’unico eccesso (Smr 1,47) riguarda la latenza per coloro
con venticinque-ventinove anni trascorsi dall’inizio dell’esposizione.
Nell’aggiornamento (Ward 2000) in cui si fa un’analisi stratificata per mansione si rileva un trend
positivo e significativo per categorie crescenti di esposizione cumulativa a cvm (ma solo a 2800
ppm) in coloro che hanno svolto unicamente le mansioni di insaccatori, mentre nessuna tendenza è
stata osservata al crescere dell’esposizione cumulativa per i lavoratori che avevano svolto mansioni
sia come imballatori sia come insaccatori.
Invece nello studio della coorte americana, nel suo ultimo aggiornamento (Mundt), si afferma che
non ha trovato alcuna evidenza l’associazione tra esposizione a cvm e tumore del polmone, né
complessivamente né per stratificazione, con riferimento sia alla durata dell’esposizione sia alla
latenza, sia all’età e al periodo di inizio dell’esposizione, e pertanto non è suggerito alcun rischio.
Nello studio sulla coorte di Porto Marghera da parte dei consulenti dell’accusa pubblica si è sì
osservato un incremento significativo fra gli insaccatori in considerazione dell’intensità
dell’esposizione a cvm, ma temporalmente l’esposizione veniva collocata in particolare tra il 1950 e
il 1970.
L’aggiornamento al 30 luglio 1999 indica un eccesso (Smr 1,30) fra gli addetti all’insacco e un
ulteriore incremento (Smr 1,59) tra coloro che sono stati esclusivamente addetti all’insacco.
Dalle tabelle allegate risulta confermato che si tratta di lavoratori esposti nel periodo tra gli anni
cinquanta e la prima metà degli anni settanta.
Anche il prof. Mastrangelo, consulente di parte civile, che ha presentato lo studio caso-controllo già
esaminato sull’insorgenza del tumore del polmone nei lavoratori di Porto Marghera, conclude con il
dire che il periodo eziologicamente rilevante per i casi di cancro polmonare, che attribuisce alle
polveri di pvc, era quello anteriore al 1975 («per tutti i casi mostrati in tabella 11 l’anno di
assunzione va dal 1954 al 1974»), allorquando vi erano concentrazioni elevate di cvm nelle polveri
tanto da suggerire l’introduzione dello strippaggio per estrarre il cvm residuo.
In proposito il consulente afferma nella sua relazione che gli interventi finalizzati alla diminuzione
nella polvere del cvm residuo «furono realizzati nella seconda metà degli anni settanta quando la
maggior parte dei casi di cancro polmonare avevano già cessato il lavoro di insacco del pvc».
Sulla base degli studi epidemiologici sopra riferiti si può individuare un accordo uniforme e
assoluto tra tutti i consulenti che hanno partecipato al presente processo, anche nell’interpretazione
dei dati di letteratura, che l’esposizione rilevante al cvm per l’esplicazione dei suoi effetti
cancerogeni e patologici è esclusivamente quella a dosi elevate o elevatissime degli anni cinquanta-
sessanta e sino alla metà degli anni settanta.
È altrettanto pacifico che nessun angiosarcoma del fegato (che è il tumore tipico da esposizione a
cvm) si è manifestato in lavoratori assunti successivamente al 1973 nella coorte europea e
successivamente al 1967 nella coorte statunitense e in quella di Porto Marghera.
Nel recente studio di Rozman e Storm (1997) si conferma ulteriormente che «fino all’ottobre del
1993 nessun nuovo caso di angiosarcoma epatico fu riportato dal registro internazionale fra i più di
ottantamila lavoratori degli Stati uniti che erano stati esposti per la prima volta al cloruro di vinile a
partire dal 1968», traendone la conseguenza che «la riduzione delle esposizioni entro il range di 0,5-
5 ppm sembra essere stata fino ad ora adeguatamente protettiva».
Se si considera che la dose cumulativa più bassa a cui è stato individuato un angiosarcoma
(oltretutto di tipologia non certa) è quella di 288 ppm pari a circa 28 ppm di esposizione giornaliera,
si può affermare che alle esposizioni già presenti nella coorte di Porto Marghera nel 1974, e ancor
di più alle esposizioni degli anni successivi, pacificamente rientranti nei limiti dapprima adottati e
in seguito imposti di 3 ppm giornalieri (e anche ampiamente al di sotto degli stessi come
documentato dalle rilevazioni dei gascromatografi) non risulta esservi prova di una efficienza lesiva
del cvm.
Anche gli studi tossicologici e di oncogenesi di cui già si è parlato sono convergenti
nell’individuare un rapporto dose-risposta per il cvm: basti qui ricordare gli esperimenti di Maltoni
e gli studi di Weinrauch e di Swemberg secondo cui al di sotto di dosi cumulative di 10 ppm non è
stata accertata un’idoneità lesiva del cvm.
I consulenti del p.m., relativamente al problema dell’idoneità lesiva del cvm alle basse dosi non
hanno potuto smentire né i risultati epidemiologici né quelli sperimentali. Si sono limitati ad
affermare «che non si può escludere», «che la soglia al di sotto della quale non si sono osservati
tumori non è una soglia effettiva ma una soglia apparente [...] perché non si possono fare degli studi
che dimostrino l’inesistenza di una soglia perché bisogna andare nell’infinitamente piccolo»
(Berrino); «attualmente una relazione tra esposizione e cancerogenicità delle sostanze genotossiche
è troppo confusa per offrire linee guida sulla soglia [...] e perciò non vi è possibilità di uscire
dall’atteggiamento di essere molto conservativi e sull’esposizione e sul rischio e quindi accettare
che non vi è una dose sicura» (Terracini); «con questo tipo di modello non riesco a vedere l’effetto
alle basse dosi e quindi sulle basse dosi non posso dire assolutamente nulla» (Martines).
Gli epidemiologi Simonato e Boffetta, coautori degli studi sulla coorte europea, sentiti in proposito
hanno dichiarato quanto segue (udienza 12 luglio 2000):
Simonato: «il rapporto dose-risposta è rilevante ai fini di affermare una correlazione tra la sostanza
e la patologia; la sua assenza determina un’improbabilità dell’ipotesi.
L’individuazione di un livello minimo senza rischio non era tra gli obiettivi dello studio [...]
avevamo cercato di metterci in collaborazione con i colleghi dei laboratori per approfondire il
problema dose-risposta negli animali e nell’uomo, ma purtroppo c’è molta carenza di dati [...] quel
che si può dire è che il gruppo esposto al di sotto di certe dosi cumulative non mostra un eccesso e
questo è descrittivo, mentre credo che poter escludere che ci sia un rischio abbia delle implicazioni
diverse [...] però credo si possa concludere in maniera descrittiva: con quello che abbiamo adesso i
dati non mostrano [...] credo che l’aggiornamento dello studio apra un capitolo importante, che è
quello di poter indagare meglio su ordini di grandezza in cui uno è esposto per dieci anni a 10
ppm».
Boffetta: «abbiamo trovato una relazione dose-risposta molto forte con l’angiosarcoma simile a
quella che era stata già individuata nell’analisi precedente [...] riguardo agli angiosarcomi non
avevamo nessun caso sotto i 288 ppm che è il livello di esposizione cumulativa più basso [...] cosa
succede al di sotto, quindi nel range di esposizioni cumulative analoghe a quelle che possono essere
quelle sperimentali, penso non si possa ancora dirlo».
I due citati epidemiologi si sono pronunciati anche sul problema della rilevanza delle basse dosi
successive alle alte esposizioni ai fini della causazione dei tumori.
Simonato: «dove noi abbiamo effettivamente pochi dati sull’uomo è nel contributo differenziale
all’interno dei periodi espositivi; alla domanda se possiamo noi configurare che in realtà c’è un
meccanismo del tipo che alle alte dosi iniziali il processo si innesca, è irreversibile e non importa
quello che succede dopo oppure vi è una situazione di equilibrio instabile in cui anche le fasi
successive [...] questo dipende dai modelli di cancerogenesi che si studiano, però nell’uomo non si è
in grado attualmente di dare una risposta [...] noi riusciamo ad avere due o tre modelli di
cancerogeni in mente, però non sappiamo quanti sono quelli veri [...] insomma il limite della
conoscenza attuale».
Boffetta: «il differente contributo di esposizioni recenti o antiche alla stima dell’esposizione
cumulativa [...] a questo non possiamo rispondere [...] è diverso accumulare 1.000 ppm all’anno con
dieci anni a 100 ppm oppure in quindici anni e poi negli ultimi anni più basso [...] su questo non
abbiamo fatto analisi specifiche [...] se guardiamo la latenza come un approccio più grossolano a
questo, e vedere se gli ultimi anni incidono o meno, io su questo non posso [...]».
Sulla base dei convergenti elementi sopra riferiti si può sin d’ora concludere affermando che non
sussiste la prova della causalità generale e cioè dell’associazione tra cvm e tumore al cervello, al
sistema emolinfopoietico e melanomi, essendo stati riscontrati o deficit significativi ovvero piccoli
eccessi non rilevanti o comunque ritenuti non significativi anche per vizi di classificazione ovvero
per andamenti concernenti la durata e l’intensità dell’esposizione nonché la latenza, fortemente
anomali e quindi escludenti un’associazione. In proposito non si può non condividere sia quanto
affermato nella premessa del suo intervento dal consulente di parte civile prof. Duca che in
epidemiologia «assenza di evidenza di rischio non è evidenza di assenza di rischio» per le finalità
precauzionali e preventive che tale scienza si propone, sia quanto affermato conclusivamente che
comunque tale risultato «in un processo penale in cui sono in discussione altri valori degni di tutela
non può che portare a un’assoluzione almeno per insufficienza di prove».
Un’adesione a tale meditato convincimento, come si è visto certo non isolato tra i consulenti
dell’accusa, avrebbe potuto sin dall’inizio portare a una selezione delle patologie e
conseguentemente degli eventi penalmente rilevanti introdotti nel dibattimento.
Per quanto concerne gli angiosarcomi e gli epatocarcinomi riscontrati negli autoclavisti nonché i
tumori del polmone negli insaccatori e nei solo insaccatori, ammesso che questi ultimi tipi di
tumore, a differenza del primo, abbiano significatività statistica oltre che plausibilità biologica, si
sono verificati tutti a seguito delle alte esposizioni risalenti agli anni cinquanta e sessanta e prima
parte degli anni settanta, e cioè a quelle esposizioni elevate antecedenti alla conoscenza della
cancerogenicità del cvm.
Nessun tumore del fegato e del polmone ha interessato lavoratori della coorte di Porto Marghera
assunti dopo il 1967 e da tale data ormai è trascorso interamente il periodo di latenza non solo
medio ma approssimantesi anche alle punte medio-alte rilevate.
Conseguentemente si può trarre una prima incontestabile conclusione: alla stregua delle analisi
epidemiologiche aggiornate l’idoneità lesiva del cvm si è rivelata ad alte o elevatissime dosi mentre
non sussiste la prova di un’efficienza lesiva anche a basse dosi e in particolare a quelle esistenti dal
1974 in poi.
Le incertezze della scienza in proposito o le mere ipotesi o i postulati fondati su preoccupazioni
cautelative, seppure possano costituire dei punti di partenza per ulteriori approfondimenti in ambito
epidemiologico e sperimentale, come auspicano Simonato e Boffetta, non apportano nessun dato di
conoscenza utilizzabile in ambito processuale dove ci si deve attenere ai fatti accertati e provati.
A quei fatti cui il p.m. stesso ha affermato di volersi esclusivamente riferire nelle battute iniziali
della sua requisitoria: dabo tibi factum, dona mihi ius.
Sulla base di questa prima, ma non definitiva, conclusione non si può non rilevare sin d’ora che se
il p.m. fosse stato fedele a questa impostazione avrebbe dovuto tener conto delle incontestabili
evidenze emergenti dagli studi epidemiologici di maggior potenza statistica, e quindi, più
informativi, tanto più che i loro risultati erano convergenti con quelli derivanti dagli studi sulla
coorte di Porto Marghera e di conseguenza avrebbe dovuto non solo — come già detto — ampliare
l’ambito delle neoplasie e delle patologie non riproponibili, ma avrebbe dovuto tener conto altresì
delle sole esposizioni eziologicamente rilevanti dal punto di vista temporale, traendone tutte le
conseguenze sia sotto il profilo della riferibilità delle imputazioni agli imputati tutti tratti in
giudizio, sia sotto il profilo dell’addebitabilità per colpa degli eventi.
Infatti le condotte cui riferire causalmente gli eventi sono antecedenti al 1974 e, quindi, ad epoca
precedente alla conoscenza della cancerogenicità del cvm.
Inoltre non sussistendo la prova di un’idoneità lesiva di tale sostanza alle basse dosi successive,
immediatamente contenute nei limiti imposti dalle norme cautelari e poco dopo ridotte anche al di
sotto degli stessi (e quindi nell’ambito di un rischio consentito nell’attività di impresa), non si
ravvisano neppure condotte cui causalmente riferire e colpevolmente addebitare tali eventi.
Vero che il p.m. ha fatto risalire la data dei commessi reati al 1969, e cioè presumibilmente
all’epoca della prima segnalazione sulla cancerogenicità del cvm da parte del dott. Viola che aveva
condotto le prime sperimentazioni su animali come già riferito nella parte introduttiva. Ma ammesso
e non concesso che tale sperimentazione avesse quelle caratteristiche di adeguatezza metodologica e
di validazione che la comunità scientifica pretende per prestare, oltreché attenzione, anche consenso
ai suoi risultati, oltre tutto comunicati dallo stesso ricercatore come non estensibili all’uomo, il p.m.,
sotto il profilo causale, avrebbe comunque dovuto porsi il problema di individuare le condotte
temporalmente rilevanti cui attribuire gli eventi contestati e a tale accertamento avrebbe dovuto far
seguire, attenendosi al principio della personalità della responsabilità penale, l’individuazione di
quei soggetti che nel periodo eziologicamente rilevante avevano ricoperto posizioni di garanzia
nell’ambito delle società che gestivano il rischio di impresa.
Già l’imputazione aveva un vizio d’origine poiché mancavano «le coordinate spazio temporali»
che orientassero nell’individuazione delle condotte e dei soggetti cui fossero imputabili e tale
situazione si è protratta sino alla conclusione del processo nonostante che inizialmente, poiché tutti
gli eventi erano indistintamente riferiti a tutti gli imputati, il tribunale avesse imposto quanto meno
il rispetto del criterio d’imputazione temporale così da evitare, stante l’ampio arco cronologico di
trent’anni, di riferire a imputati che avevano assunto cariche societarie o ruoli dirigenziali in epoca
successiva, eventi già verificatisi o viceversa eventi verificatisi posteriormente a soggetti cui non
erano riferibili perché già cessati da ogni carica prima dell’assunzione e quindi dell’esposizione
delle parti offese.
L’accusa ha infatti stratificato nel tempo gli eventi lesivi secondo il mero criterio cronologico del
loro accadimento collegandoli agli imputati, avvinti da una cooperazione colposa, mediante
condotte indifferenziate e accomunate sostanzialmente dal rimprovero di non aver diminuito il
rischio derivante dalla produzione di sostanza cancerogena: individuando sì le norme cautelative
violate, ma non distinguendo quali tra queste violazioni andassero attribuite all’uno piuttosto che
all’altro imputato, nonostante le modificazioni impiantistiche e organizzative intervenute in
trent’anni nel Petrolchimico e il succedersi degli amministratori e dei dirigenti che, secondo
l’accusa, avevano assunto posizioni di garanzia.
E così sostituendo al criterio della responsabilità personale quello della responsabilità del gruppo
societario, le cui variazioni attraverso fusioni, incorporazioni, cessioni e trasferimenti sono state
ritenute irrilevanti («un gioco di scatole cinesi»), l’impostazione accusatoria ha portato ad un
appiattimento e ad un’indifferenziazione delle responsabilità individuali e a una cristallizzazione
delle situazioni individuate e descritte come quelle proprie degli anni antecedenti la scoperta della
cancerogenicità del cvm che per l’accusa sono rimaste immutate sino al 2000.
Ma nell’impostazione accusatoria non vi è solo un procedere senza distinzioni e neppure vi è solo
l’assenza di una prospettazione diacronica dei fatti: vi è qualcosa di più grave che scompone il
quadro accusatorio e dissocia i fatti dai confini temporali dell’accusa.
Il p.m. compie una vera e propria traslazione dei piani temporali perché rappresenta
nell’imputazione «un quadro del passato» che ci riporta a condizioni lavorative (e a conseguenti
addebiti di colpa) che sono quelle proprie degli anni cinquanta-sessanta e invece propone all’esame
dibattimentale tali situazioni come verificatesi nel successivo ampio arco temporale che va dal 1970
al 2000.
Se infatti è vero che gli eventi addebitati (tumori e patologie) sono riconducibili eziologicamente
alle elevate esposizioni degli anni cinquanta-sessanta anche per gli stessi consulenti dell’accusa e
non già a quelle degli anni settanta (quanto meno a quelle a far data dalla fine del 1974), che sono
state drasticamente ridotte per effetto degli interventi sulle procedure e sugli impianti, una volta
avuta conoscenza della cancerogenicità del cvm, ci si deve chiedere per quale ragione il p.m. abbia
contro l’evidenza trasferito quella realtà a un’epoca successiva.
Appare inverosimile che non sia bastata l’evidenza dei dati rilevati dai misuratori personali e dai
gascromatografi che hanno resistito a tutti i controlli effettuati dai consulenti della pubblica e
privata accusa per persuadere che la situazione era cambiata e non era rimasta mummificata ai primi
anni settanta.
Ancora più incredibile sembra che neppure siano stati sufficienti i dati offerti dai severi consulenti
dell’accusa Nano e Rabitti che nel reparto a maggior inquinamento ambientale (CV 6) avevano
calcolato un valore medio tra l’aprile 1974 e il febbraio 1975 compreso tra 14 e 29 ppm per
scendere ulteriormente a 5,27 ppm dal mese successivo sino a valori attorno a 1 ppm in epoca
successiva.
Questa sfasatura temporale ha percorso tutto il processo e ne ha determinato gli esiti: perché era
realistica la rappresentazione dei fatti se riferita al tempo passato e invece contraria al vero se
riferita agli anni successivi, tanto che il p.m. sulle responsabilità personali dei singoli imputati si è
trovato in grave imbarazzo nell’individuare gli specifici addebiti di colpa indicati in termini
indifferenziati e globali.
In tal modo, oltreché non selezionare, alla stregua delle risultanze epidemiologiche, le patologie
correlabili, neppure il p.m. ha adottato un criterio selettivo per individuare i soggetti cui
fondatamente addebitare gli eventi lesivi: si è scelta invece — come è stato reiteratamente affermato
dalle difese — la strategia «della massificazione degli eventi e delle condotte»: indubbiamente
«fatto» di maggior evidenza e impatto verso l’esterno, ma di nessun fondamento in «diritto».
Ritornando alle evidenze sia epidemiologiche che ambientali da cui risulta che in concreto era stato
eliminato il rischio cancerogeno (almeno sulla base dei dati di fatto e delle conoscenze oggi
esistenti), il p.m. avrebbe dovuto, innanzitutto, porsi il problema se poteva ritenersi raggiunta la
dimostrazione che la causa efficiente degli eventi di morte e di malattia per esposizione a cvm si era
verificata già prima del pur ampio arco temporale ricompreso nell’imputazione.
Se è vero infatti che il cvm è un cancerogeno «iniziante» la cui efficacia di induzione oncogena è in
rapporto alle dosi di esposizione e, più esattamente, alle dosi cumulative cui segue un lungo periodo
di latenza per tutti i tumori in considerazione, l’epoca eziologicamente rilevante andava ricercata
ripercorrendo a ritroso un corrispondente lasso temporale e collocata quindi negli anni cinquanta-
sessanta, cioè anteriormente al tempus commissi delicti contestato.
Va detto subito che il tribunale ha imboccato un’altra strada — che sarà più oltre oggetto di
approfondimento — e cioè quella che conduce all’assenza della prova allo stato delle conoscenze
scientifiche dell’idoneità del cvm a provocare il cancro del polmone, l’epatocarcinoma e la cirrosi,
riconoscendo solo la sua associazione causale con l’angiosarcoma, con tipiche epatopatie e con la
sindrome di Raynaud.
Ma anche tale impostazione merita attenzione e considerazione perché mette in tutta evidenza la
mancata considerazione da parte dell’accusa di risultanze incontrovertibili che avrebbero anch’esse
evitato l’introduzione nel processo di eventi riconducibili eziologicamente a un lontano passato
(ancorché cronologicamente ricadenti nel vasto arco temporale considerato dall’accusa) e avrebbe
indotto a riflettere sulle cautele che si potevano pretendere dall’«agente modello» di quell’epoca in
cui in tutto il mondo produttivo europeo e statunitense vi erano livelli espositivi elevati in egual
misura a quelli esistenti a Porto Marghera (e che hanno prodotto le stesse conseguenze sulla vita e
sulla salute dei lavoratori di quelle aree industriali, come si è potuto constatare esaminando gli studi
epidemiologici condotti in quelle coorti).
Basti considerare, quale testimonianza del grado di consapevolezza dei rischi e di espressione di
cultura precauzionale dell’epoca, che l’Osha — riconosciuto come l’ente più restrittivo nell’ambito
della protezione della salute — ha mantenuto un livello di esposizione ceiling di 500 ppm sino al
marzo 1974!
La realtà produttiva era altra da quella progressivamente realizzatasi dagli anni settanta in poi: i
rischi venivano gestiti secondo le poche e approssimative norme cautelari vigenti all’epoca dettate
dalle conoscenze scientifiche e tecnologiche di quel tempo, e soprattutto da scelte di politica
economica finalizzate all’industrializzazione e all’occupazione delle popolazioni che andavano
abbandonando le insufficienti risorse agricole e si inurbavano venendo inserite senza formazione e
informazione in ambiti produttivi usuranti e nocivi.
I processi attraverso cui i lavoratori dell’industria raggiungeranno consapevolezza dello
sfruttamento del loro lavoro e della nocività degli ambienti di lavoro con pregiudizio della loro
salute saranno lunghi e costellati da aspri e lunghi conflitti sindacali e sociali.
Le rivendicazioni sino alla fine degli anni sessanta sono soprattutto rivolte ad ottenere un giusto
salario e il rischio viene anch’esso monetizzato con la previsione di specifiche indennità; solo più
tardi, con il maturare della coscienza che la salute è il bene supremo che va tutelato in sé, con i
diversi rapporti di forza che la mobilitazione sindacale viene a imporre nelle fabbriche, con i
contratti successivi al 1970, si otterrà di poter controllare con le rappresentanze interne e con i
delegati la nocività per poterla almeno ridurre (il «rischio zero» era una parola d’ordine più che un
obiettivo concreto).
Questo è «il quadro del passato» cui si doveva fare riferimento per trarne tutte le conseguenze sotto
il profilo giuridico senza farsi prendere dalla tentazione di farlo riemergere per riproporlo come
attuale.
Non è compito del giudice fare processi alla storia della industrializzazione, ma semmai di
contestualizzare i fatti per trarne le debite conseguenze sotto il profilo giuridico.
La riprovazione morale o il giudizio politico non possono essere confusi con la responsabilità
penale e gli «anatemi contro i mercanti» sono solo suggestive imprecazioni estranee ad un processo.
Ma l’accusa ha obiettato, in diritto, che all’epoca erano vigenti nel nostro ordinamento i d.p.r.
547/55 e 303/56 — di cui si parlerà più diffusamente nella parte concernente la colpa — che
ricomprendevano norme che dovevano considerarsi cautelative rispetto ai rischi che hanno
determinato gli eventi.
Si può rispondere già in questa sede che allora si ignorava la pericolosità e la cancerogenicità sia
del gas (cvm) sia delle polveri (pvc) che si diffondevano nell’ambiente di lavoro e quindi la
rappresentazione e la prevedibilità degli eventi poi verificatisi, essendo il solo rischio noto alla metà
degli anni sessanta la sindrome di Raynaud (cfr., in tal senso, Boffetta, udienza 12 luglio 2000)
evento di tipo tutt’affatto diverso, patologia che determinava disfunzioni alla circolazione delle
mani e che veniva a colpire i lavoratori che per le loro mansioni venivano a diretto contatto con la
sostanza nella pulizia delle autoclavi o dei filtri o nell’insacco.
E davvero non appare condivisibile l’assunto accusatorio secondo cui quelle norme richiederebbero
al datore di lavoro, qualunque sia la nocività, prossima o remota del fattore inquinante, di mettere in
atto ogni strategia possibile per eliminarlo o neutralizzarlo, assumendosi diversamente la
responsabilità di tutte le conseguenze potenziali derivanti da quella violazione ancorché in quel
momento impreviste o imprevedibili.
Questa tesi, se vuole essere affermazione di un principio generale, estremizza e dilata sino
all’imputabilità oggettiva il concetto di responsabilità colposa, poiché non si fa carico neppure di
assumere come elemento essenziale non tanto la prevedibilità dell’evento tipico, ma neppure la
rappresentazione dell’evento generico di un grave danno alla vita o alla salute: non si può eludere il
problema della conoscenza o conoscibilità della nocività, e ancor più della cancerogenicità della
sostanza (e nel caso particolare del cvm) in un determinato momento storico sia in ambito
scientifico che in quello industriale secondo il modello del c.d. agente modello.
Tale tesi la si può condividere se applicata a quelle sostanze delle quali già si conoscono effetti
tossici cronici come l’amianto, la cui pericolosità per la salute era già stata normativamente prevista
sia dalla l. 455/43 sia dalle tabelle allegate al d.p.r. 1124/65, in quanto la sua esposizione
determinava il rischio di contrarre una malattia grave e irreversibile come l’asbestosi: in tal caso si
può convenire che già la prevedibilità di un tale grave danno all’integrità fisica con esito infausto
esigesse l’osservanza delle norme cautelari di riduzione della polverosità che, rispetto
all’esposizione all’amianto, venivano oltretutto ad assumere un carattere di specificità, essendo
comuni i rimedi per entrambe le patologie. Sicché il verificarsi del mesotelioma piuttosto che
dell’asbestosi, può correttamente ricomprendersi nell’evento pur dall’agente non rappresentatosi
tipicamente, ma prevedibile come conseguenza dannosa dell’inosservanza di norme cautelari
comuni.
In tal senso si esprime infatti la Suprema corte (11 maggio 1998, Calamandrei, Foro it., 1999, II,
236): «dipendendo entrambe le patologie dalla respirazione delle polveri d’amianto e sostanziandosi
le misure preventive nella riduzione o eliminazione della polverosità della lavorazione, non sussiste
la proclamata differenziazione dei rimedi, in quanto questi erano comuni a entrambe le malattie
mortali. Pertanto ai fini della configurabilità della colpa è sufficiente che fosse comunque ...
prevedibile che l’indiscriminata esposizione alla polvere d’amianto nella lavorazione della sostanza
comportava alti rischi di contrarre l’asbestosi, di cui il mesotelioma costituisce una complicanza
dipendente dalla medesima causa».
Evidenti sono le ragioni per cui non è accettabile un’applicazione di tale orientamento per
estrapolazione dall’amianto al cvm-pvc, non essendovi alcuna correlazione o progressione tra la
patologia nota (Raynaud) e la neoplasia (angiosarcoma) causata dal cvm.
Ancor meno è legittimo confondere il piano soggettivo con quello oggettivo deducendo
dall’inosservanza di quelle norme di cautela generica l’attribuibilità dell’evento lesivo «con alta
probabilità riconducibile proprio all’inalazione delle polveri o del gas», così ritenendo decisivo per
l’accertamento della causalità il solo fatto che la condotta omissiva abbia astrattamente aumentato il
rischio del verificarsi dell’evento.
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti escludono che nell’ambito dell’accertamento del nesso
causale possa farsi ricorso alla teoria dell’aumento del rischio, «non essendo possibili ibride
commistioni di elementi di carattere soggettivo» poiché dalla problematica oggettiva del nesso di
causalità «devono rimanere escluse tutte le questioni afferenti la prevedibilità che attengono
propriamente all’elemento psicologico» (Cass. 17 dicembre 1993, Ianieri, id., Rep. 1996, voce
Reato in genere, n. 28).
È allora necessario, per affrontare la problematica che ci si è posti, riportarci su un piano
strettamente ontologico.
Si tratta cioè di individuare quale sia stata nel 1974 la condotta antidoverosa e quale avrebbe
dovuto essere per contro la condotta corretta che, se posta in essere, avrebbe impedito il verificarsi
dell’evento, e cioè il comportamento alternativo idoneo ad evitare secondo le leggi scientifiche di
copertura anche di carattere probabilistico — ma in quei termini di alta probabilità che la frequenza
statistica garantisce e che solo sconta i limiti conoscitivi propri di ogni scienza — gli eventi
tumorali e patogeni che si sono venuti a verificare nel periodo eziologicamente rilevante.
Secondo l’ipotesi d’accusa i comportamenti antidoverosi sarebbero stati principalmente sia
l’omessa fermata degli impianti — o comunque un adeguato e tempestivo intervento sugli stessi per
ridurre l’esposizione nociva e cancerogena — sia l’omesso allontanamento dai reparti o dalle
lavorazioni a rischio dei lavoratori maggiormente esposti (in particolare autoclavisti e insaccatori).
Ammesso per pura ipotesi che tali condotte omissive si siano verificate pur in presenza della
conoscenza del rischio tossico e oncogeno, si tratta di verificare se avrebbe potuto il comportamento
alternativo che si esige evitare il verificarsi dei tumori epatici e polmonari in quei lavoratori che
erano stati esposti, come risulta dalle consulenze epidemiologiche e dalle schede personali prodotte
nel corso degli esami medico-legali, alle elevate concentrazioni degli anni cinquanta e sessanta.
I dati di conoscenza scientifica ci dicono: a) che il cvm è una sostanza che agisce secondo un
rapporto dose-risposta e che le esposizioni cumulative più elevate sia per quantità sia per durata
sono quelle maggiormente responsabili degli effetti oncogeni; b) che secondo il modello
carcinogenetico multistadio, il cvm sarebbe un cancerogeno iniziante e cioè inducente una
mutazione tendenzialmente irreversibile nei primi stadi del processo tumorale; c) che il periodo di
esposizione lavorativa e di latenza, anche sottratto il periodo di lag (che è il periodo intercorrente tra
la presumibile epoca dell’induzione a seguito di esposizione alla sostanza cancerogena e la
manifestazione del tumore, calcolato in circa quindici anni sulla base della letteratura esistente),
sarebbe rispettato per tutti i lavoratori che hanno contratto i tumori, così da poter ragionevolmente
ritenere che le esposizioni rilevanti a determinare i tumori siano quelle degli anni cinquanta-
sessanta [...].
Ne consegue che all’epoca in cui i comportamenti doverosi erano concretamente esigibili essi non
avrebbero potuto evitare gli eventi verificatisi o, se si vuole, più cautelativamente, sia per le
indeterminatezze dei modelli di cancerogenesi sia per le variabili concernenti il periodo di lag, non
sussiste una prova dimostrativa avente elevata probabilità che il comportamento alternativo avrebbe
impedito o ritardato il verificarsi dei tumori.
Il tribunale è consapevole di un opposto orientamento giurisprudenziale che si è formato in tema di
rapporto causale tra esposizione ad amianto e mesotelioma pleurico e tumore polmonare ove si
afferma che «tutte le condotte che nell’arco dell’intera vita lavorativa abbiano consentito
l’esposizione alle polveri di amianto sono in nesso di causalità con la morte verificatasi»: ma ancora
una volta non si possono non sottolineare le differenti peculiarità dell’amianto rispetto al cvm che
possono consentire tale conclusione per la prima sostanza ma non per la seconda.
Invero l’esposizione ad amianto, anche a concentrazioni minime, può essere idonea a «indurre» e a
«promuovere» (quindi a innescare e a far progredire anche a distanza di tempo) il processo
tumorale, tanto che la sua utilizzazione è stata vietata con l. 27 marzo 1992 n. 257.
Pertanto può trovare giustificazione sulla base di tali caratteristiche della sostanza oncogena
l’affermazione che sarebbero rilevanti e idonei anche interventi prossimi all’insorgenza del tumore
per impedire l’evoluzione della patologia tumorale o per allungare il periodo di latenza e quindi di
speranza di vita. Ma non è altrettanto giustificabile per il cvm che è oncogeno solo iniziatore e ha
idoneità lesiva solo ad elevate esposizioni non più sussistenti sin dal 1974, anno dal quale furono
ridotte le esposizioni a livelli per i quali manca la prova di una loro idoneità lesiva.
Una qualche perplessità è comunque doveroso esprimere rispetto a questi orientamenti che
affermano di affidarsi «al sapere degli esperti», perché appare difficile allo stato delle conoscenze
sulla oncogenesi individuare leggi di copertura dotate di scientificità su cui fondare quell’alta
probabilità cui tuttavia ci si richiama per imputare l’evento alla condotta omissiva antidoverosa.
Si ha l’impressione che, ancorché non esplicitamente dichiarato ma confuso nella valutazione
probabilistica, si insinui il criterio dell’aumento del rischio determinato dall’inosservanza delle
norme cautelari.
Il tribunale, come preannunciato, ha tuttavia intrapreso una diversa soluzione della problematica
attinente la causalità: tutti i dati di conoscenza introdotti nel presente processo, molteplici e
aggiornati, valutati complessivamente, non consentono di ritenere sussistente un’associazione
causale tra cvm-pvc e tumori diversi dall’angiosarcoma e patologie che non siano la sindrome di
Raynaud e l’acrosteolisi, nonché tipiche epatopatie interessanti l’endotelio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione IV penale; sentenza, 17-05-2006
Giudicante: CORTE DI CASSAZIONE; sezione IV penale; sentenza, 17-05-2006
Magistrati: Pres. Coco, Est. Brusco, P.M. Passacantando (concl. parz. diff.)
Parti e avvocati: ric. Proc. gen. App. Venezia e altri in c. Bartalini e altri.
Giudizio precedente: Annulla App. Venezia 15 dicembre 2004.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione IV penale; sentenza, 17-05-2006
Omissis. — b) I criteri di accertamento della causalità. Altre censure proposte nei ricorsi delle parti
civili riguardano invece i criteri utilizzati dalla corte di merito per l’accertamento del rapporto di
causalità tra esposizione e patologie verificatesi.
Trattandosi, in questo caso, di critiche che denunziano il vizio di violazione di legge si rende
necessario un preliminare esame dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul tema dei
criteri che il giudice deve utilizzare per l’accertamento del rapporto di causalità non solo per le
caratteristiche di complessità di questi temi ma anche perché, dopo la pronunzia della sentenza di
primo grado e prima di quella d’appello (che difatti la prende espressamente in considerazione), è
intervenuta una decisione sul tema delle sezioni unite di questa corte che rende necessario un
approfondimento del tema.
In generale può osservarsi che il concetto di causa delle azioni umane o degli eventi naturali
costituisce da lungo tempo oggetto della ricerca filosofica, scientifica e delle scienze sociali. Nel più
ristretto ambito delle discipline giuridiche il rapporto di causalità costituisce un criterio di
imputazione oggettiva di un evento alla condotta di un soggetto; solo se l’evento può essere ritenuto
ricollegabile alla sua condotta l’agente potrà essere tenuto a risponderne (concorrendo i criteri di
imputabilità soggettiva).
Il codice penale ha esplicitato questo concetto nella formula usata dall’art. 40, 1° comma, con la
previsione che l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, debba essere
«conseguenza» della sua azione od omissione. Con questa formulazione il codice, come è
tradizionalmente riconosciuto, ha inteso accogliere la c.d. teoria condizionalistica della causalità
(condicio sine qua non) o dell’equivalenza delle cause.
Tradizionalmente si afferma che all’accertamento dell’esistenza del rapporto di causalità si
perviene con un procedimento di eliminazione mentale: un’azione è causa di un evento se non può
essere mentalmente eliminata senza che l’evento venga meno o si verifichi con modalità diverse. La
condotta deve costituire quindi una condizione c.d. necessaria (contrapposta alle condizioni c.d.
sufficienti) per il verificarsi dell’evento.
Il procedimento di eliminazione mentale costituisce un metodo largamente approssimativo, come è
stato in più occasioni dimostrato, che non sempre consente di pervenire ad una ragionevole
soluzione del problema. In particolare la dottrina ha chiarito come il procedimento di eliminazione
mentale sia inutilizzabile nei casi di causalità alternativa ipotetica (si consideri il caso di distruzione
di un bene che sarebbe stato ugualmente distrutto per altra causa) o di causalità addizionale (si pensi
alla duplice, contemporanea, indipendente ed efficace azione omicida). Con il processo di
eliminazione mentale l’evento si verifica ugualmente in entrambi i casi ma apparirebbe singolare
escludere il nesso di condizionamento per una delle due condotte. E lo stesso deve dirsi nel caso di
concorso di cause sopravvenute.
Insomma il metodo dell’eliminazione mentale va utilizzato tenendo conto della necessità di non
pervenire alla disapplicazione su base interpretativa delle norme sul concorso di cause ponendo nel
nulla il principio, normativamente previsto, dell’equivalenza delle cause. Si deve quindi fare
riferimento alle condotte di tutti coloro che hanno contribuito all’esito finale e non alle singole
condotte in relazione alle quali valgono gli usuali criteri da utilizzare nell’accertamento del
concorso di cause.
Questo, a parere della corte, è il criterio da adottare in tutti i casi in cui la condotta di un soggetto si
inserisce in modo efficiente in un processo causale e questo vale anche nel caso di condotte di
natura diversa. I casi di più immediata evidenza sono riscontrabili nell’attività medica: se tre
medici, chiamati a consulto, forniscono tutti, colposamente, la stessa diagnosi errata che provoca la
morte del paziente per escludere il rapporto di causalità non basta affermare che, eliminando
mentalmente uno dei tre pareri (quale? se si affermasse un tal principio l’esclusione varrebbe per
tutti), la terapia non sarebbe mutata e il paziente sarebbe deceduto ugualmente perché le norme sul
concorso di cause impongono di considerare unitariamente i tre pareri e di compiere il giudizio di
eliminazione mentale considerandoli complessivamente.
Queste difficoltà si accentuano nel caso di causalità omissiva — cui si accenna perché alcuni dei
ricorrenti vi si riferiscono e anche nelle sentenze di merito in alcune parti vi si fa riferimento ma
erroneamente perché (come si è già accennato) agli imputati è stata contestata la violazione di un
divieto (non sottoporre i lavoratori ad esposizioni nocive) e non la violazione di un obbligo —
perché, nella causalità omissiva, il decorso degli avvenimenti non è, nella realtà fenomenica,
influenzato dall’azione (che non esiste) di un soggetto.
La causalità omissiva — che, proprio per queste caratteristiche, parte della dottrina qualifica come
«equivalente normativo della causalità» — si configura come una costruzione giuridica (art. 40, 2°
comma, c.p., che non a caso usa la locuzione «equivale», secondo l’equazione: non impedire
equivale a cagionare) che consente di ricostruire l’imputabilità oggettiva come violazione di un
obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell’evento (in violazione del c.d. obbligo di garanzia);
omissione che provoca l’evento di pericolo o di danno (reati omissivi impropri o commissivi
mediante omissione; contrapposti ai reati omissivi propri nei quali il reato si perfeziona con la mera
omissione della condotta dovuta).
La maggior complessità dei problemi in tema di causalità nei reati omissivi impropri non è
ricollegata tanto alla necessità, in questo tipo di reati, d’individuare (secondo i criteri ai quali si
accennerà più avanti) se l’evento sia conseguenza dell’omissione accertata (problema che si pone in
modo non dissimile nel caso di reati commissivi con riferimento all’azione compiuta), ne dalla
ricostruzione in via meramente ipotetica dell’efficacia dell’azione omessa (anche questo è problema
comune alla causalità attiva perché, anche in questi casi, il giudice deve ricostruire, in via di ipotesi,
l’effetto dell’eliminazione della condotta commissiva) ma dalla necessità ulteriore d’individuare la
condotta positiva che, se posta in essere, avrebbe evitato il prodursi dell’evento (si è detto che, nella
causalità omissiva, il procedimento logico è doppiamente ipotetico).
Ovvio essendo che se l’evento era destinato a prodursi ugualmente con tempi e modalità identici
(in base all’indicato processo di eliminazione mentale, inteso nel senso in precedenza indicato, che
più propriamente, nella causalità omissiva, dovrebbe essere chiamato di «aggiunta» mentale), anche
nel caso in cui l’agente avesse attivato tutti gli interventi richiestigli, le conseguenze dell’omissione
non potrebbero essere a lui addebitate.
La causalità omissiva, proprio per essere giustificata in base ad una ricostruzione logica e non in
base ad una concatenazione di fatti materiali esistenti nella realtà ed empiricamente verificabili,
costituisce una causalità costruita su ipotesi e non su certezze. Si tratta quindi di una causalità
ipotetica, normativa, fondata, come quella commissiva, su un giudizio controfattuale («contro i
fatti»: se l’intervento omesso fosse stato adottato si sarebbe evitato il prodursi dell’evento?) alla
quale si fa ricorso per ricostruire una sequenza che però, a differenza della causalità commissiva,
non potrà mai avere una verifica fenomenica che invece, nella causalità commissiva è spesso (non
sempre però) verificabile. In questo caso, si è detto, il rapporto si istituisce tra un’entità reale
(l’evento verificatosi) e un’entità immaginata (la condotta omessa) mentre nella causalità
commissiva il rapporto è tra due entità reali. Nell’enunciato ipotetico della causalità omissiva tanto
l’antecedente che il conseguente sono falsi (la condotta richiesta non è stata posta in essere; l’evento
si è verificato).
Si badi: la causalità omissiva non è di origine soltanto normativa. Per avere conferma di ciò basti
ricordare che in ordinamenti giuridici (per es. quello tedesco fino ad una modifica relativamente
recente), anche di origine non diversa dal nostro, è comunemente riconosciuta l’efficacia causale
dell’omissione anche in assenza di una norma che la preveda espressamente come il 2° comma
dell’art. 40 c.p. ricordato.
Secondo un orientamento, ormai largamente diffuso e condiviso, per compiere la ricostruzione del
fenomeno causale devono essere utilizzate (come nella causalità commissiva ma con l’ulteriore
ricordata necessità di verificare ipoteticamente l’efficacia salvifica della condotta omessa) le leggi
c.d. di copertura (espressione ermetica che starebbe a significare che la spiegazione di un evento
può aversi solo «coprendo» — meglio sarebbe dire «spiegando» — l’evento con una legge o, come
parimenti si dice, sussumendo l’evento sotto una legge). Leggi di copertura, di origine scientifica,
che possono avere un valore universale o un valore semplicemente statistico e la cui funzione è
quella di attribuire un valore generalizzante a sequenze di accadimenti altrimenti tra di loro
arbitrariamente collegate sulla base di presunzioni non fondate su leggi dotate di un pari grado di
credibilità.
Va ancora precisato che la riferita conclusione teorica sulla diversità della causalità omissiva
rispetto a quella commissiva, pur prevalente, è peraltro posta in discussione da una corrente
dottrinaria che invece motivatamente sostiene che, anche nella causalità omissiva, «l’effetto
condizionante è dunque reale: il tasso d’ipoteticità del sillogismo che così si imposta non è
maggiore né diverso da quello di un sillogismo relativo alla causalità attiva» (la dottrina che fa
proprio questo orientamento richiama gli studi che hanno inquadrato la condotta omissiva tra i
«processi statici» e, pur riconoscendo la natura reale del condizionamento, ritiene che nella
causalità omissiva la spiegazione dell’evento avvenga non con una «ricostruzione del passato»,
come nella causalità commissiva, ma con un giudizio «prognostico»).
Indipendentemente dalla soluzione di questi problemi teorici va segnalato che il pluridecennale
dibattito, giurisprudenziale e dottrinale, diretto ad individuare criteri soddisfacenti per ricollegare
l’evento all’omissione in termini di ragionevolezza non si è ancora concluso e, ancora di recente, ha
trovato nuovi sviluppi. L’interprete deve infatti constatare come, a seconda delle epoche, il
problema della causalità omissiva (ma anche di quella commissiva) si sia posto oscillando da
impostazioni teoriche (per es. quella dell’aumento del rischio) che tendevano a trasformare i reati
omissivi in questione in reati di mera condotta — con grave lesione dei principî di legalità e di
determinatezza per averli invece il legislatore indiscutibilmente configurati come reati di evento
(per es. i delitti di lesioni e omicidio) — ed altre che richiedevano invece l’impossibile prova della
certezza dell’esistenza del rapporto eziologico non raggiungibile in questa materia non solo per le
caratteristiche ipotetiche della causalità omissiva ma anche per la variabilità dei casi specifici, per la
normale coesistenza di concause e per la frequentissima non assolutezza delle leggi scientifiche
applicate.
La giurisprudenza di legittimità, formatasi prevalentemente (con riferimento non solo alla causalità
omissiva) sul tema della responsabilità professionale medica in tema di trattamenti terapeutici, ha
prevalentemente seguìto, fino alla fine degli anni novanta, una linea che può definirsi di tipo
«probabilistico» affermando — con varianti per lo più terminologiche — che, per ritenere esistente
il rapporto di causalità materiale, si dovesse accertare che l’intervento omesso, se tempestivamente
e correttamente eseguito, avrebbe avuto «serie ed apprezzabili probabilità di successo» (in realtà le
formulazioni usate sono le più diverse e quella indicata è la formula riassuntiva che meglio esprime
questa linea interpretativa).
Spesso questo giudizio di natura probabilistica si è espresso in termini percentuali con margini di
oscillazione, per la verità, eccessivamente ampi (verso il basso) secondo un percorso interpretativo
che si è spinto fino all’attribuzione di un evento a un soggetto sol perché, con la sua condotta, ha
eliminato o diminuito le chances di salvezza del bene individuale protetto. In queste ipotesi è palese
che l’orientamento c.d. «probabilistico» si risolve in quello dell’aumento del rischio e a queste
conseguenze non si sottraggono neppure i sostenitori di un’altra teoria, quella dell’imputazione
oggettiva dell’evento, sorta peraltro per restringere l’ambito di applicazione della teoria
condizionalistica.
Anche in questo campo l’impostazione probabilistica trova il suo fondamento (peraltro di natura
più pratica che teorica) sulle medesime difficoltà ricostruttive: la natura ipotetica della ricostruzione
a posteriori, le difficoltà d’individuazione del trattamento omesso che avrebbe potuto salvare il bene
o diminuire il rischio, la più frequente diversità delle condizioni soggettive e la compresenza di
concause rende ancor più difficoltosa la ricostruzione del fatto sotto il profilo della causalità. Ma
identico è il fondamento teorico-pratico che sta alla base della teoria probabilistica: la constatazione
dell’impossibilità, nella causalità omissiva impropria, d’individuare con certezza il fattore
condizionante omesso che, se compiuto, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento.
L’orientamento che possiamo definire «probabilistico» è stato sottoposto a vivace critica da parte di
alcune sentenze (v., in particolare, Cass. 28 settembre 2000, Baltrocchi, Foro it., 2001, II, 420, in
tema di responsabilità medica; più di recente, 25 settembre 2001, Covili e altri, id., 2002, II, 289,
sul tema dell’esposizione all’inalazione delle fibre di amianto) di questa medesima sezione che ha
capovolto l’impostazione tradizionale della giurisprudenza di legittimità fondata sul giudizio
probabilistico giungendo ad affermare che «in tanto il giudice può affermare che un’azione od
omissione sono state causa di un evento, in quanto possa effettuare il giudizio controfattuale
avvalendosi di una legge o proposizione scientifica che ‘enunci una connessione tra eventi in una
percentuale vicina a cento’».
I passaggi logici attraverso i quali questo orientamento è pervenuto alle conclusioni riportate
possono così riassumersi: premesse le acquisizioni in precedenza riferite sulla natura del giudizio
controfattuale da operarsi nel caso di reato omissivo improprio, al valore — universale o
semplicemente statistico — delle leggi di copertura, al dibattito dottrinale sulla diversa natura, o
meno, della causalità omissiva rispetto a quella commissiva le sentenze citate riaffermano che il
giudice non può non prendere atto dei migliori esiti della ricerca giuridico-scientifica ed in
particolare del fatto che tali orientamenti, pur divergendo sulla natura della causalità omissiva,
purtuttavia convergono sulla necessità che, per ritenere esistente il rapporto di causalità, a
conclusione del giudizio controfattuale, il giudice dovrà verificare che l’intervento omesso, se
effettuato, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento con una probabilità vicino alla certezza.
A conferma della tesi riportata le sentenze citate richiamano le conclusioni contenute nel progetto
di riforma del codice penale, elaborato dalla commissione ministeriale istituita con d.m. 1° ottobre
1998, che effettivamente, nella prima stesura, si esprimeva sul rapporto di causalità nei reati
omissivi in termini di certezza.
Più recentemente, per dirimere il contrasto insorto all’interno di questa medesima sezione, sono
intervenute le sezioni unite di questa corte che, con la sentenza 10 luglio 2002, Franzese (ibid., 601)
hanno posto un punto fermo su questa complessa problematica proponendone una condivisibile
ricostruzione.
In sintesi le sezioni unite, dopo aver ribadito la perdurante validità della teoria condizionalistica
(ritenuta temperata con il riferimento alla teoria della «causalità umana» quanto alle serie causali
sopravvenute, autonome e indipendenti, di cui all’art. 41, 2° comma, c.p.) e la necessità di
procedere al giudizio controfattuale al fine di verificare se, eliminata mentalmente la condotta presa
in considerazione, l’evento si sarebbe ugualmente verificato, hanno poi confermato la necessità che
la spiegazione causale dell’evento verificatosi hic et nunc provenga da attendibili risultati di
generalizzazioni del senso comune ovvero facendo ricorso generalizzante alla sussunzione del
singolo evento sotto leggi scientifiche che consenta di affermare che l’antecedente può essere
considerato condizione necessaria dell’evento se rientra tra quelle conseguenze che le indicate leggi
di «copertura» consentono di ritenere aver provocato l’evento.
Secondo le sezioni unite «il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide consente infatti di
ancorare il giudizio controfattuale, altrimenti insidiato da ampi margini di discrezionalità e di
indeterminatezza, a parametri oggettivi in grado di esprimere effettive potenzialità esplicative della
condizione necessaria, anche per i più complessi sviluppi causali dei fenomeni naturali, fisici,
chimici o biologici».
Passando poi a trattare più specificamente della causalità omissiva la sentenza citata, senza
addentrarsi nella soluzione del già accennato problema teorico della natura reale, o meramente
normativa, dell’effetto condizionante nei reati omissivi impropri, ha però richiamato,
condividendolo, l’orientamento che ritiene valido il «paradigma unitario di imputazione
dell’evento» con riferimento al «condizionale controfattuale» la cui formula deve rispondere al
quesito se «mentalmente eliminato il mancato compimento dell’azione doverosa e sostituito alla
componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso,
supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, hic et nunc verificatosi, sarebbe, o non, venuto
meno, mediante un enunciato esplicativo ‘coperto’ dal sapere scientifico del tempo».
Da queste premesse le sezioni unite sono giunte alla conclusione che, «superato l’orientamento che
si sostanzia in pratica nella ‘volatilizzazione’ del nesso eziologico», il contrasto giurisprudenziale
verta sui «criteri di determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione
causale»; non viene dunque in considerazione lo statuto condizionalistico e nomologico della
causalità ma la sua concreta «verificabilità processuale» e su tale problema le sezioni unite hanno
ritenuto di non condividere l’orientamento che, particolarmente sul tema dei trattamenti terapeutici,
fa riferimento, al fine di ritenere accertato il nesso di condizionamento, alle «serie e apprezzabili
probabilità di successo» del trattamento omesso in quanto, con questa formula, si esprimono
coefficienti indeterminati di probabilità con il rischio di violare i principî di legalità e tassatività
della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio.
Fatte queste premesse la sentenza in esame ha indicato una via che riconduce la soluzione del
problema all’accertamento processuale dell’esistenza del nesso di condizionamento alla stregua di
quei canoni di «certezza processuale», non dissimili da quelli utilizzati per l’accertamento degli altri
elementi costitutivi della fattispecie, che conduca, all’esito del ragionamento di tipo induttivo, ad un
giudizio di responsabilità caratterizzato da «alto grado di credibilità razionale». In quest’ottica,
secondo la sentenza citata, «non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del
condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano
un coefficiente probabilistico ‘prossimo ad 1’, cioè alla ‘certezza’, quanto all’efficacia impeditiva
della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento».
Con riferimento alla scienza medica, ma con argomentazioni di carattere generale utilizzabili anche
in altri settori, le sezioni unite, da questa considerazione, traggono la conclusione che la «certezza
processuale» può derivare anche dall’esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità c.d.
frequentista quando, corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza, nel
caso di specie, di altri fattori interagenti, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale
del rapporto di causalità. Per converso livelli elevati di probabilità statistica o addirittura schemi
interpretativi dedotti da leggi universali richiedono sempre la verifica concreta che conduca a
ritenere irrilevanti spiegazioni diverse. Con la conseguenza che non è «consentito dedurre
automaticamente — e proporzionalmente — dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla
legge la conferma dell’ipotesi sull’esistenza del rapporto di causalità».
È inadeguato, infatti, secondo la sentenza in esame, esprimere il grado di corroborazione
dell’explanandum mediante coefficienti numerici mentre appare corretto enunciarli in termini
qualitativi per cui le sezioni unite mostrano di condividere quell’orientamento della giurisprudenza
di legittimità che fa riferimento alla c.d. «probabilità logica» che, rispetto alla c.d. «probabilità
statistica», consente la verifica aggiuntiva dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica al
singolo evento.
Solo con l’utilizzazione di questi criteri può giungersi alla certezza processuale sull’esistenza del
rapporto di causalità in modo non dissimile dall’accertamento relativo a tutti gli altri elementi
costitutivi della fattispecie con criteri non dissimili «dalla sequenza del ragionamento inferenziale
dettato in tema di prova indiziaria dall’art. 192, 2° comma, c.p.p.» al fine di pervenire alla
conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che «esclusa l’interferenza di
decorsi alternativi, la condotta omissiva dell’imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati
ontologici, è stata condizione ‘necessaria’ dell’evento, attribuibile per ciò all’agente come fatto
proprio». Mentre l’insufficienza, la contradditorietà e l’incertezza del riscontro probatorio, e quindi
il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva, non possono che
condurre alla negazione dell’esistenza del nesso di condizionamento.
c) Esame delle censure delle parti civili sulla causalità. Il problema che si pone nel presente
processo è pertanto quello di verificare se i giudici di merito si siano attenuti ai principî enunciati
dalle sezioni unite nella sentenza indicata ed in particolare se abbiano fornito di adeguata
motivazione la loro valutazione sull’esclusione dell’efficienza causale delle condotte colpose
accertate escludendo di poterle ricollegare all’evento in termini di «alto grado di credibilità
razionale» nel quale si sostanzia la certezza processuale come affermato nella sentenza ricordata.
È opinione di questa corte che la sentenza della corte d’appello veneziana abbia rispettato, in
questa verifica, i principî enunciati dalle sezioni unite in precedenza sintetizzati. Le argomentazioni,
già ricordate, proposte dalle ricorrenti parti civili sono state ampiamente esaminate dalla corte di
merito che ha condiviso (non tanto le premesse teoriche quanto) le conclusioni dei primi giudici
sulla causalità e ha altresì ritenuto che le critiche formulate sulla causalità fossero infondate anche
in fatto.
Passando più specificamente all’esame delle censure che riguardano le patologie ricordate va infatti
rilevato che la corte di merito — per quanto riguarda i tumori polmonari — ha ritenuto che le
insanabili contraddizioni tra gli stessi consulenti e testimoni del pubblico ministero non
consentissero di ritenere che l’accusa avesse adempiuto all’onere probatorio su di lei incombente
anche sulla sola astratta idoneità della sostanza a cagionare le patologie in esame.
Va intanto escluso che la corte non abbia fornito risposta alle censure e ai temi sollevati dalle
appellanti parti civili perché l’esame della sentenza impugnata dimostra il contrario.
In particolare la corte ha evidenziato i dissensi riscontrati nelle ricostruzioni effettuate dai
consulenti tecnici delle parti (ma anche tra i consulenti tecnici del pubblico ministero) sulle diverse
ipotesi ricostruttive formulate in merito alle conclusioni Iarc dopo il 1987, sul collegamento tra
esposizione a cvm e tumore al polmone: mentre Berrino resta fermo sulle originarie conclusioni Iarc
Mastrangelo, Comba e Pirastu esprimono dubbi significativi sia sulla validità dello studio di coorte
— perché comprendente i soci di cooperative che lavoravano anche presso imprese diverse — sia
per l’esistenza di un dato epidemiologico (relazione inversa tra aumento della latenza e valore del
Smr per il tumore al polmone) che depone in senso contrario al collegamento eziologico.
Indubbiamente, nella prospettazione delle parti civili ricorrenti, il dato più significativo che emerge
è quello che si riferisce ai casi di tumore al polmone che ha colpito gli insaccatori per i quali
l’incidenza è nettamente superiore rispetto agli altri dipendenti. La corte ha però ritenuto che questo
scostamento non consentisse di pervenire ad un giudizio causale positivo perché lo studio di coorte
richiamato dai ricorrenti aveva analizzato congiuntamente i casi dei lavoratori dipendenti da
Montedison ed EniChem e quelli delle cooperative che prestavano la loro attività anche in aziende
diverse e ciò non consentiva un giudizio omogeneo; tanto più che, per gli insaccatori dipendenti da
Montedison ed EniChem, «non emergerebbe alcun eccesso».
È certamente vero, come sostengono le ricorrenti parti civili, che questa conclusione non appare
appagante ma il sindacato di legittimità è limitato alla coerenza logica della decisione che non può
certamente escludersi nel caso in esame. Trattasi, tra l’altro, di conclusione verosimilmente resa
necessaria da una carente impostazione dell’imputazione che non ha selezionato adeguatamente le
diverse situazioni riferibili ai settori di maggiore esposizione anche per i dipendenti delle
cooperative (per es. se si fosse accertato che questi dipendenti non prestavano attività in altri
ambienti in situazioni di rischio e non esistevano fattori di confondimento di diversa natura il dato
accertato avrebbe potuto assumere un diverso significato).
Per quanto riguarda invece gli epatocarcinomi diversi dagli angiosarcomi la corte ha ritenuto
infondato il motivo di appello fondato sugli studi Epa — secondo cui l’eccesso per queste forme
tumorali sarebbe confermata per gli esposti a cvm — sia per i criteri metodologici utilizzati nella
ricerca e ritenuti non adeguati; sia perché questi dati sarebbero smentiti dalle indagini
multicentriche in Europa (Ward 2000 e 2001) sia perché, infine, il documento Epa riconoscerebbe i
limiti della ricerca per la possibilità che angiosarcomi siano stati classificati come epatocarcinomi.
Anche in questo caso sono state rilevate diverse posizioni tra i consulenti dell’accusa e si è
sottolineato il maggior rischio di confondimento esistente per l’epatocarcinoma (rispetto
all’angiosarcoma) per la multifattorialità di questa forma tumorale.
In particolare sulle specifiche censure proposte dalle parti civili prossimi congiunti di Bonigolo
Gastone, deceduto per epatocarcinoma, si osserva che la diversa interpretazione che le ricorrenti
parti civili propongono delle conclusioni del consulente tecnico prof. Berrino valgono soltanto a
consentire di pervenire ad un giudizio di possibilità (o al più di probabilità ma non in elevato grado)
sulla riconducibilità della patologia contratta dal loro prossimo congiunto all’esposizione a cvm e
quindi non consentono di ritenere accertata, in termini di elevata credibilità razionale, l’esistenza
della causalità individuale. Mentre, per quanto riguarda la tipicità delle lesioni che caratterizzavano
la patologia di Bonigolo la corte, con valutazione incensurabile, l’ha esclusa.
Quanto alla cirrosi la corte di merito si è rifatta integralmente alle considerazioni svolte dal
tribunale, che dunque non vengono riportate nella sentenza, ritenendo che l’eccesso riscontrato nella
coorte di Porto Marghera non sia significativo dal punto di vista statistico per la presenza dei fattori
di confondimento (epatiti e abuso di alcool) e «per la scarsità di informazioni in ordine ad
un’associazione che là dove viene evidenziata, come nello studio Martines, si riporta solo alla
categoria dei soggetti con elevata esposizione (esposizione cumulativa maggiore di 1650 ppm)».
Nella categoria intermedia di esposizione i valori sono invece inferiori o uguali a uno; il che
dimostra che il rischio non cresce gradatamente.
In conclusione, secondo la sentenza impugnata, la contradditorietà di dati e l’inesistenza di un
riconoscimento condiviso se non generalizzato, da parte della comunità scientifica, della possibilità
di affermare la causalità generale tra l’esposizione a cvm e le patologie indicate non
consentirebbero di pervenire ad un giudizio che superi il criterio del ragionevole dubbio.
Queste conclusioni, seppure — lo si ripete — possano essere ritenute inappaganti in una tragica e
pluridecennale vicenda nella quale si sono inserite gravi conseguenze personali per i lavoratori del
petrolchimico, anche con esito infausto, appaiono coerenti con i principî stabiliti dalle sezioni unite
nella sentenza Franzese; ciò, in particolare, laddove si sottolinea che l’insufficienza, la
contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla reale
efficacia condizionante della condotta omissiva (ma analogo ragionamento può farsi per quella
commissiva), non possono che condurre a non ritenere provata l’esistenza del nesso di
condizionamento.
Basti pensare alle sottolineate divergenze tra le conclusioni delle agenzie internazionali; alle
contraddizioni all’interno degli studi effettuati dalla medesima agenzia (Iarc); alle differenti
conclusioni cui sono pervenuti, su alcuni temi relativi alla causalità, gli stessi consulenti tecnici del
pubblico ministero per avere conferma come le conclusioni della corte di merito non potessero
discostarsi da quelle assunte non essendosi raggiunta la soglia dell’inesistenza del ragionevole
dubbio ritenuta necessaria dalla giurisprudenza di legittimità anche prima dell’introduzione
legislativa ad opera della l. 46/06.
Non diverse sono le conclusioni sui motivi riguardanti le problematiche relative a: 1) lesività del
cvm a basse dosi; 2) efficacia promovente e non solo iniziante del cvm; 3) efficacia concausale per
l’azione sinergica del cloruro di vinile con altri riconosciuti fattori causali. Su questi punti la corte
di merito dichiara espressamente di condividere le ragioni indicate dalla sentenza di primo grado
che viene integralmente richiamata.
Sulla c.d. «bassa soglia» si ricorda, nella sentenza impugnata, anche il parere del consulente del
p.m. Martines e si sottolinea come tutti i casi rilevati riguardino esposizioni elevate e si siano
verificati tra gli addetti assunti in epoche più lontane. E la letteratura formatasi su questo problema
sembra ormai concordemente orientata nel senso dell’inesistenza della prova dell’efficienza causale
del cvm a basse soglie.
Parimenti, per quanto riguarda l’efficacia promovente del cvm, la corte sottolinea l’inesistenza di
una legge di copertura scientifica che confermi questa efficacia mentre l’efficacia iniziante è ormai
condivisa dalla comunità scientifica.
Sulla concausalità i giudici di secondo grado, pur facendo intendere di condividere la tesi del p.m.
appellante sull’erroneità dell’affermazione del tribunale secondo cui se non è provato che un fattore
sia da solo causa neppure può essere concausa — critica indubbiamente corretta perché
l’affermazione del tribunale ha come conseguenza quella di disconoscere l’efficienza concausale in
tutti i casi nei quali uno dei fattori causali non è da solo sufficiente a cagionare l’evento ma lo è se
associato ad altro fattore causale — hanno ritenuto che le prove acquisite non fossero sufficienti per
affermare l’efficacia sinergica di fumo, alcool o epatopatie diverse proprio perché difetta la prova
che, sulle patologie diverse dall’angiosarcoma (e dalle altre patologie riconducibili all’esposizione a
cvm), abbia effetto (anche non esclusivo) l’esposizione alla sostanza in questione.
E la corte sottolinea altresì come gli appellanti pretendano un’inammissibile inversione dell’onere
della prova richiedendo che venga fornita la prova che i casi di decessi per epatocarcinomi, cancro
al polmone, ecc. siano stati causati esclusivamente da alcool, fumo, epatiti.
Adeguatamente motivate ed esenti da illogicità devono quindi ritenersi le conclusioni della corte di
merito nella parte in cui è stata confermata, quanto all’esistenza del rapporto di causalità, la
valutazione dei primi giudici sul difetto di prova di una correlazione causale tra esposizione a cvm e
tumori diversi dall’angiosarcoma e a malattie diverse dalla sindrome di Raynaud ed acrosteolisi e
comunque, con il riferimento temporale al periodo successivo al 1974, per la mancanza di prova
dell’efficacia lesiva dell’esposizione a basse soglie; con la conseguenza dell’insussistenza dei reati
di omicidio colposo e lesioni colpose riferiti a queste diverse patologie.
Parimenti logicamente motivate devono ritenersi le conclusioni della sentenza impugnata, negative
sulla causalità, per quanto riguarda le epatopatie di tipo diverso nelle quali non sono state
riscontrate le classiche lesioni da cvm ovvero nelle quali sono stati accertati fattori di
confondimento quali l’abuso di sostanze alcooliche o epatiti B o C o l’esistenza di altre patologie
(obesità, diabete, steatoepatite non alcoolica, accumulo epatico di ferro, celiachia) che influiscono
sull’aumento degli enzimi epatici.
E altrettanto correttamente motivata appare la soluzione (che peraltro non risulta contestata nei
ricorsi del p.g. e delle parti civili), sulla richiesta del p.m. di ritenere che casi contestati come
epatocarcinomi o cirrosi vengano considerati come epatopatie conseguenti all’esposizione a cvm,
avendo la corte rilevato che ciò costituirebbe un’immutazione non consentita del fatto contestato
con la conseguenza che alcun obbligo di pronuncia incombeva sul tribunale di affrontare questo
aspetto. Ma la censura del p.m. sarebbe infondata anche in fatto, secondo la corte, perché i casi in
questione (due di cirrosi e due di epatocarcinoma) non presenterebbero le lesioni tipiche da cvm già
in precedenza indicate.
Infine esenti da alcuna illogicità sono gli altri casi, già oggetto dell’appello del p.m., sui quali ha
rilevato la corte, analizzando ciascuno di essi, che la riconducibilità all’esposizione a cvm è da
ritenere esclusa sia per l’esposizione a quantitativi la cui efficienza lesiva non è provata sia per la
manifestazione della malattia in tempi assai lontani rispetto all’esposizione significativa (non
essendo riconosciuta una latenza particolarmente lunga per queste malattie).
Dalle considerazioni svolte consegue il rigetto dei ricorsi delle parti civili riguardanti lesioni o
decessi per patologie diverse da quelle più volte ricordate per le quali è stata accertata l’esistenza
del nesso di condizionamento tra l’esposizione e la patologia contratta.
Alcune precisazioni vanno fatte per quanto riguarda il ricorso dei prossimi congiunti di Bertaggia
Giobatta proposto anche nei confronti del responsabile civile Montefibre alle cui dipendenze la
persona offesa aveva prestato la sua attività lavorativa. Il rigetto dei ricorsi perché non è
sufficientemente provata l’esistenza del rapporto di causalità tra le patologie contratte da Bertaggia
(cirrosi epatica e carcinoma polmonare) e la malattia e il decesso del medesimo rende superfluo
l’esame delle difese degli imputati che eccepiscono una mancata esplicita contestazione
dell’omicidio colposo. Gli aspetti che riguardano l’azione civile nei confronti del responsabile civile
soc. Montefibre saranno esaminati nella parte che riguarda l’esame dei motivi sulle statuizioni
civili. (Omissis)
c) L’esame dei motivi. La natura della colpa. Fatte queste premesse e passando all’esame dei
motivi di ricorso va intanto osservato che la vastità delle argomentazioni e l’approfondimento,
anche teorico, con cui sono stati trattati i temi della colpa nel presente processo da parte delle difese
degli imputati e del responsabile civile ricorrenti richiede una premessa di carattere generale.
La premessa teorica da cui occorre prendere le mosse sul tema della colpa è costituita dalla
constatazione dell’avvenuto superamento delle più risalenti teorie che fondavano la responsabilità
colposa su elementi psicologici.
Oggi è ormai pressoché generalmente accettata la costruzione teorica che afferma la natura
normativa della colpa non solo nel senso che il reato colposo deve essere dalla legge previsto come
tale (altro problema è se la previsione debba essere espressa o possa essere implicita) e che alla
fattispecie colposa corrisponde sempre una fattispecie dolosa ma soprattutto nel senso che il
fondamento della responsabilità è rinvenibile nella contrarietà della condotta a norme di
comportamento di cui sono espressione le regole cautelari dirette a prevenire determinati eventi e
nell’inosservanza del livello di diligenza oggettivamente dovuta ed esigibile.
Non più dunque «rimproverabilità» della condotta perché fondata su una volontà inosservante o su
una negligenza «interiore» ma solo perché in contrasto con regole che l’organizzazione sociale si è
data e senza che vengano in considerazione i processi psichici che hanno interessato l’agente
(evidente è la differenza con il dolo che richiede invece proprio un’indagine sui processi
psicologici, conoscitivi e volitivi, interiori).
Altrettanto superate devono ritenersi le teorie che individuano il fondamento della colpa nella mera
inosservanza di un dovere di diligenza (anche la condotta negligente può risultare corretta), nella
mancanza di attenzione (non è detto che la persona disattenta ponga in essere una condotta
scorretta; per converso l’attenzione non esclude una violazione della regola cautelare), nell’inerzia
psichica.
E analoghe considerazioni possono farsi per quelle teorie che riconducono la colpa all’errore che
trovano un’insuperabile obiezione a fronte della constatazione che molto spesso la colpa è
ravvisabile in condotte certamente non caratterizzate da errore colpevole (i casi di trascuratezza,
dimenticanza, ecc.).
È dunque logica la conclusione che la collocazione teorica della colpa oggi non possa esaurirsi
nell’ambito della colpevolezza ma attenga direttamente anche alla tipicità del reato: sia che si tratti
di colpa generica che di colpa specifica la responsabilità per colpa fa riferimento non ad un
indefinito processo psicologico interiore ma ad un sistema normativo esterno (i cui criteri di
formazione costituiscono una generalizzazione di quei criteri di prevedibilità ed evitabilità che sono
rilevanti anche sotto il profilo soggettivo) ed i cui contorni peraltro (soprattutto nella colpa
generica) spesso non sono esattamente definiti. Ciò non significa che spetti al giudice un’attività
d’integrazione giurisprudenziale delle fattispecie normative ma certamente quello d’individuare le
«regole sociali» non osservate la cui violazione fonda la colpa generica.
La natura normativa della colpa risulta ancora più evidente nelle fattispecie di reato (che
interessano in particolare il presente processo) denominate «casualmente orientate» (in particolare
omicidio e lesioni colpose) — caratterizzate dal fatto che il legislatore prende in considerazione
esclusivamente l’evento senza che venga descritta la condotta — nelle quali la tipicità è descritta
sostanzialmente dalle regole cautelari violate; la concretizzazione della fattispecie passa attraverso
l’individuazione dei doveri violati essendo impossibile, per il legislatore, descrivere tutte le
condotte ipotizzabili, con una conseguente accentuazione della normativizzazione delle fattispecie
(ancor più evidente nelle fattispecie omissive improprie) ed un ampliamento dei poteri del giudice
cui è attribuito il compito di delimitare le fattispecie in esame.
Anche le ricostruzioni che fondano la responsabilità colposa sull’origine normativa e sulla
significativa natura oggettiva della colpa non possono però omettere di considerare che è sempre
presente nella colpa una componente soggettiva — in particolare nell’elemento della prevedibilità
anche se riferita non all’agente concreto ma all’agente modello — né possono dimenticare che
esiste una forma di colpa (quella c.d. «cosciente») in cui è certamente presente e forse prevalente
l’aspetto psicologico.
d) La violazione delle regole cautelari in genere. L’agente modello. Dunque la natura normativa
della colpa si riferisce prevalentemente a questo riferimento esterno costituito dalla violazione delle
regole cautelari, che hanno sempre efficacia preventiva e natura strumentale — a differenza delle
norme penali che hanno invece natura prescrittiva e funzione repressiva — ma non è esclusiva del
reato colposo. Inutile soffermarsi, in questa sede, sulle varie distinzioni tra le varie regole cautelari
essendo sufficiente ricordare che, in base alla fonte (sociale o giuridica) si distingue tra colpa
generica e colpa specifica e che il fondamento delle regole cautelari può essere di natura scientifica
oppure soltanto riconducibile all’esperienza e che è più frequente (ma non è sempre così) che quelle
fondate su leggi scientifiche vengano normativizzate.
L’omogeneità tra le due forme di colpa è oggi generalmente riconosciuta ma non sempre la
distinzione è chiara perché vi sono casi in cui la norma giuridica è generica e rimanda a regole
sociali: l’esempio tipico è costituito dall’art. 140, 1° comma, cod. strada (che impone di comportarsi
in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione). Da ciò, come è stato affermato,
«consegue che quanto più è indeterminata la regola, tanto più la colpa specifica scolora in quella
generica». In materia di sicurezza sul lavoro una norma di questo genere è l’art. 2087 c.c.
A seconda che siano astrattamente idonee ad impedire il verificarsi dell’evento o soltanto a
diminuire la probabilità che si verifichi è stata di recente proposta la distinzione in regole cautelari
«proprie» e «improprie». La regola cautelare «propria» per eccellenza è naturalmente quella
dell’astensione dall’attività cui potrebbe conseguire il pericolo dell’evento.
In particolare, sul tema della sicurezza sul lavoro, è stato osservato che le regole cautelari dirette
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro sono prevalentemente «proprie» mentre in tema di
malattie professionali è normale che ci si trovi in presenza di regole «improprie» anche se, in
qualche caso, la pericolosità dell’esposizione ha portato all’inibizione dell’esercizio dell’attività
(per es. nel campo dell’amianto) con la conseguente trasformazione di una regola «impropria» in
una di natura «propria».
Ma quale deve essere il criterio per valutare se l’agente, nel caso di colpa generica, si sia attenuto
alle richieste regole di diligenza, prudenza e perizia e quale sia, nel caso di colpa specifica, il livello
di rispetto della regola cautelare (nei casi in cui esistano diversi livelli di osservanza della regola) e
se l’agente si sia mantenuto nei limiti richiesti (ovviamente se la regola cautelare impone
l’astensione questa indagine è superflua).
La giurisprudenza e la dottrina dominanti si rifanno a criteri che rifiutano i livelli di diligenza, ecc.
esigibili dal concreto soggetto agente o dall’uomo più esperto o dall’uomo normale e si rifanno
invece a quello dell’agente modello (homo eiusdem professionis et condicionis) sul presupposto che
se un soggetto intraprende un’attività, tanto più se pericolosa, ha l’obbligo di acquisire le
conoscenze necessarie per svolgerla senza porre in pericolo (o in modo da limitare il pericolo nei
limiti del possibile nel caso di attività consentite) i beni dei terzi.
L’agente modello va di volta in volta individuato in relazione alle singole attività svolte. Si è
affermato in dottrina che «lo standard della diligenza, della perizia e della prudenza dovute sarà
quella del modello di agente che ‘svolga’ la stessa professione, lo stesso mestiere, lo stesso ufficio,
la stessa attività, insomma dell’agente reale, nelle medesime circostanze concrete in cui opera
quest’ultimo».
Il parametro di riferimento non è quindi ciò che usualmente viene fatto ma ciò che dovrebbe essere
fatto; non possono infatti essere convalidati usi scorretti e pericolosi e questi principî sono ormai
patrimonio comune anche nella dottrina e giurisprudenza straniere. In questa valutazione, quando
vengano in discussione beni della persona (vita e salute), non va tenuto conto del costo economico
necessario per il rispetto delle regole cautelari o addirittura per la rinuncia all’attività.
Deve ancora osservarsi che una pluralità di agenti modello può esistere anche all’interno della
medesima attività (per es. quella medico-chirurgica) o del medesimo circolo e con una
differenziazione tra le categorie di agenti modello.
Inoltre — nel caso in cui l’agente sia in possesso di conoscenze, competenze e capacità superiori a
quelle dell’agente modello — il parametro cui rifarsi, sia per la riconoscibilità del rischio che per le
modalità di intervento, sarà quello superiore essendo, questa condotta, esigibile dall’agente. Perché
l’evento possa essere attribuito all’agente non è infatti sufficiente che il medesimo si sia reso
responsabile della violazione della regola di condotta e che l’evento fosse prevedibile come
conseguenza di questa inosservanza ma è necessario che la condotta alternativa lecita fosse da lui
esigibile; solo in questo caso è soggettivamente attribuibile all’agente il verificarsi dell’evento.
e) Le censure riguardanti la violazione delle regole cautelari nel presente processo. Tutti i ricorrenti
hanno dedotto la violazione dell’art. 2087 c.c. ma deve preliminarmente precisarsi che questa
norma, pur formando oggetto della contestazione, e pur essendo richiamata nella motivazione della
corte d’appello, non è posta a fondamento della valutazione sull’esistenza della colpa perché non si
riferisce ad un ambito di applicazione non disciplinato da norme cautelari specifiche ma si
sovrappone ad esse.
Va infatti rilevato che, indipendentemente dall’individuazione dell’ambito di applicazione dell’art.
2087 (questione non ancora risolta in modo preciso da dottrina e giurisprudenza) non è dubbio che
il problema della violazione di regole cautelari che fanno riferimento alla norma civilistica non si
ponga quando la violazione contestata non si riferisca ad un settore non disciplinato — per esempio
in relazione all’ipotizzato obbligo di adozione di cautele ulteriori quando quelle normativamente
previste si appalesino insufficienti — ma coincida con l’ambito di applicazione della regola
cautelare specifica.
In realtà la violazione ipotizzata esaustivamente (nel senso che esaurisce l’ambito della condotta
colposa ipotizzata) dalla corte di merito è quella che si riferisce alla violazione degli art. 20 e 21
d.p.r. 19 marzo 1956 n. 303 (norme generali sull’igiene del lavoro), norme cautelari di natura
«impropria» che impongono al datore di lavoro, nel caso di ambienti di lavoro in cui siano presenti
prodotti nocivi o polveri, di impedirne o «ridurne per quanto è possibile» lo sviluppo e la diffusione.
Né ci troviamo in presenza di un’ipotesi in cui, nel caso concreto, la regola non sia idonea —
perché imperfetta o imprecisa o perché superata dall’evoluzione tecnologica o per altre ragioni —
ad escludere il pericolo di un evento dannoso per cui potrebbe ritenersi che l’agente fosse tenuto (in
base all’art. 2087) ad adottare le ulteriori regole cautelari.
Puntuali sono invece le censure degli imputati e del responsabile civile che si riferiscono alla
violazione degli art. 20 e 21 d.p.r. 19 marzo 1956 n. 303 il cui contenuto è stato già riassunto.
Puntuali ma infondate.
Anzitutto è da ritenere palesemente infondata la tesi (peraltro problematicamente prospettata ma
comunque sostenuta nella più parte dei ricorsi) secondo cui le norme indicate si riferirebbero alle
polveri moleste o fastidiose.
Basti pensare che l’art. 20 parla di gas o vapori «tossici» (non molesti o fastidiosi) e il cvm, in
quanto derivato degli idrocarburi alifatici, è inserito nella tabella allegata al citato d.p.r. n. 303 (n.
38) riferita (art. 33 d.p.r.) alle lavorazioni industriali che espongono all’azione di «sostanze tossiche
o infettanti o che risultano comunque nocive».
Quindi si tratta di una sostanza la cui natura tossica o nociva è riconosciuta dalla legge! Del resto
che senso avrebbe la previsione dell’art. 33 medesimo d.p.r. che prevede visite mediche iniziali e
periodiche per coloro che sono soggetti all’esposizione se la normativa ricordata fosse diretta solo
ad eliminare molestie e fastidi?
È vero che l’art. 21 (che si riferisce alla difesa contro le polveri) neppure fa riferimento alla natura
tossica delle polveri ma ciò non significa certo che non riguardi queste sostanze. In questo caso la
tutela è invece maggiormente estesa perché l’obbligo di ridurre l’esposizione «per quanto è
possibile» è imposto indipendentemente dalla natura tossica o nociva della sostanza (qualità che
semmai rafforzano l’obbligo di adozione delle misure di prevenzione).
Gli aspetti relativi alla prevedibilità e alla concretizzazione del rischio conseguente alla violazione
degli art. 20 e 21 indicati saranno trattati più avanti. Vanno invece in questa sede esaminate le
censure (riguardanti sia la violazione di legge che il vizio di motivazione) che si riferiscono ad
un’asserita indeterminatezza della fattispecie contestata e, conseguentemente, dell’obbligo imposto
all’agente nel senso che i giudici di appello non sarebbero riusciti ad individuare il comportamento
alternativo lecito idoneo ad evitare il verificarsi dell’evento.
Queste critiche riprendono alcune affermazioni contenute nella sentenza di primo grado laddove,
richiamando l’espressione «per quanto è possibile», contenuta nei ricordati art. 20 e 21, si afferma
che in tali situazioni «la colpa non può essere individuata nella mera violazione della regola, la
quale per l’appunto non descrive la condotta prescritta; del resto il richiamo al concetto di
‘possibilità’ consentirebbe un’imputazione obiettiva dell’evento che renderebbe del tutto superflua
ogni indagine sulla colpa».
Se si è ben compreso l’argomentare riportato il tribunale dubita della tipicità — o della
determinatezza — della norma nel senso che ritiene non descritta sufficientemente la condotta
richiesta ma va osservato che, se così fosse, la conseguenza non sarebbe certo la disapplicazione
della norma ponendosi invece un problema di legittimità costituzionale della medesima. In ogni
caso questa conclusione non è condivisibile.
Va intanto osservato che in tema di prevenzione del rischio d’infortuni o di malattie professionali è
frequente la scelta del legislatore, nel caso di attività pericolose, di imporre determinate cautele
idonee a ridurre il rischio facendo riferimento a criteri generici che possono di volta in volta essere
specificati con il richiamo alle cautele che la scienza, l’esperienza e l’evoluzione tecnologica
dell’epoca sono in grado di suggerire. Nelle attività pericolose consentite (e questo vale anche per le
attività non di tipo lavorativo) l’agente deve attivare le misure preventive che le conoscenze del
momento consentono di ritenere le più idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.
La tipicità della norma incriminatrice e la determinatezza della fattispecie sono dunque garantite da
questo criterio: la formula «per quanto è possibile» utilizzata dagli art. 20 e 21 significa che l’agente
deve fare riferimento alle misure idonee in base alla miglior scienza ed esperienza, conosciute
all’epoca della condotta, per ridurre il più possibile le esposizioni; e ciò indipendentemente dal loro
costo.
È infatti ovvio che il legislatore non poteva che prevedere una fattispecie di tipo aperto che tenesse
conto dell’evoluzione delle conoscenze e soprattutto dell’evoluzione tecnologica. Se una sostanza è
tossica — e purtuttavia ne è consentita la manipolazione — l’agente dovrà fare riferimento, nel
momento in cui opera, ai mezzi di prevenzione esistenti e se ne esistono di idonei ad eliminare
l’esposizione dovrà eliminarla; diversamente dovrà ridurla nei limiti in cui lo consentono i mezzi
conosciuti che siano disponibili in quel momento. L’obbligo di eliminare l’esposizione sorgerà,
eventualmente, quando, successivamente, l’evoluzione tecnologica avrà consentito di creare mezzi
idonei ad eliminarla.
Si può affermare che una simile norma così interpretata difetti di tipicità o determinatezza? Se così
fosse la gran parte dell’apparato normativo precauzionale verrebbe posto nel nulla. Ma una tesi così
estrema varrebbe ad escludere la tipicità di tutte quelle ipotesi nelle quali un elemento del reato non
è compiutamente descritto dalla norma incriminatrice ma con il richiamo ad un sistema esterno.
Né può porsi, nel caso in esame, il problema, che alcuni studiosi prospettano, della c.d. «misura
soggettiva della colpa» (che fa riferimento alle capacità soggettive dell’agente) atteso che, nel
nostro caso, si parla degli obblighi di prevenzione di una delle maggiori imprese a livello mondiale
del settore petrolchimico.
Le censure che denunziano invece il vizio di motivazione sulla circostanza che le misure adottate
dal 1970 fino al 1974 sarebbero state già adeguate ai criteri standard di sicurezza dell’epoca sono da
ritenere inammissibili e comunque infondate avendo, i giudici di merito (di primo e di secondo
grado) incensurabilmente accertato che solo dal 1974 in avanti la Montedison ebbe ad attuare le
misure di prevenzione idonee ad evitare il verificarsi degli eventi dannosi. Efficacia confermata
dalla circostanza che alcun lavoratore esposto, che abbia iniziato a lavorare nei settori a rischio dal
1974 in avanti, ebbe a contrarre l’angiosarcoma epatico.
In particolare la sentenza impugnata individua queste misure nell’abbattimento dei livelli di
esposizione, nella collocazione degli strumenti prevenzionali, nell’investimento in nuove
tecnologie, nell’intensificazione della sorveglianza sanitaria.
La sentenza, nell’esaminare la fattispecie di reato di cui all’art. 437 c.p., individua tra le misure
prevenzionali omesse — richiamandosi a quanto già accertato dal tribunale — la mancata fornitura
delle maschere ai lavoratori che operavano in situazioni di rischio (per es. all’interno delle
autoclavi), l’omessa collocazione di parti di impianto (valvole, rubinetti, tenute) aventi anche
finalità prevenzionale perché idonee ad impedire dispersioni di gas nell’ambiente, l’omessa
collocazione di un impianto di monitoraggio sulla concentrazione di gas nell’ambiente e l’omessa
collocazione di impianti di aspirazione (tra l’altro l’aspirazione dei gas è prevista dal 2° comma
dell’art. 20 d.p.r. n. 303).
Come è agevole verificare si tratta di accertamenti in fatto, concordemente compiuti dai giudici di
merito con valutazione incensurabile nel giudizio di legittimità in quanto esenti da alcuna illogicità.
E del tutto apodittica e indimostrata (e comunque non verificabile in questa sede) è l’affermazione,
contenuta in alcuni ricorsi, ma smentita da entrambe le sentenze di merito, secondo cui i mezzi di
protezione indicati erano già disponibili alla fine degli anni sessanta.
Ad ulteriore conferma di questi accertamenti possono essere richiamate le considerazioni svolte
nella sentenza di primo grado che, pur dando atto di una riduzione dei livelli di concentrazione del
cvm rispetto agli anni precedenti (nei quali erano stati raggiunti livelli pari a 40.000 ppm) riferisce
di livelli che rappresentano, secondo il tribunale, «valori massimi sicuramente elevati».
Il tribunale indica valori di concentrazione particolarmente significativi (non si tratta di una
valutazione del giudice di legittimità ma conforme ai parametri utilizzati dai giudici di merito).
Basti pensare che, relativamente all’ultimo periodo cui si riferisce il comportamento ritenuto
inosservante vengono riportati valori, relativi a singole zone e singoli momenti del processo
produttivo, pari a 1580 ppm nell’aprile 1973 nella sala autoclavi al momento dell’apertura del
boccaporto; nella zona dei serbatoi schiuma tre rilevazioni effettuate tra il 15 novembre e il 21
dicembre 1973 evidenziano concentrazioni di 4000, 3650 e 1765 ppm; ancora: nel luglio-settembre
1973 venivano rilevati, presso il posto di operatore autoclavi, valori di concentrazione medi pari a
2788 ppm con punte di 8300 ppm; e l’8 luglio 1974, durante il lavaggio dell’autoclave, punte di
2000 ppm. Addirittura nel dicembre 1974 all’interno del reparto CV24 fu evidenziata una punta di
5366 ppm.
Né questo complesso accertamento — sul quale, lo si ribadisce, i giudici di primo e di secondo
grado si sono trovati in sintonia — è incrinato dalla documentazione indicata nei motivi nuovi
proposti ai sensi della l. 46/06 (e anche in alcuni dei ricorsi originari) che verranno più avanti
esaminati e per i quali si può fin d’ora anticipare che si tratta di motivi privi di alcun carattere di
decisività e che comunque richiederebbero una complessiva rivalutazione di tutto il compendio
probatorio inammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo le ricordate innovazioni legislative,
per quanto già detto in precedenza.
f) La prevedibilità dell’evento. In generale. È da premettere che la prevedibilità ha anche un
risvolto oggettivo che attiene alla causalità: secondo la teoria della causalità umana, le cause
sopravvenute sono infatti idonee ad escludere il rapporto di causalità (art. 41, 2° comma, c.p.) solo
quando abbiano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità. Naturalmente, sotto questo profilo,
trattandosi dell’elemento oggettivo, l’accertamento deve essere condotto con criteri ex post (e
tenendo anche conto delle conoscenze non disponibili all’epoca della condotta).
L’esistenza della prevedibilità sotto il profilo che attiene all’elemento soggettivo va invece
accertata con criteri ex ante e trova il suo fondamento sul rilievo che non possa essere addebitato
all’agente di non aver previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe
dovuto avere, non poteva prevedere.
Sotto quest’ultimo profilo la prevedibilità dell’evento è certamente riferibile all’elemento
soggettivo, la colpa, perché attiene al processo cognitivo e decisionale dell’agente (sia pure nel
senso già precisato di natura non psicologica e con il riferimento all’agente modello) che è tenuto a
prendere in considerazione le conseguenze della sua condotta. Naturalmente, da questo angolo
visuale, l’agente sarà ritenuto in colpa solo se non ha tenuto conto delle conseguenze della sua
condotta, che conosceva o era tenuto a conoscere, in base alla sua professione e alla sua condizione.
Il fondamento della prevedibilità sotto il profilo soggettivo risiede nella necessità di evitare forme
di responsabilità oggettiva. Se il risultato della condotta non poteva neppure essere immaginato
dall’agente queste conseguenze non possono essergli addebitate sotto il profilo della colpevolezza.
Perché l’agente possa essere ritenuto colpevole non è sufficiente che abbia agito in violazione di
una regola cautelare ma è necessario che non abbia previsto che quella violazione avrebbe avuto
come conseguenza il verificarsi dell’evento. Se dunque quella conseguenza dell’azione non è stata
prevista perché non era prevedibile non v’è responsabilità per colpa.
Ma qual è il parametro cui occorre rifarsi per valutare la prevedibilità (o, come taluni si esprimono
in dottrina, il dovere di riconoscere)? È evidente che se si adottasse un criterio che fa riferimento
all’agente concreto si ricadrebbe negli orientamenti che riferiscono la colpa all’elemento
psicologico; e infatti dottrina e giurisprudenza seguono comunemente il criterio della prevedibilità
da parte dell’homo eiusdem professionis et condicionis — il c.d. «agente modello» — non
diversamente da quanto avviene per l’individuazione dei criteri per accertare il rispetto delle regole
cautelari.
Va però sottolineato che questo criterio (e, a maggior ragione, quelli dell’uomo normale, dell’uomo
avveduto, ecc.) non è ritenuto accettabile da autorevole dottrina che invece fa riferimento alla
«miglior scienza ed esperienza» come unico idoneo criterio: a individuare i comportamenti fonte di
pericolo e le condotte idonee ad evitarle; a potenziare la funzione pedagogica delle regole cautelari;
ad evitare di privilegiare i soggetti dotati di conoscenze superiori; a garantire maggiormente
esigenze di tassatività; a ridurre il relativismo della condotta.
Essendo indiscusso che la valutazione relativa alla prevedibilità, sotto il profilo soggettivo, va fatta
con criterio ex ante rimane ancora da decidere quale sia il momento cui occorre fare riferimento per
poter pretendere che l’agente riconoscesse i rischi della sua attività e i potenziali sviluppi lesivi.
Naturalmente non vanno presi in considerazione i successivi progressi della conoscenza mentre si
deve tener conto di eventuali conoscenze superiori dell’agente. Per questo fine di previsione è stato
affermato che «le conoscenze rilevanti non sono quelle diffuse solo nella cerchia degli specialisti, e
tanto meno le conoscenze avanzate di taluni centri di ricerca, bensì solo le conoscenze che
costituiscono un patrimonio diffuso a partire da una certa data».
Questo criterio può essere ritenuto accettabile purché si precisi che l’agente ha un obbligo di
informazione in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche anche se non ancora patrimonio
comune e anche se non applicate nel circolo di riferimento a meno che si tratti di studi isolati ancora
privi di conferma. È quindi condivisibile la successiva precisazione che «il momento a partire dal
quale le conoscenze specialistiche diventano conoscenze diffuse, e la cui trascuranza fonda la colpa,
va desunta dalle informazioni che l’agente ‘modello’ è in condizione di acquisire in ogni
momento».
Il giudizio di prevedibilità vale a specificare il contenuto dell’obbligo di diligenza altrimenti
astratto. Si è detto che «basandosi sugli esiti del giudizio di prevedibilità, il contenuto del dovere di
diligenza otterrebbe una certa specificazione, con la conseguenza di poter fornire delle note di
concretezza a quell’obbligo del neminem laedere altrimenti del tutto inafferrabile nella sua
astrattezza». Solo se il pericolo del verificarsi di un evento dannoso è prevedibile o riconoscibile
l’agente può essere obbligato a rispettare quelle specifiche regole cautelari idonee ad evitare il
prodursi del fatto dannoso.
Alcuni autori preferiscono parlare, piuttosto che di prevedibilità, di «rappresentabilità» precisando
che «questo termine possiede una maggiore comprensività del primo, potendosi riferire non soltanto
ad accadimenti futuri, ma anche a quelli concomitanti o addirittura antecedenti all’azione del
soggetto». Altri ancora parlano di «riconoscibilità» così esprimendosi: «la tipicità colposa risulta
configurabile allorché la situazione concreta sia stata caratterizzata dalla presenza di elementi,
giuridici e fattuali ... che, in correlazione con le stesse leggi scientifiche e conoscenze empiriche
utilizzate dal giudice ai fini dell’imputazione dell’evento, avrebbero permesso di rappresentarsi la
concreta realizzazione del fatto previsto dalla legge come reato colposo»).
La dottrina è quindi da tempo sostanzialmente uniforme nel ritenere che il giudizio sulla colpa non
possa prescindere da una valutazione sulla prevedibilità che, non essendo riferita all’agente
concreto, ha caratteristiche di oggettività pur essendo riferita alla colpevolezza.
g) L’evoluzione della giurisprudenza in tema di prevedibilità. In giurisprudenza queste conclusioni
sono di più recente acquisizione. Un risalente orientamento, anche di legittimità, escludeva infatti
che la prevedibilità costituisse elemento necessario per configurare la responsabilità per colpa e
affermava che nella colpa (in particolare quella specifica) la previsione dell’evento viene già
compiuta con la formazione della regola cautelare per cui, nel concreto accertamento dell’esistenza
della colpa, il giudice deve soltanto accertare la violazione della regola cautelare e non anche la
prevedibilità dell’evento (v., in questo senso, Cass. 15 ottobre 1997, Pretto, id., Rep. 1998, voce
Reato in genere, n. 29; 25 settembre 1990, Severino, id., Rep. 1991, voce cit., n. 49; 1° dicembre
1989, Iannuzzi, ibid., n. 46; 18 febbraio 1982, Manassero, id., Rep. 1983, voce cit., n. 46). In alcune
decisioni si precisava che il requisito della prevedibilità riguardava i casi di colpa generica ma non
era richiesto per la colpa specifica (v. Cass. 27 febbraio 1987, Brizzi, id., Rep. 1988, voce Omicidio
e lesioni personali colpose, n. 80; 16 ottobre 1984, Serione, id., Rep. 1986, voce cit., n. 11).
È evidente come questa giurisprudenza fosse elusiva del problema della prevedibilità. È infatti vero
che quando viene dettata una regola cautelare si formalizza un giudizio di prevedibilità di un evento
dannoso; ma il problema da risolvere è proprio quello di individuare il perimetro entro il quale
individuare gli eventi presi in considerazione dalla norma e, in particolare, se fosse in astratto
prevedibile non un evento dannoso di qualsiasi genere ma l’evento in concreto verificatosi (ed
inoltre se questo evento fosse ricompreso tra quelli che, nella formazione della regola cautelare, si
volevano evitare; ma questo tema sarà più avanti esaminato).
Non può quindi esservi dubbio che, anche per la colpa specifica, si ponga il problema di accertare
se l’evento verificatosi fosse in concreto prevedibile. E anche la giurisprudenza della Corte di
cassazione si è adeguata a questi principî (cons. Cass. 22 novembre 1996, Marconi, id., Rep. 1997,
voce Reato in genere, n. 32; 28 aprile 1994, Archilei, id., Rep. 1995, voce Omicidio e lesioni
personali colpose, n. 39; 1° luglio 1992, Boano, id., Rep. 1993, voce Reato in genere, n. 32. Nella
giurisprudenza di merito, v., tra le altre, Trib. Foggia 10 maggio 2000, id., Rep. 2001, voce
Omicidio e lesioni personali colpose, n. 39).
Va semmai verificato, anche alla luce di una recente pronunzia di questa sezione (sentenza 20 aprile
2005, Stasi e Bucci, id., Rep. 2006, voce Lavoro (rapporto), n. 1328) se la norma cautelare violata
abbia contenuto «rigido» o «elastico», cioè se il comportamento richiesto sia dalla medesima
delineato con assoluta precisione ovvero se abbisogni, per poter essere applicata, di un legame più o
meno profondo con le circostanze del caso concreto. Nel primo caso (norma «rigida»), secondo
questa pronunzia e secondo la dottrina che propone questa soluzione, il giudizio di prevedibilità ed
evitabilità è già intrinseco nella norma e l’agente non ha altra alternativa che quella di adeguarvisi.
È da osservare peraltro, per quanto si è già detto, che le norme di natura cautelare la cui
inosservanza è stata ritenuta addebitabile agli imputati nel presente processo, hanno carattere
elastico e non rigido per cui la necessità di operare il giudizio di prevedibilità resta immutata.
h) L’ambito della prevedibilità. Fatte le ricordate premesse resta però ancora irrisolto il problema di
maggior complessità che si pone in questa materia: individuare i criteri da utilizzare per verificare
se un evento casualmente riconducibile alla violazione di una regola cautelare fosse prevedibile
significa, in particolare, verificare se la prevedibilità debba riguardare lo specifico evento
realizzatosi ovvero una categoria di eventi riconducibili alla medesima causa e quale grado di
specificità sia richiesto sull’individuazione degli eventi.
La giurisprudenza di legittimità su questo punto è univoca: si è da tempo affermato (fin da Cass. 6
dicembre 1990, Bonetti, id., 1992, II, 36, relativa al disastro di Stava) che «ai fini del giudizio di
prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una
situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell’evento dannoso, quale
si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione». Queste conclusioni sono state
ribadite da Cass. 31 ottobre 1991, Rezza (id., Rep. 1993, voce Reato in genere, n. 19) ed
espressamente richiamate da Cass. 30 marzo 2000, Camposano (id., 2001, II, 278).
Il problema enunciato merita un approfondimento perché l’orientamento espresso dalla
giurisprudenza di legittimità, oltre a non essere condiviso (ovviamente) dai ricorrenti, incontra
soluzioni diverse anche in dottrina.
Detto in estrema sintesi: per ritenere esistente la colpa dell’agente è necessario che il medesimo si
sia rappresentato — o fosse in grado di rappresentarsi — tutte le specifiche conseguenze della sua
condotta derivanti dalla violazione delle regole cautelari o di prevenzione, o è sufficiente che fosse
in grado di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta, una potenzialità lesiva del suo
agire che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione?
È parere della corte che la risposta corretta sia quest’ultima accolta dalla sentenza di secondo
grado. E ciò sotto diversi profili.
Il primo profilo riguarda la potenzialità lesiva della sostanza nociva. Fino a che il rischio per la
salute umana — in base alle conoscenze disponibili — è escluso o è limitato a patologie di modesta
gravità la prevedibilità non può che riguardare queste conseguenze o altre di analoga gravità e
quindi una patologia più grave è correttamente ritenuta non prevedibile. Se il cvm fosse stato
ritenuto idoneo a provocare semplici patologie momentanee e regredibili con il venir meno
dell’esposizione sarebbe ragionevole ritenere che non potevano ritenersi prevedibili effetti più gravi
sulla salute umana.
Si comprende quindi l’insistenza dei ricorrenti sull’asserito ridotto ambito di applicazione degli art.
20 e 21 più volte ricordati alle sole emissioni moleste o fastidiose. Se così fosse ne discenderebbe
l’imprevedibilità dei più gravi danni verificatisi (il datore di lavoro è tenuto ad evitare l’esposizione
a odori sgradevoli; ma se si scopre successivamente che la sostanza che li provoca è anche
cancerogena non risponderà dei danni provocati quando gravi danni alla salute neppure erano
ipotizzabili).
Questa è la regola giuridica cui deve attenersi il giudice di merito sulla valutazione sull’esistenza
della prevedibilità che costituisce pur sempre una valutazione di merito a lui riservata.
E deve ritenersi che i giudici di appello abbiano correttamente applicato la disciplina giuridica sulla
prevedibilità accertando che il cvm e il pvc erano sostanze di cui era conosciuta l’idoneità a
provocare gravi patologie (quali, secondo quanto incensurabilmente accertato dai giudici di merito,
il morbo di Raynaud e in particolare l’acrosteolisi).
Non solo. La corte ha richiamato anche i documenti aziendali Montedison che già sul finire degli
anni cinquanta riconoscevano la tossicità di queste sostanze; le dichiarazioni dell’imputato Bartalini
che ha riconosciuto l’epatotossicità del cvm risalente ai suoi studi universitari (circostanza
confermata dal medico di fabbrica del petrolchimico, dott. Giudice); un documento
dell’associazione europea dei produttori di materie plastiche (Apme) secondo cui erano già
conosciute, come effetti dell’esposizione al cloruro di vinile, negli anni cinquanta e sessanta,
«alterazioni non specifiche della funzionalità epatica e del sistema digestivo e respiratorio,
sindrome di Raynaud nelle mani, lesioni sclerodermiche e alterazioni ossee osteolitiche delle
falangi distali».
Logica è quindi la conclusione della corte di merito secondo cui, ben da prima dell’epoca della
contestazione (che parte dal 1969), dovevano già ritenersi prevedibili gravi danni alla salute dei
lavoratori esposti al cloruro di vinile e quindi doveva ritenersi sorto l’obbligo (anche se fossero
mancate regole cautelari di origine normativa), per il datore di lavoro, di adottare le cautele
necessarie per preservare i lavoratori dal rischio in esame perché la tutela della salute umana
costituisce obbligo primario di salvaguardia di un diritto costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.),
cautele peraltro già imposte dalla legge.
È da evidenziare che questo accertamento incensurabile del giudice di merito riguarda anche gli
effetti tossici sul fegato che la corte di merito afferma essere confermati dallo studio Tribuk
risalente al 1949.
Ma, si afferma nei ricorsi, il rischio cancerogeno non era noto e gli studi di Viola non erano
sufficienti a confermarne l’esistenza perché condotti con metodi non sofisticati, su animali (non si
dice se le ricerche avrebbero dovuto essere condotte sull’uomo) e ad esposizioni elevatissime.
Ma ciò non vale ad escludere la prevedibilità degli effetti cancerogeni del cvm. La ricerca di Viola
non costituiva infatti una congettura inaffidabile ma era stata, pur con le caratteristiche ricordate,
condotta con metodo scientifico e aveva fatto sorgere una plausibile probabilità o possibilità di un
effetto cancerogeno anche sull’uomo.
La serietà di questi studi, e la plausibilità dei risultati raggiunti, non è confermata soltanto dal
riconoscimento, anche a livello internazionale (formò oggetto di comunicazioni in convegni svolti
in Stati stranieri e fu pubblicata su un’importante rivista medica che si occupava di studi sui
tumori), che gli studi di Viola ottennero all’epoca ma dalla condotta dei dirigenti Montedison che
affidarono al prof. Maltoni un approfondimento della ricerca, evidentemente perché ritennero che
gli studi del dott. Viola avessero un fondamento scientifico.
Il che equivale a dire che, dal momento in cui i dirigenti Montedison ne vennero a conoscenza,
divenne per loro «prevedibile» o «vennero posti in condizione di prevedere», la possibilità di effetti
cancerogeni sull’uomo. Diversamente non avrebbero disposto l’approfondimento della ricerca.
i) La prevedibilità e le leggi scientifiche. Ma quali sono i criteri che devono governare
l’accertamento della potenzialità lesiva prevedibile?
Su questo punto questa corte ritiene non possano esservi dubbi sulla correttezza della tesi fatta
propria dalla sentenza impugnata secondo cui le regole di spiegazione causale dell’evento non
possono valere per l’accertamento dell’esistenza della colpa. La soglia — insita nei concetti di
diligenza e prudenza espressamente richiamati dall’art. 43 c.p. — oltre la quale l’agente può
prevedere le conseguenze lesive della sua condotta, non è costituita dalla certezza scientifica ma
dalla probabilità o anche della sola possibilità (purché fondata su elementi concreti e non solo
congetturali) che queste conseguenze si producano.
Naturalmente questa possibilità deve essere concreta e non solo astratta. È questo il limite che
differenzia le situazioni in cui le pubbliche autorità devono intervenire per la salvaguardia
dell’ambiente o per la tutela della vita e della salute dei consociati dalle situazioni in cui viene in
considerazione l’agire del singolo soggetto: la concretezza del rischio. E il rischio diviene concreto
quando — sia pure in base a ricerche non ancora complete o prive di requisiti di generale
applicabilità o anche soltanto in base a serie generalizzazioni empiriche — viene individuata la
possibilità dell’idoneità lesiva di una condotta commissiva od omissiva che dunque diviene
prevedibile.
L’ente pubblico è tenuto a salvaguardare i cittadini dal rischio dell’inquinamento per salvaguardare
la loro salute da pericoli astrattamente ipotizzabili in base, eventualmente, a indagini
epidemiologiche. Ma se, all’interno di una fabbrica, si verifica (anche empiricamente) che i
lavoratori esposti ad una determinata sostanza fino ad allora ritenuta innocua subiscono eventi lesivi
in proporzione anomala rispetto a quelli non esposti l’obbligo per il datore di lavoro di eliminare, o
ridurre per quanto possibile, l’esposizione (rischio concreto) sorge immediatamente e non solo
quando, successivamente (eventualmente dopo anni), gli studi scientifici avranno confermato
l’osservazione empirica e spiegato i meccanismi di produzione dell’evento lesivo.
Non è quindi condivisibile la distinzione — oggetto di particolare approfondimento in alcuni
ricorsi ed in particolare in quello del responsabile civile — tra rischio e pericolo; distinzione che, in
tesi difensiva, varrebbe a diversificare gli obblighi di intervento preventivo esistenti solo nel caso di
accertamento del pericolo mentre il rischio riguarderebbe soltanto il legislatore o il pubblico
amministratore.
Rischio e pericolo — come è agevole constatare leggendo le definizioni che ne danno i dizionari in
uso — sono in realtà concetti sovrapponibili e indicano entrambi una situazione o circostanza da cui
può derivare un danno. Questa difficoltà, se non impossibilità, di distinguere tra rischio e pericolo è
del resto confermata dalla circostanza che gli studiosi che hanno tentato di individuare queste
differenze sono pervenuti a risultati non solo insoddisfacenti ma addirittura contradditori. Basti
pensare che vi è chi individua una differenza di tipo qualitativo e chi opta invece per una differenza
di tipo esclusivamente quantitativo.
Semmai sarebbe corretto affermare che il c.d. «principio di precauzione» non ha una diretta
efficacia nel diritto penale ma è volto soltanto ad ispirare le pubbliche autorità nelle scelte di
regolamentare o vietare l’esercizio di determinate attività quando esista il «sospetto» di una loro
pericolosità che però mai ha trovato conferma. Il presupposto per questi interventi è costituito
dall’incertezza scientifica sulla dannosità per la persona umana, per es., di una determinata
esposizione ad un agente di cui non siano ancora conosciuti gli effetti.
I casi sono ben noti: da anni si discute sulla possibile efficienza lesiva delle onde elettromagnetiche
provenienti da impianti di trasmissione radiotelevisiva ma fino ad oggi non si sono avute conferme
scientifiche di questi effetti e lo stesso può dirsi per le emissioni derivanti dagli impianti di telefonia
cellulare. E come non ricordare le accese discussioni, anche in sede scientifica, dei possibili effetti
dannosi dei prodotti (in particolare di quelli alimentari) geneticamente modificati?
È ovvio che, fino a quando non si abbia una conferma scientifica degli effetti dannosi di queste
esposizioni sulla persona umana il problema non riguarda il diritto penale ma è rivolto alle scelte
politico-amministrative che possono essere o meno ispirate ad un rigore preventivo per evitare
danni ad oggi non confermati trattandosi di ipotesi prive di conferma e quindi di concretezza.
Ma ben diverso è il caso in cui una determinata esposizione si sia già dimostrata dannosa per la
salute umana anche se non siano ancora ben delineati i confini di tale pericolosità. In tal caso sorge
l’obbligo per l’agente di eliminare o ridurre nei limiti del possibile l’esposizione in modo da
ricondurla in termini di non pericolosità (se già fosse dimostrata l’efficienza lesiva delle onde
elettromagnetiche sulla salute dell’uomo sorgerebbe immediatamente quanto meno l’obbligo di
ridurle anche in previsione di ulteriori danni, eventualmente più gravi, oggi non conosciuti).
Ha senso poi parlare di distinzione tra rischio e pericolo e di principio di precauzione quando il
legislatore abbia già fatto la sua scelta classificando come nociva una determinata sostanza ed
imponendo la riduzione delle esposizioni nei limiti del possibile e altre cautele (per es. le visite
periodiche)? O tutte queste discussioni sono riferibili esclusivamente a casi di colpa generica per
verificare se, anche in mancanza di una disciplina limitativa, l’agente sia tenuto ad adottare cautele
non ancora previste normativamente (eventualmente — questa volta il richiamo sarebbe pertinente
— invocando l’art. 2087 c.c.)?
Evidente è quindi l’erroneità della tesi del tribunale (che difatti alcuni dei ricorrenti neppure
riprendono) secondo cui, per far sorgere l’obbligo prevenzionale, occorre fare riferimento al
«patrimonio scientifico consolidato» quale criterio per imporre l’adozione della regola cautelare per
impedire un evento che solo allora diviene prevedibile.
L’adozione di questo criterio costituisce un’indebita trasposizione delle regole che governano
l’accertamento della causalità al tema della colpevolezza. In tema di causalità si tratta di addebitare
oggettivamente un evento dannoso alla condotta colposa dell’agente, di accertare quindi se il fatto è
«suo» (se quella morte è stata da lui provocata con la sua condotta inosservante); è ovvio che le
regole processuali di un paese che si ispira ai principî della democrazia liberale debba richiedere sul
piano probatorio quell’elevato grado di probabilità — in cui si esprimono le regole dell’elevato
grado di credibilità razionale e dell’oltre il ragionevole dubbio — che possa consentire di addebitare
ad un soggetto un evento.
Ma le regole che disciplinano l’elemento soggettivo hanno natura non di verifica a posteriori della
riconducibilità di un evento alla condotta di un uomo ma funzione precauzionale e la precauzione
richiede che si adottino certe cautele anche se è dubbio che la mancata adozione provochi eventi
dannosi.
L’utilizzazione di questi criteri comporterebbe, in tema di prevenzione di rischi alla salute, che
sarebbe esigibile l’adozione delle regole cautelari (anche di quelle già previste dalla legge!) solo
dopo che fosse stato accertato, in termini di elevata credibilità razionale (secondo i criteri indicati
nella già citata sentenza, Cass., sez. un., 10 luglio 2002, Franzese, in tema di causalità) che alla
mancata adozione di regole di cautela consegue un determinato effetto dannoso.
Questa operazione ermeneutica avrebbe come ovvio risultato quello di porre nel nulla la natura
preventiva delle regole cautelari dirette ad evitare il verificarsi di eventi dannosi anche se
scientificamente non certi (purché non solo congetturali) ed anche se non preventivamente e
specificamente individuati.
È dunque obbligata la conclusione che (a differenza dell’addebito oggettivo per il quale, sotto il
profilo della causalità, è necessario accertare che l’evento non si sarebbe verificato con elevato
grado di credibilità razionale se fosse stata posta in essere la condotta richiesta) ben inferiore è la
soglia che impone l’adozione della regola cautelare.
Se poi con il richiamo al «patrimonio scientifico consolidato» il tribunale intendeva riferirsi non
tanto alle leggi scientifiche riconosciute quanto al consenso generalizzato della comunità scientifica
è facile osservare che questo criterio, nel contiguo campo della validità della prova scientifica, non
viene più ritenuto l’unico criterio utilizzabile neppure dalla giurisprudenza nordamericana come
emerge dalla notissima sentenza 28 giugno 1993 della Corte suprema federale degli Stati uniti,
relativa al caso Daubert (id., 1994, IV, 184), che ha indicato i criteri idonei a valutare la validità e
l’attendibilità delle prove scientifiche individuandoli nella controllabilità, falsificabilità e
verificabilità della teoria o tecnica posta a fondamento della prova; nella percentuale di errore
conosciuto o conoscibile; nella possibilità che la teoria o tecnica abbia formato oggetto di controllo
da parte di altri esperti perché divulgata in pubblicazioni scientifiche o con altri mezzi; nella
presenza di standard costanti di verifica; nel consenso generale da parte della comunità scientifica.
Criterio, quest’ultimo, da vari decenni ritenuto l’unico utilizzabile dal giudice per avere conferma
della validità della prova scientifica e che invece la più recente giurisprudenza non ritiene più
l’unico cui fare riferimento per i fini indicati.
Ma il tribunale è incorso anche in un secondo errore perché ha fatto riferimento, nell’indicare il
livello di diligenza esigibile, «alle applicazioni tecnologiche generalmente praticate ed agli
accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, correlati all’osservanza
degli standard di sicurezza delle diverse attività per conseguire l’esclusione del verificarsi
dell’evento».
L’errore consiste nell’aver individuato le misure preventive esigibili non in quelle più adeguate
ipotizzabili ma in quelle «generalmente praticate» in contraddizione con un principio ormai
generalmente riconosciuto (non solo in Italia) secondo cui non possono essere convalidati usi
scorretti o pericolosi anche se generalmente praticati (lo studioso italiano che ha maggiormente
approfondito i temi della colpa così ha compendiato nel 2005 il suo pensiero su questo punto:
«diligente non è ciò che usualmente viene fatto, ma ciò che si deve fare, pagando anche i costi
necessari»).
Questo secondo errore ha un rilievo minore nel presente giudizio perché anche la sentenza di primo
grado ha riconosciuto che la Montedison ebbe ad applicare, fino al 1974, misure di prevenzione
inadeguate anche se si afferma che le conoscenze scientifiche allora disponibili non imponevano
l’adozione delle misure richieste. Insomma il secondo errore rifluisce sul primo avendo, i primi
giudici, omesso di considerare che da oltre quindici anni erano in vigore, nel nostro ordinamento,
regole cautelari (gli art. 20 e 21 più volte citati) che imponevano di ridurre le esposizioni «nei limiti
del possibile».
l) La concretizzazione o realizzazione del rischio. In generale. La responsabilità colposa si fonda
sulla violazione della regola cautelare ma non è sufficiente che sia stata accertata questa violazione
essendo altresì necessario che la regola violata fosse diretta ad evitare quel tipo di evento.
Diversamente l’agente verrebbe punito per la mera infrazione anche se la regola cautelare aveva
tutt’altro scopo, cioè verrebbe sanzionato — non diversamente dal caso in cui difetti la prevedibilità
dell’evento — il mero versari in re illicita con la previsione di una sorta di responsabilità oggettiva.
Si parla dunque di «concretizzazione del rischio» o «realizzazione del rischio» come alcuni autori
preferiscono.
Preliminare a questa verifica (non diversamente dagli altri aspetti della colpa) è l’accertamento
della causalità materiale dell’evento (che può consistere anche nella condotta dell’uomo) perché
solo quando sia stata individuata l’origine causale del pregiudizio sarà possibile accertare se la
violazione della regola cautelare abbia cagionato l’evento, se l’evento rientri tra quelli che la regola
mirava a prevenire e se il comportamento alternativo lecito sarebbe stato idoneo e sufficiente ad
evitare il suo verificarsi.
Nel caso in esame, come si è visto, il problema della causalità materiale è da ritenere superato
perché i giudici di merito, di primo e di secondo grado, non hanno dubitato che la causalità
materiale degli angiosarcomi che hanno provocato la morte di numerosi lavoratori debba essere
individuata nell’esposizione al cloruro di vinile in quantità eccessive (non diversamente dalle altre
malattie ritenute cagionate da questa esposizione).
Il principio della concretizzazione del rischio si situa sul versante oggettivo della colpevolezza
mentre la prevedibilità riguarda più specificamente l’aspetto soggettivo: è una valutazione che
prende in considerazione l’evento in concreto verificatosi ed è diretta ad accertare se questa
conseguenza dell’agire rientrava tra gli eventi che la regola cautelare inosservata mirava a
prevenire. La ragione per cui è richiesto questo requisito è di meno agevole comprensione rispetto
al requisito della prevedibilità (non posso rispondere di quanto neppure l’agente modello poteva
prevedere); la concretizzazione fa riferimento allo scopo della norma ed è la verifica della
corrispondenza tra finalità della regola cautelare e finalità effettivamente raggiunta. Si tratta di
un’operazione di carattere logico diretta ad accertare l’esistenza della corrispondenza indicata.
La prevedibilità va accertata con criteri ex ante e va valutata dal punto di vista dell’agente (non di
quello che ha concretamente agito ma dell’agente modello) per verificare se era prevedibile che la
sua condotta avrebbe potuto provocare quell’evento; il criterio della concretizzazione del rischio è
invece una valutazione ex post che consente di avere conferma, o meno, che quel tipo di evento
effettivamente verificatosi rientrasse tra quelli presi in considerazione nella formazione della regola
cautelare.
Ci si potrebbe anche chiedere che cosa abbia a che fare questo principio con l’elemento soggettivo
del reato posto che l’accertamento della sua esistenza va compiuta in relazione all’evento già
verificatosi, con criteri che non possono che essere individuati ex post e con una valutazione di tipo
esclusivamente normativo (quell’evento concreto rientrava nel tipo di eventi che la norma mirava a
prevenire?). Il dubbio è confermato dalla circostanza che non è facile stabilire la linea di confine tra
questo principio e la c.d. «causalità della colpa» cui fa espresso riferimento l’art. 43 c.p.
Ci troviamo infatti in presenza di tre aspetti della ricerca sulla colpa che sono strettamente
confinanti, in parte sovrapponibili e per i quali non è facile individuare differenze e ambiti di
applicazione. Per stabilire una linea di confine tra questi concetti, e abbozzare una risposta su
questo complesso problema, possiamo dire anzitutto che in gran parte si tratta non tanto di elementi
o aspetti diversi relativi alla colpa ma di diversi punti di vista dai quali il medesimo problema viene
affrontato.
Prevedibilità e concretizzazione in realtà riguardano il medesimo problema; la prevedibilità, come
si è già accennato, viene valutata ex ante facendo riferimento all’agente modello mentre la
concretizzazione del rischio richiede una verifica ex post sul rapporto tra evento concreto e norma
cautelare; insomma si tratta di una prevedibilità di natura esclusivamente oggettiva e verificata a
posteriori; si potrebbe ancora dire (ma l’affermazione non è da tutti condivisa) che la prevedibilità è
prevedibilità in astratto, la concretizzazione è prevedibilità in concreto.
L’accertamento relativo alla causalità della colpa mira invece non a verificare la corrispondenza tra
evento e scopo della regola cautelare — come quello che si riferisce alla concretizzazione del
rischio — ma a chiarire se quella violazione ha cagionato quell’evento concretamente verificatosi.
La contiguità e parziale sovrapposizione del concetto di concretizzazione del rischio con gli altri
due aspetti della colpa rende necessario fare ricorso ad un esempio concreto, quello ricorrente
dell’automobilista che percorre una strada in senso vietato.
Se il veicolo da lui guidato va ad urtare contro un altro veicolo che percorre la strada nel senso
consentito è evidente la coesistenza di tutti i profili della colpa (e della causalità della colpa):
l’evento era prevedibile dall’agente modello che deve sincerarsi previamente se il senso di marcia è
a lui consentito. Quell’incidente realizza la concretizzazione del rischio perché la regola cautelare
mira proprio ad evitare che si verifichino quegli incidenti. V’è causalità della colpa perché la
violazione della regola cautelare ha «cagionato» quell’evento.
L’agente risponderà quindi delle lesioni provocate al conducente di un veicolo che proveniva dal
senso opposto; non risponderà invece dell’investimento di chi sia caduto dal balcone. In
quest’ultimo caso la caduta non era certamente prevedibile; la norma non mirava ad evitare
quell’evento — e neppure quel tipo di eventi — e la violazione non ha cagionato quell’evento se
non nel senso meramente materiale.
In realtà i casi non sono sempre così evidenti; nel caso dell’automobilista che procede contro mano
potrebbe aversi l’investimento di un pedone che attraversa improvvisamente la carreggiata
preoccupandosi soltanto di verificare che la strada sia libera nel senso di marcia consentito. In
questo caso la possibilità di ricollegare l’evento alla violazione della regola cautelare presenta
aspetti di maggior problematicità perché, verosimilmente, questo evento non era stato preso in
considerazione nel momento in cui è stata formulata la regola cautelare ma la violazione della
regola ha comunque interferito nella causazione dell’incidente perché il pedone ha fatto affidamento
sul suo rispetto.
m) Il «tipo» di eventi. Proprio questo riferimento (al «tipo» di eventi e non all’evento specifico
concretamente verificatosi) può costituire una soluzione equilibrata che evita i rischi del versari in
re illicita con l’utilizzazione del criterio dell’eccezionalità dell’evento concretamente verificatosi.
Insomma: l’evento deve rientrare nel tipo di eventi che la norma cautelare mirava a prevenire (per
es. il pericolo per la vita del soggetto tutelato o un grave danno alla sua salute) ma questi eventi non
devono avere carattere di eccezionalità. L’agente è rimproverabile se agisce — in contrasto con
regole cautelari — sapendo (o dovendo sapere) che la sua condotta può avere conseguenze dannose
anche se questi esiti della condotta non sono determinabili preventivamente purché si tratti di
conseguenze del tipo di quelle prese in considerazione nel momento in cui la regola cautelare è stata
redatta anche se non ancora interamente descritte e conosciute.
La valutazione sul «tipo» di evento trova varie conferme in dottrina: si è infatti affermato che
«l’evento lesivo di fatto cagionato deve appartenere al tipo di quelli che la norma di condotta
mirava a prevenire» e che «l’inosservanza della regola cautelare comporta l’imputazione non di tutti
gli eventi cagionati, ma solo di quelli del tipo che essa mira a prevenire».
Nell’esempio fatto è possibile che coloro che hanno redatto la regola cautelare che vieta di guidare
veicoli contro il senso di marcia intendessero riferire la tutela alla sola circolazione dei veicoli. Ma
l’obiettività della norma — cui soltanto dobbiamo fare riferimento — non consente certo di
escludere dal perimetro della tutela anche tutti quei comportamenti non caratterizzati da
eccezionalità (come è invece la caduta dal balcone) che la regola è idonea a tutelare anche se meno
frequenti. È quindi ragionevole ritenere che la tutela sia oggettivamente preordinata anche a favore
dei pedoni quando la consapevolezza del divieto possa indurre comportamenti di affidamento sul
rispetto della regola da parte degli automobilisti.
Questo aspetto — che riguarda anche la causalità — non è estraneo al nostro tema perché è
necessario verificare se in questi casi si possano addebitare soggettivamente all’agente le
conseguenze ulteriori in quanto prevedibili e se queste conseguenze costituiscano realizzazione del
rischio. In queste ipotesi dobbiamo dare per scontato che sussista il rapporto di causalità materiale e
che l’evento non sia dovuto ad una causa sopravvenuta da sola idonea a determinarlo; e, sotto il
profilo soggettivo, non si può che rilevare che non possono formare oggetto di previsione
esclusivamente quelle conseguenze ulteriori (ovvero protratte o tardive) che hanno carattere di
eccezionalità adottando la formula usualmente utilizzata per escludere la causalità (e lo stesso
criterio può essere utilizzato quando le conseguenze dannose si verifichino nei confronti di un terzo
diverso da quello preso in considerazione dalla regola cautelare).
D’altro canto il richiamo ad un ambito oggettivo della regola cautelare consente di evitare una
quasi impossibile ricerca diretta ad individuare un’intenzione soggettiva dei redattori della
medesima, di individuare un ambito oggettivo di applicabilità e di tener conto della sua espansione
nel caso di mutamento del contesto di applicazione.
Questa elasticità nell’ambito di applicazione della regola cautelare può derivare anche
dall’evoluzione delle tecnologie. Ciò avviene frequentemente nell’ambito della disciplina delle
cautele in tema di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali laddove casi
in cui viene in considerazione l’osservanza della regola cautelare — non previsti dai redattori della
medesima — possono trovare un ambito di applicazione più esteso in caso di modifica dei
procedimenti produttivi e di introduzione di nuove tecniche di lavorazione.
Né può ritenersi, come si è affermato in alcuni ricorsi (in particolare quelli del responsabile civile
Edison e degli imputati Gatti e Bartalini; ma anche in un contributo di dottrina dedicato all’esame
critico della sentenza della Corte d’appello di Venezia), che questa ricostruzione si ponga in
contrasto con i principî di tassatività e determinatezza perché si tratta di principî estranei al tema
che stiamo esaminando.
Infatti, in estrema sintesi, il principio di tassatività è riferibile al divieto di analogia nella materia
penale mentre il principio di determinatezza riguarda la formulazione della norma che deve essere
sufficientemente chiara («determinata») nel descrivere la condotta vietata e costituisce una
riaffermazione del principio di legalità.
Nessuno dei due principî si riferisce quindi all’elemento soggettivo del reato né può affermarsi che
l’indeterminatezza riguarderebbe l’oggetto della previsione da parte dell’agente perché qui siamo al
di fuori del principio in esame. Il contenuto dell’oggetto della possibilità di previsione non riguarda
infatti la formulazione della norma (semmai potrebbe riguardare la formulazione della regola
cautelare ove prescrivesse condotte aspecifiche) ma i contorni che deve assumere l’oggetto della
previsione al fine di verificare la rimproverabilità della condotta.
Se poi le critiche in esame dovessero intendersi rivolte alla formulazione delle regole cautelari
previste nei più volte ricordati art. 20 e 21 d.p.r. 303/56 si porrebbe naturalmente un problema di
costituzionalità che può peraltro ritenersi superato dall’orientamento della Corte costituzionale che,
con la sentenza 25 luglio 1996, n. 312 (id., 1996, I, 2957), ha ritenuto (in un caso analogo in cui la
norma prevedeva l’adozione delle misure tecniche, organizzative e procedurali «concretamente
attuabili» per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore) che il legislatore si
riferisse «alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad
applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali
altrettanto generalmente acquisiti».
Anche se può ritenersi opinabile il riferimento alle misure generalmente applicate (e non a quelle di
maggior efficacia) è rilevante notare che la Corte costituzionale, in una materia assai vicina a quella
che stiamo trattando, ha ritenuto che la determinatezza, in queste fattispecie, si determina con il
riferimento alle misure tecnologiche applicabili al processo produttivo all’epoca della condotta.
n) Il criterio della «ratio» della regola cautelare. Il tema può essere approfondito anche sotto un
diverso aspetto.
Si è visto che la violazione della regola cautelare consente l’addebito soggettivo se l’evento in
concreto, verificatosi «rientri nel novero degli accadimenti che la norma mirava a prevenire» e che
«è difficile negare, anzitutto, che le regole cautelari presentano per lo più uno spettro preventivo
assai ampio, nel senso che esse mirano a evitare non un solo tipo di evento, ma una serie di eventi
tra loro diversi per gravità». E il medesimo autore prosegue: «dato che caratteristica delle regole
cautelari di fonte giuridica è quella di indicare la pretesa comportamentale formalizzandola
attraverso leggi, regolamenti, ordini o discipline, si comprende che in questi casi le valutazioni di
rischio che il fine di tutela introduce nella tipicità penale, vanno logicamente desunte dalla ratio
della regola giuridica, quale risulta dall’interpretazione della sua struttura lessicale e logica».
Pur dandosi atto della problematicità della soluzione questo collegio ritiene che il principio della
concretizzazione del rischio vada inteso con criteri di ragionevolezza interpretando la regola
cautelare non in senso formale e statico ma secondo la sua ratio e secondo criteri che tengano conto
dell’evoluzione delle conoscenze e della possibilità di ricondurre comunque l’evento alle
conseguenze della violazione della regola di condotta, anche se infrequenti e non previste
anticipatamente, purché non siano completamente svincolate dallo scopo perseguito nella redazione
della regola cautelare.
Dunque la ratio della regola cautelare. La regola è stata dettata per impedire il verificarsi di uno
specifico evento preventivamente individuato o per uno spettro più ampio di eventi determinato
soltanto nel «tipo»? Per compiere questa verifica utili indicazioni — ai fini dell’accertamento se un
determinato evento rappresenti la realizzazione del rischio preso in considerazione dalla norma
cautelare — possono trarsi dalla natura della norma cautelare che si assume violata.
Esistono infatti norme cautelari specificamente previste per la prevenzione di eventi ben
individuati: si pensi alle cinture di sicurezza o alle scarpe protettive, le prime dirette ad evitare
cadute dall’alto e le seconde per prevenire lesioni conseguenti alla caduta di corpi pesanti sugli arti
inferiori. Se il datore di lavoro non fornisce il lavoratore di questi mezzi di protezione risponde dei
danni provocati dalla precipitazione del lavoratore o di quelli cagionati dalla caduta di un oggetto
pesante sui suoi piedi. Lo scopo di protezione può però ritenersi esistente anche nel caso di eventi
che non rappresentino quelli tipici ma siano comunque ricollegabili alle modalità dell’attività
lavorativa (per es. la caduta sia stata provocata dall’urto di un veicolo contro l’impalcatura o il
piede del lavoratore sia stato schiacciato da un veicolo operante nell’ambiente di lavoro).
Ma se un lavoratore privo del casco protettivo viene punto alla testa da un grosso insetto (che non
avrebbe potuto pungerlo in presenza del mezzo di protezione) o il lavoratore privo delle scarpe
protettive contrae una malattia ai piedi perché esposti ad un agente patogeno (salva la responsabilità
per aver sottoposto il lavoratore a tale agente) sembra evidente che si è al di fuori dell’area di
concretizzazione o realizzazione del rischio.
Quelle regole di condotta erano dirette a tutt’altro scopo e il verificarsi degli eventi dannosi
descritti esulava completamente dagli scopi di protezione delle medesime; con la conseguenza che
gli eventi medesimi, caratterizzati da eccezionalità, erano imprevedibili per l’agente che dunque
versa in re illicita ma non può essere ritenuto in colpa sia perché l’evento non era prevedibile sia
perché il fatto in concreto verificatosi era completamente estraneo allo scopo di protezione della
norma.
Ma esistono regole di condotta ad ampio spettro che — o perché le conoscenze dell’epoca in cui
sono state dettate erano ancora limitate o perché si è in presenza di cause dannose o eventi talmente
numerosi da rendere impossibile non solo l’enumerazione completa ma anche la loro anticipata
individuazione — si limitano a dettare la regola di condotta in relazione all’astratta possibilità del
verificarsi di eventi dannosi alcuni dei quali possono essere ancora ignoti. Se una sostanza è
riconosciuta come dannosa il legislatore ne può vietare l’impiego, o limitarne l’uso con l’adozione
di determinate cautele, proprio perché eventuali conseguenze, se del caso più gravi di quelle note,
non sono ancora conosciute.
E può affermarsi l’esistenza del solo versari in re illicita nella condotta di chi, nonostante
l’esistenza del divieto o della disciplina limitativa, non adotti le cautele richieste e si verifichi un
danno del tipo di quelli conosciuti ma non ancora specificamente conosciuto al momento della
condotta? Oppure il divieto o l’imposizione della regola di condotta sono preordinati, in caso di
regole per così dire «aperte», anche a prevenire le conseguenze non conosciute ma comunque
riconducibili all’area di protezione della norma?
Sarebbe veramente singolare che una condotta imposta in presenza di determinati presupposti (per
es. la pericolosità per la salute umana dell’esposizione ad un agente patogeno di cui sia stata
accertata la tossicità) sia ritenuta incolpevole per aver provocato una conseguenza di cui il
legislatore non aveva tenuto conto (perché non conosciuta) al momento della formulazione
originaria della norma che peraltro sia stata dettata in termini generali e aspecifici proprio perché
tutte le conseguenze dell’esposizione non erano ancora conosciute (e verosimilmente mai lo
saranno).
Ancora oggi: potrebbe escludersi la prevedibilità nel caso di una patologia (diversa da quelle
tradizionalmente conosciute) che si scoprisse essere conseguenza dell’esposizione all’amianto
avvenuta dopo l’introduzione del divieto dell’impiego di questa sostanza o al cloruro di vinile
monomero in dosi superiori a quelle ritenute non tossiche? O può affermarsi che nell’ambito delle
conseguenze del «tipo» di quelle che il legislatore voleva prevenire (morte della persona; grave
danno alla salute) l’agente che opera in violazione delle regole cautelari non solo versa in re illicita
ma si assume le conseguenze della sua condotta comprese quelle non ancora conosciute quando sia
possibile affermare che la norma è stata dettata per prevenire anche queste conseguenze?
Se via via nel tempo si scopre che una sostanza provoca malattie diverse non è possibile o
addirittura probabile che ve ne siano ancora di non conosciute e ciò non costituisce un presupposto
della prevedibilità e un addebito di rimproverabilità della condotta di chi ignora questo pericolo?
È noto che vi sono malattie (in particolare alcune forme tumorali) che hanno tempi di latenza
lunghissimi (per il mesotelioma pleurico cagionato dall’amianto si è parlato di tempi che possono
superare i cinquanta anni); se nulla si sa della nocività dell’esposizione ad una sostanza che provoca
queste malattie è ovvio che l’agente non è rimproverabile perché il risultato della sua condotta non
poteva essere previsto.
Ma che agente modello è quello che sottopone altri all’esposizione ad una sostanza già riconosciuta
(dalla legge!) come nociva anche se le conseguenze dell’esposizione non sono ancora tutte
completamente note? È possibile affermare, oggi, che solo fra alcuni decenni potrà ritenersi
prevedibile una malattia provocata da un agente oggi conosciuto come nocivo ma i cui effetti siano
ancora in parte sconosciuti?
E allora il discrimine tra il versari in re illicita (la responsabilità oggettiva) e la colpa —
ipotizzabile solo in presenza della prevedibilità dell’evento e della realizzazione del rischio — è
costituito, nel caso di violazione di una regola cautelare, dalla circostanza che la norma sia redatta
in previsione di uno specifico e determinato evento, poi concretamente verificatosi, oppure per un
tipo di eventi che peraltro non sono tutti preventivamente individuabili.
Nel primo caso il verificarsi di un evento completamente diverso consente di affermare soltanto
l’esistenza del versari in re illicita; ma se, trattandosi di regola cautelare «aperta», l’evento rientra
nel «tipo» di eventi che la norma mira a prevenire — e purché non sia completamente diverso da
quelli presi in considerazione nella formulazione della regola di cautela e non costituisca uno
sviluppo eccezionale della violazione — la condotta dell’agente è «rimproverabile» perché era
prevedibile che esistessero conseguenze, eventualmente non ancora conosciute o descritte, del
medesimo tipo.
o) L’accertamento del decorso causale. Vi sono poi casi nei quali il criterio della concretizzazione
del rischio richiede un «dippiù» rispetto alla realizzazione del rischio tipico e si afferma (ma il tema
è controverso) che anche il decorso causale debba essere corrispondente a quello preso in
considerazione nella redazione della norma cautelare. Si pensi al decesso di un automobilista a
seguito di un infarto cagionato dall’emozione provocata da una manovra azzardata di un altro
automobilista (per es., un sorpasso irregolare, una perdita di controllo del veicolo poi rientrata,
ecc.).
La selezione degli anelli causali intermedi è ritenuta necessaria, da una parte della dottrina, per
poter ritenere che l’evento verificatosi sia corrispondente a quello che la regola cautelare mirava ad
evitare. È stato affermato che «il vero problema è quello di selezionare gli anelli causali (o le
modalità dell’evento) di cui è necessario accertare la presenza nell’ambito dell’accadimento
concretamente prodottosi, determinando altresì a quali condizioni la loro successione all’interno del
decorso causale configuri effettivamente l’evento ‘finale’ come realizzazione del rischio in
considerazione del quale la condotta era stata vietata, senza arrestarsi al mero riscontro che tale
evento fosse in effetti uno di quelli che la regola cautelare mirava a prevenire».
Non è sempre così. Esistono effettivamente casi nei quali non solo ai fini della causalità ma altresì
ai fini della prevedibilità e della concretizzazione del rischio, non è sufficiente riferirsi al mero
evento finale comunque verificatosi ma deve richiedersi che venga descritto (o ridescritto come
pure si afferma) l’intero evento in concreto realizzatosi.
Ciò avviene quando un evento si sia verificato in presenza di una causa preesistente e della
violazione della regola cautelare ma la causa preesistente non abbia in concreto cagionato l’evento
in realtà riconducibile ad un diverso decorso causale assolutamente eccezionale ed imprevedibile.
Un esempio di questa ipotesi è costituito dal caso affrontato da App. Torino 18 ottobre 1996 (id.,
Rep. 1999, voce cit., n. 32). In quel caso si trattava di una valanga che aveva travolto alcuni sciatori;
la pista avrebbe dovuto essere chiusa per le abbondanti nevicate verificatesi nei giorni precedenti
che creavano un serio e attuale rischio di valanghe; la valanga si era però verificata non per
l’accumulo di neve ma per la rottura del fronte di un ghiacciaio, fatto ritenuto assolutamente
imprevedibile. Gli imputati versavano quindi in re illicita, l’evento non si sarebbe verificato se
avessero rispettato la regola cautelare ma quell’evento, come concretamente verificatosi, non era
prevedibile perché non ricollegabile alla violazione della regola cautelare.
Sembra evidente che, nel nostro caso, ci troviamo al di fuori di queste ipotesi perché l’evento è
invece ricollegabile alla violazione delle regole cautelari dettate per prevenirlo. Per restare
all’esempio fatto ci troveremmo in un’ipotesi assimilabile a quella ricordata se, per esempio, i
lavoratori del petrolchimico, privi dei mezzi di protezione personale, avessero subìto danni alla
salute non per le esalazioni dello stabilimento dove lavoravano ma per essere stati investiti da una
(imprevedibile) nube tossica fuoriuscita da altro stabilimento. Se avessero avuto a disposizione il
mezzo di protezione (per es. le maschere) non avrebbero subìto danni ma il meccanismo causale
delle lesioni è completamente estraneo al rispetto della regola cautelare da parte dell’imprenditore.
p) La prevenibilità dell’evento. Non è sufficiente che l’agente abbia violato la regola cautelare, che
questa violazione abbia cagionato l’evento e che quel tipo di eventi fosse ricompreso nella
previsione della norma cautelare. È necessario che venga anche individuata la condotta
(«comportamento alternativo lecito»; ma in dottrina vi è chi preferisce denominarlo
«comportamento alternativo diligente») che, se posta in essere, avrebbe evitato il verificarsi
dell’evento che dunque non solo deve essere prevedibile ma altresì evitabile o prevenibile.
È chiaro che il problema di individuare il comportamento alternativo lecito non si pone quando la
regola cautelare imponga di astenersi da una determinata attività: in questo caso il comportamento
alternativo lecito è costituito dalla mera omissione della condotta vietata.
È l’evitabilità dell’evento, ancor più della sua prevedibilità (che ne costituisce il presupposto) che
indirizza la formazione della regola cautelare secondo criteri sociali o giuridici; se esiste il pericolo
o il rischio di un evento che può essere immaginato la regola cautelare sarà formulata in relazione a
questo rischio ma la sua concreta definizione non potrà che avvenire in base alla concreta possibilità
che questa regola sia idonea ad evitare l’evento anche se — e ciò si verifica in particolare
nell’ambito del rischio consentito nelle attività pericolose — è improbabile che possa aversi la
garanzia totale che l’evento non si verificherà (per es. un’attività di paracadutismo svolta con
l’osservanza di tutte le regole previste non potrà escludere il verificarsi di eventi dannosi provocati
dall’insorgere di improvvisi eventi atmosferici).
Nel caso oggetto del presente processo, e in relazione agli eventi di danno fin qui presi in
considerazione, la prevenibilità dell’evento forma oggetto di contestazioni, neppure troppo
specifiche, contenute in alcuni dei ricorsi ma va detto che su questo tema la risposta della corte di
merito (ma questa valutazione coincide con quella dei giudici di primo grado che hanno escluso la
prevedibilità ma non certo la prevenibilità) è del tutto appagante.
Basti richiamare le condotte, già descritte, poste in essere dal 1974 in poi, che la corte ha ritenuto
idonee (e lo sono certamente state come emerge dalle motivazioni dei giudici di merito) ad azzerare
il rischio di contrarre l’angiosarcoma epatico. Il comportamento alternativo lecito è stato quindi
individuato e la sua efficacia impeditiva addirittura confermata con criteri di certezza (secondo un
giudizio controfattuale valido non solo ai fini dell’accertamento della causalità ma altresì ai fini
dell’individuazione del comportamento alternativo lecito).
q) L’esame dei motivi nuovi del responsabile civile e degli imputati Gatti e Grandi. Si è già detto
che una parte dei motivi nuovi si riferisce alla causalità e incorre dunque nelle preclusioni cui si è
già accennato (ciò vale in particolare per gran parte dei motivi Grandi che si riferiscono al suo
contributo causale soggettivo oltre che ai motivi — comuni a Gatti e Grandi — relativi ai reati di
lesioni colpose dichiarati estinti per prescrizione dei quali si è già trattato). Altre censure contenute
nei motivi aggiunti costituiscono un approfondimento delle censure proposte nei motivi principali e
se ne è tenuto conto nell’esame di questi ultimi.
Altre doglianze riguardano invece il vizio di motivazione previsto dal novellato art. 606, lett. e), del
codice di rito con la specifica indicazione degli atti dai quali risulterebbe l’esistenza del vizio.
In particolare il responsabile civile indica gli atti del processo che dimostrerebbero la mancanza e
contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta prevedibilità degli effetti cancerogeni del cvm dal
1969 e sulla condotta inosservante della Montedison in epoca anteriore al 1974 ma è facile
osservare che, per un verso, si tratta di censure già esaminate nell’esame dei motivi principali
mentre, sotto diverso profilo, gli atti indicati non solo sono stati presi in considerazione dalla corte
di merito e dal tribunale ma si tratta di atti il cui contenuto è inidoneo a disarticolare le conclusioni
cui è pervenuta la corte di merito sull’esistenza dell’elemento soggettivo.
Conclusioni, peraltro, neppure particolarmente divergenti con quelle dei giudici di primo grado
che, pur riconoscendo che, fino al 1974, non erano stati adottati interventi risolutivi per ridurre
l’esposizione al cvm, hanno escluso l’elemento soggettivo del reato per mancanza di prevedibilità
degli eventi e non perché risultasse in concreto che erano state adottate le cautele necessarie.
D’altro canto poiché la decisione impugnata si fonda su una massa ingentissima di informazioni
probatorie da cui ha tratto il convincimento riferito è evidente che le informazioni ricavabili dagli
atti indicati, per supportare l’asserita esistenza del vizio di motivazione, andrebbero rivalutate
unitamente agli altri numerosissimi atti su cui il giudice di merito ha fondato le sue conclusioni e,
per questa via, verrebbe attribuito al giudice di legittimità un compito (di giudice di merito di terzo
grado) estraneo alle sue funzioni istituzionali per quanto si è in precedenza accennato. La Corte di
cassazione dovrebbe rivalutare l’intero compendio probatorio su cui la corte di merito ha fondato il
suo convincimento che, per quanto si è già detto, è esente da vizi di logicità e da alcuna
contraddittorietà.
Ma v’è di più: il semplice esame dell’indicazione degli atti dimostra la loro (dichiarata) inidoneità a
fondare una diversa valutazione.
In particolare: le dichiarazioni e comunicazione del prof. Maltoni in parte esprimono opinioni —
anche di natura giuridica! — dello studioso mentre, in altra parte, riportano i tempi di conoscenza
dei suoi studi che non sono oggetto di contestazione; gli interventi indicati di Montedison effettuati
negli anni dal 1971 al 1973 riguardano settori limitati degli impianti; la circostanza dell’esistenza di
commesse anteriori al 1974 non dimostra che in quegli anni i temi della prevenzione siano stati
adeguatamente affrontati.
Deve quindi concludersi, sui motivi aggiunti del responsabile civile, che gli atti indicati da un lato
sono inidonei a disarticolare il ragionamento probatorio e le conclusioni cui è pervenuto il giudice
di merito ma, d’altro canto, neppure sono caratterizzati da decisività essendo inidonei, nel loro
valore testuale derivante dalla loro mera lettura, e anche se interpretati nel senso voluto dal
ricorrente, a fondare una diversa decisione.
Analoghe considerazioni vanno fatte per quanto riguarda i motivi aggiunti degli imputati Gatti e
Grandi.
Sugli atti costituiti dalle comunicazioni e osservazioni del prof. Maltoni le considerazioni da fare
sono identiche a quelle esposte in merito al ricorso del responsabile civile. E analogamente vanno
valutati i motivi che si riferiscono alla condotta inosservante fino al 1974.
Per quanto riguarda invece la dedotta circostanza che gli studi di Viola del 1969 e la sua
comunicazione del 1970 non accennavano agli effetti cancerogeni del cvm la circostanza contrasta
con quanto già accertato nella sentenza di primo grado nella quale si dà atto che gli studi di Viola
facevano riferimento a conseguenze tumorali (alla pelle e ai polmoni) dell’esposizione al cvm anche
se non all’angiosarcoma. Anche in questo caso dunque l’atto dovrebbe essere valutato all’interno di
tutto il compendio probatorio acquisito e comunque non avrebbe carattere di decisività nel senso
indicato.
Gli altri motivi aggiunti riguardano prevalentemente il tema della prevedibilità già in precedenza
trattato nell’esame dei motivi principali e in relazione al quale alcun atto decisivo idoneo a
scardinare la ricostruzione del giudice di merito è stato indicato.
IV. - I motivi sulla colpa della parte civile Terrin. — a) Cooperazione colposa e continuazione del
reato. Sono già stati esaminati i motivi del ricorso di questa parte civile relativi alla causalità
individuale. Terrin ha peraltro proposto altri motivi che, direttamente (la cooperazione colposa) o
indirettamente (la continuazione) riguardano l’elemento soggettivo del reato e che in questa sede
possono più opportunamente essere esaminati.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia l’inosservanza od erronea applicazione dell’art. 113
c.p. in relazione all’art. 43, 3° comma, del medesimo codice e, in subordine, mancanza e manifesta
illogicità della motivazione sull’esclusione dell’ipotesi di cooperazione colposa. In particolare si
contesta la motivazione della sentenza impugnata laddove richiede, per ritenere realizzata la
cooperazione colposa, la «consapevolezza reciproca delle rispettive azioni» — dovendosi invece
ritenere sufficiente la prevedibilità della condotta altrui — e la si censura in diritto nella parte in cui,
invece di ricondurre i requisiti soggettivi della cooperazione alla definizione di colpa di cui all’art.
43, 1° comma, li riporta al modello del concorso doloso ex art. 110 c.p. affermando che l’unica
differenza consisterebbe nella volizione dell’evento reato.
La consapevolezza, secondo il ricorrente, è invece elemento estraneo allo schema della
cooperazione per ravvisare la quale è sufficiente che i vari contributi «siano legati dall’oggettivo
‘cooperare’ o convergere insieme in un contesto di ripartizione di compiti, ruoli, funzioni, che si
possono certo succedere anche nel tempo, purché stretti da comuni regole cautelari da osservare,
che riflettono la strutturale connessione e convergenza oggettiva delle attività svolte in un’intrapresa
che sia frutto dell’opera comune». Deve naturalmente trattarsi di contributi non avulsi e
indipendenti uno dall’altro ma confluenti a produrre l’evento. L’eventuale requisito psicologico in
ogni caso non potrebbe che riferirsi «alla mera azione od omissione altrui di per sé considerata,
senza in alcun modo estendersi a tutti i requisiti oggettivi del fatto tipico ed in specie alla loro
efficacia causale rispetto all’evento consumativo del delitto che viene in considerazione».
Nel caso in esame la cooperazione è ravvisabile esistendo un «legame oggettivo e strutturale fra le
diverse azioni ed omissioni dei soggetti che hanno esercitato l’attività di direzione o controllo
dell’impresa o comunque assunto al suo interno posizioni di garanzia», che hanno dunque
indirizzato la loro attività ad un’unica «opera», mentre la corte di merito avrebbe illogicamente
omesso di considerare la convergenza strutturale delle diverse condotte contestate agli imputati
sviluppatesi in un ampio arco temporale ma convergenti perché concatenate «in senso sincronico e
diacronico» nell’unica direzione della gestione aziendale.
Ma secondo il ricorrente, anche accettando una concezione della cooperazione che abbia
riferimento alla consapevolezza della partecipazione degli altri agenti questa consapevolezza non
poteva mancare nel caso in esame nel quale ogni nuovo garante aveva coscienza delle scelte
organizzative precedenti con riferimento all’aver adibito i lavoratori alle elevate esposizioni a cvm
che avevano provocato gli eventi lesivi denunziati. Ciò anche quando l’EniChem è subentrata a
Montedison avendo conoscenza di tutte le situazioni rilevanti riguardanti la sicurezza anche nei
minimi dettagli con la conseguenza della piena consapevolezza delle situazioni di rischio cui i
lavoratori erano esposti.
Con il terzo motivo si denunzia invece l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 81, 2°
comma, in relazione all’art. 158, 1° comma, c.p., sul mancato riconoscimento della continuazione
tra i delitti di lesioni colpose in danno del ricorrente e quelli di omicidio colposo ed in particolare di
quello in danno di Faggian Tullio. Pur dando atto che la giurisprudenza di legittimità è
prevalentemente orientata in senso negativo (salvo i casi in cui l’agente abbia agito con la
previsione dell’evento o nei casi di colpa «impropria»: art. 47, 1° comma, e 59, ultimo comma, c.p.)
il ricorrente richiama la cospicua dottrina che segue invece un diverso orientamento. Nell’ambito
dei settori produttivi in esame i reati ipotizzabili, pur conservando la loro natura colposa, si
concretizzano in condotte «sorrette da requisiti psicologici reali di ‘ideazione, programmazione e
deliberazione’, che in quanto miranti al raggiungimento degli scopi di politica aziendale specifici ...
integrano requisito psicologico dell’unicità del disegno criminoso».
In capo a ciascun imputato va dunque riconosciuto, con l’assunzione del ruolo aziendale e la
realizzazione delle condotte contestate, «l’originaria ideazione, deliberazione e volizione di porle in
essere in tale gestione d’impresa». La condivisione di questo scopo criminoso rende «ravvisabile in
capo a ciascuno dei singoli imputati responsabili della pluralità di violazioni loro contestate, avendo
agito ciascuno nel perseguimento dei medesimi scopi aziendali».
Censurata anche sotto il profilo motivazionale la sentenza impugnata in punto continuazione il
ricorrente chiede, in conclusione, che in considerazione dell’applicazione dell’istituto della
continuazione il reato non sia ritenuto prescritto in quanto la prescrizione decorre dal momento
consumativo dell’ultimo fatto di reato contestato collocabile nel 2000.
b) L’esame dei motivi del ricorso Terrin. Anche per quanto riguarda le censure di Terrin va rilevata
la loro ammissibilità anche se dovesse ritenersi decorso il periodo di prescrizione (cosa che peraltro
il ricorrente contesta) posto che le censure proposte attengono ovviamente agli aspetti civilistici che
obbligano il giudice ad un esame completo della fattispecie penale e non limitato ai presupposti per
l’applicazione dell’art. 129 c.p.p.
Il reato in esame (se anche fossero superabili le argomentazioni della corte di merito sulla
causalità) dovrebbe essere ritenuto consumato nel 1993 (come incensurabilmente accertato dai
giudici di merito) e quindi alla data odierna dovrebbe essere ritenuto ampiamente prescritto anche
se il ricorrente tenta di superare l’ostacolo con la pretesa di ricollegare con la continuazione il reato
in esame all’omicidio colposo in danno di Faggian.
Ribadito che la censura è da ritenere assorbita dalla pronunzia sulla causalità si osserva peraltro che
la tesi proposta è da ritenere manifestamente infondata. Inutile citare giurisprudenza, di legittimità o
di merito, che sostenga l’applicabilità dell’istituto della continuazione ai reati colposi perché non si
rinviene alcuna decisione in questo senso. Le isolate affermazioni dottrinarie che sostengono questa
tesi sono smentite dalla semplice lettura dell’art. 81, cpv., c.p. che fa riferimento al «disegno
criminoso» e alla ricostruzione di questo elemento come rappresentazione anticipata del programma
criminoso per avere conferma che questi elementi possono connotare esclusivamente i reati dolosi.
Né può essere sostituito il collegamento della continuazione con la cooperazione colposa. A parte il
rilievo che non sono ben chiare le caratteristiche di decisività di questa ricostruzione ai fini che
interessano (e quindi il motivo di ricorso potrebbe essere ritenuto inammissibile per carenza di
interesse) va comunque osservato che la nozione di cooperazione colposa che il ricorrente propone
non è condivisibile; manifestamente infondato deve infatti ritenersi il tentativo del ricorrente di
individuare la natura della cooperazione colposa in un mero collegamento oggettivo del quale non
costituisca elemento costitutivo la consapevolezza dei singoli agenti della partecipazione di altri.
Com’è noto il tema della configurabilità del concorso di persone nel reato colposo è stato risolto,
dal legislatore del codice penale vigente, con l’introduzione della c.d. cooperazione colposa
disciplinata dall’art. 113 c.p. che, in realtà, non differenzia il trattamento sanzionatorio rispetto a
quello delle condotte indipendenti ma si limita a prevedere alcune aggravanti tipiche del concorso di
persone nel reato (doloso). Ciò che contraddistingue questa forma di concorso (detto anche
«improprio») è il legame psicologico che si instaura tra gli agenti ognuno dei quali è conscio della
condotta degli altri. Naturalmente la consapevolezza riguarda esclusivamente la partecipazione di
altri soggetti e non, come è ovvio trattandosi di reati colposi, il verificarsi dell’evento.
Per ritenere esistente la cooperazione colposa non è però richiesta la specifica coscienza o
conoscenza sia delle persone che cooperano sia delle specifiche condotte da ciascuno poste in
essere. Non ignora la corte che una corrente dottrinale sostiene che, per ipotizzare la cooperazione,
sia necessaria la consapevolezza anche della natura colposa dell’altrui condotta ma questa tesi (che
peraltro non influisce sulla decisione del caso che interessa) non è mai stata condivisa dalla dottrina
dominante che ha obiettato che, richiedendo questo requisito, la cooperazione sarebbe configurabile
solo nel caso di colpa cosciente.
Se, come è comunemente ritenuto, è invece sufficiente la coscienza dell’altrui partecipazione e non
è invece necessaria la conoscenza delle specifiche condotte né dell’identità dei partecipi non può
però trarsi la conclusione, sostenuta dal ricorrente, che la cooperazione sia ipotizzabile anche in
tutte le ipotesi nelle quali è presente un mero collegamento oggettivo perché, seguendo questa tesi,
verrebbe meno ogni differenza con il contiguo istituto delle condotte colpose indipendenti.
In conseguenza di quanto esposto anche i motivi sulla colpa contenuti nel ricorso di Terrin
Ferruccio devono essere rigettati.
Il rigetto dei motivi della ricorrente parte civile sulla colpa (e, come in precedenza esposto) sulla
causalità rende superfluo l’esame delle considerazioni contenute nella memoria dei dirigenti
EniChem (Terrin ha lavorato anche presso questa società oltre che presso la Montedison) i quali
hanno chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. (Omissis)
Capitolo III: esame dei motivi di ricorso sul reato di cui all’art. 437 c.p. — a) Premessa sul reato
previsto dall’art. 437 c.p. Il delitto previsto dall’art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di
cautele contro infortuni sul lavoro) è inserito, dal codice penale, tra i delitti contro l’incolumità
pubblica e nel capo dedicato ai «delitti di comune pericolo mediante violenza».
A differenza di altri reati ricompresi nel medesimo capo questa fattispecie di reato è prevista nella
sola forma dolosa; non può infatti essere ricompresa tra i delitti colposi di danno previsti dall’art.
449 c.p. che richiama soltanto l’incendio o gli altri disastri; il fatto tipico previsto dall’art. 437 non
rientra tra queste ipotesi (incendio o disastro) e il disastro è previsto soltanto nella fattispecie
aggravata di cui al 2° comma ma non nell’ipotesi base.
Non ben definiti sono invece i contorni della consapevolezza richiesta (in particolare si discute in
dottrina se debba essere conosciuta la destinazione della cautela alla prevenzione degli infortuni)
mentre condivisibile è da ritenere la critica rivolta dalla corte di merito alla sentenza di primo grado
nella parte in cui è stato ritenuto, dai primi giudici, che rientrassero nel fatto tipico solo gli impianti
ed apparecchi la cui destinazione sia esclusivamente quella di prevenzione degli infortuni (secondo
il tribunale la previsione si riferirebbe «a strumenti aventi specificamente ed unicamente la
destinazione alla sicurezza»).
Con argomentazioni condivisibili la corte di merito ha infatti evidenziato come questa limitazione
non sia prevista dalla norma e contrasti con le finalità di prevenzione della medesima. Deve quindi
confermarsi il giudizio di irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato in esame, della
circostanza che lo strumento adempia anche a diverse funzioni purché sia accertato che svolga
anche una funzione di prevenzione di infortuni e disastri.
Soluzione peraltro condivisa, anche recentemente, dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 20
aprile 2006, Simonetti e altri, id., Rep. 2006, voce Incolumità pubblica (reati e sanzioni), nn. 26-31
— in un’ipotesi riguardante la configurabilità dell’ipotesi di reato prevista dal 2° comma dell’art.
437 — secondo cui «nessuna norma, tra quelle contenute nel d.p.r. n. 547 del 1955, giustifica
l’affermazione che per ‘dispositivo antinfortunistico’ debba intendersi soltanto un dispositivo che
abbia esclusivamente funzioni antinfortunistiche, e non anche un dispositivo che, presentando
comunque indiscutibilmente una potenzialità antinfortunistica, svolga contemporaneamente anche
specifiche e magari rilevantissime funzioni tecniche, ai fini del funzionamento dell’impianto nel
quale tale dispositivo è inserito»).
Com’è noto i delitti contro l’incolumità pubblica si caratterizzano per la loro attitudine ad esporre a
rischio la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone. I danni alle cose non
costituiscono l’oggetto della tutela se non nei limiti in cui, dalla condotta, possa derivare un
pericolo per la vita e la sicurezza delle persone.
L’indeterminatezza della potenzialità offensiva dell’omissione (o della rimozione) delle cautele
conduce ad escludere che possa ipotizzarsi il reato in esame allorché l’omissione riguardi un singolo
e individuato lavoratore (per es. il datore di lavoro omette volutamente di fornire al suo dipendente
il mezzo di protezione) mentre sembra superato l’orientamento giurisprudenziale che riteneva
inapplicabile questa fattispecie di reato alle aziende di piccole dimensioni.
In dottrina, di questa categoria di reati — i reati di pericolo caratterizzati dal fatto che non è
necessario, per la consumazione del reato, che si verifichi l’evento (nel nostro caso un disastro o un
infortunio sul lavoro) — sono state individuate più sottospecie:
— i reati di «pericolo concreto» per i quali il pericolo per il bene protetto deve effettivamente
esistere e quindi in ogni caso deve esserne accertata in concreto l’esistenza;
— i reati di «pericolo astratto» nei quali il pericolo è ritenuto insito dalla legge nella condotta e il
giudice deve limitarsi a verificare la conformità della condotta descritta dalla legge a quella
accertata ma è consentita la prova contraria;
— i reati di «pericolo presunto» nei quali non è neppure consentita la prova contraria.
Quest’ultima categoria non è riconosciuta da tutti gli autori che spesso la riconducono alla seconda,
quella dei reati di pericolo astratto. V’è infatti chi, nel criticare la distinzione tra reati di pericolo
concreto e di pericolo astratto, precisa che l’unica distinzione consentita è quella tra reati di pericolo
concreto e quelli di pericolo presunto e afferma che «nei casi in cui si ravvisa un pericolo astratto,
in realtà non si ha una forma speciale di pericolo, ma una presunzione di pericolo, la quale non
ammette prova in contrario». Prova contraria evidentemente ammessa nei reati di pericolo concreto.
Tra coloro che accolgono invece la tripartizione tra reati di pericolo astratto, concreto e presunto vi
è chi così si esprime considerando «reati di pericolo concreto (o effettivo), per la sussistenza dei
quali il pericolo per il bene protetto deve effettivamente esistere, costituendo esso elemento tipico
‘espresso’ e dovendosi accertarne in ciascun caso la concreta esistenza».
Altri autori distinguono tra reati di pericolo concreto (o effettivo) e reati di pericolo presunto (o
astratto) e affermano che nei primi «il pericolo — in genere concepito come rilevante possibilità di
verificazione di un evento temuto — rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie
incriminatrice, onde spetta al giudice, in base alle circostanze concrete del singolo caso, accertarne
l’esistenza».
La giurisprudenza di legittimità (v. la recente Cass. 2 dicembre 2005, Strazzarino, ibid., n. 32, e, in
precedenza, sez. I 11 marzo 1998, Luciani, id., Rep. 1999, voce cit., n. 19; 20 novembre 1996,
Frusteri, id., Rep. 1997, voce cit., n. 23; 16 giugno 1995, Gencarelli, id., Rep. 1996, voce cit., n.
27), ritiene che il pericolo per la pubblica incolumità, per il reato in esame, non sia previsto come
elemento costitutivo del reato ma che debba ritenersi presunto (o astratto) nel senso che il
legislatore ha considerato la condotta tipica descritta nella norma come astrattamente idonea a
produrre gli effetti dannosi nei confronti di una comunità di lavoratori. Con la conseguenza che il
danno effettivamente verificatosi integra una fattispecie aggravata del reato (ma questa conclusione
è discussa) mentre il reato base, nella fattispecie omissiva, è catalogabile tra i reati omissivi propri.
b) L’esame dei motivi di ricorso relativi al periodo fino al 1973. Si è già detto che il procuratore
generale, e le parti civili che hanno proposto analoghe censure, si dolgono della statuizione della
corte d’appello che ha assolto gli imputati dal delitto in esame, per il periodo fino a tutto il 1973,
con la formula «perché il fatto non costituisce reato».
In sintesi con i motivi di ricorso da queste parti proposti ci si duole dell’affermazione secondo cui,
prima del 1974, non può parlarsi di dolo perché, si dice nelle proposte censure, la natura dannosa
per la salute umana e la cancerogenicità del cvm erano conosciute anche negli anni precedenti.
I motivi sono peraltro infondati. Va premesso in particolare che non esiste la lamentata
contraddittorietà tra le affermazioni in tema di causalità dei giudici di merito e l’esclusione del dolo
per il periodo indicato e comunque si tratta di comparazione tra concetti non omogenei (causalità e
colpevolezza).
Semmai la comparazione andrebbe fatta tra quanto la corte di merito ha affermato sul tema della
colpa per gli omicidi e le lesioni colpose e quanto ha ritenuto in merito alla violazione dell’art. 437
c.p. posto che, in tema di accertamento della causalità, possono e debbono essere utilizzati criteri
diversi: per l’accertamento della causalità può tenersi conto delle conoscenze successive alla
condotta mentre ciò non è consentito per l’accertamento della colpa.
Orbene le considerazioni in precedenza riportate, e contenute nella sentenza oggi impugnata,
dimostrano che agli imputati Bartalini, Calvi, Grandi, Gatti e D’Arminio Monforte (assolti in
appello dal reato di cui all’art. 437 c.p. fino al 1973 perché il fatto non costituisce reato) è stato
addebitato di aver sottovalutato le conoscenze che indicavano la potenzialità lesiva del cvm ed in
particolare gli studi di Viola procedendo, invece che agli interventi di modifica e ristrutturazione
degli impianti (peraltro già necessari per la situazione di illegalità in cui già si trovava la
Montedison), ad un adempimento conoscitivo certo opportuno che però non poteva essere
sostitutivo degli interventi richiesti.
È quindi del tutto logica la considerazione del secondo giudice che ha ricostruito l’addebito nei
confronti degli imputati come un’ipotesi di negligenza (e non di errore sull’obbligo di attivarsi
come si sostiene nel ricorso della parte civile Terrin) ben potendo, la condotta dei medesimi, essere
stata determinata dalla convinzione (colpevole ma non dolosa) dell’esclusione della pericolosità
dell’esposizione e dalla sottovalutazione degli elementi concreti che consentivano di prevedere un
possibile effetto cancerogeno del cloruro di vinile. È pertanto corretto affermare che si tratta di
condotta negligente, e quindi colposa, ma non idonea a configurare, pur essendo cosciente e
volontaria, un’ipotesi di volontaria omissione consapevole del rischio oncogenico dell’esposizione.
La natura dolosa dell’ipotesi di reato in questione richiede infatti che l’agente, cui sia addebitabile
la condotta omissiva o commissiva, sia consapevole che la cautela che non adotta — o quella che
rimuove — servano (oltre che per eventuali altri usi) per evitare il verificarsi di eventi dannosi
(infortuni o disastri).
Se la condotta, pur tipica secondo la descrizione contenuta nell’art. 437 c.p., è adottata senza la
consapevolezza della sua idoneità a creare la situazione di pericolo non può essere ritenuto esistente
il dolo che richiede una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta dell’agente
anche nel caso in cui queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate (v., sul tema del
dolo nel reato di cui all’art. 437, sia pure con qualche differenziazione, Cass. 1° settembre 1994,
Arienti, id., Rep. 1995, voce Reato in genere, n. 27; 19 novembre 1993, Chiavarini, id., 1995, II,
126).
Analoghe considerazioni vanno fatte per quanto riguarda i motivi di ricorso delle parti civili
A.LL.C.A. e Confederazione unitaria di base (Cub) nei quali si fonda l’affermazione dell’esistenza
del dolo sulla circostanza che, anche anteriormente al 1974, erano conosciuti gli effetti tossici del
cvm. Non si tiene infatti conto, nel proporre queste censure, che il dolo, sia pure generico, richiesto
dalla fattispecie di reato in esame, richiede la consapevolezza di omettere una cautela idonea ad
evitare l’evento lesivo e che non è sufficiente la consapevolezza di omettere una cautela quando
esista la convinzione che l’evento non si verificherà (convinzione incensurabilmente ritenuta
accertata dai giudici di merito).
In realtà le censure rivolte alla sentenza impugnata per aver negato l’esistenza del dolo fino al 1973
nella sostanza riproducono simmetricamente gli argomenti cui si è fatto riferimento sul tema della
prevedibilità. Si dice: poiché erano conosciuti gli effetti dannosi sulla salute delle persone esposte e,
da un certo momento in avanti, anche gli effetti cancerogeni del cvm, gli imputati erano coscienti
che la mancata adozione delle cautele richieste avrebbe potuto cagionare gli eventi lesivi. Ma non è
così: quegli studi avrebbero dovuto convincere gli agenti che esisteva un grave rischio per la salute;
essi avrebbero quindi dovuto prevedere che si sarebbero potuti verificare eventi dannosi e non
hanno fatto quanto necessario per evitarlo.
Insomma gli imputati sono stati negligenti (ma non dolosamente consapevoli) perché hanno
sottovalutato segnali inquietanti che avrebbero dovuto indurli ad operare diversamente ma non
hanno consapevolmente accettato (sia pure sotto il profilo del dolo eventuale) che questi eventi
dannosi si verificassero.
In conclusione, premesso che l’accertamento sull’esistenza del dolo è comunque compito del
giudice di merito che, nel caso in esame, l’ha condotto secondo corretti criteri logico-giuridici non
può che affermarsi l’incensurabilità della motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
Superfluo aggiungere che, per questa ipotesi di reato (quella prevista dall’art. 437), diviene
irrilevante — una volta esclusa l’ipotesi base prevista dal 1° comma dell’art. 437 c.p. — affrontare
il problema, prospettato nel primo ricorso del p.g., con il quale si chiede che venga affermato che
l’ipotesi prevista dal 2° comma costituisce un’ipotesi autonoma di reato e non un’aggravante.
Svincolata dall’ipotesi base la fattispecie sarebbe in astratto autonomamente configurabile come
ipotesi autonoma di disastro innominato «interno» per il quale esiste autonoma imputazione.
I motivi relativi all’esistenza del disastro «interno» autonomamente considerato andranno quindi di
seguito esaminati.
c) Il periodo successivo al 1973. Si è visto che la sentenza impugnata ha escluso l’ipotesi di reato in
esame, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, per il periodo dal 1974 in avanti,
avendo ritenuto adeguati gli interventi per ridurre le emissioni nocive con l’unico dubbio residuo
relativo all’installazione degli aspiratori — che risultano attivi e funzionanti solo dal 1980 in avanti
— e in relazione alla cui mancata installazione il reato di cui all’art. 437 c.p. è stato dichiarato
estinto ai fini penali per prescrizione non essendo evidente l’innocenza degli imputati (anche sotto il
profilo soggettivo essendo all’epoca ormai conclamati anche gli effetti cancerogeni del cvm, il che
rende astrattamente plausibile l’affermazione di una condotta dolosa sia pure sotto il profilo del
dolo eventuale).
Il procuratore generale, con il secondo ricorso proposto, la presidenza del consiglio dei ministri e il
ministero dell’ambiente, contestano le conclusioni della corte, con le argomentazioni in precedenza
riassunte, sostanzialmente sotto due profili:
1) non sarebbe stata data risposta alle censure contenute nell’appello del p.m. sulla ritenuta
elusione, rimozione o blocco doloso del sistema di monitoraggio gascromatografico del cvm (nel
periodo 1991-1995) con comportamenti fraudolenti consistiti nell’abbassamento della soglia di
misura dell’allarme da 30 a 25 ppm, nell’inserimento di stringhe di comando informatico che
impedivano la registrazione delle misure realmente effettuate nelle zone più a rischio,
nell’inserimento di uno speciale interruttore che consentiva di scollegare il gascromatografo dallo
strumento che consentiva la registrazione della misura effettuata dal gascromatografo.
I motivi di ricorso — che, per la convergenza delle censure proposte possono essere esaminati
congiuntamente e unitamente ai motivi aggiunti di entrambi gli enti — sono peraltro infondati.
Non è infatti vero che la corte di merito — che non ha fondato la sua decisione sull’asserita non
configurabilità dell’ipotesi di reato in esame nel caso di condotte elusive come sostiene l’avvocatura
dello Stato — non abbia dato alcuna risposta alle censure proposte con i motivi d’appello sui punti
in precedenza indicati.
La corte riproduce infatti integralmente le considerazioni del tribunale sull’efficienza del sistema di
monitoraggio e afferma di condividerle integralmente. Esamina poi i motivi di ricorso del p.m.
rilevando: 1) che il sistema appariva conforme alla normativa vigente (d.p.r. 962/82); 2) che le
denunziate carenze si fondavano su asserite manchevolezze «tecnicamente non convincenti»; 3) che
alcune delle irregolarità denunziate si fondavano su accuse non suffragate da convincenti dati
tecnici o su sospetti non comprovati (l’asserito utilizzo di un dispositivo per eliminare rilevazioni
non gradite) o su un’erronea interpretazione dei dati (per es. quelli relativi alle giornate nelle quali il
sistema non aveva funzionato e che la corte ritiene invece siano state correttamente considerate
come mancanti di prelievi).
Aggiunge la corte che il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio automatico è
confermato dalla sostanziale omogeneità dei dati acquisiti con i campionatori individuali indossati
(nel periodo marzo 1976 - luglio 1980) da dipendenti che operavano in vari reparti. E neppure si è
sottratta, la sentenza impugnata, all’esame della rilevanza delle temporanee e periodiche disfunzioni
che si sono verificate nel corso degli anni nel funzionamento dell’impianto di monitoraggio delle
quali la corte, con motivata valutazione, ha accertato il carattere sporadico ritenendo altresì che
l’abbassamento della soglia costituisse un adeguamento a logica di maggiore prudenza.
È vero che la sentenza non affronta espressamente (evidentemente inserendolo nei casi
complessivamente considerati di cui ha ritenuto la sporadicità) il caso di una prolungata fuga di gas,
verificatasi dal 3 al 26 marzo 1993, ma il ricorrente non indica le ragioni (che dovrebbero avere
carattere di decisività) idonee a confermare una omissione dolosa di cautele (o la rimozione delle
medesime) per cui, anche nella prospettazione del ricorrente, non emergono elementi idonei a far
ritenere dolosa la condotta.
Anzi la circostanza che il fatto si sia verificato in un periodo in cui tutte le cautele, ritenute idonee
dai giudici di merito, erano in funzione fa ritenere ragionevole e conseguente la conclusione (che
costituisce una valutazione di merito che peraltro appare implicita nella sentenza impugnata) che
l’episodio si sia verificato non per scelta deliberata ma per negligenza e imperizia (verosimilmente
per un’inadeguata manutenzione dell’impianto) e quindi non come conseguenza delle condotte
tipiche (e consapevoli) indicate nell’art. 437 c.p.
In relazione a questi fatti verificatisi nel 1993 deve darsi atto dei rilievi contenuti nella memoria
depositata dal difensore di Trapasso Italo nel quale si rileva che la statuizione del primo giudice —
di assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste» — era divenuta definitiva. In realtà
l’appello del p.m. non aveva consentito la formazione del giudicato ma è fondato il rilievo che le
funzioni svolte da Trapasso presso il petrolchimico risultano cessate nell’ottobre 1988 (in base alla
formulazione dell’imputazione) e ciò costituisce ulteriore ragione d’infondatezza del ricorso del p.g.
2) Il secondo profilo di censura riguarda l’esclusione dell’ipotesi del disastro prevista dal 2°
comma dell’art. 437 c.p. ma l’esclusione dell’ipotesi di reato base rende irrilevanti, come si è già
visto, le censure proposte sul punto. Se non sussiste l’ipotesi di reato prevista dal 1° comma non è
neppure astrattamente configurabile, per ovvie ragioni, l’ipotesi aggravata.
La censura potrebbe ritenersi ammissibile solo per quanto attiene alla limitata ipotesi nella quale il
reato in questione è stato dichiarato estinto per prescrizione (omessa collocazione degli impianti di
aspirazione fino al 1980). Ma, nelle censure proposte dal p.g., non si ipotizza l’ipotesi aggravata con
il riferimento a questa omissione di cautele e comunque la soluzione non muterebbe atteso che,
trattandosi di reato la cui consumazione è terminata nel 1980, dovrebbe ritenersi decorso il termine
di prescrizione anche nel caso in cui fosse ipotizzata l’ipotesi aggravata.
Queste conclusioni rendono superfluo l’esame delle controdeduzioni contenute nella memoria
depositata nell’interesse dei dirigenti EniChem (Pisani, Smai, Palmieri, Parillo, Burrai, Presotto,
Porta, Necci e Zerbo) i quali — con le argomentazioni già in precedenza riassunte — hanno chiesto
che il ricorso del procuratore generale venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato
richiamando argomentazioni in parte coincidenti con quelle qui espresse ed in parte altre
argomentazioni il cui rilievo viene meno a seguito della decisione di rigetto del secondo ricorso del
p.g.
d) Il ricorso di Presotto Cirillo. Alcuni dei motivi contenuti in questo ricorso vengono esaminati in
questa parte della motivazione perché il primo motivo del ricorso proposto da Presotto Cirillo
riguarda la possibilità di configurare nei suoi confronti l’ipotesi di reato prevista dall’art. 437 c.p.
per la quale in relazione all’omessa installazione degli impianti di aspirazione, dal 1974 al 1980 la
Corte d’appello di Venezia ha dichiarato non doversi procedere (anche) nei suoi confronti per essere
il reato estinto per prescrizione.
Presotto deduce infatti l’inosservanza della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità
della motivazione, in relazione all’esistenza dell’obbligo d’installazione degli impianti di
aspirazione nel corso degli anni settanta. La censura riguarda in particolare l’esistenza di una
posizione di garanzia in capo al ricorrente che non è mai stato dipendente del gruppo Montedison
che ha gestito gli impianti fino al 1° giugno 1987. Il ricorrente, dipendente del gruppo EniChem,
solo da questa data avrebbe potuto assumere la posizione di garanzia ma l’addebito riguarda il
periodo fino al 1980. La mancata installazione delle cappe di aspirazione non poteva quindi essergli
addebitata.
Questa successione nella titolarità degli impianti risulta dalla stessa sentenza impugnata ne può
avere rilievo la circostanza che Presotto fosse responsabile della produzione della divisione chimica
di base della società Anic dal gennaio 1979 al dicembre 1980 perché l’Anic acquisirà gli impianti di
Porto Marghera solo tre anni dopo.
Con i motivi nuovi, presentati ai sensi della l. n. 46, si sottolinea che questa successione nella
titolarità degli impianti risulta dalla stessa sentenza impugnata e dagli atti che vengono
specificamente indicati nei motivi aggiunti e allegati alle note di udienza depositate davanti alla
corte d’appello il 28 ottobre 2004 dai quali risulta che EniChem ha assunto la gestione degli
impianti solo dal 1° giugno 1987.
Il ricorso, sotto il profilo dell’esistenza di una posizione di garanzia di Presotto, è fondato.
Risulta dalla sentenza d’appello (all. A riguardante le qualità degli imputati) che Presotto è stato
dirigente del gruppo Eni e responsabile di produzione della divisione chimica di base della soc.
Anic dal gennaio 1979 al dicembre 1980; direttore della medesima divisione dal gennaio 1981 al
febbraio 1985; amministratore delegato delle società EniChem Polimeri e EniChem Base dal marzo
1986 all’ottobre 1987 (oltre altre qualità svolte successivamente che non interessano).
Risulta inoltre dalla medesima sentenza, che richiama quella di primo grado, che la soc. EniChem è
subentrata nel 1987 alla soc. Montedison nella gestione degli impianti di lavorazione del cvm.
Poiché non risulta da alcuna parte delle sentenze di merito, che in precedenza Presotto abbia
lavorato alle dipendenze di Montedison né che le società Eni ed Anic, presso le quali ha svolto
funzioni dirigenziali o ricoperto cariche sociali, abbiano gestito prima del 1980 gli impianti in
questione, evidente appare l’estraneità del ricorrente alla condotta contestatagli che si riferisce al
periodo 1974-1980.
Con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, deve pronunziarsi nei suoi confronti,
da parte di questa corte, sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. (Omissis)
d) Esame dei motivi di ricorso. Premessa. Alcune delle censure formulate nei motivi di ricorso in
precedenza riassunti appaiono fondate anche se non conducono ad una soluzione diversa rispetto a
quella adottata nella sentenza impugnata.
Va però premesso che questa corte si trova ad esaminare censure rivolte ad una decisione su reati
per i quali non è ben chiara la formulazione anche per la commistione tra le due ipotesi di disastro
innominato che risultano formulate nei due capi d’imputazione.
L’imputazione formulata nel giudizio di primo grado era chiara: si ravvisavano due ipotesi di
disastro, quello c.d. «interno» allo stabilimento del petrolchimico con riferimento alla situazione
ambientale creatasi all’interno della struttura che aveva provocato i decessi e le lesioni alle quali si è
più volte fatto riferimento. E un disastro «esterno» riferito alla situazione d’inquinamento
ambientale dei siti su cui insiste il petrolchimico, di quelli prossimi nonché delle falde acquifere,
delle acque lagunari e dell’atmosfera.
Altrettanto chiara la soluzione adottata sul punto dal Tribunale di Venezia che ha ravvisato
l’esistenza degli elementi oggettivi di questo reato — per quanto riguarda il disastro «interno» —
per il periodo fino al 1973 escludendo però l’elemento soggettivo e quindi assolvendo gli imputati
con la formula «perché il fatto non costituisce reato».
Per gli imputati si è quindi creata, per quanto attiene agli aspetti penali, la preclusione (se non si
vuol parlare di giudicato interno) non avendo i medesimi appellato la sentenza su questo punto della
decisione (esistenza dell’elemento oggettivo del reato di disastro colposo innominato interno — o
del fatto tipico se si accede alla concezione tripartita — per il periodo fino a tutto il 1973).
Meno chiara è la situazione dopo la sentenza d’appello. I giudici della corte veneziana precisano
infatti che, a seguito della modifica dell’imputazione operata dal pubblico ministero nel giudizio di
primo grado, sarebbe stato configurato, nelle ipotesi di accusa anche con riferimento all’appello del
p.m., un unico disastro rilevante sia ai fini dell’ipotesi prevista dal 2° comma dell’art. 437 c.p. sia
con riferimento ad un’ipotesi unica di disastro interno ed esterno.
In realtà la lettura dei capi d’imputazione contenuti nella sentenza di secondo grado (che la corte,
accogliendo il rilievo del p.m. appellante, precisa essere quelli risultanti dalle modificazioni e
integrazioni operate nel giudizio di primo grado al cui esito la sentenza emessa riportava invece
quelli originari) non giustifica questa interpretazione perché se è vero che nel primo capo
d’imputazione (che riguarda i fatti interni allo stabilimento) sono state inserite contestazioni che
riguardano anche il disastro esterno, è altrettanto vero che non risulta formulata un’imputazione
comune per un unico disastro.
Con la conseguente correttezza della soluzione adottata dalla corte di merito che ha continuato a
ritenere distinte le imputazioni anche dopo la loro riformulazione. E l’ulteriore conseguenza che i
riferimenti al disastro esterno, contenuti nella prima imputazione, vanno esaminati nella parte che
riguarda i motivi attinenti al secondo capo d’imputazione.
e) Esame dei motivi di ricorso. Reato di danno o di pericolo. Il «macroevento». La più parte delle
censure formulate dalle parti civili ricorrenti (non vi sono censure sul disastro nei ricorsi del
procuratore generale) riguardano la natura del reato di disastro colposo innominato che tutti i
ricorrenti vorrebbero inquadrare tra i reati di pericolo.
Queste censure sono peraltro infondate. È sufficiente leggere l’art. 449 c.p. (la cui rubrica è
significativamente formulata come «delitti colposi di danno») — laddove così descrive la condotta
tipica: «chiunque ... cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto ...» — per rendersi
conto che, perché possa ritenersi integrata questa fattispecie di reato, occorre che il disastro si
verifichi.
Condivisibile appare dunque il percorso argomentativo seguìto dalla corte di merito in particolare
nella parte in cui sottolinea la differenza con l’ipotesi dolosa nella quale, per il disposto del 1°
comma dell’art. 434, la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo
per la pubblica incolumità (salvo che possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dal 2° comma
quando il disastro in concreto si verifichi).
Meno convincente appare invece l’affermazione della corte di merito secondo cui, per potersi
configurare l’ipotesi del disastro innominato, previsto dall’art. 434 c.p., sia necessario il verificarsi
di un «macroevento» se con questa definizione s’intende fare riferimento ad eventi analoghi a quelli
che la sentenza impugnata richiama come esempi significativi del macroevento («sia un incendio
che devasta quanto incontra, sia il naufragio di una nave, la caduta di un aeromobile, il
deragliamento di un treno, il crollo di un edificio, o quant’altro abbia appunto queste caratteristiche
che i casi tipici individuati dal legislatore fanno cogliere»).
Orbene se si richiede che il disastro «innominato» previsto dall’art. 434 c.p. abbia le caratteristiche
oggettive tipiche dei fatti disastrosi addotti come esempio dalla corte di merito l’affermazione non
può essere condivisa. Quegli eventi sono infatti caratterizzati da un fatto tipico che si esaurisce, di
per sé stesso (non gli effetti che possono perdurare per lungo tempo), in un arco di tempo assai
ristretto e con il verificarsi di un evento di grande evidenza immediata (il crollo, il naufragio, il
deragliamento, ecc.).
Ma il disastro può anche non avere queste caratteristiche di immediatezza perché può realizzarsi in
un arco di tempo anche molto prolungato, senza che si verifichi un evento disastroso
immediatamente percepibile e purché si verifichi quella compromissione delle caratteristiche di
sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di
affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità.
Questa situazione può anche essere qualificata «macroevento» purché si precisi che la
compromissione di cui trattasi (riguardi la situazione ambientale o un luogo diverso quale
l’ambiente di lavoro o altra situazione tipica prevista dalla legge) può avere caratteristiche di durata
che non richiedono il verificarsi di un evento eccezionale dotato di caratteristiche d’immediatezza.
Del resto non tutte le ipotesi di disastro previste dal capo I del titolo VI c.p. (delitti contro
l’incolumità pubblica) hanno le caratteristiche cui la corte di merito sembra fare riferimento (per es.
la frana — art. 426 — può consistere in spostamenti impercettibili che durano anni; l’inondazione
può consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi).
Questa, peraltro, è anche la condivisibile interpretazione che il tribunale ha dato del disastro
innominato quando ha assolto per mancanza dell’elemento soggettivo gli imputati di questo reato
ravvisando quindi l’esistenza degli elementi oggettivi del reato con particolare riferimento alla
ravvisata tipicità del fatto accertato ed in particolare dell’evento verificatosi (così si esprime la
sentenza di primo grado: «nel caso che ci occupa il rischio costituito dall’esposizione a cvm ha
causato gli otto angiosarcomi contestati ... in tal modo dimostrando di avere idoneità lesiva
dell’integrità fisica e di avere efficienza diffusiva nell’ambito della comunità dei lavoratori esposti
alle alte dosi di tale sostanza e addetti alle mansioni più a rischio ... Con la conseguenza che tale
reato è causalmente riferibile a quegli imputati che ricoprivano nell’epoca in considerazione (1969-
1973) posizioni di garanzia ...»).
f) Conclusioni sul disastro fino al 1973. Così delineato l’ambito delle statuizioni di merito sul
disastro innominato interno le conclusioni da trarre sono le seguenti.
Per il periodo fino a tutto il 1973 la situazione accertata dal primo giudizio era corrispondente alla
tipicità oggettiva del delitto di disastro dal quale gli imputati sono stati assolti per mancanza
dell’elemento soggettivo.
Pur in mancanza d’appello degli imputati la corte di merito sembra aver rimesso in discussione,
anche ai fini penali, l’esistenza degli elementi oggettivi del disastro perché, se l’interpretazione che
se ne è data è corretta, ha ritenuto necessaria l’esistenza del «macroevento» anche per il periodo
anteriore al 1974. Accertamento che non doveva, e neppure poteva, compiere perché per gli
imputati si era formata una preclusione conseguente al non aver appellato la sentenza; le parti civili,
ovviamente, non avevano alcun interesse a porre in discussione un elemento a loro favorevole.
In mancanza di appello degli imputati la corte avrebbe dovuto limitare il suo esame, ai soli fini
civili, alle censure proposte con gli appelli delle parti civili limitatamente all’esistenza
dell’elemento soggettivo. La sentenza impugnata infatti alcun accenno fa all’esistenza della colpa
nel periodo anteriore al 1974 limitandosi invece ad esaminare le censure che si riferiscono alla
natura del reato (di danno o di pericolo) e alla necessità di accertare l’esistenza del macroevento.
Ma questi problemi erano da ritenere superati dalla decisione (non appellata dagli imputati) dei
primi giudici che, dopo aver riconosciuto gli elementi obiettivi del reato, avevano invece posto in
discussione esclusivamente l’esistenza dell’elemento soggettivo. Il giudice d’appello avrebbe quindi
dovuto limitare il suo esame all’esistenza della colpa — essendone stato investito dalle
impugnazioni del pubblico ministero e delle parti civili — con l’ovvia conseguenza della necessità
di verificare se dovessero coerentemente essere estese al reato in esame le considerazioni sulla
colpa espresse nell’esame dell’elemento soggettivo per i reati di omicidio e lesioni colposi.
Ma l’esame dei motivi di ricorso delle parti civili non consente di affermare che il punto della
sentenza impugnata (pur mancante) riferibile all’esistenza dell’elemento soggettivo abbia formato
oggetto di ricorso in Cassazione essendosi, le parti civili, limitate a dolersi dei soli punti della
sentenza riguardanti la natura di reato di pericolo o di danno del disastro colposo e il tema della
necessità del «macroevento».
È vero che in alcuni ricorsi si fa cenno all’elemento della colpa (nel secondo motivo del ricorso
Legambiente; nel quinto motivo Camera del lavoro e Filcea; nel quinto motivo Ust Cisl; nel quarto
motivo dei ricorsi Ros Graziella e Checchin Luca e altri; nel quarto motivo Canazza Iole e altri; nel
terzo motivo Lino Giuliana e altri; nel quarto motivo Teresa Barbiero e altri; nel quarto motivo
regione Veneto e comune di Venezia; nel sesto motivo della provincia di Venezia).
Ma in nessuno di questi motivi si censura la sentenza impugnata per vizi di violazione di legge, o
attinenti alla motivazione, riguardanti l’esistenza dell’elemento soggettivo riferito alle condotte
tenute fino al 1973.
Le censure sono tutte specificamente rivolte ai punti che la corte d’appello non avrebbe più potuto
esaminare, in mancanza d’appello degli imputati (tutti gli aspetti che si riferiscono all’elemento
oggettivo o alla tipicità), e non riguardano specificamente il vizio ancora deducibile riferito alla
colpevolezza sul quale la corte non si è pronunziata (ovvero, se si dovesse ritenere l’esistenza di una
pronunzia implicita, l’avrebbe fatto condividendo la pronunzia di primo grado).
Dal che consegue che la statuizione sull’esistenza del disastro innominato interno formulata dai
primi giudici — assoluzione con la formula «perché il fatto non costituisce reato» — deve ritenersi
definitiva: quanto all’elemento oggettivo perché l’accertamento positivo della sua esistenza non ha
formato oggetto d’appello da parte degli imputati (gli unici ad averne interesse); quanto
all’elemento soggettivo perché le parti civili non hanno investito, con i loro ricorsi, la mancanza di
motivazione su tale elemento o l’implicita condivisione della statuizione dei primi giudici.
g) Conclusioni sul disastro «interno» per il periodo successivo al 1973. Analoghe sono le
conclusioni della corte di merito per quanto riguarda il periodo dal 1974 in avanti. La corte fonda il
suo convincimento sull’esclusione dell’ipotesi di reato in esame sull’inesistenza del «macroevento»
(e in questo caso poteva farlo perché i primi giudici avevano proprio escluso il fatto tipico) ma
richiama altresì la sentenza di primo grado che aveva escluso che potessero configurarsi, da un
punto di vista oggettivo, gli estremi del disastro innominato colposo per l’opera avviata dalla
dirigenza Montedison che, nell’arco di alcuni anni, portò ad una drastica limitazione delle
esposizioni a cvm nei confronti dei lavoratori addetti agli impianti.
Se dunque, per quanto riguarda questo periodo, possono confermarsi i dubbi in precedenza
formulati sulla necessità dell’esistenza del «macroevento» le ulteriori considerazioni della corte di
merito che richiama, condividendole, quelle dei primi giudici consentono di ritenere infondate le
censure rivolte contro la decisione impugnata.
L’accertamento in fatto e la valutazione di merito dei giudici d’appello sull’inesistenza del disastro
per il periodo dal 1974 in avanti sono infatti sostenuti da congrua e logica motivazione idonea a
dimostrare l’inesistenza del fatto tipico contestato.
D’altro canto la sola circostanza che non si siano verificati decessi ricollegabili all’esposizione a
cvm per gli assunti dopo questa data è sicuro indice della correttezza della soluzione adottata dai
giudici di merito. (Omissis)
Potrebbero piacerti anche
- Taruffo La Prova Del Nesso CausaleDocumento9 pagineTaruffo La Prova Del Nesso CausaleEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- Da Balduzzi A GelliDocumento34 pagineDa Balduzzi A GelliSalvatore ProcopioNessuna valutazione finora
- Domande Diritto Penale Prof Valentina MasaroneDocumento28 pagineDomande Diritto Penale Prof Valentina MasaroneFrancesca FalcoNessuna valutazione finora
- Il Nesso Di Causalita Nella ResponsabiliDocumento9 pagineIl Nesso Di Causalita Nella ResponsabilitrevotjeanNessuna valutazione finora
- DISPENSA STELLA-d.penaleDocumento55 pagineDISPENSA STELLA-d.penaleElisa D'AliaNessuna valutazione finora
- La Prova Del Dna e Il Ruolo Degli Esperti Nel Processo PenaleDocumento49 pagineLa Prova Del Dna e Il Ruolo Degli Esperti Nel Processo PenaleBenny FerraroNessuna valutazione finora
- La Vicinanza Della ProvaDocumento19 pagineLa Vicinanza Della ProvaCristinaNessuna valutazione finora
- Investigazioni Scientifiche Biologia Forense Genetica Forense e Catena Di CustodiaDocumento3 pagineInvestigazioni Scientifiche Biologia Forense Genetica Forense e Catena Di CustodiathalesNessuna valutazione finora
- SANZIONI AMMINISTRATIVE I presupposti, il ricorso e il giudizio di opposizione: Le sanzioni amministrative e il covid 19Da EverandSANZIONI AMMINISTRATIVE I presupposti, il ricorso e il giudizio di opposizione: Le sanzioni amministrative e il covid 19Nessuna valutazione finora
- Vulnerabilità, carcere e nuove tecnologie: Prospettive di ricerca sul diritto alla saluteDa EverandVulnerabilità, carcere e nuove tecnologie: Prospettive di ricerca sul diritto alla saluteNessuna valutazione finora
- Fascino e Insidie Della Prova ScientificaDocumento17 pagineFascino e Insidie Della Prova ScientificaSergio LorussoNessuna valutazione finora
- Medicina LegaleDocumento103 pagineMedicina LegaleTiziano Licata100% (1)
- 719888IUS17 Donini PriDocumento14 pagine719888IUS17 Donini PriGenovese CarlaNessuna valutazione finora
- Corsi, Giancarlo - Diritto (Baraldi Corsi Esposito, Luhmann in Glossario)Documento2 pagineCorsi, Giancarlo - Diritto (Baraldi Corsi Esposito, Luhmann in Glossario)RafaelBluskyNessuna valutazione finora
- Giusto Processo e Verita GiudizialeDocumento13 pagineGiusto Processo e Verita GiudizialeAlex Rodríguez OrtizNessuna valutazione finora
- Impregilo Bis - Piergallini - 2022 - SPDocumento14 pagineImpregilo Bis - Piergallini - 2022 - SPAlessandro NaviglioNessuna valutazione finora
- Medlegbs 3Documento84 pagineMedlegbs 3cicleo74Nessuna valutazione finora
- Giustizia e Modernità Manuale StellaDocumento46 pagineGiustizia e Modernità Manuale StellanicNessuna valutazione finora
- Chiavario 2006Documento10 pagineChiavario 2006felipebdelimaNessuna valutazione finora
- CSMQuaderno Procedimento Monitorio OpposizioneDocumento51 pagineCSMQuaderno Procedimento Monitorio OpposizioneLawrence BoschettiNessuna valutazione finora
- Graziosi ''Contro L'utilizzabilità Delle Prove Nel Processo Civile''Documento27 pagineGraziosi ''Contro L'utilizzabilità Delle Prove Nel Processo Civile''Sara PrestigiacomoNessuna valutazione finora
- ESAME AVVOCATO. CASI DI DIRITTO PENALE (edizione 2022): Risolti con soluzioni schematiche Edizione 2022Da EverandESAME AVVOCATO. CASI DI DIRITTO PENALE (edizione 2022): Risolti con soluzioni schematiche Edizione 2022Nessuna valutazione finora
- Il Danno Da Perdita Di Chances EvoluzionDocumento29 pagineIl Danno Da Perdita Di Chances EvoluzionPrévôtManuelNessuna valutazione finora
- A Proposito Di Carlo Ruga Riva, I Nuovi Ecoreati, Commento Alla Legge 22 Maggio 2015, N. 68, Torino, Giappichelli, 2015 AMARELLI - 2015a PDFDocumento14 pagineA Proposito Di Carlo Ruga Riva, I Nuovi Ecoreati, Commento Alla Legge 22 Maggio 2015, N. 68, Torino, Giappichelli, 2015 AMARELLI - 2015a PDFBenny FerraroNessuna valutazione finora
- Riassunti Di Medicina LegaleDocumento45 pagineRiassunti Di Medicina LegaleGreta Venturelli100% (1)
- Parte Speciale - Poteri Probatori Del Giudice e Diritto Alla ProvaDocumento16 pagineParte Speciale - Poteri Probatori Del Giudice e Diritto Alla ProvaSindyNessuna valutazione finora
- Giusto Processo e Verita GiudizialeDocumento13 pagineGiusto Processo e Verita GiudizialePollo899Nessuna valutazione finora
- Tonini PDFDocumento74 pagineTonini PDFMichele Pozzo100% (2)
- Collaboratori di giustizia e delitti di criminalità organizzata: luci ed ombre del regime penitenziario premialeDa EverandCollaboratori di giustizia e delitti di criminalità organizzata: luci ed ombre del regime penitenziario premialeNessuna valutazione finora
- Diagramma Di IPHIKAWADocumento18 pagineDiagramma Di IPHIKAWApoianadellachianaNessuna valutazione finora
- La contrattazione collettiva e la qualificazione dei rapporti di lavoroDa EverandLa contrattazione collettiva e la qualificazione dei rapporti di lavoroNessuna valutazione finora
- L'ordine di esame dei motivi di ricorso nel processo amministrativoDa EverandL'ordine di esame dei motivi di ricorso nel processo amministrativoNessuna valutazione finora
- La Valutazione Di Credibilità Come StrumentoDocumento21 pagineLa Valutazione Di Credibilità Come StrumentoMarioNessuna valutazione finora
- Criminologia Applicata Di Concetta MacriDocumento29 pagineCriminologia Applicata Di Concetta MacriAbigail ObregónNessuna valutazione finora
- Docsity Procedura Penale Tonini Sintesi 2021 22Documento187 pagineDocsity Procedura Penale Tonini Sintesi 2021 22giovanni russoNessuna valutazione finora
- Veca, Sull'idea Di Giustizia ProceduraleDocumento17 pagineVeca, Sull'idea Di Giustizia ProceduraleFrancescomariaTedescoNessuna valutazione finora
- TP Mala Praxis UltimoDocumento14 pagineTP Mala Praxis Ultimoaylen avilaNessuna valutazione finora
- NRG. 287 Del 2022Documento8 pagineNRG. 287 Del 2022simulinneissau-4514Nessuna valutazione finora
- Intorno Alla Relativitá Della Distiziones Tra Norme Sostanziali e Norme ProcessualiDocumento12 pagineIntorno Alla Relativitá Della Distiziones Tra Norme Sostanziali e Norme ProcessualiHugo CaveroNessuna valutazione finora
- Fassone, Dalla Certeza All Ipotesi PreferibileDocumento22 pagineFassone, Dalla Certeza All Ipotesi PreferibileNicolás Ariel LázaroNessuna valutazione finora
- Facciotti Silvia TesiDocumento186 pagineFacciotti Silvia TesiRenato Higa GriffinNessuna valutazione finora
- 19.9 Resp. Danni Da FarmaciDocumento24 pagine19.9 Resp. Danni Da FarmaciDanilo Bertunes TeixeiraNessuna valutazione finora
- Il Lavoro UccideDocumento187 pagineIl Lavoro UccideAntonio ChiocchiNessuna valutazione finora
- Diritto Penale RiassuntoDocumento111 pagineDiritto Penale RiassuntoDario SellaNessuna valutazione finora
- Prova IllecitaDocumento2 pagineProva IllecitaSara PrestigiacomoNessuna valutazione finora
- PisaniDocumento32 paginePisanifrancescapaciello.565005Nessuna valutazione finora
- Neuropolitica. Come Le Scienze Del CervelloDocumento12 pagineNeuropolitica. Come Le Scienze Del Cervellojareck18Nessuna valutazione finora
- Tratti evolutivi e questioni aperte nelle politiche anticorruzione: Tra emergenza continua e prospettive di stabilizzazioneDa EverandTratti evolutivi e questioni aperte nelle politiche anticorruzione: Tra emergenza continua e prospettive di stabilizzazioneNessuna valutazione finora
- Medicina LegaleDocumento493 pagineMedicina LegaleCatanfronia100% (2)
- Perizie e ConsulenzeDocumento52 paginePerizie e ConsulenzepuppettaNessuna valutazione finora
- La Prova Scientifica Nel Processo CivileDocumento24 pagineLa Prova Scientifica Nel Processo CivileFábio Machado MalagóNessuna valutazione finora
- Medicina Legale, Tossicologia e Medicina Del LavoroDocumento686 pagineMedicina Legale, Tossicologia e Medicina Del LavoroErmal64100% (1)
- Inchiesta SocialeDocumento3 pagineInchiesta SocialemarcoNessuna valutazione finora
- Tesi Andrea GangemiDocumento178 pagineTesi Andrea GangemiAnonymous ud43xkjnmNessuna valutazione finora
- Contenzione Misure, Diritti e Consenso InformatoDocumento3 pagineContenzione Misure, Diritti e Consenso Informatofisietto8035Nessuna valutazione finora
- Abuso D Ufficio - Eccesso Di Potere e Violazione Di Norme Di Legge o RegolamentoDocumento16 pagineAbuso D Ufficio - Eccesso Di Potere e Violazione Di Norme Di Legge o RegolamentonikNessuna valutazione finora
- Investigazioni Scientifiche, Verità Processuale Ed Etica Degli EspertiDocumento18 pagineInvestigazioni Scientifiche, Verità Processuale Ed Etica Degli EspertiSergio LorussoNessuna valutazione finora
- Precedente e Giurisprudenza - Michele Taruffo PDFDocumento16 paginePrecedente e Giurisprudenza - Michele Taruffo PDFIgorRRSSNessuna valutazione finora
- Esame avvocato 2020-21. CASI DI DIRITTO CIVILE: con soluzioni schematiche dimostrateDa EverandEsame avvocato 2020-21. CASI DI DIRITTO CIVILE: con soluzioni schematiche dimostrateNessuna valutazione finora
- UntitledDocumento214 pagineUntitledDario SellaNessuna valutazione finora
- Cass. EternitDocumento146 pagineCass. EternitDario SellaNessuna valutazione finora
- Diritto Penale RiassuntoDocumento111 pagineDiritto Penale RiassuntoDario SellaNessuna valutazione finora
- Antropologia MedicaDocumento66 pagineAntropologia MedicaDario SellaNessuna valutazione finora
- Cass. Porto MargheraDocumento58 pagineCass. Porto MargheraDario SellaNessuna valutazione finora
- I-RAMELLI La Satira IV Di Giovenale PDFDocumento17 pagineI-RAMELLI La Satira IV Di Giovenale PDFcrtm2012Nessuna valutazione finora
- Hand Bike RegolamentoDocumento13 pagineHand Bike Regolamentogiajot56Nessuna valutazione finora
- Lettera Pietro e Simon Scarpato 2Documento3 pagineLettera Pietro e Simon Scarpato 2simonethringNessuna valutazione finora
- Tabella Punteggi Patente Art 126 Bis D e 29 Luglio 2010Documento3 pagineTabella Punteggi Patente Art 126 Bis D e 29 Luglio 2010Abaco CisterninoNessuna valutazione finora
- S.U.L.P.L. - Discriminazione Lavoratori Polizia Locale Italiana - Ricorso Alla Corte Di Giustizia Europea Per I Diritti Dell'uomoDocumento3 pagineS.U.L.P.L. - Discriminazione Lavoratori Polizia Locale Italiana - Ricorso Alla Corte Di Giustizia Europea Per I Diritti Dell'uomoSulplCampaniaNessuna valutazione finora
- Registro tirocinioTFAA036Documento5 pagineRegistro tirocinioTFAA036Caruso GiovanniNessuna valutazione finora