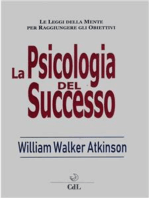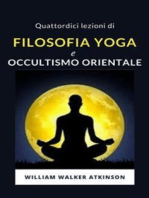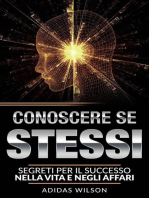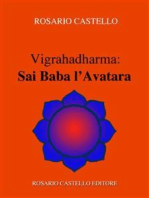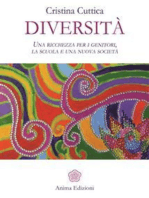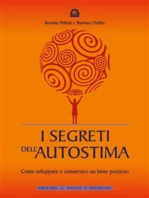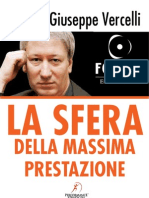Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
L'ascolto Attivo - Nanetti
Caricato da
Daniela MagnocavalloTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
L'ascolto Attivo - Nanetti
Caricato da
Daniela MagnocavalloCopyright:
Formati disponibili
Since then, at an uncertain hour,
Dopo di allora, ad ora incerta,
Quella pena ritorna,
E se non trova chi lo ascolti
Gli brucia in petto il cuore..
Il superstite . Primo Levi
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&#
NNETTI ' %E""RI# ()*+
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&#
NNETTI ' %E""RI# ()*+
un processo permette di comprendere
---cosa laltro ci vuole dire
-ci che laltro
Coinvolge mente e cuore e richiede :
concentrazione ,volont ,impegno
cultura
equilibrio
disponibilit affettiva ed empatia
capacit di amare!
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&#
NNETTI ' %E""RI# ()*+
E,patia
E,patia
Comprensione e amore
non possono essere separati altrimenti
solo un processo razionale
e le porte della vera
comprensione
rimangano sbarrate
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&#
NNETTI ' %E""RI# ()*+
-.E$/TI
-.E$/TI
"lempatia mette innanzitutto in
contatto con la ricchezza infinita di
altri accanto a noi #$ %&'oella
"&&& e nel reciproco riconoscimento
avviene una nuova nascita per
entrambi #$& (dith )tein
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&#
NNETTI ' %E""RI# ()*+
*scoltare attivamente
significa immaginare noi stessi
nella situazione vissuta dallaltro
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&#
NNETTI ' %E""RI# ()*+
Il dialo0o presuppone l.ascolto
Il dialo0o presuppone l.ascolto
+on c dialogo senza il
nostro impegno a
comprendere quanto laltro
ci vuole comunicare,
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&#
NNETTI ' %E""RI# ()*+
Lascolto attivo esige
Accettazione
(non negazione del dissenso)
Coinvolgimento
Partecipazione
Riconoscimento
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&#
NNETTI ' %E""RI# ()*+
-. ascolto 1 un atto volontario che
-. ascolto 1 un atto volontario che
oltrepassa le parole.
oltrepassa le parole.
-er ascolto non intendiamo tacere
per permettere allaltro di parlare,
% ascolto non si affida al semplice
registrare ci che laltro dice,
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&#
NNETTI ' %E""RI# ()*+
+on curiosit fine a se stessa
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&#
NNETTI ' %E""RI# ()*+
Talora per le nostre inibizioni
Talora per le nostre inibizioni
possono diventare una barriera
possono diventare una barriera
per lascolto dellaltro
per lascolto dellaltro
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&#
NNETTI ' %E""RI# ()*+
Le barriere possono dipendere da
blocchi emotivi che mettono fuori
campo la comprensione
ATTEN!"NE
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&#
NNETTI ' %E""RI# ()*+
#e temiamo il giudizio
dellaltro$ o una svalutazione %
non riusciamo ad ascoltare
Perch& siamo impegnati a
rinforzare la nostra maschera
Non ascoltiamo
se vogliamo vincere
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&#
NNETTI ' %E""RI# ()*+
! monologhi possono rivelare ansia
paura $ angoscia nevrotica $
insicurezza #
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&#
NNETTI ' %E""RI# ()*+
-. ascolto autentico presuppone
-. ascolto autentico presuppone
due 2onda,entali ,odalit34
due 2onda,entali ,odalit34
1 - ASCOLTO CRITICO
2 - ASCOLTO EMPATICO
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&#
NNETTI ' %E""RI# ()*+
L ascolto autentico ' un giusto
L ascolto autentico ' un giusto
mi( tra i due tipi di ascolto
mi( tra i due tipi di ascolto
L ascolto autentico non
privilegia un tipo di ascolto
sullaltro in )uanto entrambi
hanno una propria funzionalit*
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&# NNETTI
' %E""RI# ()*+
+ , A#C"LT" CR!T!C"
+ , A#C"LT" CR!T!C"
Centrato sulla decodifica dei messaggi e
sul costrutto logico di ci che laltro
dice## individua e valuta la
razionalit e la coerenza del discorso&
.ndaga, cerca difetti ed errori
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&# NNETTI
' %E""RI# ()*+
, A#C"LT" !PERCR!T!C"
, A#C"LT" !PERCR!T!C"
concentrato sui dettagli e sugli
errori
/isconosce le emozioni
0osi troppo alte producono senso di
inadeguatezza
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&# NNETTI
' %E""RI# ()*+
- , A#C"LT" E.PAT!C"
- , A#C"LT" E.PAT!C"
% ascolto empatico vuole comprendere le
motivazioni ed intenzioni sottese non esplora
la razionalit del discorso dellaltro
Ci si mette nei panni dellaltro, ci si pone dal suo punto di vista
per cogliere in modo intuitivo, diretto, immediato la totalit e
lessenzialit del suo esserci (non in modo analitico)
0osi troppo alte costringono laltro a
compiacersi della propria inadeguatezza
+asce una simbiosi che impedisce un
confronto
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&# NNETTI
' %E""RI# ()*+
VERE UN TTEN5I#NE
VERE UN TTEN5I#NE
/ENSNTE
/ENSNTE
0i colui che sa correttamente scegliere
il giusto equilibrio
tra un eccesso di ascolto
e una carenza di ascolto 1& +anetti 2334!
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&# NNETTI
' %E""RI# ()*+
Chi si pone in un atteggiamento di ascolto
autentico non si limita a /registrare0 le
parole dell altro ma cerca di intravedere
in esse una intenzionalit* spesso oscura in
entrambi gli attori della comunicazione1
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&# NNETTI
' %E""RI# ()*+
Ri2lettere su ci6 che si ascolta
Ri2lettere su ci6 che si ascolta
%cogliere il senso incompiuto
del discorso dell altro nella sua
globalit* tramite un consapevole
sforzo metacomunicativo %
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&# NNETTI
' %E""RI# ()*+
Nellascolto attivo sono coinvolti
Nellascolto attivo sono coinvolti
tre processi
tre processi
%* 5.C(6.7+(
%(%*'75*6.7+( 0(% /())*88.7
%* 5.)-7)9*
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&# NNETTI
' %E""RI# ()*+
LA R!CE!"NE 2EL .E##A33!"
LA R!CE!"NE 2EL .E##A33!"
.mplica da parte di chi ascolta una concentrazione
intenzionale non strutturata
"facilitata da una autentica disponibilita nei confronti
dell altro$& 1& +anetti 2334!&
.mportante nella ricezione del messaggio
"abbassare il livello della propria soggettivit$
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&# NNETTI
' %E""RI# ()*+
L ELA4"RA!"NE 2EL .E##A33!"
L ELA4"RA!"NE 2EL .E##A33!"
Lelaborazione del messaggio avviene
)uando chi ascolta attribuisce uno o pi5
significati al messaggio ricevuto1
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&# NNETTI
' %E""RI# ()*+
%ascolto nella fase di
elaborazione pu essere distinto
in sei aspetti :
C7+9(+:97
*:975.;(%*6.7+(
5.C<.()9*
5(%*6.7+(
()-5()).7+(
C7+9()97
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&# NNETTI
' %E""RI# ()*+
* 7 &#NTENUT#
* 7 &#NTENUT#
#i tiene conto di che cosa laltro ci vuole
informare e di che cosa pensa in relazione
alloggetto della comunicazione tenendo
conto che la vera oggettivit* si basa sul
confronto delle rappresentazione che ognuno
ha dello stesso fatto
7
2i che cosa sta parlando 6
7
2i che cosa ci vuole informare 6
7
7uali sono le sue idee ed opinioni in merito a
)uanto ci sta dicendo 6
( 7 RIVE-5I#NE DI SE.
( 7 RIVE-5I#NE DI SE.
% emittente in modo consapevole o
inconsapevole rivela qualcosa di s=&
%a carenza di autorivelazione causa
di un comunicazione difficile&
)pesso cerchiamo solo
-
0i dimostrare la nostra superiorit
-
0i fare bella figura
-
0i essere considerati
( 7 RIVE-5I#NE DI SE.
( 7 RIVE-5I#NE DI SE.
%a paura nevrotica del giudizio porta ad
una dissimulazione :
Con un formalismo eccesivo
+on esprimendo mai alcuna opinione
Forme linguistiche che rivelano questa paura
:so impersonale del ). o del +7.
0omande di mascheramento
)valutarsi eccessivamente per essere
contraddetto!
accusare
+ella dimensione di autopresentazione
lattenzione focalizzata nelle seguenti
domande:
-
Che cosa laltro sta dicendo di s=, mentre comunica >
-
Che cosa vuole che io pensi di lui >
-
;uole che io lo valuti positivamente o negativamente >
-
;uole apparire una persona onesta # colta #
+ 7 //E--# o RI&8IEST
+ 7 //E--# o RI&8IEST
Nella )uale si tiene conto di che cosa laltro in
modo esplicito od implicito ci appella a pensare$
credere$ fare o non fare1
3li appelli possono essere8
2!RETT!
NA#C"#T!
PARA2"##AL!
9na comunicazione positiva si nutre di molti
appelli diretti1
3li appelli nascosti si hanno )uando chi parla
influenza il destinatario in modo manipolatorio
per sottometterlo o per ottenere favori o privilegi1
3li appelli paradossali sono )uelli che si
contraddicono tra loro1
C una contraddizione nei termini
3li appelli diretti implicano lespressione chiara e
spontanea di desideri ed intenzioni1
Parte delle persone evitano tali appelli perch&
hanno paura di scoprirsi$
temono di essere rifiutati$
oppure cercano di non dare limpressione
dimporre ci che in realt* desiderano1
Nella dimensione dellappello
si cerca di rispondere alle
domande8
,Che cosa laltro mi chiede 6
7
2i che cosa mi vuole convincere 6
7
Che cosa vuole ottenere da me 6
9 7 RE-5I#NE
9 7 RE-5I#NE
come laltro percepisce la
relazione in corso e come
intende modificarla
Nella dimensione della relazione si
cerca di rispondere alle domande8
,!n che modo laltro mi percepisce 6
,Che tipo di relazione ha instaurato con me 6
,Come vorrebbe modificarla 6
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&# NNETTI
' %E""RI# ()*+
: 7 ES/RESSI#NE
: 7 ES/RESSI#NE
sentimenti,
emozioni,
stati danimo
che il soggetto prova ad esprimere&
/olte emozioni e molti sentimenti sono
visibili attraverso il corpo, che si
esprime suo malgrado&
-er esempio la tristezza prima nel volto che nelle parole
UNIVERSIT! DI UR"IN#
$STER DIRETT# D %RN&# NNETTI
' %E""RI# ()*+
Nella dimensione dellespressione
emerge la comunicazione non verbale
si cerca di rispondere alle domande8
,Che cosa laltro sente dentro di s& 6
,7uali stati danimo esprime 6
,7uali sentimenti ed emozioni 6
: , C"NTE#T"
#i esamina come si incastonano
le cose narrate
con il contesto in cui sono
immerse e con la situazione
interpersonale
Potrebbero piacerti anche
- Carl Rogers e I ValoriDocumento6 pagineCarl Rogers e I ValoriEsonet.org100% (1)
- Tecniche Di Suggestione Ipnotica Milton EricksonDocumento191 pagineTecniche Di Suggestione Ipnotica Milton EricksonPEYMANFATTAHI100% (2)
- Emotional Life Ritrova il tuo equilibrioDa EverandEmotional Life Ritrova il tuo equilibrioNessuna valutazione finora
- La Comunicazione Assertiva in Ambito Scolastico PDFDocumento26 pagineLa Comunicazione Assertiva in Ambito Scolastico PDFCosimoNessuna valutazione finora
- Guarire Da DentroDocumento12 pagineGuarire Da DentrofveroliniNessuna valutazione finora
- La Psicologia del Successo: Sentieri mentali che conducono al potereDa EverandLa Psicologia del Successo: Sentieri mentali che conducono al potereNessuna valutazione finora
- Le 5 Ferite SintesiDocumento4 pagineLe 5 Ferite SintesiSimone Savina100% (1)
- 300 Indovinelli e 300 Barzellette Per Bambini 2 Libri in 1 (Italian Edition)Documento77 pagine300 Indovinelli e 300 Barzellette Per Bambini 2 Libri in 1 (Italian Edition)Penisola giorgiaNessuna valutazione finora
- 15-Manuale Del CounselorDocumento65 pagine15-Manuale Del CounselorSchwarz AdlerNessuna valutazione finora
- La Tecnica Ipnotica Del Milton Model PDFDocumento17 pagineLa Tecnica Ipnotica Del Milton Model PDFAnaNessuna valutazione finora
- Psicosomatica PDFDocumento13 paginePsicosomatica PDFDaniela Magnocavallo0% (1)
- Quattordici lezioni di Filosofia yoga e occultismo orientale (tradotto)Da EverandQuattordici lezioni di Filosofia yoga e occultismo orientale (tradotto)Nessuna valutazione finora
- Alla Scoperta Delle Emozioni Iomanager PDFDocumento54 pagineAlla Scoperta Delle Emozioni Iomanager PDFDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- Alla Scoperta Delle Emozioni Iomanager PDFDocumento54 pagineAlla Scoperta Delle Emozioni Iomanager PDFDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- Esercizio Di Disidentificazione e Di Auto Identificazione - Per Dispensa - 1Documento9 pagineEsercizio Di Disidentificazione e Di Auto Identificazione - Per Dispensa - 1Chri de LucaNessuna valutazione finora
- Comunicare Con L'ipnosi.Documento13 pagineComunicare Con L'ipnosi.Ciro PignalosaNessuna valutazione finora
- La profezia che si autoavvera: Come usare le aspettative per ottenere tutto quello che vuoiDa EverandLa profezia che si autoavvera: Come usare le aspettative per ottenere tutto quello che vuoiNessuna valutazione finora
- Conoscere se stessi: segreti per il successo nella vita e negli affariDa EverandConoscere se stessi: segreti per il successo nella vita e negli affariNessuna valutazione finora
- Holos 04 Psiche EmozioniDocumento7 pagineHolos 04 Psiche Emozionimorpheus19770Nessuna valutazione finora
- Giocando con le VISUALIZZAZIONI, il potere delle IMMAGINIDa EverandGiocando con le VISUALIZZAZIONI, il potere delle IMMAGININessuna valutazione finora
- Pensieri Del CuoreDocumento14 paginePensieri Del CuoreAnonymous zMwLc7qlsqNessuna valutazione finora
- La: "Morphogenetics Touch": Tutto ciò che non si esprime si imprime. La memoria emozionale nel corpo!!!Da EverandLa: "Morphogenetics Touch": Tutto ciò che non si esprime si imprime. La memoria emozionale nel corpo!!!Nessuna valutazione finora
- Malattia Linguaggio Dell'animaDocumento6 pagineMalattia Linguaggio Dell'animaDaniela Magnocavallo100% (1)
- Al di là dell’anima: Narrazioni ed esperienze medianicheDa EverandAl di là dell’anima: Narrazioni ed esperienze medianicheValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Teoria Del Se e Ciclo Del ContattoDocumento9 pagineTeoria Del Se e Ciclo Del ContattoMarta BenettinNessuna valutazione finora
- 2017 Comunicazione Efficace PDFDocumento39 pagine2017 Comunicazione Efficace PDFwerner71Nessuna valutazione finora
- A Che Gioco GiochiamoDocumento11 pagineA Che Gioco GiochiamoClaudio RajolaNessuna valutazione finora
- La Legge dei Fenomeni Psichici (Tradotto): Per lo studio sistematico dell'Ipnotismo, Spiritismo, Terapeutica mentaleDa EverandLa Legge dei Fenomeni Psichici (Tradotto): Per lo studio sistematico dell'Ipnotismo, Spiritismo, Terapeutica mentaleNessuna valutazione finora
- (Cli - 2015) TERAPIA DI GRUPPODocumento33 pagine(Cli - 2015) TERAPIA DI GRUPPOAngela CoglitoreNessuna valutazione finora
- Thytronic SHGDocumento60 pagineThytronic SHGalfredohdnNessuna valutazione finora
- Marcello Peri - Tesina CounselingDocumento8 pagineMarcello Peri - Tesina CounselingMarcello PeriNessuna valutazione finora
- Ipnotismo pratico - come influire sulle nostre condizioni fisiche, psichiche e di comportamentoDa EverandIpnotismo pratico - come influire sulle nostre condizioni fisiche, psichiche e di comportamentoNessuna valutazione finora
- Abilità Di CounselingseconodomoduloDocumento49 pagineAbilità Di Counselingseconodomodulomusat vioNessuna valutazione finora
- Presentazione Istituto Psicologia AnalogicaDocumento19 paginePresentazione Istituto Psicologia AnalogicaRuth FoffNessuna valutazione finora
- 101caffè Per Avere Successo!Documento75 pagine101caffè Per Avere Successo!EmanueleLucaPalozzaNessuna valutazione finora
- Marco Pacori - Come Interpretare I Messaggi Del Corpo Le Ultime NovittaDocumento2 pagineMarco Pacori - Come Interpretare I Messaggi Del Corpo Le Ultime NovittasjddyfhNessuna valutazione finora
- Diversità: Una ricchezza per i genitori, la scuola e una nuova societàDa EverandDiversità: Una ricchezza per i genitori, la scuola e una nuova societàNessuna valutazione finora
- Energia Nuova: Usa Il Potere Della Mente Per Ottenere Tutto Dalla VitaDa EverandEnergia Nuova: Usa Il Potere Della Mente Per Ottenere Tutto Dalla VitaNessuna valutazione finora
- Gestalt Counseling Arte Del Contatto STAMPA FINALE PDFDocumento140 pagineGestalt Counseling Arte Del Contatto STAMPA FINALE PDFLucasNessuna valutazione finora
- Motivazione 365 su 365: 365 Frasi Giornaliere per Per Motivarti e IspirartiDa EverandMotivazione 365 su 365: 365 Frasi Giornaliere per Per Motivarti e IspirartiNessuna valutazione finora
- RiassuntoDocumento6 pagineRiassuntodozz8750% (2)
- Mida Ideogrammi - Deep Coaching, Alessandra VesiDocumento34 pagineMida Ideogrammi - Deep Coaching, Alessandra VesiMida spaNessuna valutazione finora
- Come Creare Un Attività - Bookfarm - EuDocumento8 pagineCome Creare Un Attività - Bookfarm - EuBookfarm.euNessuna valutazione finora
- Aspetti Psicologici della Dipendenza da InternetDa EverandAspetti Psicologici della Dipendenza da InternetNessuna valutazione finora
- Abilità Di CounselingDocumento114 pagineAbilità Di CounselingSimonetta Scavizzi100% (1)
- Sfìdati: Trasforma l’ordinario in straordinario con il Mindset WellbeingcoachDa EverandSfìdati: Trasforma l’ordinario in straordinario con il Mindset WellbeingcoachNessuna valutazione finora
- Practitioner in PNL Nuovo Documento Completo Di PresentazioneDocumento5 paginePractitioner in PNL Nuovo Documento Completo Di PresentazioneNocom Roberto MicarelliNessuna valutazione finora
- Metafora e PsicoterapiaDocumento13 pagineMetafora e PsicoterapiaCrescita PersonaleNessuna valutazione finora
- La rivoluzionaria teoria delle Intelligenze Multiple: Alcune valutazioni criticheDa EverandLa rivoluzionaria teoria delle Intelligenze Multiple: Alcune valutazioni criticheNessuna valutazione finora
- Vita Morte Karma ReincarnazioneDocumento29 pagineVita Morte Karma ReincarnazioneMoffa Antonio LucianoNessuna valutazione finora
- L'alchimia del successo: vol.1 - Come creare una fortuna partendo dal nullaDa EverandL'alchimia del successo: vol.1 - Come creare una fortuna partendo dal nullaNessuna valutazione finora
- StorytellingDocumento1 paginaStorytellingEnrico ViceconteNessuna valutazione finora
- La Comunicazione AssertivaDocumento3 pagineLa Comunicazione AssertivamarijaNessuna valutazione finora
- I segreti dell'autostima: Come sviluppare e conservare un bene prezioso.Da EverandI segreti dell'autostima: Come sviluppare e conservare un bene prezioso.Nessuna valutazione finora
- Impara ad usare l'intelligenza delle emozioni: Come diventare padrone delle proprie emozioniDa EverandImpara ad usare l'intelligenza delle emozioni: Come diventare padrone delle proprie emozioniNessuna valutazione finora
- Carisma: Il metodo a 3 step semplice ed efficace adatto a tutti. Come migliorare la tua comunicazione e i tuoi comportamenti trasformandoti in un vero leaderDa EverandCarisma: Il metodo a 3 step semplice ed efficace adatto a tutti. Come migliorare la tua comunicazione e i tuoi comportamenti trasformandoti in un vero leaderNessuna valutazione finora
- Lascolto 1Documento49 pagineLascolto 1ascanio67Nessuna valutazione finora
- Arcangelo MirandaDocumento34 pagineArcangelo MirandaLuca Dal SantoNessuna valutazione finora
- AutostimaDocumento7 pagineAutostimaGuidoneNessuna valutazione finora
- Ascolto Attivo PDFDocumento16 pagineAscolto Attivo PDFClaudio Rajola100% (1)
- Se Solo Potessi...Documento54 pagineSe Solo Potessi...Max Formisano TrainingNessuna valutazione finora
- Mida Ideogrammi - Gruppi Di Lavoro Tra Team Building e Conflitti, Claudio FunesDocumento38 pagineMida Ideogrammi - Gruppi Di Lavoro Tra Team Building e Conflitti, Claudio FunesMida spa100% (1)
- Recensione Libro Donne Che Corrono Coi LupiDocumento12 pagineRecensione Libro Donne Che Corrono Coi LupiDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- Slide KohutDocumento16 pagineSlide KohutDaniela Magnocavallo100% (1)
- Amicizia S. WeilDocumento23 pagineAmicizia S. WeilDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- La Volontà Di GuarireDocumento54 pagineLa Volontà Di GuarireDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- Accendi Il Tuo Spirito Guerriero LightDocumento32 pagineAccendi Il Tuo Spirito Guerriero LightDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- Carl Gustav Jung Anima e Morte PDFDocumento7 pagineCarl Gustav Jung Anima e Morte PDFDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- Murphy e BeckettDocumento20 pagineMurphy e BeckettDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- Il Trauma e Il Corpo PreviewDocumento72 pagineIl Trauma e Il Corpo PreviewDaniela Magnocavallo100% (1)
- Articoli - Recensione LibriDocumento129 pagineArticoli - Recensione LibriDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- C. Feldman CompassioneDocumento6 pagineC. Feldman CompassioneDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- Introduzione Terapia Della GestaltDocumento2 pagineIntroduzione Terapia Della GestaltDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- Autostima e Adolescenza Regole Per MotivareDocumento1 paginaAutostima e Adolescenza Regole Per MotivareDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- WWW - Maxformisano.it Upload Dispense AutostimaDocumento25 pagineWWW - Maxformisano.it Upload Dispense AutostimaFederica BonsignoreNessuna valutazione finora
- Basic Des La GestaltDocumento85 pagineBasic Des La GestaltDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- CognitivismoDocumento35 pagineCognitivismoDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- GestaltDocumento2 pagineGestaltDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- In Mind Magazine25 PDFDocumento52 pagineIn Mind Magazine25 PDFDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- In Mind Magazine 24 PDFDocumento50 pagineIn Mind Magazine 24 PDFDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- Meditare Per Scacciare La PauraDocumento6 pagineMeditare Per Scacciare La PauraDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- In Mind Magazine25 PDFDocumento52 pagineIn Mind Magazine25 PDFDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- VERCELLI La SferaDocumento18 pagineVERCELLI La SferaDaniela MagnocavalloNessuna valutazione finora
- HeideggerDocumento8 pagineHeideggerlulujazz100% (1)
- Percorso Di Storia Della MusicaDocumento22 paginePercorso Di Storia Della MusicaMauro Vergimigli100% (1)