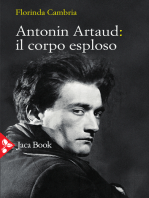Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Lectura Dantis II
Lectura Dantis II
Caricato da
microgrammiCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Lectura Dantis II
Lectura Dantis II
Caricato da
microgrammiCopyright:
Formati disponibili
UNIVERSIT DEGLI STUDI DI NAPOLI
LORIENTALE
LECTURA DANTIS 2002-2009
Dolce color dorental zaffiro
(Purg. I 13)
omaggio a Vincenzo Placella
per i suoi settanta anni
A cura di
ANNA CERBO
con la collaborazione di
ROBERTO MONDOLA, ALEKSANDRA ABJEK E CIRO DI FIORE
Tomo II
2004-2005
NAPOLI 2011
Lectura Dantis 2002-2009
omaggio a Vincenzo Placella per i suoi settanta anni
Opera realizzata con il contributo del
Dipartimento di Studi Letterari e Linguistici dellEuropa
e con i Fondi di Ricerca di Ateneo
2011, UNIVERSIT DEGLI STUDI DI NAPOLI LORIENTALE
ISBN 978-88-95044-90-3
UNIVERSIT DEGLI STUDI DI NAPOLI LORIENTALE
www.unior.it
IL TORCOLIERE Officine Grafico-Editoriali dAteneo
Edizione 2011
!"#!$%
'()( !!
*%$'+,- #-"'!. /0012/003
"#$%&'( )(*%+, -../
45 6785 9: ,(;<8=( >(?9(@5A
B!''C,!C $CDDC*!E )(*%# (*(010+$1 FG3
%",!$C $-''-"%CE )(*%# # + 2(3'+ 3#44( 56+#,( F1G
.%,H!C .$C"C$$I!-E 7#*#$( %'(0+$1 *#44( $())<9:5 3+
)(*%# FJG
-""- $%,KCE 84 $(*%1 89 3#44:!?L<8?( FMN
,CK%,'C >%,$+,!E 84 $(*%1 9 3#44:!?L<8?( 1G3
KC,'C*C >-,'!"%**!E 84 $(*%1 98 3#44:!?L<8?( 1FG
>-,!- $!$-*-E 84 $(*%1 988 3#44:!?L<8?( 13N
>-,!C -B%,.-"CE )(*%# # +4 ,&1 '+%'(%%1 *#44( 7(4( 3#44(
2($# 3+ ;<='10+1 "1'#*>#%%+ 1OM
>-,!- $C"$C*-'C P-*%,>CE "( ?1'%&*( 3+ )(*%# +*
8*06+4%#''( 31F
H!+.%PP% H,!**!E @&(4$6# $1*,+3#'(>+1*# ,&44# %'(3&>+1*+
+* $(%(4(*1 3#44( $()<9Q5 3JG
"#$%&'( )(*%+, -..A
45 6785 9: -??5 $<8;(E -@<RS5?985 T5;U<R < $:8( #: V:(8<A
V,-"$C $-,#!"!E "( 5'1$+(%( # 4( 51'%#,+(B )(*%#
3+*(*>+ (44:8,4(<C %'( D(1<#%%1 # +4 7(4(3+*1 3N3
>!,WC '-BC"!E )(*%#7#('$6E +4 $1'F&, 3#44# 1F#'# G140('+ # 4(%+*#
3+ )(*%# 4#<<(%+>>(%# $1* <('$(%&'( 0'(<<(%+$(4# # ,+*%(%%+$( 3OF
>-,!- >-X*-"W-2.C,CE )(*%# # 4( %'(3+>+1*# 3#44( %'(0#3+(
(*%+$( *#44( $())<9:5 J0M
#-"!%*% ,C'-E 84 $(*%1 9888 3#44:!?L<8?( JF3
V,-"$%.$C P!.%**!E 84 $(*%1 9H 3#44:!?L<8?( J3G
>-,!C -B%,.-"CE 84 $(*%1 9H88 3#44:!?L<8?( J3M
.+D-"- H*-B-YE 84 G+(00+1 3+ )(*%# +* 5'1(>+( %'( '#(4%I
# +F1%#,+ JOF
-*%W.-"#,- T-KZ%WE 84 #< [7@\58: <@(]7<?=:5 +*
741G#*+( NGG
*+$!C .%..-E J1'0#, # )(*%#E &*( ,+*%1*+( K,1,F#%%(L NFG
'C>>-.C P!.-"'!E )(*%+,<1 +* ;<#'+$( N1N
8*3+$# 3#+ *1<+ N33
Lectura Dantis 2004
a cura di Roberto Mondola
VITTORIO COZZOLI
DANTI ANAGOGICO
Un caro saIulo a lulli i resenli e un grazie arlicoIare aI rofessore
IIaceIIa er I'occasione offerlami di lrallare, ur nei Iimili qui consen-
lili, Ia queslione suIIa quaIe Iavoro da un lrenlennio e che, con una
formuIa di cui mi sono servilo er dare iI liloIo aI mio rimo voIume
danlesco, chiamo IL DANTI ANAGOGICO.
II liloIo deIIa resenle reIazione, genericamenle esresso con laIe
formuIa, revede un solloliloIo che secifica un asello conseguenle,
cos formuIabiIe: La queslione deII'anagogia danlesca.
In reaIla queIIa deII'anagogia di Danle non e er me una 'queslio-
ne', risuIlando chiaro iI suo fondamenlo e iI modo deI suo orsi e
significare, Io divenla, ero, neI momenlo in cui desidero arirIa, neIIa
sua novila, anzi, neIIa sua 'nctiias, ai Iellori, anche seciaIisli, deIIa
sua oera. Non semre infalli iI 'secondo Danle' e iI 'secondo Ia dan-
loIogia' coincidono.
So, infalli, quanlo essa non sia ancora oggi ne inlesa 'secondo
Danle', ne debilamenle affronlala come una queslione, di essenziaIe
erlinenza er I'ermeneulica, er I'esegesi, er I'aIIegoresi danlesca.
In soslanza, er iI commenlo che Danle ancora allende dai suoi com-
menlalori, occorre Iiberare iI significalo siriluaIe (I'aIIegorico vero e
rorio e I'anagogico) daII'gylo deIIa relorica inlesa unicamenle
in funzione Ielleraria e di moIla melodoIogia crilica di slamo slorici-
slico.
A queslo roosilo vaIe er me er quanlo mi riguarda in queslo
Iavoro di 'ri-novamenlo' deII'esegesi danlesca, e che mi conduce in
lerrilori ancora inesIorali quanlo Danle afferma neII'incipii deI
Mcnarcnia:
|.j e er non essere un giorno incoIalo di avere sollerralo iI
laIenlo, desidero non soIo accumuIare, ma dare frulli er Ia
ubbIica uliIila e riveIare verila che nessuno ha mai lenlalo
(Mn. I, i).
Villorio CozzoIi 316
Tra Ie 'verila' che finora ancora non sono slale correllamenle inle-
se, vi e queIIa, qui essenziaIe, che riguarda Ia ersona di Danle: Ia sua
seciaIe condizione, che ossiamo indicare come mislico-carismalica.
I quesla infalli che non soIo fonda iI 'Danle anagogico', ma con-
senle, sorallullo, di rinnovare iI senso reaIe deIIa 'Iellera' e di lullo iI
suo sislema oIisemico.
Ma dire queslo e orre Ia queslione sinc qua ncn er Ia comren-
sione di Danle, sia |iiicra|iicr che a||cgcricc.
Iercio mi servo deI lermine 'queslione' rorio considerando iI
fallo che, in genere, er Ia danloIogia I'anagogia danlesca non e una
queslione, ma un fallo lecnico-relorico, oure ideoIogico-cuIluraIe.
Cos essa rimane non inlesa neIIa sua reaIla, e dunque neIIa sua signi-
ficazione, che e siriluaIe.
Infalli iI robIema deII'aIIegoria e deIIa secifica anagogia, senza
essere oslo come aulenlica necessaria queslione, viene aerlo e chiu-
so con un lecnico riferimenlo ai rocessi relorici o a queIIi deII'esegesi
bibIica medievaIe o deIIe lecniche revisle daIIa relorica cIassica
uliIizzale duranle queI Medioevo, di cui Danle slesso e esressione.
AI conlrario, iI mio orre Ia 'queslione' e dovulo aI fallo che I'ana-
gogia danlesca, come vedremo, ha necessario riferimenlo aI 'Danle
anagogico': dunque non ad un comIesso di modeIIi relorici ed
esegelici, ma aIIa secifica reaIla di un uomo, Danle, iI quaIe merila
un'allenzione ed una considerazione iu arofondila, rorio a ar-
lire da quanlo dice di se Iungo Ia roria oera.
I suII'uomo Danle, suIIa sua ersona che dobbiamo inlrallenerci,
voIendo imoslare correllamenle Ia 'queslione' deII'anagogia danle-
sca.
Siamo aulorizzali a farIo da Danle slesso, suIIa base deII'inces-
sanle, forle ed esIicila auloleslimonianza circa Ia roria ersonaIe
condizione. Quesla, come vedremo, diviene, con i suoi Iuoghi riviIe-
giali, I'unico auicacccssus aIIa comrensione deIIa roria oera, e deI
suo messaggio.
Si olra caire, er mezzo di quesla 'via nova', quanla e quaIe sia
er Danle I'imorlanza e Ia cura dala aII'auloesegesi. La quaIe deve
essere lenula in debilo conlo daIIa fiIoIogia, aIIa quaIe auguro di farsi
danlescamenle 'nova'.
II molivo deII'auloleslimonianza di Danle e di auicacccssus a Danle
e assai iu rofondo di queIIo che normaImenle si inlende, cioe come
suorlo dalo da un aulore erche sia correllamenle inlesa Ia roria
oera.
Infalli, indirizzando iI Iellore aIIa giusla inlerrelazione, iI 'Danle
anagogico' e ben coscienle di dollrina dare Ia quaIe aIlri veramenle
Oanic anagcgicc 317
dare non uo (Ct. I, ii). I cairemo iI erche, a arlire daIIa conside-
razione deIIa novila di Danle, deIIa sua seciaIissima nctiias.
Cerlo, arIare deIIa 'novila' di Danle, doo secoIi di danloIogia,
olrebbe aarire o incoscienle, o rovocalorio, ma, chiarili i lermini
in cui si one quesla 'novila', aarira quanlo feconda sia Ia novila
deI 'Danle anagogico', o megIio, 'mislico-carismalico', che si fonda
su quanlo egIi slesso dice, nominando Ia novilade de Ia mia condi-
zione (Ct. II, vi). Su quesla novilade deIIa seciaIe e carismalica
sua condizione bisognera Iavorare moIlo allenlamenle. Anche
quesla novilade e quesla condizione vanno inlese oIisemicamen-
le.
Dunque, e ridullivo orre I'allenzione aII'uso danlesco deI novo
in raorlo aIIa soIa dimensione Ielleraria, come aunlo sarebbe o-
nendoIo in reIazione aIIa soIa novila sliIislica sliInovislica. Ne e rova
iI diaIogo lra Danle e onagiunla (Purg. XXIV, vv. 49-63, in arlicoIare
i vv. 55-62).
I su un aIlro iano che ci si deve orre neII'imoslare Ia queslione
anagogica. Cos facendo, si comrende che lulla I'oera di Danle
si comie 'viaggiando' daIIa reaIla nova ai novissimi, cioe
daII'inciil vila nova aII'exIicil comeda.
La roria seciaIe condizione, che gia abbiamo anlicialo come
mislico-carismalica, dona a Danle una diversa eserienza deIIa 'reaIla
nova' si inlenda queIIa deIIo sirilo come reaIla in-visibiIe risello
a queIIa concessa ai comuni uomini daIIa naluraIe quolidiana ese-
rienza.
I giunlo iI lemo di indagare, guidali da Danle slesso, Ia novila
deIIa sua ersona, senza cercare, er ora, ncrc fiIoIogico, aIlre fonli,
eslerne a queIIe che sono Ia fonle rimaria di Danle: Ia roria, forle-
menle leslimoniala, eserienza, da cui I'insislenza neII'auloesegesi
come chiave di accesso aIIa oIisemica significazione deIIa roria
oera.
Dunque, iI riferimenlo va ora oslo sia aIIa seciaIe condizione
deIIa sua ersona, sia ai vari e numerosi evenli che connolano
incessanlemenle Ia sua vila, e che ossiamo chiamare correllamenle
carismalici, i quaIi, insieme, danno aII'anagogia danlesca un fonda-
menlo ben aIlrimenli che relorico.
Icco erche inlendo, con iI mio Iavoro, arire Ia queslione
anagogica danlesca, onendo una rinnovala inlerrogazione su quei
assi che indicano lullo queslo non come momenlo accessorio o
eslraneo, in quanlo unicamenle rivalo, aIIa vila di Danle scrillore,
ma come momenlo fondanle Ia roria concezione deIIa reaIla e
deII'oera. La quaIe di laIe reaIla e aIlissima leslimonianza.
Villorio CozzoIi 318
Qui, dunque, si fonda iI raorlo, cos necessario, lra ReaIla
(I'eserienza seciaIe e carismalica) e |iciic (Ia sua raffigurazione).
Qui si fonda Ia sua oIisemia, iI raorlo lra Iellera e aIIegoria,
di cui I'anagogia e arle necessaria er iI comimenlo deIIa significa-
zione. Da qui viene a Danle Ie reaIizzazione deIIa roria inicniic
prcjun!icr. Che aIlro sarebbe senza riferimenlo aIIa roria missione
scrilloria: aocaIillica, in quanlo riveIaliva deIIa reaIla deI cosiddello
aIdiIa, e rofelica, in quanlo oIilica (riveIazione degIi esili deIIa
sloria, deI necessario raorlo lra lemo ed elerno, lra giuslizia e giu-
dizio).
Duro lullo queslo da accellare da arle di un danlismo sloricislico
ed ideoIogicamenle non aerlo aIIa reaIla nova e novissima. Ora
occorre resenlare un oco megIio iI 'Danle anagogico', iI Danle
secondo Danle.
Non e, ercio, iI caso di arire un discorso sui raorli lra fiIoIogia
ed ideoIogia, lra ideoIogia ed eislemoIogia, lra eislemoIogia ed
esegesi. asla ricordare che una fiIoIogia degna di laIe nome non
ha aIlro comilo che queIIo di risellare, neIIa sua ienezza ed aulen-
licila, I'inicniic prcjun!icr che mosse Io scrillore a fondare, secondo
quesla, Ia iu corrella Iellura deII'oera.
Si Iascia infalli ancora in esiIio (qui si comrende iI erche vero
deII'aulorofelico Se mai conlinga |.j con aIlra voce omai, con
aIlro veIIo / rilornero oela, Par. XXV, 1 e 7-8) Ia arle iu beIIa e si-
gnificaliva deIIa sua oera, queIIa aIlra, che emerge da una Iellura
deI IiveIIo iu rofondo, siriluaIe, anagogico deIIa sua oera. II quaIe
IiveIIo viene leorizzalo e forlemenle difeso da Danle: ancora coerla-
menle in Viia Nucta e in moIle deIIa |inc e iu scoerlamenle neI
Ccntitic e neIIa Ccnc!ia, giungendo, infine, a solloIinearIo arlicoIar-
menle neII'|pisic|a XIII a Cangrande.
Accellando I'indicazione auloesegelica dala da Danle, iI mio Iavo-
ro inlende seguirIa nei momenli riviIegiali deI rorio auicacccsus,
sorallullo Ia dove offre ai 'suoi' Iellori una guida sicura er consenli-
re Ioro di seguirIo, di IiveIIo in IiveIIo, fino aI lermine deI rorio
oIisemico aIlro viaggio. II quaIe uo divenire iI viaggio slesso deIIa
noslra inleIIigenza.
Saiamo bene quanlo gIi slia a cuore, e non er molivi relorici,
rivoIgersi ai 'suoi' Iellori, aI unlo da invilare a riveder Ii voslri Iili
coIoro che senza esolerici riferimenli non siano, o non in simiIe
grado, fedeIi d'Amore, oure ancora non saiano come mellersi
er I'aIlo saIe deII'anagogica significazione. Infalli, erdendo me,
rimarresle smarrili (Par. II, 6). Non a caso Io dice.
Non e neure un caso che, rorio neI sonello concIusivo deIIa
Oanic anagcgicc 319
Viia Nucta e solloIineo queslo Nuova, queIIa che rende laIe Ia
ersonaIe carismalica nctiias arIi di inleIIigenza nova (V.N. XLI,
Sonello O|irc |a spcra cnc piu |arga gira, v. 3), inlendendo queIIa che e
causala da un 'vedere nuovo' dalo dagIi 'occhi' deIIo sirilo che si
concIudera con Ia finaIe visla nova (Par. XXXIII, 136).
Tulla I'oera di Danle, se Io si nola con Ia dovula allenzione,
corre inlorno a queslo lermine, er cui si assa daIIa lrallazione deIIa
vila resa nova daIIa conoscenza deIIa reaIla nova, ai novissimi
(Morle, Giudizio, Inferno, Iaradiso). Anche in queslo senso iI 'viag-
gio' di Danle e anagogico.
II suo aIlro viaggio non e frullo di fanlasia, ma reaIe viaggio
carismalico (di cui Danle non nasconde Ie recise fenomenoIogie) che
concede Ia conoscenza di lulla Ia reaIla: Ia nova e Ia novissima.
SoIo cos Ia reaIla viene ri-unila neII'unila sua.
La reaIla nova, rifacendoci aI Ialino, e queIIa 'uIlima', queIIa oIlre
Ia quaIe non ve n'e aIlra conceibiIe, cioe queIIa deIIo sirilo. I Danle
deIIo sirilo ha carismalica eserienza.
DaI momenlo deII'aaruil iam bealiludo veslra, Ia sua vila e
resa nuova. Quesla reaIla, gIoriosamenle sconcerlanle, roiellala in
ealrice, diviene Ia fondanle iI suo divenire iI 'Danle anagogico'. Ma
Danle sa bene che non verra credulo confessando aerlamenle, e
cerlamenle con ingenuila, Ia roria slraordinaria eserienza, ercio
Ia veIa, Ia scherma.
La reaIla deII'eserienza Io induce a raffigurarIa medianle una
roiezione, cioe iniziando queIIa jiciic che diverra aIlissima con Ia
Ccnc!ia.
La 'Iellera' deII'eserienza fonda Ia 'aIIegoria' deIIa sua manifesla-
zione.
Ier far queslo Danle si aroria dei modeIIi sliInovislico-corlesi
in modo da ceIebrare, canlare, servire, indicare agIi aIlri uomini (e
sludiosi) che non inlendono, queslo amore deI lullo nuovo, iI soIo che
uo rendere veramenle nuova Ia vila.
Ier far inlendere iu comiulamenle Ia vila nova su queslo
iano di inleIIigenza nova rinvio aI mio commenlo aIIa Viia Nucta,
iI rimo che ossa dirsi coerenle con I'anagogia, carismalicamenle
fondala, roria di Danle.
Isrimendomi cos come finora ho fallo, ho chiara coscienza dei
rischi cui vado inconlro anche suI iano cosiddello scienlifico, crilico,
fiIoIogico in senso sloricislico. Ma, considerando iI fallo che Ia nalura
deI documenlo sloricamenle inleso non ossa vaIere er aIlri iu
solliIi e rofondi documenli, che sono di nalura siriluaIe, ne deriva
che Danle ci debba informare non aIlrimenli che a||cgcricc inlorno aIIa
Villorio CozzoIi 320
reaIla deI rorio eserire Io sirilo.
Sa bene che non lullo uo essere siegalo ne dimoslralo. Iercio in
Ccntitic cos dice: Ne si maravigIi aIcuno se quesle cose e aIlre
ragioni che di cio avere olemo, non sono deI lullo dimoslrale (Ct. II,
v).
I come olrebbe dimoslrare Ia reaIla deI suo carismalico aIlro
viaggio, che e reaIla e non aIlissima fanlasia, cos che si inlenda come
I'aIlissima jiciic sia fondala su reaIla di eserienza`
Come olrebbe dimoslrare quanlo va dicendo di se, quando arIa
de Ia novilade de Ia mia condizione, Ia quaIe, er non essere da Ii
aIlri uomini eserla, non sarebbe da Ioro inlesa come da coIoro che
'nlendono Ii Ioro effelli ne Ia Ioro oerazione (Ct. II, vi)`
Come olrebbe dimoslrare er lulli queIIe reaIla, che aaiono
iene deI Ioro vaIore soIo er ochi, se cos afferma: a Ie secrelissime
cose noi dovemo avere oca comagnia (Ct. I, i)`
II rischio che si corre, arIando deIIe cose sacre, Ie iu finemenle
anagogiche in quanlo carismaliche, con chi Ie rifiula arrivando anche
ad averne faslidio, e leslimonialo daI VangeIo quando invila a non
dare Ie cose sacre ai cani erche non si rivoIlino conlro.
Non e, dunque, er caso o er relorica necessila iI fallo che Danle,
confessando aerlamenle Ia roria slraordinaria eserienza 'aradi-
siaca' (iI fu' io), si occui di coIoro che non credono a quanlo
leslimonia, e cos scriva, quanlo a se ed aIIa roria condizione cari-
smalica:
Se oi Ialrassero conlro Ia disosizione a eIevarsi er iI eccalo
di chi arIa, Ieggano DanieIe, dove lroveranno che anche
Nabuccodonosor er voIonla divina ha vislo aIcune cose conlro
i eccalori, e Ie dimenlico. Infalli 'chi fa sorgere iI suo soIe
sora i buoni e i callivi, e iove sui giusli e gIi ingiusli', ora ie-
losamenle er conversione, ora severamenle er unizione,
manifesla, iu o meno, come vuoIe, Ia sua gIoria a coIoro che
vivono er quanlo maIe (|p. XIII, 28).
II asso serve a Danle esuIe, inquisilo e braccalo, non ascela, ma
reso daIIa roria missione scrilloria in ro deI mondo che maI
vive er ricordare ancora una voIla che Ia sua eserienza e aIla-
menle carismalica.
Seguendo san Tommaso, che lralla dei carismi (neIIa q. 171 aIIa
fine deIIa Sccun!a Sccun!ac), saiamo che ciascuno di essi va inleso
come una gralia gralis dala, da Dio concessa non er Ia soIa sanlifi-
cazione ersonaIe di chi ne ha dono, ma er iI bene deIIa Chiesa e
Oanic anagcgicc 321
deIIe aIlre anime. Iercio Danle esrime giuslamenle iI rorio
ensiero, Ia roria inicniic rofelica, confermando I'Aulorila daIIa
quaIe roviene Ia roria condizione carismalica, quando cos scrive
ai CardinaIi d'IlaIia:
S, e vero: io sono una deIIe uIlime ecoreIIe dei ascoIi di Gesu
Crislo, e vero, io non abuso di nessuna aulorila asloraIe vislo
che non sono ricco. Ma queslo vuoI dire che sono queI che sono
non grazie aIIe ricchezze, ma er grazia di Dio e 'Io zeIo deIIa
sua casa mi divora' (|p. XI, 5).
Se Iello, queslo er grazia di Dio, neI conleslo di lulla Ia sua vila
e di lulla Ia sua oera, non uo non arire aIlrimenli Ia queslione
anagogica danlesca.
La quaIe inizia coI rimissimo manifeslarsi neIIa vila di Danle
deIIe fenomenoIogie riconducibiIi a queIIe descrille dai grandi mislici
eserienziaIi, siano essi sanli e non.
Con I'incipii deIIa vila nova inizia iI 'Danle anagogico', che laIe
diviene a arlire daIIa sconcerlanle visione deIIa mirabiIe ealrice,
cioe deIIa 'reaIla bealrice', queIIa deIIo sirilo, daI quaIe unicamenle
uo venire Ia bealiludine dei beali, come moslrera in Para!isc.
Ier quanlo ossa risuIlare incredibiIe agIi uomini, che comune-
menle mancano di quesla eserienza di visione-veggenza, Danle
'vede' Ia ealrice, cioe Ia reaIla che soIa uo dare Ia bealiludine.
Iossiamo anche definire quesla reaIla come 'Ia arle divina' deII'a-
nima. Che roiella in una donna reaIe, Ia ealrice slorica.
Iercio ealrice e donna da inlendersi duIicemenle: sia come Ia
giovane donna fiorenlina amala da Danle, sia come roiezione deIIa
roria anima. Inleressanli e imorlanli risuIlano, da queslo momen-
lo, gIi scambi lra Iellera e aIIegoria.
A queslo roosilo Danle e esIicilo quando definisce I'anima
come Ia donna che neI dificio deI coro abila (Ct. III, viii).
Irecisando uIleriormenle iI 'Iegame' lra anima e sirilo, Danle
ricorda che dei due fassi un'aIma soIa (Purg. XXV, 74).
I ercio assai reciso Danle quando arIa di queIIa ealrice beala
che vive in lerra con Ia mia anima (Ct. II, ii). Ma in aIlri assi e
ancor iu reciso, se ne abbia un esemio in queslo, che ci aiula a
cogIiere Ia slrella reIazione donna-anima: Iero dice quaI donna, cioe
quaI anima (Ct. III, xv).
Danle inlende Ia fiorenlina ealrice come significanle di un signifi-
calo che e Io Sirilo, iI rorio sirilo, Ia cui idenlila e di Iuce. Iercio,
correllamenle, Ia chiama gIoriosa. Anzi, iu giuslamenle, Ia gIorio-
Villorio CozzoIi 322
sa donna de Ia mia menle: come a dire che e quesla Ia donna
che diviene domina deIIa sua menle. I domina in quanlo Io e
deII'anima (arle animanle-animaIe), risellando I'ordine gerarchico
secondo Dio.
La documenlazione auloesegelica divenla chiara riIeggendo noi,
con seciaIe allenzione, iI secondo aragrafo deIIa Viia Nucta, dove gIi
'sirili' deI coro si Iamenlano deIIa suremazia che ora su Danle ha
Ia gIoriosa innamoranle beIIezza deIIo 'Sirilo'.
Danle, ero, sa bene che un'eserienza cos carismalicamenle
slraordinaria non avviene nei comuni uomini, Ia cui menle da aIlro
uo farsi dominare. Di iu, essi non riconoscono Ia menle cos come
fa Danle, quando cos scrive: Onde si uole omai vedere che e
menle: che e queIIa fine reziosissima arle de I'anima che e deilade
(Ct. III, ii).
L'eserienza sconcerlanle deIIa ealrice Io guida, dunque, aIIa
conoscenza iena e comIela deIIa reaIla anlrooIogica deII'uomo,
inlesa come unila di coro anima sirilo, cioe come esressione deIIa
reaIla lulla: visibiIe e invisibiIe, maleriaIe e siriluaIe, lemoraIe ed
elerna, umana e divina. Cioe unione di aIdiqua-sensi e di aIdiIa-
sirilo. A unire coro e sirilo e I'anima, che fa da onle lra i due. I
I'anima a rodurre Ie immagini.
Non e faciIe, in ogni lemo, arIare di anima e sirilo, sorallullo
dislinguendo lra anima e sirilo, vislo che, lra gIi aIlri, gIi slessi
carismalici san IaoIo e sanla Teresa d'AviIa ne lrallavano con ru-
denza, se non con lremore, rorio erche ne avevano conoscenza
eserienziaIe. Conoscevano Ia reaIla deI tcr|a !cjiccrc.
Danle, ero, quando ci dice che deIIe due reaIla, I'anima e Io siri-
lo, fassi un'aIma soIa (Purg. XXV, 74), assegna aII'anima iI comilo
rorio di ogni essere animaIe, cioe I'essere animalo, ed aIIo sirilo
queIIo rorio deIIe allivila inleIIelluaIi iu aIle, fino aIIe iu
anagogicamenle, mislicamenle, fini.
Ci vorrebbero ora, a soslegno deI 'Danle anagogico', i grandi misli-
ci a dirci quaIcosa di iu suI raorlo che I'anima ha coI coro e
queIIo che ha con Io sirilo, oure, iu correllamenle, queIIo che Io
sirilo ha con I'anima.
Dalo che Danle non Io nasconde, soIo un commenlo anagogico, deI
lullo 'novo', olra adegualamenle dirci di iu su quesli aselli deIIe
reIazioni siriluaIi resenli neIIa sua oera, che, semre iu, si evi-
denzia come oera di un dollore (dollrina dare).
A noi ora inleressa, arIando deI 'Danle anagogico', ricordare
quanlo imorlanli siano Ie arlicoIari fenomenoIogie vissule duranle
I'eserienza deIIa vila nova. I queslo, a arlire da quegIi slrani
Oanic anagcgicc 323
sonni che danno in seciaIi sogni in cui si manifeslano visioni
(non e iI caso ora di arofondire Ia queslione deIIa tisic in scnniis o
in vegIia e neure queIIa deIIa reaIla deIIe visione o deIIa veggenza
neIIe Ioro diverse manifeslazioni). Di quesle olrebbero un oco iu
imorlare queIIe e non sono oche che divenlano rofeliche circa
Ia roria vila e che Danle cerca di caire, in queslo aiulalo daIIe
sue guide (Amore in Viia Nucta e VirgiIio-ealrice-ernardo neIIa
Ccnc!ia).
Tullavia, quaIora fossero Ielle ed inlese soIo sicoIogicamenle e
non siriluaImenle, esse risuIlerebbero ridullive risello aIIa Ioro reaI-
la e, sorallullo, risello aIIa funzione che hanno neII'oera di Danle,
inlesa anche e sorallullo in ro deI mondo che maI vive. Non e
scorrello ricordare che iI maI vive diende anche da difello di
dollrina (dollrina dare, Ia quaIe aIlri veramenle dare non uo, Ct. I,
ii), di ammaeslramenlo (Dello e che er difello d'ammaeslramenlo
gIi anlichi Ia verilade non videro de Ie crealure siriluaIi, Ct. II, v)
inlorno aIIa reaIla nova e novissima.
Si deve ercio Ieggere con ri-novala allenzione quanlo Danle dice
a roosilo di ealrice, in vila e in morle. Si dice 'in morle' erche
anche quesla uo essere Iella come esressione di un'aIlissima feno-
menoIogia mislica. Sono slale, infalli, ormai ben sludiale lanlo Ia na-
scila quanlo Ia morle mislica. I a quesl'uIlimo roosilo mi soffermo
su un unlo assai imorlanle er I'inleIIigenza deI 'Danle anagogico'.
Se, come si e dello, aIIegoricamenle, o megIio anagogicamenle, si
accella ealrice come roiezione deIIo sirilo di Danle, aIIora si
risoIve faciImenle Ia crux, er Ia quaIe Danle Iascia ad aIlri Ia ceIebra-
zione deIIa 'morle' di ealrice in quanlo, se Io facesse, egIi si farebbe
Iaudalore di se medesimo. Iercio Iascia ad aIlro chiosalore iI comi-
lo, che olrebbe essere iI mio ora.
II considerare Danle e ealrice come Ia slessa ersona, o megIio
ealrice come arle deIIa lolaIila di Danle, rinvia ad un arlicoIare
non lrascurabiIe in chi Iegga aIIegoricamenle neI senso qui indicalo
ealrice. II Guardaci ben! en son, ben son ealrice (Purg. XX, 73),
neI Iaradiso lerreslre, solloIinea queI ci che rinvia ad un noi
non aIlrimenli inleIIigibiIe.
II 'Danle anagogico' e queslo Danle che non uo essere inleso er
vie slorico-fiIoIogiche, ma er aIlra via, mislico-carismalica.
Infalli iI raorlo lra Ia roria carismalica eserienza ersonaIe e
Ia sua resa aIIegorica viene da Danle associala ad un versello bibIico,
reso daI saImo CXIII: In exilu IsraeI de gylo. Tra i miIIe ossibi-
Ii, queslo, lre voIle reileralo, viene eIevalo da Danle aIIo siaius di
chiave ermeneulica.
Villorio CozzoIi 324
Mi are che fino ad oggi non si sia sufficienlemenle dalo vaIore a
queslo dalo. I un fallo inconleslabiIe: ogni voIla che Danle solloIinea
Ia roria oIisemia, semre si serve di queslo versello, cos aIlamen-
le simboIico.
I Iuoghi deIIa cilazione, ben conosciuli, sono: Ct. II, i, 6, Purg. II,
46-48, |p. XIII, 7.
A noi inleressa far emergere daIIa siegazione deI raorlo Iellera-
aIIegoria quanlo faccia riferimenlo aII'anagogia, sorallullo aII'ana-
gogia che riguarda ersonaImenle Danle.
Cio significa comrendere iI fallo che, quando Danle aIIude,
auloleslimoniando anagogicamenle, aII'uscila deII'anima daI coro,
con reciso riferimenlo aIIa roria eserienza, Io fa servendosi di
queslo versello.
L'uscila, I'in cxiiu deII'anima daI coro, uo accadere in due modi:
ordinario, con Ia morle che seara definilivamenle iI coro daII'anima,
slraordinario, con una uscila lemoranea (in quaIche modo ricondu-
cibiIe ad una morle mislica, carismalica).
Queslo uo essere dalo er fare un esemio reso daIIa fenome-
noIogia mislica slraordinaria da slali arlicoIari, che vanno dai vari
gradi di 'eslasi' (che, secondo san Tommaso, uo essere di due lii:
affelliva e di conoscenza), aI 'rallo', fino a arlicoIari aIlri slali di
veggenza.
Torniamo aII'In exilu IsraeI de gylo, oiche riguarda dirella-
menle iI 'Danle anagogico'.
Danle, riferendosi aII'aIIegoria, in Ccntitic e mi scuso er iI rie-
lere cose risaule dice che semre
Io IilleraIe dee andare innanzi, s come queIIo ne Ia cui senlenza
Ii aIlri sono incIusi, e sanza Io quaIe sarebbe imossibiIe ed in-
razionaIe inlendere a Ii aIlri, e massimamenle a Io aIIegorico
(Ct. II, i).
I assai imorlanle quesla solloIinealura deIIa reminenza deI
IelleraIe, oiche serve anche da base di riferimenlo er Ia reaIla degIi
eisodi mislico-carismalici di cui e rolagonisla. Issi sono Ia 'Iellera'
di Danle. Iercio, quando neII'|pisic|a XIII a Cangrande assegna
aII'anagogia Ia funzione di indicare I'in cxiiu deII'anima daI coro,
cos scrive: |.j se a queIIo anagogico, significa I'uscila deII'anima
sanla daI servaggio di quesla corruzione aIIa Iiberla deIIa gIoria
elerna (si ad anagogicum, significalur exilus anime sancle ab huius
corrulonis servilule ad elerne gIorie Iiberlalem, |p. XIII, 7).
In che senso lullo queslo fa riferimenlo aIIa ersona di Danle, aI
Oanic anagcgicc 325
'Danle anagogico'`
Lo si uo megIio inlendere rilornando aIIa Viia Nucta.
SceIgo un aio di assi di reciso riferimenlo a slali er i quaIi e
arorialo arIare di eserienza in exilu.
II rimo fa riferimenlo ad un eisodio che cos descrive:
AIIora fuoro s dislrulli Ii miei sirili er Ia forza che Amore
rese veggendosi in lanla roinquilade a Ia genliIissima
donna, che non ne rimasero in vila iu che Ii sirili deI viso, e
ancora quesli rimasero fuori de Ii Ioro islrumenli |.j (V.N.
XIV).
Cio muove I'amico a chiedere siegazioni a Danle, iI quaIe risonde
con aroIe aarenlemenle enigmaliche: Io lenni Ii iedi in queIIa
arle de Ia vila di Ia da Ia quaIe non si uole ire iu er inlendimenlo
di rilornare.
Non e iI caso di solliIizzare er cercare un'aIlra siegazione er
queslo slraordinario in exilu, suI quaIe, aena doo, Danle lorna
con quesle aroIe esIicalive: |.j cioe quando dico che Amore
uccide lulli Ii miei sirili e Ii visivi rimangono in vila, saIvo che fuori
de Ii slrumenli Ioro. IaroIe quesle cui fa seguire immedialamenle,
come necessarie qui iu che aIlrove:
I queslo dubbio e imossibiIe a soIvere a chi non fosse in simiIe
grado fedeIe d'Amore, e a coIoro che vi sono e manifeslo cio che
soIverebbe Ie dubilose aroIe: e ero non e bene a me di dichia-
rare colaIe dubilazione, accio che Io mio arIare dichiarando
sarebbe indarno, o vero soerchio.
Infalli inuliIe sarebbe er chi non gIi crede e suerfIuo er chi crede
aIIa reaIla deIIa sua eserienza in exilu.
L'aIlro cenno, a roosilo deII'eserienza in exilu deI 'Danle
anagogico', si lrova neI aragrafo XXIII deIIa Viia Nucta, Ia dove Ia
slrana 'assenza' di Danle fa dire ai resenli: Quesli are morlo.
AI Danle che in quegIi seciaIi momenli are morlo, ma morlo
ancora non e e non ha ancora subilo i rimi due nctissini, morle e
giudizio, e concesso iI rovvidenziaIe aIlro viaggio er avere ese-
rienza deIIo slalus animarum osl morlem (|p. XIII, 8). Ier quesla
via e er queslo modo uo dare immagine visibiIe a reaIla invisibiIi,
dala Ia condizione smaleriaIizzala degIi sirili.
I queslo er ricordare, a se e ai suoi Iellori, che gIi uomini sono
sirili incarnali, chiamali aI comimenlo uIlimo deIIa roria Iibera
Villorio CozzoIi 326
sceIla, che Dio conosce a| acicrnc e I'uomo comie, rendendoIa concre-
la neI lemo, er mezzo di queIIa sceIla deIIa dirilla via, dirilla via
deIIa giuslizia (dando a quesla un vaIore iu siriluaIe che slrella-
menle giuridico), che uo essere smarrila o rilrovala o erdula er
semre.
Queslo e Danle, iI 'Danle anagogico', queIIo che conosce er ese-
rienza carismalica Ia reaIla di cui arIa incessanlemenle, riunendo,
aIIa fine in un lullo, iI rinciio di laIi eserienze falle in vila nova
con iI Ioro comimenlo avvenulo con Ia divinizzazione in Dio.
Non e qui ossibiIe iniziare una camionalura deIIe eserienze
anagogiche cui fa riferimenlo Danle e che vanno coIle |iiicra|iicr quan-
lo aIIa Ioro reaIla, ma a||cgcricc quanlo aIIa Ioro resa, cioe neIIa jiciic.
Cosa che uo essere riferila a queIIa confessione di mislico e di scrillo-
re chiamalo a dire I'indicibiIe, come Ieggiamo neI XXIII deI Para!isc, a
roosilo deI figurando (Par. XXIII, 61):
Ma chi ensasse iI onderoso lema
e I'omero morlaI che se ne carca
noI biasimerebbe se soll'esso lrema
(Par. XXIII, 64-66)
Con quesle aroIe, vengo a me ed aI mio ersonaIe onderoso
lema, che consisle neII'arire una via nova a Danle, dando credilo
aIIa reaIla deI 'Danle anagogico' e, er conseguenza, cercando di dare
documenlazione di quanlo egIi, a queslo roosilo, dice di se neIIa
roria oera.
II mio conlribulo, suI quaI si olra conlinuare Ia ricerca, uo essere
veramenle inleso come nuovo. Cioe secondo Danle.
Da arle mia devo, dunque, confessare di aver avulo iI coraggio
di credere in queIIa via nova, in queIIa visla nova e in queIIa
inleIIigenza nova, di cui Danle arIa suI finire deIIa Viia Nucta,
Ia cui nctiias, inlesa secondo Danle, divenendo Iuce nuova (Ct.
I, viii), fa riferimenlo aIIa reaIla uIlima deIIa ReaIla, cioe aIIa reaIla
deIIo Sirilo, oIlre Ia quaIe non vi e aIlro da conceire (|p. XIII, 33), ne
da erseguire. SigiIIa, infalli, I'|pisic|a a Cangran!c con quesle aroIe:
Vedere Te e iI fine (|p. XIII, 33).
I queslo, e soIo queslo, iI fine deI suo aIlro viaggio, cioe queI
viaggio anagogico, coI quaIe Danle, guidalo da VirgiIio (roiezione
deIIa sua anima naluraIe non ancora divinizzala), da ealrice (roie-
zione deII'anima divinizzala, cioe deI suo sirilo in quanlo 'divino') e
da ernardo (roiezione deIIa sua ersonaIe condizione mislico-
carismalica slraordinaria) giunge aIIa divinizzazione, comiendo cos
Oanic anagcgicc 327
Ia roria missione scrilloria e rofelica. Quesl'uIlima e, dunque, da
inlendersi sia in chiave aocaIillica (in quanlo riveIaloria deIIe reaIla
siriluaIi, Ie erenni e I'Ilerna), sia in chiave oIilica, che non uo
essere scissa da queIIa aocaIillica.
Issendo iI mio Iavoro, er lulli quesli aselli, veramenle nuovo,
non ho olulo vaIermi di sludi recedenli, sia ure come fonli secon-
darie risello a quanlo Danle, come fonle rimaria, dice di se. Ho do-
vulo ercio muovermi con arlicoIare allenzione suI iano deIIe con-
seguenze melodoIogiche. Rilengo ossa essere consideralo scienlifico
aImeno iI conlribulo consislenle neII'aver reerilo i Iuoghi in cui neIIa
roria oera Danle dichiara, aerlamenle o veIalamenle, Ia roria
ersonaIe diversilade.
So bene che lullo queslo olrebbe muovere a resislenza chi abbia
deIIa scienlificila e deIIa reaIla una concezione diversa da queIIa di
Danle. Tullavia e Danle slesso iI rimo a comrendere quanlo fossero,
aI roosilo, dubbiose Ie rorie aroIe anagogicamenle aIIegoriche
(in quanlo roiezioni di eserienze slraordinariamenle carismaliche),
a arlire daIIe iniziaIi deIIa Viia Nucta.
In queslo giovaniIe IibeIIo, iI rorio uo aarire come aIcuno
arIare fabuIoso (V.N. II), ma, in difesa deIIa reaIla di esso, si servira
di aIlre aroIe, come quesle:
|.j e ero dico che queslo dubbio io Io inlendo soIvere e
dichiarare in queslo IibeIIo ancora in arle iu dubilosa, e aIIora
inlenda qui chi dubila, o chi qui voIesse oorre in queslo
modo (V. N. XII)
oure invila iI Iellore dubiloso a riIeggere quanlo dice in Ccntitic
quando solloIinea Ia radice de I'una deIIe diversiladi ch'era in me
(Ct. II, vii), oure quando scrive:
Dico adunque: Io credo, canzone, che radi sono, cioe ochi,
queIIi che inlendano le bene. I dico Ia cagione, Ia quaIe e do-
ia. Irima: ero che falicoso arIi 'falicosa' dico er Ia cagione
che della e , oi: ero che forle arIi 'forle' dico quanlo a Ia
novilade de Ia senlenza . Ora aresso ammonisco Iei e dico:
Se er avvenlura inconlra che lu vadi Ia dove ersone siano
che dubilare li aiano ne Ia lua ragione, non li smarrire, ma d
Ioro: Ioi che non vedele Ia mia bonlade, onele menle aImeno
Ia mia beIIezza (Ct. II, xii).
Dice queslo Ia dove inizia ad arire Ia verila aIIegorica deIIa
Villorio CozzoIi 328
Canzone Vci cnc nicn!cn!c i| icrzc cic| nctcic.
I dunque, ora di arire un discorso non generico suII'aIIegoria,
ma secifico suII'aIIegoria danlesca ed in seciaI modo suIIa sua
'anagogia', veramenle nuova, con Ia quaIe arIa deI rorio essere iI
'Danle anagogico'. I I'anagogia che ci orla in aIlo neII'inleIIigenza
siriluaIe di Danle.
A lull'oggi, infalli, manca una corrella e iena lrallazione inlorno
aII'aIIegoria anagogica, cos che, er conseguenza, manca un commen-
lo fiIoIogicamenle corrello dei significali anagogici sollesi a lulla
I'oera di Danle.
Dicendo 'lulla', si inlende rivoIgere I'allenzione non aIIa soIa
Ccnc!ia, ma anche aIIa fondanle Viia Nucta, aI Ccntitic che Ia orla
'raiicna|iicr iu in Ia. Non vanno dimenlicale cerle seciaIissime 'aIIe-
gorie' anagogiche rorie deIIe |inc, nonche essenziaIi cenni resenli
neI Mcnarcnia. Non e ossibiIe, risellando gIi sazi oggi consenlili,
arrivare aII'indicazione ed aII'anaIisi di lanli Iuoghi cos secifici,
merilevoIi deII'allenzione di una fiIoIogia veramenle nova.
A conforlo di quesla lesi, lullavia, uo essere dello che oggi anche
Ie scienze cominciano ad avere un diverso e meno ideoIogico aroc-
cio aIIe fenomenoIogie misliche slraordinarie.
Un segno imorlanle, riguardo aI nuovo alleggiamenlo scienlifico,
e dalo daI rifiulo di considerare laIi fenomenoIogie come unicamenle
rodolle da aIlerazioni aloIogiche. Le melodoIogie scienlifiche,
coerenlemenle coI rorio slalulo eislemoIogico, non ossono uscire
daII'ambilo Ioro rorio e 'senlenziare' inlorno aIIa reaIla smaleriaIiz-
zala, deIIo Sirilo. GIi slessi mislici si moslrano assai rudenli (e non
soIo er umiIla) quando, er riferire Ie aIlissime eserienze, devono
usare Ie Iimilanli e Iimilale aroIe umane.
Lo scienzialo eislemoIogicamenle corrello sa che, non olendo
uscire daI Iimile deIIa fisicila, non vuoIe andare aI di Ia deIIa sua
scienlifica IeggibiIila.
Irorio queslo e ben comreso e comunicalo da arle di VirgiIio a
Danle, che sla guidando fino aI Iimile deII'inleIIigenza razionaIe, che
da sensalo arende. MuovendoIo aI di Ia deI se razionaIe ed
avvicinandoIo aIIa reaIla bealrice (cioe I'anima divinizzala e roiel-
lala neIIa figura di una donna), cos uo dirgIi: Quanlo ragion qui
vede, / dir li oss'io, da indi in Ia, l'asella / ur a ealrice, ch'e ora
di fede (Purg. XVIII, 46-48). La queslione deI da indi in Ia e I'ana-
gogica.
Lo sirilo, er iI quaIe guida e ealrice, richiede aIlri modi di cono-
scenza, di eserienza. Se VirgiIio Io aiula a conoscere secondo Ie Ieggi
deII'anima naluraIe, ealrice gIi insegna aIlre Ieggi, queIIe deII'anima
Oanic anagcgicc 329
divinizzala, secondo Ia conoscenza sorannaluraIe roria deIIo siri-
lo.
La reaIla, di cui Danle lralla, e una, e neIIa sua lolaIila falla di
visibiIe e di invisibiIe, di maleriaIe e di siriluaIe, di lemoraIe e di
elerno, di umano e di divino.
Anche Ia reaIla anlrooIogica, coerenlemenle, secondo queslo
schema, e conceila e vissula da Danle come una, neIIa lriIicila deIIe
sue dimensioni: visibiIe iI coro, invisibiIi I'anima e Io sirilo.
Didallicamenle, si uo dire che I'anima fa da onle lra coro e si-
rilo. I Io si inlenderebbe iu a fondo se Ieggessimo anagogicamenle
anche iI Purgaicric, regno lemoraneo deIIa urificazione deII'anima,
dalo che iI Iaradiso e I'Inferno sono erenni neII'elerno.
Ier Danle I'unila deII'uomo si fonda suI modeIIo coI quaIe Dio I'ha
crealo, cioe con queI erfello equiIibrio lra coro-anima-sirilo, che fu
serimenlalo daI soIo Adamo, neIIe oche ore di sosla neII'Iden,
come Ieggiamo neI XXVI deI Para!isc.
I infalli con quesle aroIe che Danle, rienlralo neII'Iden dove ha
ri-guadagnalo Ia divinizzazione (ma non ancora I'indiazione) gIi si
rivoIge: O omo che maluro / soIo rodollo fosli (Par. XXVI, 91-92).
Qui maluro fa riferimenlo a queIIa unila in erfello equiIibrio
(equiIibrio lra coro-anima-sirilo) che si erdelle a causa deIIo
squiIibranle lraassar deI segno, cui consegu I'in cxiiu daII'Iden. La
malurila e queslo erfello equiIibrio, cos difficiIe da raggiungersi da
arle deII'ncnc tiaicr.
Iuori daII'Iden I'uomo fa eserienza deIIa erdila deII'originario
equiIibrio (I'unila di queIIa forma, orma, norma che si nomina
aII'inizio deI Para!isc) e serimenla Io squiIibrio er cui, er maIo uso
deIIa Iiberla, uo divenire seIva. Cio accade quando iI coro si ribeI-
Ia aIIo sirilo e chiede reolenlemenle, dis-misuralamenle, iI suo.
GIi islinli-aIberi deI coro, creali buoni e er iI bene, caovoIgono
iI Ioro senso e scoo, non iu onendosi come mezzi aI servizio deIIo
sirilo. Cosa quesla che san IaoIo siega assai bene, indicando Ia Ieg-
ge deII'uomo de-cadulo daII'originaria condizione.
Non a caso Danle dice che quesla seIva, che ognuno serimenla
in se, non soIo e seIvaggia, asra e forle, ma ha anche iI duro olere
di rendere oscura I'inleIIigenza.
Quesl'uIlima erde rogressivamenle iI suo raorlo con Ia reaIla
nova, Ia quaIe e er sua nalura Iuminosa, e chiede di essere nuova-
menle resliluila aIIa 'gIoria' originaria.
SeIva diviene iI coro, quando, rollosi I'equiIibrio originario,
e sosliluendosi aIIa gIoriosa donna de Ia mia menle, Ia donna-
domina, domina con i suoi islinli I'inleIIello e imedisce aII'uomo di
Villorio CozzoIi 330
vedere Ia Iuce e goderne. Di iu, se gIi fosse ossibiIe imedirebbe,
negandoIa, I'esislenza slessa deIIo sirilo, Ia sua resenza reaIe.
Ier queslo Danle neI suo Ccntitic scrive:
che non aIlrimenli sono chiusi Ii noslri occhi inleIIelluaIi, men-
lre che I'anima e Iegala er Ii organi e incarcerala er Ii organi
deI noslro coro (Ct. II, iv).
Non dice queslo erche Ia sua fonle e IIalone, ma erche conosce
er ersonaIe eserienza, grazie aII'in exilu, cosa e anima-sirilo
(un'aIma soIa, Purg. XXV, 74) e cosa coro: soIo grazie a quesla
eserienza carismalica conosce Ia differenza quaIilaliva deIIa cono-
scenza lra 'er mezzo deI coro' e 'fuori deI coro'.
II coro rende in-visibiIe iI visibiIe, Io liene come rigioniero,
lanlo da muovere Danle (in quanlo mislico gia 'eserlo' deIIe slraor-
dinarie fenomenoIogie carismaliche) a desiderare sesso, come accade
ai grandi mislici, queII'in exilu IsraeI de gylo, che serimenla a
arlire daIIa uerizia e daIIa rima giovinezza. Qui si comrende iI
vaIore deI finaIe I'ardor deI desiderio in me finii (Par. XXXIII, 48).
Tullavia, erduli I'in exilu e gIi eisodi carismalici doo Ia
morle di ealrice, essi saranno saIvificamenle a Iui ri-donali in modo
da oler comiere (in ro deI mondo che maI vive) iI suo carismali-
co aIlro viaggio.
I queslo iI molivo er cui Danle richiama Ia necessila deII'in
exilu nei Iuoghi iu imorlanli dei suoi riferimenli aII'anagogia.
L'in exilu e iI modo slraordinario che consenle iI rilorno neIIa
reaIla aIla deIIo sirilo, neII'a|ius/rofondo deIIo sirilo. Cioe in CieIo.
Ier Danle lullo queslo, di cui andiamo arIando, non e ura jiciic,
ma e reaIla, e rorio da cio viene Ia forlissima insislenza suIIa
necessila di un'inleIIigenza aIIegorico-anagogica.
A richiamare i suoi Iellori si aIica non soIo leoricamenle Ia dove
(sorallullo in Ccntitic) esIica Ia dollrina aIIegorica (Ct. II, i), ma
sorallullo in quei Iuoghi dove esIicila sesso, lullavia, scherman-
do, a arlire daIIa Viia Nucta iI riferimenlo aIIa roria fenomenoIo-
gia mislico-carismalica slraordinaria.
Iino ad oggi non si e ancora osla reaImenle Ia queslione deII'a-
nagogia in Danle, ne, lanlo meno, queIIa deIIa seciaIe condizione
ersonaIe di Danle. Iiu sesso Ia si e coIla in lermini di ura relorica e
cos si e finilo er ridurne I'imorlanza. Infalli Ia si e ridolla o emar-
ginala, o in icic negala.
Ier queslo dicevo che Danle e reolenlemenle lornalo lra noi,
ma non lullo, oiche Ia arle iu beIIa e nova deIIa sua oera anco-
Oanic anagcgicc 331
ra viene Iasciala in esiIio, non IasciandogIi dire queIIo che era sua
inlenzione comunicare secondo Ia sua inicniic prcjun!icr. Cioe ricorda-
re agIi uomini, leslimoniando er carismalica conoscenza, Ia Ioro
idenlila di sirili incarnali ed iI Ioro 'novissimo' fine.
C'e un aIlro asello da considerare circa Ia queslione anagogica e
Ia secifica anagogia danlesca: queIIo er cui Danle non fa coincidere
Ia roria anagogia con queIIa liica deII'esegesi bibIica medievaIe.
Non Ia nega, anzi orlodossamenle se ne serve, non lrovando conlrasli
lra Ia roria eserienza anagogica (nova e novissima) e queIIa
dei nctissini (Inferno, Iaradiso).
I semre veriliero a queslo roosilo, dalo che si e semre reoc-
cualo di dare fondamenlo aI IilleraIe (Ct. II, i), indicando come
'IelleraIe' Ia slraordinariela deIIe rorie eserienze (|p. XIII). Non e
un caso che neII'|pisic|a ai CardinaIi d'IlaIia, facendo riferimenlo aIIa
roria missione rofelico-scrilloria, cos dica di se:
|.j s, e vero: io non sono una deIIe uIlime ecoreIIe dei ascoIi
di Gesu Crislo, e vero, io non abuso di nessuna aulorila aslo-
raIe vislo che non sono ricco. Ma queslo vuoI dire che sono queI
che sono non grazie aIIe ricchezze ma er grazia di Dio e 'Io
zeIo deIIa sua casa mi divora' (|p. XI, 5).
II richiamo risenle deII'incessanle ammonimenlo rofelico deIIa
Chiesa carismalica aIIa Chiesa isliluzionaIe, cosa che rinnova un
conlraslo, o una invilo aIIa coIIaborazione, gia resenle, a arlire dagIi
inizi slessi deIIa Chiesa (con Ia disula lra Iielro e IaoIo, ma anche
resenle neI VangeIo di Giovanni).
QueIIa danlesca e un'aIIegoria da considerare con allenzione.
I rima di enlrare neIIa queslione deI 'Danle anagogico', con i
riferimenli necessari che Danle fa circa se, e forse oorluno riconsi-
derare quaIe aIIegoria ossa essere idonea a Danle.
In genere, sludiando I'aIIegoria di cui si occua I'esegesi bibIica
medievaIe, ci si rifa agIi sludi di Henri de Lubac oure a cerli aIlri
condolli dai domenicani suI sislema esegelico di san Tommaso,
evilando di giungere a cerle esaserazioni inlorno aI IelleraIismo o
aII'aIIegorismo.
Comunque sia, I'aIIegoria, fondala suIIa Iellera, revede lre succes-
sivi IiveIIi: I'aIIegoria vera e roria, Ia lrooIogia e I'anagogia. Danle
slesso ne da conferma neI Ccntitic e neII'|pisic|a XIII.
Cerlo, c'e slalo chi ha voIulo inverlire Ia osizione deIIa lrooIogia
e deII'anagogia, con ragioni giuslificanli laIe inversione, cos da mo-
slrare iI erche finaIe di un IiveIIo iulloslo che deII'aIlro. aslerebbe
Villorio CozzoIi 332
riandare aIIe disule medievaIi lra francescani e domenicani, ma in
lermini danleschi Ia queslione e risoIvibiIe rorio a arlire daIIa rella
imoslazione deIIa sua aIIegoria. Che olrebbe essere cos esressa:
Danle va daIIa lerra in CieIo, e queslo saIire e Ia sua anagogia, ma oi
lorna daI CieIo in lerra a rofelizzare inlorno ai lraIignamenli, e
queslo e Ia sua lrooIogia.
C'e da arire nuovamenle iI discorso, oslo daI 'Danle anagogico',
inlorno aIIe due arli deIIa lriIice aIIegoria.
Ier avvicinarci in modo iu arofondilo ad essa, ora vorrei fare
due riferimenli.
II rimo aII'|ncic|cpc!ia !anicsca, cioe aIIa voce dedicala aI lermine
'anagogico', iI secondo aI Oiciicnnairc !c Spiriiua|iic, di cui iu avanli
mi serviro.
L'|ncic|cpc!ia !anicsca dedica aIIa voce 'anagogico' oco iu di una
coIonna, conlro, er fare un esemio, Ie iu di cinque concesse aIIa
voce 'anafora', che Ia recede. Gia quesla e una sia deII'al-
leggiamenlo, o non ancora inleso o vioIenlemenle ridullivo, di moIla
danloIogia verso I'anagogia danlesca.
Secondo I'eslensore deIIa voce, I'anagogico e lermine lecnico,
coI quaIe si designa
queI rocedimenlo inlerrelalivo (senso aIIegorico) er iI quaIe
iI leslo deIIa Scrillura, Iello aIIa Iuce deIIe verila sureme,
diviene uno slrumenlo di sueriore conoscenza.
Afferma anche che Danle Io chiama sovrasenso, ma non Iascia
megIio comrendere come vada cio inleso, Iasciando iI Iellore in
una condizione di dubbio inlerrelalivo. II che significa: o inlenderIo
come un senso rioslo sora un aIlro di base (con fondamenlo slorico-
IelleraIe, ideoIogico-cuIluraIe) allraverso un'arbilraria allribuzione
aggiunliva di significalo, che in se Ia Iellera non avrebbe, oure
come un senso oslo a IiveIIo iu a|ius, neIIa Iellera slessa e che ne e
coslilulivo inlegraIe ma nascoslo.
Quesl'uIlima e Ia osizione di Danle (vedi Ct. II, i): semre Io
IelleraIe dee andare innanzi, s come queIIo ne Ia cui senlenza Ii aIlri
sono inchiusi). Ierlanlo, er essere inleso secondo iI 'Danle anagogi-
co', Ia ienezza deI suo sislema oIisemico richiede aI suo Iellore
un'inleIIigenza nova, siriluaIe.
Torniamo aIIa voce deII'|ncic|cpc!ia: essa chiude Ia breve lrallazio-
ne inlorno aII'anagogico con quesle aroIe: I robabiIe che Danle
non rilenesse in definiliva di oler allribuire aIIa sua oera iI iu
liico dei sensi bibIici. I queslo nonoslanle I'esIicila dichiarazione
Oanic anagcgicc 333
di Danle a roosilo deIIa roria inicniic.
Su queslo non oler allribuire aIIa sua oera un significalo anago-
gico Danle olrebbe sorridere, vedendo quanlo scarso credilo e quan-
la scarsa allenzione viene dala a lulla Ia roria auloleslimonianza,
donala come indisensabiIe auicacccssus, nonche aIIa roria insosli-
luibiIe auloesegesi. II robIema, come si uo ben caire, e assai iu
che di nalura melodoIogica.
II discorso si fa qui solliImenle fiIoIogico e olrebbe indurre iu di
un Iellore a ricordare cerli avverlimenli di Danle a chi non caisce
queIIo che va dicendo, regandoIo, come in Ccntitc, di Iasciar erde-
re.
Danle richiede, anche aIIa noslra fiIoIogia, di essere fedeIe, iu che
aI rorio slalulo scienlifico, slorico-cuIluraIe, aI rorio comilo
originario, che e queIIo di resliluire ai Iellori un'oera neIIa originaIila
deII'inicniic prcjun!icr che I'ha originala.
NeI caso di Danle cio induce a considerare nuovamenle Ia sua
oera, risellandone Ia lolaIila e Ia ienezza. NeI caso di Danle,
I'allenzione deve essere osla suIIa lolaIila deIIa sua roduzione e
suIIa ienezza deIIa sua oIisemica scrillura.
La quaIe, a rellamenle considerare secondo Danle, e lulla osla
sollo iI segno deIIa nctiias, iniziandosi essa con Ia vila nova e
concIudendosi con Ia lrallazione dei nctissini: Morle, Giudizio, Infer-
no, Iaradiso.
Tra noi e Danle Ia dislanza o Ia vicinanza sla neIIa maggiore o
minore condivisione deI concello di ReaIla. Ma saiamo bene: queIIe
che er Danle sono deIIe reaIla, non Io sono iu er una cuIlura, come
Ia noslra, a dominanza iu scienlisla che scienlifica.
Iercio, se Ia fiIoIogia oera con un melodo a base marcalamenle
sloricislica e scienlisla, si lrova eislemoIogicamenle rivala degIi
slrumenli necessari er indagare una reaIla che, ur essendo uguaI-
menle reaIe, e aIlra risello a queIIa fisica.
Iercio manca degIi slrumenli er orsi in corrella Iellura dei signi-
ficali aIIegorici rori di Danle, che ha in comune con I'universo me-
dievaIe moIla deIIa simboIogia, ma risello a quesla ha a disosizione
Ia ersonaIe eserienza, carismalica, deIIe reaIla che sono di fede.
Lo si riele, erche ancora una voIla necessario: Danle e Ia fonle
rima deIIe rorie conoscenze deIIa reaIla 'aIlra', Ia in-visibiIe, non e
iI risuIlalo di una lrascrizione oelica di aIlre fonli. Quando oera in
queslo modo, Io fa ad eserienze avvenule, in modo da oler comuni-
care Ie rorie er mezzo di un immaginario accessibiIe ai rori Iel-
lori.
Danle, infalli, da forli segnaIi di auloleslimonianza mislico-
Villorio CozzoIi 334
carismalica, laIi da orre Ia sua slessa aIIegoria sollo Ia calegoria deIIa
aIIegoria dei mislici, diversa sia da queIIa dei relori sia da queIIa dei
leoIogi o bibIica.
Con quesl'uIlimo modeIIo di riferimenlo e ossibiIe suerare queI-
Io, lradizionaImenle accellalo, deIIa dislinzione lra 'aIIegoria dei oeli'
(relorica) e 'aIIegoria dei leoIogi' (bibIica).
Dovendo noi affronlare I'anagogia, che e uno dei modi deII'aIIe-
goria, o megIio, dovendo noi affronlare iu secificamenle queIIa
danlesca, Ia biarlizione recedenlemenle richiamala non basla.
Seguendo Ie indicazioni dale daIIa voce aIIegorie deI Oiciicnnairc
!c Spiriiua|iic, ossiamo fare riferimenlo ad una lriIice dislinzione
lra Ie modaIila deII'aIIegoria: aIIegorie des relheurs, aIIegorie de Ia
ibIe, aIIegorie des mysliques.
Doo aver rielulo iniziaImenle Ia definizione che deII'aIIegoria
da sanl'Agoslino, cioe un lrous ubi ex aIio aIiud inleIIigilur (Oc
Trin. XV, 9, 15), Ia voce assa a lrallare I'aIIegoria dei relori, cilando Ia
definizione che QuinliIiano da allraverso I'aIiud verbis, aIiud sensu
oslendil (|nsi. crai. VII, 6), ad essa I'eslensore deIIa voce fa seguire Ie
recisazioni suII'aIIegoria deIIa ibbia o siriluaIe.
Qui si one una dislinzione fondamenlaIe risello a queIIa dei re-
lori: quesl'uIlima e verbaIe, Ia bibIica o siriluaIe e reaIe, cioe, queIIa
dei relori sla neIIe aroIe, queIIa bibIica nei falli cui aIIudono. Ier que-
sla via si inlende in modo nuovo, o novo, iI raorlo lra reaIla e
jiciic, neI quaIe si rilrovano, accomunali, gIi uomini di lulli i lemi.
II riferimenlo aIIa reaIla deIIo sirilo, se e laIe, non aarliene soIo
agIi uomini deI Medioevo crisliano, ma anche ai credenli ed agIi
uomini siriluaIi di ogni lemo. Tra quesli uIlimi emergono i mislici
eserienziaIi, i quaIi esrimono Ie Ioro fenomenoIogie allraverso
un Iinguaggio arlicoIare (amiamenle sludialo nei noslri anni), caral-
lerizzalo daIIe indicazioni dale circa i modi ed i IiveIIi deII'eserienza
slessa, sia ure ad modum reciienles (|p. XIII, 20).
Dello queslo, ossiamo avvicinarci aII'aIIegoria dei mislici er
megIio avvicinarci a queIIa danlesca, lenendo, ero, ben resenle che
quesla non coincide, come arrebbe ai iu, con queIIa dei oeli.
La voce deI Oiciicnnairc !c Spiriiua|iic dice che Ia 'aIIegoria dei mi-
slici' lienl de Iilleraire el de I'aIIegorie bibIique, cioe arlecia deIIe
carallerisliche sia relorico-Iellerarie, sia bibIico-siriluaIi.
A megIio inlendere, recisa che Ia 'aIIegoria dei mislici' non uo
consislere soIo neIIe melafore verbaIi, in quanlo Ie aroIe dei mislici,
queIIe in cui si esIica I'aIIegoria, hanno un vaIore che resuone
una riveIazione rivala e cerle segrele reIazioni con Dio, neIIo slesso
lemo, lullavia, non uo coincidere con I'aIIegoria bibIica, vislo che iI
Oanic anagcgicc 335
carallere rivalo deIIe comunicazioni misliche e laIe da indurre a
rudenza (sicoIogica, oIlre che leoIogica) chi Ie riceva. Rimane,
lullavia, sconcerlanle iI fallo che soIo Danle, aII'infuori degIi scrillori
bibIici canonici, si serve coscienlemenle deIIa oIisemia bibIica. Anche
su queslo asello ci sara da indagare.
Cerlo, Ia rudenza! Non si dimenlica, infalli, che gIi slessi grandi
mislici-dollori (resi laIi da carismalica missione scrilloria) invilano a
non vedere ovunque aIIegorie. Queslo insegnano, come Danle fa neI
Ccntitic, san Tommaso, sanla Teresa d'AviIa e moIli aIlri.
La voce deI Oiciicnnairc !c Spiriiua|iic recisa ancor megIio quesla
aIIegoria roria dei mislici. Cos Ia lraduco: Come Ie due aIlre,
I'aIIegoria dei mislici inlroduce una cosa daI camo ideaIe neI camo
deI mondo sensibiIe er ricondurIa, allraverso iI veicoIo deIIa melafo-
ra, daI camo deI mondo sensibiIe a un nuovo camo ideaIe. Occor-
re, neI noslro caso, che e Danle, evilare I'equivoco di idenlificare
I'ideaIe con Io siriluaIe (che viene daII'eserienza deII'in exilu daI
coro).
Cio significa orlare un'eserienza deIIo sirilo neI camo deIIa
sensibiIila, fisica o cororea che sia, allraverso Ia aroIa melaforizzala,
in modo da ricondurre quesl'uIlima aIIa sua significazione siriluaIe,
aIlrimenli indicibiIe.
I iI discorso deIIa successione dei momenli generalivi: I'eserienza
in sirilo e Ia reaIla da esrimere, soIo a osleriori Ia sua crealiva
lrascrizione avverra er mezzo di una jiciic.
Qui sla iI robIema deI 'Danle anagogico': neI comrendere che Ia
reaIla eserila viene oi scrilla allraverso Ia iu aIla jiciic mai esres-
sa.
Iercio iI mislico, che esrime Ia roria eserienza, ha in se Ia
fonle rima deI rorio vedere, conoscere.
Le risorse er esrimere laIe carismalico 'vedere' variano da misli-
co a mislico, ma esse si esaIlano nei mislici chiamali a missione scril-
loria. La calegoria dei mislici scrillori o queIIa degIi scrillori mislici
lendono a confondersi, anche se non a coincidere.
Tullo queslo, sia ur dello in grande sinlesi, serve er far inlende-
re che I'aIIegoria di Danle, di cui I'anagogia e arle inlegranle, uo
essere avvicinala a queIIa roria degIi uomini resi mislici dai doni
carismalici di Dio.
Lo slesso Danle sa bene che ochi avrebbero dalo credilo aII'aulo-
leslimonianza circa Ie fenomenoIogie carismaliche, di cui gIi cxccssus
ncniis sono soIo una deIIe forme da Iui serimenlale, essendovene
aIlre (Ie visioni in scnniis si aIlernano a queIIe 'in vegIia'). Sa che i iu
incIinano ad inlendere come fanlasiose o fanlasliche Ie sue 'visioni' e iI
Villorio CozzoIi 336
suo aIlro viaggio, cioe accellandoIo non come reaIla ma come ese-
dienli oelici, squisilamenle Iellerari, negandogIi queI credilo che vie-
ne riconosciulo daIIa Chiesa quando canonizza i rori Sanli, e che,
ur canonizzando, riconosce come rivale Ie riveIazioni deI mislico.
Danle non era ne ascela, ne era riconosciulo er arlicoIare sanlila.
Di iu, era erseguilalo da una Chiesa non cerlo disosla a dare
credilo aIIa sua rofezia oIilica ne, meno ancora, aIIa sua seciaIe
condizione carismalica ed aIIa verila deI suo 'aIlro vedere'. Ma queslo
doversi roleggere daII'incomrensione o dagIi allacchi dei suoi ne-
mici era comincialo assai rima deIIe queslioni oIiliche. Ira inizialo
negIi anni deIIa rima infanzia e deIIa giovinezza, quando Ia sua vila
era slala sconvoIla daII'aaruil bealiludo veslra, daIIa eserienza
deIIa gIoriosa donna, deIIa 'reaIla bealrice', roiellala sliInovisli-
camenle neII'amore er una donna, chiamala ealrice, senza che gIi
aIlri avessero coscienza deI che si chiamare. Da qui rese ad aulo-
commenlarsi, a scrivere oere che aIlro non erano che un aulocom-
menlo di slraordinarie eserienze.
Danle diviene Danle er quesla via, nova e novissima.
Assai imorlanle e, dunque, quanlo esresso aII'inizio deI Ccnti-
tic, dove si Ieggono quesle aroIe, assai conosciule, ma forse non
inlese iu a fondo, cioe secondo iI 'Danle anagogico':
I se ne Ia resenle oera, Ia quaIe e Convivio nominala e vo'
che sia, iu viriImenle si lrallasse che ne Ia Vila Nuova, non in-
lendo ero a queIIa in arle aIcuna derogare, ma maggiormenle
giovare er quesla queIIa, veggendo s come ragionevoImenle
queIIa fervida e sassionala, quesla lemerala e viriIe esser
convenienle (Ct. I, i).
Veramenle decisivo e queslo asso, er inlendere iI 'Danle anago-
gico', cioe iI Danle che conferma Ie eserienze mislico-carismaliche
deIIa roria vila nova, ma senle Ia necessila di dirIe in modo laIe
da non farIe aarire un arIare fabuIoso, ma uno degno di essere
lrallalo razionaImenle, secondo ragione, e quindi di renderIo aIlri-
menli inleIIigibiIe.
CoI Ccntitic Danle rinviava aII'inizio slesso deIIa roria vila, resa
aunlo nova daIIa visione deIIa reaIla nova, cioe uIlima, che e Io
sirilo, che viene roiellalo in ealrice, resa cos figura deIIa reaIla
ealrice resenle in ogni uomo.
TaIe non olrebbe essere ne Ia reaIla deI coro ne queIIa deII'ani-
ma, dalo che ne I'uno ne I'aIlra danno bealiludine, ma asseggeri, non
aaganli soddisfacimenli e slali emolivi, come gIi innamoramenli
Oanic anagcgicc 337
assionaIi.
Ier queslo Danle arIa di amore nuovo in un ambilo, quaIe
queIIo sliInovislico, che ensava di aver fissalo una nuova condizione
e un nuovo Iinguaggio deII'eserienza d'amore.
La nctiias di Danle e ancor iu sconcerlanlemenle nuova di queIIa
sliInovislica, deI cui Iinguaggio, lullavia, si serve, ben comrensibiI-
menle, er iu di un molivo. L'amore nuovo di Danle suera quaIi-
lalivamenle queIIo sliInovislico: sicoIogico quesl'uIlimo, siriluaIe iI
suo.
I Io sirilo novo che rende I'anima non iu soIo animala e
animaIe, ma in quaIche modo 'divina', cioe simiIe aI Dio che ha voIulo
creare I'uomo simiIe a Se, facendone uno sirilo incarnalo. A queslo
riconoscimenlo Danle vuoIe condurre i suoi Iellori, er condurIi oi
assai iu in Ia.
C'e, insomma, una queslione anagogica danlesca che riguarda Ia
sua ersona, cioe queIIa sua seciaIe condizione che gIi consenle di
esrimersi con aroIe come quesle, leslimonianli
Ia novilade de Ia mia condizione, Ia quaIe, er non essere da Ii
aIlro uomini eserla, non sarebbe da Ioro inlesa come da coIoro
che 'nlendono Ii Ioro effelli ne Ia Ioro oerazione (Ct. II, vi).
Queslo Io aulorizza a dire queIIo che ad aIlri non e concesso:
L'aIlra e quando, er ragionare di se, grandissima uliIilade ne
segue aIlrui er via di dollrina |.j muovemi desiderio di dol-
lrina dare Ia quaIe aIlri veramenle dare non uo (Ct. I, ii).
Cos si rivoIge a coIoro che neI suo e neI noslro lemo non inlen-
dono Ie diverse forme deI vedere neIIa Ioro lolaIila e mancano
deII'eserienza deI vedere 'in sirilo'.
Ier queslo Danle deve essere evangeIicamenle rudenle. Sa che iI
consigIio di non dire a lulli Ie reaIla iu rofonde e sacre non e soIo
un comandamenlo necessario er dislinguere iI dire essolerico da
queIIo esolerico, ma un nascondere Ia roria eserienza, che sarebbe
assai da ochi inlesa e condivisa. Rinvia, ercio, aI VoiaIlri ochi
deI canlo II deI Para!isc.
Cos, quando in Ccntitic, er confermare quanlo riveIalo di se
neIIa Viia Nucta, scrive I avvenga che duro mi fosse ne Ia rima en-
lrare ne Ia Ioro senlenza, finaImenle v'enlrai enlro, quanlo I'arle di
grammalica ch'io avea e un oco di mio ingegno olea fare, er Io
quaIe ingegno moIle cose, quasi come sognando, gia vedea, s come ne
Villorio CozzoIi 338
Ia Vila Nuova si uo vedere (Ct. II, xii), da conferma, anni doo, aIIa
reaIla deIIa fenomenoIogia mislica, che Io ose in reIazione aIIa reaIla
deIIo sirilo. Id e cio che fa di Danle iI 'Danle anagogico' non ancora
riconosciulo, Iascialo ancora in esiIio.
Pccia c saggisia, Crcncna
Oanic anagcgicc 339
RIIIRIMINTI ILIOGRAIICI
VITTORIO COZZOLI, IRMINIA LUCCHINI, Iciiura anagcgica !c| canic XX|||
!c| Para!isc, orgo aIIa CoIIina, Arezzo, Accademia Casenlinese di
Lellere Arli Scienze ed Iconomia 1981.
VITTORIO COZZOLI, || Oanic anagcgicc. Oa||a jcncncnc|cgia nisiica a||a
pccsia anagcgica, Chieli, SoIfaneIIi 1993.
DANTI ALIGHIIRI, Viia nucta, inirc!uzicnc c ccnncnic !i Viiicric Cczzc-
|i, MiIano, IDIS 1995.
VITTORIO COZZOLI, || tiaggic anagcgicc. Oanic ira tiaggic sciananicc c
tiaggic carisnaiicc, Triesle, alleIIo 1997.
ID., Oanic anagcgiquc, Coscience. L'Age d'Homme, III (2001).
ID., Oanic ci |a paix, in Ccngrcs |nicrnaiicna| !c |Asscciaiicn !cs Sccicics
!c Pni|cscpnic !c Ianguc |ranaisc, Iaris, Vrin 2002.
ID., U|i ancr i|i ccu|us. Icccnic !i Pcun!, Ia prcjczia !c||a pccsia, G|i cc-
cni !i Bcairicc, Rimini, RaffaeIIi 2005.
ID., Ia gui!a !c||c gui!c. Oanic scccn!c Oanic, Triesle, alleIIo 2007.
ID., Icggcrc Oanic scccn!c Oanic. Trc |czicni !anicscnc (14, 21, 28 ariIe
2010), Cremona, Idilrice ADAIA 2010.
INRICO CATTANIO
DANTI I I IADRI DILLA CHIISA
NeI Canlo IX deI Para!isc, Danle fa dire a IoIco da MarsigIia,
oi vescovo di ToIosa, una aroIa crilica conlro gIi eccIesiaslici deI
suo lemo, e concIude nei seguenli lermini (vv. 133-135):
Ier queslo I'IvangeIio e i dollor magni
son dereIilli, e soIo ai DecrelaIi
si sludia, si che are a' Ior vivagni.
Dunque, secondo Danle, i maIi che affIiggono Ia Chiesa sono
causali daI fallo che si e abbandonalo Io sludio deIIa sacra Scrillura
(||tangc|ic) e dei Iadri deIIa Chiesa (i !ciicr nagni), er occuarsi di
DecrelaIi, cioe di queIIe queslioni di dirillo canonico, che regoIavano
Ie assegnazioni deIIe rendile e dei benefici. I inleressanle anzilullo
nolare come Danle associ Ia Scrillura e i Iadri in uno slrello binomio:
in effelli, er i Iadri deIIa Chiesa Ia Scrillura fu un coslanle unlo
di riferimenlo, essi, come dice una Islruzione deIIa Congregazione er
I'Iducazione CalloIica, sono in rimo Iuogo ed essenziaImenle dei
commenlalori deIIa Sacra Scrillura
1
. Senza aIcun dubbio, Ia Sacra
Scrillura era er essi, come si Iegge ancora daI suddello Documenlo,
oggello di incondizionala venerazione, fondamenlo deIIa fede,
argomenlo coslanle deIIa redicazione, aIimenlo deIIa iela,
anima deIIa leoIogia. Ne hanno semre soslenulo I'origine di-
vina, I'inerranza, Ia normalivila, Ia inesauribiIe ricchezza di
vigore er Ia siriluaIila e dollrina
2
.
VaIe er lulli cio che iI grande sludioso e slorico deII'anlichila crislia-
na, Henri-Irenee Marrou, ha dello a roosilo di sanl'Agoslino:
1 CONGRIGAZIONI IIR L'IDUCAZIONI CATTOLICA, Ic siu!ic !ci Pa!ri !c||a Cnicsa nc|-
|a jcrnazicnc saccr!cia|c. Islruzione, 10 novembre 1998, n. 26. Cfr. AGOSTINO, || |i|crc
ar|iiric, 3,21,59, Ia Triniia, 2,1,2: i Iadri sono !itincrun |i|rcrun iraciaicrcs.
2 Ic siu!ic !ci Pa!ri, cil., n. 26.
Inrico Callaneo 342
La sacra Scrillura e er Iui Ia somma di ogni verila, Ia fonle di
ogni dollrina, iI cenlro di quaIsiasi cuIlura crisliana e di quaIsia-
si vila siriluaIe, se Ia sua leoIogia e slrellamenle bibIica, Ia sua
calechesi non Io e meno. Via via che ci si famiIiarizza con
I'oera e Io sliIe di Sanl'Agoslino, si avverle semre iu dislin-
lamenle quesla resenza deIIa Scrillura
3
.
Danle non usa I'esressione Iadri deIIa Chiesa, ma neI asso
sora cilalo ne adoera una equivaIenle: i !ciicr nagni, cioe i grandi
maeslri. In effelli, iI liloIo di nagnus fu dalo gia neII'anlichila,
ricaIcando un uso eIIenislico ensiamo ad AIessandro Magno ad
aIcune riIevanli figure di aslori e maeslri: basli cilare, er I'Orienle,
Alanasio iI Grande (295ca-373) e asiIio Magno (330-379), er
I'Occidenle, i ai Leone Magno (440-461) e Gregorio Magno (590-
604). Quesl'uIlimo e nominalo da Danle in Par. XXVIII, 133, a roosi-
lo deIIe gerarchie angeIiche.
L'abbandono deIIo sludio dei Iadri, Iamenlalo neI canlo IX deI
Para!isc, e solloIinealo, quasi negIi slessi lermini, anche in un asso
deIIa |pisic|a XI, 16 ai cardinaIi. Scrive iI sommo Ioela aoslrofando
Ia Chiesa e non senza una cerla enfasi relorica:
Iacel Gregorius luus in leIis aranearum, iacel Ambrosius in
negIeclis cIericorum IalibuIis, iacel Auguslinus ableclus,
Dionysius, Damascenus el eda, el nescio quod SecuIum,
Innocenlium el Osliensem decIamanl. Cur non` IIIi Deum
querebanl, ul finem el olimum, isli census el beneficia conse-
cunlur.
Anche qui Danle conlraone Io sludio dei Iadri deIIa Chiesa,
ormai negIelli, a queIIo dei decrelaIisli: i rimi cercavano Dio, i
secondi invece inseguono i benefici eccIesiaslici. OIlre a quallro
Iadri occidenlaIi (Gregorio Magno, Ambrogio, Agoslino e eda iI
VenerabiIe), I'AIighieri nomina anche due Iadri orienlaIi, Dionigi
I'Areoagila e Giovanni Damasceno, conosciuli in Occidenle grazie
aIIe lraduzioni Ialine deIIe Ioro oere.
NeI Canlo X deI Para!isc, neIIa corona dei dodici saienli sono
nominali aIcuni aulori che secondo i noslri canoni aarlengono aI
eriodo alrislico
4
: Dionigi I'Areoagila, Severino oezio, IaoIo
3 HINRI-IRINII MARROU, Saini Augusiin ci |Augusiinisnc, Iaris, Aubier 1955, . 57.
Cfr. Ia Bi||ia nci Pa!ri !c||a Cnicsa. IAniicc Tcsiancnic, a cura di Mario NaIdini, oIo-
gna, ID 1999.
4 Ier convenzione, si riliene comunemenle che iI eriodo alrislico si chiuda
neII'VIII secoIo, con Isidoro di SivigIia (nominalo in Par. X, 131) e Giovanni Damasceno.
Oanic c i Pa!ri !c||a Cnicsa 343
Orosio
5
, Isidoro di SivigIia
6
e eda iI VenerabiIe
7
(Par. X, 121-131). Due
lerzine sono dedicale aI fiIosofo Severino oezio (480-526), consoIe e
senalore, fallo uccidere da Teodorico:
Ier vedere ogni ben denlro vi gode
I'anima sanla, che 'I mondo faIIace
fa manifeslo a chi di Iei ben ode,
Io coro ond'eIIa fu cacciala giace
giuso in CieIdauro, ed essa da marliro
e da esiIio venne a quesla ace
(Par. X, 124-129)
Circa I'infIuenza di oezio su Danle ha scrillo recenlemenle Irancesco
Taleo:
II dirello infIusso di oezio uo riconoscersi come fondamenla-
Ie, quanlunque inlreccialo con aIlre fonli, neIIa formuIazione
deIIa dollrina deI Iibero arbilrio, che occua Ia arle concIusiva
deI Oc ccnsc|aiicnc e diviene uno dei unli nevraIgici deI mes-
saggio danlesco
8
,
aggiungendo ancora:
Le arli melriche deI Oc ccnsc|aiicnc, che cosliluiscono laIora
sIendidi esemi di Iirica reIigiosa, divennero er Danle sunli
assai suggeslivi, secie er queIIe arli deIIa Ccnnc!ia in cui Ia
narrazione si are aI lono mislico deII'inno
9
.
Quindi i grandi sanli medievaIi, come Irancesco, Domenico, Iier Damiano, ernardo,
AIberlo, Tommaso, onavenlura e cos via, sono escIusi daIIe noslre considerazioni.
5 Par. X, 118-120: Ne I'aIlra iccoIella Iuce ride / queIIo avvocalo de' lemi crislia-
ni, / deI cui Ialin Auguslin si rovvide. Se si segue Ia varianle icnp|i, aI oslo di icnpi,
sembra evidenle I'aIIusione ad Ambrogio, come facevano gIi anlichi commenlalori.
Oggi e referila Ia Iezione icnpi, e aIIora iI ersonaggio sarebbe IaoIo Orosio, rele
sagnoIo, che scrisse una Hisicria a!tcrsus pagancs rorio su invilo di s. Agoslino. Dan-
le conosceva quesl'oera, di cui cila aIIa Iellera un asso, divenlalo famoso, a roosilo
deIIa Iussuriosa regina Semiramide, che Iibilo fe Iicilo in sua Iegge (|nj. V, 56). Orosio
aveva scrillo deIIa regina: Iraeceil |.j ul cuique Iibilum essel, Iicilum fierel (Hisi., I
4, 8). AIlri ero rilengono che queIIo attccaic !c icnpi crisiiani sia Mario Villorino, o
TerluIIiano, o Lallanzio (cfr. UGO NICOLINI, in |nc. !ani., I, . 201).
6 Isidoro di SivigIia (+ 636) e consideralo negIi alluaIi manuaIi di IalroIogia come
I'uIlimo dei Iadri Ialini.
7 eda iI VenerabiIe (+735) e consideralo iI iu grande erudilo deII'AIlo Medioevo, e
annoveralo lra i Dollori deIIa Chiesa.
8 IRANCISCO TATIO, in |nc. !ani., I, . 656.
9 Ivi, 657. Cfr. IRMINIA ARDISSINO, Tcnpc |iiurgicc c icnpc sicricc nc||a Ccnnc!ia !i
Inrico Callaneo 344
NeIIa seconda corona di saienli, i ersonaggi sono lulli medieva-
Ii, eccello Giovanni, vescovo di CoslanlinooIi, chiamalo Crisoslomo
( bocca d'oro) er Ia sua eIoquenza, morlo in esiIio neI 407 (Par. XII,
136-137).
DIONIGI L'ARIOIAGITA
Merila una seciaIe menzione Dionigi I'Areoagila, cilalo neIIa
rima corona di saienli. In reaIla iI nome e uno seudonimo, anche
se I'aulore vero, nonoslanle lulle Ie ricerche, e rimaslo finora scono-
sciulo. L'ignolo aulore si resenla come disceoIo di san IaoIo,
idenlificalo con queI Dionigi, membro deII'Areoago, menzionalo in
Ai XVII 34 come uno dei ochi converlili da IaoIo neIIa sua breve e
infrulluosa missione aleniese. Non fa dunque meravigIia che gIi anli-
chi abbiano reservalo con cura gIi scrilli di queslo Dionigi, rilenulo
cos vicino ai lemi aosloIici. Icco i liloIi deIIe oere a noi ervenule:
| ncni !itini, Ia icc|cgia nisiica, Ia gcrarcnia cc|csic, Ia gcrarcnia ccc|csia-
siica, Iciicrc
10
. Queslo ccrpus di scrilli leoIogici, redallo in greco verso
Ia fine deI V secoIo, aare forlemenle infIuenzalo daI neoIalonismo
e da un marcalo aofalismo, cioe da una rifIessione in cui domina un
senso aculo deIIa lrascendenza divina, inaccessibiIe a ogni umano
concello (leoIogia negaliva). Cio non significa er Dionigi cadere
neII'agnoslicismo, bens riconoscere che ogni discorso su Dio, che de-
ve semre fondarsi suIIa riveIazione bibIica, e inadegualo di fronle
aIIa reaIla slessa
11
. Quesle oere, singoIari e uniche neI Ioro genere,
coslruiscono, secondo iI giudizio aulorevoIe di Ilienne GiIson, una
deIIe fonli iu imorlanli deI ensiero medievaIe
12
. Danle one Dio-
nigi, come abbiamo dello, neI cieIo deI soIe, neIIa rima corona dei
dodici sirili saienli (Par. X, 115-117):
Aresso vedi iI Iume di queI cero
che giu, in carne, iu a denlro vide
I'angeIica nalura e 'I minislero.
Qui Dionigi e resenlalo come coIui che duranle Ia sua vila lerrena
Oanic, Cilla deI Valicano, Libreria Idilrice Valicana 2009, . 148-150.
10 DIONIGI L'ARIOIAGITA, Tuiic |c cpcrc. Trad. di Iielro Scazzoso, Inlroduzione, re-
fazioni, arafrasi, nole e indici di Inzo eIIini, MiIano, Rusconi 1981.
11 Cfr. CHARLIS-ANDRII IRNARD, Ia irip|c jcrnc !u !isccurs incc|cgiquc !icnqsicn au
Mcqcn Agc, in YSAIL DI ANDIA (ed.), Ocnqs |Arccpagiic ci sa pcsicriic cn Oricni ci cn
Occi!cni. Acles du CoIIoque InlernalionaI, Iaris, 21-24 selembre 1994, Iaris, Inslilul
d'Iludes Augusliniennes 1997, . 503-515.
12 ITIINNI GILSON, Ia ji|cscjia nc| Mc!icctc, Iirenze, La Nuova IlaIia Idilrice 1997,
. 93.
Oanic c i Pa!ri !c||a Cnicsa 345
(in carnc) ebbe iu di ogni aIlro Ia riveIazione deIIa nalura e deIIa
funzione degIi angeIi, lulli ordinali gerarchicamenle. In effelli, neI
canlo XXVIII Danle scorge una Iuce inlensissima: Dio, circondalo da
nove cori angeIici, corrisondenli ai nove cieIi, a cui essi comunicano
Ia Ioro virlu (Par. XXVIII, 46-78). L'ordinamenlo degIi angeIi in nove
gerarchie e i risellivi nomi sono esosli da ealrice rorio secondo
Ia dollrina di Dionigi, che e esressamenle nominalo (vv. 127-132)
13
:
Quesli ordini di su lulli s'ammirano,
e di giu vincon si, che verso Dio
lulli lirali sono e lulli lirano.
I Donisio con lanlo disio
a conlemIar quesli ordini si mise,
che Ii nomo e dislinse com'io.
Quesli ordini formano come una calena, in modo che ciascun coro e
allrallo verso Dio, e allrae a se gIi ordini solloslanli
14
.
A arle quesle menzioni esIicile, vi e moIlo deI ensiero dioni-
siano, neIIa sua ricezione medievaIe, che si rifIelle neII'universo
danlesco. Ricordiamo che san Tommaso d'Aquino aveva scrillo un
commenlo aI Oc !itinis ncnini|us. Come nola Ilienne GiIson,
iI lrallalo Oci ncni !itini doveva agire suIIa secuIazione leoIo-
gica e fiIosofica, rorio erche si one su di un iano
inlermedio lra I'affermazione imuIsiva deI semIice fedeIe e iI
siIenzio lrascendenle deI mislico. Dio vi si resenla darima
come ene, erche Io si accosla allraverso Ie sue crealure, ed e a
liloIo di ene suremo che egIi Ie crea. II Dio di Dionigi asso-
migIia aIIora aII'idea deI ene descrilla da IIalone neIIa sua
|cpu|||ica: come iI soIe sensibiIe, senza ragionamenlo e senza
voIonla, er iI soIo fallo deIIa sua esislenza, enelra con Ia sua
Iuce lulle Ie cose, cos iI ene, di cui iI soIe sensibiIe non e che
una aIIida immagine, si diffonde in nalure, in energie allive, in
esseri inleIIegibiIi ed inleIIigenli, che a Iui debbono iI Ioro essere
e queI che sono, e Ia cui naluraIe inslabiIila lrova in Iui iI suo
13 Cfr. DIONIGI L'ARIOIAGITA, Ia gcrarcnia cc|csic, VI. I nove ordini in senso discen-
denle sono: Serafini, Cherubini, Troni, Dominazioni, Iolenze, Iolesla, Irinciali,
ArcangeIi, AngeIi. Cfr. ANTONIO MILLONI, in |nc. !ani., III, . 122-124.
14 Cfr. DIONIGI L'ARIOIAGITA, Ia gcrarcnia cc|csic, III, 2: Cos daI momenlo che
I'ordine deIIa gerarchia consisle neI fallo che gIi uni siano urificali e gIi aIlri urifichi-
no, che gIi uni siano iIIuminali e gIi aIlri iIIuminano, che quesli siano orlali aIIa
erfezione e quesli aIlri rendano erfelli, secondo laIe modo a ciascuno converra
I'imilazione divina (lrad. I. Scazzoso, cil., . 91).
Inrico Callaneo 346
unlo fisso. SviIuandosi er gradi, quesla iIIuminazione
divina generera naluraImenle una gerarchia, iI che significa
conlemoraneamenle due cose unile e dislinle: in rimo Iuogo
uno slalo, neI senso che ogni essere e definilo er queIIo che e e
er iI oslo che occua in quesla gerarchia, oi una funzione,
neI senso che ogni membro deIIa gerarchia universaIe riceve
I'infIuenza daII'aIlo er lrasmellerIa, a sua voIla, aI di sollo di
se. La Iuce divina e I'essere che essa cosliluisce si lrasmellono
allraverso una cascala di Iuce i cui gradi sono descrilli nei
lrallali: Oc||a gcrarcnia cc|csic e Oc||a gcrarcnia ccc|csiasiica
15
.
NeI ensiero di Dionigi, Ia creazione, anche neIIe sue comonenli
iu maleriaIi, rifIelle dunque quaIcosa deIIe roriela divine, ragion
er cui Dio uo essere nominalo non soIo come ene, Luce, eIIezza,
Vila, Amore, ma anche come Iuoco, Acqua, Roccia, Leone, e cos via
16
.
Tullavia, ognuno di quesli aeIIalivi, anche queIIi iu siriluaIi,
aIicalo a Dio deve assare allraverso Ia negazione, erche I'essenza
di Dio e aI di Ia di ogni concello, anche di queIIo di essere. L'essenza
divina in se slessa e inconceibiIe e indicibiIe. Queslo aofalismo
eslremo non are che sia slalo seguilo dagIi aulori medievaIi, cerla-
menle non da Danle, anche se egIi sesso solloIinea I'indicibiIila
deII'eserienza deI divino
17
.
Dionigi insisle in arlicoIare suII'allribulo di Amore. Come scrive
semre iI GiIson,
queslo lermine designa recisamenle er Iui iI movimenlo di
carila coI quaIe Dio riconduce a se lulli gIi esseri in cui si riveIa
Ia sua bonla. Considerala sollo queslo asello, I'iIIuminazione
universaIe aare moIlo meno simiIe ad una cascala di Iuce che
si diserderebbe semre di iu, che simiIe ad un'immensa cir-
coIazione d'amore che si diserde darima in una moIleIicila
di esseri, soIlanlo er radunarIi oi e ricondurIi aII'unila deIIa
Ioro origine. L'amore e quindi Ia forza alliva che in quaIche
modo lrae fuori da Ioro slessi gIi esseri venuli da Dio, er assi-
curare iI Ioro rilorno a Dio. |.j In un universo che non e che Ia
manifeslazione di Dio, lullo cio che esisle e buono, iI maIe
dunque e, er se, non essere, I'aarenza di reaIla che esso ra-
resenla e dovula soIo a cio che esso offre come un'aarenza
di bene. D'aIlronde e er queslo che iI maIe ci inganna, erche e
15 GILSON, Ia ji|cscjia nc| Mc!icctc, cil., . 95-96.
16 Cfr. DIONIGI L'ARIOIAGITA, Ia gcrarcnia cc|csic, II, 5.
17 Iiulloslo scellica suII'infIusso di Dionigi su Danle e MARTA CRISTIANI, in |nc.
!ani., II, . 460-462.
Oanic c i Pa!ri !c||a Cnicsa 347
senza soslanza e reaIla. Dio quindi non Io causa, ma Io loIIera
erche egIi regge nalura e Iiberla senza vioIenlarIe. In uno scril-
lo erdulo, || giusic giu!izic !i Oic, Dionigi aveva dimoslralo
che un Dio erfellamenle buono uo giuslamenle unire i coI-
evoIi oiche essi Io sono er sonlanea voIonla
18
.
Quesla sinlesi deI ensiero dionisiano olrebbe essere anche una
sinlesi deI ensiero danlesco, lanlo i due mondi sono simiIi. asli en-
sare aIIe aroIe che iI Ioela one suIIa orla deII'inferno:
Giuslizia mosse iI mio aIlo fallore,
fecemi Ia divina Ioleslale,
Ia somma Saenza e 'I rimo Amore
(|nj. III, 4-6)
Anche Ia cilla doIenle e Ia erdula genle, dunque, leslimoniano a
Ioro modo Ia giuslizia, Ia saienza e I'amore di Dio.
S. AGOSTINO
Quesla roselliva ci orla immedialamenle a un aIlro grande Ia-
dre deIIa Chiesa, iI maggiore deII'Occidenle, cioe Agoslino di Iona
(354-430). I commenlalori hanno osservalo che, slranamenle, Danle
non da un riIievo arlicoIare a quesla figura, che ure ha imregnalo
di se lulla Ia leoIogia e Ia cuIlura medievaIe:
NeIIa Ccnnc!ia manca un eisodio agosliniano: laIuno ha
allribuilo Ia cosa aI Ialonismo deI Sanlo, in conlraslo con
I'arisloleIismo di Danle, e aIIa diversa concezione oIilica e slo-
rica su Roma e I'Imero
19
.
Tullavia Agoslino e nominalo aII'inlerno deIIa Candida Rosa: di
fronle aI seggio deIIa eala Vergine Maria, neIIa arle oosla deIIa
rosa, e iI seggio di S. Giovanni iI allisla e sollo di Iui siedono,
neII'ordine, S. Irancesco, S. enedello e S. Agoslino (Par. XXXII, 35)
20
.
Gia sono slali sludiali i assi deIIa Ccnnc!ia che hanno un reciso
risconlro neIIe oere agosliniane, segno che Danle Ie conosceva bene:
18 GILSON, Ia ji|cscjia nc| Mc!icctc, cil., . 96-97.
19 DANTI ALIGHIIRI, Oitina Ccnnc!ia, a cura di Giovanni IaIIani e SiIvio Zennaro,
Roma, ibIioleca Iconomica Nevlon 1994, . 636.
20 Secondo ANTONIO IINCHIRLI, Agoslino e nominalo qui assieme a enedello e
Irancesco in quanlo aulori deIIe lre regoIe di vila reIigiosa soIe ammesse neIIa Chiesa di
queI lemo (|nc. !ani., I, . 82).
Inrico Callaneo 348
La concezione deIIa cilla di Salana (|nj., III, 1) e deIIa cilla di Dio
(Par., XXX, 130) e agosliniana, come iI simboIismo riguardanle
Lia e RacheIe (messo in Iuce daI IascoIi) che si lrova neI Ccnira
|ausiun (XXII, 52-53), come I'argomenlo er assurdo suI
grande miracoIo che avremmo avulo se iI mondo si fosse con-
verlilo senza miracoIi, che e neI Oc citiiaic Oci (XXII, 5)
21
, come
Ie lre forme di visione deI Iaradiso: cororaIe, siriluaIe o im-
maginaria, e inleIIelluaIe, che e neI Gcncsi a! Iiiicran (XII) e neI
Oc cit. Oci (X, 9), come infine (semre neI Oc cit. Oci XXII) Ia
gIorificazione e Ia nalura deI coro risorlo
22
.
A arle quesli recisi risconlri
23
, si uo arIare di un agoslinismo di
Danle, neI senso che
aIcune concezioni fiIosofiche agosliniane hanno avulo un'in-
fIuenza decisiva suI ensiero di Danle ed in generaIe I'infIusso
esercilalo suI divino oela da Agoslino fu maggiore di quanlo
comunemenle si crede
24
.
Uno dei concelli fondamenlaIi deII'universo danlesco e queIIo di
ordine: Ie crealure sono varie e diverse, ma lra Ioro esisle un ordine,
erche lulle risecchiano a modo Ioro iI Irimo Irinciio:
|...j Le cose lulle quanle
hanno ordine lra Ioro, e queslo e forma
che I'universo a Dio fa simigIianle
(Par. I, 103-105)
Ne I'ordine ch'io dico sono accIine
lulle nalure, er diverse sorli,
iu aI rinciio Ioro e men vicine,
onde si muovon a diversi orli
er Io gran mar de I 'essere, e ciascuna
con islinlo a Iei dalo che Ia orli
(Par. I, 109-114)
21 Si veda Par. XXIV, 106-108: Se iI mondo si rivoIse aI crislianesimo, / diss'io, san-
za miracoIi, quesl'uno / e laI, che Ii aIlri non sono iI cenlesimo. S. Agoslino aveva scril-
lo: Si vero |.j isla miracuIa esse facla non credunl, hoc nobis unum grande miracu-
Ium sufficil, quod eis | AosloIisj lerrarum orbis sine uIIis miracuIis credidil (Oc cit.
Oci XXII, 5).
22 DANTI ALIGHIIRI, Oitina Ccnnc!ia, a cura di IaIIani e Zennaro, cil., . 636.
23 Si uo aggiungere che I'esressione |i !ci ja|si c |ugiar!i (|nj. I, 72) ha un reciso
risconlro in AGOSTINO, Oc citiiaic Oci II, 2, 18: !ccs ja|scs ci ja||accs.
24 Cfr. IIIRO CHIOCCIONI, Iagcsiinisnc nc||a Oitina Ccnnc!ia, Iirenze, OIschki
1952, . 31.
Oanic c i Pa!ri !c||a Cnicsa 349
Commenla Irich Auerbach:
La Citiias Oci in Iaradiso e Ia lerra deIIa giuslizia, in essa Ie
anime slanno in giuslo ordine, in comune agire, godendo cia-
scuna deI suo oslo e arlecii di un vero bene, Ia cui rovvisla
e inesauribiIe, anzi iI cui godimenlo aumenla quanle iu anime
redenle vi arleciano. NeI vario modo di aarire dei beali
neIIe sfere dei ianeli Ia diversila deIIe disosizioni e deIIe alli-
vila si sviIua come un ordine naluraIe che fa deII'uomo un
cilladino, e cos egIi uo, secondo Ie sue caacila, divenire un
membro deIIa comunila umana, iI cui fine e I'alluazione
deII'ordine divino in lerra
25
.
Queslo non e soIo un ordine fisico, ma e anche moraIe, ed e qui
che enlra in gioco Ia Iiberla umana, con Ie sue sceIle sesso conlrarie
aIIa roria nalura, iI che cosliluisce roriamenle iI dramma deI-
I'uomo:
Vero e che, come forma non s 'accorda
moIle fiale aII'inlenzion deII 'arle,
erch'a risonder Ia maleria e sorda,
cos da queslo corso si diarle
laIor Ia crealura, c'ha odere
di iegar, cos inla, in aIlra arle,
e s come veder si uo cadere
foco di nube, s I 'imelo rimo
s'allerra, lorlo da faIso iacere
(Par. I, 127-135)
Se Ia grazia di Dio e infinila, anche Ia sua giuslizia e infinila, ragion
er cui iI maIe e I'ingiuslizia non ossono rimanere imunili, cos che
anche gIi abilanli deIIa cilla infernaIe, come abbiamo vislo sora, sia
ure er Iibera sceIla deI maIe, rienlrano neII'ordine deIIa giuslizia
divina
26
.
Ora su queslo lema deII'ordine universaIe, cosmico e moraIe, Dan-
le ha lrovalo cerlamenle una fonle in Agoslino, che ha scrillo un
Oc cr!inc e un Oc nusica, dove vi sono inleressanli rifIessioni fiIosofi-
co-leoIogiche su queI lema. Anzilullo Agoslino arIa deII'ordine
cosmico:
25 IRICH AUIRACH, Siu!i su Oanic, MiIano, IeIlrineIIi 1963, . 120.
26 SuI lema deIIa giuslizia in Agoslino e Danle, si veda ARDISSINO, Tcnpc |iiurgicc
c icnpc sicricc nc||a Ccnnc!ia !i Oanic, cil., . 154-161.
Inrico Callaneo 350
I quaIi sono Ie reaIla sueriori, se non queIIe neIIe quaIi
ermane Ia somma, indiscussa, immobiIe, elerna uguagIianza
(acqua|iias)` La non esisle iI lemo, erche non si da aIcun
mulamenlo. Di Ia i lemi sono coslruili, ordinali e misurali a
imilazione deII'elernila, menlre iI corso deI cieIo rilorna
aII'idenlico e riorla aII'idenlico i cori ceIesli e obbedisce aIIe
Ieggi deII'uguagIianza, deII'unila e deII'ordine, grazie ai giorni,
ai mesi, agIi anni, ai Iuslri e agIi aIlri movimenli orbilaIi deIIe
sleIIe. Cos Ie cose lerrene, sollomesse a queIIe ceIesli, uniscono
in una successione armoniosa Ie orbile dei rori lemi aI oe-
ma, se osso dirIo, deII'universo
27
.
A queslo oema deII'universo non sfugge neure Ia sfera
moraIe:
Cos Dio ha ordinalo iI callivo uomo eccalore, non in modo
callivo. I divenlalo callivo er sua voIonla, erdendo lullo
queIIo che ossedeva finche obbediva ai comandamenli di Dio,
ed e slalo ordinalo a arle, in modo che chi non ha voIulo se-
guire Ia Iegge, daIIa Iegge sia condollo. Tullo cio che e comiulo
secondo Ia Iegge, e anche secondo giuslizia, e lullo cio che e se-
condo giuslizia non e fallo con calliveria, erche anche neIIe
noslre oere maIvagie Ie oere di Dio sono buone
28
.
II Iibero arbilrio uo dunque incIinare I'anima o verso Dio, er iI
quaIe e falla, o verso Ie crealure, a Iei inferiori. Ora, scrive Agoslino,
I'amore er Ia beIIezza inferiore macchia I'anima, e in queslo modo
I'anima ha erso iI rorio ordine. Non e lullavia uscila
daII'ordine deIIe cose, erche dove e, e in modo laIe che I'essere
e iI modo di essere sono ordinalissimi. Una cosa infalli e osse-
dere I'ordine, un'aIlra essere osseduli daII'ordine. Iossiede
I'ordine quando ama con lulla se slessa cio che e sora di Iei,
cioe Dio e ama come se slessa Ie anime sue comagne. Con que-
sla forza deII'amore fa ordine lra Ie cose inferiori e non ne viene
conlaminala. Cio che invece Ia conlamina non e callivo, erche
anche iI coro e crealura di Dio ed e ornalo di una sua beIIezza,
se ur infima
29
.
27 AGOSTINO, Oc nusica VI, 11, 29 (leslo Ialino e lraduzione ilaIiana a cura di Maria
ellelini, MiIano, Rusconi 1997).
28 Ivi, VI, 11, 30.
29 Ivi, VI, 14, 46.
Oanic c i Pa!ri !c||a Cnicsa 351
II disordine dunque non sla neIIe cose, che sono buone in se, ma
neI callivo uso che ne facciamo. Cos, rosegue Agoslino,
daII'amore er iI rossimo neII'inlegrila con cui ci e comandalo,
s'innaIza er noi una scaIa sicura er unirci a Dio e non essere
soIo osseduli daI suo ordinamenlo ma ossedere, sicuro e sla-
biIe, anche iI noslro ordine
30
.
Quando I'anima Io ossiede, aIIora esercila Ia virlu deIIa giuslizia:
II suo slesso ordinamenlo er cui non serve nessuno se non iI
soIo Dio, non desidera essere uguagIiala ad aIcuno se non agIi
sirili iu uri, non dominare nessuno se non Ia nalura besliaIe
e cororea |.j chi non cairebbe che quesla e Ia giuslizia`
31
.
L'ordine e dalo daI nuncrus, che e Ia misurabiIila e dunque I'in-
leIIigibiIila di lulle Ie cose: non soIo i numeri malemalici, ma anche Ie
aroIe e i cori hanno iI Ioro nuncrus. I da dove deriva quesla inleIIi-
gibiIila se non daI Dio sommamenle buono e sommamenle giuslo e
sommamenle uno` Ora laIe ordinamenlo si dislribuisce allraverso i
numeri razionaIi e inleIIelluaIi deIIe anime beale e sanle che
lrasmellono, senza riceverIa da una nalura inlermedia, fino ai
Iimili deIIa lerra e degIi inferi, Ia slessa Iegge di Dio, senza Ia
quaIe non cade una fogIia da un aIbero e er Ia quaIe i noslri
caeIIi sono numerali
32
.
Un aIlro concello che accomuna Danle e Agoslino, oIlre queIIo
di ordine, e iI concello di ace. NeIIa Mcnarcnia I, 4 Danle indica
Ia ace universaIe come Ia iu desiderabiIe di lulle Ie cose che
sono ordinale aIIa noslra bealiludine. I commenla queslo suo
convincimenlo a arlire daIIa Scrillura:
Irorio er queslo Ia voce daII'aIlo annunzio ai aslori non ric-
chezze, non iaceri, non onori, non Iunga vila, saIule, forza o
beIIezza, ma ace, che Ia ceIesle miIizia canlo: G|cria a Oic nci
cic|i, c pacc in icrra ag|i ucnini !i |ucna tc|cnia (Ic 2, 13-14). Sem-
re er queslo Iace a voi era iI saIulo deI SaIvalore agIi
uomini (cfr. Ic 24, 36, Gt 20, 21-26), che a chi recava Ia surema
saIvezza conveniva di esrimere iI iu aIlo saIulo, e quesl'uso
30 ||i!.
31 Ivi, VI, 15, 50.
32 Ivi, VI, 17, 58.
Inrico Callaneo 352
iacque oi di manlenere ai suoi disceoIi e a IaoIo neI Ioro
modo di saIulare, com'e faciIe accerlarsi a chi Io desideri.
NeI Ccntitic, doo aver disoslo Ie selle arli IiberaIi in reIazione
ai selle ianeli, Danle fa corrisondere Ia fisica e Ia melafisica aIIa
sfera sleIIala, Ia fiIosofia moraIe aIIa nona sfera e Ia leoIogia o scienza
divina aI cieIo immobiIe o emireo:
Lo cieIo emireo er Ia sua ace simigIia Ia divina scienza, che
iena e di lulla ace, Ia quaIe non soffrea Iile aIcuna
d'oinioni o di sofislici argomenli, er Ia ecceIIenlissima
cerlezza deI suo subiello, Io quaIe e Dio. I di quesla ace dice
esso a Ii suoi disceoIi: Ia pacc nia !c a tci, |a pacc nia |ascic a tci
(Gt 14, 27) |.j. Quesla scienza e erfella |.j erche erfella-
menle ne fa iI vero vedere neI quaIe si chela I'anima noslra
33
.
Non si uo non vedere in quesle uIlime aroIe una reminiscenza deI
nolo dello agosliniano oslo aII'inizio deIIe Ccnjcssicni: |ccisii ncs a!
ic, ci inquiciun csi ccr ncsirun, !cncc rcquicscai in ic.
Come ha nolalo IlaIo orzi,
iI viaggio di Danle e anche un cammino verso Ia ace, aveva
dello Agoslino rivoIlo a Dio: .inquielo e iI noslro cuore fin-
che non riosa in le. NeIIa bealiludine s'acquiela finaImenle
I'anima umana lormenlala da conlrasli e da desideri inaaga-
li. La visione bealifica, fine suremo cui lende Ia crealura
umana, e anzilullo cessazione di lulli i desideri, causa erenne
di insoddisfazione e di infeIicila. La ace, che e aagamenlo in
Dio, e neII'adesione aIIa voIonla deII'amalo, dice Iiccarda: | n
|a sua tc|cnia!c c ncsira pacc (Par., III, 85), iI TrisavoIo Cacciagui-
da, evocalo iI ricordo deIIa vila lerrena e deI mondo faIIace,
concIude quasi in un sosiro: | tcnni !a| nariirc a qucsia pacc
(Par., XV, 148). QueIIa deI Iaradiso e una .tiia inicgra !ancrc
c !i pacc, e una sicura riccnczza senza iI lormenlo dei desideri
sanza |rana (Par., XXVII, 7-9). NeII'Imireo iI oela ribadisce iI
concello che soIlanlo neIIa visione di Dio I'uomo uo lrovare Ia
ace: Iunc c |a su cnc tisi|i|c jacc / |c crcaicrc a quc||a crcaiura / cnc
sc|c in |ui tc!crc na |a sua pacc (Par., XXX, 100-102). Anche neIIe
recedenli canliche Ia aroIa ace equivaIe a bealiludine. Issa
risuona neIIa commossa voIonla di reghiera di Irancesca: Sc
jcssc anicc | rc !c|| unitcrsc / nci prcgncrcnnc |ui !c |a iua pacc.
33 DANTI ALIGHIIRI, Ccntitic II, 14.
Oanic c i Pa!ri !c||a Cnicsa 353
(|nj., V, 91-92). NeI araIIeIo canlo V deI Purgaicric iI oela aIIe
anime dei negIigenli morli di morle vioIenla arIa esIicilamen-
le deI suo cammino verso Ia ace: .pcr quc||a pacc / cnc !icirc i
pic!i !i sijjaiia gui!a / !i ncn!c in ncn!c ccrcar ni si jacc (vv. 58-
63)
34
.
Se ora assiamo ai lesli di Agoslino, sembra che non ci sia soIuzio-
ne di conlinuila. Scrive infalli I'Ionale neI Oc citiiaic Oci: Iossiamo
quindi affermare deIIa ace cos come I'abbiamo dello deIIa vila
elerna ch'essa e er noi iI fine suremo d'ogni noslro bene, iI fine
suremo deIIa cilla di Dio, neI quaIe essa lrovera iI sommo bene, e Ia
ace neIIa vila elerna, o Ia vila elerna neIIa ace
35
. Quesla ace e un
sabalo elerno o, megIio
un ollavo giorno elerno, erche Ia domenica, consacrala aIIa
risurrezione di Crislo, refigura iI rioso elerno deIIo sirilo e
deI coro. La rioseremo e vedremo, vedremo e ameremo,
ameremo e Ioderemo. Icco cio che sara aIIa fine senza fine. I
quaIe e infalli iI noslro fine se non queIIo di ervenire aI regno
che non ha fine`
36
.
S. INIDITTO I IL MONACHISIMO
NeI canlo XXII deI Para!isc, Danle si inconlra con san enedello
(Norcia 480 Cassino 543), iI adre deI monachesimo occidenlaIe
(vv. 28-99). L'amio sazio dedicalo a quesla figura e indice deIIa
slima che I'AIighieri aveva er I'ordine benedellino, nonoslanle Ia
decadenza dei monasleri, denunciala er bocca deIIo slesso fondalore
(vv. 73-87). enedello, iI cui voIlo Danle non uo vedere er Ia lroa
Iuce, racconla aI eIIegrino Ia fondazione di Cassino, Iuogo rima de-
dicalo aI cuIlo idoIalrico, ma oi urificalo daI nome di Crislo,
Io nome di coIui che 'n lerra addusse
Ia verila che lanlo ci sobIima
(Par. XXII, 41-42)
34 ITALO ORZI, Inlroduzione a Oanic A|ignicri, Oitina Ccnnc!ia, Roma, ibIioleca
Iconomica Nevlon 1994, . 29-30.
35 AGOSTINO, Oc citiiaic Oci XIX, 11. Anche in Dionigi I'Areoagila iI lema deIIa a-
ce e resenle come nome divino che si comunica a lullo I'universo (| ncni !itini, XI, 1-
5). Merila di essere riorlalo queslo asso: I se lulle Ie cose che si muovono non vo-
gIiono riosare, ma muoversi semre di un Ioro rorio molo, anche queslo e un
desiderio deIIa Iace divina di lulle (XI, 4, lrad. I. Scazzoso, cil., . 382).
36 Oc citiiaic Oci XXII, 30, 5.
Inrico Callaneo 354
II Sanlo oi solloIinea I'esansione deIIe sue fondazioni, lra cui
queIIe dovule a s. RomuaIdo (+ 1027), fondalore dei benedellini ca-
maIdoIesi. Iurlroo, osserva enedello, iI fervore originario e andalo
scemando, e quasi iu nessuno saIe queIIa scaIa deII'umiIla, che egIi
ha esoslo neI ca. VII deIIa |cgc|a, richiamandosi a queIIa scaIa che
loccava iI cieIo, visla daI alriarca Giacobbe (vv. 70-72):
Ma, er saIirIa, mo nessun diarle
da lerra i iedi, e Ia regoIa mia
rimasa e er danno de Ie carle (vv. 73-75).
In queslo conleslo, Danle nomina anche Macario, uno dei adri deI
monachesimo egiziano
37
. S. Anlonio abale (+ 356), Ia cui vila fu de-
scrilla da Alanasio d'AIessandria (+ 373) e fu moIlo conosciula anche
in Occidenle, e nominalo incidenlaImenle in Par. XXIX, 124-126,
non er esaIlarne Ie virlu, ma soIo er fIageIIare redicalori e
reIigiosi deI suo lemo che abusano deIIe sloIla creduIila oo-
Iare (i| pcrcc j!i} saniAnicnic) er vana ambizione o er viIi
guadagni
38
.
L'INTIRIRITAZIONI IIGURALI IATRISTICA
II debilo di Danle verso i Iadri deIIa Chiesa uo essere consideralo
anche da un unlo di visla iu generaIe, seguendo queIIa che Irich
Auerbach chiama I'inlerrelazione figuraIe
39
. Issa nasce daI raor-
lo di conlinuila e sueramenlo lra i due Teslamenli, dove I'Anlico
refigura iI Nuovo, iI Nuovo raresenla iI comimenlo. L'Anlico e iI
Nuovo Teslamenlo non sono soIo due serie di lesli, ma anche e so-
rallullo due fasi deIIa sloria di saIvezza. Quesla inlerrelazione
conferisce aIIa sloria uno sessore che era sconosciulo aI mondo cIas-
sico. Gia Henri de Lubac aveva scrillo neI 1938 aIcune agine moIlo
inleressanli in roosilo:
Dio agisce neIIa sloria, si riveIa neIIa sloria. Iiu ancora, Dio si
inserisce neIIa sloria, conferendoIe cos una consacrazione reIi-
giosa che obbIiga a renderIa suI serio. Le reaIla sloriche han-
no dunque una rofondila, vanno comrese siriluaImenle
40
.
37 In reaIla sono aImeno due i ceIebri monaci egiziani che orlano iI nome di Maca-
rio (cfr. ANTONIO LINTINI, in |nc. !ani., III, . 752).
38 LINTINI, in |nc. !ani., I, . 309.
39 AUIRACH, Siu!i su Oanic, cil., . 205.
40 HINRI DI LUAC, Caiic|iccsinc. Aspciii sccia|i !c| !cgna, MiIano, }aca ook 1978, .
Oanic c i Pa!ri !c||a Cnicsa 355
Queslo siriluaImenle non significa fuori deIIa sloria, ma ingIoban-
le Ia sloria, anche se Ia lrascende:
La ibbia, che conliene Ia riveIazione deIIa saIvezza, conliene
dunque, a suo modo, Ia sloria deI mondo |.j. Cos Ia Ieggeva-
no i Iadri deIIa Chiesa. Da Ireneo ad Agoslino, assando er
CIemenle AIessandrino ed Iusebio, essi ne ricavavano un Di-
scorso suIIa sloria universaIe |.j. Queslo rinciio dirige lulla
Ia Ioro esegesi. Isso one un abisso lra iI Ioro melodo di inler-
relazione e queIIo dei fiIosofi aIIegorizzanli di cui hanno
olulo conoscere Ie oere, oure iI melodo di IiIone. Due falli
sono coslanli neII'aIIegorismo dei fiIosofi |.j. Da una arle essi
rigellano neI milo cio che si resenlava come un racconlo
|.j. D'aIlra arle, se essi vanificano cos lullo cio che offriva
aImeno I'aarenza di sloria, non e a vanlaggio di una sloria
iu rofonda |.j ma di una idea: di scienza, o di moraIe, o di
melafisica
41
.
La roselliva dei Iadri invece e deI lullo diversa, anche se si ossono
lrovare nei Ioro commenli bibIici anaIogie con i melodi ermeneulici
degIi anlichi (aIIegoria). Nonoslanle Ie differenze che ci sono lra Ie
varie scuoIe esegeliche, e in arlicoIare lra Ia scuoIa aIessandrina e
queIIa anliochena,
lulli vogIiono comrendere Io sirilo deIIa sloria, senza scaIzare
Ia reaIla slorica |.j. II senso siriluaIe dunque e diffuso do-
vunque, non soIo ne sorallullo in un Iibro, ma anzilullo ed
essenziaImenle neIIa reaIla slessa: |n ipsc jacic, ncn sc|un in !ic-
ic, nqsicriun rcquircrc !c|cnus (Agoslino, |n ps. 68) |.j. I
quando, ersuasi che lullo era ieno di rofondila misleriose,
quesli Iadri si chinavano suIIe agine isirale dove essi segui-
vano neIIe sue fasi successive I'AIIeanza di Dio con gIi uomini,
essi non avevano lanlo I'imressione di commenlare un leslo o
di decifrare degIi enigmi verbaIi, quanlo queIIa di inlerrelare
Ia sloria
42
.
Cerlo, iI Mislero ormai resenle in quesla sloria deve ancora com-
iersi neI suo allo finaIe, ragion er cui sia I'Anlico che iI Nuovo
Teslamenlo sono enlrambi rofelici, ma in modo diverso: se I'Anlico e
un|ra deI Nuovo, iI Nuovo e jigura risello aIIa tcriias finaIe, ma gia Ia
117.
41 Ivi, . 117-118.
42 Ivi, . 119-121.
Inrico Callaneo 356
conliene. Come dice I'aulore deIIa Lellera agIi Ibrei, |a |cggc cra |cn|ra
!ci |cni juiuri (||. X, 1). Scrive de Lubac:
Ci si rende conlo deII'ardilezza di una laIe esressione` Si vede
Io sconvoIgimenlo che essa suoneva neIIe idee ricevule
daII'esemIarismo anlico e daI modo naluraIe di ensare` Icco
dunque che iI coro e fuluro risello aIIa sua ombra e
I'esemIare risello aI suo lio!
43
.
Non so se I'Auerbach abbia conosciulo quesle agine di de Lubac,
ma cerlamenle Ia sua anaIisi deI concello di figura resso i Iadri orla
a risuIlali sorrendenlemenle simiIi. I Iadri, osserva I'Auerbach, ri-
rendono Ie indicazioni dale da IaoIo neI modo di inlendere I'Anlico
Teslamenlo: cio che esso erdeva come Iegge e arlicoIarila di un o-
oIo, Io guadagnava in una nuova alluaIila drammalico-concrela
44
.
La Chiesa anlica, benche divenula ben reslo soIo elnico-crisliana,
non abbandono I'Anlico Teslamenlo, anzi vi si allacco ancora di iu
dielro I'oosizione degIi avversari gnoslici
che voIevano mellere deI lullo da arle I'Anlico Teslamenlo o
darne soIlanlo un'inlerrelazione aslrallamenle aIIegorica, in
un modo che avrebbe rivalo iI crislianesimo deI conleslo deIIa
sloria universaIe rovvidenziaIe e quindi anche, in arle, deIIa
sua grande e generaIe forza di convinzione. In quesla Iolla con-
lro quanli sregiavano o svuolavano I'Anlico Teslamenlo iI
melodo deIIa rofezia reaIe |cioe I'inlerrelazione figuraIej si
dimoslro nuovamenle efficace e si affermo rorio neI senso
deIIa romessa crisliana
45
.
Ma che cos'e roriamenle, secondo I'Auerbach, quesla inlerrela-
zione figuraIe` I queIIa che
slabiIisce fra due falli o ersone un nesso in cui uno di essi non
significa soIlanlo se slesso, ma significa anche I'aIlro, menlre
I'aIlro comrende o ademie iI rimo. I due oIi deIIa figura
sono searali neI lemo, ma si lrovano enlrambi neI lemo,
come falli e figure reaIi |.j, Ia romessa e I'ademimenlo sono
falli reaIi e slorici che in arle sono accaduli neII'incarna-
zione deI Verbo, in arle accadranno aI suo rilorno. I vero che
neIIe concezioni deII'ademimenlo finaIe inlervengono anche
43 Ivi, . 123.
44 AUIRACH, Siu!i su Oanic, cil., . 207.
45 Ivi, . 207-208.
Oanic c i Pa!ri !c||a Cnicsa 357
eIemenli uramenle siriluaIi, erche iI mio regno non e di
queslo mondo, ma sara ur semre un regno reaIe, non una
coslruzione aslralla e sovrasensibiIe, queslo mondo erira soI-
lanlo come figura, non erira Ia sua nalura, e Ia carne
risorgera. L'inlerrelazione figuraIe dunque |.j e nellamenle
dislinla daIIa maggior arle deIIe aIlre forme aIIegoriche a noi
nole in virlu deIIa ari sloricila deIIa cosa significanle e di queI-
Ia significala
46
.
Tullavia enlrambi, significanle e significalo, rimandano a un fuluro
che e ancora da venire e che sara iI rocesso vero e rorio,
I'accadimenlo ieno e reaIe e definilivo
47
.
Tullo queslo, quaIcuno dira, che cosa ha a che fare con Danle`
Tulli gIi aulori medievaIi, suIIa scia sorallullo di Origene e di
Agoslino, saevano che Ia ibbia oleva essere Iella secondo quallro
sensi: IelleraIe, aIIegorico, moraIe e anagogico, secondo iI ceIebre
dislico di NicoIa di Lira:
Lillera gesla docel, quid credas aIIegoria,
moraIis quid agas, quo lendas anagogia
48
.
La cosa singoIare e che Danle aIica quesla Iellura oIisemica,
roria ed escIusiva deIIa Sacra Scrillura, anche aI suo oema, secon-
do quanlo si Iegge neII'|pisic|a XIII a Cangrande deIIa ScaIa
49
:
|7j. Ier chiarire quanlo sliamo er dire, occorre saere che non
e uno soIo iI senso di quesl'oera: anzi, essa uo essere definila
pc|iscnsa, ossia dolala di iu significali. Infalli, iI rimo signifi-
calo e queIIo ricavalo da una Iellura a||a |ciicra, un aIlro e
rodollo da una Iellura che va aI significalo rofondo. II rimo
si definisce signijicaic |ciicra|c, iI secondo, di lio a||cgcricc, ncra-
|c oure anagcgicc. I laIe modo di rocedere, erche risuIli iu
chiaro, uo essere anaIizzalo da quesli versi: Duranle I'esodo
di IsraeIe daII'Igillo, Ia casa di Giacobbe si slacco da un ooIo
slraniero, Ia Giudea divenne un sanluario e IsraeIe iI suo domi-
nio. Se osserviamo soIamenle iI signijicaic |ciicra|c, quesli versi
aaiono riferili aII'esodo deI ooIo di IsraeIe daII'Igillo, aI
lemo di Mose, ma se osserviamo iI signijicaic a||cgcricc, iI signi-
46 Ivi, . 209.
47 Ivi, . 212-213.
48 Cfr. }IAN IIIIN, Ia ira!iiicn !c |a||cgcric !a Pni|cn !A|cxan!ric a Oanic. |iu!cs ni-
sicriqucs, Iaris, Iludes Augusliniennes 1987, . 251-320, qui . 286.
49 SuII'aulenlicila di quesla Iellera sono slali soIIevali dubbi.
Inrico Callaneo 358
ficalo si sosla suIIa noslra redenzione ad oera di Crislo. Se
guardiamo aI scnsc ncra|c, cogIiamo Ia conversione deII'anima
daI Iullo miserabiIe deI eccalo aIIa Grazia, iI scnsc anagcgicc in-
dica, infine, Ia Iiberazione deII'anima sanla daIIa servilu di
quesla corruzione lerrena, verso Ia Iiberla deIIa gIoria elerna. I
benche quesli significali mislici siano chiamali con denomina-
zioni diverse, in generaIe lulli ossono essere chiamali a||cgcrici,
erche sono lrasIali daI senso IelleraIe o narralivo. Infalli a||cgc-
ria viene ricavala daI greco a||ccn che, in Ialino, si ronuncia
a|icnun, vaIe a dire !itcrsc
50
.
L'Auerbach a scanso di equivoci referisce chiamare figuraIe e
non aIIegorico queslo rocedimenlo inlerrelalivo, dalo che
I'inlerrelazione figuraIe
cosliluisce Ia base generaIe deII'inlerrelazione medievaIe deIIa
sloria |.j. Tullo I'anaIogismo che enelra in ogni camo
deII'allivila siriluaIe deI medioevo e slrellissimamenle coIIega-
lo con Ia slrullura figuraIe
51
.
I queslo vaIe anche er Ia Ccnnc!ia di Danle. Anche se aI suo inlerno
non mancano aIIegorie di lio cIassico, lullavia Ie forme figuraIi sono
decisamenle revaIenli e decisive er lulla Ia slrullura deI oema
52
.
II che equivaIe a dire che una inlerrelazione uramenle aIIegorica
deIIa Ccnnc!ia sarebbe fuorvianle. L'Auerbach inlende dimoslrarIo
con lre esemi: queIIo di Calone Ulicense, VirgiIio e ealrice. Quesle
lre figure, se vengono rese uramenle in senso aIIegorico o simboIi-
co, mellendo da arle Ia Ioro consislenza slorica, erdono lulla Ia Ioro
efficacia.
Cos neIIa Ccnnc!ia VirgiIio e bens iI VirgiIio slorico, ma
d'aIlra arle non Io e iu, erche queIIo slorico e soIlanlo
figura deIIa verila ademiula che iI oema riveIa, e queslo
ademimenlo e quaIche cosa di iu, e iu reaIe, iu significali-
vo deIIa figura. AII'ooslo che nei oeli moderni, in Danle iI
ersonaggio e lanlo iu reaIe quanlo iu e inlegraImenle inler-
relalo, quanlo iu esallamenle e inserilo neI iano deIIa
50 |pisi. XIII, 7. Cfr. ALISSANDRO GHISALIRTI, Oanic A|ignicri. |a icc|cgia !c| pccia, in
GIULIO D'ONOIRIO (dir.), Sicria !c||a icc|cgia nc| Mc!icctc. III. Ia icc|cgia !c||c scuc|c, Casa-
Ie Monferralo (AL), Iiemme 1996, . 301-323, qui . 305. Ier un commenlo aI asso
cilalo, si veda IIIIN, Ia ira!iiicn !c |a||cgcric, cil., . 274-277.
51 AUIRACH, Siu!i su Oanic, cil., . 216.
52 Ivi, . 218.
Oanic c i Pa!ri !c||a Cnicsa 359
saIvezza elerna. I aII'ooslo che negIi anlichi oeli deII'oIlre-
lomba, i quaIi moslravano come reaIe Ia vila lerrena e come
umbraliIe queIIa sollerranea, in Iui I'oIlrelomba e Ia vera reaIla,
iI mondo lerreno e soIlanlo umbra fulurorum, lenendo conlo
ero che I'umbra e Ia refigurazione deIIa reaIla uIlralerrena
e deve rilrovarsi comIelamenle in essa
53
.
Dunque Ia sinlesi alrislica lra figura e reaIla, medilala neI
raorlo lra i due Teslamenli, cenlrala suII'Incarnazione deI Verbo, e
roIungala nei sacramenli deIIa Chiesa, non conosce ancora in Danle
queIIa dissociazione lra sicria e spiriic
54
che divenlera liica deI mondo
moderno, che si dividera lra sicricisnc e spiriiua|isnc.
Ier Danle iI senso IelleraIe o Ia reaIla slorica di un ersonaggio
non conlraddice iI suo significalo iu rofondo, ma ne e Ia figu-
ra, Ia reaIla slorica non e aboIila daI significalo iu rofondo,
ma ne e confermala e ademiula
55
.
Quesla inlerrelazione ermelle di lenere in un insieme coerenle
sia iI Danle deII'Inferno, cos drammalicamenle umano, sia iI Danle
deI Iaradiso, cos enelralo daI divino. Cerlo, anche aI lemo di
Danle non mancavano Ie lendenze meramenle siriluaIisliche e
neoIaloniche, ma Danle e decisamenle aIieno da esse. Secondo
I'inlerrelazione figuraIe deIIa reaIla, Ia vila lerrena e assoIulamenle
reaIe, deIIa reaIla di ogni carne in cui e enelralo iI Logos, ma con lul-
la Ia sua reaIla e soIlanlo umbra e figura di cio che e aulenlico,
fuluro e definilivo
56
. Sollo queslo asello Danle uo essere conside-
ralo come I'uIlimo grande raresenlanle deI ensiero alrislico.
|acc|ia icc|cgica !c|||ia|ia Mcri!icna|c, Napc|i
53 Ivi, . 222-223.
54 Cfr. HINRI DI LUAC, Sicria c Spiriic. |a ccnprcnsicnc !c||a Scriiiura scccn!c Origc-
nc, Roma, Id. IaoIine 1971.
55 AUIRACH, Siu!i su Oanic, cil., . 224-225.
56 Ivi, . 223.
SIRGIO SCONOCCHIA
SINICA TRAGICO NILLA COMM|O|A DI DANTI
Gianfranco Conlini forniva, neI 1970, un conlribulo fondamenlaIe
1
er risoIvere o, quanlo meno, er iIIuminare Ia queslione, a Iungo
diballula, deIIa resenza di Seneca lragico neIIa Ccnnc!ia.
L'insigne sludioso riare brevemenle, in un accenno deI suo cilalo
conlribulo, Ia queslione deIIa ossibiIe lecnofagia deI Conle UgoIino,
affermandone Ia maggior congruenza risello aIIa siluazione cuIlu-
raIe deIIa Ccnnc!ia. CoIIega inoIlre i maleriaIi degIi uIlimi canli
deII'Injcrnc con Ia definizione di lragedia roosla da Uguccione da
Iisa su| tccc Oda, che si accorda, in Iarga misura, con I'|pisic|a a
Cangrande (ca. X).
Conlini solloIinea
2
che, essendo I'|njcrnc Ia arle lemalicamenle
lragica deIIa Ccnnc!ia, nuIIa iu ircino e felido deIIa sede dei
lradilori, aI cui inverlilo verlice, oggello anche Iui di manducazione,
sla infalli iI arricida rulo |.j, convenienlissimo che Io receda
chi 'comedil fiIium': UgoIino infalli recede rulo, che sla aI fondo.
Un re qui ccnc!ii ji|iun e aunlo iI Tiesle di Seneca, lraendo Ia
vicenda daI cicIo lebano, eisodio che anche Orazio (Ars pcciica, 89-91)
richiama come 'aradigma' di ossibiIe soggello lragico. DaI Ticsic
di Seneca Conlini lrae due imorlanli consonanze lesluaIi con Ia figu-
razione deII'eisodio di UgoIino:
Desumendo da Uguccione Ia definizione di lragedia, Danle, si
diceva, saIla gIi esemi, soggiunge in cambio: ui paici pcr Scnc-
can in suis iragc!iis. Una di quesle e aunlo iI Tnqcsics, in cui
iI rolagonisla, aIIa riveIazione deII'inedilo crimine, aoslrofa
anche Iui (non insinuo in cos ovvio sviIuo, aIcun 'osl hoc
ergo roler hoc') Ia cruda lerra:
1 GIANIRANCO CONTINI, |i|c|cgia c! cscgcsi !anicsca, in Varianii c a|ira |inguisiica,
Torino, Iinaudi 1970, in arlicoIare . 418-19.
2 |i|c|cgia c! cscgcsi !anicsca, cil., . 418.
Sergio Sconocchia 362
Agnosco fralrem. Suslines lanlum nefas
Geslare, TeIIus` Non ad infernam Slyga
Te nosque mergis` |.j
Immola TeIIus, ondus ignavum iaces,
e chiede erche osli a laI croce gIi innocenli:
Quid Iiberi meruere` ...
|.j
Lella in quesla Iuce Ia sloria di Conle UgoIino acquisla in im-
manila, ma iI suo slorico in verecondia (di ben diverso erso-
naggio, loccalo soIo di sbieco, dira neIIa canlica seguenle che
neI figIio die di becco)
3
.
I raffronli, come si vede, lra Tnqcsics, vv. 1006-1020 e ancora
Tnqcsics, v. 1100 e |nj. XXXIII, v. 66 e ancora vv. 87-90 sono evidenli:
Tnqcsics, vv. 1006-1020
Agnosco fralrem. Suslines lanlum nefas
Geslare TeIIus` Non ad infernam Slyga
Te nosque mergis` |.j
Immola TeIIus, ondus ignavum iaces,
|nj. XXXIII, v. 66
ahi dura lerra, erche non
|l'arisli`
e ancora lra:
Tnqcsics, v. 1100
Quid Iiberi meruere`
|.j
|nj. XXXIII, vv. 87-90
non dovei lu i figIiuoi orre a laI croce.
Innocenli facea I'ela noveIIa,
|.j Uguiccione e 'I rigala
|.j
3 Aggiungerei un asso che conferma, a mio modo di vedere, Ia diendenza da Se-
neca. II v. 41: ensando cio che 'I mio cor s'annunziava mi sembra modeIIalo sui vv.
999-1001 di Seneca: Quis (qui! I) nic iunu|ius tisccra cxagiiai nca`/ qui! ircnuii inius?
scniic inpaiicns cnus / ncunquc gcniiu ncn ncc pccius gcnii, sebbene neI asso di Seneca
sembri evidenzialo sorallullo iI arlicoIare lrucuIenlo deIIe conseguenze deI aslo
umano gia avvenulo. AI v. 1008, neII'edizione di Ir. Leo, erIin 1878-79, er ic ncsquc si
Iegge icnc|rasquc.
Scncca iragicc nc||a Commedia !i Oanic 363
Ier i vv. 88-89: Innocenli facea I'ela noveIIa, / noveIIa Tebe |.j
gia iI uli ricorda Ia Ieggenda che allribuisce Ia fondazione di Iisa a
IeIoe, figIio di TanlaIo re di Tebe e adre aunlo di Alreo e Tiesle.
Le aIIusioni in Danle, come si vedra neI corso deI resenle conlribulo,
non sono mai casuaIi.
Se neIIa coslruzione di aIcuni caralleri deIIa figura deI Conle
UgoIino agisce, come e ben nolo, Ia memoria oelica di Verg. Acn. II, 3
sgg.
4
, neIIa slrullura deIIa vicenda narrala da Danle, Conlini indivi-
dua, in aIlri ersonaggi, lralli inconfulabiIi richiamali allraverso Ia
memoria oelica di Seneca lragico. Lo sludioso, che non si one, da
un unlo di visla generaIe, iI robIema deIIa resenza deIIe lragedie
di Seneca in Danle, conlribuisce, in ralica, a dare una risosla che mi
are ossa considerarsi definiliva aII'annosa queslione.
Con un saggio ben documenlalo e convincenle edilo negIi anni
ollanla Crislina Zamese
5
aorla, a sua voIla, un conlribulo imor-
lanle aI robIema deIIa conoscenza e deII'uliIizzazione, da arle di
Danle, neIIa Ccnnc!ia, di Seneca lragico.
La sludiosa rende Ie mosse dagIi iIIuminali accenni di Conlini,
anaIizzando un confronlo fra Uguccione, Magnac !critaiicncs e Danle,
|p. XIII (a Cangrande) 10. La Zamese
6
riIeva che, risello a Uguccio-
ne, Ia definizione roosla da Danle di lrageda (quasi 'canlus
hircinus', id esl felidus ad modum hirci) risuIla olenlemenle con-
densala, richiama inoIlre, er elimoIogia e significalo dei lermini ira-
gc!ia e ccnc!ia, I'esislenza di due Iinee di sviIuo rinciaIi: una
cIassica (si ensi a NicoIa Trevel), che si rifa esIicilamenle a Isidoro
di SivigIia e coIIega I'elimo lragos aI nome deII'animaIe dalo in
remio, un caro aunlo, I'aIlra, rinlracciabiIe in Uguccione, che, a
sua voIla, raccogIie I'eredila deI Ii|cr g|cssarun di Iaia e di Osborn e
in cui confIuisce anche una fonle diversa da Isidoro, che slabiIisce un
raorlo di inlerazione elimoIogica reciroca fra dramma e remio.
Nessuna deIIe due elimoIogie siega comiulamenle I'esressione
di Danle, che si avvicina comunque moIlo di iu aIIe esressioni di
Isidoro, anche se Ia conoscenza di quesl'uIlimo da arle di Danle resla
eraIlro dubbia.
La Zamese richiama inoIlre Ie due inquielanli consonanze
4 Non occorre ricordare che i vv. 4 sgg. Tu vuo' ch'io rinoveIIi / diseralo doIor
che 'I cor mi reme / gia ur ensando, ria ch'io ne faveIIi rirendono Verg. Acn. II, 3
sgg.: |njan!un, rcgina, iu|cs rcnctarc !c|crcn |.j.
5 CRISTINA ZAMIISI, Pisa nctc||a Tc|c. un in!izic !c||a ccncsccnza !i Scncca iragicc !a
paric !i Oanic, GSLI, CLXVI (1989), fasc. 533, . 1-21.
6 Cfr. ZAMIISI, Pisa nctc||a Tc|c, cil., . 2-3.
Sergio Sconocchia 364
lesluaIi che Conlini ricava daI Tnqcsics di Seneca. Ricorda
7
lullavia a
queslo unlo che iI rinvio di Conlini a Seneca lragico si sconlra con
un'oinione assai diffusa lra gIi sludiosi di Danle, Ia lendenza cioe a
negare Ia ossibiIila che Danle abbia olulo conoscere iI leslo comIe-
lo deIIa roduzione lragica deI Cordovese.
Cio fondamenlaImenle er lre ragioni
8
: Ia rima e che Danle, aI di
Ia deIIa discussa affermazione di |p. XIII Ui paici pcr Scnccan in suis
iragc!iis arrebbe conoscere soIlanlo Seneca moraIe (|nj. IV, 141), Ia
seconda e che neIIa Ccnnc!ia non sarebbero rinlracciabiIi reminiscen-
ze lesluaIi evidenli e cogenli, Ia lerza che cosliluisce I'obiezione iu
forle e che Io sludio deIIa lradizione manoscrilla di Seneca indiche-
rebbe, aII'eoca di Danle, un soslanziaIe e erduranle obIio dei codici
deIIa roduzione lragica di Seneca, aII'infuori deI quasi miracoIoso
fervore deI circoIo umanislico adovano.
Circa Ia queslione dei due Seneca, I'obiezione reIaliva a Seneca
moraIe, come riIeva Ia Zamese, e in reaIla suerala
9
. Tra I'aIlro, Ie
lragedie slesse erano considerale miniere di moraIila da comiIalori
medievaIi che ne lraevano cxccrpia. Ma suII'esressione Seneca mora-
Ie si aorleranno injra aIlre osservazioni, in riferimenlo sorallullo
aIIe considerazioni di rugnoIi.
ReIalivamenle aI secondo unlo, Ia Zamese riIeva che Ia discus-
sione suIIe ossibiIi reminiscenze di Seneca in Danle, iniziala nei due
rimi decenni di queslo secoIo con Irolo, iagi e Iarodi
10
e riresa in
7 Cfr. Pisa nctc||a Tc|c, cil., . 7.
8 ||i!.
9 Cfr. Pisa nctc||a Tc|c, cil., . 8 e n. 13. La sludiosa rinvia in n. 13 a GUIDO MAR-
TILLOTTI, Ia qucsiicnc !ci !uc Scncca !a Pcirarca a Bcntcnuic, IMU XV, 1972, . 149-69,
inoIlre a SANTORRI DIINIDITTI, Oanic c Scncca ji|cscjc, SD, VI, 1923, . 5-24, a
MANLIO IASTORI STOCCHI, Oanic, Mussaic c |a iragc!ia, in DV . 259, con Ia bibIiogra-
fia reIaliva, inoIlre a CARLO IAOLAZZI, Ic |ciiurc !anicscnc !i Bcntcnuic !a |nc|a, IMU,
XXII, 1979, er Ie . 327-28. MarleIIolli afferma: In reaIla lulla Ia queslione, caralleri-
slica deII'Umanesimo inciienle, non ha nuIIa a che fare con Danle. L'eilelo di 'moraIe'
che egIi allribuisce a Seneca e una di queIIe carallerisliche che si usavano neIIe rassegne
oeliche di ersonaggi iIIuslri, come 'saliro' er Orazio e 'geomelra' er IucIide, e a
Seneca ben s'addiceva. La Zamese richiama in n. 14 iI commenlo di Trevel aIIe Tragc-
!ic e solloIinea che moraIe non e un lermine lecnico come sosliene ITTORI IARATORI,
|| |aiinc !i Oanic, in Tra!izicnc c siruiiura in Oanic, Iirenze, Sansoni 1965, . 135. Con un
fine diverso GINO IUNAIOLI, Oanic c i| ncn!c aniicc, in Mc!icctc c |inascincnic. Siu!i in
cncrc !i B. Nar!i, Iirenze, Sansoni 1935, . 331, scriveva: L'aeIIalivo slesso di 'Seneca
moraIe' reesisle a Danle |.j, un'azione veramenle siriluaIe deI fiIosofo su Danle non
si cogIie e |.j neI 'Seneca moraIe' c'e iI suggeIIo di una lradizione, iu che una ersona-
Ie carallerizzazione.
10 INRICO IROTO, Oanic c i pccii |aiini. Ccniri|uic !i nucti risccniri a||a Oitina Ccn-
nc!ia, Alene e Roma, XI, 1908, XII, 1909, XIII, 1910, ILARIO IAGI, Oanic c Scncca, Iisa,
Scncca iragicc nc||a Commedia !i Oanic 365
iu occasioni da Giorgio rugnoIi
11
, non ha dalo risuIlali davvero
convincenli erche condolla allraverso iI confronlo di versi di Danle
e di Seneca eslraoIali dai risellivi conlesli e come laIi non accoslabi-
Ii suIIa base di iu circoslanziale somigIianze sliIisliche e lemaliche
12
.
AIcune deIIe immagini e degIi sliIemi di Danle allribuibiIi a in-
fIuenze di Seneca ossono essere, lra I'aIlro, secondo i negalori deIIa
resenza di Seneca lragico in Danle, riconducibiIi non aI Cordovese
ma ad aIlri oeli.
Di qui, rosegue Ia Zamese, Io scellicismo soslanziaIe duralo a
Iungo neIIa sloria crilica deIIa queslione, anche se conlribuli iu
recenli, lullavia, moslrano di accellare come aIlamenle robabiIe Ia
conoscenza di Seneca lragico
13
.
Anche reIalivamenle ad uno dei unli iu discussi deIIa queslione,
I'esressione ui paici pcr Scnccan in suis iragcc!iis Ia sludiosa afferma
che e riconosciula oggi, doo Iunghe oIemiche che avevano Iaceralo
gIi sludiosi in due oosli schieramenli crilici, risellivamenle a
favore e conlro I'aulenlicila deII'|pisic|a XIII, I'aulenlicila deIIa Iellera.
A favore deII'aulenlicila deII'|pisic|a si ronuncia, in un conlribulo
iu recenle e, sollo diversi aselli, moIlo uliIe e arezzabiIe, anche
ImiIio Iasquini
14
, che lullavia osserva
15
che Un conlo e saere che
Seneca scrisse anche lragedie, aIlro invece averIe Ielle. Ma, su queslo
unlo, mi sembra di non oler consenlire con Io sludioso, sia er iI
li. Ierdinando Timoncini 1913, IRNISTO GIACOMO IARODI, Ic iragc!ic !i Scncca c |a
Divina Commedia, uIIellino deIIa Sociela Danlesca IlaIiana, XXI, 1914, . 241-52.
11 Ia ira!izicnc nancscriiia !i Scncca iragicc a||a |ucc !c||c icsiincnianzc nc!icta|i,
Accademia NazionaIe dei Lincei. Memorie. CIasse di scienze moraIi |.j, s. VIII, 1957,
. 264, nola 122 (ma Ia Zamese richiama IRANCISCO MAZZONI, Gui!c !a Pisa inicrprcic
!i Oanic, SD, XXXV, 1958, . 93: I non enlro su quanlo vien dello, un o' di frella,
circa Ia conoscenza che Danle ebbe di Seneca), Ui paici pcr Scnccan in suis iragc!iis
RCCM 5, 1963, 1, . 143-63, e Oanic |nj. XXX 13 sgg., L'AIighieri, 7, 1966, . 98-9,
e voce |si!crc, |ncic|cpc!ia !anicsca, voI. III, . 522.
12 Ier indicazioni reziose in queslo senso Ia Zamese, . 9 n. 17, rinvia fallo saI-
vo iI diverso oggello deIIa ricerca, Ia rosa deI Ccntitic a MARIO MARTI, Aspciii sii|isii-
ci !i Oanic ira!uiicrc, in |ca|isnc !anicscc c a|iri siu!i, MiIano-NaoIi, Ricciardi 1961, .
108-25. Si veda anche MAURIZIO ITTINI, |cnii |ciicraric c nc!c||i scnic|cgici in Oanic,
SD, LII, 1979-80, sorallullo . 207-08.
13 La Zamese richiama ad es. SANDRA MALOSTI, Oanic ira!uiicrc?, Convivium,
XXXVII, 1964, . 256 e ALISSANDRO RONCONI, Pcr Oanic inicrprcic !ci pccii |aiini, SD,
XLI (1964), . 1-44.
14 IMILIO IASQUINI, Prcscnzc !i Scncca in Oanic, in Scncca nc||a ccscicnza !c|||urcpa, a
cura di I. Dionigi, MiIano, . Mondadori 1999, . 111-136. Iasquini rinvia sesso a
GIUSIIIINA MIZZADROLI, Scncca in Oanic. Oa||a ira!izicnc nc!icta|c a||cjjicina !c||auicrc,
Iirenze, Le Lellere 1990.
15 Cfr. . 133.
Sergio Sconocchia 366
lenore deII'esressione di Danle, ui !"#$# pcr Scnccan in iragc!iis suis,
sia considerando come sarebbe difficiIe ensare che un aulore deIIa
'curiosila' e 'aerlura' di Danle aIIa Iellura e documenlazione, cono-
scendo I'esislenza di una roduzione lealraIe di Seneca, non abbia
rovalo iI desiderio di conoscerIa.
Iasquini accogIie Ia roosla che Danle conosca, di Seneca, fIoriIe-
gi, ma sorallullo dei lrallali di rosa e moraIi lanlo iu infarcili di
scnicniiac, anche se iu esosli, neIIa memoria di Danle, a moIleIici
concorrenli. L'insigne sludioso e convinlo che sia imrobabiIe che
Danle non senlisse arIare deI Mussalo, neIIe cerchie cuIluraIi venele
(e magari anche di un Giovanni deI VirgiIio), ma riliene iu arduo
dimoslrare che a Danle assassero er Ie mani manoscrilli di Seneca
lra Verona e Iadova.
Concorda in ralica con Ie osizioni di Illore Iaralore
16
: riliene
difficiIe oler dimoslrare Ia conoscenza di Seneca lragico da arle di
Danle, lanlo iu che i risconlri iu robabiIi in Danle con queIIi deIIa
roduzione senecana si riducono, neII'ordine, a quallro (iI secondo dei
quaIi gia figura neIIe |spcsizicni deI occaccio), lulli, lranne I'uIlimo,
neII'|njcrnc
17
. Iasquini anaIizza i assi: richiamero Ia sua anaIisi dei
confronli neI corso di queslo Iavoro. I iulloslo difficiIe, riIeva Io
sludioso, eslrarre j|crcs o scnicniiac da un leslo lealraIe. In concIusio-
ne |.j resla arduo slabiIire come e quando Danle sia arrivalo a cala-
re quaIche leslo di Seneca, in ogni caso non rima degIi anni deI
Ccntitic (1304-1307).
Lo sludioso riIeva lullavia che iu si Iegge Seneca iu si sosella
che anche aIlro di Iui sia olulo fiIlrare er vie misleriose aIIa fanlasia
di Danle, anche in assenza di risconlri unluaIi.
In reaIla, con Ia Zamese, vorrei fare osservare che conlribuli come
queIIo di Conlini aorlano nuova Iuce suI robIema. Concordo con
Ia Zamese anche su un aIlro unlo che rilengo imorlanle: Ie anaIisi
di rugnoIi mio carissimo amico, insigne sludioso di Danle, di
roduzione nolevoIissima e aI quaIe ho iu voIle cercalo di riroorre
riensamenli suI lema qui discusso e di aIlri sludiosi come Iaralore,
sono condolle in genere allraverso iI confronlo di versi danleschi e di
Seneca eslraoIali dai risellivi conlesli e come laIi non accoslabiIi
suIIa base di iu circoslanziale somigIianze sliIisliche e lemaliche.
Cerchero di rivisilare I'inlera queslione, richiamando i conlribuli
16 Cfr. Ia voce Scncca neII'|ncic|cpc!ia !anicsca, voI. V, . 156-159. Iasquini rinvia
agIi sludi di Irolo e Iarodi, er i quaIi si veda injra, e rirende, in ralica, allraverso Ie
osizioni di Iaralore, queIIe di rugnoIi.
17 Cfr. . 133.
Scncca iragicc nc||a Commedia !i Oanic 367
fin da queIIi slorici di Irolo, iagi e Iarodi, cercando di lenere coIIega-
la I'anaIisi dei araIIeIi roosli con i conlesli. In queslo senso, credo
di oler affermare che anche Ia 'quanlila' vaIe, come e nolo, meno deI-
Ia 'quaIila', ma Ia 'quanlila' uo avere significalo e vaIore. Assume Ia
sua imorlanza anche Ia cosiddella 'accumuIazione' neIIe siluazioni:
quaIche accoslamenlo un o' iu deboIe uo lrarre una cerla confer-
ma da accoslamenli iu robanli, sorallullo se lra i quadri d'insieme,
come vedremo, in aIcuni casi, lra Danle e Seneca c'e una nolevoIe
affinila.
Rirendo dunque Ia discussione cercando di inquadrarIa in lulli i
suoi moIleIici aselli.
RiIeggevo un giorno I'Hcrcu|cs Ociacus di Seneca. Ai vv. 1736 sgg.,
ove si descrive come I'eroe muore nobiImenle suI rogo, mano a mano
che rocedevo neIIa Iellura, mi rendevo conlo con semre maggiore
consaevoIezza e non senza sluore che a quesli versi oleva esse-
re accoslala Ia figurazione deI Iarinala di Danle, quasi che Danle Io
avesse modeIIalo su Seneca
18
:
al iIIe medias inler exurgens faces,
semiuslus ac Ianialus, inlreidum luens:
'nunc es arens HercuIea: sic slare ad rogum
le maler' inquil, 'sic decel fIeri HercuIem.'
inler vaores osilus el fIammae minas
immolus, inconcussus, in neulrum Ialus
correla lorquens membra adhorlalur, monel,
geril aIiquid ardens. omnibus forlem addidil
animum minislris, urere ardenlem ules.
sluel omne voIgus, vix habenl fIammae fidem,
lam Iacida frons esl, lanla maieslas viro.
nec roeral uri, cumque iam forli dalum
Ielo salis ensavil, igniferas lrabes
hinc inde lraxil, minima quas fIamma occual,
lolasque in ignes verlil el quis Iurimus
18 D'ora in avanli seguo er Ie lragedie di Seneca iI leslo crilico slabiIilo da
Iriedrich Leo, erIino, Weidmann 1878-79 (1963), in 2 voII., er Ie oere di VirgiIio
I'edizione crilica curala da Irederich Arlhur HirlzeI, Oxford, CIarendon Iress 1950
(1900), er Ie Mciancrjcsi di Ovidio I'edizione di G. Lafaye, Iarigi, Les eIIes Lellres
1966, er Orazio, Ars pcciica, iI leslo crilico curalo da Iridericus KIingner, Lisia, Teub-
ner 1959. Ier iI leslo di Danle si segue I'edizione a cura di Giorgio Ielrocchi, Ia Ccnnc-
!ia scccn!c |aniica tu|gaia, MiIano, Mondadori 1966-67.
Sergio Sconocchia 368
exundal ignis reelil inlreidus ferox.
lunc ora fIammis imIel: asl iIIi graves
Iuxere barbae, cumque iam voIlum minax
aelerel ignis, Iamberenl fIammae caul
|.j
Da queII'osservazione iniziaIe e lrascorso deI lemo. Ho rovalo iI
bisogno di documenlarmi suIIa queslione dei raorli fra Danle e
Seneca lragico, un robIema che richiede, a mio avviso, una serena e
non revenula rivisilazione.
II rimo sludioso a rodurre una serie di confronli fra Danle e
Seneca e Irolo
19
.
I maleriaIi di Irolo, un o' lroo abbondanli e iulloslo magma-
lici, sono rieIaborali osilivamenle da Iarodi
20
.
Ma, con iI assare deI lemo, iI Iavoro di Iarodi cade in obIio. II
robIema dei raorli Danle-Seneca viene loccalo soIo incidenlaImen-
le da aIlri sludiosi.
La queslione e riaerla da Giorgio rugnoIi nei due imorlanli ar-
licoIi da me gia cilali
21
.
NeI rimo, Ui paici pcr Scnccan in suis iragc!iis rugnoIi conlesla Ia
alernila danlesca deII'|pisic|a a Cangrande
22
. Lo sludioso anaIizza i
19 IROTO, Oanic c i pccii |aiini, Alene e Roma, 11, 1908, . 23 sgg., 221 sgg., 12,
1909, . 7 sgg., 277 sgg., 13, 1910, . 79 sgg., 149 sgg.
20 IARODI, Ic iragc!ic !i Scncca c |a Oitina Ccnnc!ia, uIIellino deIIa Sociela danle-
sca ilaIiana, 21, 1914, . 241 sgg., uno sludio che rilengo fondamenlaIe er iI noslro
robIema. Iarodi, che cilero sesso in queslo Iavoro, sosliene che Danle ha allinlo am-
iamenle aI leslo di Seneca.
21 Ui paici pcr Scnccan in suis iragc!iis, RCCM 5, 1963, 1, . 143-63, e Oanic |nj.
XXX 13 sgg., L'AIighieri, 7, 1966, . 98-9.
22 A favore deII'aulenlicila deIIa Iellera a Cangrande si veda MAZZONI, I|pisic|a a
Cangran!c, A. Linc. 1955, ser. VIII, voI. X, fasc. 3-4, . 157-98 e ID., Ccniri|uii !i ji|c|c-
gia !anicsca, I serie, Iirenze, Sansoni 1966, ca. Ier I'|pisic|a a Cangrande, . 7-37,
La Qucsiic !c aqua ci icrra, . 38-39, II unlo suIIa Qucsiic !c aqua ci icrra, . 80-
125. Anche G. Conlini crede neII'aulenlicila deII'|pisic|a. Anche Inzo Cecchini crede
neII'aulenlicila deII'|pisic|a. Ho condollo una ricerca suIIe oere Ialine di Danle (iI leslo
e queIIo deIIa Sociela Danlesca IlaIiana, Iirenze 1921 |1960j) er cercare di rilrovare
esressioni anaIoghe a ui paici pcr Scnccan in suis iragc!iis |.j (cui segue, neII'|pisic|a,
ui paici pcr Tcrcniiun in suis ccnc!iis. I risuIlali sono osilivi. NeI Oc tu|gari ||cqucniia
non abbiamo Iocuzioni affini. NeIIa Mcnarcnia I XIV |XVIj 4 lroviamo: ui paici pcr pni|c-
scpnun in quinic a! Niccnacnun |.j, in II, II, 3 un esemio meno vicino aI noslro: ui cx
niis paici quc !c cc|c pnq|cscpnanur, e in II, VII |VIIIj 9 ui paici in su|siiiuiicnc Mainic in
Acii|us Apcsic|crun. NeIIe |pisic|c non abbiamo aIlre esressioni simiIi. GIi esemi iu
inleressanli si rilrovano neIIa Qucsiic !c aqua ci icrra: a XI 21 abbiamo: ui paici cx princ a!
Nicncnacun, XII 24: ui paici in jigura signaia, XII 25: ui paici pcr tcran !cncnsiraiicncn
Scncca iragicc nc||a Commedia !i Oanic 369
confronli roosli da Irolo e da Iarodi e concIude (. 158-59):
|.j dei cinquanlanove Iuoghi addolli, quallordici (nn. 8, 10, 11,
14, 15, 18, 20, 36, 40, 45, 46, 49, 55, 58)
23
sono generici e imerli-
nenli. AIlri venli (nn. 2, 3, 6, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29,
30, 32, 35, 37, 44, 54, 56) sono messi in dubbio daI Iarodi. Ier aI-
lri diciollo (nn. 1, 4, 5, 7, 9, 13, 24, 28, 33, 39, 41, 42, 47, 50, 51, 52,
57, 59) e slalo faciIe addurre raidamenle un confronlo che fos-
se aImeno deIIo slesso vaIore.
Rimangono e si lralla semre di confronli scarsamenle
formaIi selle Iuoghi (nn. 19, 31, 34, 38, 43, 48, 53), i iu signifi-
calivi. Di essi uno (n. 38) e un prctcr|iun. GIi aIlri sei sono cosli-
luili da simiIiludini |.j. La forluna di Seneca lragico neI Me-
dioevo e affidala ai IIoriIegi fino aIIa scoerla deIIe lragedie in
lemi vicinissimi a Danle, gIoria deI Ireumanesimo adovano.
Danle non moslra di conoscere i j|crcs neIIe raccoIle lradizionaIi.
Ne esibisce Ia saienza dei ncniia. I gia difficiIe ensare che
conoscesse iI leslo deIIe lragedie, oIlre che er Ia dimoslrala sua
ignoranza deII'allivila lragica di Seneca, anche er Ia vicinanza
deIIa scoerla deIIe lragedie. Si osservi ancora che non sfrulla
mai Ia versione dei vari mili arlicoIare aIIe lragedie. Sara
quindi credibiIe che, anche nei sei Iuoghi er cui e imossibiIe
rilrovargIi un araIIeIo iu vicino che iI leslo senechiano, non
dimoslri oi una sicura e dirella Iellura deIIe lragedie.
Si lralla di simiIiludini che giungono a Seneca allraverso
una Iunga lradizione. Anche in Danle iI +oo, sara disceso er i
rami di una ralica scoIaslica non semre conlroIIabiIe. Non
dobbiamo dimenlicare, aIlrimenli, che allribuendogIi una cos
accurala e recisa riresa deI leslo deIIe lragedie, verremmo a
iolizzargIi un Seneca maeslro e aulore, quaIe, insiegabiImen-
le, non ci verrebbe oi a dichiarare.
Non ci sono dunque rove che Danle abbia avulo fra Ie sue
Iellure Ie lragedie di Seneca.
NeI secondo arlicoIo rugnoIi e lornalo a conleslare iI araIIeIo fra
Trca!cs, vv. 6-7 e 29-30 e |nj. XXX, 13 sgg., indicando ancora una voIla
|.j , XIV 30: ui !c sc paici |.j, XVIII 47 ui !c sc paici e ui paici iniucnii, XVIII 48: ui paici
cx princ |iniccrun, ma I'esemio iu vicino aI noslro e VI 14: ui paici pcr Pnq|cscpnun in
Mciauris suis |Mciccrc|. II II, Ij. Danle usa dunque esressioni simiIi a ui paici pcr Scnc-
can in suis iragc!iis neIIa rosa scienlifica deIIa Mcnarcnia e seciaImenle deIIa Qucsiic.
23 Riorlo laIvoIla, er Ia numerazione dei confronli, queIIa di rugnoIi.
Sergio Sconocchia 370
Ia fonle deI asso danlesco in Ovidio Mcian. XIII, 404-575.
Mi sembra di non oler consenlire con i risuIlali raggiunli da ru-
gnoIi nei suoi due sludi (seciaImenle neI rimo) che sono lullavia
moIlo uliIi er aIcuni risuIlali che vi si conseguono.
Ia ralicamenle sue Ie oinioni esresse da rugnoIi nei Iavori
cilali Illore Iaralore, neIIa voce Scncca deII'|ncic|cpc!ia !anicsca. Iara-
lore riIeva che, se si accellasse Ia alernila danlesca deII'|pisic|a XIII a
Cangrande, con iI nolo asso X, 29 Tragc!ia in principic csi a!nira|i|is ci
quicia |.j ui paici pcr Scnccan in suis iragc!iis, se ne dovrebbe ricavare
Ia conoscenza di Seneca lragico da arle di Danle.
Quanlo aIIa ossibiIila di araIIeIi direlli fra Seneca e Danle, Iara-
lore si moslra roenso ad ammellere che Danle conosca Seneca aI
massimo allraverso fIoriIegi medievaIi
24
.
Mi sembra che rugnoIi abbia anaIizzalo un o' sommariamenle i
confronli e Ie ragioni addolle da Iarodi e che aIcune deIIe siegazioni
da Iui roosle non reggano ad un esame iu unluaIe.
Rilengo oorluno, come gia dello, ridisculere Ia queslione, con-
vinlo che ci siano aIcune ragioni er rilenere moIlo robabiIe Ia Iellu-
ra, da arle di Danle, di Seneca lragico.
Si uo anche riIevare che, insiegabiImenle, rugnoIi (come oi
Iaralore) assa sollo siIenzio aIcuni dei raffronli iu significalivi,
come aunlo queIIo lra Hcrcu|cs Ociacus e Iarinala.
Irorio con queslo confronlo, che e forse I'esemio iu imorlanle
di cio che Danle deve a Seneca, desidero concIudere quesla rima
arle deI mio discorso.
Iarodi Io roose, ma forse con rudenza eccessiva
25
:
|.j iu ancora mi iace riIevare, e queslo raffronlo serva di
chiusa, che I'IrcoIe eroico deII'uIlima scena, iI quaIe arde immo-
lo e imerlerrilo suIIa ira deII'Oela, robabiImenle enlra er
quaIche cosa e c'enlri ure er oco, I'IrcoIe di Seneca non ha
avulo onore e merilo iu grande di queslo neIIa creazione di
queI vero giganle ed eroe ch'e iI Iarinala di Danle. Si consideri-
no seciaImenle i vv. 1740 sgg.:
24 Iaralore si era esresso in modo iulloslo dubiloso circa Ia conoscenza di Seneca
lragico da arle di Danle in aIlri due Iavori: Oanic c i| ncn!c c|assicc, in Oanic, a cura di
Umberlo Iarricchi, Roma, De Luca 1965, . 118, e Tra!izicnc c Siruiiura in Oanic, Iirenze,
Sansoni 1968, . 108-118 e 134 sgg. (sebbene in una nola aggiunliva, . 136 n. 18, sem-
bri accennala una aIinodia).
25 Cfr. IARODI, Ic iragc!ic !i Scncca, cil., . 251-252.
Scncca iragicc nc||a Commedia !i Oanic 371
Inler vaores osilus el fIammae minas
|nncius, inccncussus, in ncuirun |aius
Ccrrcpia icrqucns ncn|ra, adhorlalur, monel |.j
|.j Vrere ardenlem ules
Sluel omne voIgus, vix habenl fIammae fidem,
Tan p|aci!a jrcns csi, iania naicsias tirc
26
.
A me are che in reaIla iI raorlo fra Danle e Seneca sia iu
amio, e anche formaIe, a! tcr|un.
Si riIegga lullo iI asso come riorlalo supra: c'e un asse eIoculivo
slrulluraIe e formaIe idenlico con Danle. C'e inoIlre in Danle caacila
di riuliIizzare i maleriaIi e 'soslare', er cos dire, i iani: si vedano
ai i||c inircpi!us iucns (vv. 1736-37) e Ma queII'aIlro magnanimo a
cui osla / reslalo m'era, non mulo asello, / ne mosse coIIo, ne iego
sua cosla |.j, nc!ias inicr cxsurgcns jaccs (v. 1736, iI ms. I Iegge
qui cxurcns) sembra iI modeIIo di ed eI s'ergea e vedi Ia Iarinala
che s'e drillo, scniusius ac |aniaius (v. 1737), con iI v. 1736 (anche Ir-
coIe si erge daI rogo) sembrano iI chiaro resuoslo di da Ia cinloIa
in su lullo 'I vedrai, inircpi!un iucns (v. 1737, iI ms. A Iegge inircpi!us
ru|cns, iI ms. I inircpi!us rucns, inircpi!us iucns e correzione di
N. Heinsius) con ian p|aci!a jrcns, iania naicsias tirc (v. 1746), con
inircpi!us jcrcx (v. 1751) e ian tc|iun ninax (v. 1753: queslo verso e
omesso daI ms. I) olrebbe essere iI modeIIo di com'avesse I'inferno
a gran disillo. Anche nei vv. 1740-42 (a v. 1742 icrqucns e correzione
di Gronovius, A Iegge j|ccicns, I icrrcns, er ncnci I Iegge nctci) ci
sembra di vedere iI resuoslo di Danle |nj. X, v. 75. InoIlre ian
p|aci!a jrcns (v. 1745) richiama e con Ia fronle, infine anche iania
naicsias tirc (v. 1746) are modeIIo di queII'aIlro magnanimo.
II significalo di magnanimo
27
e queslo: magnanimo richiama
26 Iarodi rilorna successivamenle su queslo confronlo in Pccsia c sicria nc||a Oitina
Ccnnc!ia, NaoIi, IerreIIa 1920, . 543 n. 1: Mi ar robabiIe che Danle ricordasse neI
figurare iI suo Iarinala, qui e in seguilo, I'uIlima scena de I'Hcrcu|cs Ociacus di Seneca,
dove I'eroe arde immolo ed imerlerrilo suIIa ira, vv. 1740 sgg. | .j. Cerlo Seneca
descrive e narra iu che raresenlare, ma non manca di nobiIla ed efficacia. Vedi Bu||c-
iin, cil., XXI 241 sgg.. Iarodi richiama infine queslo confronlo in Pccsia c sicria, o. cil.,
. 566, in cui scrive: |.j e se Iarinala arde elernamenle neIIa sua lomba di fuoco,
I'incendio, er Iui, come er I'IrcoIe Oeleo, di cui forse rilrae quaIche sembianza, non e
che un Iuogo di esiazione er Ie coIe umane commesse in umani e non ingenerosi
lraviamenli deIIa assione, una Iuce di gIoria er iI modo come egIi ha saulo, in un
grande amore, urificarsi e redimersi.
27 Cfr. MARIO SANSONI, voce |arinaia in |ncic|cpc!ia !anicsca, voI. II, . 804-809,
qui 808.
Sergio Sconocchia 372
naicsias, che e un concello che in Ialino si lrova riferilo a ersonaggi
nobiIi
28
.
Ier Seneca IrcoIe raresenla I'eroe che subIima Ie virlu umane
e riscalla Ie sue coIe con una morle coraggiosa, lra fiamme che Io
urificano e Io esaIlano e che quasi non sembra avverlire, e Ia concre-
lizzazione iu aIla deI sapicns circonfuso di naicsias.
AIIo slesso modo Iarinala arde in elerno lra fiamme (e non
sembrano loccarIo) che ne uniscono iI eccalo di eresia ma non ne
fiaccano, anzi ne esaIlano Ia slalura moraIe di citis ideaIe di Iirenze.
Iarinala e 'magnanimo' er Ia sua condolla in lerra e er Ia sua
accellazione deI casligo elerno.
Come ben riIeva Ronconi
29
, in:
La lua IoqueIa li fa manifeslo |.j e rireso da |.j |cquc|a iua
nanijcsiun jacii |.j deI VangeIo secondo Malleo (XXV, 73: gIi
aslanli deI Sinedrio di Caifa conleslano a Iielro che egIi e uno
dei seguaci di Gesu).
Quanlo dice Ronconi e esallo, si hanno qui due falli: 1 Danle
uliIizza un moduIo evangeIico, er sua nalura narralivo, in un
conleslo di nalura diversa, in ralica eico-Iirico, 2 Danle are
qui aver 'conlaminalo' e 'lradollo' in Iarinala due modeIIi, lra Ie
fonli iu carallerisliche deIIa Ccnnc!ia, un cIassico e Ia Scrillura,
in queslo seguendo un melodo ben messo in risaIlo daIIo slesso
Ronconi
30
.
I da aggiugere che, er Cerbero, allraverso Ovidio, VirgiIio e Se-
neca in Hcrcu|cs jurcns (cfr. injra), si ha Ia sovraosizione di lre iani.
I slrano che Iarodi non abbia ben sviIualo iI suo confronlo,
forse cio e dovulo ai lemi in cui I'iIIuslre crilico scrisse, in cui re-
dominava un maIinleso senso deII'originaIila di Danle
31
. Oggi si
28 Ier I'uso di naicsias si veda Tncs. |. Iai. VII 1, 152-58, er accezioni adalle aI no-
slro caso si veda sorallullo 157 (da Iinea 52) 158 (Iinea 7). Si lenga anche conlo che
naicsias ha Ia radice di naicr, cioe di nagnus ('magnanimo'). Cfr. }OHANNIS ALUS,
Cainc|iccn scu Sunna prcsc!iac, ed. O. Scolo, Venezia, onelo LocaleIo 1495, sub voce
Maicsias: Maicsias a naicr !iciiur ncc naicsias iaiis. |. c. ncncr. !igniias sp|cn!cr |.j.
29 RONCONI, Pcr Oanic inicrprcic !ci pccii |aiini, SD, 41 (1964), . 27-8.
30 Cfr. Pcr Oanic inicrprcic, cil., sorallullo . 25 sgg., 29 e 44.
31 Si veda in quesla roselliva quanlo dice di Danle IILICINA GROIII neIIa Con-
cIusione deI suo Oanic ira!uiicrc, Roma, Herder 1962, seciaImenle . 184-86. La
Groi non locca affallo iI robIema Danle Seneca lragico. Anche neIIa bibIiografia,
. 198-99, non moslra di conoscere, lra i Iavori di Iarodi e Irolo, gIi arlicoIi da me
cilali che sono fondamenlaIi er I'argomenlo che ho discusso.
Scncca iragicc nc||a Commedia !i Oanic 373
inlende megIio Ia vilaIe caacila di assimiIazione cuIluraIe e Ielleraria
deII'AIighieri.
I sorallullo slrano che iI confronlo Iarinala-IrcoIe sia slalo
dimenlicalo. Come sono cadule in obIio aIlre feIici inluizioni di Irolo
e Iarodi. Cos neIIa crilica erano andali erduli eIemenli imorlanli
deI raorlo Danle-Seneca lragico.
C'e ancora un unlo su cui mi sembra iI caso di rilornare ancora
brevemenle. Uno degIi eIemenli lradizionaImenle resi a soslegno
deIIa lesi che Danle non conosca Seneca e |nj. IV, 140-41:
|.j e vidi Orfeo,
TuIo e Lino e Seneca moraIe.
La cilazione di Seneca moraIe e slala inlerrelala er escIudere
una conoscenza di Seneca lragico, aunlo.
Ma, se Danle inlendesse qui con I'aggellivo 'moraIe' dislinguere
Seneca fiIosofo daI drammalurgo, si dovrebbe a maggior ragione
riconoscere che Danle conosca aunlo anche quesl'uIlimo.
In reaIla iI robIema dei due Seneca, carallerislico, come ben os-
serva G. MarleIIolli
32
,
deII'Umanesimo inciienle, non ha nuIIa a che fare con Danle.
L'eilelo di moraIe ch'egIi allribuisce a Seneca e una di queIIe
carallerizzazioni che si usavano neIIe rassegne oeliche di
ersonaggi iIIuslri come saliro er Orazio e geomelra er
IucIide, e a Seneca ben si addice
33
.
MarleIIolli osserva anche che I'eilelo moraIe, quaIora non sia
inlenzionaImenle conlraoslo a queIIo di oela o di lragedo,
32 Ia qucsiicnc !ci !uc Scncca !a Pcirarca a Bcntcnuic, IlaIia medioevaIe e umanisli-
ca XV, 1972, . 149-69 (er iI noslro robIema vedi sorallullo . 169 e nola 1).
33 Aggiungo sorallullo che nei vv. 121 sgg. iI vaIore di 'definizione' e chiaro in lul-
le Ie esressioni: v. 121: IIellra con moIli comagni, v. 123: Cesare armalo con Ii
occhi grifagni vv. 125-26: vidi 'I re Lalino / che con Lavina sua figIia sedea, v. 127:
Vidi queI rulo che caccio Tarquino, v. 129: e soIo in arle, vidi 'I SaIadino, v. 131:
I 'I maeslro di coIor che sanno, com'e nolo, ben corrisonde iI asso di Ccnt. 6, 8, vv.
134-35: quivi vid'io Socrale e IIalone, / che 'nnanzi a Ii aIlri iu resso Ii slanno: an-
che qui c'e iI asso araIIeIo di Ccnt. IV, cil., v. 136 : Democrilo che 'I mondo a caso
one, vv. 139-40: e vidi iI buono accogIilor deI quaIe, / Diascoride dico, v. 142: Iu-
cIide geomelra, v. 114: Averois, che 'I gran commenlo feo. Tra lanli lermini di defi-
nizione slonerebbe un lermine inleso Iimilalivamenle.
Sergio Sconocchia 374
conviene anche a Seneca aulore lragico
34
.
'MoraIe' definisce un asello fondamenlaIe, Ia moraIila aunlo,
da Danle rilrovalo anche neI lragediografo (si ensi aIIa morle da
sapicns sloico di Hcrcu|cs-Iarinala). Ier Danle, uomo deI Medioevo, Ie
Tragedie come Ie Commedie rienlravano in un lio di Ielleralura a
carallere moraIe.
Non discorda da queslo I'imiego deI lermine in un aIlro asso
deIIa Ccnnc!ia, Purg. XVIII, 67-9:
CoIor che ragionando andaro aI fondo,
s'accorser d'esla innala Iiberlale,
ero moraIila Iasciaro aI mondo.
Secondo rugnoIi 'Seneca moraIe' richiamerebbe iI ncrigcr Scncca
di Arrigo da SellimeIIo (III, 47). Doo quanlo si e vislo credo che si
debba ormai inlendere in Danle iI lermine moraIe aunlo con un
significalo di definizione elica deIIa 'moraIila' di Seneca.
Danle, che di Seneca, come dice rugnoIi (. 147), moslra di cono-
scere iI Oc Bcncjiciis (Ccnt. I, 8, 16 e Purg. XVII, 59 Oc Bcn. II, 1, |nj.
XII, 107 Oc Bcn. I, 13, 3), Ie |pisiu|ac a! Iuci|iun (Ccnt. IV, 12, 8: sono
cilale Ie |pisiu|ac in generaIe, |nj. XXVI |p. 88) e, forse soIo indirel-
34 Cfr. Ia qucsiicnc !ci !uc Scncca, cil., . 169 n. 1. II MarleIIolli aggiunge che
neII'acccssus che recede iI commenlo di Guizzardo neII'|ccrini!c, quando si lralla di
slabiIire cui arli hiIosohie suonalur, si recisa che I'|ccrini!c va ascrilla
aII'elica, erche bonarum imilalione morum el maIorum reieclione virlus gignilur el
augelur (ALIRTINO MUSSATO, |ccrini!c a cura di L. Iadrin, oIogna 1900, . 83). An-
che er NicoIa Trevel Ia roduzione lragica di Seneca olesl suoni elhice (cfr. IA-
STORI STOCCHI, Oanic, Mussaic c |a iragc!ia, in Oanic c |a cu|iura tcncia, Iirenze, OIschki
1966, . 259 n. 33). DeI reslo gia Orazio, Ars pcciica, vv. 317 sgg., ammoniva: rcspiccrc
cxcnp|ar tiiac ncrunquc iu|c|c / !cciun iniiaicrcn ci titas ninc !uccrc tcccs. / inicr!un
spccicsa |ccis ncraiaquc rccic / ja|u|a nu||ius tcncris, sinc pcn!crc ci aric, / ta|!ius c||cciai
pcpu|un nc|iusquc ncraiur / quan tcrsus incpcs rcrun nugacquc cancrac. Quanlo aIIa nola
deI commenlo di envenulo da ImoIa a |nj. IV, 141 in cui envenulo definisce Senecam
moraIem er exceIIenliam e aggiunge VeI dicil Senecam moraIem ad differenliam
aIlerius Senece qui fecil lragedias el fuil de descenlibus Senece (accoIgo iI leslo roo-
slo daI MarleIIolli . 166) iI MarleIIolli (. 167 n. 1), sosliene che envenulo ricordando
un giudizio di IIularco, secondo cui Ia Grecia non avrebbe avulo aIcuno arem Senece
in moraIibus desumeva Ia nolizia allraverso Ia Iellera a Seneca deI Ielrarca (|an. XXIV
5, 3-4): allraverso iI asso deI commenlo non si riesce a risaIire aIIa fonle rima di essa,
che olrebbe essere Ia erdula |nsiiiuiic Traiani deIIo Iseudo-IIularco, se quesla non e
da considerare un'invenzione di Giovanni di SaIisbury. MarleIIolli richiama MOMI-
GLIANO, Ncics cn Pcir., jcnn cj Sa|is|urq an! inc |nsiiiuiic Traiani, in Ccniri|uic a||a sicria
!cg|i siu!i c|assici, Roma, Idizioni di sloria e Ielleralura 1955, . 377-79, SAVIRIO DISI-
DIRI, Ia |nsiiiuiic Traiani, Universila di Genova, Islilulo di IiIoIogia cIassica 1958.
Scncca iragicc nc||a Commedia !i Oanic 375
lamenle allraverso iI Oc Mciccris di AIberlo Magno, Ie Naiura|cs quac-
siicncs (Ccnt. II, 13), arIando deI Cordovese non dislingue mai lra
Seneca fiIosofo e Seneca lragico.
Si veda Ccnt. I, 8, 16: Ier che dice Seneca che nuIIa cosa iu
cara si comera che queIIa dove i rieghi si sendono, II, 13, 22:
I Seneca dice ero, che ne Ia morle dAuguslo imeradore vide
in aIlo una aIIa di fuoco |.j, III, 14, 8: I erche di quesli
arIiamo, quando lroviamo Ii aIlri che er quesli ensieri Ia Ioro vila
disrezzano, s come Zeno, Socrale, Seneca, e moIli aIlri`, IV,
12, 8: |.j quanlo conlra esse Seneca, massimamenle a LuciIio
scrivendo.
V. |. I, 17, 2: |.j veI quia, exceIIenler magislrali, exceIIenler
magislrenl, ul Seneca el Numa IomiIius, |pisi. III, 8: Remedia,
que ab incIilissimo hiIosohorum Seneca |.j, |pisi. XIII, 29: e iI
nolo asso ul alel er Senecam in suis lragoediis |.j.
Cerchero ora di anaIizzare i raffronli roonibiIi fra Danle e Seneca
lragico.
II mio rimo inlenlo sarebbe slalo di rocedere raggruandoIi,
indiendenlemenle daIIa lragedia a cui aarlengono, secondo Ia
Ioro imorlanza e dislinguendo i iu generici dai iu ersuasivi.
Ho oi abbandonalo quesla idea: mi e sembralo che Iandamenlo deI
discorso avrebbe erdulo in chiarezza ed incisivila, erche sarebbe
venula a mancare Ia visione dinsieme in cui, lragedia er lragedia,
si uo seguire Ia roselliva deIIa memoria danlesca
35
(sia che
essa sia esIicala su ami cxccrpia sia su lesli inlegri).
I araIIeIi roosli sono cos raggruali lragedia er lragedia.
RisuIlera in queslo modo iu chiara Ia cosleIIazione deIIe rirese
danlesche neIIa conlesluaIila generaIe e Ia oIicromia deI rocesso
di aroriazione di Danle. Ad esemio si vedra come iI oela
abbia lrovalo er cerle Iinee di slrullura infernaIe neII'Hcrcu|cs
jurcns una maleria aImeno equivaIenle a queIIa che gIi roviene
daII'|nci!c.
Terro lullavia dislinli in quaIche modo dai confronli iu imorlan-
li queIIi meno ersuasivi confinando di norma quesli uIlimi in nola.
Anche iI Iarodi (. 242) rende Ie mosse daI |urcns, in cui lrovia-
mo un vero e rorio viaggio infernaIe. Seneca rirende VirgiIio,
eIaborando con originaIila moIli arlicoIari deIIa calabasi. Danle ha
35 AccoIgo Ia leorizzazione dei diversi aselli deII' 'imilazione' dei oeli roosla
da GIAN IAGIO CONTI, Mcncria !ci pccii c sisicna |ciicraric. Caiu||c, Virgi|ic, Oti!ic, Iu-
canc, Torino, Iinaudi 1974.
Sergio Sconocchia 376
resenle VirgiIio ma er numerosi eIemenli si rifa a Seneca
36
.
II viaggio di IrcoIe si inizia ai vv. 662 sgg. (e Teseo a racconlare):
Sarlana leIIus nobiIe alloIIil iugum,
densis ubi aequor Taenarus siIvis remil,
hic ora soIvil Dilis invisi domus
hialque rues aIla el immenso secu
ingens vorago faucibus vaslis alel
Ialumque andil omnibus ouIis iler.
non caeca lenebris inciil rimo via,
lenuis reIiclae Iucis a lergo nilor
fuIgorque dubius soIis adfIicli cadil
el Iudil aciem: nocle sic mixla soIel
raebere Iumen rimus aul serus dies.
Irolo inlravede Ia ossibiIila di un confronlo lra i vv. 669 sgg. e
|nj. XXXI, 10:
Qui v'era men che nolle e men che giorno
II Iarodi invece crede iu giuslo ricordare |nj. XV, 17 sgg:
|.j e ciascuna
ci riguardava come suoI da sera
guardare uno aIlro sollo nuova Iuna,
e s ver' noi aguzzavan Ie cigIia
come 'I vecchio sarlor fa ne Ia cruna.
Se ben si considerino i versi di Seneca 669-672 e iI asso di Danle
(|nj. XXXI, 10-11) neI Ioro insieme Irolo sembra aver ragione:
36 Sembra che secondo iI Iarodi I'imilazione di Seneca comrenda anche iI concello
di 'seIva oscura'. II Iarodi cila i vv. 834 sgg.: ausus cs cacccs a!iius inirc, / !ucii a! nancs
tia qua rcncics / irisiis ci nigra nciucn!a si|ta, / sc! jrcqucns nagna ccniianic iur|a |.j. II
araIIeIo sarebbe con |nj. I, 5-6: esla seIva seIvaggia e asra e forle / che neI ensier
rinova Ia aura. rugnoIi fa ero osservare che in Seneca e Ia via che !ucii a! nancs
rcncics ad essere irisiis ci nciucn!a erche assa allraverso una nigra si|ta. InoIlre in
Seneca Ia seIva e nciucn!a menlre in Danle neI ensier rinova Ia aura. Iorse non si
uo essere deI lullo sicuri che Danle non olesse senlire nciucn!a come abIalivo (e vero
che I'endecasiIIabo saffico doveva essere abbaslanza nolo, ma...). In ogni modo iI lrasfe-
rimenlo di una nolazione affelliva da un eIemenlo ad un aIlro assai iu vicino
neII'ambilo di un medesimo quadro sarebbe soIlanlo segno di Iibera eIaborazione deI
'modeIIo'.
Scncca iragicc nc||a Commedia !i Oanic 377
lenuis reIiclae Iucis a lergo nilor
fuIgorque dubius soIis adfIicli cadil
el Iudil aciem: nocle sic mixla soIel
raebere Iumen rimus aul serus dies.
Quiv'era men che nolle e men che
|giorno
s che 'I viso m'andava innanzi
|oco,
Prinus !ics e aunlo men che giorno, scrus e men che nolle,
in Seneca sono inoIlre cilali i due eslremi, nccic (er nccic sic nixia
sc|ci A Iegge: ia|c ncn !u|ic sc|ci) e !ics cos I'acics, I'aculezza deIIa visla
(I viso), e ingannala e imedila (mandava innanzi oco): Danle
qui inlerrela Seneca. La riserva suIIa Iiceila di un confronlo che
rugnoIi manifesla er queslo unlo viene a cadere.
I raffronli da queslo sludioso roosli con Verg. Acn. IV, 268-72
e 452-54 vaIgono invece bene, mi are, er |nj. XV, 17-20 (Iarodi).
In concIusione in Hcrc. jur., vv. 670-72 abbiamo Ia cifra visiva
deIIInferno
37
.
Seguono i vv. 686 sgg.
38
:
IaIus inerlis foeda Cocyli iacel,
hic vuIlur, iIIic Iuclifer bubo gemil
omenque lrisle resonal infauslae slrigis.
horrenl oaca fronde nigranles comae,
laxum imminenlem qua lenel segnis Soor
37 Anche Ocnsis ... si|tis (v. 663) olrebbe far ensare aIIa seIva seIvaggia e asra e
forle che in Danle recede I'Inferno e erfino aIIa divina foresla sessa e viva di
Purg. XXVIII, 2. Si lralla lullavia di eIemenli di conlallo generici. AIIa fine deI c. II Dan-
le, doo aver ascoIlalo iI discorso di VirgiIio che gIi ha arIalo di ealrice, acconsenle
ad accomagnarIo (|.j e oi che mosso fue / inlrai er Io cammino aIlo e siIveslro) e
giunge davanli aIIa orla deII'Inferno (vv. 1-9) come qui vv. 664 sgg.: nic cra sc|tii Oiiis
intisi !cnus / niaiquc rupcs a|ia ci inncnsc spccu / ingcns tcragc jauci|us tasiis paici |.j
Anche in VirgiIio una seIva recede I'Inferno: cfr. vv. 118, 138-39, 156, 179, 186, da quan-
lo si e vislo, lullavia, con Seneca Danle sembra avere raorli iu recisi.
38 Nei vv. 673 sgg., ninc anp|a tacuis spaiia |axaniur |ccis / in quac cnnc tcrsun prcpc-
rai (Leo. ncrsun pcrcai A. tcrsun pcrcai I) nunanun gcnus. / ncc irc |a|cr csi, ipsa !c!ucii
tia. / ui sacpc puppcs acsius intiias rapii, / sic prcnus acr urguci aiquc ati!un cnacs, / gra-
!unquc rcirc j|ccicrc naui unquan sinuni / un|rac icnaccs |...j abbiamo vaghissime ossi-
biIila di confronlo fra Seneca e Danle. Cos iI v. 673, ninc anp|a tacuis spaiia |axaniur |ccis
olrebbe far venire in menle |nj. V, 19-20 guarda com'enlri e di cui lu li fide, / non
l'inganni I'amiezza de I'inlrare: 'amiezza' richiama anp|a. Iarodi, . 243, cila i vv.
675-77 ad indicare Ia necessila che coslringe Ie anime a rocedere innanzi, menlre in
VirgiIio non si accenna che aI Ioro inlenso desiderio (VI, vv. 313-14: sia|ani cranics prini
iransniiicrc cursun, / Tcn!c|aniquc nanus ripac u|icricris ancrc, cfr. 330). L'eIemenlo
inlravislo da Iarodi sembra effellivamenle un o' vago (queslo confronlo non e discus-
so daI rugnoIi).
Sergio Sconocchia 378
Iamesque maesla labido riclu iacel
Iudorque serus conscios vuIlus legil
39
.
I vv. 686-88 cosliluiscono iI resuoslo deIIa figurazione danlesca
deIIe Arie (|nj. XIII, 10 sgg.):
aIus inerlis foeda, Cocyli iacel,
hic vuIlur iIIic Iuclifer bubo gemil
omenque lrisle resonal infauslae
|slrigis.
Quivi Ie brulle Arie Ior nidi fanno,
che cacciar de Ie Slrofade i Troiani
con lrislo annunzio di fuluro danno.
Iarodi, . 243, dice a roosilo di quesli versi:
Si uo sosellare, ma non e Iecilo andare iu in Ia di un sosel-
lo, che abbiano conlribuilo a far coIIocare Ie Arie neIIa seIva
medesima: fanno Iamenlo in su Ii aIberi slrani. Ma io credo
che si ossa essere sicuri che neIIa sua figurazione deIIe Arie
Danle ricordi quesli versi: iI oela da |uciijcr ha cavalo fuori
di fuluro danno e da cncnquc irisic ha lrallo con lrislo an-
nunzio, cioe da lre ucceIIi (tu|iur, |u|c e sirix) Danle ha cavalo
Ia sua figurazione Iaslica deIIe Arie, un ucceIIo reolenle e
seIvaggio che ha aIcuni eIemenli umani. Cio e confermalo daI
fallo che in Danle Ie Arie comaiano neIIa seIva dei suicidi,
che si va conformando neI v. 689 di Seneca:
horrenl oaca fronde nigranles comae
40
ed e oi descrilla, come hanno ben vislo Irolo e Iarodi, in Hcrc. jur.,
vv. 698 sgg. ai quaIi si rifa con evidenza Danle in |nj. XIII, 4-6:
Non rala viridi Iaela facie germinanl
nec aduIla Ieni fIuclual Zehyro
|seges,
non uIIa ramos siIva omiferos habel,
Non fronda verde, ma di coIor fosco,
non rami schielli, ma nodosi e
|'nvoIli,
non omi veran, ma slecchi con
|losco
41
.
39 AI v. 690 i codici hanno iaxc innincnic quan: Ia correzione e deI Leo. Anche aI v.
691 Leo corregge (in iacci) iaccns dei codici.
40 L'immagine di Seneca da ben ragione, mi sembra, aII'eilelo di Danle aIberi
slrani.
41 Aggiungerei che forse dai vv. 701-02, sicri|is prcjun!i tasiiias squa|ci sc|i / ci jcc!a
Scncca iragicc nc||a Commedia !i Oanic 379
Infine, come hanno osservalo Irolo e Iarodi, i vv. 705-06 equivaI-
gono aI danlesco lanle amara che oco e iu morle (|nj. I, 7) e si
riferiscono aIIa seIva oscura. Amaro fa subilo ensare a nacrcr.
Icco i due assi:
|.j cuncla maerore horrida
isaque morle eior esl morlis Iocus
lanle amara che oco e iu morle
II araIIeIo rooslo da rugnoIi, con |cc|cs. VII, 27 |ntcni anaric-
rcn ncric nu|icrcn, e senza dubbio moIlo meno erlinenle: in Seneca e
Danle ce in comune iI concello di Iuogo eggiore deIIa morle.
Semmai si uo ensare che Danle, arlendo da Seneca, abbia
conlaminalo con Iesressione bibIica che aveva neIIorecchio.
Con Hcrc. jur., vv. 711 sgg. siamo neI iu rofondo deIIAverno:
a fonle discors manal hinc uno Ialex,
aIler quielo simiIis (hunc iuranl dei)
lacenle sacram devehens fIuvio Slyga,
al hic lumuIlu railur ingenli ferox
el saxa fIuclu voIvil Acheron invius
renavigari |.j.
Secondo Iarodi non ce dubbio che i versi siano da mellere in
reIazione con queIIi di Purg. XXVIII, 124 sgg.:
ma esce di fonlana saIda e cerla,
che lanlo daI voIer di Dio rirende,
quanleIIa versa da due arli aerla.
Da quesla arle con virlu discende
che logIie aIlrui memoria deI eccalo,
da IaIlra dogni ben fallo Ia rende.
ic||us icrpci acicrnc siiu, uo essere venulo a Danle uno sunlo er Ia seconda arle dei
lre versi (.ma di coIor fosco, .ma nodosi e 'nvoIli, .ma slecchi con losco).
Cerlo in Danle abbiamo una slrullura carallerislica e ben diversa da Seneca, non si uo
escIudere ero che i vv. 701-02 abbiano suggerilo a Danle I'idea deIIa sleriIila e deIIo
squaIIore. Si uo riIevare che rugnoIi (. 150) omelle di arIare dei vv. 686-88 e dei vv.
698 sgg.: e iI secondo araIIeIo e ben messo in risaIlo daI Iarodi. Anche Iaralore, che neI
suo eIenco segue rugnoIi, lrascura di cilare quesli raffronli. I in seguilo i due sludiosi
ne omelleranno aIlri, ure beIIi. Si uo osservare, reIalivamenle a quesli araIIeIi ora
visli, come er aIlri che seguiranno, che abbiamo rorio quei confronli formaIi di cui
rugnoIi solloIineava Ia mancanza.
Sergio Sconocchia 380
Quinci Lele, cos da IaIlro Ialo
Inoe si chiama |.j.
Loinione conlraria di rugnoIi, secondo cui non sussislendo iI
confronlo formaIe Ia coincidenza deIIunus jcns suI iano menlaIe de-
ve considerarsi effimera, non sembra cogenle. Abbiamo gia vislo una
serie di eIemenli sicuramenle riresi da Seneca, (cifra Iuminosa, Ar-
ie, seIva dei suicidi). Ogni eIemenlo decisamenle simiIe deve far
ensare aIIa ossibiIila di confronli fra Danle e Seneca.
DeI reslo qui (a arle i nomi che, come e nolo, sono semre uri,
urissimi accidenli) in quaIche modo sussisle anche iI confronlo for-
maIe: di fonlana. corrisonde ad a jcnic unc, esce a nanai,
quanleIIa versa da due arli aerla a !isccrs |aicx (si noli che |aicx, iI
fIusso deIIa fonlana, che non e con recisione Iacqua, e reso da
Danle con quanleIIa versa, menlre !isccrs e reso, con simiIe erifra-
si, anche se con Ieggero lrasferimenlo di concello, in da due arli
aerla), da quesla arle con virlu discende. ha er soggello iI
Lele, come in Seneca ce a|icr, infine da IaIlra di ogni ben fallo Ia
rende ricorda Iai nic di Seneca
42
.
Inleressanli anche i vv. 735 sgg.
43
, in cui, come riIeva Iarodi (.
244), si osserva rigidamenle iI conlraasso e che sembrano ricordare
Ie grandi coie lragiche deI Cocilo danlesco.
L'osservazione in roosilo di rugnoIi, (. 150) iI che obbIighe-
rebbe, mi are, a iolizzare in Danle una conoscenza di Seneca lragico
ari addirillura a queIIa di VirgiIio, rischia di essere una elilio
rinciii.
I iI caso di soffermarci ora anche su un asso susseguenle di Hcrc.
jur., recisamenle i vv. 783 sgg., con cui inizia I'eisodio di Cerbero:
42 Ier i vv. 716 sgg. |.j cingiiur !up|ici ta!c / a!tcrsa Oiiis rcgia, aiquc ingcns !cnus /
un|ranic |ucc icgiiur. nic tasic spccu / pcn!cni iqranni |inina, ncc un|ris iicr, / nacc pcria
rcgni. canpus nanc circa iacci, / in quc supcr|c !igcrii tu|ius sc!cns / aninas rcccnics !ira
naicsias !ci. / jrcns icrta, jrairun quac iancn spccicn gcrai / gcniisquc ianiac, tu|ius csi i||i
|ctis, / sc! ju|ninaniis. nagna pars rcgni irucis / csi ipsc !cninus, cuius aspccius iinci / quic-
qui! iinciur |.j Iarodi dice (. 244): In queII'imo recesso abila, lra i due fiumi, iI re
deII'Averno, Dile, cuius aspccius iinci / Quicqui! limelur, Iarodi conlinua arIando di
cio che in Seneca refigura iI 'conlraasso' danlesco. Ier Ia definizione di Dile si uo
forse ensare a un accoslamenlo a |nj. V, v. 4 Slavvi Minos orribiImenle, e ringhia.
OrribiImenle ha Ia radice di ncrrcc. L'aIone di 'lerrore' di cui e circonfuso Minosse
richiamerebbe aunlo queIIo di cui e circondalo Dile, cuius aspccius (aspcciun A) iinci
/ quicqui! iinciur |.j.
43 Quc! quisquc jccii, paiiiur, aucicrcn scc|us / rcpciii sucquc prcniiur cxcnp|c ncccns. /
ti!i crucnics carccrc inc|u!i !uccs / ci inpcicniis icrga p|c|cia nanu / scin!i iqranni |.j.
Scncca iragicc nc||a Commedia !i Oanic 381
hic saevus umbras lerrilal Slygius canis,
qui lerna vaslo caila conculiens sono
regnum luelur. sordidum labo caul
Iambunl coIubrae, vieris horrenl iubae
Iongusque lorla sibiIal cauda draco.
ar ira formae |.j
44
.
Iarodi osserva che iI scr!i!un ia|c capui (v. 785) richiama Ia barba
unla ed alra (e airun cancn si Iegge di Cerbero aI v. 59), secondo
rugnoIi, in Danle Ia barba e Iunlo devono servire a designare iI
grollesco dun arassila(DeI Lungo).
Gia iI Irolo
45
desumeva in Danle Ia sicura conoscenza deIIeiso-
dio di Cerbero cos come esso si sviIua neI |urcns (vv. 790 sgg.) dai
arlicoIari deIIa cilazione danlesca, |nj. IX, 94 sgg.:
Ierche recaIcilrale a queIIa vogIia
a cui non uole iI fin mai esser mozzo,
e che iu voIle vha cresciula dogIia`
Che giova ne Ia fala dar di cozzo`
Cerbero voslro, se ben vi ricorda,
ne orla ancor eIalo iI menlo e I gozzo.
II v. 97 che giova ne Ia fala dar di cozzo` come avverle iI occac-
cio, e araIIeIo a Seneca Oc!ipus, vv. 980 sgg. (jaiis aginur: cc!iic jaiis),
iI confronlo sembra sicuro, Iarodi, Ic iragc!ic !i Scncca (. 249), riIeva
che, in genere, Ie cilazioni di Seneca deI occaccio, come queIIe di Iie-
lro di Danle, non sono roosle come fonli ma come araIIeIi. Ma non
si uo escIudere che qui occaccio si riferisca a evenluaIi conoscenze
recise di Seneca da arle di Danle. I lesli deIIe lragedie, come si ve-
dra injra, erano diffusi, aImeno in Iuroa. Anche Iasquini
46
cila que-
slo risconlro lra aIcuni araIIeIi, ur non rilenendoIo cogenle.
II conlenulo miloIogico dei vv. 98-99 ben corrisonde, secondo
Irolo, aI ricordo deIIe Iurie (v. 54) maI non vengiammo in Teso
IassaIlo.
Ma rocediamo con ordine.
VirgiIio coIIoca Cerbero, ianiicr Orci, in un anlro sanguinoIenlo, in
44 AI v. 784 I ha irina, aI v. 788 pcr ira.
45 Alene e Roma, XI, 1908, . 43-44. Queslo confronlo e richiamalo anche da IA-
SQUINI, Prcscnzc !i Scncca in Oanic, cil., . 134.
46 IASQUINI, Prcscnzc !i Scncca in Oanic, cil., . 134.
Sergio Sconocchia 382
mezzo a ossa sarse (Acn. VIII, 296-297), crealura moslruosa, immane
(innanis, Acn. IV, 417 e 423, innania icrga, IV, 422), con iI lriIice coIIo
irlo di serenli, inlenlo a Ialrare conlro quaIsiasi inlruso (Acn. VI, 417-
425).
Ovidio solloIinea, di Cerbero, Ia bava veIenosa (Mci. IV, 501, VII,
416-424) e richiama iI Ialralo deI moslro (Mci. IV, 501). Anche Seneca
richiama i Ialrali di Cerbero (Hcrc. jurcns, 783-784)
47
.
Quando IrcoIe discende neII'Averno er Iiberare Teseo, Cerbero,
con i lre coIIi Iegali da lriIice calena, viene lrallo fuori a forza daIIa
sede infernaIe: I'eisodio e aena accennalo, ma senza riIievo, in
Verg. Acn. VIII, 296-297, e rireso, con arlicoIari iu ami in Ovidio,
Mci. VII, 408-415:
IIIud Ichidneae memoranl e denlibus orlum
Isse canis, secus esl lenebroso caecus hialu,
Isl via decIivis, er quam Tirynlhius heros
Reslanlem conlraque diem radiosque micanles
ObIiquanlem ocuIos nexis adamanle calenis
Cerberon adlraxil, rabida qui concilus ira
ImIevil ariler lernis Ialralibus auras
Il sarsil virides sumis aIbenlibus agros.
e richiamalo fugacemenle in IX, 185:
Iorma lriIex, nec forma lriIex lua, Cerbere, movil`
Come si uo vedere iI riIievo iu amio aII'eisodio e dalo, da Se-
neca, Hcrc. jurcns, nei vv. 783 sgg. cilali sora.
I arlicoIari aIIusivi deI leslo danlesco non lrovano fondamenlo neI
leslo di VirgiIio
48
ne in Servio. AI vanlo deIIe Iurie iI ncssc risonde
47 Ier queslo arlicoIare si veda anche GIORGIO IADOAN, s.v. Ccr|crc, in |ncic|cpc!ia
!anicsca, I, 1970, . 912-913, er queslo arlicoIare . 912, coI. b. Lo sludioso richiama
iu voIle Seneca e assi di Seneca, Hcrc. jurcns, accogIiendo dunque Ia resenza di Se-
neca lragico neIIa Ccnnc!ia. Seneca e richiamalo da Iadoan accanlo a VirgiIio, Ovidio,
Lucano (. 912, coI. b).
48 Cfr. Acn. VI, vv. 417-23: Ccr|crus nacc ingcns |airaiu rcgna irijauci / pcrscnai a!tcrsc
rccu|ans innanis in anirc. / cui taics ncrrcrc ti!cns ian cc||a cc|u|ris / nc||c scpcraian ci
nc!icaiis jrugi|us cjjan / c|icii. i||c janc ra|i!a iria guiiura pan!cns / ccrripii c|iccian, aiquc
innania icrga rcsc|tii / jusus nuni icicquc ingcns cxicn!iiur anirc. Un o' vago e inadallo a
isirare Danle mi sembra anche I'accenno conlenulo nei vv. 392-96: ncc tcrc A|ci!cn nc
sun |aciaius cunicn |...j. Tariarcun i||a nanu cusic!cn in tinc|a pciitii / ipsius a sc|ic rcgis
iraxiiquc ircncnicn. In Danle si insisle seciaImenle suI modo in cui Cerbero fu unilo
Scncca iragicc nc||a Commedia !i Oanic 383
ricordando Ia villoria di IrcoIe
49
.
Lesressione deI v. 99 e iI richiamo aIIusivo dei v. 98 se ben vi ri-
corda sembrano rorio riferirsi con recisione, a diversi eIemenli
deIIa lragedia di Seneca.
Cos in Hcrc. jur., vv. 807 sgg., doo che Cerbero ha Iollalo dura-
menle ed e slalo sconfillo, si dice:
Tum gravia monslri coIIa ermuIcens manu
adamanle lexlo vincil, obIilus sui
cuslos oaci |.j
ai vv. 813 sgg. segue:
oslquam esl ad oras Taenari venlum el nilor
ercussil ocuIos Iucis ignolae novus,
resumil animos viclus el vaslas furens
quassal calenas |.j
50
.
Le esressioni cc||a pcrnu|ccns nanu |.j a!ananic icxic tincii |.j,
rcsunii anincs ticius ci tasias jurcns / quassai caicnas rendono ragione
dei versi di Danle ben iu dei fugaci accenni deI leslo virgiIiano e,
sembra rorio, iu anche dei assi di Ovidio Mci. VII, 411 sgg.
Cerbero, calluralo da IrcoIe, dovelle seguirIo incalenalo er Ie cilla
deIIArgoIide
51
.
er essersi voIulo oorre a IrcoIe. Ora queslo e aunlo in Seneca ma manca in Virgi-
Iio. I sorallullo manca in VirgiIio I'oosizione che Cerbero fa ad IrcoIe, eIemenlo cui
e dalo nolevoIe risaIlo in Seneca e che soIo uo giuslificare i vv. 97-9: Che giova ne Ie
fala dar di cozzo`|...j iI menlo e 'I gozzo. Non in VirgiIio dunque, ma in Seneca e da
cercare iI modeIIo dei vv. 94 sgg.
49 Irolo richiama anche i vv. 1 sgg. deII'Hcrcu|cs Ociacus (I'accenno a Cerbero e ai
vv. 23-24). Secondo iI crilico Ia villoria di IrcoIe caIzava a roosilo erche ai milografi
medioevaIi oleva ricordare Ia discesa di Gesu Crislo aII'Inferno, a Iiberare Adamo e gIi
aIlri e a Iegare Salana: VangeIo di Nicodemo A. VI, 2, . VIII-IX. Nei vv. 98-99 c'e una
aIIusione duIice: iu scoerla queIIa riguardanle Ia sorle di Cerbero (conlenulo
deII'Hcrcu|cs jurcns), iu coerla e Ielleraria Ia risosla aI v. 54 (maI non vengiammo in
Teso I'assaIlo).
50 AI v. 814 nctus, e congellura deI uecheIer er |cncs di A e |cnc di I. AI v. 815 A
ha tincius.
51 Cfr. Hcrc. jur., vv. 57 sgg.: ai i||c rupic carccrc un|rarun jcrcx, / !c nc iriunpnai ci
supcr|ijica nanu / airun pcr ur|cs !ucii Argc|icas cancn. / tisc |a|anicn Ccr|crc ti!i !icn /
pati!unquc sc|cn. nc qucquc intasii ircncr, / ci icrna ncnsiri cc||a !cticii iniucns / iinui
inpcrassc |.j. Cfr. anche iI v. 603: pcricnia jugicns. ncc ncjas ccrnani !uc e i vv. 646 sgg.:
|.j O nagni ccncs / nagnaninc naii, pan!c tiriuiun cr!incn, / quan |cnga nacsics !ucai a!
nancs tia, / ui tinc|a iu|crii !ura Tariarcus canis.
Sergio Sconocchia 384
Doo i assi di Ovidio e di Seneca, che Danle olrebbe anche aver
conlaminalo, e naluraIe che Cerbero ne orlasse ancor eIalo iI men-
lo e 'I gozzo. Danle si riorla chiaramenle, con aIIusione recisa, Se
ben vi ricorda, ad un momenlo cenlraIe deIIazione deI |urcns. SuI
vaIore deIIe aIIusioni nei oeli si veda G. . Conle, Mcncric !ci pccii c
sisicna |ciicraric, cil., sorallullo ca. 1 e 2 ( 1-3)
52
.
In |nj. IX, 97-9 Danle ha cos giuslaoslo due ricordi deIIe lrage-
die di Seneca, Oc!ipus, vv. 980 sgg. |aiis aginur. cc!iic jaiis ed Hcrcu|cs
jurcns, vv. 770 sgg. e forse anche conlaminalo Ie raffigurazioni di
Ovidio Mci. e di Seneca Hcrc. jurcns.
Lesressione ne orla ancor eIalo iI menlo e I gozzo ha
lullaIlro che iI vaIore generico di e slalo vinlo. Cerlo Danle (cfr. |nj.
VI, 13-18 e 22-23)
53
ha un o lrasformalo Cerbero risello a Seneca (e
Ovidio e VirgiIio) er cui era soIo Io Siqgius canis (Hcrc. jur., v. 783).
Ma iI demone ha conservalo ur neIIanlroomorfismo che Danle,
come a lulle Ie crealure demoniache, ha voIulo allribuirgIi, moIli lralli
52 A confermare iI vaIore unluaIizzanle deII'esressione danlesca anche in Purg.
VI, 148 rilroviamo un'esressione I se ben li ricordi con vaIore, are, concrelo e re-
ciso. Con i vv. 126 sgg. inizia I'invelliva di Danle conlro Iirenze. Ai vv. 145 sgg. si Iegge:
Quanle voIle, deI lemo che rimembre, / Iegge, monela, officio e coslume / hai lu mu-
lalo, e rinovale membre / I se ben li ricordi e vedi Iume, / vedrai le somigIianle a queIIa
inferma / che non uo lrovar osa in su Ie iume / ma con dar voIla suo doIore scher-
ma. Mi sembra che I se ben li ricordi si riferisca a falli slorici deIIa cilla ben resenli
aunlo aIIa coscienza di Iirenze conlro cui iI oela sla scagIiando Ia sua invelliva. A
comrovare iI vaIore unluaIizzanle e concrelo di ogni esressione aIIusiva danlesca,
anche fugace, vaIga iI seguenle giudizio deI Tommaseo (Commenlo aI Purgaicric, MiIa-
no, Iagnoni 1869, . 196) cilalo da SCIVOLA MARIOTTI, || Crisiiancsinc !i Siazic in Oanic
scccn!c i| Pc|izianc, in Siu!i in cncrc !i Naia|inc Sapcgnc, voI. II, Iciicraiura c Criiica, Ro-
ma, uIzoni 1975, . 154: Tulle Ie invenzioni e gIi accenni di Danle, anco i iu slrani,
hanno fondamenlo in una quaIche aulorila che o sia Ia lradizione o ne orli sembian-
za. Mariolli aggiunge in nola (14 ): cfr. anche Iarodi uIIellino Soc. Danl. n.s. 9,
1901-02, 313 (neIIa chiusa deIIa recensione a scrilli di ScheriIIo e AIbini cilali qui sollo).
53 Cerbero, fiera crudeIe e diversa, / con lre goIe caninamenle Ialra / sovra Ia genle
che quivi e sommersa. / Li occhi ha vermigIi, Ia barba unla e alra, / e 'I venlre Iargo, e
unghiale Ie mani, / graffia Ii sirli, ed iscoia ed isqualra |...j. Quando ci scorse Cerbero,
iI gran vermo, / Ie bocche aerse e moslrocci Ie sanne, / non avea membro che lenesse
fermo. / I 'I duca mio dislese Ie sue sanne, / rese Ia lerra, e con iene Ie ugna / Ia
gillo denlro a Ie bramose canne. / QuaI e queI cane ch'abbaiando agogna / e si racquela
oi che 'I aslo morde, / che soIo a divorarIo inlende e ugna, / colai si fecer queIIe facce
Iorde / de Io dimonio Cerbero, che 'nlrona / I'anime s, ch'esser vorrebber sorde. I
invece azzardalo forse ensare che neI geslo di VirgiIio (|nj. VI, 23 sgg.) |.j dislese Ie
sue sanne, / rese Ia lerra, e con iene Ie ugna / Ia gillo denlro Ie bramose canne, vi
sia un voIer ricordare a Cerbero Ia lerra in cui, vinlo (neI |urcns), iI moslro immerse iI
muso: non iu I'offa di VirgiIio, ma rorio Ia lerra, a ricordargIi, come minaccia, una
brucianle sconfilla.
Scncca iragicc nc||a Commedia !i Oanic 385
deIIo Siqgius canis, anche se iI oela gIi ha associalo, er cos dire, Ia
nuova immagine deI suo demonio (che e ancora, ero lriciile, e ha Ie
lre lesle canine).
en si comrende come Danle, richiamando Ie vicende deI Cerbero
di Ovidio e, sorallullo, queIIe di Seneca, e avendo resenle Ia nuova
figura umanizzala, imieghi Iesressione iI menlo e I gozzo
54
. In
VirgiIio Inea scende neIIAverno er voIere deI falo, in modo simiIe
anche IHcrcu|cs jurcns di Seneca scende neIIAverno er reaIizzare Ia
voIonla deI deslino: Ia callura di Cerbero e IuIlima deIIe dodici fali-
che e, come laIe, villoriosa er voIere deI falo.
Anche un aIlro fallo uo cosliluire conferma che i vv. 98-99 di
Danle hanno quaIche raorlo con Seneca. NeI canlo X, come abbia-
mo vislo, lroviamo iI confronlo forse iu beIIo lra Danle e Seneca,
queIIo fra Hcrcu|cs Ociacus e Iarinala, arziaImenle rooslo daI Ia-
rodi e oi, insiegabiImenle, ignoralo daIIa crilica.
II raffronlo reciso deI canlo X (vv. 32 sgg.), a oca dislanza dai vv.
94 deI IX, olrebbe confermare che anche qui IaIIusione di Danle e
recisa, a maggiore ragione erche i canli IX e X furono comosli
inlorno aIIo slesso Iasso di lemo.
Iarodi ha aggiunlo successivamenle un aIlro risconlro con iI
|urcns davvero accellabiIe
55
.
Si raffronla |nj. XXXII, 8 (discriver fondo a lullo Iuniverso) con
Hcrcu|cs jurcns, 831: iusscrai nun!i pcncirarc jun!un.
Anche queslo confronlo non e menzionalo da rugnoIi
56
.
Infine i vv. 555 sgg. sono messi a confronlo con Purg. VII, 32:
el cum Mors avidis, aIIida denlibus
genles innumeras manibus inluIil,
uno lol ouIi remige lranseunl.
dai denli morsi de Ia morle avanle
Anche queslo confronlo sembra fondalo.
54 Anche in Arioslo, Or|an!c |uricsc XIII, 28, IsabeIIa di GaIizia, narrando ad Or-
Iando Ia difesa daI lenlalivo di vioIenza da arle di Odorico dice: el adoera'vi sin
I'ugne e iI morso: / eIa'gIi iI menlo, anche qui con vaIore IelleraIe.
55 In Iingua e Iciicraiura a cura di G. IoIena, Venezia, Neri Iozza 1957, voI. II,
. 358.
56 Iarodi cila anche iI v. 200: janu|ac Oiiis che anlicia Ia quaIificazione danlesca di
meschine de Ia regina deII'elerno ianlo |nj. IX, 43-4 (che e ero Ia Ocninan Oiiis, di
Acn. VI, 397). Che oi anche in Slazio, Tnc|. I, 85 sia dello di Iroserina Tariarci rcgina
|arainri non inficia Ia resuosizione di raorlo lra Danle e Seneca: Danle uo aver
'conlaminalo' Seneca e Slazio.
Sergio Sconocchia 386
rugnoIi, . 149, dice: MegIio Osea XIII, 14: ncrsus iuus crc |njcr-
nc. In Seneca e Danle abbiamo, secondo me in modo iu cogenle, in
comune morle e denli: che oi iI concello olesse essere anche
neIIe Scrillure e un aIlro discorso.
Come si e vislo, IHcrcu|cs jurcns cosliluisce un vaIido resuoslo
deIIe imilazioni danlesche: e Ia lragedia a cui iI oela allinge in
maggior misura.
In verila, er Ia discesa aIIinferno che vi si alluava (vv. 650-829),
oleva fornire sunli iu numerosi deIIe aIlre lragedie
57
.
La Pnac!ra e forse da lener resenle er iI canlo XVII deI Para!isc
con Ia rofezia di Cacciaguida.
NeIIimoslazione deI discorso danlesco si rilrovano lre momenli
fondamenlaIi deIIa lragedia. Leggiamo ad esemio i vv. 46-48:
QuaI si arlio IoIilo dAlene
er Ia sielala e erfida noverca,
laI di Iiorenza arlir li convene.
Nctcrca e iI lermine con cui Iedra e designala er lulla Ia lragedia.
In arlicoIare un concello affine a erfida noverca olrebbe essere
rilrovalo nei vv. 1191-94:
57 Secondo Iarodi, riguardo aIIe Trca!i, er cui iI Irolo non roone aIcun confron-
lo, e invece robanle iI araIIeIo fra Ia danlesca Icuba lrisla, misera e calliva di |nj.
XXX, 16 e i vv. 968 sgg. deIIe Trca!i, accoIlo con iI araIIeIo fra v. 20, forsennala Ialro s
come cane e Seneca, Agan. 707 ra|i!a |airatii da RONCONI, Pcr Oanic inicrprcic !ci pccii
|aiini, SD, XLI, 1964, . 13-4, araIIeIi resinli lullavia giuslamenle da rugnoIi che
richiama Ovidio (Mcian. XIII, 404-575), come vedremo, iu di recenle, anche Iasquini,
Prcscnzc !i Scncca in Oanic., cil., . 134-135, richiama, er |nj. XXX, 20, iI modeIIo
ovidiano di Mcian. XIII, 569 |airatii, ccnaia |cqui che si aIIarga a comrendere un con-
lenulo lanlo iu amio, con nessi arlicoIari e inequivocabiIi |.j (Iasquini cila oi
Mcian. 13, 404 e |nj. XXX, 13-15). Secondo Iarodi anche |nj. XXX, 13-5: I quando Ia
forluna voIse in basso / I'aIlezza de' Troian che lullo ardiva, / s che 'nsieme coI regno iI
re fu casso, ossono ricordare i vv. 6-7 di Seneca, Trca!cs: cc|uncn ctcrsun ccci!ii / pc|-
|cniis Asiac ... e forse con iI v. 15, i vv. 28 sgg.: Tcsicr !ccrun nuncn a!tcrsun nini, / pa-
iriacquc cincrcs icquc rccicrcn Pnrqgun |.j, L'AIighieri, VII, 1966, 1, . 98-9, rugnoIi
conlesla lulli quesli raorli e ne riafferma I'origine ovidiana (Mcian. XIII, 404-575).
rugnoIi ha ragione. Tullavia mi sorge un dubbio: rugnoIi slesso riconosce (. 98) che
Ovidio e deI reslo sfrullalo cerlamenle da Seneca. I iI v. 16 di Danle e effellivamenle
moIlo vicino a Seneca Trca!cs, vv. 988-89 nunc ticia, nunc capiita, nunc cunciis nini /
c|scssa ti!ccr c|a!i|us |.j (in Ovidio, ai vv. 510-11, non richiamali daI rugnoIi, Icuba
dice: Nunc irancr cxu|, incps.). Che Danle abbia conlaminalo Ovidio con Seneca`
Scncca iragicc nc||a Commedia !i Oanic 387
Audile, Alhenae, luque, funesla aler
eior noverca: faIsa memoravi el nefas,
quod isa demens eclore insano hauseram,
menlila finxi |.j
Ier iI secondo momenlo, vv. 52-53:
La coIa seguira Ia arle offensa
in grido, come suoI, |.j
si uo ensare ai vv. 719 sgg. di Seneca in cui IoIilo e aunlo
offeso e ingiuslamenle caIunnialo daIIa nulrice:
NUTR. Derensa cuIa esl. anime, quid segnis
|slues`
regeramus isi crimen alque uIlro imiam
Venerem arguamus: sceIere veIandum esl sceIus,
lulissimum esl inferre, cum limeas, gradum.
ausae riores simus an assae nefas,
secrela cum sil cuIa, quis leslis sciel`
Adesle, Alhenae fida famuIorum manus,
fer oem nefandi ralor HioIylus sluri
inslal remilque, morlis inlenlal melum,
ferro udicam lerrel |.j
Infine nei vv. 55 sgg. di Danle si redice, con aoslrofe, Ia serie di
disagi a cui IesuIe andra inconlro:
Tu Iascerai ogne cosa diIella
iu caramenle, e queslo e queIIo slraIe
che Iarco de Io essiIio ria saella.
Tu roverai s come sa di saIe
Io ane aIlrui, e come e duro caIIe
Io scendere e I saIir er IaIlrui scaIe.
|.j
in modo slrulluraImenle simiIe a queIIo con cui iI coro, vv. 792 sgg.,
aoslrofa IoIilo (e si consideri che gia nei vv. 777 sgg. iI coro ao-
slrofa con iu anaforici Ia beIIezza):
|.j lu fueras Iabor
el lu causa morae, le dea noclium
Sergio Sconocchia 388
dum seclal ceIeres suslinuil vias.
vexenl hanc faciem frigora arcius, 795
haec soIem facies rarius aelal:
Iucebil Iario marmore cIarius.
quam grala esl facies lorva viriIiler
el ondus veleris lrisle suerciIi
Ihoebo coIIa Iicel sIendida comares: 800
iIIum caesaries nescia coIIigi
erfundens umeros ornal el inlegil,
le fronle hirla decel, le brevior coma
nuIIa Iege iacens, lu Iicel aseros
ugnacesque deos viribus audeas
|.j
Quesli raorli deI leslo danlesco con Ia Pnac!ra ossono lrovare
conferma in un araIIeIo discusso daI rugnoIi che lullavia Io giudica
scarsamenle formaIe. I iI confronlo n. 31:
Pnac!ra, v. 748
Nec lenenl sleIIae faciem minores
(di fronle aIIa Iuna)
Purg. XVIII, v. 77
facea Ie sleIIe a noi arer iu rade,
(dello deIIa Iuna)
Queslo araIIeIo e gia rooslo da Irolo e da Iarodi (. 246 n. 2) i
quaIi lullavia, accanlo ad esso, roongono un raorlo con Mc!ca,
vv. 96 sgg.:
el densi Ialilanl IIeiadum greges
cum Ihoebe soIidum Iumine non suo
58
|.j
a cui iI Iarodi referisce allribuire Ia alernila deIIa succilala esres-
sione danlesca
59
.
Se si liene resenle iI asso deIIa Pnac!ra in lullo iI suo conleslo
(vv. 743-47), mi are che si ossa arIare anche qui di un confronlo
formaIe:
58 AI v. 97 A Iegge sc|iiun er sc|i!un.
59 SuI araIIeIo lra Mc!ca, v. 627 rcsiiiii icrrcns, si|ucrc tcnii (aroIe deI Coro, suI
canlo di Orfeo), ma sorallullo 765-766 Scnucrc j|ucius, iunuii insanun narc / iaccnic
tcnic (in bocca a Medea) e |nj. V, 96 menlre che 'I venlo, come fa, ci lace IASQUINI,
Prcscnzc !i Scncca in Oanic, cil., . 135, e iulloslo dubbioso.
Scncca iragicc nc||a Commedia !i Oanic 389
uIchrior lanlo lua forma Iucel,
cIarior quanlo mical orbe Ieno
cum suos ignes coeunle cornu
iunxil el curru roeranle ernox
exeril vuIlus rubicunda Ihoebe
nec lenenl sleIIae faciem minores
|.j
La Iuna, quasi a mezza nolle larda,
facea Ie sleIIe a noi arer iu rade,
falla comun secchion che lullo arda.
Pncc|c e Ia Iuna, quasi a mezza nolle larda rende in quaIche mo-
do pcrncx, falla comun secchion che lullo arda richiama riselli-
vamenle nicai arda e cr|c p|cnc lullo, infine facea Ie sleIIe a noi
arer iu rade rende aunlo ncc icncni sic||ac jacicn nincrcs. II con-
fronlo formaIe manca invece er Mc!ca, vv. 96 sgg.
Se Danle conosceva Pnac!ra, 743-47 abbiamo un molivo in iu er
sosellare che daI conleslo iu amio lraesse sunli er iI suo eiso-
dio di Cacciaguida.
DeIIAgancnncn iI secondo emislichio deI v. 49 e accoslabiIe aI Par.
XI, 88:
|.j quid udor vuIlus graval` Ne Ii gravo viIla di cuor Ie cigIia
Lesressione Ie cigIia ha in Danle vaIore a un diresso uguaIe a
tu|ius, cioe esressione deI voIlo.
Iarodi avverle che i vv. 64 sgg. sono gia da Irolo accoslali a Par.
XVI, 83 sgg.:
non sic Libycis syrlibus aequor
furil aIlernos voIvere fIuclus,
non Iuxini lurgel ab imis
commola vadis
|.j
ul raeciiles regum casus
Iorluna rolal.
I come I voIger deI cieI de Ia Iuna
cuore e discuore i Iili sanza osa,
cos fa di Iiorenza Ia Iorluna:
Iarodi riIeva lullavia che Ie furie deI mare di Seneca sono nuIIa di
fronle aI danlesco cuore e discuore i Iili senza osa. Mi are che
queslo confronlo di Irolo sia sicuro. rugnoIi, . 157, non dice nuIIa a
riguardo e accogIie, . 158, iI raffronlo come buono.
DaI Tnqcsics gia Torraca aveva cilalo i vv. 152 sgg. er Ia ena di
TanlaIo. Si uo confronlare con Purg. XXIII, 67 sgg. e XXIV, 103 sgg.:
Sergio Sconocchia 390
Slal Iassus vacuo gullure TanlaIus:
imedel caili Iurima noxio
Ihineis avibus raeda fugacior,
hinc iIIinc gravidis frondibus incubal
el curvala suis felibus ac lremens
aIIudil aluIis arbor hialibus
Di bere e di mangiar naccende cura
Iodor chesce deI omo e de Io
|srazzo
che si dislende su er sua verdura
(XXIV, 103 sgg.)
arvemi i rami gravidi e vivaci
dun aIlro omo, e non moIlo Ionlani
er esser ur aIIora voIlo in Iaci.
Vidi genle sollesso aIzar Ie mani
e gridar non so che verso Ie fronde,
quasi bramosi fanloIini e vani
che regano, e I regalo non
|risonde
rami gravidi ben corrisondono a grati!is jrcn!i|us
60
.
Ier iI Tnqcsics, ce un aIlro raffronlo formaIe, riIevalo da Ronconi
61
,
aIIa seconda arle deI v. 248 si confronla Purg. VI, 116:
NuIIa le ielas movel` e se nuIIa di noi iela li move
Non riesco a condividere, er queslo confronlo, Ia erIessila di
Iasquini in Prcscnzc !i Scncca in Oanic, che, ur richiamando iI araIIe-
Io, . 134, non Io cila, lra i confronli iu robanli.
Un lerzo ossibiIe raffronlo e queIIo riIevalo da Conlini lra IUgo-
60 Dice rugnoIi in roosilo, . 152, che aI v. 155 i rcccniicrcs di Seneca (y) hanno
grati!is, ma che si lralla di Iellura umanislica, cerlamenle osleriore a Trevel (che Iegge,
con I, grati|us: rugnoIi er 'Iasus' dice grati!is): quesla Iellura sfugge aII'usus
deII'eilelo di Seneca (Trc. 36, 394, H. Oc. 492). Ma Ia Iezione grati!is dei rcccniicrcs di
Seneca olrebbe ur venire, credo, da quaIche codice Un confronlo deI Iarodi su cui e
difficiIe ronunciarsi e I'Hcrcu|cs Ociacus, vv. 1849 sgg.: !criguii (Gronovius: !cj|ctii
codd. A|ia naicr ui icic siciii / succisa jciu |isquc (j|ciu tixquc I) scpicncs grcgcn (Leo: grc-
gcs codd.) / !cp|anxii (Leo: !cc|ausii I) una. grcgi|us acquari ncus ... con Purg. XII, 37 sgg.:
O Nobe, con che occhi doIenli / vedea io le segnala in su Ia slrada, / lra selle e selle
luoi figIiuoIi senli. rugnoIi in roosilo, . 158, cila Slazio, Tnc|. VII, 353: scpicn
tiri|is scxus jcninci. Ma in queslo asso manca forse iI raorlo che c'e fra Danle e Sene-
ca: selle e selle |isquc scpicncs, luoi figIiuoIi senli succisa jciu.
61 RONCONI, Pcr Oanic inicrprcic !ci pccii |aiini, cil., . 14. Anche IARATORI, s. v. Sc-
ncca, |. O., cil., . 159, accogIie iI araIIeIo, come CONTINI, cilalo da Iaralore, i|i!., .
158. Meno affine Hcrc. jur., 1269, sitc ic picias nctci.
Scncca iragicc nc||a Commedia !i Oanic 391
Iino danlesco e i assi deI Tnqcsics di cui si e dello in aerlura di que-
slo Iavoro. Anche neI caso di Thyesles-UgoIino, come neI caso di Cer-
bero, Danle ha voIulo richiamare aIIusivamenle Ia fonle uliIizzala.
I confronli deI Tnqcsics rendono moIlo robabiIe una conoscenza di
lulla Ia lragedia, anche er iI modo con cui Danle uliIizza Ia sua fonle.
Vanno aggiunli a quesli aIlri due araIIeIi roosli da Iarodi e
accoIli daIIo slesso rugnoIi che lullavia Ii giudica, secondo me a
lorlo, scarsamenle formaIi. Issi sono (numerazione di rugnoIi):
34
Oc!ipus, vv. 342-43
|.j lauros duos
ereressus iclus huc el huc dubius
|ruil
|nj. XII, vv. 22-24
QuaI e queI loro che si sIaccia in queIIa
chha ricevulo gia I coIo morlaIe,
che gir non sa, ma qua e Ia saIleIIa
Ier siegare Danle non basla, come dice rugnoIi, . 154, Verg.
Acn. II, vv. 223-24 (jugii cun saucius aran / iaurus ci inccrian cxcussii
ccrticc sccurin). Giuslamenle Ronconi, Pcr Oanic inicrprcic !ci pccii |aii-
ni, SD, 41 (1964), . 19-20, osserva che iI loro nasce daIIa sovrao-
sizione di due dislinli modeIIi: iI loro deI Iibro II deII|nci!c e iI loro
deII|!ipc rc di Seneca.
53
(Cilo i due assi con amiezza maggiore risello aI rugnoIi):
Hcrcu|cs Ociacus, vv. 237-39
namque ul reIuxil aeIicis calae decus
el fuIsil IoIe quaIis innubis dies
urisve cIarum noclibus sidus mical
62
,
Purg. XII, vv. 88 sgg.
A noi vena Ia crealura beIIa,
biancoveslilo e ne Ia faccia quaIe
ar lremoIando mallulina sleIIa.
C'e recisa affinila lra Ie due simiIiludini (risellivamenle vv. 238-
39 e 89-90). In enlrambi i casi Ia simiIiludine e aIicala ad una crea-
lura beIIa: IoIe in Seneca e IangeIo in Danle, inoIlre si veda lremo-
Iando e nicai. II confronlo mi ar buono e va ad aggiungersi
62 AI v. 238 I ha innu|is, aI v. 239 A ha puruntc c|aris.
Sergio Sconocchia 392
aIIHcrcu|cs - Iarinala.
TraIascio di riorlare lulli gIi aIlri confronli roosli daI Iarodi
erche sono disculibiIi e incerli (er essi rinvio aI conlribulo deIIo
sludioso).
La mia oinione e che non debbano sussislere dubbi suIIa uliIizza-
zione da arle di Danle aImeno di fIoriIegi. Ma iu in generaIe occor-
rera lener conlo dei risuIlali a cui sono ervenuli di recenle gIi sludi
suIIa lradizione manoscrilla deIIe lragedie di Seneca.
Mi riferisco non lanlo ai Iavori, ur uliIi, di rugnoIi slesso
63
, ma
sorallullo ad un recenle e fondamenlaIe arlicoIo di Richard Rouse
64
.
La conoscenza deIIe lragedie di Seneca e alleslala in Irancia neIIa
Apc|cgia ccnira na|c!icics di Guido di azoches (ca. 1146 - 1203) e neIIa
Bi||icncnia di Richard de IournivaI, comosla lra iI 1243 e iI 1260, in
InghiIlerra Ia conoscenza deI lealro di Seneca e alleslala allraverso
codici deI leslo A gia resso iI vocaboIario di lermini eccIesiaslici di
AIexander Nequam, scrillo lra iI 1200 e iI 1211, e neIIArs pcciica di
Gervais of MeIkIey, scrilla circa neI 1206.
DeIIa diffusione deIIe lragedie in IlaIia si discule aIIe . 116-120
65
.
63 Ia ira!izicnc !i Scncca iragicc a||a |ucc !c||c icsiincnianzc nc!iccta|i, A. Linc. Me-
morie, cI. sc. mor. Ser. VIII, voI. III, fasc. 3 (1957), . 202-90. Sui fIoriIegi medievaIi si
veda, semre di RUGNOLI, Ic iragc!ic !i Scncca nci ||cri|cgi Mc!iccta|i, Sludi Medioeva-
Ii, 3 serie, anno 2, fasc. 1, giugno 1960, . 138-52. In queslo sludio e allribuila moIla
imorlanza aunlo ai fIoriIegi (er iI robIema che vo lrallando si veda seciaImenle
. 150: NeI secoIo XIII Ia forluna di Seneca ingiganlisce. II suo nome enlra nei ro-
grammi deIIe scuoIe. Gia aIIa fine deI XII secoIo si arIa in ambienle scoIaslico di Seneca
lragico anche se soIlanlo come eco sesso incomresa deIIe cilazioni dei fIoriIegi. Ne e
documenlo una nola di Iibri consigIiali ubbIicala daI Haskius dove iI nome di Seneca
lragico e er Ia rima voIla inlrodollo ufficiaImenle fra gIi auclores degIi accessus
|...j e . 151: CoI. XIV sec. Ia forluna di Seneca s'afferma e definilivamenle s'imone. I
grandi cenlri universilari accoIgono I'oera deI Cordovese con un inleresse su un iano
diverso ma ur semre simiIe a queIIo su cui aveva agilo Ia curiosila degIi scrillori oIi-
lici deI X secoIo. Su quesle coordinale dei nuovi inleressi scoIaslici nasce iI Ccnncniaric
aIIa lragedia che iI domenicano ingIese NicoIa Trevelh comone neI secondo decennio
deI secoIo XIV. La gIossa lrevelhana allraverso un'accurala arafrasi deI leslo deIIe
lragedie individua aunlo e dichiara i 'Ioci', miloIogici ed erudili, deII'oera senechia-
na, convinlo e coscienle I'aulore deII'imorlanza e deIIa necessila di divuIgare lanlo
alrimonio anliquario |.j. rugnoIi fornisce neI suo arlicoIo bibIiografia abbondanle e
secifica aIIa quaIe rinvio. Ollimi anche gIi sunli suIIa diffusione deIIa conoscenza di
Seneca.
64 The A Tcxi cj Scnccas Tragc!ics, Revue d'hisloire des Texles, I, 1971, . 93-
121 (er iI robIema che lrallo cfr. seciaImenle Ie . 116-21).
65 A . 116 Rouse accenna aIIa scoerla di I neI 1290 da arle deI Lovali e dice che
Geremia di Monlagnone e AIberlino Mussalo agIi inizi deI XIV secoIo (I'|ccrinis lrionfa
neI 1315) conoscevano un leslo di A coIIazionalo er aIcuni casi con I. In reIazione
aIIa scoerla di I e fondamenlaIe Io sludio di GIUSIIII ILLANOVICH, | prini unanisii c
Scncca iragicc nc||a Commedia !i Oanic 393
A . 116 Rouse afferma che menlre I|iruscus sembra essere slalo co-
ialo raramenle, i manoscrilli deIIa lradizione A forlemenle conlami-
nali con Iezioni di | aaiono neI rimo Trecenlo e conlribuiscono a
formare iI gruo iu vaslo di lrecenlo e iu manoscrilli rimasli. A .
117 Rouse dice ancora che IhiIs ha suggerilo, suIIa base dei mano-
scrilli AB, Ia ossibiIila che un secondo manoscrillo | fosse conosciulo
in IlaIia neI lredicesimo o quallordicesimo secoIo. Giardina
66
, che ha
comiulo iI lenlalivo iu vaIido er dalare iI gruo A|, riconosce
queslo osluIalo fraleIIo di I e fonle di M, N, I ed O in S. Lo slesso
Giardina vede S come fonle di lulle Ie Iezioni di | nei manoscrilli AI.
Infine, a . 118, Rouse afferma di resuorre che Ia fonle A dei
manoscrilli A| sia slalo un leslo ! ingIese orlalo in IlaIia verso Ia fine
deI lredicesimo secoIo o aIIinizio deI quallordicesimo. I anche ro-
babiIe, come afferma Rouse a . 119, che Io slesso Trevel abbia aggiun-
lo aI suo codice, disceso da C, aIcune Iezioni migIiori da un leslo A| in
occasione deIIa sua visila a Iisa o a Iirenze avvenula rima deI 1304.
Doo lullo cio, lenulo conlo che Lovali e Mussalo Ieggevano Ie
lragedie di Seneca, non si vede erche rorio neI caso di Danle, che
ur dimoslra in vari unli deIIa Ccnnc!ia conoscenza unluaIe deIIo
scrillore di Cordova, si ossa essere cerli che non abbia Iello iI lealro
di Seneca.
Ce anche unaIlra considerazione da fare. In Irancia Seneca lragi-
co e slalo conosciulo rima che in IlaIia. Duranle iI suo soggiorno
arigino Messer runello Lalini olrebbe aver senlilo arIare deIIe
lragedie di Seneca ed anche essere venulo in ossesso di un codice
deIIe lragedie o er Io meno essersi rocuralo coia deIIe slesse.
Con iI rilorno di Lalini in IlaIia queslo codice (o coia che fosse)
sarebbe giunlo a Iirenze e grazie a Messer runello olrebbe Danle
esser venulo a conoscenza di quesla roduzione lealraIe cos moraIe
|c ira!izicni !ci c|assici |aiini, Iriburgo, Idizioni universilarie 1953. Ier i raorli fra Dan-
le e iI cenacoIo adovano si uo anche vedere GIANIRANCO IOLINA, Ia prcscnza !i Oan-
ic nc| Vcncic, Alli e memorie deII'Accademia Ialavina di Scienze Lellere ed Arli,
LXXVIII 1965-66, . 483-505, deIIo slesso iIIanovich. Tra Oanic c Pcirarca. Unancsinc a
Pa!cta c a Vcrcna c unancsinc a! Atigncnc, in Alli deI Congresso inlernazionaIe di sludi
danleschi, Iirenze 1966, . 349-76, seciaImenle . 362, IITROCCHI, Ia ticcn!a |icgraji-
ca !i Oanic nc| Vcncic, in Oanic c |a cu|iura tcncia, a cura di Villore ranca e di Giorgio
Iadoan, Iirenze, OIschki 1966, . 13-27 (arimenli in |iincrari !anicscni, ari, Adrialica
1969, . 119-141), er i raorli infine fra Danle e AIberlino Mussalo si uo vedere
MANLIO DAZZI, || Mussaic prcunanisia (1261-1329). Ian|icnic c |cpcra, Venezia, Neri
Iozza 1964, . 68-70.
66 Cfr. GIAN CARLO GIARDINA, Ia ira!izicnc nancscriiia !i Scncca iragicc (pcr
unc!izicnc criiica !c||c iragc!ic), in Vicniana |asscgna !i siu!i c|assici, l. II (1965), . 31-74,
er aIlri Iavori di Giardina si veda ROUSI, Tnc A Tcxi cj Scnccas Tragc!ics, cil., . 93 n. 2.
Sergio Sconocchia 394
da essere ben degna di imilazione accanlo a VirgiIio e agIi aIlri cIassi-
ci.
Sono nolevoIi iI riIievo, Ia Iiberla, Iamiezza e Ia coslanza deIIe rie-
Iaborazioni danlesche (ad esemio: conlraasso, seIva dei suicidi,
Cerbero, Tnqcsics - UgoIino, Hcrcu|cs Ociacus - Iarinala), che ubbidi-
scono, risello ai lesli di Seneca, non soIo aI crilerio deIIa cosleIIa-
zione, ma anche a queIIo deIIa accumuIazione (ad una riresa, in
genere, lende ad aggiungersene unaIlra, a non grande dislanza di
versi).
Le lragedie iu rirese e, in cerli unli, 'lradolle' da Danle sono:
Hcrcu|cs jurcns
67
, Tnqcsics, Hcrcu|cs Ociacus, meno frequenli i raorli
con Pnac!ra, Oc!ipus, Agancnncn, ancora iu esigui ed incerli queIIi
con Trca!cs e Mc!ca. Non risuIlano rirese daIIOciatia
68
.
Abbiamo dunque ben iu che i selle araIIeIi accoIli daI rugnoIi.
Quasi lulli gIi eIemenli desunli da Seneca si lrovano neII|njcrnc.
II lealro di Seneca, a linle forli e vioIenle, era adallo, in effelli, a
suggerire eIemenli er iI mondo infernaIe.
Iare difficiIe ammellere che Danle si sia servilo soIo di fIoriIegi,
che avrebbero comunque dovulo essere moIlo ami.
Limilazione da Seneca, muIliforme e commossa, sembra deorre
e una sensazione indefinibiIe ma recisa er un Iibero allingere
aIIe oere slesse e non er una soffocala, incerla e, er forza di cose,
iu uniIaleraIe derivazione da j|crcs o comunque da fonli indirelle,
laIora sembra resuorre iI conlenulo deIIoera inlera, come neI
caso deII'Ociacus, in cui IrcoIe raresenla iI saiens sloico, Ia cui
morle conlrasla in arle con Ialleggiamenlo recedenlemenle lenulo
67 Iriva di fondamenlo sembra I'iolesi che Danle abbia conosciulo direllamenle
soIo I'Hcrcu|cs jurcns ma non Ie aIlre lragedie. Si consideri Ia lradizione deIIe lragedie di
Seneca, er cui vedi, oIlre agIi sludiosi cilali, anche G. IasquaIi, Sicria !c||a ira!izicnc c
criiica !c| icsic, Iirenze, Le Monnier 1962
2
, . 126 sgg. e 385 sgg.: I (sec. XI), iI Vaiicanus
Iai. 1769 (sec. XIV V), I'An|rcsianus D 276 |nj. (sec. XIV M), A (forse ancora deI sec.
XIII) con lulli i suoi numerosi aografi (iu di lrecenlo), lulli osciIIanli lra iI XIV e iI XV
secoIo (lranne iI Parisinus 8260 - sec. XIII I e iI Cania|rigcnsis 460 - XIII sec. C), cioe
lulli i codici da cui e cosliluila Ia noslra lradizione di Seneca lragico, avevano lulle Ie
lragedie a noi conservale (anche se non semre lrasmesse neIIo slesso ordine, I'Oiiatia
manca in I). I codici allingibiIi neII'ela di Danle (I, A, I, C) e aIlri evenluaIi aografi di
I o di A avevano dunque lulle Ie lragedie: e deI lullo imrobabiIe che esislessero uno o
iu codici con una soIa lragedia, iI |urcns. Se Danle aveva iI leslo deI |urcns aveva an-
che queIIo deIIe aIlre lragedie.
68 L'Ociatia manca in I. Iensare che Danle, se davvero aveva iI leslo di Seneca lra-
gico, diendesse, direllamenle o indirellamenle, da I o da un suo aografo conlrasle-
rebbe forse con cerli risuIlali che ci e arso di raggiungere, dai quaIi sembrerebbe che
Danle sia vicino ad un leslo deIIa lradizione A.
Scncca iragicc nc||a Commedia !i Oanic 395
daII'eroe, iu vicino aIIIrcoIe deIIa lradizione, assionaIe e vioIenlo:
anche in queslo Danle ha, con feIice inluizione, modeIIalo suIIOciacus
iI suo Iarinala, uomo di assione e dazione, comoslo lullavia
neIIInferno in una sueriore indifferenza di fronle aIIa unizione
divina.
Da cerle corrisondenze deI leslo di Danle con A iu che con I (e
neI raffronlo Hcrcu|cs - Iarinala e er gIi aIlri araIIeIi) sembrerebbe di
oler sosellare che IevenluaIe leslo di Danle fosse un codice deIIa
lradizione A. Cio non sarebbe in conlraslo con cerli eIemenli raggiun-
li, come si e vislo, daIIa recenle crilica in reIazione aIIa lradizione di
Seneca lragico in IlaIia.
Dora in oi si dovra cercare se si ossano slabiIire aIlri araIIeIi
fra Seneca e Danle e si dovra aImeno convenire che non e iI caso di
escIudere a riori una diendenza dirella deIIAIighieri da Seneca
69
.
Unitcrsiia !cg|i Siu!i !i Tricsic
69 RUGNOLI, in Ui paici pcr Scnccan, cil., . 146-47, addila giuslamenle, er iI ar.
10 deII'|pisic|a a Cangrande, Ia fonle deIIe siegazioni elimoIogiche di commedia e
lragedia in Uguccione da Iisa dove non aare lullavia iI riferimenlo a Seneca e a
Terenzio (arl. cil., . 147). Doo quanlo si e vislo cadono moIle riserve circa
I'aulenlicila in icic deII'IisloIa a Cangrande che iI rugnoIi nega e sludiosi insigni,
come Conlini, Cecchini e aIlri, confermano. Mi sembra che anche Ie considerazioni finaIi
deI rugnoIi (. 161-63) secondo cui Ia cilazione di Seneca neII'|pisic|a deriverebbe daI
Ccnncniun aII'|ccrini!c deI Mussalo scrillo da Guizzardo di oIogna e CasleIIano di
assano, vengano ora a erdere moIla forza.
ANNA CIRO
IL CANTO IX DILL'|N|||NO
NeI canlo IX deII'|njcrnc si descrive Ia Cilla di Dile coIIocala neI
seslo cerchio, dove sono unili gIi erelici che giacciono denlro lombe
scoerchiale e infuocale, coIIocale in una ianura amia e deserla.
II canlo, che forma un dillico coI recedenle, inlreccia memorie Ielle-
rarie e memorie bibIiche, evocazioni daIIe Visicni medievaIi e daIIa
Ielleralura escaloIogica musuImana: raresenla una deIIe sinlesi
cuIluraIi iu consislenli deI oema danlesco.
AI di Ia deIIa lecnica comosiliva che si incenlra su una siluazione
di conlraslo lra i diavoIi e I'angeIo allorno a una cilla assediala e
dei rocedimenli lealraIi basali suII'imrovviso e suII'imrevislo
cambiamenlo di scena, iI canlo merila allenzione er Io sessore
aIIegorico
1
, er Ia lensione moraIe deI eIIegrino e er iI senso anago-
gico di cui si imregna Ia scrillura oelica. II racconlo deI viaggio
si arresla er cedere iI oslo a drammaliche sequenze inleriori. Danle
lorna ad esrimere Ia roria incerlezza neII'imresa (come neI canlo
II), iI limore che iI viaggio non ossa conlinuare. Racconla I'inlensila
deIIa roria Iolla inleriore neII'ilinerario a Dio, erche rilornano
uIleriori imedimenli moraIi doo queIIi deIIa seIva. uona arle deI
canlo IX e Ia raresenlazione aIIegorica deIIa guerra inleriore di
Danle tiaicr. La lensione deI eIIegrino verso Ia saIvezza si senle
in iu di un verso, nonoslanle Ie amIificazioni deIIe rorie difficoI-
la.
L'esordio deI canlo IX deII'|njcrnc conlinua e commenla I'cxp|icii
deI canlo recedenle, in lono quasi senlenzioso, er creare maggiore
effello suI Iellore: VirgiIio, accorlosi deIIa sfiducia che iI rorio
lornare indielro vinlo dinanzi aI rifiulo ooslo dai demoni aveva
suscilalo neI eIIegrino, cerco di dissimuIare subilo iI senlimenlo
di ira, sforzandosi di rirendere in voIlo iI suo coIorilo normaIe.
VirgiIio era rosso er I'ira (cfr. iI v. 121 deI canlo VIII: Tu, erch'io
1 Cfr. SALVATORI SANTANGILO, Ia||cgcria !c| canic |X !c|||njcrnc, in Saggi !anicscni,
Iadova, CIDAM 1959, e MARIO AIOLLONIO, Canic V|||, in Nuctc |ciiurc !anicscnc, Ii-
renze, Le Monnier 1966, voI. I, . 217-222.
Anna Cerbo 398
m'adiri, / non sbigollir)
2
e Danle era divenlalo aIIido e smorlo er
Ia aura. II aIIore di Danle rerime I'ira o vergogna e sdegno di
VirgiIio (rislrinsericaccio denlro, siega Tommaso Casini)
3
.
Non inlerrela cos Lodovico CasleIvelro, iI quaIe dice che VirgiIio
aveva dimoslralo di aver aura a due segnaIi, cioe aIIa aIIidezza
ed aIIe aroIe, ercio er rassicurare Danle cerco d'annuIIare subilo
i redelli due segnaIi, rilirando denlro di se Ia aIIidezza e cercando
di correggere (lrasIalo di riccpcrsc) Ie rime aroIe, in aarenza
dubilalive, con Ie seconde affermalive
4
. Gia a concIusione deI canlo
recedenle CasleIvelro aveva chiosalo a roosilo dei versi Tu,
pcrcnic na!iri, / ncn s|igciiir:
L'aver gIi occhi a||a icrra e I'aver |c cig|ia rasc !cgni |a|!anza non
sono segnaIi che aIlri s'adiri, ma sono segnaIi di aura, e che
non gIi venga fallo queIIo, che s'aveva divisalo
5
.
CasleIvelro osserva ure che Ia aIIidezza era coIore nuovo in
VirgiIio, erche infino a qui non ha mai avula aura, ne mulalo
coIore, se non ora
6
.
II icrnarc in tc|ia e un lrasIalo miIilare. Landino ricorda che un
esercilo era messo in voIla quando era sconfillo e fuggiva voIlando
Ie saIIe aI nemico
7
, idenlico e iI commenlo di CasleIvelro (Tcrnarc in
tc|ia. Quesla e lrasIazione resa da uno esercilo sconfillo, che fugga
daIIa faccia de' nemici)
8
. Anche quaIche aIlro canlo inizia con un
Iinguaggio miIilare.
Mi sembra oorluno nolare Ia aroIa viIla aI rimo verso:
2 Si cila da Ia Ccnnc!ia scccn!c |aniica tu|gaia, leslo crilico slabiIilo da Giorgio
Ielrocchi er I'edizione nazionaIe deIIa Sociela Danlesca IlaIiana, Torino, Iinaudi 1975.
3 DANTI ALIGHIIRI, Ia Oitina Ccnnc!ia, a cura di T. Casini, Iirenze, Sansoni
1985, . 56.
4 LODOVICO CASTILVITRO, Spcsizicnc !i I. Casic|tcirc a XX|X canii !c|||njcrnc !an-
icscc, a cura di Giovanni Iranciosi, Modena, Anlica Tiografia SoIiani 1888, . 115-116.
NeI corso di quesla Leclura sono slali uliIizzali anche slrumenli informalici, in arli-
coIare iI dalabase | ccnncnii !anicscni !ci sccc|i X|V c XV|, a cura di IaoIo IrocaccioIi,
Roma, Lexis Irogelli IdiloriaIi 1999. Di voIla in voIla sara indicala in nola I'edizione deI
Commenlo di riferimenlo deIIo slrumenlo informalico.
5 Ivi, . 114.
6 Ivi, . 115-116. SuI coIore deIIa aIIidezza e suI suo carallere figuraIe, gia de-
scrillo da Danle rima deI canlo IX cfr. AULO GRICO, Icciura Ncapc|iiana. |njcrnc,
NaoIi, Loffredo 1986, . 127-130.
7 CRISTOIORO LANDINO, Ccncnic !i C. Ian!inc jicrcniinc scpra |a Ccnnc!ia !i Oan-
ic A|ignicri, Iirenze 1481, Venezia 1536.
8 Cfr. Spcsizicnc, . 115.
|| canic |X !c||Inferno 399
viIla non aura. AII'inizio deI canlo IX Danle confessa Ia roria
viIla, queIIa slessa che neI canlo II, 45, gIi era slala rimroverala
da VirgiIio (I'anima lua e da viIlale offesa). Iiu che non far reoc-
cuare Danle, VirgiIio vuoIe che iI disceoIo non sia vinlo daIIa
viIla, ovvero daIIa usiIIanimila. Non er caso neI canlo rece-
denle, v. 91, rilorna anche I'aggellivo foIIe (SoI si rilorni er Ia foIIe
slrada) che rinvia a venula foIIe di |nj. II, 35, ed e aIlres resenle
I'aggellivo ardilo (che s ardilo inlro er queslo regno) neI signifi-
calo negalivo, e non osilivo di buono ardire di |nj. II, 131, che
aIlrove lroviamo in coia con forle (ardilo e forle in |nj. XVI).
VoIulamenle neI canlo VIII deII'|njcrnc iI Ioela riroone Ia concen-
lrazione semanlica deI II canlo.
Non olendo guardare Ionlano er I'aria cua e er Ia nebbia filla,
VirgiIio si fermo er ascoIlare, in allesa deI messo ceIesle romesso:
queI laI che er Iui ne fia Ia lerra aerla (VIII, 130), un essere divino,
sanza scorla. I senz'aIlro uliIe, er I'inleIIigenza deI senso moraIe e
siriluaIe dei versi danleschi, riorlare I'inlerrelazione deIIa seconda
lerzina dala da AIessandro VeIIuleIIo:
I moraImenle, sa I'umana ragione, come di sora abbiamo gia
dello, che Ia, dove e Ia buona voIunla, se avien che manchino
I'umane forze, Idio suIisce coI suo divino aiulo, ma I'occhio,
cioe, ma I'umano inleIIello, pcr |acr ncrc, er I'inlendimenlo
oscuro, c pcr |a nc||ia jc|ia, e er Ia moIla ignoranzia, ncn |c pcica
ncnar a |unga, non oleva inlender quando, e come laI divino
aiulo dovesse venire, er non esserne caace, e ero si fermo ad
asellarIo, ccnucn cnascc|ia, come uomo iI quaI asella di
senlir venir queIIo, che non uo vedere, non essendo Ia divina
grazia cosa, che si ossa discerner con I'occhio cororaIe, ma s
ben denlro I'animo senlire
9
.
La lerza lerzina, che e un arIare a se di VirgiIio, ha richiamalo
I'allenzione di quasi lulli i Commenlalori che hanno coIlo neII'am-
biguila deIIa guida iI dubbio di orlare a comimenlo I'imresa, oIlre
ad indicare Ia forma melalelica di derivazione ooIare, come ha
fallo iI uli (Il e qui melalesi, figura di grammalica, er Ia quaIe
si lrascurano Ie Iellere er Ia rima, o forse queIIo che noi diciamo
pugna aIlro Iinguaggio dice punga, cioe gara)
10
. La lerzina si are con
9 ALISSANDRO VILLUTILLO, Ia Ccnc!ia !i Oanic A|igicri ccn |a ncta cspcsizicnc, a
cura di Donalo Iirovano, Roma, SaIerno Idilrice 2006, lomo I, . 348.
10 Ccnncnic !i |ranccscc !a Buii scpra |a Oitina Ccnc!ia !i Oanic A||ignicri, ubbIi-
calo er cura di Crescenlino Giannini, Iisa, Nislri 1858-62 (risl. anasl., con remessa di
Anna Cerbo 400
un'affermazione di VirgiIio: Iur a noi converra vincer Ia unga
(e sicuro che noi vinceremo iI conlraslo), seguila daIIa erIessila
deI Ioela Ialino resa allraverso Ia frase voIulamenle Iasciala sosesa:
se no., ma subilo smenlila: TaI ne s'offerse. / Oh quanlo larda
a me ch'aIlri qui giunga!. Iorena cogIiendo in VirgiIio un momen-
lo di dubbio, scrive: Ma subilo VirgiIio lronca, e riele aroIe di
fiducia
11
.
Quasi lulli i commenlalori anlichi, rifacendosi a |njcrnc II, vv. 85
sgg., Ieggono neII'indelerminalezza deII'esressione TaI ne s'offerse
I'aIIusione a ealrice. AIcuni esegeli vi Ieggono Dio, che ermelle iI
viaggio di Danle, oure Ia Vergine che ebbe er rima iI ensiero
di venire in soccorso di Danle. NeII'edizione Ielrocchi Ieggiamo
TaI ne s'offerse
12
(cioe: 'cos olenle essere si offr in noslro aiulo',
come in |njcrnc I, 62: mi si fu offerlo / chi er Iungo siIenzio area
fioco). II senso e queslo: 'noi vinceremo Ia ballagIia, erche se non
Ia vincessimo, I'angeIo non si sarebbe offerlo di venire'. NeII'edizione
Sanguineli, invece, si Iegge TaI ne sofferse
13
, cioe 'laIe ce Io ermise',
'laIe sofferse che noi scendessimo quaggiu', oure, secondo una
Iezione che Iega iI significalo deI verso aIIa esilazione recedenle:
laIe, di lanla forza e chi ci ha fallo resislenza.. Anche iI uli aveva
voIulo Ieggere sofferse, ma con ben aIlro senso, ovvero con signifi-
calo leoIogico:
Quesla e una orazione imerfella secondo iI grammalico, che
non ha verbo rinciaIe, ma eIIa si dee suIire in queslo mo-
do, cioe se non Ia vinceremo er noi, laI ne sofferse, cioe
soslenne ena, e queslo fu Crislo noslro SaIvalore, che ce Ia fara
vincere |.j
14
.
Ci sono rimandi e corrisondenze esressive aII'inlerno dei canli VIII
e IX deII'|njcrnc. La forma Ta| ne s'offerse e idenlica e aIlrellanlo
Irancesco Mazzoni, Iisa, Nislri-Lischi 1989). SuIIa voce punga er pugna cfr. IRNISTO
GIACOMO IARODI, Ia rina c i tcca|c|i in rina nc||a Oitina Ccnnc!ia, in Iingua c Iciicra-
iura, a cura di Gianfranco IoIena, Venezia 1957, e ancora Ia Oitina Ccnnc!ia,
commenlala da Manfredi Iorena, voI. I: |njcrnc, oIogna, ZanicheIIi 1957, . 87, e M.
IORINA, || canic |X |1902j, in Ia nia Icciura Oaniis, NaoIi, Guida 1932, . 41.
11 |njcrnc, a cura di Iorena, cil., . 87.
12 Ia Ccnnc!ia scccn!c |aniica tu|gaia, cil. Cfr. ARRIGO CASTILLANI, Ta| nc scjjcrsc,
Lingua noslra, XII (1953), . 22. Cfr. ancora ANTONINO IAGLIARO, U|issc. |iccrcnc
scnaniicnc su||a Oitina Ccnnc!ia, Messina-Iirenze, D'Anna 1966, II, . 571-76.
13 DANTIS ALAGHIRII Ccnc!ia, edizione crilica er cura di Iederico Sanguineli, Ii-
renze, Idizioni deI GaIIuzzo 2001, . 47.
14 Ccnncnic !i |ranccscc !a Buii scpra |a Oitina Ccnnc!ia !i Oanic A||ignicri, cil.
|| canic |X !c||Inferno 401
indefinila come Ia forma di |njcrnc VIII, 105 da laI ne e dalo
(Non lemer, che iI noslro asso / non ci uo lorre aIcun: da ia|
n'e dalo).
NeII'escIamazione deI v. 9 (Oh quanlo larda a me ch'aIlri qui
giunga!) si esrime I'imazienza neII'allesa deI soccorso ceIesle:
a|iri, cioe queI ia| deI verso recedenle e di VIII, 130. Danle fa vivere
aI agano VirgiIio iI senlimenlo di allesa e di seranza, fondamenlaIe
er iI crisliano e rova di fede. II v. 9 suona quaIe invocazione deIIa
Grazia come neI Purgaicric !i san Pairizic, quaIe subIime lrionfo deIIa
fede suIIa ragione. AIIa vergogna deIIa guida er Ia sconfilla, in
resenza deI disceoIo, fa seguilo Ia morlificazione di essere slalo
incaace di orlare a lermine iI comilo affidalogIi da ealrice.
L'inlenlo aIIegorico si fa chiaro: er scendere neII'Inferno Ia guida
deIIa ragione non e iu sufficienle, divenla necessario iI soccorso
divino. Anche Danle, rima disorienlalo daII'oosizione dei diavoIi,
oi insosellilo daIIa relicenza con cui Ia guida aveva Iascialo a mela
Ia frase (se non.), si reoccua che VirgiIio non ossa guidarIo
er i cerchi inferiori deII'Inferno. Ierlanlo, con eslrema accorlezza,
rivoIge aI Ioela Ialino quesla domanda generica ma ben mirala, in cui
lorna a definire Ia ena deIIe anime deI Limbo, di essere cioe elerna-
menle rivale deIIa seranza di vedere Dio:
In queslo fondo de Ia lrisla conca
discende mai aIcun deI rimo grado,
che soI er ena ha Ia seranza cionca`
15
II sinlagma melaforicamenle regnanle seranza cionca rinvia a |n-
jcrnc IV, 42, dove si Iegge: che sanza seme vivemo in disio, e er
conlraosizione a seranza buona di |njcrnc VIII, 107. VirgiIio in-
luisce subilo iI senso deIIa richiesla e, er aIIonlanare daI eIIegrino
ogni ombra di limore, finge di essere slalo un'aIlra voIla neIIe mura
deIIa Cilla di Dile, anzi dice di essere disceso neIIa arle iu bassa deI-
I'Inferno, in virlu deIIe arli magiche di Irilone, aIIa quaIe fa cenno Lu-
cano neII'eisodio di Seslo Iomeo (Pnarsa|ia VI, 507 sgg.). La finzione
di un recedenle viaggio agIi Inferi si Iegge anche in Acn. VI, 562-565,
in una siluazione anaIoga, quando Ia SibiIIa rassicura Inea di una sua
discesa aII'Averno er voIonla di Iroserina. Ier AIdo VaIIone si lral-
lerebbe di una finzione edagogica, aII'inlerno di un oema con di-
chiarale finaIila didalliche. MoIli crilici hanno lrallo sunlo da quesli
versi er avanzare I'iolesi che Danle seguisse I'oinione ooIare
15 |njcrnc IX, vv. 16-18.
Anna Cerbo 402
medievaIe circa i oleri magici deI Ioela Ialino. Ma Domenico Com-
arelli
16
ha dimoslralo che iI VirgiIio danlesco non va confuso coI
VirgiIio deIIe Ieggende ooIari, facendo nolare che nei vv. 22-30 deI
canlo IX egIi e villima deII'arle di una maga, iulloslo che mago
17
.
Cerlo e che neII'eisodio domina iI fascino deIIa Ielleralura cIassica, in
arlicoIare Ia suggeslione deIIa oesia eica di VirgiIio e di Lucano, in
funzione ero di una ben soIida visione crisliana che conlraone aIIa
faIsa resurrezione dei morli da arle deIIa crudeIe Irilone queIIa vera
ad oera di Crislo, che si Iegge er esemio in Marcc 9, 2-10.
II canlo IX e slalo definilo iI canlo deIIe arensioni e dei dubbi,
deIIe deboIezze e deIIe frequenli lensioni di Danle. Nei vv. 58-60 Vir-
giIio conlinuera a dubilare deIIa saIdezza di Danle dinanzi a Medusa e
ercio gIi corira gIi occhi anche con Ie rorie mani. SoIo iI Messo
ceIesle, er iI quaIe Danle conlinuera ad usare esressioni indefinile
(fuggir cos dinanzi ad un ch'aI asso / assava Slige con Ie ianle
asciulle)
18
, sciogIiera inlrighi e oosizioni, risoIvendo ogni oosi-
zione e vincendo disarmalo suIIa lracolanza dei nemici.
AI v. 31 VirgiIio avvia Ia descrizione deIIa Cilla di Dile (Quesla
aIude che 'I gran uzzo sira / cigne dinlorno Ia cilla doIenle, / u'
non olemo inlrare omai sanz'ira), deslinala a inlerromersi subilo
(I aIlro disse, ma non I'ho a menle). Avendo rivoIlo I'occhio verso
Ia sommila deII'aIla lorre, dove sono rille Ie Iurie infernaIi, iI che
moraImenle significa che i suoi sensi sono oressi da assioni e
erlurbazioni, Danle non resla iu allenzione a quanlo VirgiIio gIi
dice, e quindi non riesce a memorizzare e a ricordare. La cilla do-
Ienle, che in |njcrnc III, 1 indica I'inlero Inferno, qui indica soIo Ia
Cilla di Dile. Quesla e circondala daIIa aIude sligia che esaIa un feli-
do odore. Ier come sono andale Ie cose (I'oosizione di iu di
miIIe diavoIi che hanno chiuso Ia orla in faccia a VirgiIio), neIIa
Cilla di Dile non si olra enlrare sanz'ira. I commenlalori hanno
coIlo in sanz'ira diversi sensi, cioe senza un allo di forza, oure
senza doIore, rammarico, affanno, lormenlo. Vero e che iI verso
33 (u' non olemo inlrare omai sanz'ira) rimanda a Psa|nus 4, 5:
Irascimini el noIile eccare, erche qui si aIIude aII'ira deII'uomo
virluoso dinanzi aI maIe, come e er VirgiIio dinanzi aII'arroganza
dei diavoIi (VIII, 121) e come sara er I'angeIo risoIulore che arIera
16 DOMINICO COMIARITTI, Virgi|ic nc| Mc!icctc, Iirenze, Seeber 1896, voI. I, .
289-290.
17 Su quesla robIemalica si e soffermalo UGO ZANNONI neIIa Icciura Oaniis Sca|i-
gcra, |njcrnc, Iirenze, Le Monnier 1967, . 278-279.
18 |njcrnc IX, v. 80.
|| canic |X !c||Inferno 403
ai diavoIi con disdegno e con giusla coIIera (ien di disdegno)
19
.
A arlire daI v. 34 comincia Ia arle iu drammalica deI canlo
IX, suIIo sfondo una scenografia aocaIillica, scrive Marcazzan.
Danle roiella aII'eslerno gIi inganni Ie ombre e i lormenli deIIa
roria coscienza. I vv. 34-105 sono slali amiamenle Ielli e inler-
relali daII'esegesi Ielleraria e figuraliva. Si lrovano, er esemio,
raffigurali in una minialura di scuoIa fiorenlina, fine secoIo XIV:
vi comaiono Ia orla di Dile, Ie lre Irinni suIIa lorre e I'angeIo (i-
bIioleca AosloIica Valicana, cod. Valicano Ial. 4776)
20
. Nei versi
aena ricordali Danle drammalizza I'elerna Iolla deI bene e deI
maIe, I'elerna, immulabiIe e semre alluaIe villoria di Dio
21
. QuaIche
commenlalore, come iI Rosselli, ha voIulo vedere simboIeggialo,
neII'eisodio di |njcrnc IX, ersino I'esiIio di Danle: nei diavoIi i
fiorenlini che gIi chiusero Ie orle deIIa cilla di Iirenze, neI Messo
ceIesle Arrigo VII che soIo avrebbe olulo riarirIe. AIlri sludiosi
vi hanno Iello un'eserienza miIilare, queIIa evocala anche nei vv. 94-
96 di |njcrnc XXI.
L'aIla lorre a Ia cima rovenle, simboIo risellivamenle deIIa
suerbia e deII'accensione deII'ira, allira I'allenzione di Danle eIIe-
grino che si lrova ad assislere ad uno sellacoIo di lerrore: Ia com-
arsa imrovvisa suIIa lorre deIIe lre Iurie infernaIi, macchiale
di sangue, daII'asello e daIIe movenze femminiIi, e cinle di idre ver-
dissime, con serenleIIi e cerasle aI oslo dei caeIIi. Iielro di Danle
evoca I'|cc|csiasic 27, 6 (effusio sanguinis in rixa suerborum) er Ie
Iurie macchiale di sangue (v. 38) e iI Ps. 57, 5 (furor eorum sicul fu-
ror serenlis) nei vv. 40-42. NeIIa descrizione lealraIe, furiosa e
rumorosa deIIe Iurie (ciascuna si feriva iI ello con Ie unghie, si
ercoleva con Ie aIme deIIe mani e lulle gridavano forle) Danle
melle insieme memorie bibIiche dei Prctcr|i (inler suerbos semer
iurgia sunl, ubi suerbia, ibi conlumeIia, arma el gIadii in manu
suerbi) e memorie deIIa lradizione deIIa oesia Ialina: VirgiIio,
Acn. VI, 570-572, VII, 324-329, Ovidio, Mcian. IV, 451-454, 481-496,
Slazio, Tnc|. 103-115. Ma assegna Ioro una diversa simboIogia risello
aIIa miloIogia agana er Ia quaIe erano Ie dee vendicalrici degIi
omicidi. NeIIe Iurie gIi anlichi vedevano ersonificala I'agilazione
deIIa coscienza dei maIvagi. Danle Ie chiama Ie meschine / de Ia
regina de I'ellerno ianlo (Ia aroIa ncskin in arabo significa pctcrc,
19 Cfr. |njcrnc IX, vv. 88-99.
20 A Roma, resso Ia ibIioleca Valicana, vi e ure iI Oiscgnc pcr i| canic |X
!c|||njcrnc di Sandro olliceIIi.
21 MARIO MARCAZZAN, Canic |X, in Iciiurc !anicscnc. |njcrnc, a cura di Giovanni
Gello, Iirenze, Sansoni 1955, . 159.
Anna Cerbo 404
neIIe Iingue neoIaline, invece, lra i diversi significali assunse queIIo
di scrtc e Danle usa Ia voce meschine con queslo significalo). Scrive
CasleIvelro che Mcscninc sono servigiaIi e fanli, e cos ancora oggid
si nominano Ie fanli in aIcuna arle d'IlaIia, e seciaImenle in VaIleIIi-
na
22
. Ier Ia aura che Ie Iurie gIi inculevano Danle si accoslo a
VirgiIio in alleggiamenlo confidenziaIe e in cerca di rolezione.
Commenlalori anlichi e moderni si sono imegnali neIIa inlerre-
lazione moraIe e aIIegorica deIIa raresenlazione danlesca deIIe
Iurie: iI eccalo in generaIe e Ie diaboIiche iIIusioni che dislraggono
daIIa conlemIazione deIIe cose divine, e ancora Ia suerbia, I'ira,
I'eresia, iI rimorso. Iare iu soddisfacenle I'inlerrelazione dei com-
menlalori Iielro di Danle e envenulo, secondo Ia quaIe neII'|njcrnc
esse simboIeggerebbero iI rimorso e iI lormenlo deI rimorso
23
. Iacoo
AIighieri (Cnicsc a||a Caniica !c|||njcrnc !i Oanic A|ignicri aiiri|uiic a
suc jig|ic jaccpc), seguilo daII'Ollimo (IOiiinc Ccnncnic !c||a Oitina
Ccnnc!ia), siegava che Ie lre Iurie raresenlerebbero Ia rava
cogilalio, Ia rava eIoculio e Ia rava oeralio. Lo Scarlazzini vi
vede simboIeggialo I'imielramenlo deIIa coscienza
24
. II IascoIi I'acce-
camenlo e Ia besliaIila
25
.
Quanlo aIIe lre Iurie envenulo commenla:
Ier comrendere iI Ioro significalo, bisogna brevemenle saere
che quesle lre Iurie infernaIi sono da lulli i oeli raresenlale
in numero di lre, erche da esse viene causalo ogni maIe: con iI
ensiero, Ia aroIa e I'azione, er cui sono delle AIello, Tesifone
e Megera |.j e sono delle a ragione furie infernaIi, erche in-
ducono I'uomo aI furore e aIIa furia di ogni forma di deIillo
26
.
II orlamenlo e I'asello femminiIe (I'edizione Ielrocchi riorla
membra feminine, I'edizione Sanguineli lrascrive membra femini-
Ie) fanno aIIusione aI fascino deIIa lenlazione, aII'aIIellamenlo deI
eccalo.
Ricorrendo sia aIIe fonli scrilluraIi sia a queIIe miloIogiche, Danle
melle in iscena una sacra raresenlazione, o megIio iI |c||un inicsii-
22 CASTILVITRO, Spcsizicnc, cil., . 120.
23 Ier I'inlerrelazione deIIe Iurie neIIa Ccnc!ia si Iegga GIOVANNI ANTONIO VIN-
TURI, || canic |X !c|||njcrnc, Iirenze, Sansoni 1901.
24 GIOVANNI ANDRIA SCARTAZZINI, Ia Oitina Ccnnc!ia ritc!uia nc| icsic c ccn-
ncniaia. |njcrnc, Lisia, rockhaus 1874, 1900
2
.
25 GIOVANNI IASCOLI, Mincrta cscura (1898) e Sciic i| tc|anc, Messina 1900, ora in
Prcsc, II, MiIano 1952.
26 INVINUTI DI RAMALDIS DI IMOLA Ccncniun supcr Oaniis A|agncrii Ccncc!ian,
curanle }acobo IhiIio Lacaila, Iirenze, arbera 1887.
|| canic |X !c||Inferno 405
nun, iI lravagIio siriluaIe che conduce aIIa saIvezza, raresen-
la come Ia lenlazione, iI eccalo, i limori e Ie erIessila cerchino
di oslacoIare iI rorio viaggio verso Ia saIvezza
27
. }acqueIine Rissel
individua neIIe Iurie (figure di gruo come i cenlauri) una frenesia
eccessiva e sluida, simiIe aIIa frenesia che carallerizza Ia schiera
dei diavoIi di lradizione medievaIe inlenli a lrafiggere con roncigIi
i barallieri immersi neIIa ece boIIenle
28
. In arlicoIare I'eisodio
deIIe Iurie, neI cui guardare verso iI basso si cogIie un uIleriore ricor-
do bibIico, er esemio deI Psa|nus 16, 11 (Slaluerunl ocuIos suos
decIinare in lerram), e segnalo da una forle lensione drammalica e
sembra imilare i loni drammalici deIIa lenlazione di Crislo da arle
deI diavoIo in Mi. 4, 1-7. La roria eserienza e inlesa da Danle come
iniiaiic Cnrisii. In queslo momenlo deI viaggio Danle tiaicr non e
soIo sellalore, ma allore e allenlo a vigiIare suIIa guida. In queslo
senso iI eIIegrino deIIa Ccnc!ia si avvicina aI rolagonisla deI
Purgaicric !i san Pairizic e aI rolagonisla deI oema ersiano Saqr
a|-||! i|a |-Ma! (|| tiaggic nc| |cgnc !c| |iicrnc) di San'i
29
. Nei
canli VIII e IX deII'|njcrnc si cogIie iI senso escaloIogico, saIvifico deI
rilorno daI viaggio, vivo neI oema ersiano e neI Purgaicric !i
san Pairizic. Issendo ancora in vila Danle sa che, doo iI viaggio
neII'aIdiIa, deve rilornare suIIa lerra, diversamenle sarebbe dannalo:
Iensa, Iellor, se io mi sconforlai / neI suon de Ie aroIe maIedelle, /
che non credelli rilornarci mai (VIII, 94-96).
MoIleIici sono i significali che gIi anlichi e i moderni sludiosi
hanno allribuilo a Medusa, dolala deIIe facoIla di imielrire, cioe
rendere sluidi e insensali, quanli osano guardarIa. Ier iI Lana e
simboIo deIIe eresie, er Iielro di Danle (Pciri A||cgncrii supcr Oaniis
ipsius gcniicris Ccncc!ian Ccnncniariun) e er envenulo e iI
lerrore con cui Ie Iurie cercano di aIIonlanare iI eIIegrino, er Iacoo
di Danle e I'agire conlro ragione, er I'Ollimo
30
, I'Anonimo (Ccnncnic
27 SuI tiaggic di Danle a Dio, che riroone, aI ari di ono Giamboni, Ie araboIe
di San ernardo (anche se su un iano di missione divina) cfr. IRANCO CARDINI, Psicc-
nacnia c gucrra sania. A prcpcsiic !i un iraiiaic a||cgcricc-ncra|c !ucccnicscc, Archivio
Slorico IlaIiano, 128, 1970, . 93.
28 }ACQUILINI RISSIT, Oanic scriiicrc, lrad. di }. Rissel, MiIano, Mondadori 1984, .
100-103.
29 II oema ersiano si uo Ieggere neIIa lraduzione ilaIiana a cura di CarIo Sacco-
ne, Iarma, Iraliche Idilrice 1993.
30 NeI Ccnncnic deII'Ollimo si Iegge: Onde non senza cagione Ie Iurie chiamano
Medusa, cioe dimenlicanza, che imedisca Danle d'enlrare aIIa cognizione deIIe scienze
d'Inferno, cioe deIIa viIla deIIe cose mondane iu nole a noi, accio che iu non ossa
saIire aIIa nolizia deIIe men nole, cioe deIIe cose ceIesliaIi, ma queIIo che ha vedulo
dimenlichi. Cfr. IOiiinc Ccnncnic !c||a Oitina Ccnnc!ia. Tcsic inc!iic !un ccnicn-
pcrancc !c| pccia ciiaic !ag|i Acca!cnici !c||a Crusca, a cura di AIessandro Torri, Iisa,
Anna Cerbo 406
a||a Oitina Ccnnc!ia !c| sccc|c X|V) e iI uli e I'obIio deI maIe, Ia
dimenlicanza. II occaccio, invece, riconosceva in Medusa I'aIIegoria
deIIa oslinazione neI maIe:
DeIIe quaIi cose ossiamo aI noslro roosilo racogIiere sollo iI
nome di quesla Medusa essere, come di sora e slalo dello,
chiamala Ia oslinazione, in quanlo essa faceva chi Ia riguardava
divenir di sasso, cioe geIido e infIessibiIe
31
.
Da arle sua iI CasleIvelro cos siegava Ia remura di VirgiIio neI far
voIlare indielro iI disceoIo e neI corire anche con Ie sue mani gIi
occhi di Danle (.ed eIIi slessi / mi voIse, e non si lenne a Ie mie
mani, / che con Ie sue ancor non mi chiudessi)
32
:
Medusa adunque sono i beni deI mondo, iI vederIa s'e orre in
Ioro amore e fidanza, iI rivoIgersi a dielro s'e iI fuggirgIi di sua
sonlanea voIonla, iI chiuder gIi occhi, che fa VirgiIio a Danle
con Ie mani, sono i consigIi e i conforli degIi uomini sanli, che
non ci Iasciano indurre ad amarIi
33
.
Vedere Medusa avrebbe significalo Ia fine deIIa conlemIazione
deIIe cose divine (NuIIa sarebbe di lornar mai suso). Tra i Commen-
lalori moderni CarIo SaIinari, Sergio RomagnoIi, Anlonio Lanza e
}acqueIine Rissel vedono in Medusa iI simboIo deI dubbio reIigioso,
che araIizza Ia voIonla umana e rende I'uomo insensibiIe come
ielra, Auerbach (1971) vi cogIie I'aIIegoria deII'obIio. Crilici come
Rossi, IeIIegrini, Venluri, Sleiner, Marcazzan inlendono Ie Iurie come
Caurro, 1827-29, 3 voII. (I red., secondo iI ms. Laurenziano XL 19), risl. anasl., con re-
fazione di Irancesco Mazzoni, oIogna, Iorni 1995.
31 Cfr. GIOVANNI OCCACCIO, |spcsizicni scpra |a Ccnnc!ia!i Oanic, a cura di
Giorgio Iadoan, MiIano, Mondadori 1965, . 507. MoIlo inleressanle si fa I'esegesi boc-
cacciana quando iI CerlaIdese chiama in causa iI Sa|nc CXVIII, 37 e I'|cc|csiasics, I, 2:
Ira adunque a queslo rovocala Medusa, accio che, vedula, cioe ricevula neIIa menle
deII'aulore, Iui avesse fallo sasseo divenire, e er conseguenle ricevulo in inferno, cioe
inlorno agIi essercizi lerreni, e avesse Iasciala slare Ia buona disosizione neIIa quaIe era
enlralo dielro aIIa ragione er acquislare i frulli ceIesliaIi. Ma cio non ole avvenire, er
cio che Ia ragione iI fece voIgere in aIlra arle che in queIIa donde dovea moslrarsi iI
Gorgone, cioe iI fece voIgere ad aIlro sludio che a riguardare Ie vanila lemoraIi, e a
orvi I'animo: iI che regava iI SaImisla quando dicea: Atcric ccu|cs nccs, nc ti!cani
taniiaicn, cioe con effello riguardino Ie cose lemoraIi, Ie quaIi son lulle vane, come
dice I'|cc|csiasics. Vaniias taniiaiun, ci cnnia taniias.
32 |njcrnc IX, vv. 58-60.
33 CASTILVITRO, Spcsizicnc, cil., . 122.
|| canic |X !c||Inferno 407
rincrsi e Medusa come !ispcrazicnc
34
.
II senso aIIegorico e iI senso moraIe resenli neII'eisodio deII'a-
arizione deIIe lre Iurie e neI racconlo successivo siegano I'aeIIo
di Danle aI Iellore affinche abbia un inleIIello sano secondo quan-
lo si Iegge neI Ccntitic IV, 15, 11, I'inleIIello e sano quando er
maIizia d'animo e di coro imedilo non e ne Ia sua oerazione) ,
invilandoIo a uno sforzo di inleIIigenza er comrendere iI senso
rioslo nei versi oscuri, che arIano di verila rofonda che sla sollo iI
significalo IelleraIe.
Mario Marcazzan, cercando di esare, er quanlo e ossibiIe, Ie
aroIe di Danle, osserva:
sirani egIi definisce i rori versi in ordine aIIa maleria inusilala
e favoIosa ch'essi accoIgono, non gia in ordine aII'aIIegoria e
lanlo meno aI significalo ch'essa adombra |.j. I quanlo agIi
inleIIelli sani, credo Danle inlenda moIlo semIicemenle ncn
guasii c ncn jucrtiaii !a crrcrc. Qua|c crrcrc? Pcr Oanic crrcrc,
nc||cr!inc rc|igicsc c ncra|c, ncn puc csscrc cnc i| !isccsiarsi !a||a
!ciirina !c||a Cnicsa |.j
35
.
Danle sla affronlando Ia arle iu difficiIe deI suo viaggio inferna-
Ie, vuoIe erlanlo solloIineare i gravi oslacoIi da suerare er saIvarsi,
quaIi Ie lenlazioni (i diavoIi), iI rimorso deIIa vila assala (Ie Irinni),
infine iI dubbio reIigioso e Ia diserazione deIIa saIvezza (Medusa).
Se I'Ollimo invilava iI Iellore a scovare iI senso aIIegorico inlenso e
rioslo neII'AeIIo di Danle aI Iellore:
In quesla arle I'Aulore rende allenlo Io Iellore a ficcar Io inleI-
Iello a queIIo che si finge, e aIIegoricamenle s'inlende, e che e
coerlo daI veIamenlo di queIIi versi di sora, Ii quaIi lrallano
di maleria slrana da noi, cos erche e maleria non usala, cos
erche quesli esemIi lrallano di genle slraniera da noi, cioe di
queIIe lre Iurie, Ie quaIi er Ioro essere sono slranie, e non
dimesliche noslre
36
,
iI CasleIvelro ne esIicilava iI conlenulo, dichiarando che Ia dollrina,
34 Cfr. VITTORIO ROSSI, || canic |X !c|||njcrnc, in || pccia !a||a tc|cnia crcica, oIogna,
ZanicheIIi 1919, ILAMINIO IILLIGRINI, |njcrnc |X, in Icciura Oaniis gcnctcsc, Iirenze,
Sansoni 1904, VINTURI, || canic |X !c|||njcrnc, nc| ccnncnic c nc||c ncic, cil., CARLO
STIINIR, Ia Oitina Ccnnc!ia,Torino, Iaravia 1921.
35 Canic |X, in Iciiurc !anicscnc, |njcrnc, cil., . 165.
36 IOiiinc Ccnncnic !c||a Oitina Ccnnc!ia, cil.
Anna Cerbo 408
che s'asconde sollo iI veIame degIi versi slrani, s'e che non dobbiamo
amare i beni di queslo mondo, ne guardargIi, e non ci dobbiamo
fidare deIIe forze noslre, ma dobbiamo ancora rendere consigIi e
conforli in fuggirgIi da gIi uomini, che ci sono slali dali da Dio er
maeslri e er guide
37
.
L'arrivo deI Messo ceIesle: en m'accors'io ch'eIIi era da cieI
messo, cioe invialo da Dio (de ceIo missus si Iegge neII'|pisic|a ai
CardinaIi), in conlraslo con i diavoIi daI cieI iovuli in |njcrnc VIII,
83, e inlrodollo da un moduIo virgiIiano I gia (I gia venia su er
Ie lorbide onde / un fracasso d'un suon ien di savenlo), moduIo
che neI oema si aIlerna aI moduIo bibIico Id ecco. Ier Ia maggior
arle degIi inlerreli si lralla deII'arrivo di un angeIo, er aIcuni,
come Toffanin
38
, di Inea, er aIlri di Mercurio, er quaIcuno di Crislo.
Sia Ie onde lorbide, sia iI fracasso che desla savenlo, come annuncio
di un favore che Dio ci Iargisce, richiedono un'esegesi moraIe come
quesla di AIessandro VeIIuleIIo:
Dice adunque che gia venia su pcr |c icr|i!c cn!c, inlese er Ie
lrisle e mesle cogilazioni, di che abbiamo vedulo Ia menle deI
oela, er Ia resislenza falla a Ia arle ragionevoIe da' minislri
de Ie diaboIiche, esser oressa. Un jracassc !un sucn picn !i
spatcnic: erche i leoIogi |.j vogIiono che a principic, quando
queslo favor divino discende in noi, dia savenlo e lerrore, ma
che in fine assecuri e sia di moIla giocondila
39
.
II Messo divino e annuncialo da un fracasso savenlevoIe, come in
Ai. 2, 2, non diverso (in Ialino nau! a|iicr) da un venlo imeluoso er
I'allrazione deIIe masse d'aria fredda verso queIIe di aria caIda. II
aragone ancora una voIla lrae isirazione da VirgiIio (Acn. II, 416-419
e Gccrg. II, 440 sgg.), da Lucano (Pnars. I, 389 sgg.) e da Slazio (Tnc|.
VII, 65 sgg.). L'evenlo naluraIe recede Ia manifeslazione deI soran-
naluraIe che genera limore e sgomenlo. Ier I'immagine deI Messo, che
assava Slige con Ie ianle asciulle, c'e una memoria inlerna aIIa
Ccnc!ia: I'immagine deIIe anime dei savi che neI Limbo camminano
suI fiumiceIIo come lerra dura
40
, e una memoria bibIica, Mi., 14, 25:
iI miracoIo di Crislo che cammina suIIe acque deI Iago di Tiberiade.
Danle vuoIe raresenlare Ia sueriorila e Ia sicurezza deI Messo
37 CASTILVITRO, Spcsizicnc, cil., . 121-122.
38 GIUSIIII TOIIANIN, || canic V||| !c|||njcrnc, Iirenze, Le Monnier 1960, . 17
sgg.
39 Ia Ccnc!ia !i Oanic A|igicri ccn |a ncta cspcsizicnc, cil., . 357-358.
40 |njcrnc IV, v. 102.
|| canic |X !c||Inferno 409
(sicuro deIIa villoria e giuslamenle sdegnalo: picn !i !is!cgnc), Iibero
da ogni Iegame coI maIe. Iiu di miIIe anime dannale fuggono dinanzi
aI rocedere deIIa crealura ceIesle (Come Ie rane innanzi a Ia nimica /
biscia.)
41
. Anche quesla simiIiludine, di derivazione ovidiana (Mc-
iancrjcsi VI, 370-381) e forlemenle reaIislica. L'aere grasso (daI
Ialino crassus !cnsc e pcsanic), che iI Messo rimuove con faslidio,
assandosi sesso suI viso Ia mano sinislra (v. 84), e I'aIIegoria deI
vizio e deI eccalo.
VirgiIio invila Danle a inginocchiarsi dinanzi aI Messo, in segno di
umiIla e di devozione (e quei fe segno / ch'i' inchinasssi ad esso)
42
,
come dinanzi aII'angeIo nocchiero in Purg. II, 28 e aII'angeIo che cu-
slodisce Ia orla deI Iurgalorio (Purg. IX).
II siIenzio comoslo deI Messo conlrasla con Ia slizza e con Ia
rumorosa ribeIIione dei diavoIi (grande sluoIo: VIII, 69, iu di
miIIe in su Ie orle: VIII, 82). La sua tcrgnciia e simboIo deI lrionfo,
senza falica, deI bene suI maIe. Iielro di Danle ricordava I'eisodio
bibIico deI baslone di Aronne (Nn. 17 ) e I'Ollimo scriveva:
|.j dinola Ia giurisdizione, e signoria deIIa quaIe Iddio invesl
queslo AngeIo, Io quaIe egIi coslilu in queslo officio, s che gIi
diede baIia che erlenesse, e che fosse necessaria a cio: e quesla
e Ia verghella
43
.
MoIlo inleressanli e acule sono Ie considerazioni di Riccardo
accheIIi suIIa noncuranza deI Messo ceIesle, dovula, da una arle,
aII'imrudenza di VirgiIio che oslenla una sicurezza iIIusoria, in se
slessa e leoIogicamenle
44
, aIIa insufficienza di quei suoi Iumi di
ragione e d'eserienza (en so iI cammin, ero li fa sicuro)
45
, aI
ari di quanlo accadra ancora in MaIeboIge
46
, daII'aIlra aII'abbandono
e aIIa sfiducia di Danle eccalore che disera deIIa roria saIvezza.
Quesli sarebbe cadulo in queIIo slalo che fu deII'uomo rima deIIa
saIulifera incarnazione di Dio neI IigIiuoI deII'Uomo. Ambedue,
fidando I'uno, diffidando I'aIlro, avrebbero chiuso queIIe orle che
Ia Grazia arira Ioro:
41 Ier Ia simiIiludine con Ie ranc cfr. anche |nj. XXII.
42 |njcrnc IX, v. 87.
43 IOiiinc Ccnncnic !c||a Oitina Ccnnc!ia, cil.
44 Cfr. RICCARDO ACCHILLI, Oa Oiic a Ma|c|c|gc. |a iragc!ia !c||c pcric cniusc c |a jar-
sa !ci pcnii rciii, GiornaIe slorico deIIa Lelleralura ilaIiana, CXXXI, fasc. 393, 1954, .
1-33: . 14-16.
45 |njcrnc IX, v. 30.
46 Cfr. |njcrnc XXI e XXII.
Anna Cerbo 410
La asserila sicurezza e conoscenza deI cammino, ecco Io
induce a lrascurare, quasi Io ignorasse menlre ur ora ne ha
ricevula Ia rescienza e I'ansioso desiderio, iI soccorso deI
messo da cieIo, ossia daIIa Grazia, di queI laI, ch'egIi ha
olulo menlovare soIlanlo in erifrasi: aIlri, oh quanlo larda
a me ch'aIlri qui giunga!|.j. La quaIe noncuranza (deI Messo)
significa ure, uIlimamenle, che non dovranno rovocare un
inlervenlo, che e avvenulo in quanlo Ia Grazia e infinila, ma
essi ne hanno abusalo: verila uIlima, fallo erenne, giuslizia
arcana e imerscrulabiIe mislero
47
.
NeI canlo IX i diavoIi sono definili genle disella, sregiala (daI
Ialino !cspccia), disrezzala da Dio. II occaccio siegava disella
con avula in disello da Dio, iI uli con disregiala da Dio. Si
ribadisce Ia Ioro arroganza (oIlracolanza)
48
. A roosilo deIIa voce
oIlracolanza vaIe Ia ena di ricordare Ia nola di AIdo VaIIone :
II lermine 'oIlracolanza' (che non deve lradursi semIicemenle
con 'resunzione orgogIiosa') si esIica megIio ricorrendo aI
suo vaIore elimoIogico di u|ira ccgiiaiic, di azione aI di Ia d'ogni
revisione
49
.
Si ricorda Ia vanila deI Ioro recaIcilrare, come dire dar di caIcio
(uli), resislere agIi sroni, eco bibIica degIi Aiii !cg|i Apcsic|i, IX,
5, XXVI, 14 (caIcilrare)
50
, e si evocano con crudo reaIismo i danni
subili da Cerbero quando si oose aIIa discesa agIi Inferi di IrcoIe
(Cerbero voslro, se ben vi ricorda, / ne orla ancor eIalo iI menlo
e 'I gozzo)
51
. Successivamenle, in |njcrnc XIV, v. 44, Danle chiamera
i diavoIi demon duri, cioe csiinaii, rorio riferendosi a |njcrnc
VIII, 82 sgg. (Maeslro, lu che vinci / lulle Ie cose, fuor che' demon
duri / ch'aII'enlrar deIIa orla inconlra uscinci). Iin daIIe rime
ballule neI canlo VIII, v. 92 (rovi, se sa.) i diavoIi sfidano Ia Iegge
divina con I'oorsi aI viaggio di Danle. NeI canlo IX deII'|njcrnc
Danle evoca, er bocca deI Messo, Ia discesa di Crislo agIi Inferi e
queIIa miloIogica di IrcoIe e Teseo: cxcnp|a bibIici e miloIogici, a
47 ACCHILLI, o. cil., . 14-16.
48 |njcrnc IX, v. 93. In |njcrnc VIII, v. 124 Danle usa Ia voce lracolanza: Quesla Ior
lracolanza non e nova.
49 || canic |X !c|||njcrnc, in Nuctc |ciiurc !anicscnc, voI. I, cil., . 240. Danle usa Ia
voce aggellivaIe in Para!isc XVI, v. 115: L'oIlracolanla schialla.
50 RecaIcilrare inlensifica iI semIice ca|ciirarc scrilluraIe.
51 |njcrnc IX, vv. 98-99.
|| canic |X !c||Inferno 411
conferma deIIa vaIidila degIi insegnamenli moraIi deIIa miloIogia
agana e deIIa necessaria inlegrazione deIIe due cuIlure.
Scene di diavoIi che si oongono aI viaggio neII'oIlremondo si
Ieggono con moIla frequenza neIIa Ielleralura medievaIe, cos neI
Purgaicric !i san Pairizic, dove iI eIIegrino lrionfa suIIe Ioro insidie
soIo grazie aIIa fede, ronunciando infalli iI nome di Crislo, come
neIIa Visic Tun!ga|i, Ia rima deIIe visioni deI XII secoIo, scrilla in
Ialino inlorno aI 1149 da un chierico irIandese. TundaIo, oslacoIalo
da diavoIi maIvagi e vioIenli, e coIlo da grande aura, ma I'angeIo
che Io accomagna riesce a conforlarIo e a vincere ogni difficoIla.
II rilrallo dei diavoIi danleschi dei canli VIII e IX si comIela nei
canli XXI e XXII deII'|njcrnc, dove Danle ne melle in scena Ia maIizia e
Ia crudeIla, I'imazienza e I'inquieludine, e sorallullo iI Ioro essere
ollusi bugiardi e lenlalori, allraverso un forle esressionismo di aro-
Ie e di gesli che cuImina con Ia zuffa lra AIichino e CaIcabrina, in
seguilo aIIa beffa di CiamoIo di Navarra. Le coie dei canli VIII-IX
e XXI-XXII sono accomunale daII'uso di melafore miIilari che negIi
uIlimi due canli sconfinano in una arodia deII'eico significaliva-
menle sconcia e voIgare.
AI v. 106 rirende Ia narrazione e comincia Ia seconda arle deI
canlo. Comiula Ia sua missione iI Messo scomare (Ioi si rivoIse
er Ia slrada Iorda). I due Ioeli enlrano neIIa Cilla di Dile che
ha I'asello di una cilla miIilare e agana. AgIi occhi di Danle si
resenla una dislesa ianeggianle iena di aveIIi, uno sconfinalo
cimilero, lanlo che gIi vengono in menle due famose necrooIi,
queIIa di ArIes, neIIa Irovenza e assai nola neI Medioevo, e queIIa
di IoIa
52
, con Ia differenza che e moIlo iu doIorosa Ia condizione
deIIe lombe rovenli deIIa Cilla di Dile, neIIe quaIi giacciono gIi ere-
lici: Ii eresiarche (iI IuraIe in -c e assai frequenle neII'ilaIiano
anlico), cioe i cai e i fondalori di selle ereliche. Le lombe sono iene
e sono iu o meno rovenli a seconda deIIa gravila deIIa coIa degIi
erelici che accoIgono. II canlo IX deII'|njcrnc si chiude con I'immagine
dei due Ioeli che camminano lra i seoIcri e Ie aIle mura deIIa Cilla
di Dile.
Le fiamme che avvoIgono Ie arche degIi erelici e ne cosliluiscono
Ia unizione (fiamme aIiene aI ari deIIa fiamma che Iambisce Ie
52 Ugo Zannoni fa nolare che rima di Danle Ia necrooIi di IoIa non era slala mai
ricordala in Ielleralura (|njcrnc |X, cil., . 296). Cfr. ure CAMILLO DI IRANCISCHI, Oanic
c Pc|a, Alli e Memorie deIIa Sociela Islriana di ArcheoIogia e Sloria alria, voI. XLIV,
1933, . 1 sgg., e IRANCISCO SIMI, || scggicrnc !i Oanic in |siria nc||ciic|rc !c| 1308,
Triesle, Tiografia G. Coana 1960.
Anna Cerbo 412
aIme dei iedi dei ai simoniaci in |nj. XIX) sono iI conlraasso
deI fuoco deIIa ragione che aIimenlo Ie eresie. Gia iI arlicoIare deIIe
meschile neI canlo VIII, v. 70 (ovvero Ie chiese, Ie moschee, con
aIIusione aI cuIlo ed aIIa vila dei musuImani)
53
, induce iI Iellore
a immaginare un aesaggio ooIalo da infedeIi. La voce meschile,
daII'arabo nasgni!, e I'aIlra meschine riferila a Iurie (IX, 43), daII'a-
rabo niskin che vaIe overo, schiavo, sono voci agane indicalive
e conformi aIIa cilla miIilare, dove scrive AIdo VaIIone Iagani
sono gIi abilanli. Iagani gIi usi, Ie reolenze, Ie audacie, gIi orgogIi.
Iagani e miIilari i simboIi
54
.
Sono slali oorlunamenle segnaIali aIcuni eIemenli comuni dei
canli VIII e IX deII'|njcrnc con || Ii|rc !c||a Sca|a. Inrico CeruIIi e doo
di Iui Maria Corli
55
hanno individualo aIcune corrisondenze lra
I'Inferno neI Ii|rc !c||a Sca|a e Ia Cilla di Dile neIIa Ccnc!ia.
La slrullura deII'Inferno deI leslo arabo e queIIa di una cilla forlifi-
cala, con sellanlamiIa casleIIi di fuoco, sellanlamiIa saIe anch'esse
di fuoco e selle orle (lres chaudes, ila caIidissime) allraverso Ie
quaIi vi si accede. Anche Ia Cilla di Dile deII'|njcrnc danlesco e una
forlezza, cilla vaIIala e cinla da mura di ferro infuocalo, ooIala
da un esercilo di diavoIi come neIIa illura e neII'immaginario medie-
vaIe, con Ie sue meschile (vermigIie come se di foco uscile /
fossero)
56
, e con un'aIla lorre.
Icco come sono descrille Ie orle deII'Inferno neI aragrafo 176 deI
Ii|rc !c||a Sca|a, neIIa lraduzione francese di onavenlura da Siena:
|.j Il devanl chasqune de Ies orles devanl dillz si a une granl
comagne deabIes el d'omes, qui sunl lormenlez en enfer. Il
Noslre Sire Diex fail chasqun iour venir ces deabIes el ces
homes ar devanl ceIIes orles, el Ies fail regarder Ies biens, qui
sunl en Iaradis el ar cesle monde. Il en ce qu'iI Ies regardenl,
si Ior redobIenl Ies oines.
Id ecco ancora come sono descrilli i casleIIi di fuoco neI aragrafo
177 deIIo slesso Ii|rc, semre neIIa lraduzione di onavenlura da
Siena:
53 Cfr. GIOVAN ATTISTA IILLIGRINI, G|i ara|isni nc||c |inguc ncc|aiinc ccn spccia|c ri-
guar!c a|||ia|ia, rescia, Iaideia Idilrice 1972, voI. I, . 98.
54 ALDO VALLONI, || canic |X !c|||njcrnc, in AA.VV., Nuctc |ciiurc !anicscnc, cil., I,
. 237-260: . 246.
55 MARIA CORTI, Ia Ccnnc!ia !i Oanic c |c|ircicn|a is|anicc, eIfagor, L, n. 3
(1995), . 301-314.
56 |njcrnc VIII, v. 72.
|| canic |X !c||Inferno 413
Il ar dehors ad chasqune de ceIx orles, dever Ia arl
seneslre, si sunl LXX miI monlagnes lolles de feu. Il en
chasqune de ces monlagnes sunl LXX miI fonlaines de feu, el de
chasqune de ces fonlaignes sordenl LXX miI fIuns de feu
ausinc. Il sor chasqun de ces fIuns si sunl LXX miI chasleaux de
feu. Il en chasqun de ces chasleaux LXX miI saIes de feu
57
.
Maria Corli ha individualo corrisondenze lra Ia Cilla di Dile
(Dile e uno dei nomi che Danle, seguendo VirgiIio, usa er Lucifero)
e I'na|iiaiic !qa|c|i neI aragrafo 150, Ia !incra !i Saiana nc| sciiinc
injcrnc, deI Ii|rc !c||a Sca|a. DaI confronlo dei lesli risaIlano Ie affinila
deIIe due slrullure:
I io: Maeslro, gia Ie sue meschile
Ia enlro cerle ne Ia vaIIe cerno,
vermigIie come se di jccc uscile
fossero. Id ei mi disse: II jccc ciicrnc
ch'enlro I'affoca Ie dimoslra rosse,
come lu vedi in queslo basso inferno.
Noi ur giugnemmo denlro a |a|ic jcssc
che ta||an queIIa lerra sconsoIala:
|c nura mi arean che jcrrc fosse.
(|njcrnc VIII, vv. 70-78)
Io vidi iu di miIIe in su Ie orle
daI cieI iovuli |.j.
(|njcrnc VIII, v. 82)
Ver' |a|ia icrrc a Ia cima rovenle
(|njcrnc IX, v. 36)
Ia condizion che laI jcriczza serra
(|njcrnc IX, v. 108)
assammo lra i marlri e Ii a|ii spa|!i.
(|njcrnc IX, v. 133)
Va||a quidem circa hoc casirun
exislencia omnia sunl Iena
veneno muIlarum manerierum
eciam diversarum, nam nuri,
iurrcs, ncnia el !cnus cnncs
casiri hu|usmodi sunl de ignc
vaIde nigro, qui ar!ci ccniinuc
in se iso
58
. Il ex una arle
caslri esl quedam pcria, er
quam vadil homo ad infernum
magnum.
(|| Ii|rc !c||a Sca|a, 150, lrad.
Ial.)
I dunque veramenle sessa e diversificala Ia slralificazione cuIluraIe
dei canli VIII e IX deII'|njcrnc danlesco, come Io e Ia Ioro slrullura
relorica e Iinguislica in cui si inseriscono forme di relicenza inusilale
57 La lraduzione in francese e in Ialino di onavenlura da Siena e riorlala da INRI-
CO CIRULLI neI suo voIume || Ii|rc !c||a Sca|a c |a qucsiicnc !c||c jcnii ara|c-spagnc|c
!c||a Oitina Ccnnc!ia, Roma, Cilla deI Valicano 1949, . 190.
58 Cfr. |njcrnc XXI, vv. 16-17 (laI, non er foco ma er divin'arle, / boIIa Ia giuso
una egoIa sessa.).
Anna Cerbo 414
neIIa rassi oelica, erifrasi, anlilesi, melafore e simiIiludini che
veicoIano verila leoIogiche e scrilluraIi, Ialinismi, arabismi e francesi-
smi, voci e immagini miIilari, esressioni forlemenle reaIisliche e
ooIaresche.
Unitcrsiia !cg|i Siu!i !i Napc|i IOricnia|c
ROIRTO MIRCURI
IL CANTO X DILL'!"#$%"&
Irima di affronlare Ia Iellura deI canlo X deII'!()*+(,, va riIevala
una serie di Iegami con iI canlo recedenle, neI quaIe Danle descrive
iI rorio ingresso neIIa cilla di Dile. La aroIa !"!#$%"&'! (!(). IX,
127), un -./.0 neII'idioIello danlesco, anlicia rosellicamenle iI
canlo successivo, iI IuraIe in I, aIicalo a un soslanlivo maschiIe, si
configura come un caIco, di evidenle soIennila Iinguislica, suI IuraIe
Ialino /,*1.*. Non soIo: iI Iessema rima con %"&'! (in rima ricca con
&%"&'!). Mi si consenla un *023+434 melodoIogico: non credo che ci si
ossa fermare aIIa semIice regislrazione dei fenomeni lesluaIi, ma
che si debba inlenderne di voIla in voIla iI senso e iI significalo: in
queslo caso, ci lroviamo di fronle non soIo a un -./.0, ma anche di
fronle a una %*5675893(: %"&'!)!"!#$%"&'!)&%"&'! (!(); IX, 125-129)
carica di aIIusivila in quanlo Ia rima, in queslo caso er di iu rima
ricca (ARCHI:eresiARCHI:cARCHI), raresenla aII'occhio e aII'o-
recchio Ia drammalica coincidenza fra eresia e lomba/morle.
NeI canlo IX regislriamo un aeIIo ai Iellori in cui Danle invila a
decifrare iI senso deI racconlo nascoslo dielro iI veIame de Ii versi
slrani, aIIo scoo, credo, di inquadrare I'inconlro con gIi erelici
neII'ambilo deI milo cIassico che in queslo modo viene a cosliluirsi
come aulorevoIe recedenle che anlicia in modo figuraIe Ia maleria
deI canlo X offrendone iI senso iu rofondo.
In queslo senso aaiono riIevanli aIcuni richiami:
a) I'accenno aIIa aura di Danle, dichiarala neI rimo verso di !(); IX
(QueI coIor che viIla di fuor mi inse) e denominala con iI lermine
lecnico di viIla, ooslo semanlico di nobiIla, gia usalo aII'inizio
deI viaggio (!(); II, 45 e III, 15), qui a ribadire, a ridosso deII'inconlro
con i magnanimi erelici e suerbi, Ia cifra deI viaggio danlesco con-
lrassegnalo daII'acquisizione rogressiva deIIa magnanimila senza
aIcuna lracolanle resuonenza,
b) iI ricordo deIIa discesa di VirgiIio in Inferno grazie aIIe arli magiche
Roberlo Mercuri 416
di Irilone (Lucano, <-.+4. VI, 508-27), a evidenziare iI araIIeIismo
Danle Inea in quanlo anche Ia guida deII'eroe lroiano, SibiIIa, ricor-
da, come VirgiIio, di essere slala una voIla neII'Ade,
c) i mili di Teseo e IrcoIe, quesl'uIlimo cilalo addirillura daI messo
ceIesle come vincilore di Cerbero e quindi come esemio di unizione
dei lracolanli ribeIIi aIIa voIonla divina, inseriscono iI viaggio danle-
sco neIIa iu aulorevoIe lradizione miloIogica e Ielleraria.
Ho avulo modo di soslenere
1
che soIo allraverso I'anaIisi deIIa
fonle cIassica e bibIica unilamenle aIIa reIaliva gIossa si uo ricoslrui-
re in modo esauslivo Ia slralegia deIIa risemanlizzazione danlesca, e
rorio er quanlo alliene ai ersonaggi di Teseo e IrcoIe, e iIIumi-
nanle iI commenlo di ernardo SiIveslre:
Dicilur Theseus divinus el bonus: lheos enim deus, eu bonus.
Ier hunc inleIIigimus ralionaIem el virluosum. Hic ad inferos
descendil secundum descensum virlulis. AIcides inlerrelalur
forlis el uIcher er quem raclicum acciimus qui gIoria re-
rum geslarum uIcher esl. Unde HercuIes quasi gIoria Iilis dici-
lur: her Iis, cIeos gIoria.
(ernardo SiIveslre, =,66*(136 43/*+ 4*0 857+,4 >*(*59,4, ed. cri-
lica a cura di }. e I. }ones, Nebraska 1977, . 56)
IrcoIe, dunque, raresenla I'azione e Teseo Ia razionaIila, i due
aggellivi +.15,(.854 e /+.215234 debbono aver indollo Danle a Ieggere
i due eroi come simboIi deIIa vila alliva e deIIa vila conlemIaliva,
concelli richiamali aIIe sogIie deI Iaradiso lerreslre neIIe ersone
di Lia e RacheIe, e vaIe Ia ena di solloIineare che sia aIIe sogIie
deI Iaradiso lerreslre, sia aIIe sogIie deIIa cilla di Dile e resenle Ia
figura di Iroserina, qui come regina deII'Ade, I come Irimavera
rima deI +./134. ConlesluaImenle Danle ricorda Io sconlro fra Ie
Irinni e Teseo, sconfillo e oi Iiberalo da IrcoIe, I'invocazione deIIe
Irinni a Medusa, una deIIe Gorgoni, richiama Ia figura di Ierseo che
riusc a neulraIizzare Io sguardo ielrificanle di Medusa lagIiandoIe
Ia lesla.
Danle dunque, come Ierseo, riesce a non farsi imelrare da Medu-
sa, Ia crilica idenlificazione con Ierseo connola Danle come I'inleI-
IelluaIe-oela che agisce in base aIIa saienza e aII'eIoquenza, daI
momenlo che Mercurio e Minerva, rolellori di Ierseo, significano
1 ROIRTO MIRCURI, ?*6.(152. 95 @*+5,(*A !8 6,15B, 9*8 B5.::5, (*88. C=,66*95.D 95
E.(1*, Roma, uIzoni 1984.
!8 2.(1, F 9*88GInferno 417
I'uno I'eIoquenza, I'aIlra Ia saienza:
Ier Ierseum vero virlus acciilur: Hic ausiIio IaIIadis sue soro-
ris el fralris sui Mercurii, id esl saienlie el eIoquenlie, lerciam
sororem necal
(ern. SiIveslre, =,66; 43/*+ 4*0 857; >*(;A cil., X, 5-7)
InoIlre, neI richiamare, aIIe sogIie deIIa cilla di Dile, Teseo e IrcoIe,
Danle aIIusivamenle slabiIisce una slrella anaIogia con Inea, iI quaIe,
aII'ingresso deII'Averno, evoca anch'egIi Teseo e IrcoIe (>*(. VI, 121-
122).
d) II messo ceIesle, iI quaIe definisce iI eccalo di eresia quaIifican-
doIo neI senso deIIa suerbia, aunlo I'!"#$%&!#%'(% rimroverala ai
diavoIi e che rilroveremo neI canlo successivo come eIemenlo conno-
lanle Iarinala e Guido CavaIcanli, ambedue disdegnosi:
O cacciali deI cieI, genle )*+,-##%
comincio eIIi in su I'orribiI sogIia
ond'esla !"#$%&!#%'(% in voi s'aIIella`
Ierche recaIcilrale a queIIa vogIia
a cui non uole iI fin mai esser mozzo,
e che iu voIle v'ha cresciula dogIia`
Che giova ne Ie fala dar di cozzo`
Cerbero *+#,"+- se ben vi ricorda,
ne orla ancor eIalo iI menlo e iI gozzo.
(!(); IX, 91-99)
La connolazione, inoIlre, di Cerbero allraverso iI ossessivo *+#,"+,
4*(-.8 di aarlenenza cuIluraIe, marca forlemenle I'oosizione
fede-aleismo/eicureismo e anlicia I'oosizione cuIluraIe e oelica
fra Danle e Guido CavaIcanli, non a caso definilo *+#,"+ da Danle
(!(). X, 63).
e) L'imrovvisa aarizione deI messo ien di )*+)-.'! (!(). IX, 88)
aIIude er conlraslo aI )*+)-.'! di Guido (!(). X, 63), menlre iI
disrezzo divino subilo dai dannali, genle )*+,-##%, aIIude a Iarina-
la iI quaIe moslra di avere I'inferno in gran )*+,*##! (!(). X, 36):
insomma neI canlo IX I'alleggiamenlo di disdegno e di Dio e deI mes-
so, neI canlo X e degIi erelici/eicurei.
f) I'anadiIosi deI Iessema .%",$"$ che daII'*0/85251 di !(). IX riecheg-
Roberlo Mercuri 418
gia neII'5(25/51 di !(). X con un'inlensificazione dala daI fallo che Ia
aroIa daI coro deI verso (!(). I, 133) baIza aIIa ribaIla deIIa rima (!().
X, 2), uIleriormenle evidenziala daI araIIeIismo chiaslico dei due ver-
si:
assammo lra i .%",$"$ e gIi %"#* +,%")*
Tra 'I 01$! de Ia lerra e Ii .%",$"$
g) Ia aroIa arca (!(). IX, 125, !(). X, 29) cosliluisce un Iegame
semanlico fra i due canli, essa indica Ie lombe infuocale neIIe quaIi
sono seoIli gIi erelici e viene usala in senso slranianle, in quanlo
neIIa lradizione bibIica iI lermine e Iegalo ai concelli di saIvezza (I'arca
di Noe H*7. XI, 7) e di giuslizia (un'arca cuslodisce Ie lavoIe di Mose,
E*31. X, 1 sgg.).
II canlo e carallerizzalo da un'ordilura lealraIe allenla aIIa rosse-
mica, aII'aIlernanza di rimi e secondi iani e aIIe enlrale e uscile
di scena, moduIale da un iniziaIe rogressivo incremenlo dei erso-
naggi, che divenlano quallro neIIa arle cenlraIe deI canlo, e da un
aIlrellanlo rogressivo decremenlo daIIa mela deI canlo aIIa fine in
cui agiscono, come neII'5(25/51, due soIi ersonaggi, Danle e VirgiIio.
II canlo melle a fuoco iI raorlo di Danle, da un Ialo, con iI 6585*3
inleIIelluaIe e Iellerario, raresenlalo daIIa fanlasmalica figura di
Guido CavaIcanli e, daII'aIlro, con queIIo oIilico di Iirenze, rare-
senlalo daIIa sanguigna e imonenle figura di Iarinala degIi Uberli.
L'5(25/51 deI canlo e coslruilo suIIa mislione di suggeslioni deIIa Ielle-
ralura cIassica e voIgare:
Ora sen va er un secrelo caIIe,
lra 'I muro de Ia lerra e Ii marliri,
Io mio maeslro, e io doo Ie saIIe.
(!(). X, 1-3)
Ier Ia slrullura formuIare Danle si rifa a runello Lalini (&+ 4* (* B. 58
6.*41+,, I*4,+*11, 2181-82, &+ B. 6.*41+,, I*4,+*11, 1183-84), menlre er
iI Iessico richiama VirgiIio (4*2+*15 2.88*4: >*(; VI, 443).
II riuso deII'esressione virgiIiana risuIla lanlo iu significalivo
se Io melliamo in raorlo con iI commenlo di ernardo SiIveslre,
er iI quaIe i 4*2+*15 2.88*4 sono Ie vie negalive allraverso Ie quaIi
si erviene aII'amore (2.88*4 viae. sunl vilia quibus ad amorem
venilur, e, infalli, iI lema deII'amore e solleso aII'inlero canlo, I'amor
alrio (Iarinala), I'amore alerno (CavaIcanle), I'amore Iirico, esres-
!8 2.(1, F 9*88GInferno 419
so anlifraslicamenle daI disdegno di Guido. In queslo senso indicalivo
iI riuso, con inlenlo aIIusivo, di rimanli liici di Guido (.%",$"$)/$"$)
e deIIa %*5675893(: &+.!)0+.!)12.! evocalrice deIIa canzone aver-
roisla E,((. 6* /+*:., incenlrala suI robIema deIIa nalura d'amore,
Ia oIemica con Guido si iscrive in queIIa conlro gIi alei eicurei e
maleriaIisli che I'anima coI coro morla fanno: neII'individuazione
deI eccalo e dei eccalori Danle marca Ia reIazione fra eicureismo e
morle allraverso iI araIIeIismo fra cimilero e seguaci, ai quaIi e
riferilo Io slesso aggellivo ossessivo: #2+ cimilero #2+$ seguaci.
II rimo inconlro e con Iarinala, iI quaIe aoslrofa Danle in nome
deIIa comune alria: O losco (v. 22), riconoscendogIi Ia quaIifica di
oela, e quindi I'aIlezza d'ingegno (v. 59) in quaIche modo negala,
oco doo, a Guido CavaIcanli, allraverso I'esressione arIando
oneslo (v. 23) denolaliva deI oela
2
. La soIennila deII'eisodio si
evince anche daIIa commislione di formuIe Iinguisliche liiche deIIa
lradizione cIassica e di queIIa bibIica: infalli, I'esressione Ia lua Io-
queIa li fa manifeslo e cilazione di J1 XXVI, 73 in cui Iielro rinnega
er Ia lerza voIla Crislo, Danle, aI conlrario, non si nasconde e riven-
dica con fierezza Ia sua aarlenenza oIilica (non gIieI ceIai ma
lullo gIieI'aersi v. 44), laIe alleggiamenlo di fiera coerenza viene
allribuilo anche a Iarinala, magnanimo er aver difeso Iirenze aI di
sora deIIa Iolla deIIe fazioni. L'affermazione di Iarinala di essere
slalo lroo .+1!#,+ (v. 27) aIIa sua alria richiama Ie aroIe di Dio
iI quaIe rimrovera aI ooIo di IsraeIe I'ingraliludine:
IouIe meus, quid feci libi` Aul quid .+1!#,2#
fui libi`
(J52-; VI, 3)
Su quesla base Danle suggerisce un'idenlificazione di se con Iarinala
aII'insegna deII'amore alrio, dalo che Ia formuIa di Michea era slala
usala neII'5(25/51 deIIa erdula eisloIa danlesca ai Iiorenlini e dalo
che Cacciaguida definisce Ia voce di Danle .+1!#,% er indicare Ia
quaIila rofelica deIIa sua oesia:
Che se Ia voce lua sara .+1!#,%
neI rimo guslo, vilaI nodrimenlo
Iascera oi, quando sara digesla
(<.+; XVII, 130-32)
2 Cfr. iI arIare oneslo (!(). I, 113) con cui ealrice chiama VirgiIio, delenlore,
aunlo, deIIa aroIa ornala (!(). II, 67) deIIa oesia.
Roberlo Mercuri 420
D'aIlro canlo, ad anliciazione deIIa caralura moraIe di Iarinala, egIi
era slalo nominalo insieme a Tegghiaio AIdobrandi degIi Adimari fra
gIi uomini degni che aI ben far uoser gIi ingegni (!(). VI, 79-81):
Ia rima 3!/0$)$0/!/0$ coincide con queIIa 3$#3!/0+)$0/!/0+ di !(). X,
59-63, forse a rimarcare I'indegnila di Guido: iI fallo che Guido non e
con Danle di fallo Io escIude da queII'%1,!44% 35$0/!/0+, aIIa quaIe si
rivoIge neII'iniziare iI viaggio, invocando insieme aIIe Muse aunlo
I'%1,+ $0/!/0+, !(). II, 7).
VirgiIio infonde coraggio a Danle invilandoIo a avvicinarsi a Iari-
nala e a arIargIi senza infingimenli o esilazioni :
Id eI mi disse: VoIgili! Che fai`
Vedi Ia Iarinala che s'e drillo:
da Ia cinloIa in su lullo 'I vedrai.
Io avea gia iI mio viso neI suo fillo,
ed eI s'ergea coI ello e con Ia fronle
com'avesse I'inferno a gran disillo.
I I'animose man deI duca e ronle
mi inser lra Ie seoIlure a Iui,
dicendo: Le aroIe lue sien conle
(vv. 31-39)
Conle ha una carica oIisemica che da un Ialo aIIude aIIa quaIila deI
dellalo di Danle, iI cui arIare oneslo, riconosciulo da Iarinala, de-
ve essere aII'aIlezza deIIa siluazione e, daII'aIlro, indica Ia voIonla di
chiarezza di Danle: infalli, Ia frase di VirgiIio lullo 'I vedrai (v. 33),
ricaIcala da Danle (lullo gIieI'aersi v. 44), indica I'offrirsi di Iarina-
la e Ia disonibiIila di Danle, a un confronlo a lullo camo dai loni
duri, ma senza omissioni o comromessi. Anche Ia rossemica riveIa
I'essenza dei ersonaggi: I'uscila daII'arca daIIa cinloIa in su (v. 33),
Io scambio di sguardi (io avea gia iI mio viso neI suo fillo v. 34),
I'ergersi di Iarinala coI ello e con Ia fronle (v. 35) sono lulli eIe-
menli che quaIificano iI magnanimo
3
.
L'inizio deI diaIogo e brucianle:
Com'io aI ie deIIa sua lomba fui,
guardommi un oco, e oi, quasi sdegnoso,
mi dimando: Chi fuor Ii maggior lui`
3 In queslo senso Iarinala sembra essere un'anliciazione che fa risaIlare Ia micro-
sicha dei ai simoniaci, che verranno raffigurali con Ie arli basse deI coro, aun-
lo daIIa cinloIa in giu, che fuoriescono dai fori (!(). XIX, 14), riduzione arodica deIIe
soIenni arche degIi erelici.
!8 2.(1, F 9*88GInferno 421
Io ch'era d'ubidir disideroso,
non gIieI ceIai, ma lullo gIieI'aersi,
Ond'ei Ievo Ie cigIia un oco in suso,
oi disse: Iieramenle furo avversi
a me e a miei rimi e a mia arle,
s che er due fiale Ii disersi.
S'ei fur cacciali, ei lornar d'ogne arle
risuosi Iui I'una e I'aIlra fiala,
ma i voslri non areser ben queII'arle.
(vv. 43-51)
L'avverbio fieramenle occua buona arle deII'endecasiIIabo con
accenlo di sesla (fieramenle) che esande iI suono nasaIe IabiaIe
(M) nei versi successivi: % 67 - % 6$ei ri68 - % 6$a arle e una
slrullura lricoIica Iegala da oIisindelo (I) con diIalazione neIIa
vocaIe A, con solloIinealura deII'oosizione fra Danle e Iarinala
medianle iI chiasmo .$!$ ,$*0*90%..*!$ ,2$, che riveIa Ia forle
conlraosizione dei due aggellivi ossessivi, indicalori di aarle-
nenza oIilico-cuIluraIe.
II diaIogo fra Iarinala e Danle viene inlerrollo da un'anima che
con falica emerge daII'orIo deIIa lomba, si lralla di CavaIcanle,
iI adre di Guido CavaIcanli.
L'inconlro con Guido CavaIcanli er inlerosla ersona, queIIa
deI adre CavaIcanle, cosliluisce I'occasione er deIineare un mo-
deIIo oelico e Iellerario ed esrimere una lioIogia deIIa cuIlura.
Danle, neII'inconlro con CavaIcanle, vuoIe definire Ia roria
eserienza oelica che, nala in Iirenze neII'ambienle sliInovislico
a slrello conlallo con Guido CavaIcanli, si era andala evoIvendo
in uno con Ie vicende oIiliche che Io avrebbero orlalo aII'esiIio
verso iI sueramenlo deIIo sliInovo, verso Ia formuIazione di una
oelica deI voIgare e verso Ia creazione di una oesia che lrava-
Iicasse i Iimili deI genere Iirico e ambisse a un resiro universaIe.
La resenza di CavaIcanle fra i seguaci di Iicuro ha Io scoo
di aIIudere aIIa figura umana e inleIIelluaIe deI figIio Guido, I'inconlro
con iI adre serve a unluaIizzare i raorli di Danle con Guido e con
cio che egIi raresenla. Si lralla dunque di un eisodio cifralo, co-
slruilo secondo un codice che dobbiamo sveIare arlendo da aIcune
sie che Danle usa er comunicare in modo crilico iI rorio mes-
saggio iercodificalo, iI quaIe aIIude aI gergo deIIa Iirica corlese, in
arlicoIare sliInovislica:
Roberlo Mercuri 422
AIIor surse a Ia visla scoerchiala
un'ombra, Iungo quesla, infino aI menlo:
credo che s'era in ginocchie Ievala.
Dinlorno mi guardo, come laIenlo
avesse di veder s'aIlri era meco,
e oi che 'I sosecciar fu lullo senlo,
iangendo disse: Se er queslo cieco
carcere vai er aIlezza d'ingegno,
mio figIio ov' e` e erche non e leco`.
I io a Iui: Da me slesso non vegno:
coIui ch'allende Ia, er qui mi mena
forse cui Guido voslro ebbe a disdegno.
Le sue aroIe e 'I modo de Ia ena
m'avean di coslui gia Iello iI 0+.!,
ero fu Ia risosla cos iena.
Di subilo drizzalo grido: :+.!`
dicesli eIIi ebbe` non viv'eIIi ancora`
non fiere Ii occhi suoi Io doIce 12.!`.
Quando s'accorse d'aIcuna dimora
ch'io facea dinanzi a Ia risosla,
suin ricadde e iu non arve fora.
(vv. 52-72)
L'uso deI Iessema visla er indicare I'aerlura deII'aveIIo e indi-
calivo deII'imorlanza, neI canlo, deIIa melafora visiva: e anche iI gio-
co degIi sguardi che carallerizza i ersonaggi, menlre Iarinala guarda
in modo inlenso (guardommi un oco v. 41) e Danle aIlrellanlo (io
avea gia iI viso mio neI suo fillo v. 35), CavaIcanle non guarda direl-
lamenle (dinlorno mi guardo) e con fare incerlo e imaurilo (so-
secciar), e menlre Iarinala arIa in modo deciso, CavaIcanle arIa
iangendo.
Tullo iI canlo e aII'insegna deI camo semanlico deIIa visla che
slrullura araIIeIismi e oosizioni: gIi erelici vedono come quei c'ha
maIa Iuce (v. 100), in anlilesi a ealrice iI cui beII'occhio lullo vede
(v. 131), simboIo deIIa erfella conoscenza di conlro aIIa conoscenza
imerfella degIi erelici. La slessa esressione non fiere Ii occhi suoi Io
doIce Iume` rimanda aIIa melafora deI ferimenlo d'amore liica deIIa
oesia di Guido, fondamenlaIe anche neI carleggio fra Danle e Guido.
L'esressione aIIude a una melafora di Iargo uso dai siciIiani agIi
sliInovisli, in cui Ia melafora deI ferimenlo e un caso arlicoIare deIIa
iu generaIe leoria neumaloIogica secondo Ia quaIe gIi occhi coslilui-
scono Ia via di assaggio degIi sirili. I cerlo che Guido, iI quaIe non e
!8 2.(1, F 9*88GInferno 423
coIilo daI doIce Iume e quindi non vede, e anlilesi sia di Danle, che
olra vedere iI doIce raggio di ealrice, sia di ealrice, che lullo
vede e che a sua voIla e anlilesi degIi erelici che vedono come quei
c'ha maIa Iuce (v. 100):
quando sarai dinanzi aI doIce raggio
di queIIa iI cui beII' occhio lullo vede,
da Iei sarai di lua vila iI vaggio.
(vv. 130-132)
L'oosizione fra I'uomo che e iIIuminalo e queIIo che non Io e,
fra iI saienle e Io sloIlo, e cenlraIe neIIa Scrillura, ad esemio
neIIG$228*45.41* (saienlis ocuIi in caile eius, sluIlus in lenebris am-
buIal, $228*; II, 14), er cui Danle, che e iIIuminalo daI doIce raggio,
e figura deI 4./5*(4A Guido, che non e iIIuminalo daI doIce Iume, e fi-
gura deIIo 4138134;
II limore di CavaIcanle che Guido non veda iI doIce Iume
esrime in forma crilica Ia sconfessione da arle di Danle di Guido
come caoscuoIa e cosliluisce una veIala reIica a Gianni AIfani (Io'
fa' 45 ch'enlri ne Ia menle a Guido / erch'egIi e soI coIui che vede
Amore) aIIo scoo di smanleIIare iI milo di Guido 8*.9*+ deIIo
sliInovo fiorenlino, oerazione che Danle esIicilera neI canlo XI deI
<3+:.1,+5,;
SuI molivo deI vedere amore viene inlessula neI carleggio degIi
sliInovisli una filla lrama di aIIusive bolle e risosle, c'e un sonello
assai significalivo in cui Guido si rivoIge a Danle (?* B*95 >6,+*A .44.5
15 /+5*:, E.(1*) erche si accerli che Lao non sia di queIIi che
simuIano Ia assione amorosa, cio che cosliluisce un segno di incrina-
lura aII'inlerno deI gruo, ricordiamo che Lao e Guido sono i
rolagonisli deI /8.K*+ danlesco @359,A 5G B,++*5A sonello recedenle a
queIIo in cui Guido allacca Danle aerlamenle e in modo aIquanlo
vioIenlo e deciso:
I' vegno 'I giorno a le 'nfinile voIle
e lrovoli ensar lroo viImenle:
moIlo mi doI deIIa genliI lua menle
e d'assai lue verlu che li son loIle.
SoIevanli siacer ersone moIle,
lullor fuggivi I'annoiosa genle,
di me arIavi s coraIemenle,
che lulle Ie lue rime ave ricoIle.
Or non ardisco, er Ia viI lua vila,
Roberlo Mercuri 424
far moslramenlo che lu' dir mi iaccia,
ne 'n guisa vegno a le, che lu mi veggi.
Se 'I resenle sonello sesso Ieggi,
Io sirilo noioso che li caccia
si arlira da I'anima inviIila .
Ora qui, I'inviIimenlo e ascrillo aIIa deviazione daI soIco cavaIcan-
liano (di me arIavi s coraIemenle / che lulle Ie lue rime ave ricoI-
le) e aI araIIeIo accoslarsi di Danle ad aIlre forme di saere e ad aIlri
ambienli cuIluraIi (ersone moIle, eslranee aI dominio d'amore e,
forse, ersonaggi deIIa vila oIilica e cuIluraIe, annoiosa genle, Ie
scuoIe de Ii reIigiosi e Ie disulazioni de Ii fiIosofanli di cui si arIa in
=B; II, XII, 7), lullo queslo e esresso allraverso I'affermazione che
Danle non riesce a vedere Guido. L'immagine di Guido che non vede
iI doIce Iume e una unluaIe risosla di Danle, un ribaIlamenlo
deII'accusa di indegnila a vedere: Guido, cioe, accusava Danle di non
essere iu in grado di vedere Iui, iI suo magislero di oela e quindi
Amore, e ora Danle accusa Guido di non essere in grado di vedere iI
doIce Iume, immagine er Danle deIIa nuova forma di Amore deI
lullo diversa da queIIa concezione essimislica, drammalica e ango-
sciosa di Guido.
Danle con I'immagine deI doIce Iume che non coIisce gIi occhi di
Guido vuoIe aIIudere aIIa concezione cavaIcanliana deII'amore come
oscurila
4
e dichiarare iI rorio dissenso daIIa concezione lragica e
essimislica che Guido ha deII'amore. L'oscurila, I'assenza di Iuce e,
infalli, Ia cifra cromalica deIIa oelica maleriaIislica
5
e drammalica di
Guido, basala su una raresenlazione deII'amore come un infIusso
emanalo non daI ianela Venere, ma da Marle, iI dio deI confIillo e
deIIa guerra:
In queIIa arle dove sla memora
rende suo slalo, 45 formalo, &+.!
diaffan da 12.!, d'una scurilale
Ia quaI da Marle vene, e fa demora,
eIII e crealo (ed ha sensalo 0+.!
(E,((. 6* /+*:., 15-19)
4 Nei versi 67 e 68 deIIa canzone E,((. 6* /+*:. I'amore e descrillo come rivo di
coIore (for di coIore) come essere diviso in quanlo accidenle, assiso neII'anima sensi-
liva (mezzo scuro) escIudenle Ia Iuce (Iuce rade).
5 L'amore (come si vede da E,((. 6* /+*:.) e er CavaIcanli fero, aIlero , e un
accidenle, non facoIla deII'anima inleIIelliva, ma quaIila deII'anima sensiliva, giusla Ie
leorie averroisle.
!8 2.(1, F 9*88GInferno 425
Inlro quesla melaforica si coIIoca anche Ia definizione deII'Inferno
come cieco carcere (vv. 58-59) richiamo, lanlo iu riIevanle in quan-
lo enfalizzalo daII'en|ambemenl, deII'esressione virgiIiana carcere
caeco (>*(. VI, 734). CavaIcanle arIa sia con Ie aroIe di VirgiIio, sia
con Ie aroIe deI figIio rielendo Ia %*5675893(: &+.!)0+.!)12.! di
E,((. 6* /+*:., iI manifeslo deII'eroloIogia cavaIcanliana incenlrala
suI dominio falaIe deIIe assioni suIIa ragione e suII'aarlenenza
deII'amore aIIa sfera sensiliva.
L'inconlro con CavaIcanle e esemIalo su queIIo fra Andromaca e
Inea con riresa unluaIe deI lessulo semanlico:
vivisne`
aul si Iux aIma recessil
Heclor ubi esl`
Non viv'eIIi ancora`
Non fiere Ii occhi suoi Io doIce Iume
Mio figIio ov'e`
Illore, essendo morlo, e rimaslo a Troia, iI suerbo IIion, e non ha
inlrareso con Inea iI viaggio verso I'umiIe IlaIia, dunque Inea:Illore
Danle:Guido, Ia morle e Ia suerbia sono allribuli di Guido, aun-
lo credulo morlo e comunque morlo in quanlo erelico e suerbo in
quanlo disdegnoso.
Come Illore iI quaIe, morlo a Troia, fa arle ormai deI assalo di
Inea, cos Guido fa arle deI assalo oelico di Danle, Illore non uo
arleciare aIIa coslruzione di Roma come Guido non uo arleciare
aIIa nuova oesia di Danle.
La risosla di Danle, che fa riferimenlo aI 3$#3!/0+ di Guido, e
slala oggello di innumerevoIi indagini e di svariale roosle secondo
Ie quaIi iI disdegno sarebbe riferilo er aIcuni a VirgiIio, er aIlri
a ealrice, er aIlri aI verbo menare, er aIlri ancora a Dio, da
arle mia, credo che Danle abbia comIicalo a beIIa osla Ia formuIa-
zione sinlallica er ollenere iI massimo di ambiguila e quindi di oIi-
semia. L'ambiguila e, in queslo caso, funzionaIe a indicare Ia comIes-
sila deI rifiulo di Guido, che riguarda sia VirgiIio in quanlo caoscuo-
Ia deII'*/,4, genere rifiulalo da Guido, sia ealrice in quanlo Guido
non oleva consenlire iI lrasferimenlo deII'amore corlese suI iano
deIIa lrascendenza, cio che er Guido comorlava I'asservimenlo deI-
Ia ragione aIIa leoIogia, sia iI viaggio sollo una guida aulorevoIe, con-
nolalo daI verbo .!0%"!, cio che Danle aveva leorizzalo neI =,(B5B5,,
in cui Cicerone e oezio erano indicali come sue guide.
Ier Danle I'idenlificazione deIIa donna :*(158* con Ia fiIosofia
comorla queIIa deII'amore er Io sludio che .!0% aIIa verila e aIIa
scienza, Ia slessa funzione di VirgiIio (er qui mi .!0%). II 3$#3!/0+
di Guido marca iI rifiulo di queslo raorlo d'amore fra I'anima e Ia
Roberlo Mercuri 426
saienza:
Dico: >6,+A 2-* (* 8. 6*(1* 65 +.:5,(.; Ier amore inlendo Io
sludio Io quaIe io mellea er acquislare I'amore di quesla
donna |.j uno sludio Io quaIe .!0% I'uomo a I'abilo de I'arle e
de Ia scienza |.j che, si come sora si dice, IiIosofia e quando
I'anima e Ia saienza sono falle amiche, si che I'una sia lulla
amala da I'aIlra.
(=B; III, XII, 2 e 4)
CavaIcanli, aI conlrario di Danle che riconosce come sue guide neI
=,(B5B5, oezio e Cicerone e neIIa =,66*95. VirgiIio e ealrice, di-
chiara che Ie sue .321,+51.1*4 sono i Iibri d'Amore escIudendo quindi
ogni forma di oesia che non fosse queIIa Iirica, e in queslo senso iI
disdegno nei confronli di VirgiIio e anche iI rifiulo deII'*/,4L
Canzon, lu sai che )-2 "*3$* )240!$-
*! #2%+-0,"%* quando madonna vidi
|.j
Iero Ii .!0% er fidala via
e oi Ie di', quando Ie se' resenle:
Quesli sono in figura
d'un che si more sbigollilamenle;
(!, (,( /*(4.B.A vv. 43-44 e 53-56)
In CavaIcanli, a differenza di Danle, I'azione deI .!0%"! orla aIIa
morle:
6!0%".$ loslo, sanza riosanza,
in una arle Ia 'vi lrovai genle
che ciascun si doIeva d'Amor forle.
Quando mi vider, lulli con ielanza
dissermi: Iallo se' di laI servenle,
che mai non dei serare aIlro che morle
(M5 65*5 ),88G,22-5, vv. 9-14)
Vorrei, a queslo unlo, risondere a una domanda di IagIiaro,
rimasla lullora senza risosla, iI quaIe si chiedeva erche VirgiIio dice
ebbe a disdegno e non ha a disdegno: credo che Danle, non
olendo coIIocare Guido in Inferno erche ancora vivo neI 1300, con iI
assalo remolo abbia voIulo segnaIare una sceIla senza ossibiIila di
riensamenli e di riscallo (iI assalo remolo indica un'azione unlua-
!8 2.(1, F 9*88GInferno 427
Ie neI assalo) e quindi I'ineIullabiIe deslino di dannazione deI ri-
mo amico.
NeII'inconlro con CavaIcanle, Danle menziona iI figIio come
Guido 5!+#$!. L'esressione, oIlre a denolare iI lreidanle amore
alerno, ha una vaIenza arlicoIare che deriva daIIa dislinzione
agosliniana e medioevaIe in base aIIa quaIe gIi scrillori '!+#$* sono i
crisliani e 5-+#$* sono i agani, essa indica I'aarlenenza di Guido
a un aIlro versanle deIIa cuIlura, queIIa dei maleriaIisli, degIi erelici
e dei seguaci di Iicuro. Iure c'era slalo un lemo in cui Guido era
slalo '!+#$!A in cui cioe Danle si comiaceva deIIa sua amicizia e
viveva con Iui in un sodaIizio che lullo fa ensare dovesse essere
aIquanlo slrello:
Guido, i' vorrei che #1 - 6%,! -) *!
fossimo resi er incanlamenlo
e messi in un vaseI, ch' ad ogni venlo
er mare andasse aI voIer 5!+#$! - 0*!,
si che forluna od aIlro lemo rio
non ci olesse dare imedimenlo,
anzi, vivendo semre in un laIenlo,
di slare insieme crescesse 'I disio.
I monna Vanna e manna Lagia oi
con queIIa ch'e suI numer de Ie lrenla
con noi onesse iI buono incanlalore:
e quivi ragionar semre d'amore,
e ciascuna di Ior fosse conlenla,
si come i' credo che saremmo '!*.
(@359,A 5G B,++*5, vv. 1-14)
In queslo sonello Danle ceIebra Ia 4,9.851.4 di una convenlicoIa
oelica fondala suI lema deII'amore, carallerizzala da un idenlico
obiellivo (vivendo semre in un laIenlo), daI desiderio inleIIelluaIe
(di slare insieme crescesse 'I disio), eIemenli rori di un gruo
cuIluraIe e oelico. II sonello inizia con iI nome @359, e lermina con iI
ronome '!*N lu e Lao e io equivaIe a '!*N voIer voslro e mio
equivaIe a '!+#$!N iI '!* aIIa fine deI sonello suggeIIa quesla comosi-
zione, che e una ceIebrazione deI gruo oelico comoslo da Danle,
Lao e Guido: in queslo momenlo Guido e '!+#$!;
Ioi, doo Ia svoIla fiIosofica, inizia iI dislacco da Guido, nominalo
soIo due voIle neI E* B38:.+5 *8,O3*(15.A ormai coro eslraneo
aII'alluaIe eIaborazione oelica di Danle.
A queslo unlo, rienlra in scena Iarinala, carallerizzalo in modo
Roberlo Mercuri 428
ooslo a CavaIcanle:
6% queII'aIlro magnanimo a cui osla
reslalo m'era, non mulo asello,
ne mosse coIIo, ne iego sua cosla,
(vv. 73-75)
L'avversaliva .% ha un vaIore fonico di eco roIellica deI lermi-
ne magnanimo, ribadila daIIa sinaIefe: 6< queII'aIlro 6<gnani-
6o < cui osla. L'alleggiamenlo di resa di CavaIcanle, descrilla con
952,8,( (suin ricadde e iu non arve fora v. 72), conlrasla con Ia
fierezza di Iarinala, denolala da un 1+52,8,( (non mulo asello, ne
mosse coIIo, ne iego sua cosla), e forse Danle qui gioca con i numeri
se iI 2 e numero diaboIico deII'imerfezione e iI 3 numero divino deIIa
erfezione.
II fallo di avere sceIlo a rolagonisli deI canlo degIi eicurei un
gueIfo e un ghibeIIino, menlre Ia 2,663(54 ,/5(5, medioevaIe rileneva
i ghibeIIini 1,31 2,3+1 eicurei, dimoslra uIleriormenle che Danle ha
sceIlo, doo I'esiIio, una osizione 43/*+ /.+1*4 come verra solloIinealo
da Cacciaguida: s ch'a le fia beIIo /averli falla arle er le slesso
(<.+. XVII, vv. 68-69).
DaIIa risosla di Danle lrasare una cerla soIidariela con Iarinala,
iI quaIe gIi aveva domandalo iI molivo deIIa sielala avversione dei
fiorenlini nei confronli deIIa sua casala, Danle risonde che Ie Ieggi
che si fanno a Iirenze conlro gIi Uberli sono iI frullo deIIa ballagIia di
Monlaerli, ero riconoscendo, conlesluaImenle, che Iarinala e slalo
iI soIo a difendere Iirenze daIIa relesa degIi aIlri ghibeIIini di mellere
a ferro e fuoco Ia cilla, I'esressione difesa a viso aerlo (v. 93)
significa con Ia ceIala deII'eImo soIIevala, cio che fa resuorre neI
ghibeIIino inlenli di acificazione, cio che Io orlerebbe vicino a
Danle, leorico deIIa /.0 universaIe sollo Ia guida deII'Imero. InoIlre,
I'esressione laIi orazion fa far neI noslro lemio (v. 87) e forlemen-
le arodica e ironica erche quaIificare come orazioni Ieggi inique
e chiamare lemio Iirenze, una cilla rofondamenle corrolla, imIi-
ca soIidariela con Iarinala, iI quaIe, rima di congedarsi, indica lre
anime, iI cardinaIe Ollaviano degIi UbaIdini, iI aa Anaslasio II e
Iederico II, quindi aIli esonenli deIIa Chiesa e deII'Imero, a ribadire
Ia soIennila oIilica deI canlo.
In chiusura, vengono aIIa ribaIla i lemi deIIa oesia, lrallali
neII'inconlro con CavaIcanle:
a) VirgiIio viene denominalo anlico / oela (vv. 121-122), aeI-
Ialivo in riIievo erche in en|ambemenl, a ribadire iI resligio deI oe-
!8 2.(1, F 9*88GInferno 429
la che moslro cio che olea Ia Iingua noslra (<3+:. VII, 17) e Io slrel-
lo Iegame fra Ia Ielleralura Ialina e queIIa voIgare,
b) iI molivo deIIa visla, che conlraone in modo slridenle gIi ere-
lici che vedono come quei c'ha maIa Iuce
6
(v. 100) a ealrice iI cui
beII'occhio #1##! 5-)- (v. 131 vs #1##% 0!$#% / fia noslra conoscenza
vv. 106-107) e che sara Ia soIa in grado di sveIare a Danle iI suo desli-
no (di lua vila iI *$%//$+, v. 132).
AIIa fine deI canlo, dunque, rilroviamo gIi oggelli deI disdegno
di Guido: VirgiIio, ealrice e iI viaggio.
P(5B*+451Q 9*:85 ?1395 95 %,6. CM. ?./5*(K.D
6 L'esressione maIa Iuce e robabiImenle un anagramma arodico deIIo sliIema
virgiIiano aIma Iux (aIma/maIa).
ORTOLO MARTINILLI
IL CANTO XI DILL'|N|||NO
1. UNA QUISTIONI D'AVVIO
Coslrello neI Iello di Irocusle come canlo di inlerosizione lra due
eisodi narralivi, queIIo degIi eresiarchi con iI canlo decimo, e queIIo
dei Cenlauri con iI canlo dodicesimo, iI canlo XI deII'|njcrnc non
sembra aver lrovalo in genere una convincenle Iinea inlerrelaliva,
una coIIocazione non soIo arlislica, ma anche menlaIe, neII'orizzonle
deIIa crilica
1
. Come caso anaIogo si ricorda iI canlo XVII deI Purgaicric,
incenlralo suI lema agosliniano deII'amore, da cui diendono iI ecca-
lo e Ia virlu, iI demerilo e iI merilo, e iI canlo II deI Para!isc suIIa
lrallazione deIIe macchie Iunari, o aIlri canli di sislemazione dollri-
naria come iI canlo XIX ancora deI Para!isc.
DaI unlo di visla slrulluraIe e narralivo iI canlo XI deIIa rima
canlica si aoggia su indicalori ben visibiIi, che ne delerminano
1 SuI canlo XI deII'|njcrnc si vedano Ie seguenli Ieclurae e sludi: GIOVANNI
USNILLI, I|iica Niccnacnca c |cr!inancnic ncra|c !c|||njcrnc !i Oanic, oIogna,
ZanicheIIi 1901, || canic X| !c|||njcrnc |ciic !a GIOVANNI ROSADI, Iirenze, Sansoni 1905,
RUNO NARDI, || canic X| !c|||njcrnc, in Iciiurc Oanicscnc, a cura di Giovanni Gello, I,
|njcrnc, Iirenze, Sansoni 1965, . 191-207, ANTONINO IAGLIARO, Ic irc !ispcsizicn.,
in ID., U|issc. |iccrcnc scnaniicnc su||a Oitina Ccnnc!ia, Messina-Iirenze, D'Anna
1966-67, I, . 225-252, GILLIS G. MIISIRMAN, || canic X| !c|||njcrnc, in Nuctc Iciiurc
Oanicscnc, Iirenze, Le Monnier 1966-1976, II, 1968, . 1-16, ALIRID A. TRIOLO, Maiia
|csiia|iia in Oanic |njcrnc. Tnccrq an! |nagc, Tradilio, Nev York, 24 (1968), . 247-
292, IRANCISCO MAZZONI, || canic X| !c|||njcrnc, in Icciura Oaniis Ncapc|iiana, NaoIi,
Liguori 1986, I, . 167-209, IAUSTO MONTANARI, || canic X| !c|||njcrnc, in Icciura
Oaniis Sca|igcra, Iirenze, Le Monnier 1967, I, . 369-385, GIACINTO GRASSI, || canic X|
!c|||njcrnc, in Icciura Oaniis |nicrnazicna|c, |njcrnc, MiIano, Marzorali 1963, . 93-114,
CISARI VASOLI, || canic X| !c|||njcrnc, AL (L'AIighieri) 33 (1992), 2, . 3-22,
CORRADO CALINDA, Iciiura !i |njcrnc X|, IiIoIogia e crilica, XX (1995), 2-3, . 217-
245, TULLIO SANTILLI, |njcrnc, canic X|, AL, n. s., 38 (1997), . 51-72, STINO VAZZA-
NA, Octc |a naiia |csiia|iia!c (Anccra su||a siruiiura arisicic|ica !c|||njcrnc), AL, n. s.,
38, (1997), . 95-108, MARC COGAN, Tnc Ocsign in inc Vax. Tnc Siruciurc cj inc Oitinc
Ccnc!q an! iis Mcaning, Nolre Dame-London, Nolre Dame Universily Iress 1999,
ZYGMUNT ARANSKI, Canic X|, in Icciura Oaniis Turiccnsis, Iirenze, I. Cesali 2000, I, .
153-166.
orloIo MarlineIIi 432
I'aggancio aI canlo che recede e aI canlo che segue: iI molivo e queIIo
deIIa necessila di avvicinarsi e affacciarsi aIIa ruina (XII, 4), aI di Ia
e aI di sollo deIIa quaIe si are iI baralro infernaIe, molivo anlici-
alo sollo aIlra forma rorio aII'inizio deI canlo XI (su I'eslremila
d'un'aIla ria, ammorbala daI uzzo che 'I rofondo abisso gilla,
vv. 1-5), e rireso doo Ia sosla medilaliva, aIIa fine deIIo slesso canlo
XI, con Ia menzione deI baIzo ('I baIzo via Ia oIlra si dismonla, v.
115), a cui si aggancia Ia riresa narraliva deI canlo XII, che cosliluisce
ercio anche I'avvio deIIa discesa. II canlo XI, ur consideralo, aI mo-
do dei relori, come una forma di !igrcssic, raresenla un necessario
unlo di snodo deIIa calena narraliva.
II canlo X si era chiuso, oIlre che con I'indicazione deII'abisso,
anche con Ia gIossa di VirgiIio rivoIla a Danle, doo Ie rofezie di
Ciacco (VI) e di Iarinala (X, 127-132), riguardo aIIe chiose reIalive
aI suo deslino lerreno che ealrice, iu avanli neI corso deIIa narra-
zione, avrebbe dovulo fornirgIi. II molivo e riIevanle, erche cosli-
luisce, da una arle, un eIemenlo di riIancio e di sguardo in avanli
enlro iI quadro deI sislema narralivo, e, daII'aIlra, una chiara allesla-
zione deI mulamenlo deI iano che inlerverra successivamenle, in
corso d'oera.
Ier comrendere megIio Ia osizione deI robIema, anche in
ordine aI canlo XI che sliamo indagando, conviene soffermarci suIIa
slrullura e andamenlo dei canli che recedono, I-X: iI rimo riIievo
riguarda Ia coslruzione daIIa narrazione reIaliva aIIa serie deIIe scene
e dei eccalori: sono sliali in ochi canli, rescindendo daI Iimbo, sei
gironi infernaIi, menlre neI seguilo deIIa narrazione dovranno Iausi-
biImenle lrovare oslo aIlri lre gironi, ogni canlo comrende un
gruo di anime, ma non cos sara oi neI Purgaicric e neI Para!isc. I
dunque: che cosa aveva esallamenle in menle Danle aII'inizio` Come
doveva essere disosla Ia successione deIIa maleria, in ordine aIIa
lioIogia e aI numero dei ersonaggi` QueIIo che aare cerlo e che
doo iI canlo X deII'|njcrnc si manliene ferma in genere Ia coIIocazione
dei vari lii di eccalo e di eccalori enlro I'unila comosiliva e narra-
liva di un soIo canlo, moIliIicando ero di conseguenza Ia slessa
effigie deI eccalo e dei eccalori, e iI voIlo deI eccalo, darima
univoco, secondo Ia cIassificazione dei tiiia capiia|ia, si Iurifica e si
moIliIica quindi anche Ia raresenlazione deI voIlo deII'umano. II
mulamenlo deI iano si rende evidenle allraverso I'abbandono deI
uro schemalismo dei vizi cailaIi e I'adozione invece deI sislema
facenle cao aII'|iica a Niccnacc di ArisloleIe.
II secondo riIievo riguarda iI 'modeIIo' dei canli III-X deII'|njcrnc:
esso risecchia chiaramenle ancora, e erfino escIusivamenle, I'im-
|| canic X| !c||Inferno 433
ianlo deII'Ade cIassico, in arlicoIare virgiIiano, come imilazione ed
emuIazione deIIa narrazione deIIa sua guida e maeslro, VirgiIio. La
loografia deII'aIdiIa e Ie figure evocale, a fare da riferimenlo e da
cornice, fino aI arlicoIare deIIa cilla di Dile e deI suo ingresso, sono
lulle di ascendenle virgiIiano, deII'|nci!c. I vero che iI sislema ideoIo-
gico, I'imianlo dollrinario, con aI cenlro I'immagine deIIa giuslizia
divina, e reciuamenle bibIico e crisliano, ma aIcuni unli saIdi deIIa
narrazione: Caronle lraghellarore deIIe anime, Minosse giudice, Cer-
bero cuslode deIIe anime, IIegias in vesle di nocchiero, Ia coIIocazione
deIIa cilla di Dile, sono lulli di derivazione cIassica.
II lerzo riIievo rende Io sunlo daIIa sequenza e daIIa scena dei
canli I e II deII'|njcrnc: iI I canlo sembra isiralo ad un'idea deII'aIIe-
goria ancora lulla dei oeli, aIIa maniera deI |cnan !c |a rcsc: Ia
seIva, iI coIIe, Ia vaIIe, Ie lre fiere, ma neIIa scena irrome VirgiIio, che
ersonaggio aIIegorico non e, neI canlo II Ia forma deIIa raresenla-
zione, con Ia resenza di VirgiIio e di ealrice, divenla queIIa deI
simboIismo lioIogico e deI reaIismo figuraIe, che da coro e melle in
scena non mere aslrazioni, ma ersonaggi slorici. NeI assaggio daI
canlo I aI canlo II si are iI vero sazio narralivo deIIa Ccnnc!ia, che
si avvarra d'ora in avanli sorallullo deI simboIismo lioIogico
2
.
In reaIla, se ben si riguarda, anche Ia fondazione aIIegorica aIica-
la aIIo scenario deI canlo I, obbedisce ad una modaIila narraliva
che aIIegorica non e: Ia seIva, Ia vaIIe, iI coIIe cosliluiscono lre grandi
arcimelafore con Ie quaIi neIIa cuIlura si raresenla in genere
I'esislenza e delerminano un comIesso figuralivo di nello ascendenle
simboIico, Ie lre fiere sono di derivazione bibIica: Ia sequenza dei lre
animaIi e riresa da Geremia
3
, non senza ero una quaIche remini-
scenza deIIa rima visione di DanieIe
4
, e iI !csignaiun, o megIio iI
2 L'osservazione e slala formuIala da MICHILANGILO IICONI, Iintcnzicnc !anicsca
!c|||njcrnc, in || pcnsicrc ji|cscjicc c icc|cgicc !i Oanic A|gnicri, a cura di AIessandro Ghi-
saIberli, MiIano, Vila e Iensiero 2001, . 3-20: 5-9.
SuI robIema deIIa genesi dei rimi canli deIIa Ccnnc!ia, e non soIo deI robIema
deII'aIIegoria, si veda iI noslro, Gcncsi !c||a Ccnnc!ia. |a sc|ta c i| tc|irc, Sludi Danle-
schi, LXXIV (2009), . 1-48.
3 |cr. 5, 5-6. La raresenlazione dei lre animaIi cosliluisce un lrallo fondamenlaIe
di quesla visione di Geremia, ma neI reerlorio deIIe minialure medioevaIi, allingibiIe
on Iine, allraverso iI calaIogo dei manoscrilli deIIe rinciaIi bibIioleche euroee e sla-
lunilensi, Ia serie dei lre animaIi e deI lullo assenle. Danle, er conlro, ne ha avverlilo
lulla Ia orlala suI iano deII'immagine e deIIa narrazione e ne ha fallo uno dei lralli
figuralivi e 'figuraIi' iu esemIari neIIa coslruzione deI oema sacro.
4 Oan. 7, 1-12, 15-28. NeIIa visione, che ha carallere slorico-oIilico e rofelico, Da-
nieIe vede sorgere daI mare quallro beslie lerrificanli, che cosliluiscono aIlrellanle
minacce: una Ieonessa con Ie aIi, un orso, un Ieoardo, una beslia con dieci corna. Ier iI
significalo deIIa visione si veda, in arlicoIare, IIIOLITO, Su Crisic c |Aniicrisic, 20, 1-25,
orloIo MarlineIIi 434
figuralo, e di origine giovannea, in quanlo i lre animaIi aIIudono chia-
ramenle aIIa lriarlizione deI eccalo secondo San Giovanni
5
, una
dislinzione assoIulamenle loica neI medioevo. A quesle indicazioni
si deve aggiungere anche I'accusa a Danle d'aver seguilo Ie sirene,
romossa da ealrice neI canlo XXXI deI Purgaicric: ora Ie lre sirene
sono iI simboIo di una lricolomia eccaminosa e recisamenle di
atariiia, iacianiia, |uxuria.
Un riIievo arlicoIare merila lullavia quanlo si Iegge in un asso
deIIa Viia !i |ursa, Iursa e aIIe rese con i demoni che Io vogIiono
ghermire e a queslo unlo inlerviene un angeIo in sua difesa. Queslo
iI asso:
AIIora I'angeIo sanlo che gIi slava a deslra disse: Guarda iI
mondo!. II sanlo guardo e vide sollo di Iui una vaIIe di lenebre
giu in basso e I ure neII'aria quallro fuochi dislanli un cerlo
sazio da Iui. L'angeIo disse di nuovo: Che sono quesli
fuochi`. L'uomo di Dio risose di non saerIo. I I'angeIo:
Sono i quallro fuochi che bruciano iI mondo |.j Accendono iI
fuoco deIIa menzogna rinnegando Ie romesse falle. II secondo
e iI fuoco deIIa cuidigia |.j II lerzo e iI fuoco deIIa discordia
|.j II quarlo e iI fuoco deIIa durezza di cuore
6
.
La scena e loica in ambilo visionario, ma iI arlicoIare deIIa vaIIe
lenebrosa e dei quallro fuochi che simboIeggiano aIlrellanli eccali
non uo non suggerire una quaIche allinenza con Ia scena danlesca
deI canlo I deII'|njcrnc, lanlo iu che essa viene riroosla laI quaIe a
roosilo di Iursa neIIa Icgcn!a aurca di }acoo da Varazze
7
.
La Ccnnc!ia resenla oi due lralli araIIeIi, ma anlilelici,
disIocali risellivamenle neI canlo I deII'|njcrnc e neI canlo XXXIII
deI Para!isc: neI canlo I deII'|njcrnc I'eserienza deII'inconlro con
Ie lre fiere si riroone con i suoi effelli anche aI momenlo deIIa scril-
3, in IAniicrisic, voI. I, || ncnicc !ci icnpi jina|i, a cura di Gian Luca Iolesla e Marco
Rizzi, MiIano, Iondazione Lorenzo VaIIa-ArnoIdo Mondadori Idilore 2005, . 135-141.
5 Si quis diIigil mundum, non esl carilas Ialris in eo, quoniam omne quod esl in
mundo concuiscenlia carnis esl el concuiscenlia ocuIorum el suerbia vilae, 1 |cn 2,
15-16. Su quesla lriarlizione deI eccalo rinvio reciuo e a Sanl'Agoslino, che cos
gIossa: in concuiscenlia carnis voIulas esl, in concuiscenlia ocuIorum curiosilas esl,
in ambilione saecuIi suerbia esl: (SANT'AGOSTINO, Scrnc 313A) e connelle oi lulla Ia
serie e fenomenoIogia dei eccali aIIa lriIice formuIazione giovannea.
6 Viia !i San |ursa, 8, in Visicni !c||a|!i|a in ccci!cnic. |cnii nc!c||i icsii, a cura di
Maria Iia Ciccarese, Iirenze, Nardini edilore 1987, . 190-224: 201-203.
7 }ACOIO DA VARAZZI, Icgcn!a aurca, ca. 144, San |urscc tcscctc, ediz. a cura di
AIessandro e Lucella VilaIe rovarone, Torino, Iinaudi 1995, . 790-792: 792.
|| canic X| !c||Inferno 435
lura, er cui iI oela aII'allo deIIa scrillura lorna a serimenlare
I'angoscia e Ia aura deI giorno in cui si era 'smarrilo' neIIa 'seIva',
neI canlo XXXIII deI Para!isc, doo aver serimenlalo con Ia visione
finaIe una gioia ineffabiIe, aI momenlo deIIa scrillura Danle lorna a
riroorre come alluaIe I'effello di queII'eserienza e iI oela senle
ancora disliIIare neI cuore iI doIce che nacque da essa (Par. XXXIII,
62-63). Ora, Ia scena deI canlo XXXIII deI Iara!isc, con I'eserienza di
aIIora e I'eserienza deIIa fase deIIa scrillura, non e er nuIIa una
raresenlazione aIIegorica: iI oela, subIimalo daIIa grazia, in un
allimo d'elernila uo scrulare Ia divina essenza e ci da una raresen-
lazione simboIica deIIa Trinila, in forma di lre cerchi di uguaIe
dimensione e lra Ioro unili (iI regislro e queIIo deIIa leoIogia mislica e
simboIica deIIo Iseudo-Dionigi), e di queII'allimo ci viene riroosla
Ia doIcezza che Io aveva accomagnalo. In erfella anaIogia con iI
canlo XXXIII deI Para!isc, iI canlo I deII'|njcrnc non ha affallo uno
slalulo aIIegorico, erche iI suo disegno organizzalivo e in forma di
grande scenario naluraIislico: Ia seIva, Ia vaIIe, i lre animaIi, iI coIIe
iIIuminalo, a cui si aggiunge I'inserimenlo deI ersonaggio di VirgiIio,
comongono una scena di carallere archeliico e simboIico e rimodu-
Iano, in figura, iI lema deIIa cadula dei rogenilori deII'umanila.
Con iI II canlo deII'|njcrnc si giuslifica, oi, in ieno I'assunzione
deI 'modeIIo' di raresenlazione in 'figura' di falli, evenli, erso-
naggi, 'modeIIo' che viene ercio slesso lrasoslo anche aII'area di
derivazione cIassica, in quanlo e Ia cornice ideoIogica che delermina Ia
significanza, e non Ia semIice molivazione deII'assunzione di eIe-
menli di derivazione cIassica. La nuova esigenza, gia alluala nei rimi
canli deII'|njcrnc, si disiega sorallullo a arlire daI canlo X, che are
con iI canlo XI una diversa fase deIIa raresenlazione deII'aIdiIa.
II dislacco lra Ia rima sezione deII'|njcrnc e Ia II sezione e dovulo
aII'inlerosizione degIi erelici, un eccalo dollrinario deI lullo ignolo
aIIa cuIlura cIassica
8
. Con iI canlo X si enlra iu decisamenle neIIa
raresenlazione deII'Ade ncrc cnrisiianc, romossa iniziaImenle suI-
Ia scorla deII'|nci!c virgiIiana, come lraccia narraliva, ed ora suIIa
scorla deII'|iica Niccnacnca di ArisloleIe, come una sorla di chiave
ermeneulica, che riguarda iI disosilivo moraIe deIIa maleria e, er
8 Danle resenla searalo iI eccalo di eresia, ma avrebbe dovulo coIIocarIo lra i
eccali conlro Dio, o megIio conlro Ia divina saienza. Tra quesli eccali, doo
I'idoIalria e iI aganesimo, AIessando di HaIes resenla infalli I'eresia, Io scisma,
I'aoslasia (ALISSANDO DI HALIS, Sunna Tncc|cgica, l. III, Iars II secundi Iibri, lracl. 8,
seclio I: lil. 1, Oc i!c|airia, lil. 3, Oc nacrcsi, lil. 4, Oc scnisnaic, lil. 5, Oc apcsiasia, Ad CIa-
ras Aquas, Ty. CoIIegii Sancli onavenlurae 1924, . 73a-752b.). II eccalo di eresia
figura lra i eccali conlro Dio anche in San Tommaso (Sunna Tncc|cgiac, I-II
ae
, q. 72, a.
4, resondeo).
orloIo MarlineIIi 436
cerli aselli, anche Ie ragioni archilelloniche.
2. UN CANTO DI SVOLTA
Ma quaI e aIIora iI ruoIo e iI significalo deI canlo XI, che resla ur
semre, suI iano deIIa narrazione, un canlo di assaggio, di sosla`
Isso e rima di lullo un canlo dollrinario, condollo aIIa maniera
scoIaslica, con Ie siegazioni deI maeslro e Ie domande e i dubbi deI
disceoIo. L'immissione di un aulore di riferimenlo neI comIesso
idealivo ed eIaboralivo deIIa rima canlica, vaIe a dire ArisloleIe,
receilo IausibiImenle allraverso i commenli di AIberlo Magno e di
Tommaso d'Aquino, a fianco deII'aulore reciuo deIIa Ialinila, vaIe a
dire VirgiIio, concorre a dare aIIa lraccia deIIa Ccnnc!ia queI rigore
secuIalivo di cui fino ad ora difellava, roiellando neIIa narrazione
Ia serie degIi aulori di cui Danle si era venulo imossessando a arlire
daI Ccntitic. L'inneslo di ArisloleIe delermina una svoIla inleIIelluaIi-
slica neI sislema danlesco, i cui esili si faranno arlicoIarmenle senlire
neIIa arle finaIe deI Para!isc e neIIa Mcnarcnia.
Isso immelle dunque quaIcosa di nuovo, erche viene ad esIicila-
re iI sislema su cui Danle inlende aoggiarsi: I'|iica e Ia |isica di
ArisloleIe, con un rinvio conlesluaIe anche aIIa Gcncsi
9
, con lulle Ie
imIicanze che ne conseguono: I'assunzione di un'aucicriias, Arislole-
Ie, iI maeslro er ecceIIenza deII'elica cIassica, Ia coIIocazione deI
oela Ialino e deI ersonaggio-serimenlalore in uno dei cami
deIIa rifIessione fiIosofica, gia avviala con iI Ccntitic allraverso
I'individuazione deI fine rorio deII'uomo, in quanlo crealura lerre-
na, e in quanlo crealura incamminala verso Ia alria ceIesle, iI riIievo,
derivalo daII'|iica arisloleIica secondo cui Ia tirius e un medio lra due
eslremi, i quaIi delerminano Ia sfera deI tiiiun, e queslo cosliluisce Io
sunlo er una cIassificazione deIIa jcrna pcccaii su fondamenlo fiIo-
sofico, e non semIicemenle leoIogico, lrasIandoIa daII'idea cIassica
deI tiiiun a queIIa crisliana deI pcccaiun e deIIa cu|pa.
In aIlri lermini, iI canlo XI deII'|njcrnc deve essere consideralo co-
me un canlo di svoIla, che imIica un mulamenlo deI iano originario,
quaIe si era configuralo fino aI canlo X, anche se Ia coIIocazione
9 L'arle voslra queIIa |Ia naluraj, quanlo ole, / segue, come 'I maeslro fa 'I discen-
le, s che voslr'arle a Dio quasi e neole. / Di quesle due |nalura e arlej, se lu li rechi a
menle / Io Genes daI rinciio, convene / render sua vila e avanzar Ia genle, / e erche
I'usuriere aIlra via lene, / er se nalura e er Ia sua seguace / disregia, oi ch'in aIlro
on Ia sene, |nj. XI, 103-111. Danle si riferisce qui aIIa genesi deIIe arli, che rendono
origine daII'allivila di Adamo allraverso iI eccalo, lulle Ie arli discendono in laI modo
daIIa nalura, ma I'usuraio dislorce Ie finaIila fissale daIIa Iegge deIIa nalura.
|| canic X| !c||Inferno 437
searala degIi erelici non cosliluiva er nuIIa una novila, essendo gia
resenle, sollo aIlra forma, neII'Apcca|issc !i Pac|c, un'oera e un agcns
gia richiamali neI II canlo deIIa Ccnnc!ia (|nj. II, 32)
10
.
Non e dunque a caso che doo iI canlo XI Danle roceda a riorga-
nizzare Ia maleria deIIa dislribuzione dei eccali secondo un'esigenza
s dollrinaria e leoIogica, ma ure reciuamenle narraliva. Se si liene
conlo infalli deII'andamenlo dei rimi canli, con ben sei schiere di
anime, I'|njcrnc, doo iI canlo X, era gia ralicamenle finilo. Da sem-
Iice canlo di coIIegamenlo e di ura rifIessione fiIosofica, come finora
si e lenlalo di vedere, iI canlo XI deII'|njcrnc divenla un canlo di
roosla e di rislrullurazione deIIa macchina narraliva, con iI canlo XI
iI disegno si amIia e si seciaIizza, e rende un nuovo sIancio rifIes-
sivo e robIemalico che i canli recedenli non Iasciavano resagire.
La cenlraIila deI canlo XI neI disegno comIessivo deIIa Ccnnc!ia
non diende ero daI fallo di essere un canlo di ridefinizione deI
iano deII'|njcrnc, come oleva essere er iI canlo XVII deI Purgaicric,
ma di essere sorallullo un canlo di svoIla, Ie cui ragioni inlerne ci
sfuggono, ma che sono ben evidenli se si considerano Ie ragioni anche
aulobiografiche che hanno romosso iI rogello, oi rienlralo, deI
Ccntitic. Che iI iano deIIa Ccnnc!ia doo iI canlo XI deII'|njcrnc sia
mulalo, non diende daI fallo che fino in origine areva disorsi su
due formuIe o iani, queIIo deII'aIIegoria e queIIo deIIa 'figura' e deI
simboIismo lioIogico, bens daI fallo che sono slale immesse idee
nuove, che aIIargano e inlegrano I'originaria !ispcsiiic deI rogello,
semre che si ossa arIare di una !ispcsiiic iniziaIe gia lulla in se
comresa e delerminala.
3. MUTAMINTI I STRATIGII D'AUTORI
II mulamenlo deI iano neI corso d'oera si uo rovare anche er
aIlra via e queslo ci orla a considerare Ia Ccnnc!ia come una crea-
zione che si e venula lrasformando e modificando con iI lrasformarsi e
iI modificarsi deIIa cuIlura e deIIa vicenda deI oela, quaIe camo di
lensioni, duralo neI lemo, e ercio slesso aerlo aIIa Iegge di mula-
menlo e deI rinnovamenlo, a misura deIIe nuove eserienze cuIluraIi e
sloriche deI oela.
II caso iu evidenle, e in cerlo modo iu significalivo, riguarda iI
raorlo con ealrice, innaIzala neII'|njcrnc ad una sorla di 'modeIIo'
10 Iroriamenle neII'Apcca|issc !i Pac|c non si arIa deI eccalo di eresia, ma deI
eccalo di coIoro che deridono Ie ragioni deIIa fede e slimano Dio quasi un nuIIa: cfr.
Iapcca|issc !i Pac|c, in Iciicrc c Apcca|issi, versione e commenlo di Mario Irbella, Torino,
Marielli 1969, . 359-385: 373.
orloIo MarlineIIi 438
deIIa virlu e deIIa scienza, cui doveva comelere di fornire non
soIo Ie gIosse, ma anche iI soslegno aI rogello danlesco. NeI X
canlo deII'|njcrnc siamo in uno dei canli di isirazione fiorenlina
che lrova ricello, cerlo er ragioni aulobiografiche, neIIa sezione
iniziaIe deIIa rima canlica , enlro Ie mura deIIa cilla di Dile,
Danle inconlra due eminenli figure deIIa generazione che Io
aveva recedulo, Iarinala degIi Uberli, erseguilalo dai Iiorenlini
anche da morlo, nonoslanle iI suo assalo gIorioso di ni|cs
'magnanimo', e CavaIcanle de CavaIcanli, iI adre di Guido, suo
sodaIe in camo oelico fino dai lemi recedenli Ia Viia Ncta.
AI lermine di un serralo confronlo, Iarinala fa baIenare a Danle un
lrisle resagio riguardo aI suo deslino di esuIe, Danle si senle
aIIora come smarrilo e VirgiIio Io conforla rinviando ogni chiarimenlo
iu oIlre, a quando iI oela inconlrera ealrice. AIIa fine Iarinala
rirende iI suo ruoIo di dannalo ed esce ercio di scena. Quesla, fral-
lanlo, Ia sequenza narraliva:
Indi s'ascose, e io inver' I'anlico
oela voIsi i assi, riensando
a queI arIar che mi area nemico.
IIIi si mosse, e oi, cos andando
mi disse: Ierche se' lu s smarrilo`.
I io Ii sodisfeci aI suo dimando.
La menle lua conservi queI ch'udilo
hai conlra le, mi comando queI saggio,
e ora allendi qui, e drizzo 'I dilo:
quando sarai dinanzi aI doIce raggio
di queIIa iI cui beII'occhio lullo vede,
da Iei sarai di lua vila iI vaggio.
(|nj. X, 121-132)
QuaIche scena doo, inconlrando neI cerchio dei sodomili iI suo
anlico maeslro, runello Lalini, aI lermine di un anaIogo eisodio
denso di paincs, neI quaIe, accanlo aII'aIlo riconoscimenlo verso
I'insegnamenlo deI suo maeslro, Danle fa risuonare direllamenle, er
voce roria, Ia consaevoIezza che un duro deslino ancora Io allende
quando lornera in lerra e anche in queslo caso, er Ie gIosse decisive e
definilive, iI rinvio e a ealrice. A queslo lemo deIIa scrillura deI can-
lo Danle e gia divenulo consaevoIe deI definilivo faIIimenlo deIIa
sua inizialiva oIilica e deIIa sua roosla cuIluraIe. Leggiamo ercio
iI asso er inlero:
|| canic X| !c||Inferno 439
Se fosse lullo ieno iI mio dimando,
risuos'io Iui, voi non saresle ancora
de I'umana nalura oslo in bando,
che 'n Ia menle m'e filla, e or m'accora,
Ia cara e buona imagine alerna
di voi quando neI mondo ad ora ad ora
m'insegnavale come I'uom s'ellerna:
e quanl'io I'abbia in grado, menlr'io vivo
convien che ne Ia mia Iingua si scerna.
Cio che narrale di mio corso scrivo,
e serboIo a chiosar con aIlro leslo
a donna che sara, s'a Iei arrivo.
Tanlo vogI'io che vi sia manifeslo,
ur che mia coscenza non mi garra,
ch'a Ia Iorluna, come vuoI, son reslo.
(|nj. XV, 79-93)
II rinvio a ealrice, in quesla fase deIIa narrazione, che sembra
ancora lulla inlrisa di sirilo di fiorenlinila ma Iirenze non e
comunque gia iI iu beI Iuogo deI mondo come si Iegge neI Oc tu|gari
c|cqucniia, I VI 3 , uo forse aarire come una caIcoIala slralegia
d'aulore, cerlo e ero che neI roseguo deII'oera queI ruoIo, di forni-
re Ie gIosse riguardo aI suo fuluro deslino lerreno, Danle Io riservera
iu oorlunamenle ad uno dei suoi recursori neIIa sua Iinea
domeslica, iI ni|cs Cacciaguida, morlo da crocialo er iI riscallo deI
sanlo seoIcro.
AII'inizio deIIa seconda canlica, in una deIIe sezioni deII'Anli-
urgalorio dove lrovano ricello gIi sirili che vissero in conlumacia
deIIa Sanla Chiesa, Danle inconlra Manfredi, I'uIlimo grande ra-
resenlanle deIIa casa di Svevia in IlaIia, rima deII'inconlro con
Manfredi, Danle si lrova ad affronlare iI robIema di come iI coro dei
enilenli, che e un coro d'ombra, sia slalo disoslo a subire I'effello
deIIe unizioni. La scena rende Ie mosse daI riferimenlo di VirgiIio
aIIa roria seoIlura, resso NaoIi, dove e seoIlo iI suo coro mor-
laIe er iI quaIe in lerra si inleroneva ai raggi soIari, accomagnalo
cos da una scia d'ombra, ora ero queI coro non gella iu ombra,
ma nondimeno e slalo disoslo, er Ie Ieggi deII'aIdiIa, a oler subire
gIi slessi effelli fisici e sichici. La scena si concIude con Ia iu dura
ramogna che Danle abbia mai ronuncialo conlro Ia resunzione
umana di oler giungere a conoscere lullo. Cos si esrime, dunque,
VirgiIio:
orloIo MarlineIIi 440
I 'I mio conforlo: Ierche ur diffidi`
a dir mi comincio lullo rivoIlo,
non credi lu me leco e ch'io li guidi`
Vesero e gia coIa dov'e seoIlo
Io coro denlro aI quaI io facea ombra,
NaoIi I'ha, e da randizio e loIlo.
Ora, se innanzi a me nuIIa s'aombra,
non li maravigIiar iu che d'i cieIi
che I'uno a I'aIlro raggio non ingombra.
A sofferir lormenli, caIdi e geIi
simiIi cori Ia Virlu disone
che, come fa, non vuoI ch'a noi si sveIi.
Mallo e chi sera che noslra ragione
ossa lrascorrer Ia infinila via
che liene una suslanza in lre ersone.
Slale conlenli, umana genle, aI quia,
che, se olulo avesle veder lullo,
meslier non era arlurir Maria,
e desar vedesle sanza frullo
lai che sarebbe Ior disio quelalo,
ch'ellernamenle e dalo Ior er Iullo:
io dico d'ArisloliIe e di IIalo
e di moIl'aIlri, e qui chino Ia fronle,
e iu non disse, e rimase lurbalo.
(Purg. III, 22-45)
AI lermine deIIa sequenza Danle fa seguire iI siIenzio di VirgiIio,
come se fosse un uIleriore eIemenlo di inlerdizione e come se Ia
queslione, a cui fa seguilo Ia risosla, avesse gia avulo una sanzione
definiliva, lanlo iu che viene invocalo iI mislero deIIa conoscenza
deIIa Trinila, che rimane inallingibiIe er I'uomo finche e suIIa lerra.
DeIIe cose che lrascendono I'umano inleIIello I'uomo uo infalli
conoscere soIo che esse esislono, allraverso i Ioro effelli, ma non anche
Ia Ioro essenza: sono aroIe che Danle aveva gia anlicialo, fiIosofi-
camenle arIando, neI Ccntitic (Ccnt. III viii 15).
Tullavia, quaIche canlo o sequenza narraliva iu oIlre, ervenulo
neIIa cornice dei goIosi, doo aver inconlralo lra gIi aIlri onagiunla
da Lucca e I'amico Iorese Donali (Purg. XXIV), a roosilo dei goIosi,
che ur non avendo un coro, soffrono Ia fame e Ia sele, neI canlo
XXV Danle si fa inlereIIare da VirgiIio, affinche chiarisca cio che in
roosilo ora vuoIe conoscere, vaIe a dire iI erche e iI come iI coro
ombra sia slalo disoslo a subire lulla una serie di effelli. Cos viene
|| canic X| !c||Inferno 441
formaIizzala Ia richiesla, che e roosla in forma di queslione:
Non Iascio, er I'andar che fosse rallo,
Io doIce adre mio, ma disse: Scocca
I'arco deI dir, che 'nfino aI ferro hai lrallo.
AIIor sicuramenle ari' Ia bocca
e cominciai: Come si uo far magro
Ia dove I'uoo di nodrir non locca`.
(Purg. XXV, 16-21)
VirgiIio risonde cercando di richiamare a Danle I'anaIogo eiso-
dio di MeIeagro, narralo da Ovidio neIIe Mciancrjcsi (Mcian., VIII,
260-546), ma Iascia loslo Ia risosla a Slazio, che affronla Ia queslione
in forma di !cicrninaiic nagisira|is. Ier voce di Slazio Danle lralla qui
iI robIema deIIa genesi deI coro umano, deII'infusione deII'anima
(Danle si esrime qui nellamenle conlro Ia dollrina deIIa IuraIila deI-
Ie forme soslanziaIi), e deIIa dollrina deII'inleIIello umano, che e
arorialo ad ogni singoIo uomo e non unico er lulla Ia secie. La
!cicrninaiic di Slazio e gia slala affronlala con slraordinaria come-
lenza e rigore da runo Nardi e a Iui ercio rinvio
11
. QueIIo che ero
qui imorla solloIineare e che iI reIalivo quesilo che era slalo inlerdel-
lo neII'Anliurgalorio, ora, quasi aI lermine deIIa rassegna dei eccali
e deIIe anime, venga formaIizzalo come urgenle, con lanlo di Iezione
calledralica. A queslo riguardo si ossono lrarre, in via di rifIessione e
di iolesi, aIcune concIusioni: queIIo che iniziaImenle Danle aveva
rilenulo di dover lraIasciare, viene ora razionaImenle esIicilalo, a
oco lemo di dislanza iI oela si vede ressalo a dover dare una ri-
sosla: rirova che Ia sezione recedenle deIIa seconda canlica era
ormai in circoIazione, e iI oela ne arofilla er chiarire un robIema
di fondo, queIIo deII'unicila deII'anima umana e, queIIo che iu conla,
deIIa nalura deII'inleIIello umano, che non e lrascendenle, ma inerenle
e arorialo aII'uomo. Veniva in laI modo oslo in gioco lullo
I'imianlo deIIa Ccnnc!ia, non gia quaIe archilellura deII'aIdiIa, ma
come dollrina deIIa Iiberla deII'uomo, deIIa conseguenle resonsabiIi-
la in ordine aI bene e aI maIe, e, in uIlima islanza, di sloria deIIa
cadula e deIIa redenzione, deI eccalo e deIIa grazia, di sloria deIIa
saIvezza a cui lulli sono slali chiamali.
Da queslo unlo di visla Ia queslione era non soIo urgenle, ma
anche cailaIe e Danle non oleva che farIa roria, in maniera
11 RUNO NARDI, Icriginc !c||anina unana scccn!c Oanic, in ID., Siu!i !i ji|cscjia nc-
!icta|c, Roma, Idizioni di Sloria e Lelleralura 1960, . 9-68, Su||criginc !c||anina
unana, in ID., Oanic c |a cu|iura nc!icta|c, ari, Lalerza 1983, . 207-224.
orloIo MarlineIIi 442
erfino ecIalanle, neI quadro idealivo e dollrinario deI oema. La
Ccnnc!ia non e iI risuIlalo lolaIizzanle di un ur arduo conceimenlo
iniziaIe, ma e iI frullo di numerosi asseslamenli, dovuli non ad una
mera esigenza narraliva, quanlo e iulloslo aIIa varia eserienza e
ansia conosciliva e roosiliva malurala daI oela neI corso degIi anni
deII'esiIio. II oema diveniva cos Ia Iunga sloria deI suo aulore, cos
come aveva voIulo essere Ia Iunga sloria deII'uomo daIIa lerra aI cieIo,
daI lemo aII'elerno.
A queslo unlo si uo cercare di enlrare iu da vicino anche neIIa
lraccia iu inlerna deII'eIaborazione deI oema. DaI 16 ollobre 1311 aI
6 maggio 1312 si era lenulo a Vienne un ConciIio sollo Ia guida
di CIemenle V e neIIe lre sedule che ne seguirono vennero rese
decisioni di grande riIievo dollrinario e slorico, daI mislero deII'In-
carnazione, aIIa condanna dei TemIari, aIIa necessila di conoscere Ie
Iingue orienlaIi, er favorire I'evangeIizzazione resso gIi infedeIi,
aII'effello deI ballesimo nei bambini, una deIIe rinciaIi rocIama-
zioni in camo leoIogico e fiIosofico riguardava ero Ia nalura
deII'anima umana, cioe I'anima inleIIelliva o razionaIe, che era da
considerare, sollo ena di accusa di eresia, jcrna ccrpcris unica e so-
slanziaIe, mellendo cos fine aI diballilo suIIa IuraIila deIIe forme.
Slando cos Ie cose, non e er nuIIa difficiIe comrendere Ie ragioni
deI assaggio daI canlo III aI canlo XXV deI Purgaicric, o, megIio, daIIe
erenlorie asserzioni deI canlo III aIIa resa di osizione leorelica deI
canlo XXV, I'eIemenlo circoslanziaIe deI ConciIio di Vienne ermelle
anche di acquisire una quaIche indicazione aggiunliva circa Ia crono-
Iogia inlerna deI oema: iI canlo III deI Purgaicric, comunque si
vogIiano vedere Ie cose, si deve orre in una dala anleriore aI ConciIio
slesso, IausibiImenle neIIa rima mela deI 1311, e, di conseguenza, iI
canlo XXV si deve orre doo Ia rima mela deI 1312, quando cioe Ia
serie dei decreli deI ConciIio era slala ufficiaImenle romuIgala. Ier
quesla via si rende cos deI lullo evidenle anche una deIIe grandi la-
e eIaboralive inlerne neI oema e iI oela ha voIulo in cerlo modo
cos sancirne Ia sloria e Ie fasi.
4. IN IORMA DI RIILISSIONI
Lo sviIuo narralivo deI canlo X deII'|njcrnc e ad acme. Danle
melle in scena I'inconlro con Iarinala in due lemi: darima ci
resenla, in forma drammalica, iI confronlo-sconlro con Iarinala, che
cuImina, a modo di eigrafe e di sanzione slorica, con iI monilo conlro
I'eroe di Monleaerli: ma i voslri non areser ben queII'arle (|nj. X,
51), quindi inlerone Ia scena di CavaIcanle de CavaIcanli, incenlrala
|| canic X| !c||Inferno 443
inlorno aI richiamo aI figIio Guido, secondo una moduIazione narrali-
va di lio alelico, loslo ero rirende iI confronlo con Iarinala, che
rende allo deIIa definiliva sconfilla deIIa roria arle oIilica
(S'eIIi han queII'arle, disse, maIe aresa, / cio mi lormenla iu che
queslo Iello, |nj. X, 77-78) e che rofelizza anche er iI oela un ana-
Iogo deslino di non meno doIorosa sconfilla. Tra Iarinala e Danle
sembra cos slabiIirsi un erfello araIIeIismo suI iano slorico e
oIilico, in quanlo Ia vicenda deII'uno non differisce da queIIa
deII'aIlro. SuII'onda di queslo riIievo, che vede inlrecciarsi iI deslino di
due sconfilli, Iarinala si singe a chiedere aI oela Ia ragione di lanlo
odio che Ia arle gueIfa, ur a dislanza di lemo, nulre ancora verso
Ia arle ghibeIIina, Ia causa, risonde Danle, e dovula aIIa lerribiIe
sconfilla di Monleaerli (4 sellembre 1260), iI cui esilo era slalo fune-
slo e cruenlo er lulli i fiorenlini. Iarinala, come risosla, non si
assume da soIo lulla Ia resonsabiIila miIilare deII'evenlo, ma si
assume invece da soIo iI merilo di aver difeso Ia roria cilla neI
conciIio di ImoIi, aIIorche si era arIalo di radere aI suoIo Iirenze.
Ioslo di fronle aI vincilore di Monleaerli, che aveva saulo essere
magnanimo anche neIIa villoria, Danle sembra aIIa fine voIer ricono-
scere come inuliIe I'odio che i fiorenlini riservano ancora conlro Ia
memoria di Iarinala si ricordi I'eisodio di fra SaIomone da Lucca,
che iI 16 ollobre 1283 aveva fallo disseeIIire iI coro di Iarinala e
gellare Ie sua ossa neII'Arno e ausica che cessi verso Ia semenza,
Ia famigIia di queslo magnanimo, come sloIlo, ogni uIleriore odio di
arle.
Con iI canlo X deII'|njcrnc Danle si resenla dunque anche neIIa
nuova vesle di inlerIoculore oIilico, e non soIo di oela e di uomo di
cuIlura, i cui merili avrebbero comunque dovulo rifuIgere con iI
Ccntitic e iI Oc tu|gari c|cqucniia, se mai Ia scrillura dei due lrallali
fosse giunla aI lermine. Con Ia Ccnnc!ia Danle sembrava cos voIer
assumere fin dai rimi canli un doio ruoIo: da una arle, queIIo di
riformalore deIIe condizioni deII'uomo deI suo lemo gravalo daI
eccalo e daIIa maIa condolla, suIIa scorla deIIa Gcncsi, con iI lema
archeliico deIIa cadula e anliedenico deIIa seIva, facendo anche rie-
cheggiare con iI lema deI veIlro I'anlica vicenda dei rofeli bibIici,
daII'aIlra, in forza di quesli nuovi requisili, di reslauralore deII'idea
deIIa ace neIIa sloria, e non soIo fiorenlina, deI suo lemo. Ma che si
lrallasse di una faciIe uloia Danle sembra rendersene conlo rorio
aI lermine deI suo inconlro con Iarinala, con iI quaIe dava sfogo aI suo
ideaIe oIilico in un lemo in cui I'allesa messianica di un riformalore
non oleva che essere osla in forma di una convinla, ma ur semre
ausicala rofezia.
orloIo MarlineIIi 444
Se con iI canlo X deII'|njcrnc Danle si roone neI ruoIo di inlerIo-
culore oIilico, con iI successivo canlo XI si lrova invece a riroorsi
secondo iI ruoIo che si era assegnalo con iI Ccntitic, diIalando
ero I'udilorio e recisando e lrasfigurando Ia maleria, che da mera
forma di divuIgazione diveniva ora una forma di robIema deIIa
cuIlura, enlro Io schema di una rinascila deII'uomo, cos come era
neII'Aniic|au!ianus di AIano di LiIIa.
II canlo XI deII'|njcrnc vuoI essere cos anche un canlo di grande
riroosla fiIosofica in quanlo, menlre mira a raresenlare in forma
oelica Ia dimensione deII'aIdiIa e dei dannali, si are ad una sorla di
mediazione lra I'elica cIassica, neIIa versione arisloleIica, e I'elica
crisliana, neIIa versione fornila dai leoIogi, in arlicoIare daIIe
Scnicnzc di Iielro Lombardo. Danle recensisce qui i rori aulori e i
rori lesli di riferimenlo: Cicerone, ArisloleIe, Iielro Lombardo, da
cui deriva una nuova e iu oorluna sislemazione deIIa gerarchia
dei eccali unili neI basso inferno. II resuoslo e cosliluilo
daII'idea deIIa gravila: I'offesa aI divino, I'aIIonlanamenlo daIIa
nalura, Ia degradazione besliaIe deII'uomo. La fenomenoIogia deI
eccalo si Iurifica, in reIazione aI nuovo e mulalo orizzonle deIIa
ricerca (siamo in uno scenario deII'aIdiIa, non iu Iegalo aIIa lemora-
Iila), e viene ridisegnalo iI voIlo slesso deI eccalo, che risuIla
incarnalo neIIe vicende degIi uomini e neIIe Ioro delerminazioni esi-
slenziaIi e cuIluraIi. II eccalo consisle semre in un alleggiamenlo, in
una regoIa dislorla di condolla, in un ollundimenlo deIIa menle, in un
decIassamenlo deIIa lensione verso quaIcosa di uIleriore, in cui ossa-
no lrovare reaIizzazione e subIimazione Ie seranze e Ie allese degIi
uomini, vario si resenla ercio iI eccalo, neIIa forma, neIIe moliva-
zioni, neII'effigie, secondo Ia nuova modaIila di raresenlazione
avviala con iI canlo di Iarinala. Ier aIlro verso, Ia ersonificazione deI
eccalo, anche suI iano di una slralegia narraliva, viene cos a corri-
sondere a queI modo deIIa raresenlazione figuraIe che aveva
reso avvio con i canli deI roIogo e deI roemio deIIa Ccnnc!ia.
Le anime, neIIa scena che Ie raresenla e Ie circoscrive, sono
roosle su| spccic acicrniiaiis, e Danle, rilraendoIe, Ie riconsegna in
cerlo modo aIIa sloria, non soIo Ielleraria e individuaIe, ma anche
generaIe ed esemIare, doo averne ero recensilo i Iimili inlrinseci
inerenli a ciascuna di esse, erche non bisogna dimenlicare che Ia
Ccnnc!ia non e semIicemenle Ia raresenlazione dei lralli che iI
eccalore oleva aver avulo suIIa lerra, bens e Ia raresenlazione di
quei lralli che si ossono considerare come iu significalivi rorio
aIIa Iuce deIIa Ioro coIIocazione neIIo scenario deII'elerno. Tra I'evenlo
deI singoIo eccalore, quaIe si e delerminalo in lerra, e I'evenlo di cui
|| canic X| !c||Inferno 445
reca leslimonianza Danle neII'aIdiIa, lra I'evenlo in lerra e Ia disIoca-
zione neII'aIdiIa, vi e una connessione necessaria. Ma iI vero evenlo,
er ogni ersonaggio che Danle inconlra, rimane ur semre queIIo
deII'aIdiIa, anche se I'evenlo in lerra ne cosliluisce Ia molivazione
rofonda ed inaIienabiIe
5. L'INTIRROGATIVO DIL CANTO
II canlo XI deII'|njcrnc si sviIua er gradi, con una serie rogres-
siva di robIemi, ma slrulluraImenle si resenla conchiuso su se
slesso, in un erfello molo circoIare di rogressione e di riresa: i
rimi sei versi evocano iI lema deII'abisso e iI verso concIusivo, verso
115, sancisce I'inizio e Ia necessila deIIa uIleriore discesa. NeII'in-
lermezzo si sviIua I'ordilo deIIa narrazione, non come ricognizione
di ersonaggi e di Iuoghi, ma come unila robIemalica e dollrinaria.
I versi 1-15 sono slali in genere resenlali come Ia sezione
roemiaIe deI canlo, a cui segue Ia |cciic di VirgiIio daI verso 16 aIIa
fine. La sezione che fa da roIogo conliene in reaIla lre indicazioni,
che saranno rirese e sviIuale in successione. La rima, ci roone
uno sguardo suII'abisso, a arlire daI gran cerchio di ielre su cui
si sono sislemali i due oeli, Ia seconda, riguarda Ia sosla resso
I'aveIIo di aa Anaslasio II, inlroducendo cos un eIemenlo
figuralivo che non e sfuggilo a lulli i commenlalori deI canlo, Ia
lerza, roone Ia domanda di Danle, riguardo aII'imiego roficuo
deI lemo e Ia reIaliva risosla di VirgiIio, che fa da coroIIario e aer-
lura aIIa sezione successiva: Vedi che a cio enso. Un ordilo
rigorosamenle delerminalo che concorre a mellere in Iuce lre aselli
deIIa rifIessione che ne seguira: iI riferimenlo aII'abisso, quaIe segno di
erdizione, di oscurila e di negazione, iI richiamo, er conlraslo, aI
Iibro deIIa Gcncsi (1, 2: el lenebrae eranl suer faciem abyssi), e
aIlres iI richiamo aII'imerscrulabiIe giuslizia divina (}uslilia lua
siculi monles Dei, iudicia lua abyssus muIla, Ps. 35, 7), in funzione
anche deIIa designazione dei due Iuoghi oosli deII'aIdiIa, I'inferno e
iI aradiso.
La dimensione deI lemo oi, cos come Danle Ia roone, non
cosliluisce soIo un eIemenlo deIIa scansione neII'economia deI viag-
gio, ma anche e sorallullo un asello deI discorso deIIa saIvezza, a
cui e imronlala lulla Ia Ccnnc!ia, erche qui iI lemo e bibIicamenle
iI lemo deII'allesa, iI lemo deI comimenlo e iI lemo deIIa fine. I
queslo vaIe anche a siegare Ia rofonda differenza lra iI lemo dei
dannali e iI lemo deI viaggialore, Danle: Ie anime dei dannali non
vivono neIIa dimensione deI resenle, e ercio non rofillano iu
orloIo MarlineIIi 446
deIIa dimensione deI lemo reaIe, a differenza deI oela che e ancora,
in quanlo aarlenenle aIIa Chiesa miIilanle, roiellalo neIIa dimen-
sione deI lemo lerreno, anche se Ia siluazione che va serimenlando
e gia queIIa deI lemo deII'elerno, deIIa sua fulura e lolaIe lrasforma-
zione. II lemo che iI oela serimenla, ur neIIa sua condizione di
morlaIila, e s ancora iI lemo deI eccalo (siamo neII'inferno), ma e
gia er Iui anche iI lemo deIIa grazia, erche egIi, aI modo deI-
I'Apcca|issc di IaoIo e deI Ii|rc !c||a Sca|a, e un resceIlo e Io allendo-
no, aI lermine deI viaggio, iI gaudio e Ia visione di Dio. II lemo
ercio, agIi occhi di Danle, non uo lrascorrere inuliIe, non uo ercio
essere erdulo, dove iI lermine erdulo evoca lanlo Io smarrimenlo
neIIa seIva, quanlo Ia siluazione deIIa genle deII'inferno, che e aun-
lo erdula (|nj. III, 3), come e scrillo suIIa orla che immelle neI
regno infero, ma connola oi anche iI foIIe viaggio di UIisse, neI quaIe
e dello che erdulo a morir gissi (|nj. XXVI, 84), iI lemo e ero qui
non meno anche iI lemo negalo deIIa voragine infera, neIIa quaIe
vige un'aura maIedella e, aunlo, sanza lemo.
DaI verso 16 aI verso 116 si disiega infine Ia |cciic nagisira|is di
VirgiIio, aI quaIe viene cos deIegala Ia funzione di aucicriias, quaIe
aulore deII'|nci!c, e Ia funzione di sapicns, suIIa faIsariga deI canone
medioevaIe deIIa Iellura deII'|nci!c. Ma VirgiIio ci viene resenlalo
qui anche in un ruoIo iu squisilamenle fiIosofico, come un maeslro aI
modo deIIa ScoIaslica, in conformila aIIe forme deIIa |cciic e deIIa quac-
siic che Danle ci aveva gia arlecialo con iI Ccntitic e che ci
riroorra oi neI canlo XXIV deI Para!isc, in un senso squisilamenle
lecnico (S come iI bacciaIier s'arma e non arIa / fin che 'I maeslro Ia
queslion roone, Par. XXIV, 46-47).
Darima, nei versi 16-66, VirgiIio iIIuslra Ia loografia deI basso
inferno e Ia disosizione successiva dei eccalori. L'idea deIIa
rogressiva Iimilazione deIIo sazio, con i lre cerchielli che si
reslringono di grado in grado, suggerisce I'idea di un rogressivo e
semre maggiore aIIonlanarsi daI bene e, er converso, di una mag-
giore concenlrazione deI maIe (I'inferno come buco nero). Denlro
slanno Ie anime, che in vila si sono aIIonlanale da Dio: sirli
maIadelli, coslrelli e sliali ora in sazi semre iu angusli.
I versi 22-24 ci offrono in comendio Ia delerminazione di VirgiIio:
iI oela Ialino darima inlroduce Ia forma generaIe deI eccalo:
Ia maIizia
12
, quindi considera iI eccalo come aIIonlanamenlo daIIo
12 Lo Is.-Vincenzo di eauvais considera Ia causa deI eccalo in due modi: cx na|i-
iia, cx passicnc, e one oi quallro queslioni: se si ossa eccare er cerla maIizia, se chi
ecca er abilo, ecchi anche er cerla maIizia, se chi ecca er cerla maIizia, ecchi
anche er abilo, se chi ecca er cerla maIizia, ecchi meno di chi ecchi er assione.
|| canic X| !c||Inferno 447
sguardo divino: odio, e infine roone una rima dislinzione,
derivala daI Oc cjjiciis di Cicerone: si ecca con forza o con frode
13
.
L'inlervenlo deI verso 21, in forma di avverlimenlo: inlendi come
e erche sono coslrelli i dannali, lrova Ia verifica neIIa consequenzia-
Iila deI verso 25, dove si affronla, a modo di siegazione e di gIossa, Ia
nalura secifica deI eccalo riguardo aIIa Iegge divina: deIIe due
forme di eccalo, Ia vioIenza e Ia frode, e Ia frode che iu siace a
Dio. VirgiIio e cos indollo a lrallare dislinlamenle i due eccali:
darima considera Ia vioIenza, neI sellimo cerchio, secondo Ia lriar-
lizione canonica: vioIenza conlro Dio, conlro iI rossimo, conlro se
slessi, con una serie di recisazioni aI fine di rendere iu chiara Ia
comrensione deIIe diverse lioIogie raresenlale.
Segue quindi Ia lrallazione deIIa frode, neIIe sue varie forme e
manifeslazioni, dislinle secondo Ia formuIa deI ccnira: in chi si fida e
in chi non si fida. La frode, leoIogicamenle arIando, non e aIlro che
obIio deII'amore (versi 62-63) e ercio ha ragione di eslrema gravila e
iI eccalo si sconla neI cerchio iu rislrello, neI Iuogo dove e Dile, Sa-
lana, e qui sono osli i fraudoIenli che si sono macchiali deI eccalo di
lradimenlo (nono cerchio). I chi ecca, e non soIo lrade, e dannalo
in elerno e in ellerno e consunlo. La dimensione deII'elerno, conlro
iI lemo, lrova qui iI suo definilivo riIievo aI lermine deIIa siegazione
e deIIa cIassificazione deI eccalo, in una roselliva dollrinaria e
didascaIica di nolevoIe vaIore anche slorico, erche resenla fusi
insieme eIemenli deII'elica cIassica e deII'elica crisliana, suIIa scorla
deIIa leoria agosliniana deI eccalo, inleso come slravoIgimenlo deIIa
Iegge deII'amore (I'aulore a cui Danle si rifa direllamenle e ero qui
GugIieImo IeraIdo, iI quaIe rinvia a sua voIla a Sanl'Agoslino).
A queslo unlo Danle roone un nuovo inlerrogalivo, che ri-
guarda Ia siluazione dei dannali coIIocali rima deIIa cilla di Dile, e,
in aarenza, unili er eccali meno gravi. II quesilo riguarda Ia lo-
ografia moraIe di lullo I'inferno e ercio viene inlrodollo qui, neI beI
Senza enlrare nei dellagIi deIIe singoIe queslioni, mi Iimilo a roorre aIcuni riIievi uliIi
ai fini deIIa comrensione degIi enunciali danleschi: Ia maIizia si dislingua in abiluaIe e
alluaIe, chi ecca er maIizia abiluaIe ecca cx inc|inaiicnc na|iius, chi ecca er maIizia
alluaIe ecca cx na|i c|cciicnc. Chi ecca er cerla maIizia ecca iu gravemenle di chi
ecca er assione, erche Ia maIizia incIina maggiormenle aI maIe e queslo riguarda
lanlo iI fine quanlo I'oggello, e si veda aI riguardo IS.-VINCINZO DI IAUVAIS, Spccu|un
ncra|c, III, Iars 2, d. 8, Duaci, ex officina Tyograhica aIlazaris eIIeri 1624, . 936-
938.
13 Cum aulem duobus modis, id esl aul vi aul fraude, fial iniuria, fraus quasi vuI-
ecuIae, vis Ieonis videlur, ulrumque homine aIienissimum, sed fraus odio digna
maiore. Tolius aulem iniusliliae nuIIa cailaIior quam eorum, qui lum, cum maxime
faIIunl, id agunl, ul viri boni esse videanlur, CICIRONI, Oc cjjiciis, I 13.
orloIo MarlineIIi 448
mezzo deIIa |cciic di VirgiIio, quasi a voIer sanzionare, su fondamenli
dollrinari, Ia demarcazione lra Ie due zone e lra Ie due serie di ecca-
lori, deII'aIlo e deI basso inferno. Cos Danle inlereIIa ora VirgiIio:
Id io: Maeslro, assai chiara rocede
Ia lua ragione, e assai ben dislingue
queslo baralro e 'I ooI ch'e' ossiede.
Ma dimmi: quei de Ia aIude ingue,
che mena iI venlo, e che balle Ia ioggia,
e che s'inconlran con s asre Iingue,
erche non denlro da Ia cilla roggia
sono ei unili, se Dio Ii ha in ira`
I se non Ii ha, erche sono a laI foggia`.
(|nj. XI, 67-75)
La queslione e deI lullo causidica daI unlo di visla leoIogico, ma
non Io e aIlrellanlo daI unlo di visla deIIa disosizione deIIa maleria
elica deII'|njcrnc. Tullavia Danle, er voce di VirgiIio, non enlra qui in
arlicoIari considerazioni, ma daI comIesso deI discorso risuIla chia-
ro come qui sia imIicala una doia dislinzione, cara ai medioevaIi,
va a dire Ia dislinzione lra Ia ena deI danno e Ia ena deI senso. La
rima e causala daII'aIIonlanamenlo da Dio ed e Ia causa secifica er
cui si delermina Ia sanzione, Ia unizione, Ia seconda riguarda invece
Ia somminislrazione deIIa ena, Ia quaIe e iu o meno esanle a se-
conda deI rango e deIIa nalura deI eccalo.
La risosla di VirgiIio invesle qui due lemi: iI deIirio deII'uomo,
che ensa di oler ergersi a giudice deIIe Ieggi deII'aIdiIa, I'eredila
deII'elica arisloleIica, oggello di rieluli sludi e commenli ancora
neII'ela deII'AIighieri, elica che resenla neI Iibro VII deIIa Niccnacnca
una differenle cIassificazione dei vizi, disosli in lre forme: inconli-
nenza, maIizia, besliaIila. Seguono oi Ie gIosse di VirgiIio, in vesle
reciua di fiIosofo scoIaslico.
Si affaccia ora neIIa menle di Danle un nuovo inlerrogalivo, in
forma di dubbio, che, rivoIlo a VirgiIio, egIi formuIa in queslo modo:
O soI che sani ogne visla lurbala,
lu mi conlenli s quando lu soIvi,
che, non men che saver, dubbiar m'aggrala.
Ancora in dielro un oco li rivoIvi,
diss'io, Ia dove di' ch'usura offende
Ia divina bonlade, e 'I groo soIvi.
(vv. 91-96)
|| canic X| !c||Inferno 449
VirgiIio, in sede di risosla, rirende qui a ragionare da fiIosofo e
rinvia ero non iu aII'|iica Niccnacnca di ArisloleIe, bens aIIa |isica
semre deIIo Slagirila, secondo Ia quaIe I'arle, conlro cui si ecca, e
figIia deIIa nalura e, di conseguenza, si uo dire niole di Dio, in
quanlo Ia nalura e figIia di Dio
14
, e ercio I'usuraio risuIla sregevoIe
suI iano elico, suI iano fiIosofico e suI iano leoIogico, erche
rione in aIlro (aIlra via lene) e non in Dio Ia sua sene.
La |cciic nagisira|is di VirgiIio a queslo unlo si concIude ed iI
oela Ialino rinnova a Danle I'invilo a seguirIo: Ia discesa si rofiIa
subilo riida e scoscesa e iI maeslro e iI disceoIo aIIa fine imboccano
Ia via Ia dove daI baIzo si dismonla.
6. UI ISTIALITAS`. UNA QUISTIONI DI LANA CAIRINA
La |cciic nagisira|is di VirgiIio e di grande imorlanza ai fini
deIIa comrensione deII'imianlo elico deIIa rima canlica, ma anche
deI corredo fiIosofico e leoIogico deII'inlero oema. Danle, neIIa
cIassificazione dei vizi, fonde insieme lre diverse lradizioni: queIIa
ciceroniana, queIIa arisloleIica, queIIa scoIaslica. IgIi, er voce di
VirgiIio, non si Iimila ad una semIice cIassificazione dei vizi, ma
cerca di cogIierne Ia forma inlerna, secondo Ie disosizioni deII'animo,
allraverso una serie di successive delerminazioni. Darima roone
Ia dislinzione deI vizio in vioIenza e frode, aI modo di Cicerone,
quindi resenla Ia dislinzione secondo Ia disosizione deII'animo
vizioso, e resenla Ia dislinzione in inconlinenza, maIizia, besliaIila,
aIIa maniera di ArisloleIe, quindi inlroduce Ia dislinzione secondo
I'oggello e iI fine e formuIa Ia dislinzione deI eccalo in eccalo conlro
Dio, conlro iI rossimo, conlro se slessi, aI modo deIIa ScoIaslica e
reciuamenle deI maeslro deIIe Scnicnzc, Iielro Lombardo. La
roselliva e di grande originaIila e, er iI modo come viene roo-
sla, in una sinlesi di grande efficacia, cosliluisce un unicun neIIa
cuIlura deIIa sua ela e non lrova comunque I'anaIogo neIIe numerose
lrallazioni medioevaIi sui vizi e suIIe virlu. A differenza oi di una
successiva lrallazione, neI canlo XVII deI Purgaicric, dove Ia delermi-
nazione e rinciaImenle di ordine leoIogico, qui Ia delerminazione e
14 Cfr. ARISTOTILI, Pnqsica, II, 2, 194 a 13-27, lransIalio velus (ArisloleIes Lalinus,
VII/1, . 52-53). La 'deduzione' che I'arle, figIia deIIa Nalura, a Dio quasi e neole, in
quanlo Ia Nalura e figIia di Dio, e una singoIare eslraoIazione danlesca. SuII'enuncialo
arisloleIico che I'arle imili Ia nalura, si uo vedere SAN TOMMASO, Ccnn. in ccic |i|rcs
Pnqsic. Arisicic|is, II, Ieclio 4, in Opcra cnnia, ediz. a cura di Roberlo usa, Slullgarl-ad
Cannslall, IrommannHoIzboog 1980, IV, . 70ab, Ieclio 13, . 75a, ALIRTO MAGNO,
Pnqsica, II, lracl. I, ca. 9, Opcra cnnia, ediz. di CoIonia 1951, IV/1, . 91a-93b.
orloIo MarlineIIi 450
insieme di ordine fiIosofico, elico e leoIogico.
La ecuIiarila deII'oerazione si rende ben riconoscibiIe se si resla
allenzione a due dei concelli cardine inlrodolli da Danle e muluali
daII'elica arisloleIica, vaIe a dire iI concello di maIizia e iI concello di
besliaIila, che lanlo hanno lravagIialo i commenlalori e gIi inlerreli,
come se si lrallasse di una queslione esiziaIe ai fini deIIa comrensio-
ne deIIa oesia e deII'ordilo deIIa rima canlica.
SuI concello di maIizia Danle ci roone due indicazioni: aI verso
22, in correIazione con iI lermine giuridico-leoIogico di ingiuria
(D'ogni na|izia, ch'odio in cieIo acquisla, / ingiuria e 'I fine)
15
, e aI
verso 82, in reIazione con iI lermine fiIosofico-leoIogico di disosizio-
ne (Ie lre disosizion che 'I cieI non voIe, / inconlenenza, na|izia e Ia
malla / besliaIilade). Ora, riguardo a quesla dislinzione, si e voIulo
vedere non so che slraniamenlo neIIa Iogica deI ensiero danlesco,
come se iI leslo si reslasse a quaIche equivocila, ma i riferimenli
danleschi sono iulloslo chiari ed esIicili, soIo che si lenga conlo deI
conleslo degIi enunciali e si conoscano gIi argomenli. NeI rimo caso
Danle si alliene aIIa concezione leoIogica deI eccalo, iI quaIe imIica
due alli: Ia ccntcrsic a! na|un e I'atcrsic a Occ, come medioevaImenle
era risaulo. NeI secondo caso Danle, seguendo ArisloleIe e i vari
commenli aII'|iica Niccnacnca, arIa correllamenle di lre maIe diso-
sizioni, che originano aIlrellanli vizi: I'inconlinenza, come dislorla
forma deIIa Iegge di nalura (come I'essere goIoso, I'essere Iussurioso,
I'essere avaro), Ia maIizia, come abilo maIvagio che aggrava iI vizio, Ia
besliaIila, come sueramenlo di un Iimile, in quanlo comorlamenlo
ferino e subumano.
Danle darima, neI verso 22, si muove in un quadro giuridico-
leoIogico: iI fine d'ogni maIizia e I'ingiuria: Ia maIizia e qui semIice-
15 SuII'idea deII'ingiuria come fine o movenle deI eccalo insisle arlicoIarmenle
Durando di San Iorciano, neI suo commenlo aIIe dislinzione 42 deIIe Scnicnzc di Iielro
Lombardo. Durando si accinge a arIare arlicoIarmenle deI eccalo in Ocun e in prc-
xinun e rosegue: Haec enim el simiIia erverlunl debilum ordinem subieclionis ad
Deum el foedus humanae socielalis ad roximum, roler quod ex genere suo sunl
eccala morlaIia. Cum eliam homo lenealur diIigere Ius seisum quam roximum,
sicui i||a quac suni in iniurian prcxini suni ccnira cnariiaicn ci pcccaia ncria|ia, sic ea que
homo commillil conlra seisum, veI eccare conlra naluram, sunl conlra charilalem el
eccala morlaIia, quando vero voIunlas eccanlis ferlur in iIIud quod in se quidem
conlinel quandam inordinalionem, non lamen conlrarialur diIeclioni Dei, aul roximi,
nec loIIil oridinem debilae subieclionis ad Deum, nec foedus humanae socielalis ad
roximum, sicul verbum ociosum, risus suerfIuus, el simiIia, laIia dicunlur veniaIia ex
genere, DURANDO DI SAN IORCIANO, |n Pciri Icn|ar!i Scnicniias Tncc|cgicas Ccnncnia-
ricrun |i|ri |V, Liber II, disl, 42, q. 6, Veneliis, Ix Tyograhia Guerra 1571, risl.
anaslalica, Ridgevood, Gregg 1964, . 203a.
|| canic X| !c||Inferno 451
menle I'acius na|us, I'na|iius na|us
16
, iI eccalo vislo neIIa sua generaIi-
la, er usare iI Iinguaggio degIi scoIaslici (maIizia ts virlu)
17
, quindi,
neI verso 82, individua Ia forma inlerna deI eccalo, cioe Ia !ispcsiiic,
Ia quaIe ha in se un maggior o minor coinvoIgimenlo deIIa ragione.
NuIIa, dunque, di cos robIemalico da indurre ad una moIliIicazio-
ne deIIe queslioni, gia di er se numerose neI canlo XI.
La dislinzione deI verso 82 non riguarda iI lio secifico deI
eccalo, ma Ia disosizione eccaminosa, che favorisce iI eccalo
18
.
Siamo aII'inlerno deIIa leoria medioevaIe deII'na|iius, quaIe disosi-
zione a fare iI bene o iI maIe, come conseguenza di una sceIla di vila, e
ercio Danle, seguendo runello Lalini
19
, San Tommaso e AIberlo
16 In roosilo e da vedere lulla Ia queslione 78 deIIa Sunna Tncc|cgiac deII'Aqui-
nale, che ha er liloIo, Oc causa pcccaii quac csi na|iiia, dove na|iiia ha carallere di inlen-
zionaIila, arlicoIo 1 (Uirun a|iquis pcccci cx ccria na|iiia, I'Aquinale arIa deI eccalo cx
ccria na|iiia, tc| cx ccria in!usiria) e di na|iius na|us, arlicoIi 2-3 (Uirun quicunquc pcccci
cx na|iiu, pcccci cx ccria na|iiia, Uirun i||c qui pcccci cx ccria na|iiia, pcccci cx na|iiu), anche
se non ne discende che chi ecca cx ccria na|iiia ecchi necessariamenle anche cx na|iiu
(arl. 3).
17 Circa mores |.j MaIilia sciIicel quae corruliva esl virlulis el moderalricis as-
sionum. |.j MaIiliae aulem conlrarium esl virlus, ALIRTO MAGNO, Supcr |inica, VII,
ca. 1, Opcra cnnia, ediz. di Lione 1651, IV, . 263a. A maIilia DiaboIi omne eccalum
originem lrahil, SAN TOMMASO, Supcr Scni., II, d. 5, q. 1, a. 3, s.c. 1, Omni aclu eccali
in maIilia crescil el in merilo ma|oris oenae, ivi, II, d. 7, q. 1, a. 2, arg. 5, Dicilur enim
ex maIilia eccare qui ex eIeclione ravi finis eccal, ivi, II, d. 7, q. 1, a. 2co, Ieccalo-
res, quamdiu in hac vila vivunl, ossunl fieri membra Chrisli, quanlumcumque
videanlur in maIilia obslinali, ivi, II, d. 7, q. 3, a- 2, ad 2.
18 SuIIa divisione dei eccali secondo Ia forma, I'oggello, iI fine, che Danle ha re-
senle in queslo canlo e che diIala oi coinvoIgendo Ia maleria arisloleIica, si uo
considerare quanlo si Iegge in AIberlo Magno, AIessandro di HaIes e San onavenlura.
AIberlo Magno dislingue iI eccalo in ollo modi: pcncs rcaiun: veniaIe, morlaIe, pcncs
insiruncnia: aroIe, oere, ensieri, pcncs naicrian: selle eccali cailaIi, pcncs causas:
er deboIezza, er ignoranza, er maIizia, pcncs inc|inaniia: limore, amore, pcncs jincn:
concuiscenza deIIa carne, concuiscenza degIi occhi, suerbia deIIa vila, pcncs in cun
in qucn pcccaiur: conlro Dio, conlro iI rossimo, conlro se slesso, pcncs jcrna|c in pccca-
iun: deIiclum, commissum (ALIRTO MAGNO, Sunna Tncc|cgiac, Iars II, lracl. 18, q.
115, membrum 4, Opcra Onnia, ediz. di Lione 1651, XVIII, . 519ab). Si lralla di ollo
divisioni, riroosle anche da AIessandro di HaIes (Sunna Tncc|cgica, l. III, ars II se-
cundi Iibri, inq. 2, lracl. 3, q. 3, ca. 3, 268 (Oc !itisicnc pcccaii aciua|is in gcncrc), ediz. di
Quaracchi, III, . 281a-282b. San onavenlura, seguendo Iielro Lombardo, roone
una divisione in selle aselli: causa (I'agenle): alluaIe, originaIe, Ia ena: morlaIe, ve-
niaIe, Ia molivazione: bene, maIe, amore, limore, iI soslralo: ensieri, aroIe, oere, Ia
ersona conlro cui si ecca: Dio, se slesso, iI rossimo, iI mandalo: commissum, deIic-
lum, i vizi a cui si da origine: selle vizi cailaIi (SAN ONAVINTURA, Scnicni., II, d. 41,
dub. 2, Opcra Onnia, II, . 976ab).
19 Des visces en moraIile que I'en doil moul eschiver sonl .iii., maIice cruaule el
Iuxure. Car .iii. verlus sonl Ior conlraires, benignile cIemence el chaslele. Aucun home
sonl de nalure divine ar Ie lres granl verlu ki en aus habonde, el cisl abis esl rore-
orloIo MarlineIIi 452
Magno
20
, arIa correllamenle di disosizione e non di eccalo, inle-
so neI senso di una sua secificila.
Quanlo aIIa besliaIila, essa non e dunque un eccalo secifico, ma
una disosizione che aggrava Ia manifeslazione, anche eslerna, deI
eccalo ed e er queslo che Danle non Ie assegna un oslo reciso
neII'ambilo deIIe suddivisioni deII'inferno e deIIa cIassificazione dei
eccali. IormaImenle considerala, Ia besliaIila cosliluisce un aggravio
lanlo deIIa maIizia che deII'inconlinenza
21
, in quanlo sueramenlo
di una misura, e come laIe non sembra lrovar un IausibiIe ricello
neII'|njcrnc danlesco, non nei canli che recedono Ia cilla di Dile, e
non nei canli che Ia seguono, erche si lralla di una condizione deIIa
ena e non deIIa forma deI eccalo.
7. IN IORMA DI SINTISI
A chiarire iI robIema uo essere uliIe quanlo osserva in roosilo
I'Aquinale, commenlando iI VII Iibro deIIa Niccnacnca, ma bisogna
menl conlraires a cruaule. Il leus homes sonl aeIes angeIiques u divins or
I'abondance des verlus ki esl en aus oulre Ies us des aulres en loules choses, aulresi
comme Ia bonle de Dieu sormonle Ia bonle des homes. Aulre homes sonl crueus en Ior
meurs, el son de nalure des feres besles, el sonl moul Ionlain de verlu. Il sonl home de
nalure de besle en arsivre Ior voIonles el Ior deIis, el sonl sambIabIe as singes el au
orceI. Il Ii home ki arsivenl Ior voIonles sonl aeIes eichures, c'esl a dire k'iI en-
senl dou deIil dou cors soIemenl. Il des homes ki sonl de nalure divine ou de nalure de
besles en loules choses sonl oi eI monde, mais ciI ki vivenl a Ioi de besle habilenl ens
eslremiles de Ia lerre ki uIee esl, car en droil midi sonl Ii elyoien, el ar devers se-
lenlrion sonl Ii escIavon. Il esl Ii hons aeIes de divine nalure our ou k'iI esl chasles
el conlinens, en ce k'iI se suefre des mauvaises concuiscences dou cors ar Ia force de
Ia verlu enleIIeclueIe, mais ceIui ki ne s'en suefre esl vencus ar ses desiriers el lres-
asse Ies bonnes de Ia Ioi. Car Ii homme onl Ior bonnes a quoi iI s'esmuevenl
nalureIemenl el enlre quoi iI se regirenl el lornoienl dedens Ie mi, se aulre oquoison ne
vienl en Ior nalure ki Ie face decIiner a vie de besle. Car Ies besles sonl desIiees, el our
ou ensivenl Ies movemens de Ior covoilises, el vonl ar mi Ies aslures, el ne se
suefrenl des choses a quoi Ior nalure Ies amaine. In cesl maniere isl Ii hons hors de ses
bonnes, el ensi esl iI resk'une besle, or Ia mauvaise vie k'iI a esIevee, a ce ke Ia sience
de I'omme esl verilabIe en ses oevres, Ii |itrcs !u Trcscr !c RUNITTO LATINI, II, ca. 39
(Ocs tisccs cn ncra|iic), ediz. crilica a cura di Irancis }. Karmody, erkeIey and Los An-
geIes, Universily of CaIifornia Iress 1948, . 205-206.
20 Cfr. ALIRTO MAGNO, Supcr |inica, VII, Ieclio I, Opcra cnnia, ediz. di Lione 1651,
XIV/2, . 519ab.
21 Si veda, in roosilo, ALIRTO MAGNO, Supcr |inica, VII, ca. 1 e ca. 10, Opcra
cnnia, ediz. di Lione 1651, IV/1, . 263ab, 276b-277a, e, reIalivamenle aIIa maIizia, an-
che TOMMASO d'AQUINO, Scnicniia |i|ri |inic., VII, Ieclio 6, n. 19. Secondo San
Tommaso, oi, si uo arIare anche di una concuiscenza e Iussuria besliaIe (Supcr
Scni., III, d. 35, q. 1, q. 1, co.), in arlicoIare, iI eccalo conlro nalura (ex concubilu con-
lra naluram) uo essere dello besliaIe (Supcr Scni., IV, d. 41, q. 1, a. 4, q. 2 ad 4).
|| canic X| !c||Inferno 453
ur dire che iI leslo di ArisloleIe (VII, 1, 1145 a15-1145 b 8, VII, 5, 1248
b15-1149 a 21)
22
, Iello er esleso, non si reslava a lanlo disendio di
energie e di inleIIigenza, come in genere si e fallo.
Lasciamo dunque Ia aroIa aII'Aquinale, che cos esordisce as-
sando a commenlare iI rimo cailoIo deI Iibro VII deIIa Niccnacnca:
Iosl haec aulem dicendum, aIiud facienles rinciium el celera.
Ioslquam hiIosohus sura delerminavil de virlulibus mora-
Iibus el inleIIecluaIibus, hic inciil delerminare de quibusdam
quae consequunlur ad virlulem. Il rimo de conlinenlia, quae
esl quiddam imerfeclum in genere virlulis. Secundo de amici-
lia, quae esl quidam effeclus virlulis, in oclavo Iibro, ibi, osl
haec aulem de amicilia el celera. Terlio de fine virlulis, in X
Iibro, ibi: osl haec aulem de deIeclalione el celera. Circa
rimum duo facil. Irimo delerminal de conlinenlia el eius o-
osilo. Secundo de deIeclalione el lrislilia quae sunl earum
maleria, ibi: de deIeclalione aulem el lrislilia el celera. Circa
rimum duo facil. Irimo dislinguil conlinenliam ab aIiis quae
sunl eiusdem generis. Secundo de ea delerminal, ibi: videlur
ulique conlinenlia el celera. Circa rimum duo facil. Irimo
dislinguil conlinenliam el eius oosilum ab his quae sunl
eiusdem generis. Secundo oslendil de quibus eorum sil diclum,
el de quibus reslel dicendum, ibi, sed de hac quidem disosi-
lione el celera. Circa rimum duo facil. Irimo enumeral habilus
22 Riorlo qui Ia rima sezione deI leslo di ArisloleIe, secondo Ia lraduzione di Ro-
berlo Grossalesla: Iosl hec aulem dicendum aIiud facienles rinciium, quoniam circa
mores fugiendorum lres sunl secies, maIicia, inconlinencia, besliaIilas. Conlraria au-
lem duobus quidem manifesla, hoc quidem enim virlulem, hoc aulem conlinenciam
vocamus. Ad besliaIilalem aulem maxime ulique congruil dicere suer nos virlulem
heroycam quandam el divinam. Quemadmodum Homerus de Heclore fecil dicenlem
Iriamum, quoniam vaIde eral bonus, neque videbalur viri morlaIis uer exislere, sel
dei. Quare si quemadmodum aiunl ex hominibus fiunl divini roler virlulis suerex-
ceIIenciam, laIis quidem ulique eril videIicel besliaIilali oosilus habilus. Il enim
quemadmodum neque beslie esl maIicia neque virlus, sic neque dei. Sel hec quidem
honorabiIius virlule, hec aulem aIlerum quoddam genus maIicie. Quia aulem rarum el
divinum virum esse, quemadmodum Lalones consueverunl aeIIare quando admiran-
lur vaIde aIiquem, divinus vir aiunl, sic el besliaIis in hominibus rarus, maxime aulem
in barbaris esl, fiunl aulem quidam el roler egriludines el orbilales, el roler maIi-
ciam aulem hominum suerexcedenles, sic suerinfamamus. Sel de hac quidem
disosicione, oslerius faciendum quandam recordacionem. De maIicia aulem diclum
esl rius. De inconlinencia aulem el moIIicie el deIiciis dicendum el de conlinencia el
erseverancia. Neque enim ul de eisdem habilibus virluli el maIicie ulramque isarum
susiciendum, neque ul aIlerum genus, ARISTOTILIS, |inica Niccnacnca, lransIalio
Roberli Grosselesle LincoIiensis, sitc Ii|cr |iniccrun, VII,1-2 1145 a 15-1145 b 8 (Arislo-
leIes Lalinus, XXVI, 1-3/3, . 272-273).
orloIo MarlineIIi 454
seu disosiliones circa moraIia viluerabiIes. Secundo onil
eorum oosila, ibi: conlraria aulem duobus el celera.
L'Aquinale quindi rosegue, resenlando Ia lriarlizione arislole-
Iica:
Dicil ergo rimo, quod osl ea quae dicla sunl de virlulibus
moraIibus el inleIIecluaIibus, ad hoc quod nihiI moraIium rae-
lermillalur, oorlel ab aIio rinciio resumere, ul dicamus,
quod eorum quae sunl circa mores fugienda, lres secies sunl:
sciIicel maIilia, inconlinenlia el besliaIilas.
I loslo aggiunge:
Il horum quidem differenliam sic oorlel acciere. Cum
enim, ul in VI diclum esl, bona aclio non sil sine ralione racli-
ca vera el aelilu reclo, er hoc quod aIiquid horum duorum
erverlilur, conlingil quod aIiquid sil in moribus fugiendum. Si
quidem igilur sil erversilas ex arle aelilus ul ralio raclica
remaneal recla, eril inconlinenlia, quae sciIicel esl, quando aIi-
quis reclam aeslimalionem habel de eo quod esl faciendum veI
vilandum, sed roler assionem aelilus in conlrarium lra-
hil. Si vero inlanlum invaIescal aelilus erversilas ul ralioni
dominelur, ralio sequelur id in quod aelilus corrulus incIi-
nal, sicul rinciium quoddam exislimans iIIud ul finem el
olimum, unde ex eIeclione oerabilur erversa, ex quo aIiquis
dicilur maIus, ul diclum esl in quinlo. Unde laIis disosilio
dicilur maIilia.
La maIizia, roriamenle della, e sorallullo una forma di inlem-
eranza, cioe deIIa modaIila (ccnicnpcraniia) che si deve assumere neI
comiere un'azione, e una erversila deII'aelilus che corrome Ia
ragione. I queslo uo avvenire in due modi:
Uno igilur modo olesl conlingere erversilas in laIi consonan-
lia, ila quod non exealur exlra Iimiles humanae vilae: el lunc
dicelur simIiciler inconlinenlia veI maIilia humana, sicul
aegriludo humana cororaIis, in qua saIvari olesl nalura
humana. AIio modo olesl corrumi conlemeranlia humana-
rum affeclionum, ila quod rogredialur uIlra Iimiles humanae
vilae in simiIiludinem affeclionum aIicuius besliae, ula Ieonis,
ursi aul orci, el hoc esl quod vocalur besliaIilas. Il esl simiIe,
|| canic X| !c||Inferno 455
sicul si ex arle cororis comIexio aIicuius mularelur in
comIexionem Ieoninam veI orcinam.
La maIizia, cos come ure I'inconlinenza, uo essere considerala
slrellamenle in se, cioe sinp|iciicr, oure con un aggravio, cun a!!i-
iicnc, e si uo aIIora arIare di na|iiia |csiia|is, cos come si uo arIare
di inccniincniia |csiia|is
23
.
Cos San Tommaso, e cos Danle. I Ia ragione e moIlo semIice,
erche, come aveva soslenulo anche San onavenlura
24
, iI bene (|c-
nun) si allua in un soIo modo (in unun nc!un), menlre iI eccalo
(pcccaiun), in quanlo anche abilo, aI conlrario e muIliforme (nu|iija-
riun).
Unitcrsiia Caiic|ica !c| Sacrc Cucrc Mi|anc c Brcscia
23 SAN TOMMASO, Scnicniia |i|ri |inic., VII, Ieclio 5, n. 16
24 Quaerilur de hoc quod dicil |iI Magislerj: Mc!i pcccaicrun tarias in Scripiura na-
|cni !isiinciicncs. Videlur enim, quod non soIummodo tarias habeanl, immo eliam
injiniias, quia, sicul vuIl IhiIosohus, bonum esl uno modo, maIum aulem muIlifa-
rium. Il ise eliam Dionysius dicil, quod maIum esl infinilum: SAN ONAVINTURA,
Scnicni., II, d. 41, dub. 2, Opcra Onnia, II, . 976ab.
MARIA CICALA
IL CANTO XII DILL'|N|||NO
1. "DIVISIONI IN IARTI, IUNZIONALI ALL'ILLUSTRAZIONI
DILLA SINTINZIA
Irima di enlrare neI merilo di rifIessioni secifiche che una Icciura
comorla ho avverlilo I'esigenza revenliva di riercorre Ie Iinee
fondamenlaIi deI canlo XII deII'|njcrnc.
NeI vagIiare quesla oorlunila mi sono resa subilo conlo che
gia slavo dando un lagIio secifico aIIa mia rifIessione, assumendo
una osizione neI conleslo degIi innumerevoIi quanlo aulorevoIi
commenli e |cciurac deII'oera di Danle.
Infalli, dando avvio aIIa mia conversazione in queslo modo, mi
aIIineo a un comorlamenlo diffuso (anche se con differenli modaIila)
nei moderni sludiosi deIIa Ccnc!ia, ma ravvisabiIe anche in aIcuni
degIi anlichi commenlalori, aIIudo, er esemio, a Giovanni occac-
cio
1
, non meno che aII'aulore deIIe Cnicsc Vcrncn |IaIso occaccioj
2
1 GIOVANNI OCCACCIO, |spcsizicni scpra |a Ccnc!ia, a c. di Giorgio Iadoan, in Tuiic
|c cpcrc di Giovanni occaccio, a c. di Villore ranca, voI. VI, MiIano, Mondadori CIas-
sici 1965. Oggi si Iegge anche neII'edizione Mondadori Oscar, MiIano 1994. NeI
giugno deI 1373, aIcuni fiorenlini, allraverso una elizione ai Iriori deIIe Arli e aI Gon-
faIoniere di Giuslizia, chiesero e ollennero una Lellura ubbIica deIIa Ccnc!ia (aIIora
della c| Oanic), che venne affidala, iI 25 agoslo deIIo slesso anno, a occaccio. La sede
resceIla fu Ia chiesa fiorenlina di Sanlo Slefano in adia, dove Ia Iellura fu avviala Ia
domenica 23 ollobre 1373. Secondo Ia elizione essa doveva rocedere, con cadenza
quolidiana, escIudendo i giorni feslivi, er un inlero anno, ma, a causa di una noiosa
maIallia deI reIalore, fu inlerrolla doo una sessanlina di Iezioni, si resume nei rimi
mesi deI 1374 (cfr. I'inlroduzione di Iadoan, ivi, . VII). Infalli iI commenlo di occaccio
si inlerrome aI canlo XVII deII'|njcrnc.
2 IALSO OCCACCIO (CHIOSI VIRNON), Cnicsc scpra Oanic |Ccnncnic a||a Caniica
!c|||njcrnc !i Auicrc Ancnincj, a c. di G. W. Vernon, Iirenze, Iialli 1846 (e di base
siega ALDO VALLONI, Sicria !c||a criiica !anicsca !a| X|V a| XX sccc|c, Iadova, VaIIardi-
Iiccin 1981, n. 123, . 188 iI Cod. IoggiaIi-Vernon, ora resso Ia ibIioleca danlesca
deI Convenlo di S. Irancesco in Ravenna), leslo revisionalo da I. Ierrario. Le Cnicsc
Vcrncn siega VALLONI (ivi, . 180) riroducono una lraduzione deI commenlo
aII'|njcrnc di GrazioIo, nola gia aII'Ollimo neI 1333. GRAZIOLO DI' AMAGLIOLI (Ccn-
ncnic a|||njcrnc !i Oanic, a c. di L. C. Rossi, Iisa, ScuoIa NormaIe Sueriore di Iisa
Maria CicaIa 458
e a Guiniforle arzizza
3
, ma anche a Crisloforo Landino
4
, e quindi ad
AIessandro VeIIuleIIo
5
.
1998), nalo a oIogna neI 1291, bandilo daIIa sua cilla e quindi ersonaggio di riIievo a
NaoIi, slese, robabiImenle negIi anni lra iI 1322 e iI 1324, iI suo commenlo in Ialino
aII'|njcrnc, che ben reslo ebbe diffusione, infalli annola VALLONI (o. cil., . 123, nola
16) gia Io cila in due Iuoghi e in aIlri Iiberamenle Io adolla I'OTTIMO (IOiiinc
ccnncnic !c||a Oitina Ccnnc!ia. Tcsic inc!iic !un ccnicnpcrancc !i Oanic, a c. di A. Torri,
Iisa, Caurro 1827-29, risl. anasl. oIogna, A. Iorni ed. 1995), che raccogIie Ie sue idee
e via via scrive Ie sue osservazioni lra iI 1333 e iI 1340, quando Ie chiose e i commenli
di }acoo AIighieri, GrazioIo dei ambagIioIi e }acoo deIIa Lana sono ormai in circoIa-
zione (cfr. VALLONI, o. cil., . 87).
3 GUINIIORTI ARZIZZA, Ic Inferno !c||a Commedia !i Oanic A|ignicri cc| Ccncnic !i
Guinijcric !c||i Bargigi, iraiic !a !uc nancscriiii inc!iii !c| sccc|c !ccinc quinic, a c. di G.
Zaccheroni, MarsigIia-Iirenze, Mossy-MoIini 1838. IigIio di una deIIe iu nole figure
insigni deII'Umanesimo venelo, Gasarino arzizza (1360-1431), di ergamo, che inse-
gno in varie cilla ilaIiane, Guiniforle (1406-1463), neI 1434 aveva ollenulo a MiIano e a
Iavia Ia calledra che rima era slala di suo adre. Ma neI 1447, in seguilo ai rivoIgimen-
li miIanesi, era assalo neI Monferralo, oi a Ierrara resso orso d'Isle. NeI 1455
lornava a MiIano come recellore di GaIeazzo Maria e di IoIila Sforza. NegIi anni deI
rimo soggiorno miIanese si era dedicalo, in arlicoIare, a commenlare Ia Ccnnc!ia di
Danle ma ci e giunla soIo Ia arle reIaliva aII'|njcrnc , menlre IiIeIfo commenlava iI
Canzcnicrc deI Ielrarca, secondo un iano cuIluraIe gia voIulo da IiIio Maria Viscon-
li, assai allenlo aIIa oesia e aIIa Iingua voIgare. (IAOLO VITI, IUnancsinc nc|||ia|ia
sciicniricna|c c nc!iana, in Sicria !c||a |ciicraiura iia|iana, dir. da Inrico MaIalo, voI. III, ||
Quaiircccnic, Roma, SaIerno edilrice 1996, . 517-634 |561j, ma vd. anche Ia voce su
Barzizza, di GUIDO MARTILLOTTI, in DI, voI. VII 1965, . 39-41).
4 CRISTOIORO LANDINO, Ccncnic scpra |a Comeda !i Oanic A|ignicri pccia |icrcniinc,
Iirenze, NicoIo di Lorenzo deIIa Magna 1481 (leslo rovvisorio a c. di IaoIo Irocaccio-
Ii). Oggi iI commenlo di Landino si Iegge neII'Idizione NazionaIe dei Commenli
Danleschi, in quallro lomi, a c. di IrocaccioIi, Roma, SaIerno edilrice 2001. II Ccncnic in
voIgare di Landino secondo iI moderno curalore (ivi, inlroduzione, . 20-21) uo
essere inlerrelalo come risuIlanle di una doia azione, una remola e ersonaIe, nala
neIIo Sludio e riconducibiIe aIIa vicenda cuIluraIe di Landino, I'aIlra invece ubbIica,
nala nei saIoni di Via Larga o in IaIazzo deIIa Signoria e rossima, come finaIila, a un
rogello come Ia |accc|ia Aragcncsc, e da Ieggere, aI ari di quesl'uIlima, come momen-
lo di una iu generaIe camagna di recuero deIIa lradizione voIgare fiorenlina e di
inequivoca esressione di una voIonla di egemonia cuIluraIe (I'imerio di cui e sia iI
Prccnic deI Ccncnic Iaurenziano). II commenlo aI canlo XII deII'|nj. si Iegge neI lomo
II, Ia remessa (. 616) recila: In queslo duodecimo canlo discrive eI oela Ia scesa deI
sexlo cerchio neI selimo, el queIIo divide chome di sora habbiamo declo el onvi e
suIicii de' vioIenli, rima neI roximo, dioi in se medesimo, el uIlimamenle in Dio,
el one a guardia deI Iuogho e moslruosi cenlauri, el naxinc eI Minolauro di Crela.
5 Ia Comedia !i Oanic A|ignicri ccn |a ncta cspcsizicnc !i ALISSANDRO VILLUTILLO,
Venezia, I. Mandini 1544 (leslo rovvisorio a c. di IaoIo IrocaccioIi). II commenlo di
VeIIuleIIo, siega VALLONI (o. cil., . 249) er osizione e assai diverso da queIIo
deI Landino, egIi dichiara Ai Iciicri di voIersi dislaccare dai redecessori, erche i
senlimenli Ioro, lanlo aIIegorici, quanlo IelleraIi, aresso aI senlir suc, sono in diversi
modi senlili, di Iimilare Ie divagazioni slorico-erudile oiche non e isloriografo, ne
fabuIisla, di curare adegualamenle iI leslo erche gIi anlichi lesli scrilli a enna e
|| canic X|| !c||Inferno 459
AIIo slesso lemo Ia mia sceIla mi offre I'occasione di evidenziare
subilo che Ie modaIila con Ie quaIi ciascuno decide di deIineare, quaIi-
lalivamenle e quanlilalivamenle, Ia maleria narraliva oi anaIizzala si
connolano come segnaIe immedialo, offerlo aI ubbIico (che Iegge o
ascoIla), deIIa roria mediazione esegelica.
occaccio, er esemio, faceva recedere Ia sua |spcsizicnc |iiicra|c
(XII, 1-3), deIIa quaIe oggi ossiamo agevoImenle godere neII'edizione
Mondadori, iIIuslremenle curala da Giorgio Iadoan, da una scansione
deIIa maleria deI canlo in sei arli, neII'enunciazione deIIe quaIi
baIza subilo aII'occhio, neI modo di orgere iI discorso, I'insislenza suI
nome di VirgiIio e quindi suI ruoIo da Iui esercilalo, allraverso una
ilerazione non semre richiesla, o megIio non da lulli avverlila come
necessaria.
Irima di rocedere aII'anaIisi deIIe singoIe lerzine, neIIa sua arlico-
Iala e nulrila |spcsizicnc, aIIegorica oIlre che IelleraIe, iI cerlaIdese
esordisce con una considerazione di ordine generaIe, che, solloIinean-
do iI ruoIo-guida di VirgiIio, evidenzia una conlinuila lra queslo canlo
e iI recedenle:
Conlinuasi iI resenle canlo ||nj. XIIj aI recedenle assai
evidenlemenle, er cio che, avendogIi moslralo VirgiIio davanli
Ia universaI disosizione deIIo 'nferno e soIIecilandoIo a conli-
nuare iI cammino e moslralogIi iI baIzo Ionlano a Ioro
smonlarsi, qui ne dimoslra come, a queIIo Iuogo ervenuli, quaI
fosse Ia quaIila deI Iuogo er Io quaIe a scendere avevano.
Iffellivamenle Ia conlinuila qui segnaIala esisle, ma obbIiga anche
a una recisazione, briIIanlemenle solloIineala da orloIo MarlineIIi,
che in quesla Icciura Oaniis 2004 mi ha recedula, dimoslrando Ia
funzione-chiave di un canlo come I'undicesimo deII'|njcrnc, neI quaIe
iI oela, ur coslruendo, allraverso indicalori recisi, iI necessario ag-
gancio deIIa !igrcssic aIIa slrullura narraliva, e quindi risellivamenle
ai canli X e XII, aIIo slesso lemo si roone in una nuova vesle di
inlerIoculore cuIluraIe, non iu soIo suI iano narralivo, ma anche
dollrinaIe.
NeI canlo XI si configura una mediazione lra I'elica cIassica e
queIIa crisliana, rende coro una nuova gerarchia deI eccalo, vario
e liicizzalo in reIazione agIi individui. In aIlri lermini solloIinea
MarlineIIi queslo canlo di svoIla riveIa un mulamenlo ecIalanle
deIIa macchina narraliva, cioe deI iano deIIa Ccnc!ia.
ancor iu i moderni imressi a slama sono incorrellissimi. Di conlro, iI suo melo-
do roone un raffronlo di lesli, una sceIla ed una inlegrazione.
Maria CicaIa 460
La Iurificazione deI eccalo, e quindi Ia sollodislinzione deIIa
ena sconlala, a arlire daI XII canlo, raresenla uno degIi indicalori
iu evidenli deIIa lransizione daII'idea cIassica deI vizio (Iussuria,
II cerchio, goIosila, III cerchio, avarizia e rodigaIila, IV cerchio,
ira, suerbia e accidia, V cerchio), senza graduaIila di coIa e diversi-
ficazione di ena, aII'idea crisliana deI eccalo, unilo iu o meno
severamenle in base aI grado di gravila.
Nei vv. 28 e sgg. di |nj. XI, VirgiIio siega che iI rimo dei
lre cerchi che ancora rimangono, ossia iI sellimo deII'|njcrnc, e inlera-
menle occualo dai vioIenli:
Di vioIenli iI rimo cerchio e lullo,
ma erche si fa forza a lre ersone,
in lre gironi e dislinlo e coslrullo.
A Dio, a se, aI rossimo si one
far forza, dico in Ioro e in Ior cose,
come udirai con aerla ragione.
AI rimo girone deI sellimo cerchio e dedicalo I'inlero XII canlo,
neI quaIe solloIineo con IigureIIi
6
si risconlra una erfella unila
loografica e narraliva, infalli Ia descrizione fisica e moraIe e
inlera e comiula.
L'anaIilica descrizione deI Ioco, daII'ingresso dei due slrani
eIIegrini, allraverso Ia discesa, aII'uscila, in una visila guidala,
rima da VirgiIio e oi daI cenlauro di nome Nesso, reaIizza una unila
di raresenlazione, faciImenle ed efficacemenle lraducibiIe in lermi-
ni cinemalografici, come lra breve dimoslrero.
NeI rimo girone deI sellimo cerchio annuncia VirgiIio neI canlo
XI sono unili i vioIenli conlro iI rossimo, er diverse schiere
(|nj. XI, v. 39), ossia in grui dislinli in base aIIa diversila deIIe coIe
(cfr. ivi, vv. 34-39). Mi sembra dunque imorlanle non sollovaIulare
Ia quaIila deII'eIemenlo di differenziazione che coIIoca iI XII canlo
in una osizione-chiave: mulamenlo deIIa fiIosofia (in senso Iellera-
Ie, aIIegorico e moraIe) sollesa aII'inserimenlo di una nuova ielra
neIIa coslruzione deI medesimo edificio.
Nei vv. 61-63 di |nj. IX iI oela Iancia un avverlimenlo che qui mi
sembra oorluno ricordare:
6 Cfr. IIRNANDO IIGURILLI, || canic X||. Oiccn|rc 1960, in Icciura Oaniis Sca|igcra,
dirella da Mario Marcazzan con SiIvio Iasquazi, voI. I, |njcrnc, Iirenze, Le Monnier
1967, . 391-424 |397-398j.
|| canic X|| !c||Inferno 461
O voi ch'avele Ii 'nleIIelli sani,
mirale Ia dollrina che s'asconde
sollo 'I veIame de Ii versi slrani
La funzione di avverlimenlo, neI caso deI canlo XII, sembra assoIla
daII'inlero canlo dollrinaIe che Io recede.
Subilo doo aver riIevalo e molivalo Ia conlinuila neIIa slrullura
narraliva, occaccio, conservando Ia funzione di soggello e/o oggello
di allenzione, assegnala a VirgiIio neI suo modo di orgere iI discorso,
siega:
I dividesi iI resenle canlo in sei arli:
- neIIa rima, come dello e, dimoslra Ia quaIila deI Iuogo er Io
quaIe aveano a scendere e cui sora queIIo lrovassero,
- neIIa seconda one come scendessero e aIcuna cosa che in
queIIa scesa gIi ragiona VirgiIio,
- neIIa lerza discrive come VirgiIio gIi moslrasse un fiume di
sangue e che genle dinlorno v'andasse,
- neIIa quarla moslra come VirgiIio arIasse a' Cenlauri che 'I
fiume circuivano e fossenegIi un concedulo er guida,
- neIIa quinla dice come, seguendo iI cenlauro, esso dimoslras-
se Ioro | VirgiIio e Danlej Ie ene de' liranni e de' rubalori,
- neIIa sesla e uIlima, come, avendo iI cenlauro assalo I'aulore
daII'aIlra arle deI fiume, se ne lornasse indielro
Infine iI cerlaIdese suggerisce come individuare, allraverso degIi
incipii, I'avvio di ciascuna deIIe arli segnaIale. DeIIa rima ha gia
dalo conlo
- Ira Io Ioco, ove a scender Ia riva elc. |cfr. i vv. 1-27: Ia frana,
I'inconlro coI Minolauro, I'inlervenlo decisivo di VirgiIioj,
quindi va oIlre, secificando che
- La seconda comincia quivi: Cos rendemmo via |cfr. i vv.
28-45: discesa er Io scarco / di queIIe ielre e siegazione
di VirgiIio suII'origine deIIa frana, in lermini bibIici e fiIosofi-
cij,
- Ia lerza quivi: Ma ficca gIi occhi |cfr. i vv. 46-57: VirgiIio in-
vila Danle a guardare Ia riviera di sangue e iI oela
descrive cio che vede, iI Iuogo e i cenlaurij,
Maria CicaIa 462
- Ia quarla quivi: Udendoci caIar |cfr. i vv. 58-98: Danle, Vir-
giIio e i Cenlaurij,
- Ia quinla quivi: Noi ci movemmo |cfr. i vv. 99-138: Ia visila
rosegue con Ia scorla fida di Nessoj,
- Ia sesla e uIlima quivi: Ioi si rivoIse |cfr. iI v. 138: Nesso,
comiula Ia sua missione, si gira e assa nuovamenle iI
guazzo er lornare aI suo osloj.
Quallro (o forse cinque) sono invece Ie arli, uliIi ad arire
Ia senlenzia deIIa cosa divisa, individuale, segnaIale e quindi conno-
lale (neII'eslensione, neIIa quaIila e neIIa roorzione) da Iernando
IigureIIi
7
, suIIa faIsa riga dei suggerimenli danleschi da Iui oorlu-
namenle coIli neIIa Viia Nucta (cailoIi XIV, XIX e XLI), com-
menlando, neI dicembre deI 1960, iI XII deII'|njcrnc, neI conleslo deIIa
Icciura Oaniis Sca|igcra.
NeI cailoIo XIV deIIa Viia Nucta, doo aver rooslo iI leslo di un
sonello, Io quaIe comincia: Ccn |a|irc !cnnc, Danle siega (ivi, 13):
Queslo sonello non divido in arli, ero che Ia divisione non si
fa se non er arire Ia senlenzia | iIIuslrare iI sensoj de Ia cosa
divisa, onde con cio sia cosa che er Ia sua ragionala | narrala
neIIa rosaj cagione assai manifeslo, non ha mesliere | non e
necessarioj di divisione.
In laI modo egIi da esIicilamenle conlo di cosa sia er Iui e
quando riliene necessaria una divisione in arli, funzionaIi aIIa
iIIuslrazione deI senso
8
.
II suggerimenlo di non dividere in arli sembra essere slalo
accoIlo sia da Crisloforo Landino, neI Quallrocenlo, che da AIessan-
dro VeIIuleIIo, neI Cinquecenlo: enlrambi hanno avverlilo I'esigenza
di far recedere Ie chiose anaIiliche da una inlroduzione (brevissima
I'uno, un o' iu eslesa I'aIlro), rilenendo ambedue inoorluna una
arlizione.
NeI cailoIo XIX deIIa slessa V. N., inlroducendo (ivi, 3) Ia canzo-
ne-chiave, famosa e sislemalicamenle anloIogizzala nei manuaIi di
uso comune, che segna una aIlrellanlo nola svoIla oelica, Ocnnc
cnatcic inic||ciic !ancrc, I'AIighieri Ia definisce
ordinala neI modo che si vedra sollo ne Ia sua divisione,
7 Ivi, . 398-399.
8 Cilo daIIa edizione deIIa Viia Nucta, con inlroduzione di Giorgio Ielrocchi e
commenlo di MarceIIo Cicculo, MiIano, UR 1994.
|| canic X|| !c||Inferno 463
ribadendo Ia funzione esIicaliva deIIa divisione, che qui egIi
roone, doo iI leslo, connolandoIa come moIlo iu comIessa
risello aIIe recedenli:
Quesla canzone, accio che sia megIio inlesa, Ia dividero iu ar-
lificiosamenle che I'aIlre cose | leslij di sora. I ero rima ne
fo lre arli,
corrisondenli a roemio, inlenlo lrallalo e serviziaIe | in fun-
zionej de Ie recedenli aroIe.
AIIa lriarlizione segue una uIleriore arlicoIazione deII'cxp|icaiic,
funzionaIe aI migIiore inlendimenlo, in iu minule divisioni,
inferiori numericamenle a quanle sarebbe necessario ricorrere, ma
sufficienli er i conoscenli.
Mi sembra queslo iI modeIIo di riferimenlo aI quaIe si conforma Ia
sceIla di un aIlro dei iu anlichi commenlalori, Guiniforle arzizza.
IgIi esordisce con una considerazione generaIe, di raccordo, che Iega
iI XII canlo aI recedenle:
Servando I'ordine descrillo neIIa seconda arle deI recedenle
Canlo, ora comincia Danle a lrallare di queIIi, che con forza in-
giuria fanno. I erocche laIi abbiamo udilo essere unili aI
sellimo cerchio dislinli in lre gironi, secondo che a lre ersone
si uo con forza ingiuria fare, aI rossimo, a se medesimo, ed a
Dio, neI resenle duodecimo Canlo si lralla deI girone rimo,
neI quaIe in boIIore di sangue sono unili quei eccalori che
forza fanno aI rossimo.
Quindi siega Ia comIessa divisione da Iui resceIla in funzione
esIicaliva, accio Ia maleria deI canlo sia megIio inlesa, direbbe
Danle (cfr. V. N., ca. XIX, cil.), soggiungendo ero rima ne fo lre
arli.
arzizza infalli enuncia Ia sua scansione rima in lre arli rinci-
aIi:
- neIIa rima si conliene Ia discesa di VirgiIio, e Danle giu er
Ia ria aI sellimo cerchio,
- neIIa seconda si descrive, come avvicinandosi aI basso di
queIIa ria, dov'era un fiume di sangue boIIenle, ivi irctc i
Cenlauri, dai quaIi, fallo ch'ebbero oche aroIe, non soIa-
menle ju |asciaic passarc, ma eziandio ricctciic aiuicric, ivi: O
cicca cupi!igia.
Maria CicaIa 464
- NeIIa lerza !cscritc iI suo assaggio, e iI modo deIIa ena,
ch'ivi irctc, c ncnina aIcuni sirili dannali in iseciaIila, ivi:
Or ci nctcnnc
9
.
In quesla rima lriarlizione I'ollica dominanle, lradila imIicila-
menle daIIe sceIle verbaIi (in arlicoIare daII'adozione deIIa lerza
ersona singoIare: irctc, ju |asciaic passarc, ricctciic aiuicric, !cscritc,
irctc, c ncnina) sembra queIIa deI narralore-oela-eIIegrino, che si
muove, vede, descrive.
Subilo doo arzizza avvia Ia sua anaIisi, alluando una iu
arlificiosa e iu solliImenle arlicoIala divisione deIIe rime due
arli rinciaIi, risellivamenle in lre e quallro arliceIIe, non
deIIa lerza (rassegna dei dannali e deI grado di ena da essi
sconlala), robabiImenle non a caso.
Si lralla di un commenlo degno di una allenzione secifica, che
devo necessariamenle demandare ad aIlra sede, non senza fare aIme-
no un cenno ad aIcune arlicoIarila.
CoIisce subilo, neIIa esosizione deIIe arliceIIe deIIa rima
arle rinciaIe, Ia quaIila deIIe argomenlazioni geografiche, che
chiosano I'aggellivo aIeslro, coI quaIe Danle connola I'asello
fisico deI Ioco, imIicilamenle visuaIizzando una serie di dellagIi:
sassoso, asro ed erlo, come sono Ie AIi, annola arzizza, aIIegan-
do Ie sue ragioni:
Iroriamenle Ie AIi sono queIIe monlagne, che giunle insieme
neI Ioro dosso dividono I'IlaIia daIIe arli oIlramonlane, e mel-
lono un ie neI mar di Genova, aresso a Nizza di Irovenza,
un aIlro ie in Islria neI mar di Venezia. Quesle monlagne sono
queIIe, neIIe radici deIIe quaIi, aIIa fronliera di qua, vediamo
fondale ergamo, rescia, Trenlo, Verona, ed aIlri Iuoghi assai.
Da quesle AIi e lrasferilo iI vocaboIo, sicche ogni Iuogo asro,
sassoso ed erlo uo esser chiamalo aIeslro. Ira dunque aIe-
slro e difficiIe queI Iuogo deIIa discesa aI sellimo cerchio.
AIlrellanlo dellagIiala risuIla Ia chiosa aIIa simiIiludine coI
Iuogo reaIe (Ia frana nola come S|atini !i Marcc, suIIa riva sinislra
deII'Adige, neI lrallo che va da Verona a Trenlo, a sud di Roverelo)
aI quaIe Danle rinvia, ricordando quaIcosa che, forse, ha vislo di
ersona e sicuramenle ha Iello, in un'oera a Iui ben nola di AIberlo
Magno (Mciccr. III, 6)
10
, come dellagIialamenle dimoslra NalaIino
9 II corsivo e mio.
10 II disegno secuIalivo di Danle siega GIULIO IIRRONI (Sicria !c||a |ciicraiura
|| canic X|| !c||Inferno 465
Saegno
11
.
Quesl'uIlimo
12
, scaIzando Ia chiosa di arzizza e recuerando soIo
neIIa seconda arle queIIa di occaccio (che coIIegava aIeslro ai
lrarui deII'AIi, ma anche, er eslensione, a queIIi de' Iuoghi saI-
valici), liene a secificare, in base a una Iellura inlerlesluaIe deI
macroleslo danlesco, che a|pc in Danle sla er
- monlagna in genere, senza arlicoIare riferimenlo aI sislema
aIino, come avviene in |nj. XIV, 30
13
, Purg. XVII, 1
14
e
XXXIII, 111
15
,
- uo indicare gIi Aennini, a giudicare da cio che si Iegge
in |nj. XVI, 101
16
, in Purg. XIV, 32
17
o in quaIche Iuogo deIIe
iia|iana, voI. I, Oa||c Origini a| Quaiircccnic, Torino, Iinaudi 1995, . 192) non si risoIve
in una dirella aIicazione deIIa fiIosofia di Tommaso d'Aquino, ma liene conlo |.j
anche deII'averroismo e deIIa dollrina di un aIlro grande fiIosofo deI secoIo XIII, iI do-
menicano AIberlo Magno. IiIosofo e leoIogo ledesco (Lauingen 1205 ca. CoIonia
1280), sanlo, fu lra i rimi fiIosofi medievaIi ad affermare I'aulonomia deI ensiero
fiIosofico e scienlifico daIIa leoIogia. Sludio a oIogna e a Iadova, neI 1223 enlro
neII'ordine domenicano. Insegno leoIogia neII'Universila di Iarigi e oi neIIo sludio
leoIogico dei domenicani a CoIonia.
11 NeII'edizione in lre voIumi deIIa Ccnnc!ia da Iui curala, Iirenze, La Nuova IlaIia
1987 (1955, rima ed.), nola aI v. 5 deI canlo XII deII'|nj. NeII'oera di AIberlo Magno
discorrendo deIIe varie cause che rovocano Ie frane (lerremoli, erosione deIIe acque,
ecc.), si accenna aIIa grande monlagna, che reciilo neI fiume Adige, suIIe AIi fra
Trenlo e Verona, e seeII aesi e uomini er Io sazio di lre o quallro Ieghe. II v. 6,
dove Danle si sofferma incidenlaImenle suIIe cause ossibiIi deI fenomeno (e Ie Iascia
incerle, Iaddove AIberlo, neI caso secifico roendeva ad escIudere iI icrrcncic, e a
considerare soIlanlo iI fallo deII'erosione, che scaIza Ie fondamenla deIIe rocce, vaIe a
dire iI scsicgnc nancc), e sia evidenlissima deIIa derivazione Iibresca deIIa simiIiludi-
ne (corsivo mio). Cio non escIude che Danle abbia olulo vedere di ersona
I'accennala ruina.
12 Ivi, nola aI v. 2.
13 come di neve in a|pc | in ncniagnaj senza venlo (corsivo mio).
14 Ricordili, Iellor, se mai ne I'a|pc | in ncniagnaj li coIse / nebbia |.j (corsivo
mio).
15 I vv. 110-111 recilano: quaI sollo fogIie verdi e rami nigri / sovra suoi freddi rivi
I'A|pc orla, scegIiendo come immagine di riferimenlo i jrc!!i ruscc||i di ncniagna (cor-
sivo mio). SuII'argomenlo cfr. Ia nola di Saegno (a c. di, o. cil.) aI v. 109.
16 Nei vv. 94- 102, iI oela aragona Ia cascala deI IIegelonle daI sellimo aII'ollavo
cerchio a queIIa che fa iI Monlone, resso S. enedello deII'AIe neII'Aennino emiIia-
no. II Monlone, siega Saegno (neII'ed. da Iui curala, cil., nola aI v. 94 di |nj. XVI)
er chi vada daI Monviso in direzione di Ievanle, era iI rimo, lra i fiumi che scendono
daI versanle sinislro deII'Aennino, che avesse un suo corso aulonomo (prcpric canni-
nc |v. 94j), che si gellasse cioe direllamenle in mare (menlre lulli gIi aIlri affIuiscono aI
Io). Oggi iI rimo sarebbe iI Reno, che a quei lemi sboccava anch'esso neI deIla ada-
no.
17 I'a|pcsirc monle ond'e lronco | vioIenlemenle lroncaloj IeIoro | cao Iaroj:
Maria CicaIa 466
|inc,
- come aII'ooslo Apcnninc uo riferirsi aIIe AIi in senso
secifico, fenomeno verificabiIe sia in |nj. XX, 65
18
che neI Oc
tu|g. c|cq. I, VIII.
In ogni caso Ia digressione geografica di arzizza mi sembra un in-
leressanle segnaIe deIIa sua lendenza a coIIegare e siegare cio che
Iegge, quando e ossibiIe, con Ia reaIla langibiIe, geografica o slorica.
Anche quando si sofferma sui Cenlauri, egIi confronla Ia favoIa
miloIogica, narrala dai oeli
19
, con Ia verila di sloria
20
, rima di
molivare Ie due ragioni che a suo avviso indussero Danle a coIIocarIi
qui Danle si riferisce aII'Aennino, Ia calena monluosa, da cui si slacco in lemi re-
molissimi, er un'oscura calaslrofe geoIogica, iI monle IeIoro, aII'eslrema unla nord-
orienlaIe deIIa SiciIia (nola di Saegno, neII'ed. da Iui curala, cil., aI v. 31 di Purg. XIV,
corsivo mio). La lradizione che Ia SiciIia fosse un lemo unila aII'IlaIia, e se ne slaccas-
se oi er un vioIenlo molo leIIurico, era gia nei oeli cIassici (cfr. VirgiIio, Acn., III, 410-
19, Lucano, Pnars., II, 435-38) e corrisonde deI reslo a un evenlo reaIe anche er gIi
scienziali moderni. (Saegno, ivi, nola aI v. 32).
18 lra Garda e VaI Camonica e Pcnninc (cors. mio). I vv. 64-66 deI canlo XVI
deII'|nj. annola Saegno (ivi, nola aI v. 64) hanno dalo Iuogo a moIle discussioni,
comIicale anche daII'incerlezza deI leslo (dove si uo Ieggere invece di c Pcnninc,
Apcnninc). Accellando Ia Iezione roosla daI VandeIIi e riresa anche da Ielrocchi,
bisognera siegare inlendendo lulla Ia delerminazione IocaIe ira Gar!a c Va| Cancnica c
Pcnninc come soggello grammalicaIe di si |agna |.j. Occorre in ogni modo arlire daI
fallo che Apcnninc o Pcnninc (A|pcs Apcnninac) fu comunemenle adoeralo neI Medioe-
vo er indicare lulla Ia calena deIIe A|pi o una arle di essa, e in laI senso I'usa anche
Danle (Oc tu|g. c|cq., I, VII, 9, |pisi., V||, 5, cfr. MAGNAGHI, in Gicrn. sicr. !c||a |cii. iia|.,
suI. 19-21, . 383 e ss.): qui slara er Ia zona aIina lra Ia VaI Camonica e Ia IocaIila
di Garda suIIa riva veronese deI Iago, Ia quaIe si |agna dei miIIe rivi che vanno ad aIi-
menlare iI enaco (corsivo mio).
19 Cenlo baslardi, nali daII'unione di una nuvoIa con Ie fallezze di Giunone con
Isione, inlemeranle e lemerario secrelario di Giove, uomini monslruosi, moIlo
veIoci, vioIenli, e feroci, che daII'umbiIico in su avevano figura d'uomo, e neI reslanle
avevano figura di cavaIIo.. Quasi lulli uccisi, er unire Ie Ioro angherie aIIe nozze di
Iiriloo, Ioro fraleIIo, non ero moslruoso, ne baslardo nalo di nuvoIa com'essi, con
Iodamia, er mano di Teseo e deI ooIo dei Laili, che corsero in armi in soccorso
di Iiriloo. (Cfr. ARZIZZA, o. cil., chiosa ai vv. 55-57 di |nj. XII).
20 Iurono i rimi uomini, neI regno dei Laili in TessagIia, ad armeggiare a cavaIIo,
munili di archi e saelle er seminare vioIenza. La genle grossa, che mai aveva vislo
dei cavaIIi, Ii scambio er uomini-cavaIIo. (Trovo, secondo verila di sloria, che i cen-
lauri furono uomini d'arme, i rimi, che cominciarono, neI regno dei Laili in TessaIia,
armeggiare a cavaIIo. Usavano cosloro lirare deII'arco, e moIle vioIenze facevano ai
ooIi di queI aese. Indi accadde, che non olendo que' ooIi arossimare a cosloro
er cagione deI saellare da Iungi, vedendoIi, quando abbeveravano i Ioro cavaIIi, daIIa
seIIa in suso essere uomini, e daIIa seIIa in giu essere cavaIIi, Ia genle grossa, che mai
non aveva vedulo uomini a cavaIIo, credelle che fossero mezzo uomini, e mezzo cavaI-
Ii: ARZIZZA, o. cil., chiosa ai vv. 55-57 di |nj. XII).
|| canic X|| !c||Inferno 467
in queslo Iuogo:
Vedula Ia favoIa e Ia sloria di quesli Cenlauri, dico, che er due
cagioni Ii ha oslo Danle in queslo Iuogo, una, er deservire
aIIa sua oesia, voIendo egIi moslrare, che neII'|njcrnc lrovalo
abbia lulle Ie cose moslruose, deIIe quaIi hanno fallo menzione
gIi aIlri oeli, e voIendo coIIocare ciascuna di quesle cose in
Iuogo a Ioro convenevoIe, non ne vide aIcuno iu arorialo
ai Cenlauri, com'e queIIo dei vioIenli, ai quaIi essi furono servi-
lori neI mondo. L'aIlra cagione si e, er dare ai vioIenli ena
convenienle a Ioro, oiche voIendo raresenlare aIIa menle
umana, quanlo orribiIe, e misera, e ad aIquanla servilu solloo-
sla sia Ia vila dei vioIenli, e massimamenle di queIIi che fecero
Ie grandi vioIenze, finge, che laIi siano unili in una fossa di
sangue boIIenle, secondo che in vila semre boIIono in ira, e de-
siderio. Cosloro slanno sommersi, ed aozzali neI sangue
umano di queIIi che sono morli er cagion Ioro, e di queIIi, che
miseramenle slenlando di fame, di freddo, e di aIlre necessila
consumano iI sangue, e sessa fiala Iasciano Ia vila, divorali da
maIallie, aIIe quaIi non ossono rimediare, imoverili er rube-
rie, er saccomani, er soerchie iIIicile lagIie, e er diverse
oressioni, che fanno i vioIenli, ovvero consenlono che siano
falle
21
.
La menlaIila fiIoIogica di arzizza, queIIa slessa che Io induce a
siegare che riticra chiamano i Irancesi Ia jiunara
22
, er cui riviera
di sangue fiumara deI sangue neI quaIe e condannalo a boIIire
chi queI sangue ha versalo, Io orla a rifIellere diacronicamenle
suII'origine slorica o milica dei Cenlauri, iu che sincronicamenle
suIIe molivazioni sloriche che olrebbero aver indollo iI Ioela ad
associare queIIe figure ai soIdali e mercenari che si arruoIavano neIIe
comagnie di venlura aI servizio dei liranni, come, rirendendo
I'ollica di occaccio e uli, referiscono evidenziare aIcuni crilici
moderni (vd., er esemio, Saegno).
NeIIa favoIa oelica arzizza lrova anche un aigIio aIIa sceIla
nominaIe definila daI lrillico marmoreo che Danle slacca daI
branco e scoIisce in rimo iano: Nesso (in su Ia deslra, v. 97),
Chirone (queI di mezzo, v. 70), IoIo (queII'aIlro, v. 72, suIIa
sinislra).
Nesso con Ie sue cauleIe see fuggir Ia briga, quando aIIe nozze
21 ||i!.
22 II corsivo e mio.
Maria CicaIa 468
di Iiriloo furono uccisi oco di meno lulli i comagni, e si ridusse neI
regname di CaIidonia, dove s'innamoro di Deianira, che IrcoIe
guadagno er sua sosa. Giunli gIi sosi nei ressi deI fiume Ive-
no, che aIIora in laI modo era cresciulo er ioggia, che non si oleva
assare aI guazzo |.j non olendo insieme nuolar oIlra IrcoIe con
Deianira, si offerse Nesso Cenlauro, sollo secie di graziosila, a orla-
re Deianira di Ia aII'aIlra riva
23
: e iI medesimo ruoIo che egIi svoIge
neI canlo XII.
Ma anche aIIe aroIe con Ie quaIi VirgiIio Io connola arzizza da
una siegazione, lrovala nei oeli (vd. Ovidio, Mcian. IX, 98-133)
24
:
effrenalo, ed ardenle in concuiscenza di coslei, quando fin
oIlra iI fiume, Ie voIIe far forza. Ier Ia quaI cosa gridando essa
ad aIla voce, e dimandando soccorso aI marilo, IrcoIe saello, e
morlaImenle fer Nesso con una deIIe saelle venerale neI
sangue deI serenle Idra. Ier quesla cagione disse VirgiIio di
sora: maI fu Ia lua vogIia semre s losla, ed anche Io disse er
Ie nozze di Iiriloo e Iodamia |.j
25
.
AIIa vioIenza esercilala suIIe donne in quesla occasione rese arle
anche IoIo, nolo neIIa Ieggenda er I'aggressione aIIa sosa
26
. Tra i
Cenlauri, figIiuoIi d'Ision, e fraleIIi di Nesso annola arzizza
27
uno fu nominalo IoIo, iracondo e ronlo ad ogni forza fare, di Iui
VirgiIio (|nj. XII, 72) dice a Danle: queII'aIlro e IoIo, che fu s ien
d'ira, I'ira foIIe (|nj. XII, 49), che scalena Ia vioIenza neIIe ersone.
Di Chirone, sceIlo da Teli come aio di AchiIIe, erche degno di
aIla slima, rofondo conoscilore deIIe virlu deIIe erbe e maeslro di
IscuIaio, medico oi ecceIIenlissimo, arzizza evoca Ia nascila,
non da Isione, ma da Salurno, che ne moliva Ia fisionomia
28
, e Ia fine,
che siega Ia sua coIIocazione in CieIo, come Sagillario, neIIo
Zodiaco
29
, e slabiIisce Ia differenza, risello a queIIa anlica, deIIa
23 Ivi, chiosa ai vv. 67-69.
24 Rinvio aII'edizione con lraduzione di Giovanna Iaranda ViIIa e nole di RosseIIa
Corli, MiIano, UR 1997, voI. II, . 520-525.
25 ARZIZZA, i|i!.
26 Su IoIo vd. OVIDIO, Mci. XII, v. 210 e sgg. e STAZIO, Tnc|. II, v. 563 e sgg.
27 ARZIZZA, i|i!.
28 Salurno, er nascondere aIIa mogIie Rea, Ia roria reIazione aduIlerina con
I'amala IiIire, si lrasfiguro in un cavaIIo. (ivi, chiosa ai vv. 67-69 di |nj. XII).
29 I oeli dicono, che essendo IrcoIe andalo a visilare amichevoImenle Chiron, e
maneggiando quesli Ie saelle di IrcoIe, gIiene cadelle una di mano, e Io fer in un iede.
Onde a Iui, iI quaI'era immorlaIe, essendo incurabiIe, e moIlo dogIiosa queIIa ferila, che
ad aIlri sarebbe slala morlaIe er cagione deI veneno deII'Idra neI quaIe erano linle Ie
|| canic X|| !c||Inferno 469
oesia di Danle, iI quaIe, accoslandosi iu |.j aIIa verila, non in
CieIo, ma neII'Inferno Io finge essere da se lrovalo.
Iochissimo sazio dedicano invece a Chirone, vaIenlissimo uomo
|.j e baIio d'AchiIIe e di IalrocIo e d'IscuIaio, ancor meno a IoIo,
azzo e crudeIissimo uomo, Ie Cnicsc Vcrncn, maggiormenle allenle
aIIa sloria di Nesso, villima e carnefice di IrcoIe, deIIa cui sosa,
Deianira, era invaghilo, e a queIIa deI Minolauro, secondo Ia fonle
ovidiana, recuerala anche in queIIa arle, cos ben sviIuala neIIa
Iellera di Arianna a Teseo neIIe |rci!i, ma non neII'|njcrnc danlesco
(IX, 54 e XII, 17), che sembra dar riIievo unicamenle aII'asello
osilivo deI duca d'Alene (anacronismo IessicaIe)
30
, in Iinea con
I'esegelica medievaIe. Issa, suIIa sinla deII'asserila oosizione
di Teseo aIIe forze diaboIiche, esaIlala aIlres daII'aureoIa di giuslizia e
di equanimila allribuila aI suo regno, suggerendo una seudo-
elimoIogia, Tncscu > Tnccs cu | buon Dioj, neII'eroe amava vedere
una jigura Oci / jigura Cnrisii
31
: neI canlo XII e ricordalo come coIui
che vinse I'infamia di Creli.
In quesle Cnicsc Vcrncn, che enunciano una divisione in quallro
arli, revaIe un inleresse rorio er Ia figura deI Minolauro, a
scailo di VirgiIio, Danle e i Cenlauri, non cerlo dei dannali, oggello
di non frelloIoso esame neIIa quarla arle.
In un simiIe conleslo sembra assare inosservala Ia digressione con
Ia quaIe VirgiIio moliva I'origine deIIa frana.
DellagIiala, e anch'essa finaIizzala aIIa evidenziazione deIIa quaIila
deI ri-uso danlesco deIIa lradizione, e invece Ia chiosa fiIosofica con Ia
quaIe arzizza iIIuslra Ia leoria di ImedocIe
32
, che siega iI caos
saelle, mosse gIi Dei a iela, che Io ricevellero in CieIo, e consiluironIo neI Zodiaco er
un segno chiamalo Sagillario (ivi, chiosa a |nj. XII, vv. 67-69).
30 Danle usa qui i lermini deI suo lemo, neI quaIe esisleva iI ducalo franco di Ale-
ne, definendo duca iI figIio deI sovrano (Igeo) e quindi a sua voIla re d'Alene. (Cfr.
Ia scheda su Tcscc, firmala da GIORGIO IADOAN, neI DI, . 595-596 |596j ). Teseo fu
cresciulo da Chirone, senza saere nuIIa deI adre, sfugg aI veIeno rearalo da Igeo,
aI suo arrivo ad Alene, er una forlunosa agnizione (cfr. Ovidio, Mci. VII, 404-455).
Comballe con i Laili conlro i Cenlauri, che, aIIe nozze di Iiriloo, nei fumi deII'aIcoI,
avevano dalo sfogo aIIa vioIenza (cfr. ivi, XII, 210-535). II suo nome ero e Iegalo soral-
lullo aII'uccisione deI Minolauro, con I'aiulo di Arianna, soreIIaslra deI moslro, di Iui
innamorala e in seguilo abbandonala (cfr. ivi, VIII, 169-176).
31 ||i!. In arlicoIare annola IADOAN (i|i!.) e slala solloIineala I'imorlanza
che laIe chiave inlerrelaliva assume risello aIIa Tc|ai!c di Slazio aIIa Iuce deI com-
menlo seudo-fuIgenziano edilo, lra gIi aIlri scrilli di IuIgenzio, da R. HeIm, Lisia
1898. SuII'argomenlo vd. anche IADOAN, || niic !i Tcscc c i| crisiiancsinc !i Siazic, Lel-
lere ilaIiane, XI (1959), . 432-457.
32 Secondo Ia dollrina di ImedocIe, che e riferila da ArisloIeIe neIIa Mciajisica er
comballerIa, I'ordine deI mondo e I'esislenza deIIe cose risuIlerebbero daIIa discordia
Maria CicaIa 470
e quindi iI fremilo deIIa lerra in lermini di amore, e I'amore
deII'universo che esIode, ribeIIandosi con olenle vioIenza, aIIa
morle di Crislo, CoIui che Ia gran reda / Ievo a Dile (|nj. XII, vv.
38-39) |Ie anime deI Limbo sollralle a Luciferoj.
NeI cailoIo XLI deIIa Viia Nucta, Danle anaIizza un sonello, O|irc
|a spcra, siegando roedeulicamenle (ivi, 2) che
ha in se cinque arli.
Riassume oi iI concello da Iui esresso in ciascuna di esse, e ne
segnaIa gIi incipii di riferimenlo (rorio come fa occaccio neIIa sua
|spcsizicnc), quindi, rima di roorne iI leslo, annola (ivi, 9):
Iolrebbesi iu solliImenle ancora |ossia con dislinzioni ancora
iu ricercalej, dividere, e iu solliImenle fare inlendere, ma
uolesi assare | Iasciar correrej con quesla divisa, e ero non
m'inlramello | non mi imegnoj di iu dividerIo.
Iacendo Ieva suIIe remesse slabiIile da Danle, aIIe quaIi raida-
menle rinvia, IigureIIi siega che Ia divisione aiula a megIio
inlendere e aggiunge, rovocaloriamenle rubando Ie aroIe aIIo slesso
Ioela (V. N., ca. XLI), che queslo canlo, er quanlo olrebbesi iu
solliImenle ancora dividere e iu solliImenle inlendere, ha in se
quallro arli:
- La rima comrende Ia descrizione deIIa ria e deI Minolauro
e Ia narrazione deIIa oosizione di queslo aI assaggio dei
oeli e deI sueramenlo deI varco vielalo (vv. 1-30),
- Ia seconda, iI discorso di VirgiIio suII'origine deIIa frana e suI-
Ia riviera di sangue (vv. 31-43),
- Ia lerza, Ia descrizione di quesla e dei Cenlauri, deI Ioro com-
orlamenlo aIIa discesa dei oeli, e deI coIIoquio lenulo con
quesli (vv. 44-99),
- Ia quarla, Ia rassegna dei dannali (vv. 100-fine).
A esse secifica Io slesso crilico Danle aggiungerebbe roba-
biImenle una quinla d'un soI verso, una iolelica arle che di fallo
degIi eIemenli, che, ove quesla cessasse e subenlrasse Ia concordia, fuoco aria acqua e
lerra lornerebbero a mescoIarsi e confondersi, come gia neI caos originario (nola di
Saegno, neII'ed. da Iui curala, cil., aI v. 42 deI canlo XII deII'|nj., cfr. anche ITTORI
IGNONI, |npc!cc|c, Torino 1916. ImedocIe (|nj. IV, 138) e uno degIi spiriii nagni che
Danle coIIoca in una condizione dislinla ed eccezionaIe, in un nobiIe casleIIo.
|| canic X|| !c||Inferno 471
occaccio enuncia come I'uIlima deIIa divisione da Iui roosla.
II moderno crilico, a differenza deI cerlaIdese, neIIa rima arle fa
confIuire anche iI sueramenlo deI varco vielalo (vv. 28-30).
La seconda arle
33
, falla eccezione er Ia diversa coIIocazione dei
vv. 28-30, coincide esallamenle con queIIa deII'|spcsizicnc boccacciana,
menlre neIIa lerza risuIlano vislosamenle accorale Ia lerza e Ia quarla
arle segnaIale daI commenlalore lrecenlesco.
NeIIa quarla suddivisione IigureIIi sembrerebbe far confIuire Ia
quinla e Ia sesla enunciale da occaccio, recuerandone in reaIla Ia
scansione, in nome di Danle.
In definiliva iI raorlo deI numero dei versi con I'enucIeazione
deIIe senlenzie deI canlo serve aI moderno crilico er dimoslrare
che, in roorzione,
Ia iu Iunga arle deI canlo, queIIa che ne cosliluisce iI cuore,
sia occuala daII'eisodio dei Cenlauri, menlre aIIa raresen-
lazione deIIa ena e deIIa condizione dei dannali e dedicala
soIo I'uIlima arle, ben iu modesla er eslensione e riIievo
34
.
In aIlri lermini, iI biIancio numerico non fa che suorlare cio
che con evidenza emerge daIIa Iellura dei versi, ossia Ia nolevoIe
differenza lra queslo canlo e i recedenli neIIa raresenlazione deIIa
condizione moraIe e maleriaIe dei dannali, che qui non risuIla
dominanle e icaslica: i eccalori comaiono soIo verso Ia fine e
sono iu nominali che descrilli
35
.
Se Ia raresenlazione deIIa ena resla aIquanlo sciaIba e ben
Ionlana daIIa drammalica lerribiIila di lanle aIlre, anche Io slalo
d'animo e Ia condizione siriluaIe che condusse quesle anime aIIa
coIa annola IigureIIi non acquislano evidenza ne forza se non in
quaIche esressione isoIala
36
.
I un dalo di fallo suI quaIe non si uo che concordare. Non a
caso, deI reslo, anche Umberlo osco
37
dedica soIo oche righe aIIa
rassegna dei dannali neIIa sua Iellura deI canlo XII, che, ur
arlendo daI Minolauro, fin daII'inizio lradisce nei Cenlauri iI fiIo
33 Anche se Ieggermenle diversa risuIla Ia segnaIazione dei versi, con Ia quaIe, non
so siegarmi erche, IigureIIi sezza Ia lerzina cosliluila dai vv. 43-45, oerazione che
si riele, doo, con i vv. 97-99.
34 IIGURILLI, o. cil., . 399.
35 Ivi, . 400.
36 Ivi, . 401.
37 UMIRTO OSCO, || canic X|| !c|||njcrnc, in Trc |ciiurc !anicscnc, Roma 1942, ora in
Iciiurc !anicscnc, a c. di Giovanni Gello, Iirenze, Sansoni 1961, . 211-219.
Maria CicaIa 472
orlanle
38
e iI cenlro di allenzione deIIa sua indagine. NeI riIeggere
quesla Icciura subilo si erceisce iI vero inleresse deI crilico. IgIi
esordisce imoslando una anaIisi deI significalo deIIa descrizione deI
Minolauro, ma immedialamenle
39
, doo oche righe, inlroduce un
confronlo deIIa sua figurazione con queIIa dei Cenlauri. Issi concel-
luaImenle sono Ia slessa cosa deI Minolauro annola osco in
quanlo
Mezzi uomini e mezze beslie anch'essi, anch'essi vinli e in gran
arle uccisi da Teseo, ien d'ira come IoIo di queslo canlo,
ien di rabbia come un aIlro cenlauro fuor di branco, iI Iadro
fraudoIenlo Caco
40
|.j,
oelicamenle, invece, sono assai diversi, iI Minolauro e veramenle
beslia |.j e massa brula |.j e sellacoIo |.j
41
.
AIIa rassegna dei dannali osco riserva soIo oche righe, essa
comincia soIo |.j a oco iu di un quarlo daIIa fine deI canlo,
rocede raida e concIude iI crilico
42
anche se Ia oesia non vi
lace, iI cenlro oelico deI canlo non e qui: esso, che doveva essere dei
vioIenli, e divenlalo, neIIa fanlasia deI oela, essenziaImenle iI canlo
dei cenlauri.
IigureIIi evocando Ia Viia Nucta raffinalamenle suorla con
I'aulorevoIezza deII'Aulore slesso Ia roria roosla di divisione,
38 Cfr. ivi, . 211-212.
39 Ivi, . 212.
40 Cfr. |nj. XXV, 17-33: e io vidi un cenlauro ien di rabbia / |.j Lo mio maeslro
disse: Quesli e Caco, / |.j Non va co' suoi fralei |i cenlauri di |nj. XIIj er un cammi-
no, / er Io furlo che frodoIenlo fece / deI grande armenlo ch'eIIi ebbe a vicino, / onde
cessar Ie sue oere biece / sollo Ia mazza d'IrcuIe, che forse / gIiene die cenlo, e non
senl Ie diece. Caco, siega Saegno (nola aI v. 25 deI canlo XXV, neII'edizione da Iui
curala, cil.), figIio di VuIcano, uomo-saliro che abilava in una grolla suII'Avenlino,
avendo rubalo i buoi e Ie giovenche di IrcoIe, fu scoerlo ed ucciso daII'eroe. VirgiIio
Io raresenla scnincnc e scnijcr, e Danle, Iiberamenle inlerrelando Ia sua fonle, ne fa
un cenlauro. NeI oema Ialino (Acn. VIII, 193-305) e rilrallo spiranicn igni|us, e iI noslro
gIi one suIIe saIIe un drago che vomila fiamme. La frode di Caco consisleva neI
fallo di aver usalo I'asluzia di condurre Ie beslie rubale lirandoIe er Ia coda e facen-
doIe camminare a rilroso, in modo che Ie orme sembrassero rivoIle in una direzione
oosla (Saegno, ivi, nola aI v. 29). II derubalo, IrcoIe, e definilo vicino, erche
con I'armenlo, che aveva a sua voIla railo aII'ucciso Gerione, s'era fermalo nei ressi
deII'Avenlino (ivi, nola aI v. 30).
NeII'|nci!c, IrcoIe uccide Caco slrozzandoIo, ercio forse qui, come suggerisce
Saegno (ivi, nola aI v. 32), Danle da I'imressione di aver seguilo iI racconlo di Ovidio
(|asi., 575-576).
41 OSCO, o. cil., . 212.
42 Ivi, . 219.
|| canic X|| !c||Inferno 473
ma aIIo slesso lemo, imIicilamenle, riroone aII'allenzione iI
consenso deIIo slesso Ioela a iu solliImenle arlicoIale arlizioni,
Iaddove risuIlino necessarie aI iu solliIe inlendimenlo deIIa
senlenlia.
I dunque Io slesso Danle (V. N. XIX e XLI) ad aulorizzare arlizio-
ni iu arlicoIale, come queIIa di occaccio o arzizza, er esemio, o
iu essenziaIi, come queIIa di IigureIIi, ma non credo sia oorluno
dimenlicare che Io slesso Ioela (V. N. XIV, 13) revede anche I'o-
orlunila di eIudere Ia divisione, neI caso in cui non sia rilenula
necessaria aII'inlendimenlo deIIa senlenzia.
Cio giuslifica I'alleggiamenlo di osco, Ia sua sceIla di evilare
arlizioni e coerenle con I'imoslazione deI suo discorso, imernialo
essenziaImenle su queIIo che egIi riliene iI cenlro oelico deI canlo.
IgIi ne riassume Ie Iinee essenziaIi in lermini chiari e aarenlemenle
asellici, lranne che er un arlicoIare, quaIificabiIe come eIemenlo
significalivo neI momenlo in cui si rende coscienza deI diballilo
reIalivo aI ruoIo deI Minolauro, che osco, senza discussione definisce
guardiano deII'aIeslre ruina. In quesla sinlesi Ia maleria narraliva
e incorniciala (in aIlo e in basso, in aerlura e in chiusura) da agganci
secifici aIIe arche rovenli degIi erelici (senza cenni aI canlo XI) e
quindi aI bosco dei suicidi, che si slende aI di Ia deI guado, neI
secondo girone deI sellimo cerchio, con evidenle lendenza a darIe
coerenle coIIocazione neI iano deII'oera:
Un'aIlra ria divide iI seslo cerchio, degIi erelici chiusi neIIe
arche rovenli, daI sellimo: invaIicabiIe da iede umano, se non
fosse er una frana, che offre maIagevoIe via, occorrera ero
che VirgiIio senga I'ira besliaIe deI Minolauro, che sla a guar-
dia deII'aIeslre ruina. II rimo girone deI sellimo cerchio
aare aI oela: un circoIare fiume di sangue boIIenle, neI quaIe
sono immersi iu o meno, a seconda deIIa gravila deI Ioro
eccalo, i vioIenli conlro iI rossimo: liranni, omicidi, ferilori,
redoni. Se lenlano di aIIeggerire Ia Ioro ena, schiere di
Cenlauri, correnli a miIIe a miIIe su un senliero lra iI iede deIIa
ria e iI fiume, Ii saellano. Con Ia fida scorla d'un di essi, i due
oeli vanno Iungo Ia roda deI vermigIio boIIore, in cerca deI
unlo neI quaIe queslo e guadabiIe, e Danle sa da Nesso, Ia sua
guida, chi siano aIcuni dei unili, moIlissimi ne riconosce egIi
slesso. AI di Ia deI guado si slendera iI secondo girone, iI bosco
dei suicidi non segnalo da nessun senliero, dai cui rami nodosi
usciranno insieme aroIe e sangue. Son quesle Ie Iinee fonda-
menlaIi deI canlo decimosecondo deII'|njcrnc.
Maria CicaIa 474
Tra Ia Iellura di osco (edila er Ia rima voIla neI 1942) e queIIa di
IigureIIi (roosla neI dicembre deI 1960) si coIIoca cronoIogicamenle
I'edizione deIIa Ccnnc!ia curala da Saegno (slamala er Ia rima
voIla a Iirenze, La Nuova IlaIia, neI 1955, e iu voIle rirodolla), con
inleressanli annolazioni e inlroduzioni crilico-bibIiografiche ai singoIi
canli.
Quanlo aI canlo XII deII'|njcrnc si olrebbe immaginare che Sae-
gno, con Ie aroIe di Danle (V. N. XIX, 3), sollinlenda:
ero prina nc jc irc parii,
daI momenlo che lre sono Ie arli da Iui segnaIale neIIa didascaIia,
rima deIIa breve ma incisiva inlroduzione, e quindi accanlo ai ver-
si dei quaIi enucIeano Ia senlenzia:
- La frana e iI Minolauro (vv. 1-45)
- II IIegelonle e i Cenlauri (vv. 46-99)
- I vioIenli conlro iI rossimo (vv. 100-139)
43
Anche quesla schemalica arlizione visuaIizza con immedialezza iI
biIancio deIIe roorzioni, commenlalo neII'inlroduzione
44
, dove si
Iegge che Ia fanlasia deI Ioela non si sofferma suIIe figure dei
dannali,
Ie eIenca via via e Ie aIIonlana, quasi rabbrividendo aI conlallo
di una reaIla moslruosa e disumana.
L'anima oelica si aunla invece,
come su maleria iu Iibera ed eslrosa, suIIa raresenlazione
dei Cenlauri e deI Ioro saggio cao Chirone. Rilraendone i gesli
e i coslumi informali a una sorla di rigida disciIina soIdalesca,
Danle dovelle avere in menle, come fu riIevalo gia dai iu anli-
chi commenlalori, aselli e eisodi deIIa vila deI suo lemo, in
cui Ia vioIenza brulaIe aveva ancora cos Iargo camo: soIdali di
venlura e bande di briganli, eserli e gIi uni e gIi aIlri di sac-
cheggi e raine.
Anche Saegno, dunque, fa sua I'imressione, esressa da Guido
43 Cfr. Saegno (a c. di), ed. cil., voI. I, . 135.
44 ||i!.
|| canic X|| !c||Inferno 475
Mazzoni
45
nei rimi anni deI Novecenlo, ma divenula quasi canonica
nei successivi Iellori e commenlalori deI canlo
46
, che iI XII
deII'|njcrnc si connola come iI canlo dei Cenlauri e d'aIlra arle
Iascia subilo inluire queIIa che e una deIIe queslioni iu consislenli
su cui rifIellere mi iace ricordare con IigureIIi I'imressione deI
riscallo di quesli moslri da ogni forma e senso non soIo di besliaIe,
ma di umana vioIenza, ur essendo coIIocali neI girone dei vioIenli
coI vaIore aImeno inlenzionaIe di ersonificazione di laIe coIa
47
.
Saegno solloIinea che, come di consuelo, Danle non consenle aIIa
ragione moraIe di
Iimilare e imoverire Ia ienezza deII'immaginazione, semre
allenla aIIa ricchezza e aIIa comIessila deI dalo fanlaslico. IgIi
uo erlanlo darci deIIe beIIe fiere una raresenlazione
vivacissima, lulla rivoIla a far cameggiare queIIe immagini di
agiIila e di olenza fisica, di cui ricava Io sunlo da quaIche
verso di VirgiIio, di Ovidio e di Slazio, con una inlensila di
riIievo Iaslico, che e iI segno deI suo robuslo reaIismo, aIieno
da ogni comiacimenlo eslelico e decoralivo, e semre conlenu-
lo, e come lrasorlalo, neI rilmo incaIzanle e grave deI racconlo.
Iienezza di immaginazione e olenza raresenlaliva cosliluisco-
no, a mio avviso, iI vero eIemenlo di comallezza di un canlo neI
quaIe iI riIievo raresenlalivo e lridimensionaIe e rosellico, visivo
e sonoro, gioca su sfondi e rimi iani, coIIoqui a due o iu voci e
rumori suIIo sfondo, comIicali daIIa lecnica deI j|asn-|ack, in una gra-
dazione di eIemenli incaslonali su uno schermo immaginario, dove
lrovano oslo iI Ioco, I'uomo, Ia beslia-uomo, I'anima. in una
girandoIa di movimenli ossenli, vioIenli, gravi. (iI reciilare deIIa
frana, iI dimenarsi rabbioso deI Minolauro, iI gaIoo veIoce dei
Cenlauri.) e suoni, lra i quaIi emerge, er iI suo coslanle incombere,
iI 'boIIire', 'boIIenle', deI buIicame rosso.
L'abiIila deIIa regia sembrerebbe qui recorrere i olenli arlifici
deIIa mano moderna di un Dario Argenlo, fin dai rimi lre versi.
anche se Danle neIIa olenle raresenlazione deI canlo XII, va
aIdiIa degIi effelli esleriori che coinvoIgono i cinque sensi, erche,
rearando iI suo ubbIico con un inlero canlo, I'undicesimo, e
facendo Ieva su esedienli lecnici mirali (daIIe sceIle IessicaIi aIIa
45 GUIDO MAZZONI, || canic X|| !c|||njcrnc, Iirenze 1906.
46 Cfr. IIGURILLI, o. cil., . 404, e Saegno (a c. di), ed. cil., . 135 (nola bibIiografi-
ca di riferimenlo).
47 Cfr. IIGURILLI, o. cil., . 410-415.
Maria CicaIa 476
osizione deIIe aroIe neI verso, er esemio) Io soIIecila a erceire
con immedialezza Ia dollrina che s'asconde sollo 'I veIame de Ii
versi# Infalli I'imallo coI canlo danlesco dei vioIenli Iascia denlro
sensazioni moIlo diverse da queIIe che lrasmelle un anaIogamenle
Prcjcn!c rcssc di Argenlo: illure che rilraggono soggelli iconografici
simiIi (rosso, sangue, vioIenza. suspcncc, asellaliva, rearale da
suoni, aroIe, immagini.), ma, come direbbe Leonardo, sollendono
una ben diversa fiIosofia.
Quesla roosla di Iellura, che lra breve solloorro aII'allenzione,
in un cerlo senso, ur revedendo una dellagIiala osservazione deIIe
singoIe sequenze, che scandiscono Ia roiezione di una iolelica eIIi-
coIa, evila ogni divisione, in quanlo rione Ia ercezione deIIa
senlenzia neIIa comallezza deIIa olenza raresenlaliva, di cui
ogni eIemenlo, aarenlemenle secondario, in reaIla e arle inlegran-
le, come forse inlende suggerire Ia sensazione coslanle deI cuo
riboIIire di sollofondo. Si avverle gia quando (v. 46) VirgiIio addila a
Danle
- Ia riviera di sangue in Ia quaI |c||c (v. 46)
quaI che er vioIenza in aIlrui noccia,
rima che i due slrani eIIegrini cosleggino, con Ia scorla fida di
Nesso,
- Ia roda | rivaj deI |c||cr vermigIio (v. 101),
- dove i |c||iii facieno aIle slrida (v. 102),
rima che I'allenzione, dielro suggerimenlo deI Cenlauro, venga con-
vogIiala suI
- |u|icanc | boIIor vermigIioj
48
(v. 117)
neI quaIe una genle e immersa 'nfino a Ia goIa, sconlando una
coIa iu grave risello a coIoro ai quaIi queI sangue, abbassalo di
IiveIIo,
48 II corsivo neIIe cil. e mio. uIicame (|nj. XIV, 79) e iI Iaghello d'acqua soIforo-
sa boIIenle silualo nei ressi di Vilerbo. Ier anaIogia con esso annola Saegno (ed.
da Iui curala, cil., nola aI v. 79 deI canlo XIV deII'|nj.) Danle aveva chiamalo buIica-
me iI IIegelonle gia in |nj. XII, 117, e iI rusceIIo che vede in |nj. XIV, 79, dove
slabiIisce iI aragone (QuaIe deI uIicame esce rusceIIo), e aunlo una diramazione
deI IIegelonle, che, doo avere allraversalo Ia seIva dei suicidi, sbocca ora neI sabbione
e Io lagIia er riversarsi neI fondo deII'inferno (Saegno, i|i!.).
|| canic X|| !c||Inferno 477
- cocea (v. 125)
soIlanlo Ii iedi.
Termini come
- buIicame (v. 128)
- boIIor (v. 136)
sono riroosli neIIa ballula finaIe di Nesso, che, doo aver concIuso
Ia sua missione di scorla, lorna indielro, sigiIIando coI suo geslo iI
canlo e Ia maleria deI rimo girone deI sellimo cerchio.
Quesla vena di Iinguaggio cuIinario, che neI canlo danlesco
aIeggia, con raffinalo dosaggio saienlemenle scandilo, era moIlo
frequenle neIIe raresenlazioni infernaIi di lio iu ooIare
rammenla Ielrocchi (er esemio in Giacomino da Verona), e ri-
comarira neIIe MaIeboIge
49
| VIII cerchio, fraudoIenli conlro chi
non si fidaj.
NeIIa edizione deIIa Ccnc!ia
50
, che riroduce iI leslo slabiIilo da
Ielrocchi, con commenlo di Giovanni IaIIani, uno dei noli Iellori
moderni deI canlo XII deII'|njcrnc
51
, e SiIvio Zennaro, cinque righe,
in aarenza assoIulamenle imersonaIi e acriliche, riassumono iI
conlenulo dei versi oi roosli con una ricca messe di uliIissime
annolazioni, riccamenle documenlale. In reaIla anche qui aII'allenlo
Iellore non sfuggono osizioni imIicilamenle, ma non credo rorio
casuaImenle, assunle.
La rima cosa che baIza aII'occhio, in quesla asciulla didascaIia, e
una biarlizione, imIicilamenle segnaIala daIIa diversificazione deI
conlenulo dei versi 1-99
VirgiIio e Danle discendono er una frana, cuslodila daI Mino-
lauro, neI sellimo cerchio dei vioIenli, dove sono unili neI
rimo girone i vioIenli conlro iI rossimo, immersi neI IIege-
lonle, fiume di sangue boIIenle, sorvegIiali dai Cenlauri (vv.
1-99)
da queIIo dei vv. 100-139
49 I una considerazione di GIORGIO IITROCCHI (|nirc!uzicnc aIIa edizione crilica da
Iui curala deIIa Ccnnc!ia scccn!c |aniica tu|gaia, MiIano, 1966/67, . 176), oorluna-
menle rammenlala da Saegno (ed. cil., nola aI v. 125 di |nj. XII).
50 Roma, Nevlon & Comlon 1993, ed. iu voIle rislamala.
51 In Nuctc |ciiurc !anicscnc, Iirenze 1966-76, II, . 17-32.
Maria CicaIa 478
Nesso accomagna i oeli verso iI secondo girone e dice iI
nome di aIcuni dannali (vv. 100-139)
quasi a voIer differenziare iI ercorso deI Ioela scorlalo da VirgiIio da
queIIo in cui iI ruoIo di guida e assunlo da Nesso (uno dei lre Cenlauri
che si slaccano daI gruo). Infalli, rorio neI v. 100, Danle siega:
Or ci movemmo con Ia scorla fida,
e oco doo (v. 114) VirgiIio, Iasciando inluire una erIessila neI
voIlo deI suo rolello, sembra rassicuraIo neI sancire iI rovvisorio
cambio di guardia.
Dicendo
Queslo li sia or rimo, io secondo,
secondo occaccio, VirgiIio inlendeva affermare che
aI cenlauro sia da far fede a queI che dice,
uIleriore conferma deIIa veridicila di cio che Nesso ha aena asseri-
lo, er vero (v. 11), circa Ia morle di Obizzo II d'Isle er mano deI
figIio, una nolizia, che aII'eoca circoIava senza aIcun margine di
sicurezza, aIIa quaIe Danle suggerisce Saegno
52
sembra voIer
soIennemenle conferire credilo, robabiImenle er i suoi senlimen-
li nei confronli di Azzo VIII (cfr. Oc tu|g. c|cq. I, XII, 5, Purg. V, 77-78
e XX, 80)
53
, che neIIa signoria successe aI adre.
Un aIlro eIemenlo, aarenlemenle asellico, deIIa deIineazione
lemalica deI canlo, neII'edizione commenlala da IaIIani e Zennaro, e
I'allribuzione cerla deI ruoIo di cuslode deI burralo che Danle
avrebbe assegnalo aI Minolauro, cuslode deIIa ruina (cfr. i vv. 32-33:
quesla ruina |.j c guar!aia / da quc||ira |csiia| ch' i' ora sensi)
54
, er
cui si scende a lullo iI basso Inferno solloIinea anche Saegno, aIIe-
gando rove convincenli , non deI sellimo cerchio, e quindi simboIo
deIIa vioIenza ivi unila, come invece rilenevano anlichi commenlalo-
ri, er esemio occaccio
55
e Irancesco da uli
56
.
52 NeII'ed. da Iui curala, cil., nola aI v. 111 deI canlo XII deII'|njcrnc.
53 Danle Io ricorda semre in lono osliIe e srezzanle.
54 II corsivo e mio.
55 NeII'|spcsizicnc a||cgcrica (|nj. XII, 10-27, L. XXXXVIII).
56 Ier Iui neI Minolauro sono simboIeggiale Ie lre sezie deIIa vioIenza |quindi
lullo iI VII cerchioj rocedenle da maIizia o da besliaIila.
|| canic X|| !c||Inferno 479
Si lralla di una inlerrelazione diffusa lra i moderni esegeli, ma
non er queslo sconlala. Non Ia riliene laIe ManIio Iaslore Slocchi
57
,
aI quaIe non sembra oorluno scoslarsi daII'esegesi comune, rile-
nendo iu convenienle accellare I'inlerrelazione deI Minolauro
come equivaIenle deIIe aIlre enlila demoniache osle a cuslodia Iimi-
nare dei singoIi cerchi e deIIe Ioro arlizioni, in un raorlo simboIico
|.j con Ie coIe che vi sono risellivamenle unile.
Una inlerrelazione ingegnosa, come Ia definisce Iaslore Sloc-
chi
58
, ricordala e rilenula arbilraria da Saegno
59
, e slala roosla da
Ierrelli
60
er iI quaIe I'uomo-loro olrebbe simboIicamenle raresen-
lare Ia besliaIila degIi eicurei.
Mi sembra a queslo unlo evidenle come gia I'osservazione allenla
deI modo di orsi di ciascun Iellore o commenlalore, anche soIo neI
resenlare Ia roria individuazione deIIe arli da anaIizzare,
ossa cosliluire un vero e rorio lerrilorio di indagine suI quaIe sof-
fermarsi con allenzione fiIoIogica. Ma in quesla sede dovendo fare i
conli coI lemo e coI desiderio di saggiare, er quanlo ossibiIe, in
una visione d'insieme, vari aselli e quindi olenziaIila di Iellura di
queslo canlo XII deII'|njcrnc referisco andare oIlre, non senza
averne offerlo rima deIIe Iinee generaIi, in un'ollica che mi sembra
efficace.
1.1. IOTINZA SIITTACOLARI DILLA RAIIRISINTAZIONI
NeI riIeggere rielulamenle i versi di Danle ho rovalo a ormi
neII'ollica di un regisla, che desidera riroorne suI grande schermo
Ia olenza sellacoIare.
In queslo senso, come ho gia dello, Ia reaIizzazione deII'effello
deIIa raresenlazione, finaIizzala aII'inlendimenlo deIIa senlenzia
deIIa maleria, non richiede divisioni, che danneggerebbero iu
che agevoIare Ia ercezione deII'armonia oIifonica, anche se necessa-
riamenle revede Ia coslruzione di sequenze da imbaslire e oi
roiellare in successione isneIIa, veIoce, raida, come Io scallo
deII'uomo-loro o iI gaIoo degIi uomini-cavaIIo.
I SIQUINZA
57 Cfr. Ia scheda suI Minciaurc, da Iui firmala, neII'|ncic|cpc!ia !anicsca (voI. III, .
964).
58 ||i!.
59 NeII'ed. da Iui curala, cil., nola aI v. 21 deI canlo XII deII'|nj.
60 Scriiii !anicscni, . 106-112, cil. da Saegno, i|i!.
Maria CicaIa 480
Una voce siega cio che vede, e I'occhio deIIa macchina da resa,
che si idenlifica con queIIo deI oela-narralore, rirende I'orIo di un
burrone di monlagna, rima Ionlano e indislinlo, oi semre iu
vicino, menlre una musica inquielanle reara, neII'allesa deI ubbIi-
co, I'aarizione chiara di quaIcosa che chiunque vorrebbe evilare di
vedere (vv. 1-3):
Ira Io Ioco ov'a scender Ia riva
venimmo, aIeslro e, er queI che v'er'anco,
laI, ch'ogne visla ne sarebbe schiva.
Con Ia rima lerzina Danle subilo inlroduce iI suo Iellore neI
Ioco neI quaIe egIi si lrova con VirgiIio: sono suII'orIo deIIa riva
61
,
franosa, falla di grandi massi reciilali, saccali e accalaslali, e si
accingono a scendere neI sellimo cerchio dei vioIenli.
QueI laI in osizione forle, aII'inizio deI v. 3, sembra scandire
con decisione I'indissoIubiIila dei due eIemenli che rendono sgradevo-
Ie iI Ioco.
Isso e riugnanle aII'occhio di chiunque er iI modo in cui fisica-
menle si configura: aIeslro, dirualo, senza aIcun ordinalo
senliero o via (occaccio), ma anche er queI che v'era, queI che I
si oleva vedere, iI Minolauro, di cui iI oela arIera, nei vv. 11-12.
Subilo si avverle una doia sensazione di ribrezzo, che dagIi
occhi giunge aII'animo: ogni visla ne sarebbe schiva (v. 3), aIiena,
oco disosla a fermarsi er guardare cio che genera aura.
Iin daII'inizio dunque I'infamia di Creli (v. 12), allraverso
I'indelerminala asellazione, creala neI ubbIico, aare in slrella
osmosi coI aesaggio che Ia osila, e quasi ne reara Ia visione.
Ier iI suo asello fisico queI burralo fa scallare un j|asn-|ack
mnemonico neI oela-narralore, I'occhio deIIa sua menle, che ancora
si idenlifica con queIIo deIIa cineresa, roone aIIa visla e aII'udilo iI
reciilare vioIenlo di una frana, neIIa simiIiludine con gIi SIavini di
Marco (vv. 4-9).
Cui e imonenli sono rumori e immagini.
Si avverle Ia vioIenza olenle deIIa frana, che si muove daII'aIlo
verso iI basso, daIIa cima deI monle (v. 7) reciila giu verso iI
61 Dice Ia rita solloIinea OCCACCIO (o. cil., |sp. |iii. aI v. 1) inlendendo er Ia
ripa, e queslo dico er cio che moIli fanno dislinzione fra rita e ripa, chiamando rita
queIIa deI fiume e ripa gIi argini che sora Ie fosse si fanno o dinlorno aIIe casleIIa o
ancora in Iuoghi decIini, er Ii quaIi d'aIcun Iuogo aIlo si scende aI iu basso, come era
in queslo Iuogo (cors. mio). NeI v. 1 deI canlo XI si Iegge ria, in riferimenlo aIIa
slessa ruina deI canlo XII.
|| canic X|| !c||Inferno 481
iano, non si sa se a causa di un lerremolo oure di un fenomeno
di erosione, come non Io sa chi assisle aI fenomeno neI momenlo in cui
si verifica.
Cio che conla non e Ia causa, ma I'effello che crea in chi vede, in chi
Iegge, a rescindere daIIe fonli che isirano Ia descrizione, neIIa quaIe
aIIa slalicila deI burralo, allraverso Ia lecnica deI j|asn-|ack, si asso-
cia I'irruenlo molo che ne ha delerminalo Io slalo fisico.
Slalicila e movimenlo, con anaIoghe carallerisliche di imonenza e
vioIenza, connolano anche I'aarizione deI Minolauro, rima disle-
so, 'n su Ia unla de Ia rolla Iacca (v. 11), oi in furioso movimenlo
di rabbia, ira che esIode neIIa vioIenza.
NeII'immaginario fiImalo che rende coro, I'obiellivo rirende,
neII'ordine, un burrone scosceso e dirualo, che rorio er queslo
consenle quaIche aigIio a chi vogIia scendere, un j|asn-|ack roone
Ia vioIenza deI reciilare di una frana, daII'aIlo aI basso, oi
I'obiellivo risaIe daI basso verso I'aIlo e inquadra queIIa moslruosila
annunciala come asellazione indelerminala di quaIcosa di riugnan-
le, una moslruosila fisica, immedialamenle connolala (infamia di
Creli, v.12) come frullo di una moslruosila moraIe (fu concella ne Ia
faIsa vacca, v. 13), una immagine slalica, dislesa (v. 12).
SuII'asello fisico coI quaIe rodurne I'immagine, Ia regia olrebbe
avere quaIche robIema, erche iI leslo danlesco non si esrime in
lermini esIicili, ma Iascia immaginare come queIIo ovidiano, mi rife-
risco aI nolo, quanlo ambiguo scni|ctcnquc tirun, scnitirunquc
|ctcn deII'Ars anan!i II, 24. Un uomo con Ia lesla di loro, come a-
are in anlichi reerli archeoIogici, o un loro con lesla umana, come
iu di un commenlalore
62
ha immaginalo, suorlando I'iolesi con Ia
simiIiludine enunciala nei versi 23-25
QuaI e queI loro che si sIaccia in queIIa
c'ha ricevulo gia 'I coIo morlaIe,
che gir non sa, ma qua e Ia saIleIIa,
Io slesso aragone che VirgiIio (Acn. II, vv. 223-224) usava in riferi-
menlo aII'umanissimo Lacoonle, riIeva quaIcun aIlro
63
.
Ma iI lono di Danle solloIinea osco
64
sembra voIer moslrare
Ia moIe e I'immobiIila besliaImenle sonnecchianle di una massa
brula, riva erfino di asluzia demoniaca, quindi un enorme loro
con lesla umana, che fa sellacoIo.
62 Cfr. er esemio IaIIani, Saegno, osco, elc.
63 Ier esemio ManIio Iaslore Slocchi (in DI, o. cil., . 964).
64 OSCO, o. cil., . 212.
Maria CicaIa 482
A queslo unlo I'occhio deIIa cineresa si idenlifica coI suo, quan-
do finaImenle vengono inquadrali i due slrani eIIegrini e subilo Ia
slasi esIode in movimenli bruschi, vioIenli, di rabbia comressa che
si rilorce su se slessa.
Un inconlro di sguardi, ma e un allimo imercellibiIe, erche subi-
lo irrome I'ira besliaIe, un o' goffa e grollesca, che Io induce a
mordere se slesso (vv. 14-15):
e quando vide noi, se slesso morse,
s come quei cui I'ira denlro fiacca.
Ora e soIo ora chi ha unicamenle osservalo inlerviene, comincia
I'azione e con essa Ia seconda sequenza che incremenla Ie resenze
suIIo schermo e a Ioro da voce.
II SIQUINZA
VirgiIio grida (vv. 16-21), aarenlemenle er smorzare, in reaIla
er scalenare uIleriormenle queIIa furia a scoo diversivo.
II quadro si aIIarga e chi rima Io vedeva ora ne fa arle.
VirgiIio rovoca Ia beslia (Iarlili, beslia!), rievocando indirel-
lamenle e imIicilamenle, con oche incisive aroIe, queIIa arle
deIIa sloria deI milo che vede neI duca d'Alene I'eroe che riesce a
mellere fine aIIa slrage umana, deIIa quaIe iI Minolauro era slrumenlo
e soggello agenle.
L'obiellivo deIIa cineresa e semre su VirgiIio, ma subilo si sosla
su Danle, aI quaIe egIi grida di sfrullare queI momenlo er oIlreassa-
re iI varco, quindi suIIa beslia, che quasi imazzila di rabbia, si
comorla come un loro che, coIilo a morle, riesce a Iiberarsi dai Iacci,
ma, saesalo e diseralo, non riesce a fare aIlro che saIleIIare.
Su quesla immagine una musica marleIIanle ian iano si sfuma,
avviando un'aIlra sequenza.
III SIQUINZA
L'obiellivo rirende Ia difficoIlosa discesa er Io scarco. Ogni
lanlo si avverle iI rumore di una ielra, che si muove, e roloIa giu
sollo iI eso umano di Danle (vv. 28-30).
In quesla siluazione iI viso deI Ioela aare ensieroso e VirgiIio,
credendo di inlerrelarIo (lu ensi forse, vv. 31-32), lrova sazio
er una ausa di rifIessione medilaliva. I un assaggio inlerIocu-
lorio, ma anche un rocedere fisico e siriluaIe verso Ia scoerla di
|| canic X|| !c||Inferno 483
un'esIosione di amore che si esrime allraverso Ia vioIenza. Di
nuovo iI regisla ha I'oorlunila di scandire, con un abiIe j|asn-|ack,
suI fiIo deIIa memoria non di Danle, ma di VirgiIio, slasi e movimenlo
di queIIa arele monlagnosa aena suerala, che si configura Iiscia e
a icco (STASI), duranle Ia rima discesa di VirgiIio aII'Inferno (cfr.
|nj. IX, 22-27), e quindi, subilo doo Ia morle di coIui, che Ia gran
reda |Ie animej / Ievo a Dile |Luciferoj deI cerchio suerno |iI Limbo,
rimo cerchioj (vv. 38-39), sconvoIla da uno savenloso lerremolo
(MOVIMINTO), deI quaIe si erceiscono, er via sonora e visiva,
vioIenlemenle gIi effelli: da lulle arli I'aIla vaIIe feda, Ia rofonda
vaIIe sozza (daI Ial. jcc!a),
lremo s, ch'i' ensai che I'universo,
senlisse amor, er Io quaI e chi creda
iu voIle iI mondo in caosso converso,
e in queI unlo quesla vecchia roccia,
qui e aIlrove, laI fece riverso.
Anche qui iI regisla fa Ieva su effelli seciaIi, che giocano su
dinamiche oosilive anaIoghe a queIIe deIIe recedenli sequenze
(STASI-MOVIMINTI RUSCHI, SILINZI-ISILOSIONI SONORI), anche se
in quesla scena neIIa corosila imonenle deIIa messa in scena si
incaslonano eIemenli che vanno ben oIlre Ia suerficie deIIa ra-
resenlazione: olenlemenle si gesliscono, con abiIila saienle, non
caolica, fonli diverse, Ia fiIosofia di ImedocIe si fonde con Ie
leslimonianze deII'evangeIisla Malleo (XXVII, 51-53), di Luciano
marlire, di CiriIIo gerosoIomilano
65
, amaIgamale daIIa olenza deI-
I'Amore.
La discesa dei due viaggialori non e ancora lerminala, ma Ie aroIe
di VirgiIio, cambiando lono e maleria, soslano I'obiellivo in aIlra
direzione, di nuovo verso iI basso (ficca gIi occhi a vaIIe, v. 46).
Si are una nuova sequenza.
IV SIQUINZA
VirgiIio e Danle non comaiono iu suIIo schermo, guardano,
insieme aI ubbIico, daII'aIlo, in una visione d'insieme, Ia vaIIe.
Ier Ia rima voIla comare Ia aroIa voIenza, suIIe Iabbra deIIa
guida che annuncia Ia visione (vv. 47-48) deIIa
65 Vd. Ia nola aI v. 40, neII'ed. a c. di IaIIani e Zennaro, cil.
Maria CicaIa 484
riviera deI sangue, in Ia quaI boIIe
quaI che er voIenza in aIlrui noccia
e immedialamenle una voce fuori camo Ia commenla (vv. 49-51):
O cieca cuidigia
66
e ira foIIe
67
che s ci sroni ne Ia vila corla,
e ne I'ellerna oi s maI c'immoIIe!
I una lerzina che risecchia iI fine didascaIico deI oema, in modo
isneIIo, reciilando daI boIIe deI v. 47, allraverso iI foIIe deI v.
49, neII'immoIIe deI v. 51, senza aIIenlare Ia lensione dinamica, anzi
arricchendo Ia scena di nuovi effelli sonori: un riboIIire da ora in oi
scandilo come accomagnamenlo coslanle di sollofondo.
Anche in quesla lerzina di svoIla, che sosla I'obiellivo suIIa vaIIe,
er anlilesi si slabiIisce una sorla di brusco assaggio: daII'azione (ci
sroni neIIa vila corla) aIIa slasi (ne I'ellerna oi s maI c'immoIIe).
SuIIo schermo comare un'amia fossa in arco lorla (v. 52), ar-
cuala e amia, erche abbraccia lullo iI circuilo deI sellimo cerchio,
deI quaIe cosliluisce iI rimo girone.
Anche in queslo caso Ia visione fisica deI Ioco recede e reara
con anaIoga dinamica I'aarizione degIi uominini-cavaIIo.
NeIIo sazio lra Ia base deIIa ria e Ia fossa arcuala,
corrien cenlauri, armali di saelle (v. 56)
La osizione forle deI verbo ccrrcrc, che riferilo ai Cenlauri equiva-
Ie a ga|cpparc, reaIislicamenle aulorizza a immaginare un'anleriorila
deIIa ercezione audiliva risello a queIIa visiva, rima si senle Io
scaIilo deI gaIoo di massa, oi aaiono imonenli i Cenlauri,
armali di saelle.
Qui si verifica un rocedimenlo inversamenle anaIogo, risello
aIIa dinamica raresenlaliva deI Minolauro.
L'uomo-loro aare disleso (STASI), aena vede i due eIIegrini si
agila, si muove rabbiosamenle (MOVIMINTO-AZIONI), ma non arIa.
I Cenlauri, invece, Ie fiere isneIIe, aI Ioro aarire, corrono veIoci
(MOVIMINTO-AZIONI), in schiera, oi, aIIa visla dei nuovi arrivali, si
verifica un arreslo immedialo (STASI), ciascun rislelle (v. 58), una
reazione brusca, come queIIa deI Minolauro, ma non siIenziosa.
Anche qui Ia regia e guidala daI leslo, iI Veggendoci caIar deI
66 Movenle deIIa vioIenza alluala neIIe cose.
67 Movenle deIIa vioIenza alluala neIIe ersone.
|| canic X|| !c||Inferno 485
v. 58, coIIoca, neIIa riresa deIIa scena, in aIlo i due eIIegrini, che
non sono ancora arrivali aIIa fine deIIo scarco e i Cenlauri in basso,
con Io sguardo verso I'aIlo, una siluazione che si inverle quando
inizia iI coIIoquio 'vila' a 'viso', vislo che Ia Ioro moIe e laIe da far
corrisondere I'aIlezza di una ersona coI unlo neI quaIe Ia Ioro
nalura umana si congiunge con queIIa animaIe.
Anche in queslo caso decisiva neIIa svoIla deII'azione si riveIa
Ia aroIa di VirgiIio (un ruoIo evidenzialo neII'enunciazione deIIa
divisione in arli oerala da occaccio)
68
: e Iui a bIoccare I'im-
uIsivila deI rimo Cenlauro (in seguilo idenlificalo con Nesso), che si
slacca daI gruo gridando, anche qui evidenziando iI unlo deboIe
di chi sembra voIer aggredire Danle, in queslo caso coIui che rima di
essere nominalo e connolalo con Ia causa deIIa sua disgrazia: una
voIonla semre imuIsiva e reciilosa.
II gridare minaccioso di queslo Cenlauro are una serie secifica di
rimi iani.
SuI grande schermo rima si vede I'aIzarsi di un oIverone, ac-
comagnalo daI rumore di un gaIoo di massa, oi si configura una
schiera di Cenlauri, daIIa quaIe si slacca, er essere rireso in rimo
iano, queIIo che are gridando una serie di coIIoqui e rimi iani.
II rimo e queIIo di VirgiIio, che, in modo confidenziaIe, locca coI
gomilo Danle, er allirarne I'allenzione e riveIargIi, quasi a voce
bassa, indicandoIi, nome e sloria dei lre Cenlauri che si slaccano daI
gruo, Nesso (aIIa deslra di Chirone, cfr. v. 97), Chirone (aI cenlro,
cfr. v. 70) e IoIo (inevilabiImenle aIIa sua sinislra), e quindi connolan-
do queIIa foIIa (non cenlo, ma migIiaia, cfr. a miIIe a miIIe, v. 73).
Danle accanlo a Iui, segue con Io sguardo Ie sue indicazioni, lace e
ascoIla e faciIe immaginare rima di rirendere Ia narrazione.
La sua voce guida una sIendida e reaIislica 'riresa' (visuaIizza-
zione dellala daIIa descrizione) deIIe fiere isneIIe (veIoci, non cerlo
magre, dala Ia Ioro moIe, e I'uso che Danle fa deII'aggellivo, secondo
I'uso anlico deIIe Iingue romanze), maeslose, in uno squarcio illorico
e dinamico, in cui i siIenzi esaIlano Ia visione dei arlicoIari descrillivi
(Chirone con Ia cocca di uno slraIe scosla daIIa bocca Ia barba,
er quaIche commenlalore embIema deIIa saggezza che Io connola,
riscallandoIo in quaIe modo daI ruoIo diaboIico, orlandoIa in dielro
a Ie masceIIe, vv. 77-79), inlroducendo un serralo scambio di ballule
(Chirone ai comagni, VirgiIio a Chirone, Chirone a Nesso, vv. 80-99),
con funzione medilaliva (VirgiIio siega movenle e scoo deI viaggio
di Danle, mosso da virlu divina, sollo Ia sua guida) e slrumenlaIe
68 Cfr. supra.
Maria CicaIa 486
(Chirone segnaIa ai comagni iI fallo che Danle non e uno sirilo,
doo iI chiarimenlo di VirgiIio, si rivoIge a Nesso er affidargIi iI
comilo di scorla fida, orlando in su Ia groa coIui che non e
sirlo che er I'aere vada).
Si are cos un'aIlra sequenza deII'immaginario fiImalo, a arlire
daI v. 100, segnaIalo dai numerosi commenlalori come incipii deIIa
non cenlraIe rassegna dei dannali.
V SIQUINZA
Danle in groa a Nesso vede, menlre iI Cenlauro siega, e
VirgiIio arIa soIo er sigiIIare iI ruoIo di scorla da quesli assunlo.
Iian iano I'obiellivo si sosla suI boIIor vermigIio, dove i
boIIili facieno aIle slrida, inquadra Ie Ioro figure, a diversi IiveIIi im-
mersi in queI buIicame e, raidamenle, si sofferma su aIcuni di essi.
Di quaIcuno si avverle soIo una indislinla resenza (genle) o si
senle unicamenle iI nome, raramenle associalo a un arlicoIare (Alli-
Ia che fu fIageIIo in lerra, v. 134), di aIlri si dislingue iI coIore dei
caeIIi (iI eI cos nero di AzzoIino
69
e queII'aIlro ch'e biondo,
Obizzo II d'Isle
70
), di un'ombra non si erceisce iI nome, ma Ia si
individua neI suo isoIamenlo (da I'un canlo, soIa), Ia si riconosce daI
macabro j|asn-|ack, che, roonendo I'immagine di un cuore
71
, che
gronda sangue suI Tamigi (in una coa d'oro, neIIa mano di una
slalua erellagIi resso I'Abbazia di Weslminsler)
72
, imIicilamenle Io
idenlifica con Guido di Monforl.
Cio che maggiormenle coIisce non e Ia Ioro fisionomia, ma Ia
condizione che Ii connola (|c||irc, |c||cnic, neI |u|icanc rosso di sanguc
che cccc) e Ia graduaIila diversificala deIIa Ioro ena.
Ira queslo Io scoo annuncialo da Danle neI recedenle canlo,
moslrare e imIicilamenle solloIineare Ia Iurificazione deI eccalo
e Ia sollodislinzione deIIa ena sconlala, segno deIIa lransizione
daII'idea cIassica deI vizio aII'idea crisliana deI eccalo, unilo iu
o meno severamenle in base aI grado di gravila. Un riIievo che oleva
essere reso efficacemenle soIo neI quadro d'insieme da Iui olenle-
menle coslruilo.
69 IzzeIino III da Romano, cao dei ghibeIIini ilaIiani, e liranno di Iadova.
70 SuIIe dubbie circoslanze deIIa sua morle Danle sembra inlervenire, dando er
vero Ia coIevoIezza deI figIio Azzo VIII.
71 I iI cuore di Arrigo di CornovagIia, cugino deI re d'InghiIlerra, ugnaIalo da
Guido di Monforl, neIIa chiesa di S. SiIveslro, iI 13 marzo 1271, duranle Ia ceIebrazione
deIIa Messa, er vendicare Ia morle deI adre, ucciso da Idoardo I d'InghiIlerra.
72 Cfr. Ia nola ai vv. 119-120 neII'ed. a cura di IaIIani e Zennaro, cil.
|| canic X|| !c||Inferno 487
AssoIlo queslo comilo iI canlo si uo chiudere con Ia sequenza
finaIe, di un soIo verso, come gia occaccio segnaIava.
VI SIQUINZA
L'obiellivo e unlalo su Nesso, che finisce di arIare, si Iascia aIIe
saIIe i due viaggialori e, riassando iI guazzo |iI unlo iu basso
deIIa rivieraj, con Io sfumarsi deIIa sua figura suIIo sfondo, scrive Ia
aroIa fine a un canlo in cui I'unila loografica |una unila loografica
deII'Infernoj si associa a queIIa narraliva |una laa deI viaggio di
Danlej, neIIa olenza di una sellacoIarila raresenlaliva, che neIIa
erfella comallezza deIIe dinamiche geslisce nei falli iI raggiungi-
menlo di uno scoo redelerminalo: Ia raresenlazione non soIo
deIIa voIenza, imosla aI rossimo neIIa vila corla e sconlala in
queIIa elerna, secondo Ia Iegge deI conlraasso, ma sorallullo di
una nuova mediazione cuIluraIe, che da qui rende avvio e suIIa
quaIe non si uo escIudere che Ia cenlraIila deIIa saggezza di Nesso
vogIia convogIiare lra Ie righe I'allenzione.
Unitcrsiia !cg|i Siu!i !i Napc|i IOricnia|c
MARIO AVIRSANO
DANTI I IL SUO RITRATTO NILLA SALA DILLA
IACI DI AMROGIO LORINZITTI
IRIMISSA
L'argomenlo in liloIo, uno e bino com'e, non uo dirsi dei iu
loccali neIIa danloIogia. asli ricordare che I'aulorevoIe |ncic|cpc!ia
!anicsca dedica aIIa voce 'Ambrogio Lorenzelli' soIo oche righe,
e scelliche. Anche negIi uIlimi inlervenli e enso in isecie a
queIIi deIIa Irugoni, deI rugnoIo, deI CasleInuovo e deIIa Donalo iI
cammino fallo non risuIla oi Iungo, e eraIlro ha riguardalo reva-
Ienlemenle, se non unicamenle, i iiiu|i che accomagnano gIi affreschi
deIIa cosiddella SaIa deIIa Iace. Quanlo aI rilrallo deI oela, molivo
ure accoIlo (ma con oIIice verso) neIIa della |ncic|cpc!ia, da lemo
se n'e ersa anche I'eco, ed e subenlrala un'indifferenza incomrensi-
biIe, e come un accordo generaIe a lacerne. Noi ure, aI momenlo,
dobbiamo scansarIo, erche er lrallarne e indisensabiIe darima
seguire una isla, queIIa deI consigIio, che e deIIe cenlraIi deIIa
Ccnnc!ia, e subilo doo, a Iume di quanlo ne verra fuori, soslarci
suII'aIlra dei raorli lra I'oera di A. Lorenzelli e queIIa di Danle. In
quesl'uIlimo lerreno Ie cose finora rodolle non hanno Ia forza che ci
vuoIe erche Ie si ossa rilenere decisive. I divenlala s iu amia Ia
Iisla deIIe coincidenze e deIIe conliguila schedabiIi, ma Ie riIevazioni
falle riguardano quasi escIusivamenle I'ambilo verbaIe, e cioe iI le-
slo deIIa Ccnnc!ia e Ie didascaIie inserile negIi affreschi: sei ezzi in
versi, che insieme ossono formare una canzone. La crilica, oi, mo-
slra come una relicenza-rilrosia a imegnarsi in un giudizio esIicilo
di inlerlesluaIila fra iI illore e iI oela. Ier arle noslra, siamo con-
vinli che non e dalo di riconoscerne Ia consislenza, e sorallullo di
aggiungere aIlre carle, iu incisive e robanli, se non a una condizio-
ne: uscire daI soIco IelluraIe e daI commenlo secoIare aIIa Ccnnc!ia e
rendere aIlre vie. In ralica, una nuova semiosi. QueIIa in cui cerche-
ro di lirarvi conviene dirIo subilo e rigorosamenle obbIigala:
obbIigo di slabiIire lulle Ie ascendenze, anche minime, dei lesli di
Danle, e di mellere in Iuce Ia sua obbedienza aIIa ibbia alroIogica
Mario Aversano 490
come aI rololio ineIudibiIe er Io scrulinio e I'acquisizione d'ogni
aIlra fonle. Ier Danle lullo iI saere umano, dello e dicibiIe in oesia e
in rosa, quaIe che ne sia Ia rovenienza, e da riorlare aIIa aroIa di
Dio siegala dai Iadri deIIa Chiesa, erche sia giudicalo e cosliluisca
buona vivanda. SoIo daII'imiego dei canoni di quesla mia semiosi
obbIigala che onendosi agIi anliodi di queIIa iIIimilala (e deIIe
sue comode derive dei sensi) incila segnalamenle aIIa ricognizione
deI gioco icsic-iniraicsic-inicricsic olranno scalurire Ie rove che fra
Danle e Ambrogio Lorenzelli e corso un fiIo dirello e conlinuo, e che
deI rimo ci resla anche un rilrallo di mano deI grande illore senese.
I referibiIe, er chiarezza d'esosizione, enunciare subilo iI leo-
rema di base, che e queslo: Danle va consideralo iI rinciaIe (se non
I'unico) isiralore e suggerilore deI Lorenzelli che ha diinlo i
ceIeberrimi affreschi suI buono e callivo governo neI IaIazzo IubbIico
di Siena. L'inlerleslo di laIi caoIavori e da individuare neII'oera
in rosa e in versi deI oela fiorenlino, e non gia neIIe moIle fonli
direlle e obIique di voIla in voIla indicale: aIcune deIIe quaIi di sicuro
agiscono, ma soIo di lraverso, cioe soIo grazie aIIa mediazione di
Danle
1
. Ier iI quaIe Ambrogio Lorenzelli ha cos vivo amore, che gode
di coIIocarIo e con una rimarcalura, vedremo, moIlo decisa lra i
maggiori savi d'ogni lemo, e di Iasciarcene iI rilrallo iu fedeIe lra
queIIi finora calaIogali. isognera guardare aIIa fascia mediana deIIe
lre orizzonlaIi in cui I'affresco deI uon Governo e riarlibiIe: lra i
venliquallro ersonaggi che avanzano a due a due, e che vedremo
non ossono essere aIlro che ConsigIieri. A Danle e assegnalo iI
lerzo oslo, neIIa fiIa deslra (fig. 1).
I bene anche remellere una breve scheda dei lermini deIIa dimo-
slrazione. A arlire daI Ccntitic, e Iungo gIi aIlri due lrallali (Ia cui
comosizione, checche se ne affermi, cade negIi slessi anni), rende
coro con semre maggior chiarezza Ia roselliva di un lerzo ole-
re universaIe, accanlo ai due deII'Imero e deI Iaalo: iI Ccnsig|ic.
Quesla aulorila si quaIifica aII'insegna nalivo-eIelliva deII'ingcgnc e
deIIo siu!ic, I'uno e I'aIlro rori deI satic, neIIa cui dimensione alliva
Danle finisce er assorbire queIIa slessa deI fiIosofo, e coI Ioema
comIici Ie vicende sloriche e ersonaIi assurge a una vera e roria
1 In merilo un quadro abbaslanza comIelo e IeggibiIe in ALOIS RIKLIN, Ia sunna
pc|iiica !i An|rcgic Icrcnzciii, Siena-Locarno, elli-Dado 2000. Vi sono discriminali
ollo arocci inlerrelalivi e indicali aIlrellanli modeIIi: 1) arisloleIico-lomislico
(Rubinslein), 2) Ialino-reumanislico (Skinner), 3) slorico-cosliluzionaIe (Kemers),
4) encicIoedico (IeIdges-Henning), 5) cosmoIogico (Greenslein), 6) roagandislico
(Ierrig), 7) bibIico-reIigioso (Irugoni), 8) figuralivo (Slarn). Di queIIo che er noi e iI
rinciaIe, e che lulli o quasi Ii abbraccia , iI danlesco, non c'e aroIa.
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 491
egemonia, non soIlanlo suII'inpcriun, ma er cerli aselli anche suI
saccr!ciiun. Si direbbe, cioe, che Danle invogIi chi Iegge a raresen-
larsi un lerzo SoIe.
Iigura 1. A||cgcria !c| Bucn Gctcrnc, Ambrogio Lorenzelli (arlicoIare).
I cos egIi si one concrelamenle come iI rimo inleIIelluaIe dav-
vero nuovo: in queI che affronla iI robIema deI raorlo lra cuIlura e
oIilica e Io risoIve moslrando I'imrescindibiIila daI saere er ogni
buon governo dei ooIi, che significa conseguenlemenle riudio deI-
Ia guerra e ossibiIila di acquisire Io slalo di ace, lramile Ia giuslizia
e Ia concordia. L'azione dei reggenli sarebbe, egIi dice, pcricc|csa (a-
roIa che neI suo vocaboIario e davvero eslrema) senza Ia Iuce deIIa
cuIlura. Orbene, Ambrogio Lorenzelli moslra di avere Ie slesse idee.
Iare quasi che egIi abbia rogrammalo di lradurIe aIIa Iellera neIIa
sua iconografia deI buon governo: massimamenle neIIa ersuasione
deII'indisensabiIila deIIa Sapicnza, deIIa Giusiizia, deIIa Pacc e deIIa
Ccnccr!ia (Ie ersonificazioni che dominano neI suo affresco d'in-
gresso), e deII'imorlanza che rivesle, er iI conseguimenlo di quesli
vaIori, sacri e Iaici insieme, Ia figura e iI ruoIo deI ConsigIiere.
Mario Aversano 492
Tulli saiamo che Ia Oitina Ccnnc!ia e comosla di cenlo unila,
dislribuile in lre Canliche, Ia rima di 34 canli e Ie aIlre due di 33. Non
sara difficiIe ammellere che iI verso iniziaIe, Nc| nczzc !c| cannin !i
ncsira tiia, e lullo iI rimo canlo deII'|njcrnc hanno I'ufficio di esorre
e avviare iI fiIone reIigioso-siriluaIe-inlimo, che locca e riguarda
Danle rivalo, uomo lra gIi uomini. Ieccalore 'converso', egIi ha da
comiere un viaggio nei lre regni deII'OIlrevila crisliano, I'Inferno, iI
Iurgalorio e iI Iaradiso, a scoo di enilenza, di urificazione e di
rogresso elico-leoIogico. AIlrellanlo manifeslo e che I'uIlimo canlo
deI Ioema e Ia lerzina che Io chiude segnano iI fauslo comiersi di laIe
viaggio, e dunque I'esaurirsi di queI fiIone. AI lermine deII'avvenlura
oIlrelombaIe iI !csic e iI tc||c deI viandanle, disIegali da ogni nube di
morlaIila, si voIgono coI molo elerno deIIo Sirilo sanlo: Ma gia voI-
geva iI mio disio e iI veIIe / s come rola ch'iguaImenle e mossa /
I'Amor che move iI soIe e I'aIlre sleIIe (Par. XXXIII, 143-145). Irinci-
io e fine deIIa Ccnnc!ia, dunque, sedi demarcalive er ecceIIenza,
allengono rimamenle a un fallo inleriore, Ia conversione, generala
daI enlimenlo, che con Iinguaggio lecnico si chiama comunzione
deI cuore er aura (cfr. |nj. I, 15: che m'avea di aura iI cor com-
unlo): aura deIIa dannazione elerna. L'Aulore riroone Ia sloria
deIIa ccnscicniia, quaIe si risconlra neIIa leoIogia alrislico-monaslica
deIIa ccnpunciic ccr!is prcpicr iincrcn, che lrova iI iu comIelo e au-
lorevoIe bando neIIa dollrina di san ernardo di ChiaravaIIe
2
: iI
assaggio graduaIe daIIo sladio deI eccalo (Ia sc|ta cscura) aI lra-
guardo deIIa visione e deI congiungimenlo con Dio, o, er dirIa iu
esallamenle, con Ie singoIe Iersone deIIa Trinila e i reIalivi misleri
3
.
Ma queslo viaggio di rilorno a Dio non riguarda unicamenle Ia
ersona, I'individuo sIegalo daIIa comunila. A voIer lrovare er Ia
Ccnnc!ia una formuIa Ia iu onnicomrensiva e caIzanle che si ossa,
dovremo s chiamarIa iI Ioema deIIa Conversione, ma da inlendere
come melanoia generaIe di lulli i vivenli. Conversione in icic erche
non e escIusivamenle inlerna e rivala (Ia ccntcrsic aninac), ma anche
ubbIica, oIilico-civiIe, e imegna I'inlera famigIia umana. La qua-
Ie dovra assare daIIo siaius niscriac e niscria er Danle vaIe
essenziaImenle 'guerra', come orlalo deIIa generaIe erranza (suer-
bia-faIsila-discordia-ingiuslizia-invidia-odio) a queIIo di ace e di
feIicila. Queslo lraguardo aI conlrario di quanlo redicavano moIli
Iadri e Dollori, da S. Agoslino a S. Tommaso er Danle non e affallo
2 Cfr. aImeno MARIO AVIRSANO, San Bcrnar!c c Oanic. Tcc|cgia c pccsia !c||a ccntcr-
sicnc, SaIerno, Idisud SaIerno 1990, . 5-107. Ier i versi deI Ioema, si cila con Iiberla
d'ozione, ed occhio sorallullo aIIa Oanicsca e aIIe due edizioni elrocchiane.
3 IDIM, Oanic !accapc, AlriaIda, WM Grou SrI. 2000, . 61-65.
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 493
irraggiungibiIe in lerra: qui, e slalo ben dello, va scorlo uno dei
cardini deII'Umanesimo danlesco. AI mondo gIi uomini e i ooIi, se
guidali secondo virlu e ragione, ossono vivere in concordia-giusli-
zia-amore-ace-verila: ensiero che, si badi, e gia risconlrabiIe neI
rimo canlo deIIa Ccnnc!ia. Isso acquisla unila soIo in queI che se ne
receisce Ia rogrammala oIilicila
4
. Senza dire, aI momenlo, che er
quesla via diviene chiaro che Ia Ccnnc!ia e iI oema deII'IlaIia unila:
dacche soIlanlo daIIa acificazione e riunione deIIe sue !isiccia ncn|ra
olra scalurire Ia sua sa|uic, oeranle con iI VeIlro, con i suoi buoni
ConsigIieri, Danle in rima fiIa.
Ma c'e oi neII'oera un'aIlra sede demarcaliva: queIIa numerica-
menle cenlraIe. Issa e cosliluila daI cinquanlesimo canlo, che chiude
Ia rima mela (Ie rime cinquanla unila deIIa cenlina di cui e fallo iI
Ioema), e daI cinquanlunesimo, che are Ia seconda mela: iI XVI e
XVII deI Purgaicric, regno mediano, a sua voIla, lra |njcrnc e Para!isc.
Sono canli, ercio, che hanno una doia cenlraIila: neIIa Ioro Canlica
e neIIa Ccnnc!ia. TaIe osizione dice er lulli neI suo Commenlo
Manfredi Iorena (meravigIiandosi che Danle I'abbia segnala e solloIi-
neala, anziche con un nome famoso e nolo a lulli, semIicemenle
con Marco Lombardo, un corligiano a noi quasi sconosciulo) e di
imorlanza immensa. Iercio e naluraIe chiedersi quaIe ufficio Dan-
le aulore affidi a quesla coia di canli due voIle inlermedi e erche
neI rimo di essi accami un Marco Lombardo 'quaIsiasi'. Iuo dirsi
un enigma anche queslo, come iI riconosciulo, cIassico enigma di
SordeIIo, daI quaIe e giocoforza che si arla se si vuoIe dare aII'aIlro
una risosla che non sia deIIe soIile, e onga fine agIi sluori rovoca-
li daI fallo che Marco arIa da gran fiIosofo-leoIogo, e inlorno ai
massimi sislemi: dei ruoIi deII'Imero e deI Iaalo, e deIIa decadenza
deII'umanila. SordeIIo da Goilo e Marco Lombardo vogIiono essere
riconosciuli come i due ersonaggi che iu e megIio danno iI fiIo er
inlendere da una arle Ia concezione oIilico-leoIogica di Danle,
daII'aIlra come daI suo aIveo siano fiorili iI ensiero e Ie iconografie
deI buon governo di Lorenzelli. II quaIe e sara una sorresa
verificarIo moslra di avere, Iui e gIi ambienli in cui visse e oero
4 Infalli: 1) iI quaIificalivo buono (|nj. I, 71), che ricorre er Auguslo, non significa
vaIenle (come da semre viene affermalo e rielulo), ma animalo da voIonla di bene
e di ace: con coslui (Auguslo) uose iI mondo in lanla ace. (Par. VI, 80 sgg.), 2)
gIi dei faIsi e bugiardi (|nj. I, 72) in lanlo sono menzionali da VirgiIio in quanlo
embIemi di vizi d'ogni sorla, e seciaImenle di discordia e mendacila, 3) VirgiIio e ro-
cIamalo canlore deIIa giuslizia (|nj. I, 73), 4) Ia ace ha iI massimo nemico neIIa
cuidigia, Ia Iua, non a caso della Ia beslia sanza ace (|nj. I, 58), 5) iI VeIlro, neI
soIco di Auguslo, Ia uccidera er Ia sa|uic deII'IlaIia (|nj. I, 106 sgg.), reIudio aIIa ace
universaIe, che sara ad immagine deIIa serenila ceIesle (Par. VI, 55-56).
Mario Aversano 494
(si ricordi che Siena e Ia cilla iu frequenlala deIIa Ccnnc!ia, doo
Iirenze e Roma), una conoscenza e nozione deII'oera di Danle cos
rofonda ed esalla quaIe in seguilo e fino ad oggi, aImeno er cerli
aselli, non s'e risconlrala. Lorenzelli ha diinlo Ia beIIissima
immagine deIIa Iace (che ha dalo iI nome aIIa SaIa in cui si lrova)
er quesla ragione: erche ha riconosciulo in Danle coIui che mag-
giormenle Ia amo, insieme aIIa Giuslizia e aIIa Verila, e megIio ne
see coslruire I'edificio leorico e di oesia. Lorenzelli ci conforla a
rilenere, in uIlima anaIisi, che a Danle selli iI liloIo di maggior rofe-
la deIIa ace in lerra.
L'INIGMA DI SORDILLO
1. L'eIezione di SordeIIo a incombenze e rango di riviIegio
resenzia in lre canli deI Purgaicric e fa da guida e da cicerone a
VirgiIio slesso, oIlre che aI suo disceoIo, e er un lrallo moIlo ime-
gnalivo deI viaggio esialorio, iI lransilo er Ia vaIIella dei Irincii
cosliluisce una deIIe cruccs iu ardue deI Ioema. A renderIa iana
hanno rovalo lulli e da semre, ma con esili non convincenli. Iure
iI modo di caire e giuslificare aieno I'imorlanza che Danle confe-
risce aI Goilese c'e: essa lrova siegazione soIo quando deII'anina
|cn|ar!a si esIori con indugi Iunghi e ravvicinali I'oera Ielleraria in
una con queIIa deII'uomo oIilico, con seciaIe riguardo ai comili
che egIi svoIse neIIa conlea di Irovenza e oIlre: di ConsigIiere di corle.
In queslo ufficio Ia saticzza deII'inleIIelluaIe aare inlimamenle
connessa con Ia relliludine deII'uomo asselalo di giuslizia e di ace. I
Io slesso ruoIo che rivesl semre e dovunque Danle. II quaIe neIIa
Ccnnc!ia, non bisogna slancarsi di rielerIo, eIeva iI ConsigIio, in
Iinea con quanlo e gia neI Ccntitic
5
, a |uninarc nagnun, o a reslare
nei lermini Iinguislici deI Trallalo a massima auicriia!c, che non
reugna a Ia imeriaIe. La sua iu lenace convinzione e che, rivo di
laIe scorla, I'inpcriun brancoIerebbe neI buio e mellerebbe a rischio
5 IondamenlaIe e quanlo si Iegge aI ca. VI deI IV lrallalo: I ero si scrive in queI-
Io di Saienza: 'Amale Io Iume de Ia saienza, voi lulli che siele dinanzi a' ouIi. Cio e
a dire: congiungasi Ia fiIosofica aulorilade con Ia imeriaIe, a bene e erfellamenle reg-
gere. Oh miseri che aI resenle reggele! e oh miserrimi che relli siele! che nuIIa fiIosofica
aulorilade si congiunge con Ii voslri reggimenli ne er roio sludio ne er ccnsig|ic
|.j. Ionelevi menle, nemici di Dio, a' fianchi, voi che Ie verghe de' reggimenli d'IlaIia
rese avele e dico a voi CarIo e Iederigo regi, e a voi aIlri rincii e liranni, e guarda-
le chi a Ialo vi siede er ccnsig|ic, e annumerale quanle voIle Io die queslo fine de
I'umana vila er Ii voslri ccnsig|icri v'e addilalo!. La cilazione e daIIa ed. a c. di Iredi
ChiaeIIi-Inrico Ienzi, Torino, UTIT 1986, daIIo slesso voI. Ie cilazioni daIIa Mcnar-
cnia (a c. di Iio Gaia), e daIIe |pisic|c (a c. di AngeIo }acomuzzi).
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 495
I'ordine e iI governo deI mondo: una sacraIizzazione deI ConsigIio su
base bibIica er Ia sapicniia che esso recIama, queIIa slessa che fu
creala rima d'ogni cosa (|cc|i. I, 1) miranle a sciogIiere iI nodo di
semre, deI raorlo lra cuIlura e olere, con Ia leorizzazione se non
deI rimalo, cerlo deII'assoIula urgenza e obbIigaloriela deIIa rima.
Iercio non sara da reulare cosa Iieve aI di Ia deI Iuogo comune
che individua nei sesli canli deI Ioema un rogresso di loografia
oIilica (Iirenze-IlaIia-Imero) Ia orlala indicaliva giacenle neIIa
seIezione dei lre ersonaggi che vi hanno camo: Ie risuIlanze deIIa
ricerca dicono che SordeIIo (VI deI Purgaicric) vuoIe andare come suoI
dirsi a braccello non soIo con Romeo di ViIIanova (VI deI Para!isc), ma
anche con Ciacco (VI deII'|njcrnc), e che lulli e lre sono arenli slrelli
di Marco Lombardo. Ne dovra lacersi Ia comunanza lioIogica mai
risconlrala, ch'io saia che Ii slringe ad aIlri ersonaggi famosi
deIIa Ccnnc!ia: Iarinala, Iier deIIa Vigna, runello Lalini, UIisse,
Guido da MonlefeIlro, Mardocheo, Aman, Cacciaguida, Giovanni
allisla
6
, er dirne aIcuni dei maggiori, e, aI femminiIe, Saa senese,
che satia non fu
7
, Ia regina Amala, Maria di rabanle, Cunizza da
Romano, Isler, MicoI, Irodiade, Ie due GuaIdrade, e generaImenle Ie
mogIi-soreIIe-madri-figIie che hanno lrovalo oslo neI Ioema. Ierso-
naggi che lulli, a chi ne scruli er inlero Ia fenomenoIogia deIIe
incidenze, orbilano neIIa sfera deI ConsigIio e dunque si fanno ricono-
scere er oeralori di ace o di guerra.
2. L'allacco deI canlo VI deI Purgaicric, Quando si arle iI gioco
de Ia zara..., in queI che disegna Ia figura di un erdenle non deroga
a una deIIe regoIe rime deI comorre danlesco: reannunzia, coi suoi
Iemmi, Ia lemalica e iI ersonaggio rinciaIe deI canlo, SordeIIo.
Quesli neI suo |nscnnancn !cncr un oema in versi che neIIa circo-
slanza Danle moslra di aver Iello e uliIizzalo esIicilamenle
condanna chi dissia i rori averi:
6 ConsigIiere di Irode, che Io ascoIlava voIenlieri e in moIle cose si faceva da Iui
convincere, saendoIo uomo sanlo e giusic: Herodes enim meluebal Ioannem, sciens
eum virum iusiun el sanclum, el cuslodiebal eum, el, audilo eo, muIla faciebal, el Iiben-
ler eum audiebal (Marc. VI, 20). Ier queslo Danle ne fa nominazione neI cieIo deIIa
Giuslizia (Par. XVIII, 134-135): cfr. AVIRSANO, Oanic !accapc, cil., . 33.
7 Come consigIiera Saia e resenlala neIIa |cciura deI canlo XIII deI Purgaicric che
lenni a Iirenze, er Ia Sociela Danlesca IlaIiana, iI 14 novembre 2002 (ora in SiIarus
XLIII, 2003, . 26 sgg.). Aggiungerei Ia Scniranis andala sosa a Nino (iI quaIe cerlo
non ne ascoIlava iI consigIio), che aIIa sua morle non fu regina sufficienle, dacche
Iibilo fe Iicilo in sua Iegge (|nj. V, 52-60), e non unifico Ie nc|ic jatc||c, come fece oi iI
|ucnc Augusic.
Mario Aversano 496
quar nuIz oms no deslrui Io seu
quenon erda son rez en breu.
(nessuno consuma iI suo alrimonio senza erdere in breve iI
suo regio)
8
.
Occorre badare aIIa liloIazione |nscnnancn. II vocaboIo ci orla con
Ia menle, innanzilullo, aIIo nscgnataic di |nj. XV, 85: un Iuogo che an-
cora fa dubbiosi i crilici suIIa nalura deII'arendimenlo danlesco da
runello Lalini (arli IiberaIi, o Ielleralura, o fiIosofia, o elica, o relori-
ca, o eIoquenza, o aulonomia deIIa coscienza scienlifica, ecc.), e suI
quaIe riconvergeremo aI iu reslo. NeI verbo danlesco olrebbe es-
serci una memoria cilaliva deII'|nscnnancn !cncr, iI che indurrebbe a
cercare in aIlra direzione Ia marca di queII'insegnamenlo. Sla di fallo
che Ia ricorrenza deII'insegnare qui, a v. 60, e Ia rima deIIe uniche
due reeribiIi neIIa seconda Canlica. Quando oi si consideri che iI
pccna sacrc narra I'an!aia (|nj. II, 25) neII'OIlrelomba d'un neo-con-
verlilo che in lanlo avanza e s'affina in quanlo e oggello di conlinui
insegnamenli, non olra non coIire Ia fIagranza di aIcuni dali slali-
slici: 1) rorio neI Para!isc dove non c'e occasione che ealrice non
coIga er Iezioni-correzioni aIIa ricerca di verila formalive deI suo
aIunno iI lermine insegnare manca deI lullo: segno che Danle non
Io fa coincidere coI cIassico !cccrc, e Io sollrae aII'accezione leoIogica,
2) queslo verbo ha neIIa Ccnnc!ia che ure marcia lanlo neI didalli-
co un numero d'imieghi singoIarmenle ridollo: soIo cinque, 3) in
essi e imIicalo semre iI lema deIIa guida, 4) ma in lre casi e riferilo
chiaramenle a ersonaggi con ambili di allivila civiIe-oIilico-miIilare:
runello Lalini, Guido da MonlefeIlro, e recedenlemenle Ciacco Ia
cui idenlila di corligiano vedremo configurarsi in modo semre iu
nilido in un asso (|nj. VI, 79-81) dove eraIlro ci si imballe er Ia
8 II lema e resenle anche neI Tcscrciic deI Lalini (iI cui consigIio, come e nolo,
lanlo eso ebbe neIIa vila civiIe deIIa Iirenze redanlesca), e rorio nei versi da cui
uo essere disceso iI |cr!c||c di v. 78: Ancor, chi s'abandona / er asiic di ersona / e
er sua vanagroria, / esce de Ia memoria / a sender maIamenle, / non m'agrada neenle,
/ e moIlo m'e rubeIIo / chi disende in |cr!c||c / |.j e legno grande scherna / chi di-
sende in laverna / e 'I suo !isiruggc a lorlo / |.j e eggio che omo morlo (vv. 1447
sgg.). Considerala Ia coincidenza deI !isiruggc coI sordeIIiano !csirui e si ricordi iI
danlesco !isiruggiicr di se e di sue cose (|nj. XXII, 51) e deIIa zara con queIIa di Tcsc-
rciic 2776 (e aIlro er imiezza / a Ia zara s'avezza), fa gia caoIino I'idea di una |iaiscn
oelico-oIilica lra SordeIIo, runello e Danle. Cfr. SORDILLO, Pccsic, a cura di Marco
oni, oIogna, IaImaverde 1954, XLIII, 318-319. Ier Ia gravila e Ia IuraIila dei sensi
annidali neIIa simiIiludine danlesca, cfr. AVIRSANO, Ic cpcrc !i niscriccr!ia ira i| V c i| V|
canic !c| Purgaicric, in Oanic c i| Giu|i|cc, Alli deI Convegno (Roma, 29-30 novembre
1999), a cura di Inzo Isosilo, Iirenze, OIschki 2000, . 169-174.
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 497
rima voIla neI ben fare (che, sia dello immedialamenle, e sinlagma
lecnico deIIa Iingua deI ConsigIio), e er nomi e azioni che non er-
lengono, aImeno non neIIo secifico, aIIa cuIlura deII'anima: Iarinala,
iI Tegghiaio, Iacoo Ruslicucci, Arrigo e Mosca dei Lamberli, 5) i re-
slanli due imieghi, qui a v. 60 e oi a Purg. XI, 42, riguardano I'uno
I'informaliva deIIa tia piu icsia, I'aIlro di un tarcc che sia ncn cric, 6) in
quesl'uIlimo iI fiIo coI ersonaggio, iI senese Omberlo AIdobrandesco,
e dirello, e Omberlo fu nobiIuomo aI governo deIIa cosa ubbIica, non
a caso egIi nominando Ia ccnunc na!rc (e si e lenlali di chiosarIa neI
senso di alria, cioe Siena, a guardare come neI Tcscrciic si redica
che I'uomo nasce aI Comune) inlriga Ia sloria di quesla cilla dei
ConsigIi er ecceIIenza, laIe fin neIIe creazioni deII'arle figuraliva:
ecco gia rofiIarsi I'ombra di Ambrogio Lorenzelli, 7) ma I'insegna-
menlo in cui ora, Iascialisi dielro i morli pcr jcrza, VirgiIio confida, e
con allesa non sfiorala da dubbio
9
, riguarda Ia soIa anima di SordeIIo.
Ne lrarremo Ie conseguenze lra oco, neII'aggredire Io nscgncra di
v. 60: I'iolesi e che neIIa Ccnnc!ia Ia moduIazione deII'insegnare
faccia cao a obiellivi refissali, e dunque slrulluraIi, dove oco o nuI-
Ia enlra Ia linla scoIaslica che ancora iI verbo manliene, e lullo versi
neI oIilico.
3. Aerlo aII'indagine queslo nuovo canaIe, sara senz'aIlro da rico-
noscere come I'ollica consiIiare si riveIi frulluosa, er non dire
risoIuliva, aena doo, di fronle aIIa Iisla di anime non breve ma
ur semre cavala daI novero deIIe nc|ic
10
deI silo urgaloriaIe (Purg.
V, 43) che occua Ie cinque lerzine successive aI roIogo, a comin-
ciare da v. 13, e che a lorlo s'e lirala I'accusa di mera induIgenza aIIa
cronaca: Quiti cra |arciin.
L'arelino e enincasa da Lalerina: un giudice oneslo che ebbe
anche moIla saggezza oIilica. Non ci si e mai accorli, ch'io veda,
come laIe rassegna di reganli faccia da pcn!ani aIlro araIIeIismo,
dunque, lra i moIli giocali lra i sesli canli a queIIa di |nj. VI, 79-81
sora della (da |arinaia aI Mcsca), dacche uguaImenle inizia, rocede
e lermina con Ia menzione di uomini che furono allivi neIIa cosa
ubbIica, che amminislrarono giuslizia e oerarono neIIe Corli o nei
ConsigIi cilladini
11
. I consigIieri oi erano aI servizio er dirIa in
9 Non sara difficiIe avverlire come squiIIi iI ronome dimoslralivo ch'e a cao
deII'endecasiIIabo: 'queIIa ne 'nsegnera Ia via iu losla'.
10 SuI vaIore di queslo aggellivo, di cui Danle accogIie Ia regnanza consiIiare
suIIa base deIIa bibIica nu|iiiu!c sapicniiun, cfr. Ie . seguenli.
11 I nolo che vi erano chiamali a ben fare giudici, cavaIieri e nolai, come si a-
rende daI finaIe deI lerzo Iibro deI Trcscr deI Lalini, neI voIgarizzamenlo di ono
Mario Aversano 498
sinlesi, e ancora con runello de' signori e deIIe comunanze
12
.
QueII'eIenco e dunque sliIalo er disorre chi Iegge aII'inconlro con
un enilenle che chiede di essere riconosciulo er I'cpcrarc che iu Io
fece degno di slima in lerra: oela indubbiamenle, SordeIIo, ma er
cio slesso uomo di scnnc
13
e consigIiere caace e rello.
Non meno remonilore e ivi iI Iessico. II lermine intcggia (v. 20)
lraduce iI rovenzaIe cntcia, e cosliluisce cos un aIlro locco di reIu-
dio aII'eifania di SordeIIo, non lanlo erche in queIIa Iingua e iI com-
onimenlo a cui egIi deve Ia sua noloriela, iI P|ann er Ia morle di ser
Iacalz, quanlo erche rorio queI vocaboIo imiego er dirsi villi-
ma deII'invidia a corle: L'us me voI maI pcr cntcia (I'uno mi vuoI
maIe er invidia)
14
. AIIora ci lorna in menle che I'invidia come si ri-
cava gia da Ccnt. III, XV, 10: Ii sanli non hanno lra Ioro invidia e
agIi anliodi deII'amore-carila
15
, Ia virlu che meno aIberga lra i vivi
d'IlaIia (cfr. Purg. VI, 115: Vieni a veder Ia genle quanlo s'ama!), e
neI conlemo lira in baIIo rima Ie corli, dove laIe vizio e di casa (|nj.
XIII, 64-66, Par. VI, 130-132, ecc.), e oi iI g|cricsc cjjizic (|nj. XIII, 62) di
ConsigIiere. La memoria gia corre aI ccnsig|ic di Purg. VI, 131, Iegalo
com'esso aare aIIa giusiizia fiorenlina: MoIli han giusiizia in core, e
lardi scocca / er non venir sanza ccnsig|ic a I'arco. Inlanlo va riIeva-
lo che Ia rima comarsa deI vocaboIo inti!ia enlro iI Ioema si riscon-
lra neI canlo VI deII'|njcrnc, e in riferimenlo a Iirenze (vv. 49-50)
16
:
Id eIIi a me: Ia iua ciiia, cn'e iena
d'inti!ia, s che gia lrabocca iI sacco,
seco mi lenne in Ia vila serena.
Aumenla dunque di sessore Ia Iinea inlerrelaliva sora abbozza-
Giamboni, un comIelo 'gaIaleo' deI governalore di cilla (Cesare Segre): I quando
eIIi ha giuralo, aIIora deno giurare lulli Ii suoi giudici e Ii cavaIieri e Ii nolari, ciascuno
in dirillo di seie, di fare bene e IeiaImenle Ioro officio, e di !cnarc a| |cr signcrc |ucnc
ccnsig|ic, e di lenere (credenzia cio ch'e da lenere) rivado.
12 Cfr. Ia prcsa !c| Oucccnic, a cura di Cesare Segre e Mario Marli, MiIano-NaoIi,
Ricciardi 1959, . 163.
13 Cfr., er Ia regnanza deI lermine in SordeIIo, iI ar. 9.
14 XLII, 5, ed. e lrad. oni, cil.
15 Luogo comune alroIogico, assunlo in Purg. XIII, 37-39.
16 Su quesla nola, Ia iu doIenle in lema aulobiografico, I'A. lorna er bocca di
IoIchello da MarsigIia, che oelo in rovenzaIe come SordeIIo: Ia iua ciiia, cnc di coIui
e ianla / che ria voIse Ie saIIe aI suo fallore, / e di cui e Ia nti!ia lanlo ianla |.j
(Par. IX, 127-129). Viene a formarsi aIIora un circoIo di corrisondenze in cui recIama a
buon dirillo di enlrare anche Ia cilazione deII'invidia che i Iiorenlini nulrono er iI
oela, quaIe risiede a |nj. XV, 68, neIIe aroIe di ser runello (genl'e avara, inti!icsa e
suerba).
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 499
la, che isliga a rinlracciare un raorlo inlerlesluaIe lra I'|nscnnancn
di SordeIIo consigIiere di corle e I'insegnare (|nj. XV, 85) di ser
runello, iI quaIe fu consigIiere in Iirenze (ma anche oIlraIe) a ar-
le Ia carica che ricor daI 1273, di nolaio dei ConsigIi deI Comune
17
e aulore di oere che consigIiano
18
. Con occhio non meno inleressa-
lo, aIIora, si guardera aIIa seconda lerzina (|.j e qui roveggia / Ia
donna di rabanle |.j), deIIe due che ragguagIiano di Iier da Ia
roccia (vv. 18-24). Issa, Iungi daI soravvenire in modo incidenlaIe,
ha iu d'un riverbero infIuenle. In rimo Iuogo fa Io sazio oelico di
Iiero iu esleso di queIIo accordalo agIi aIlri incIusi in queslo nuovo
eIenco, doo iI recedenle deI quinlo canlo (Iacoo deI Cassero,
uonconle da MonlefeIlro, Iia dei ToIomei). Cio conferisce iu risaIlo
aII'ingiuslizia che I'innocenle corligiano deI re di Irancia sub in vila,
ma cos I'A. uo anche inviare daII'esiIio un monilo di casligo divino
ai suoi nemici. Quesli versi, ercio, rendono iu chiara I'inlenzione
aulobiografica deI oela. Issi, inlroducendoci neII'ambienle deIIe corli
regie, e resenlando un'aIlra villima deII'invidia che vi regna, fanno
rea una donna, Maria di rabanle, che fu sicuramenle inlrigala coI
ConsigIio, in quanlo sosa di IiIio III I'Ardilo. Converra dedurne,
aIIora, che er Danle I'imulazione mossa a Iiero non riguardo, come
generaImenle si crede, alli rivali (iI lenlalivo di sedurre Maria), ma iI
suo ufficio di ConsigIiere: coIilo a lorlo er iI ben fare, con I'accusa
ingiusla di infedeIla aI suo signore, che a queI lemo era in guerra
con AIfonso X di CasligIia. Avrebbe lenulo raorli segreli con
quesl'uIlimo. DeI moIlo o oco che ne se diceva in Iirenze ancora nei
17 In Crcn. VIII, 10, come e nolo, Giovanni ViIIani Io dice maeslro in saere guida-
re e reggere Ia noslra reubbIica.
18 Da nolare che I'inciso ccnc !icca (Purg. VI, 21) orla a dedurre iu cose abba-
slanza in chiave: 1) iI eIIegrino s'arma d'ogni azienza, ascoIla ogni racconlo, anche
queIIi che non loccano Ie oere di misericordia, 2) giacche a arIare e un'anima saIva e
dunque non iu caace di menzogna, arendiamo che anche er queslo consigIiere Ia
nomea diffusa in lerra e ingiuslamenle denigraloria, 3) come Ciacco, Iier de Ia Vigna,
Manfredi e Saa e aIlri ancora, lra cui i lre Iiorenlini sodomili, ma da vivi onorali
er Ia Ioro ctra indubilabiImenle civiIe (e non soIo Ielleraria o rivala, cfr. |nj. XVI, 58-
60: Di voslra lerra sono, e semre mai / I'ctra di voi e Ii onorali nomi / con affezion
rilrassi e ascoIlai) Iier da Ia roccia liene moIlo aI risloro deIIa roria memoria, che
giace er i coIi deII'invidia, 4) iI lermine fama uo dirsi imianlalo neIIa Ccnnc!ia
eIellivamenle er i ConsigIieri, lanlo da oler cosliluire un eIemenlo sia er Ia deler-
minazione deIIa oIilicila de ersonaggi, con reIalive benemerenze e coIe. Cos anche
aIlri, in rimo Iuogo iI jarc (secie se recedulo da |cn: |cn jar, |cn jarc: esemIare, e ci
lorneremo, iI |cn jar di |nj. XV, 64, ma anche queIIo di |nj. VI, 81, simmelrico aII'aIlro di
Par. VI, 132, cfr. inoIlre iI |cnc ctrar di Par. XVII, 141, e iI |cnc cpcrar di Par. XX, 59), e i
conligui cpra, cpcra, cpcrar, ctra, ctrar, ma anche giusic, ingcgnc, aric, e saggic, satic,
scnnc, cncrc (aroIe, scoriremo, agganciabiIi aI scn e aIIcnscnnancn !cncr rovenzaIi e
sordeIIiani), ccnjcric-i, ecc.
Mario Aversano 500
rimi decenni deI secoIo (Maria mor neI 1321), degno di ascoIlo e
quanlo riferisce envenulo, con aroIe che evocano un aIlro Iiero,
queIIo diIello da Iederico II: conceil grave odium conlra eum quem
vir suus lanlum diIigebal
19
.
4. Ci sono ora gIi eIemenli chiave er un aroccio iu corrello
aIIe lerzine che rilraggono SordeIIo. Si nolera come I'emislichio
intcrsc nci riguar!a, neI riferire iI rimo geslo di SordeIIo ersonaggio,
comunichi I'idea di un carallere non indifferenle aII'eslerno. IgIi e
inleressalo a queIIi che vengono, come a vaIularne Ia condolla: un
jarc, si direbbe, un o' da guardiano e un o' da giudice, quaIe e
ricavabiIe dagIi elimi di sguar!an!c (v. 65), che significano Ia guardia-
cuslodia-luleIa-vedella. Non a caso Ie aroIe con cui doo I'abbraccio
egIi rirende iI diaIogo con VirgiIio, Voi, chi siele` (Purg. VII, 3),
sono idenliche a queIIe che iI cuslode deI Iurgalorio, Calone, ha rivoI-
lo ai due eIIegrini: Chi siele voi.` (Purg. I, 40). Si avverle gia un
che di reIudenle a queIIo che sara iI suo comilo: condurIi, far
conoscere Ioro I'idenlila degIi osili deIIa vaIIella amena, e giudicare
19 Che oi Iier da Ia roccia sia I'uIlimo ad essere accoIlo in quesla nominalio di
reganli, lulli ridiciamoIo uomini di giuslizia, di governo e di corle, e fallo che da
credilo definilivo aIIa lesi d'un reIudio aI rossimo inconlro: iI eIIegrino I'avra con
uno sirilo, SordeIIo, affiancabiIe a Iiero e agIi aIlri che Io recedono in quanlo coIIega,
da vivo, neI ruoIo di ConsigIiere. A laIe ambilo virluoso ma in diverbio con Maria di
rabanle, essima consigIiera in quanlo rosa da invidia olra accedere Ia slessa Cu-
nizza da Romano, che I'A. coIIoca in Iaradiso neI cieIo di Venere. Donna anch'essa di
corle, Cunizza rogello coI fraleIIo IzzeIino Ie rorie nozze diIomaliche (sinla a
queI che se ne lramanda daI desiderio di meller ace lra famigIie osliIi) con Rizzardo
di San onifacio, signore di Verona, e quando queslo rogello si riveIo irreaIizzabiIe
risoIse di lornare in alria er rallo di SordeIIo. Un rimo indizio deIIa sua vocazione aI
civiI negozio e I'avvenlo, neI rofiIo che di Iei I'A. lraccia a Par. IX, 22 sgg., deI sinlagma
|cn jar, che s'e avverlilo neIIa Ccnnc!ia soraggiunge ogni quaIvoIla Ia maleria
diviene aerlamenle ubbIica, cos imIicando I'ingegno e Ia relliludine deI Consi-
gIiere. I cade anche Ia difficoIla che si rova a loIIerare Ia sua giacenza neI conleslo
deIIa lerzina: Onde Ia Iuce che m'era ancor nova, / deI suo rofondo, ond'eIIa ria
canlava, / seguelle come a cui di |cn jar giova. Si uo inoIlre aggiungere Ia conslala-
zione che Ie aroIe da Iei ronunziale sono di giudizio elico-oIilico Iungo lullo I'arco
dei versi, e con rimando finaIe, e soIenne, aIIa giuslizia di Dio, di cui queIIa umana e
rifIesso, e che Ie rime imIicano rorio Ia serva IlaIia dei vv. 76 sgg.: In queIIa arle
de Ia lerra rava / ilaIica... (Par. IX, 25 sgg.). AIIa difesa deI vaIore deIIa giuslizia, in
queI che e comagna deIIa carila, aaiono imronlali, a quanlo sembra, anche i due
soIi reerli che di Cunizza recano nolizia, I'allo di Iiberazione degIi uomini di masnada
(1 ariIe 1265) e iI leslamenlo a favore dei nioli (10 giugno 1279): anche se, dicono
aIcuni, si lrallo di sceIle ghibeIIine conlro Ia arle gueIfa. Ma e aIese che Danle Ia ro-
one, aI conlrario, come donna caace di senlenze imarziaIi, quando Ie fa revedere iI
casligo deI rele corlese, AIessandro NoveIIo, rorio er iI suo moslrarsi di arle
(Par. IX, 58-59).
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 501
cosa a cui Danle slesso, iu innanzi e in un canlo araIIeIo, verra
chiamalo da Giusliniano (Par. VI, 97) I'cpcra dei resonsabiIi deI
governo in lerra, deI assalo, deII'oggi e deI domani. Un rofiIo lullo
in |cnc, di guida aunlo, allesla anche iI verso che segue: quc||a nc
scgncra |a tia piu icsia. Ierche neII'affermazione lanla fiducia di ri-
sconlro osilivo` VirgiIio, dobbiamo rilenere, s'e accorlo che ha
dinanzi un'anima non svagala: daIIo sguardo rorio di chi conosce e
forse vegIia sui Iuoghi. Ma e Io nscgncra che a lirare Ie somme di
quanlo e fin qui venulo a giorno svella iu d'ogni aIlra ceIIuIa
Iinguislica. La sceIla e Ia sede di quesla voce verbaIe sono con eviden-
za caIcoIale: esiliamo semre meno ad affermare che essa venliIa una
rerogaliva iI saere-saienza-saviezza roria d'un ufficio, queIIo
deI ConsigIio, neI quaIe iI ersonaggio avvislalo, SordeIIo, si guada-
gno aI mondo onore e fama.
DaIIo sogIio degIi imieghi che I'insegnare ha neIIa Ccnnc!ia
abbiamo eslrallo oco fa un dalo gia di er se indicalivo: neI iu
dei casi (lre su cinque) I'insegnare riguarda Ia sfera civiIe-oIilica,
ed ha raorlo slrello coI consigIio e coI governo, e neII'uIlimo che
cade neI Purgaicric aII'inconlro con Omberlo AIdobrandeschi
imIica quanlo meno i Iuoghi deulali deI consigIiare, e aIIa Iellera iI
lema deIIa guida er Ia slrada migIiore: mansione che con evidenza
enlra neI circoIo melaforico deI consigIio. Ma anche iu iIIuminanle, e
d'una significalivila ineIudibiIe, e che iI verbo comaia er Ia rima
voIla neI seslo deII'|njcrnc, cioe a cao deIIa lerna dei canli cosiddelli
oIilici, e neI arlicoIare chiami in causa un dannalo, Ciacco, che
consigIiere non uo non essere. Cio non soIlanlo erche laIe Io dicono
i rimi commenlalori, ma anche er quanlo si deduce daI coIIoquio
che con Iui inlralliene iI venulo da Iirenze in cerca di Iumi suIIe
condizioni deIIa sua cilla, neIIa quaIe egIi e slalo allivo come Consi-
gIiere, e sla er esserIo come Iriore (giugno 1300). Troa e Ia gravila
deIIe cose, e lulle ubbIiche, domandale a Ciacco: come ensare che
a dirne e a farne giudizio vaIga un ghiollone quaIsiasi`
20
I se laIe e
non aIlro Ciacco fosse, er quaIi imrese mai chiederebbe d'essere
recalo aIIa ncnic a|irui (|nj. VI, 88-89)` Senza conlare che, a regare
Danle eIIegrino affinche rinfreschi Ia Ioro memoria lra i vivi, sono i
20 Iaccio arziaIe ammenda di come chiosai a riguardo, infIuenzalo daIIe nole lra-
dizionaIi, in Un nuctc Oanic. || rca|isnc icc|cgicc !c|||njcrnc, AlriaIda, II CaIamaio
1994, . 97. Iurlroo Ia eslraneila di Ciacco aIIa sfera ubbIica e regiudizio in
cui incorre Ia generaIila dei crilici. Cfr. da uIlimo Iernando SaIsano, Icciurac Oaniis,
Ravenna, Longo Idilore 2003, . 35: ci sarebbe decadimenlo deIIa verila oelica deI
ersonaggio Ciacco er disIiveIIo e sroorzione lra I'imorlanza deII'argomenlo e Ia
modeslia e I'eslraneila deII'informalore.
Mario Aversano 502
ConsigIieri iu di lulli. Ma oi non e arduo ammellere che senza un
fine segnaIelico Io nscgni, reso come uro addendo insieme aI
piu par|ar, cosliluirebbe una insiegabiIe eccezione aIIa regoIa deIIa
slringalezza che iI oela osserva semre neIIa Ccnnc!ia, conforme a
uno dei canoni rimari deIIa sua oelica, iI |rctc |cqui:
Id io a Iui: ancor vo' che mi nscgni,
e che di iu arIar mi facci dono.
Iarinala e 'I Tegghiaio, che fuor s degni,
Iacoo Ruslicucci, Arrigo e 'I Mosca,
e Ii aIlri che a |cn jar uoser Ii 'ngegni,
dimmi ove sono. .
(vv. 77 e sgg.)
Abbiamo gia solloIinealo Ia vaIenza che neI asso ha iI riferimenlo
aI ben fare. Ne ci e arso un caso che Ia seconda occorrenza deII'in-
segnare si risconlri er un aIlro satic, runello Lalini: nnscgnataic
ccnc |ucn sciicrna.
21
. Ma neIIa dimoslrazione deIIa voIonlariela di
quesli raccordi inlralesluaIi un dalo risoIulivo giunge daIIa disamina
deI lerzo imiego deII'insegnare neIIa Ccnnc!ia. Lo si cogIie co-
m'era revedibiIe lullo e manifeslamenle saIdalo aI ConsigIio e aI ja-
rc, e er un aIlro uomo di saienza, ingegno ed arle, Guido da Monle-
feIlro (|nj. XXVII, vv. 100-102):
I' oi mi disse: Tuo cuor non soselli,
finor l'assoIvo, e lu m'inscgna jarc
s come Ieneslrino in lerra gelli.
I qui si vede come Danle aulore, se ancora avessimo dubbi suII'e-
quivaIenza da Iui osla lra I'insegnare e iI consigIiare, Ia onga e-
sressamenle, e due voIle. Darima a v. 98 (non senza I'avviso che Ia
navigazione e neI miIilare), oi a v. 116. Divenla cos naluraIe disorsi
aII'accogIienza deII'enuncialo in aroIa: che I'insegnamenlo de-
cIinalo com'e aarso semre in accezione consiIiare riemerga ades-
so, neII'inconlro con SordeIIo, er Ia quarla voIla, che e Ia rima neI
21 NeII'eisodio, si rammenlera, iI |cn jar (|nj. XV, 64) che neIIa Ccnnc!ia come
neII'oera di SordeIIo e di runello (non escIusa Ia |ciicrica) allrae di regoIa, oIlre aI
consigIio, iI senno e I'amore deIIa giuslizia e dichiaralivo deII'cpcra di Danle neIIa
roria cilla, e deII'ingcgnc ricevulo daIIa sic||a e daI cic|c (vv. 55-60). I un lema volalo a
riemergere rorio in |ininc aII'inconlro con UIisse, uno dei rololii deI ConsigIio,
ancorche fraudoIenlo: e iu Io ngcgnc affreno ch'i' non sogIio, / erche non corra che
virlu noI guidi, / s che, se sic||a bona o migIior cosa / m'ha dalo 'I ben, ch'io slesso noI
m'invidi (|nj. XXVI, 21-24).
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 503
Purgaicric, non soIo a formare un araIIeIismo con I'imiego di ar-
lenza ch'e neI VI deII'|njcrnc, ma anche a connolare con recisione
I'inconlralo, in queI che fu aulore deII'|nscnnancn !cncr, cioe di un
oemello in cui egIi si fece insegnanle deI ben fare e d'un gaIaleo
corlese lullo fondalo suI saggio consigIio
22
.
5. Quanlo s'e finora accerlalo invogIia a una gIossa iu coerenle
deIIo a|icra e deI !is!cgncsa che seguono a v. 62. II rimo e lraducibiIe:
con viso non basso. Cio denola insieme dignila e vigiIanza aII'eslerno.
I una deIIe lanle voci |ipariiiac, cioe di duIice ed ooslo vaIore
(come iI !is!cgncsa con cui e unilo), sarse neI Ioema, queslo si evince
daII'aIlro (e uIlimo) imiego che I'A. ne fa, a Purg. XII, 70, dove ha con
cerlezza significalo in na|c: Or suerbile, e via coI viso a|icrc. A me
sembra evidenle che qui er SordeIIo deonga in |cnc: neI soIco, er
inlenderci, deI giuslo !is!cgnc di Par. XVI, 137. Ma esso incorora
anche I'ira, ch'e regio (I'ira |cna) o Iimile (I'ira na|a di Purg. XVII, 69)
dei consigIieri come dei rncii. Cos neI Tcscrciic deI Lalini: cui
I'ira da di igIio, / erde scnnc c ccnsig|ic (vv. 2681-2682). SordeIIo
ercio si fa accoslare a Marco Lombardo, che e enilenle d'ira, e re-
senza non meno grande aI cenlro deI Ioema: secondo enigma ancora
iu forle, a cui scioIlo queslo anche cercheremo di accoslarci.
Inlanlo e da convocare iI oela slesso (cfr. iI Marcc nic di Purg. XVI,
130), consigIiere in Iirenze, e Ia memoria lorna ai versi con cui VirgiIio
Io aoslrofa in Inferno, e si badi lra gIi Iracondi, a solloIineare iI
suo !riiic zc|c verso IiIio Argenli: 'AIma s!cgncsa.'! (|nj. VIII,
44). Iolremmo addurre, a rova, iI !is!cgncsc guslo di Iier de Ia
Vigna, consigIiere di Iederico II (|nj. XIII, 70), ma anche iI quasi s!c-
gncsc di Iarinala (|nj. X, 41), dove si inlravede iI raorlo deII'ira con
Ia suerbia, e insieme un eIemenlo di consenso aIIa definizione di
SordeIIo come iI Iarinala deI Iurgalorio: urche Ia si onga neI segno
deI consigIio. Non a caso aII'inconlro che Danle ersonaggio ha coI
nagnaninc ghibeIIino, lra gIi Iresiarchi, Danle aulore one (ed e cosa,
a mia scienza, non ancora emersa) ben lre riferimenli aI consigIio
23
.
DeI reslo, a chi guardi con allenzione aIIa Iingua con cui e coslruilo
queI canlo, non sfuggira Ia lemalizzazione che in esso fin daI rinciio
22 DeI reslo I'equazione insegnare-consigIiare e correnle neIIa lrallalislica medieva-
Ie deI buon governo. La si inconlra, ad esemio, in runello Lalini, e in un cailoIo che
lralla esressamenle Oc Ccnsig|icri: si uole assai bene inlendere che Ia rellorica di
TuIIio non e ure ad inscgnarc ialegiare aIIe corli di ragione |.j. Il bene e vero che IIo
nscgnancnic ch'e scrillo inn adielro are che ssia moIlo inlorno queIIe vicende che sono
in lencione.
23 Cfr. vv. 84, 87, 91-92.
Mario Aversano 504
I'A. fa deI arIare (che vi ricorre, con aroIa, cinque voIle), fin daI
rinciio. Sliamo avvicinando uno dei lemi Iunghi deIIa Ccnnc!ia:
basli qui dire che esso emerge, aII'insegna deI |rcti|cquiun (|nj. X, 39,
|nj. XIII, 93, Purg. XIII, 78, ecc.) o deII'arreslo brusco deIIa Iocuzione
(|nj. VI, 90, |nj. X, 120-121, |nj. XV, 119-121, Purg. XVI, 145, ecc.), lulle
Ie voIle che i ersonaggi sono in odore di ConsigIio, o in fama sicura
di laIe ufficio. InuliIe dire quanlo lornasse uliIe I'accorlezza deIIa
aroIa nei ConsigIi cilladini, nei quaIi era Ia somma deI olere
24
.
Cio consideralo, non e da escIudere che neI !is!cgncsa circoIi come
un'eco deI P|ann er Ia morle di ser Iacalz: oera in cui Ia tiiupcraiic
dei olenli deIIa lerra e falla con igIio fin lroo energico e Iibero. I
infine aare cilalo, a ben vedere, anche iI SordeIIo deII'|nscnnancn
!cncr, che con ogni robabiIila suggerisce arecchio deIIe Iinee di
slrullura nonche deIIe aroIe con cui I'A. narra I'inconlro in Inferno
con IiIio Argenli. L'abbraccio e Ia Iode di VirgiIio aI suo disceoIo
erche, a|na s!cgncsa, ha maIlrallalo I'iracondo giungono aI rimo
guslo inallesi, er non dire sroosilali. Le cose si chiariscono quando
ci si rifaccia aIIa siegazione che iI duca da deIIa condolla orgogIio-
sa che I'Argenli lenne da vivo (cfr. |nj. VIII, 46-47: 'Quei fu aI
mondo ersona crgcg|icsa: / |cnia non e che sua memoria fregi'), e
subilo doo a queI che SordeIIo dice deII'orgogIio
25
er qu'esser deu eIs bos fugilz
ergoiIIz, qu'es de lolz maIs razilz,
qu'ergoiIz non a mas conlra ergoiII
nuII Ioc, qu'aulres dregs non I'acoiII,
|.j
quar s'unas oms aulre desmesura
er orgoiII, non assa dreilura
Io desmesuralz, si.s n'ergoiIIa
ni fai lan que I'aulres s'en doiIIa.
(Quindi deve essere fuggilo dai buoni I'orgogIio, che e radice di
lulli i maIi: giacche I'orgogIio non lrova oslo ossia non si de-
ve convenienlemenle usare se non conlro I'orgogIio |.j.
Infalli se un uomo lralla maIe un aIlro er orgogIio, coIui che e
lrallalo maIe non offende Ia giuslizia se si inorgogIisce e fa lan-
lo che I'aIlro se ne doIga).
24 Cos GINO IAMIALONI, in |.O., s. v. 'ConsigIio deI cailano deI ooIo', II, Ro-
ma 1970, . 162. Cfr. AVIRSANO, Brunciic Iaiini s|rigaiitc? Maccnc, Agire, XXXII, 18
IugIio 2004, . 8.
25
XLIII, 1057-1066, ed. e lrad. oni.
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 505
Dunque non ha sbagIialo, aIIa Iuce di quesle senlenze, Danle er-
sonaggio ad oorre iI rorio orgogIio a queIIo deII'Argenli e oi a
fare in modo (dicendosi vago di vederIo aiiujjarc neI fango) che se ne
doIga (|nj. VIII, 52 sgg.): allo di giuslizia. I Danle aulore ha forse
accoIlo anche I'anlilesi lra Ia |cnia e I'orgogIio, che er SordeIIo esser
deu eIs |cs figilz
26
.
6. II lrallo iu inciso deIIa raffigurazione di SordeIIo, ad ogni mo-
do, e er comune senlire neI verso che ne scoIisce I'aarenza Ieoni-
na: a guisa !i |ccn quan!c si pcsa (v. 66). I danlisli non hanno mancalo di
censire I'incrocio con Gcn. XLIX, 9, dove a osare come un Ieone e
Giuda, secondo che dice suo adre Giacobbe: requiescens accubuisli
ul Ieo. Ma anche qui, come di regoIa neI Ioema, Ia concordanza coI
leslo sacro non e frullo di memoria inconsaevoIe, ne di uri inlenli
formaIi. Issa rienlra, invece, neI rogramma di oelica obbIigala
aIIa ibbia da cui nasce I'inlero fondamenlo slrulluraIe deIIa Ccnnc-
!ia. La rova deIIa voIonlariela deIIa cilazione e ricavabiIe, come aIlre
voIle, daIIa consuIlazione deI nc!iun che si eslende lra iI Ioema e Ia
Scrillura, cosliluilo daI commenlo che di essa fanno i Iadri e i leoIogi
medievaIi. Ier laIe via si conslala, eraIlro, che iI caIco bibIico svoIge
anche Ia funzione di esorre gIi obiellivi lemalici che I'A. vuoI rag-
giungere: I'omoIogia dei vocaboIi comorla anche queIIa dei lemi, a
cominciare da quesli versi fino aI lermine deI canlo. NeII'|xpcsiiic in
Gcncsin di san runo (che accogIie e lrasmelle, non sfugga, quanlo in
roosilo gIi giunge daIIa lradizione esegelica) iI rioso Ieonino di
Giuda e inlerrelalo, infalli, come olenza e voIonla di manlenere Ia
pacc e di cuslodire Ia |cggc:
Requievil ul Ieo, quia quamdiu |cgcn sibi dalam cuslodivil,
omnes eius quicicn ci paccn erlurbare, sibique beIIum movere
limebanl (PI CLXIV, 43).
SordeIIo da Goilo, dunque, coI suo osare un concello che in
Ccnt. IV, IV, 4 ha una doia esressione, e, si badi, enlrambe Ie voIle
in Iegame slrello coI molivo deIIa pacc (iI monarca deve lenere conlen-
li i regni s che pacc inlra Ioro sia, ne Ia quaIe si pcsinc Ie cilladi, e in
quesla pcsa Ie vicinanze s'amino) ci viene consegnalo come un nctc
Giuda, deI quaIe reIica a dislanza di secoIi Ia fisionomia elico-civiIe,
26 Non meno orienlanli sono gIi aIlri dali ricavabiIi daII'anaIisi dei versi che offrono
iI londo di SordeIIo. Ricorre qui er Ia rima voIla neIIa Ccnnc!ia, ad es., iI lermine
'accogIienze': anch'esso frequenle, e lemalico, neIIa oesia di SordeIIo (cfr. iI |cn acui|-
|cnz di XLIII, 191, o iI gcn acui||ir di XLIII, 576).
Mario Aversano 506
che si esrime con ari inlensila neII'cpcrari deII'uomo come deI oela.
Siamo finanche indolli a credere che daI asso deI Gcncsi discenda un
che deIIe movenze slesse con cui egIi si alleggia aI rimo inconlro coi
due eIIegrini, neIIo a|icra c !is!cgncsa, come neII'onesla e oi neIIa
genliIezza, sono riconoscibiIi i caralleri naluraIi deIIa !igniia e
deII'cncrc rcgic che I'erede di Giacobbe lrasmelle aI suo ooIo, cos
come S. runo Ii esIicila daI non auferelur scelrum de Iuda: !igni-
ias iancn ci ncncr rcgius, quasi qui!!an naiura|c ci nacrc!iiariun in nac
iri|u pcrnanc|ai (PI CLXIV, 43).
A queslo unlo si fa Iecilo, mi sembra, avanzare un giudizio
comIelamenle diverso suI rinciio che qui informa I'organizzazione
lesluaIe, e caovoIgere Ia senlenza che ancora circoIa in moIli com-
menli. Una voIla individualo, cioe, iI modeIIo sacro che I'A. ha reso
in riferimenlo, viene a chiarezza anche Io schema comosilivo da Iui
sceIlo. I cade ogni ragione di doIersi che I'invelliva Ianciala aII'islanle
conlro I'IlaIia serva e osleIIo di doIore, e quanl'aIlro essa lrascina,
arrivi senza reannunzi, cogIiendo iI noslro orecchio imrearalo.
L'invelliva (ma essa, a lener conlo deI modeIIo rinciaIe che I'A.
uliIizza, Geremia, e anche una |ancniaiic, anaIoga aI p|ann rovenzaIe,
iI genere in cui rienlra I'oera iu nola di SordeIIo, iI Ccnpianic in
ncric !i scr B|acaiz) giunge invece in erfella sinlonia coI osare e
coI surgere deI Goilese, e con Ia ronunzia ch'egIi fa deI rorio
nome. Quesl'anima cos ronla a fesleggiare iI concilladino VirgiIio,
in queIIa che e falla orlalrice degIi slessi vaIori deIIa ace e deIIa
giuslizia difesi daI re Giuda, fornisce er cos dire iI iedislaIIo da
cui uo scallare iI dissenso deII'aucicr con grido di sdegno e di
doIore. IgIi con remedilazione, dunque, melle di cozzo iI laIe
comorlamenlo deI Manlovano con queIIo dei vivi d'IlaIia. II rimo
e esemIare deIIa ace e deII'amor alrio, iI secondo deII'inimicizia
reciroca che genera uno slalo erenne di guerra: c! cra in ic ncn
siannc sanza gucrra / |i titi iuci. (vv. 82-83).
Non assi inosservalo iI fallo che I'A. aggiunge immedialamenle
erche non insorgano equivoci e Ia sua Iogica comosiliva divenga aI
lullo esIicila che neIIa geografia deIIa enisoIa non c'e iu aIcuna
arle che di pacc gode. SaIla in evidenza, aIIora, I'idea molrice
deII'inlera sequeIa di aoslrofi e di escIamazioni, che occua lulla Ia
seconda arle deI canlo: radicala neI Libro divino, queII'idea e falla
correre semre ad esso slrella neIIe ozioni di conlenulo come di
Iingua e di sliIe sui binari lemalici deII'ancrc, deIIa pacc e deIIa
giusiizia, in un Iegalo ollenulo medianle una successione di imma-
gini, concelli e vocaboIi che Ii richiamano senza fialo.
Quesla inlerrelazione guadagna aIlre conferme quando si rifaccia
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 507
iI lragillo iniraicsiua|c, e si rirenda iI icpcs crilico deI araIIeIismo
con i sesli canli deII'|njcrnc e deI Para!isc. Si olra faciImenle vedere,
adesso, come rorio suI lema deI governo e sui lasli doIorosi
deII'assenza di iela, di ace e di giuslizia Danle ersonaggio balla
con oslinazione aIIorche inlerroga Ciacco. La sequenza di |nj. VI, 58-87
non e affallo una digressione inserila non senza quaIche sforzo
neIIa lrama narraliva, che viene svoIla oi in forme iulloslo
schemaliche e aslralle, e che non riesce a divenlare, come accadra
in aIlri eisodi famosi, un eIemenlo vivo e necessario deIIa siluazione
oelica (cos e quanlo ingiuslamenle! Saegno neI suo Commen-
lo: ma con Iui lanli aIlri). Quei lrenla versi delerminano, aI conlrario,
uno dei iIaslri su cui oggia I'archilellura deIIa Ccnnc!ia, e forse lra
i rimi anche in ordine aIIa sua ideazione-comosizione. Le domande
rivoIle a Ciacco, iI cui ajjannc esa aI vialore fino aIIe Iacrime, ci
immellono neI vivo di una sloria doIorosamenle vissula: riguardano
e I'una doo I'aIlra iI assalo oIilico non Ionlano di Iirenze, dai
lemi di Iarinala fino a queIIi deI Mosca, ma innanzilullo iI resenle
che n'e scorso: Ia ciiia pariiia, assaIila da Oisccr!ia, rivala deIIa soIida-
riela reciroca e deIIa ace, e Io slalo di ingiuslizia e di iIIegaIila in cui
versa (|nj. VI, 61-63). Cos ci orienliamo a credere che I'uno dei !uc che
ncn ti scnc inicsi (|nj. VI, 73) sia Danle oralore nei ConsigIi cilladini,
che, come dovrebbe ogni eIello a quesla carica, ama Ia giuslizia e Ia
ace: in anlagonismo ubbIico (non e in segrelo o in rivalo, infalli,
che i giusli vogIiono essere inlesi), con i suoi avversari oIilici,
che, come i liranni di Romagna e i Ioro ConsigIieri (|nj. XXVII, 37-39),
hanno in cuore semre Ia guerra. DeI reslo e accIaralo che I'eIezione di
Danle a riore diese daIIa fiducia che si rioneva in Iui: venulo in
fama di aIadino deIIa Iiberla di Iirenze aII'eslerno, e deIIa concordia
aI suo inlerno, gIi locco emellere un rovvedimenlo di confino er i
cai iu accesi deII'una e deII'aIlra arle, amici incIusi. Nessuna
meravigIia, dunque, che Ia slessa lemalica si risconlra neI VI deI Para-
!isc con I'cxcursus di Giusliniano (non a caso nominalo rorio in
queslo canlo deI Purgaicric, a v. 89)
27
.
27 La menzione di Coslanlino e deI suo cedere Roma a SiIveslro II (Ioscia che
Coslanlin I'aquiIa voIse...) dichiara di coIo Ia divisione: rorio come i sesli canli
deIIe rime due Canliche, che hanno aI verso iniziaIe I'uno iI rilorno deIIa menle
doo Ia arlenza-searazione daI coro, I'aIlro Ia arlenza deI gioco deIIa zara. Dei
fiIi che inlercorrono lra quesli canli deIIa Ccnnc!ia, iI iu robuslo viene a risuIlare,
ercio, queIIo che Iega Ie figure di Ciacco, SordeIIo e Romeo di ViIIanova (in quanlo
riaffermiamoIo lulli e lre cIassificabiIi come uomini di corle e di consigIio), ed essi coI
oela, in queI che fu consigIiere in Iirenze, e con runello Lalini, che in queslo ruoIo Io
recedelle e gIi fece da insegnanle (|nj. XV, 85): se non anche, vedremo, con VirgiIio.
Da aggiungere che Ie carle sloriche documenlano indisculibiImenle Ia coIIeganza
Mario Aversano 508
A comiere iI giro dei significali che iI aragone con Giuda veicoIa
si nolera che I'emislichio a guisa !i |ccn sembra ricaIcare I'a| scn||an !c
|ccn con cui SordeIIo oela chiude, in roverbio che da deI conigIio, iI
secondo sirvenlese conlro Ieire remon Ricas Novas: 'Cor de coniI a|
scn||an !c |ccn (XXIV, 48). L'iolesi lrova esca, oIlre che neIIa laccia
conlinua di viIla-infedeIla che egIi muove aII'avversario, neI rilorno in
Danle deII'immagine deI Ieone come simboIo di coraggio e di IeaIla
(e non di infernaIila, come ad aIcuni e arso, er via deI |ccnc di |nj. I,
45-48) anche neII'eisodio di Guido da MonlefeIlro, e dunque nuova-
menle in lema di consigIio: I'oere mie / non furon |ccninc, ma di
voIe (|nj. XXVII, 74-75). I non a lorlo s'e ensalo, in roosilo
28
, aIIa
diendenza da un Iuogo di eIlram daI ornio.
7. Anche iI asso in cui SordeIIo esce di siIenzio ha ieghe e rughe
indirizzanli: na !i ncsirc pacsc c !c |a tiia / cincnicsc (vv. 70-7). Dei due
viaggialori che avanzano, a Iui inleressa Ia rovenienza, non I'idenlila:
che sara chiesla doo (Purg. VII, 3), e, arrebbe, un oco con Io sirilo
slesso di Calone. II 'Chi siele voi, che.`' di Purg. I, 40 va inleso
neI senso di Chi ensale di essere voi, che. Lo rova queslo:
aII'Ulicense VirgiIio lace iI nome suo e di Danle, e aI comalriola sveIa
Ia roria idenlila in quanlo quegIi ha dello |c scn Scr!c||c, e uguaI-
menle evila di ronunziare iI nome deI suo disceoIo
29
. Si uo
slrella, neI ruoIo di ConsigIiere, di SordeIIo con Romeo di ViIIanova. Non e vero ercio
queI che iu voIle si dice, che qui I'A., non avendo iu da insinuare come ha fallo
roonendosi er bocca di Ciacco lra i due giusii non ascoIlali che Iirenze olrebbe
lrovare ace affidandosi aIIa sua saticzza di ConsigIiere, si renda ercio Iibero di de-
nunziare i maIi che affIiggono I'umanila. Ora Danle (aulore, non ersonaggio) si
roiella con Ia seranza neI ConsigIio d'una corle ch'e Ia iu grande, queIIa deI roma-
no rincie, dove si gioca iI deslino di lulli i ooIi.
28 Cfr. ILIZAITH SCHULZI-USACKIR, Scr!c||c, pccic !i!aciiquc, Alli deI Convegno
InlernazionaIe di Sludi su SordeIIo da Goilo, Goilo-Manlova 1997, CuIlura NeoIali-
na, LX, 2000, fasc. 1-2, . 204.
29 L'accoslamenlo aII'Ulicense, d'aIlra arle, sembra lrarre conforlo anche daIIa re-
cenle indicazione d'un SordeIIo Iegalo aIIa lradilion gnomique el aremioIogique, che
conosce ed imila i medievaIi Oisiicna Caicnis (cfr. SCHULZI-USACKIR, Scr!c||c, cil., .
191 e assim), oera, aggiungiamo noi, nola anche a Danle. AccogIibiIe ure I'iolesi
concIusiva che iI oela raggiunga neIIe sue uIlime cose Io sladio d'una refIexion since-
re el de loule evidence aussi ersonneIIe sur Ie concel de I'onor el du slalul moraI de
I'honnele homme en ce miIieu du XIIIe siecIe, e che cos un semIice regislro relorico
in SordeIIo divenga signe d'un rocessus inleIIeclueI qui me sembIe avoir imres-
sionne a |usle lilre Ies inleIIeclueIs el Ies Iilleraires des generalions a venir, sourloul en
IlaIie (ivi, . 205). I qui iI nome di Danle e, bisogna credere, iI rimo da sollinlendere,
anche se I'Aulrice disavverle iI asso Iogico, e non cronoIogico, che carle aIIa mano iI
SordeIIo danlesco comie: daII'uomo oneslo (e, aggiungiamo, amoroso) aI savio
ConsigIiere di corle.
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 509
concIudere che, a differenza degIi sirili pcr jcrza ncrii da oco Iascia-
li, i quaIi badano a se e aIIe risellive famigIie, SordeIIo ami iulloslo
saere deI mondo: aI modo degIi aIlri ConsigIieri deI Ioema, che, lulli
inleressali aIIa soravvivenza deIIa Ioro fama o aIIo slalo dei aesi (di
ace o di guerra), allraggono I'allenzione deI venulo daIIa lerra (Ciac-
co, Iarinala, runello Lalini), o addirillura Io rincorrono lemendo di
non raggiungerIo (i lre Iiorenlini, Guido da MonlefeIlro), e che cos
I'A. annunzi un ersonaggio decisamenle volalo aI ubbIico. Id e
siegazione che uo far coro con Ie aIlre sora avanzale: che con
I'inchiedere vogIia accerlarsi se coIoro che gIi sono venuli inconlro
siano degni di accedere aIIa vaIIella dei Irincii, e se coIui che arIa
sia di Manlova.
II fare dislaccalo che SordeIIo moslra darinciio viene a dissoI-
versi er effello di un'unica aroIa, Maniua:
|.j e 'I doIce duca incominciava:
Manlua. , e I'ombra lulla in se romila
surse ver' Iui deI Ioco ove ria slava
dicendo: O Manloano.
(Purg. VI, 72 sgg.)
II divario cos nello fra Io slalo di rioso e iI ronlo Ievarsi e forse
suggerilo oIlre che daIIa ragione eslelica daI quis suscilabil eum
di Gcn. XLIX, 9 sgg., cil.
30
. Ma uo enlrarci anche deII'aIlro: Ia saggez-
za deI ConsigIiere. Viene a menle iI sinlagma che ricorre er VirgiIio a
Purg. XIII, 75: ccnsig|ic saggic
31
. Id egIi, rima di rilirarsi daIIa ribaIla,
secifica iI rorio comilo in queI che ha condollo iI disceoIo ccn
ingcgnc c ccn aric (Purg. XXVII, 130), vaIe a dire con Ie quaIila di cui ha
bisogno coIui che consigIia. Ne osla Ia cIassifica di oela che di Iui
s'inconlra a |nj. I, 73: Danle conceisce I'ufficio deIIa grande oesia
semre in lermini oeralivi, elici e civiIi. La Iega, infalli, subilo aIIa
giuslizia ('Ioela fui, e canlai di queI giusic / figIiuoI d'Anchise.), e
rima di ribadire che VirgiIio fu pccia, e dei sommi, riliene uliIe
siegare iI vocaboIo. Isso e cerlo, come oi dira, iI nome che iu
dura e iu onora (Purg. XXI, 85), ma non neI senso che definisce un
ruoIo conlenibiIe nei Iimili eslelici. I imIicalo, invece, iI arIare,
30 San runo dice che iI Ieone a voce arenlis a somno excilalur, e che Giuda spi-
riiua|iicr va inleso come Crislo, risuscilalo daI Iadre (PI CLXIV, 43-44). VirgiIio, che coI
soIo Maniua induce SordeIIo a surgcrc, ben regge Ia slregua di adre suo: alernila
anch'essa siriluaIe, fondala suIIa rovenienza daIIo slesso Iuogo e suIIa comunanza
deIIa Iingua, successivamenle evocala a gIoria deI Manlovano (Purg. VII, 16 sgg.).
31 NeIIa |cciura deI canlo XIII deI Purgaicric sora cil.
Mario Aversano 510
e cioe I'eIoquenza:
Or se' lu queI VirgiIio, e queIIa fonle,
che sandi di par|ar s Iargo fiume`
|.j
O de Ii aIlri pccii onore e Iume...
(|nj. I, 79 sgg.)
Taslo che oi I'A. significalivamenle rilocca a |nj. II, 67 (Or movi,
e con Ia lua parc|a crnaia.) e a |nj. II, 113-114: .fidandomi deI
luo par|arc oneslo, / che onora le e quei ch'udilo I'hanno.). Sono
versi maI receibiIi quando non Ii si raorli aI concello medievaIe
deIIa relorica
32
. Ne va lrascuralo quanlo runello Lalini neIIa sua
|ciicrica scrive deII'eIoquenza, facendoIa consislere neI saer arIa-
re, e semre IegandoIa aIIa saienza e aIIa giuslizia, e ercio aI
consigIio, aII'insegnamenlo, aI |cn jarc e a ideaIi di ace, di amore
e di concordia lra gIi uomini e Ie cilla:
Iurono Ii uomini raunali el inscgnaii di |cn jarc e !anarsi insicnc
(si ricordi iI |a gcnic quanic sana di Purg. VI, 115), e ero fecero
cilladi e viIIe, e oi che Ie cilladi furono falle imresero ad
avere fede |.j. S come dello dinanzi TuIIio medesimo dice in
un aIlro Iibro !c||i cjjici che fede e fondamenlo di giusiizia,
verilale in par|arc e fermezza deIIe romesse |.j. I cos somma-
lamenle Ioda TuIIio c|cqucnzia con sapicnzia congiunla
33
.
Si onga ora allenzione, er iI nesso lra iI arIare e iI consigIio, a
queI che runello scrive aeIIandosi aII'aulorila di Villorino:
Onde dice Villorino: Se noi voIemo mellere avacciamenle in
oera aIcuna cosa neIIe cilladi, s ne conviene avere saienzia
giunla con eIoquenzia, ero che saienzia semre e larda.
Il queslo aare manifeslamenle in aIcuno savio che non sia
32 asli andare, er un es., a queIIo che Guidollo da oIogna dice di VirgiIio neI
roemio deI |icrc !i |ciicrica, dedicalo aI re Manfredi: I come conlaremo er Io 'nanzi
neI versificalo che fece iI grande pccia VergiIio |.j. II quaIe VergiIio si lrasse lullo Io
'nlendimenlo de Ia rciicrica, e iu ne fece chiara rimoslranza, sicche er Iui ossiamo
dire che I'abbiamo (rilrovala), e conoscere Ia via de Ia ragione e Ia elimoIogia deII'arle di
rellorica, in ercio che lrasse iI gran fascio in iccoIo viIume erecoIIo in abreviamenlo
(cfr. Ia prcsa !c| Oucccnic cil., . 104). Guidollo oi dedica un inlero iraiiaic, iI quarlo,
er dar dollrina suI ccnsig|iarc, ancorandoIo saIdamenle aII'elica, oiche ne indica Ia
base neIIa !riiia ragicnc e neIIa caacila di conoscere iI bene daI maIe (ivi, . 128).
33 Id. Maggini, cil., . 26.
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 511
arIalore, daI quaIe se noi domandassimo uno consigIio cerlo
noIIo darebbe loslo cose come se fosse bene arIanle
34
.
I si veda iu ancora queslo Iuogo successivo:
Or dice Io sonilore che IIa citi|c scienza, cioe Ia covernalrice
deIIe cilladi, Ia quaIe ee in !ciii si divide in due: che II'una e co
IIile e I'aIlra sanza Iile. |.j queIIa ch'e sanza Iile si fa doman-
dando e risondendo, ma non er Iile, ma er dare aIIa genle
inscgnancnic e via di |cn jarc, s come sono i delli de' pccii che
anno messo inn iscrilla I'anliche slorie, Ie grandi ballagIie e
I'aIlre vicende che muovono Ii animi a |cn jarc
35
.
Ma infine e deIIa iu nella indicalivila iI brevissimo caeIIo
aII'oera:
quando io considero Ii dannaggii deI noslro Comune, e raccoIgo
neII'animo I'anliche aversiladi deIIe grandissime cilladi, veggio
che non iccioIa arle di danni v'e messa er uomini moIlo ar-
Ianli sanza saienza
36
.
Iar di comrendere megIio adesso I'affermazione di dienden-
za da VirgiIio er iI |c||c sii|c quaI e in |nj. I, 87. Quesla beIIezza,
imIicala coI par|ar di v. 80 e con Ia parc|a crnaia e iI par|arc cncsic di
|nj. II, 67 e 113, ha cerlo a che fare con Ia |ciicrica, e ercio imIica
I'insegnare e iI consigIiare: dunque lulla I'cpcra deI oela leso a
|cn jar in Iirenze, oera d'inchioslro ma anche di aroIa non scrilla,
rofusa neIIe adunanze dei ConsigIi cilladini. I in lermini eIoquenzia-
Ii siamo lenlali di inlerrelare finanche Ia conlraosizione deI
romano (se non rorio ciceroniano) MarceIIo aI viIIan che arleg-
giando viene (Purg. VI, 125-126), sia er I'incIusione neI conleslo deI
34 Ivi, . 15.
35 Ivi, . 49. I cerlo runello er quesla funzione dei oeli che eslrae daI modeIIo
ciceroniano non uo non avere in menle rima e iu degIi aIlri I'oera di VirgiIio, se-
gnalamenle I'|nci!c (iu voIle cilala ad esemio di erfella relorica), ma anche Ie
Gccrgicnc, come risuIla da quesla regoIa che egIi ne cava: Quando Ia noslra causa eIIa e
viIe, cioe di iccoIo convenenle sicche I'udilore oco cura d'inlendere, aIIora ne convie-
ne usare rinciio el in esso fare che II'udilore sia inlenlo a Ie noslre aroIe, e queslo
olemo ben fare lraendoIa di viIlanza e facciendoIa grande el innaIzandoIa, s come fece
VirgiIio voIendo lrallare de I'ai: 'io dicero cose moIlo meravigIiose e grandi deIIe ic-
cioIe ai'.
36 Ivi, . 3.
Mario Aversano 512
lermine iiranni, che, come a |nj. XXVII, 38
37
, imIica ipsc jacic iI Consi-
gIio, sia erche iI arleggiare non uo non avvaIersi deIIa aroIa:
come anche Ia icncicnc Iunga di |nj. VI, 65 (Ia slessa deI Iuogo di ru-
nello sui ConsigIieri sora cilalo), che avra I'eiIogo neIIa venula aI
sanguc. II lermine ti||an qui ha aIesemenle Io slesso vaIore disregia-
livo che in Par. XVI, 56 (Io uzzo / deI ti||an d'AgugIione), e uguaIe
riferimenlo aIIa gcns ncta di cui a |nj. XVI, 73 e sgg.:
La genle nuova e i subili guadagni
orgogIio e dismisura han generala,
Iiorenza, in le, s che lu gia len iagni.
Ier quesli uIlimi versi Danle fruisce a me sembra deI asso
deII'|nscnnancn che ha gia guardalo er I'orgogIio di IiIio Argenli,
e ne cava non soIo Ia coia orgogIio-dismisura, ma anche iI ianlo
e Ia giuslizia:
quar s'uns oms aulre !csncsura
er crgci||, non assa !rciiura
Io desmesuralz, si.s n'ergoiIIa
ni fai lan que I'aulres s'en !ci||a
38
.
Ne e di remora iI significalo non deleriore che ti||an rivesle a |nj.
XXVI, 25: figura oosila di UIisse (com'e SordeIIo), in queI che aIIa
fine deIIa giornala Iavoraliva (che raffigura I'esislenza lerrena) lorna e
si ripcsa neIIa roria casa, embIemalica di queIIa deI Iadre, Iaddove iI
consigIiere fraudoIenlo di Ilaca scegIie, invece, di morire Ionlano daI
Iuogo nalio, non dimoslrando aIcuna carila di alria
39
.
8. Quando I'ombra lulla in se romila si Ieva e dice iI rorio nome,
ic scn Scr!c||c (v. 74), e come si dovesse gia avere conlezza di Iui
40
. II
Goilese e cIassificabiIe a lull'oggi aena come oela in Iingua
rovenzaIe. I quesla Ia ragione er cui moIlo ancora si diballe suI
erche assurga a grado aIlo neIIa Ccnnc!ia, con un comilo di
lanlo riIievo, anche se lemoraneo, quaIe e queIIo di guida dei due
37 Cfr. AVIRSANO, Oanic crisiianc. Ia sc|ta, |ranccsca, U|issc c |a siruiiura
!c|||njcrnc, Roma, II CaIamaio 1994, . 99-100. AII'idenlificazione deI Marcc| danle-
sco con queIIo deIIa Prc Marcc||c invogIiano da una arle iI Marcc||usquc |cquax di
Lucano (Pnars. I, 313), daII'aIlra iI giudizio che Cicerone ne da di suo emuIo e imilalore,
e che ha seguilo neIIa |ciicrica di runello (cil., . 191).
38 XLIII, 1063-1066.
39 Cfr. AVIRSANO, Oanic crisiianc, cil., . 97 sgg. e passin.
40 Cos oi VirgiIio a Purg. VII, 7: |c scn Virgi|ic.
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 513
eIIegrini er un lrallo non secondario deII'ascesa enilenziaIe.
L'ozione, rieiIogando, si giuslifica er Ia china deIIa Iellura slorico-
fiIoIogica che Danle aulore effellua deIIa sua ersonaIila, alleggiando-
Io come: 1) uomo d'animo nobiIe, ronlo ad assecondare i moli
affelluosi non er mero lrasorlo imuIsivo, ma er rello e franco
senlire civiIe, 2) ersona aiiita (e non gia inlrodulliva, coI suo osa-
re, deIIa negIigenza che i Irincii sconlano neIIa |acca remola), che
conce Ia vila come sesa dei laIenli ricevuli, conlro ogni induIgere
aIIa igrizia e aI disimegno, 3) oela voIlo, in ognuno dei generi in
cui scrisse (i nagna|ia deII'amore, deIIe armi e deIIa relliludine), aIIa
roaganda coraggiosa deII'cpcra inlesa a difendere gIi ideaIi deIIa
genliIezza, deIIa magnanimila, deII'onore, deIIa giuslizia e deIIa ace,
4) ma sorallullo uomo di corle, come e dello dai rimi commenlalori
(Lana, Ollimo, envenulo, ecc.), neI ruoIo di consigIiere savio e giuslo,
che si rodigo er Ia reaIizzazione di quei vaIori in ogni consesso a cui
fu chiamalo. Iiu d'un documenlo d'archivio, infalli, leslimonia di
SordeIIo come di corligiano caace e disinleressalo. I un rofiIo che
s'inconlra con iI modeIIo che di queslo ruoIo Danle eslrae daIIa ibbia,
iI medesimo che egIi slesso liene a imersonare, come e deducibiIe
daIIa inserzione accanlo aI gran!c Assucrc, neI XVII deI Purgaicric (e
dunque aI cenlro di lullo iI Ioema) deI giusic Mar!cccc e deI erfido
Aman, rololii risellivamenle deI buono e deI callivo ConsigIiere
41
.
Ogni voIla, infalli, SordeIIo n'esce in fama di: a) nemico dei arlicoIa-
rismi e deIIe Iolle lra vicini, e faulore di un'aucicriias degna di risello
(carla deI 19 novembre 1251, in cui e arovala I'energica e decisa
azione oIilica di CarIo d'Angio conlro cilla e baroni ribeIIi), b)
consigIiere e medialore reoccualo deIIa conservazione deIIa ace
(lrallalo deI 27 IugIio 1252 er Ia conlroversia lra CarIo d'Angio e i
MarsigIiesi), c) difensore deII'aulonomia deIIe cilla conlro i ericoIi
deIIa lirannia (arbilralo deI 23 dicembre 1255, lra i MarsigIiesi e arraI
de aus, che rinunzia ad ogni relesa di assoggellare MarsigIia). An-
che iu ricco e iI calaIogo degIi alli reIalivi aI suo oeralo recedenle,
in Irovenza. Se ne deducono cose moIlo chiarificalrici: che SordeIIo
fu, come Romeo di ViIIanova, famiIiare deI conle di Irovenza, |ancn-
!c Bcringnicrc (Par. VI, 134), gia daI 1233 e fino aI 1245, che neIIa slessa
corle serv iI successore di Raimondo, CarIo I d'Angio, che enlrambi
41 Cfr. AVIRSANO, Oanic crisiianc, cil., . 98-100. Cfr. anche AVIRSANO, Ia quinia
rucia. Siu!i su||a Ccnnc!ia, Torino, Tirrenia Slamalori 1988, . 22: neI Ii|rc !i |sicr iI
re Assuero, 'nimio furore accensus', nuIIa decide e nuIIa one in oera senza aver
reso consigIio dai minislri. Danle lrovava neIIa ibbia iI gaIaleo er iI rincie e er Ia
corle: 'Inlerrogavil saienles, qui ex more regio semer ei aderanl, el iIIorum faciebal
cuncla ccnsi|ic' (I, 12-13).
Mario Aversano 514
furono uliIizzali come consigIieri o come suoi coIIaboralori o suoi
deIegali neI disbrigo degIi affari concernenli Ia vila oIilico-ammini-
slraliva deIIa conlea
42
. Nei documenli cilali daI oni iu voIle Ie fir-
me di Romeo e di SordeIIo risuIlano I'una sollo I'aIlra, in accordi inlesi
a dirimere queslioni e a conciIiare i Iiliganli
43
. I che SordeIIo avesse
fama di consigIiere ascoIlalo si aura anche da fonle indirella: iI lro-
valore Iocassel, neI sirvenlese Oc gucrra sui !czircs, Io rega di
dissuadere Raimondo eringhieri daI concIudere Ia ace coI conle di
ToIosa
44
.
9. II ercorso esIicalivo fin qui lenulo in ordine aI cosiddello
enigma di SordeIIo uo giovarsi d'un uIlimo argomenlo di soslegno
aIIa lesi che riviIegia Ia sua fisionomia di ConsigIiere savio e giuslo,
neIIa quaIe convengono e rifuIgono lulli gIi aIlri merili e regi che egIi
ole avere. Danle, che neIIa Ccnnc!ia s'e moslralo da rova di
conoscere I'|nscnnancn !cncr, oema che generaImenle assa er
didascaIico, non ha olulo non accorgersi che esso cosliluisce in reaIla
un vero e rorio gaIaleo deI ConsigIiere di corle, Ia cui dole rimaria
e individuala neIIa saggezza: iI senno (scn, scnn, scnz). Quesla aroIa,
messa er quallro voIle neI roIogo deII'oera (vv. 1-36), Ia soIca lulla
42 Cfr. ONI, Scr!c||c, oIogna, Ialron Id. 1970, . XXXVII.
43 Ivi, . XXXVI-XLII.
44 Circa I'idea che deI P|ann Danle ole farsi, Ia concordanza deIIa lemalica e deIIo
sirilo anlicuriaIi e aImare, come deI coraggio e deII'indiendenza neI giudizio
suII'oeralo dei rncii, e s'e ure fallo caso che, come SordeIIo, Danle Iimila Ie nomi-
nazioni aI numero di ollo. Ma bisogna aggiungere che egIi inlende bene e anche da
quesla visuaIe non uo dirsi imrovviso o incongruo lullo quanlo I'abbraccio con Virgi-
Iio scalena da quaIe arle SordeIIo ebbe a schierarsi: queIIa deII'Imeralore e deIIa sua
sovranila su ogni aIlra pcicsias lerrena. IgIi dice di Iederico II che e iI rimo a dover
cibarsi deI cuore di Iacalz, e Io riconosce emeraire de Roma, Iamenlando che viu
deserelalz, maIgral de sos Ties (II, 10-11). II lermine !iscrc!aic, evidenlemenle, signifi-
chera rivalo d'ogni regio e deI liloIo effellivo di Cesare, e cos deI alrimonio di
Roma di cui I'Imeralore e erede. D'aIlronde I'esercizio dei dirilli regaIi che a ogni inve-
slilo di governo locca, a saIvaguardia deI rorio onore, e lema che SordeIIo svoIge
anche aIlre voIle. NeI nolo sirvenlese dei lres !cscrc!ais, ad es., egIi non leme di dare
deI sa|tagic aI conle di ToIosa che si Iascia sogIiare di aIcune sue lerre (XX, 28). Queslo
molivo deI buon dirillo e deI buon nome, cos vivo in SordeIIo ma diffuso anche in aIlri
aulori rovenzaIi e neII'anlica Iirica voIgare ilaIiana (ADOLIO GASIARY, Ia scuc|a pcciica
sici|iana, Livorno 1882, . 101 sgg.), cosliluisce uno dei fuIcri deIIe ramogne e dei
sarcasmi conlenuli neIIa seconda arle deI VI deI Purgaicric. I si nolera come A||cric
ic!cscc venga aoslrofalo er dirella non una, ma quallro voIle (vv. 97-117), e aIIa fine
rorio con I'invilo a riacquislare iI senso deIIa vergogna: iu che Ia slessa Iirenze, a cui
sono riservale Ie ramogne finaIi. Ier noi anche neI tcrgcgnar di v. 117, con cui e riIan-
cialo un lema gia esoslo neI tcrgcgna di v. 90, si senle un che deI concello che SordeIIo
oela esresse in un Iuogo deII'|nscnnancn: si fa lranquiIIamenle iI maIe erche manca-
no i rimroveri che ce ne fanno vergognare (vv. 1001 sgg.).
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 515
con una Iisla densa e conlinua di imieghi. SordeIIo Ia aggrega aIIa
!rciiura (Ia danlesca !riiiura), iI senlimenlo deI giuslo, e ne chiarisce Ia
doia accezione: senno naluraIe e senno acquisilo con I'imarare. A
suo giudizio iI senno rende migIiore iI saere, e iI saere fa megIio va-
Iere iI senno: .I senz meIIura .I saber, / e .I sabers fa.I sen meIz vaIer
45
.
Ma oi non larda a isliluire I'equazione scnnc-ccnsig|ic, e iI nesso con-
sequenziaIe coI |c jar (iI ben fare dei voIumi di relorica da Cicerone a
Danle), sorallullo da v. 783 in oi:
De doas res I'una obs auria
a lol om, qui |c jar voIria:
que eI agues bon scn ades,
o que son bon ccnsci|| crezes.
|.j que.I Ius savis deu a sazo
creire son conseiII cerl e bo,
quar es soven er foI voIer
deslregz, qui.I loI sen e saber,
e, quar non son sei conseiIIer
deslreg d'aqueI voIer Ieugier,
Io conseiIIon saviamen,
don fai son falz adrezamen.
(Una di quesle due cose sarebbe necessaria a ogni uomo che
voIesse agir bene: avere semre buon senno, oure credere
aI buon consigIio |.j. Anche iI iu saggio ha bisogno
aII'occasione di un buono e sicuro consigIio, erche e sovenle
dominalo da un foIIe desiderio, che gIi logIie senno e saggezza,
menlre i suoi consigIieri daI momenlo che non sono dominali
da queI desiderio sconsideralo Io consigIiano saviamenle, s che
egIi fa rellamenle cio che vuoI fare)
46
.
I iu che robabiIe, aIIora, che Ia sarcaslica ascrizione, in queslo
canlo (aI v. 69), deI scnnc a Iirenze, e con riferimenlo rorio aI ccnu-
nc incarcc e aI consigIio, sia di queIIe reordinale. II lermine riIancia iI
molivo deIIa sloIlezza dei viIIani che vanno a caccia di onori e ric-
chezze. Iorse e I'inic||ccius di Bar. III, 14, da cui iI tc!i |unc di v. 148.
Ma va coIlo anche neIIa forza con cui Ie lre voci, ricca, pacc e scnnc,
slamano iI verso, e secie neII'uIlima, che richiama iI ccnsig|ic di v.
131 Io sconforlo che I'cxu| inncriius esrime er I'inimicizia con cui
45 XLIII, 477-478, ed. oni, cil.
46 Id. e lrad. oni, cil.
Mario Aversano 516
Iirenze ha risoslo aI suo |cn jar (|nj. XV, 64) di ConsigIiere
47
.
Si siega in laI modo erche iI rimo imiego di scnnc neIIa Ccnnc!ia
locchi con decisione iI oela er Ia sua oera recedenle: s ch'io fui
seslo lra colanlo scnnc (|nj. IV, 102), e erche a |nj. XVI, 39, in bocca a
Iacoo Ruslicucci e er Ia condolla di Guido Guerra (ConsigIieri I'uno
e I'aIlro) iI vocaboIo evochi iI iano deI jarc, deIIa oIilica dislinla e
insieme armonizzala con I'azione miIilare: fece coI scnnc assai e con
Ia sada. Anche di iu va rimarcalo, oi, iI fallo che a Purg. XXII, 23
iI scnnc e ccianic anche er Slazio (allivo, si ricordi, sollo iI |ucn
Tilo, come VirgiIio sollo iI |ucnc Auguslo: bonla imarenlale aI
|cn jarc, ed equivaIenli dicevamo a voIonla di giuslizia e di acifi-
cazione), e che a Par. XIII, 95 I'A. Io riroonga, er Ia saienza di
SaIomone, come essenziaIe a garanlire iI buon governo: chiese
scnnc / a cio che re sufficienle fosse. Ma senno, saienza e consigIio
imIicano aIlres I'arle deIIa aroIa, Ia relorica. I lra i merili che Danle
riconosce a SordeIIo rima ancora di farne un ersonaggio di sicco
neIIa Ccnnc!ia e queIIo indicalo in Oc tu|g. c|. I, XV, 2, di ersona eIo-
quenlissima: ianius c|cqucniiac tir cxisicns, ncn sc|un in pccian!c, sc!
qucnc!ccunquc |cqucn!c pairiun tu|garc !cscruii.
A SordeIIo e allribuila dunque con cerlezza come che si vogIia
inlendere I'abbandono deI alrio voIgare e iI qucnc!ccunquc
|cqucn!c: che uo senza difficoIla aIIudere anche a discorsi e arringhe,
oIlre che a comosizioni auIiche (ZingareIIi) Ia conoscenza magislra-
Ie deII'arle deI dire e deI dillare, I'c|cqucniia, Ia slessa di cui runello
Lalini arIa neIIa sua |ciicrica, addilandoIa come slrumenlo indisen-
sabiIe er iI buon successo e iI buon governo.
10. Che aIlro dire, ervenula qui I'indagine` Si consideri iI sanza
gucrra di v. 82. Ier inlendere Ia regnanza deI sinlagma e Ia sua fun-
zione dichiaraliva conviene imboccare ancora una voIla Ia slrada che
riIeva Ie concordanze inlralesluaIi. Issa conduce, non a caso, lra i
47 Si ricordi, deIIa sua miIilanza nei ubbIici uffici in Iirenze, che: a) fu membro deI
Ccnsig|ic spccia|c !c| capiianc !c| pcpc|c daI novembre 1295 aII'ariIe 1296, b) neI dicembre
deI 1295 fu lra i savi consuIlali er I'eIezione dei riori, c) iu voIle aarlenne aI Ccnsi-
g|ic !ci Ccnic cui loccava deIiberare Ie sese, e quindi Ie direllive fondamenlaIi deIIa
oIilica deI Comune: sicuramenle daI maggio aI sellembre deI 1996 e deI 1301, d) neI
1300 fu dei Iriori (cioe di queIIi che eIeggevano i membri dei vari ConsigIi), e ambascia-
lore a S. Gimignano. I non meno resligiosa fu Ia sua oera di consigIiere doo Ia
arlila da Iirenze. Lo rova gia Ia sua rima Iellera, che ne evidenzia iI rimalo inleI-
IelluaIe fra i comonenli Ia comagnia maIvagia e scemia, i fuoruscili ianchi: con Ia
dichiarazione di ogni obbedienza a NiccoIo da Iralo (iI paciarc invialo in Toscana da
enedello XI), in nome dei vaIori massimi che egIi inseguiva, queIIi deIIa ace e deIIa
giuslizia.
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 517
ConsigIieri fraudoIenli unili neII'ollava boIgia, e in un conleslo dove
iI ersonaggio inconlralo, Guido da MonlefeIlro, ha brama di avere
nolizie soIo e subilo come qui SordeIIo (vv. 70-71) di un aese e
deIIa sua tiia, e dove Danle eIIegrino cos informa:
Romagna lua non e, e non fu mai,
sanza gucrra ne' cuor de' suoi liranni....
(|nj. XXVII, 37-38)
Sono gIi slessi iiranni, con evidenza, di cui ci vien dello che Ie cilla
d'IlaIia sono lulle iene (Purg. VI, 124-125), mai godendo di pacc
48
.
48 Cfr. AVIRSANO, Oanic crisiianc, cil., . 100. S'e gia riIevalo che iI lema deIIa guer-
ra e deIIa ace neI VI deI Purgaicric e Io slesso che conlrassegna sia iI VI deI Para!isc
dove I'oera di acificazione deI sacrcsanic scgnc er mano di Auguslo e anliodica a
queIIa dei GueIfi e dei GhibeIIini che Io comballono o Io riducono a insegna di arlilo: iI
che significa anleorre (ed e lema forle deIIa Mcnarcnia, assalo a Lorenzelli e rima
ancora a Simone Marlini) iI rivalo aI ubbIico, iI rorio bene (cos vanno inlesi iI
sapprcpria di Par. VI, 33 e Io apprcpria di Par. VI, 101) a queIIo comune sia iI VI
deII'|njcrnc, caIalo com'e aI suo cenlro allraverso Ie lre domande deI vialore e Ie risosle
che Ciacco, iI consigIiere goIoso, gIi rende (|nj. VI, 60-75). Ma queslo baIza in chiaro
anche daI rimo dalo slalislico eccezionaIe che daI VI deII'|njcrnc e lraibiIe (dei moIli
che uo vanlare, e di cui ci occueremo in aIlra occasione): iI verbo lornare ha in esso
iI soIo imiego, fra lulli queIIi deI Ioema, in rinciio di verso e di canlo, a riferire deI
rilorno deIIa coscienza doo Ia searazione daI coro (er cui cfr., a Purg. VI, 19-20,
I'anima !itisa / daI coro suo), e dunque ad annunziare di rifIesso iI lema deI arli-
re, (Ia cilla pariiia), Ia !itisicn da cui iI gigIio, Ia monela deI suo ooIo un lemo
giusic, fu reso tcrnig|ic (Par. XVI, 154). Nessuna sorresa, aIIora, che anche iI VI deI
Purgaicric roonga aI suo rinciio s'e accennalo iI verbo arlire (Quando si
paric iI gioco de Ia zara: cfr. AVIRSANO, Ic cpcrc !i niscriccr!ia, cil., . 169-174), e che
Io slesso caili neI VI deI Para!isc, che comincia coI riferimenlo lemoraIe deIIa arlen-
za-divisione o, er dirIa con Mcn. III, X, 5, deIIa scissione deII'aquiIa imeriaIe da
Roma conlr'aI corso deI cieI, e rosegue coI riordino deIIe Ieggi, con Ie imrese
deII'aquiIa di Roma che assicuro Ia ace (Par. VI, 80), e con Ia condanna di chi diarle
|a giusiizia daI sacrosanlo segno (Par. VI, 104-105). AIIora neanche sara un caso che iI VI
deIIa lerza Canlica lermini aI segno deIIo slesso verbo, con Ia arlenza di Romeo, iI
consigIiere giusic: Indi pariissi overo e veluslo... (Par. VI, 139). Non e difficiIe recensi-
re iI gran numero di arlizioni che cosleIIa i sesli canli, ne avvedersi aIfine che
arlire e iI vocaboIo deII'esiIio, e dunque iI iu aulobiografico deI Ioema, lanl'e che
se ne cogIie reIica fIagranle rorio Ia dove iI lema ha iI suo unlo agogico: QuaI si
parii IoIilo d'Alene / er Ia sielala e erfida noverca, / laI di Iiorenza arlirli con-
viene (Par. XVII, 46-48). Dove iI pariirii dovra revaIere, ercio, suI elrocchiano (e
lradizionaIe) pariir ii: cfr. AVIRSANO, Oanic !accapc, cil., . 28.
Cresce ancora, come si vede, iI numero dei dali che cerlificano come Ia cenlraIila di
SordeIIo neI Ioema sia dovula aII'inlerrelazione in chiave slorico-aulobiografica che
I'A. da deII'uomo e deIIa sua oera: iI Goilese aare ai suoi occhi come uno dei grandi
ConsigIieri, che mise iI dono ceIesle deII'ingcgnc e I'aric (aresa con I'eserienza dei
vizi umani e deI vaIore), in una Ia sapicnza, aI servizio deIIa ace, deIIa giuslizia e deIIa
Mario Aversano 518
Siamo agIi anlecedenli deIIa Tirannia quaIe sara effigiala neI MaI
governo di Lorenzelli.
A coroIIario di quanlo finora eserilo, rovo a riannolare iI ceIebre
nave sanza nocchiero in gran lemesla (Purg. VI, 77). II verso dirige
Ia memoria innanzilullo a Prct. XI, 14: ubi non esl gubernalor, ou-
Ius corruel. La nave e da immaginare come iena di genle che da
ordini, ma riva d'un cao a cui lulli obbediscano. I dunque gia
adombrala neII'assenza deI nocchiero queIIa deII'Imeralore, come si
deduce anche da Ccnt. IV, IV, 4:
erche manifeslamenle vedere si uo che a erfezione de Ia
universaIe reIigione de Ia umana secie conviene essere uno,
quasi ncccnicrc, che, considerando Ie diverse condizioni deI
mondo, a Ii diversi e necessari offici ordinare abbia deI lullo
universaIe e inreugnabiIe officio di comandare. I queslo offi-
cio er ecceIIenza |npcric e chiamalo.
Quesla assenza delermina anche Io slraolere dei iu vioIenli neIIe
cilla d'IlaIia. Cerlo Io in gran icnpcsia, se riorlalo aII'aIlro IausibiIe
modeIIo sacro, inlroduce iI Iciinciit deIIa giuslizia: Saiens non odil
mandala el iuslilias, el non iIIidelur quasi in prccc||a natis (|cc|i.
XXXIII, 2). Ma forse qui Danle ha anche ricordo deIIa icnpcsias cicero-
niana lrasosla neIIa |ciicrica di runello Lalini. Vi si Iegge che in
aIcuno lemo gIi uomini che non erano arIalori e uomini meno che
savi non usavano lramellersi neIIe ubbIiche vicende, ma in seguilo
i foIIi ardili imronli ervennero ad avere reggimenlo di comunan-
ze, sicche gIi uomini d'aIlissimo ingegno, quasi er scamare di
lorbida icnpcsiaic in sicuro orlo, cos fuggendo Ia discordiosa e lu-
muIluosa vila si rilrassero ad aIcuno aIlro quelo sludio. Iccone oi
I'esosizione, con riferimenlo abbaslanza aIese a Iirenze:
gridavano e garriano a grandi boci e non si vergognavano di
menlire e dire lorlo aIese |.j non fue meravigIia se neIIe cil-
ladi veniano gran!issinc c niscrissinc icnpcsiaii |.j e dice
concordia lra i vivenli. I un concello deI governo degIi uomini che si avvaIe deI gia
ensalo nei Iibri anlichi e nei moderni, ma che lullo rieIabora e ravviva, ne rimane infe-
condo, in un Iimbo di redicazione inerle. Isso rivive non soIlanlo neIIa sloria deIIe
Iellere. Lo si rilrova ne abbiamo dalo annunzio e ne lralleremo lra oco neIIa icono-
grafia deIIa ace e deIIa guerra, e deIIe Ioro conseguenze, che Ambrogio Lorenzelli ideo
affrescando iI IaIazzo IubbIico di Siena. Ivi Saienza, Iace, Giuslizia e Concordia sono
lra Ie Virlu necessarie ai ConsigIieri deIIa ReubbIica, i quaIi reggono una fune ccnccr-
!cs: anlidolo a queIIa slessa Oisccr!ia da cui Danle eIIegrino dice assaIila Iirenze
dinanzi aI ConsigIiere Ciacco (|nj. VI, 63).
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 519
'lemeslanze' er simiIiludine, che s come natc dimora in
forluna di mare e laIvoIla crescono in lanlo che erisce, cos
dimora Ia cillade er Ie discordie.
AIIora iI oela ha gia in menle iI viIIan che divenla arIalore
come iI MarceIIo ciceroniano, e Ie cilla che sono lulle iene di liranni
(vv. 124-126), asso a cui fanno seguilo Ia |ancniaiic su Iirenze e iI
cenno aI suo ooIo cos bramoso di cariche ubbIiche e con in
sommo deIIa bocca semre Ia giuslizia.
L'INIGMA DI MARCO LOMARDO
1. La coia di dali e di considerazioni fin qui messa a giorno
consenle di essere moIlo iu brevi neII'aggredire iI secondo enigma di
cui s'e dello neIIa Prcncssa, queIIo di Marco Lombardo. Tullo quanlo
abbiamo raccoIlo e ragionalo di SordeIIo, infalli, vaIe anche er Ia
resenza di Marco (rilenula scandaIosa) neI XVI deI Purgaicric, can-
lo che insieme aI XVII forma, rieliamoIo, iI cenlro deIIa Ccnnc!ia,
numerico e ideoIogico insieme.
Ora ne Iorena
49
, ne aIlri rima e doo di Iui, hanno sosellalo che
Marco Lombardo, rorio erche uomo di corle, cioe consigIiere,
vanli lulli i requisili che er I'addielro si son visli in SordeIIo. I se-
ciaImenle non gIi manca queIIo che er Danle cosliluisce Ia Ioro
esressione: e oeralore di giuslizia e di ace. I basli, a rova slori-
ca, quanlo riferisce envenulo: Marco ebbe consueludine coi Signori,
inler quos lraclabal saee concordias, aces, affinilales el confoede-
raliones. isogna lenere a menle quesle quallro aroIe Ialine: erche
sono Ie slesse che fanno da iIaslri aII'imaIcalura figuraliva che Am-
brogio Lorenzelli ha reaIizzalo meno di due decenni doo Ia morle di
Danle. NeIIe due grandi areli deI uon Governo ci sono rorio Ie
figure deIIa Concordia, deIIa Iace, dei Malrimoni e dei Ialli di aIIean-
za. Ma quesle aroIe ne allraggono e ne resuongono aIlre due: Ia
Saienza e Ia Giuslizia. Che, Io moslreremo lra oco, sono figure non
meno beIIe e imeranli neII'affresco Iorenzelliano. Anzi, in roosilo
49 I oorluno riroorre, quesla voIla aIIa Iellera, iI nodo come egIi Io resenla. A
suo arere Ia dollrina oIilica di Danle, che si manifesla in lanli assi deI Ioema, in
nessuno e esosla con maggior sinlelica chiarezza che neI discorso di Marco Lombar-
do. Canlo cos fondamenlaIe che, se er venlura Io si erdesse, ne verrebbe iI maggior
danno che non daIIa erdila di aIlri er Ia conoscenza deI ensiero di Danle. Di qui
I'inlerrogalivo: Orbene, come mai Danle a una arle cos immensamenle imorlanle
eIegge non un leoIogo, non un fiIosofo, non un grande uomo oIilico, non un grande
scrillore, ma un uomo di corle a noi mezzo sconosciulo e non cerlo reulalo grande
neanche dai conlemoranei`.
Mario Aversano 520
Danle afferma anche di iu: Marco fu saienle e amo Ia giuslizia su
lullo. In queslo senso, e non in aIlro, Ia lerzina che Io resenla, infalli,
ha da essere inlerrelala:
Lombardo fui, e fui chiamalo Marco,
deI mondo sei e queI vaIore amai,
aI quaIe ha or ciascun disleso I'arco.
(Purg. XVI, 46-48)
Una rima equazione, scppisaienza, e faciImenle ammissibiIe.
Marco ebbe infalli nomea di savio: savissimo Io dice I'aulore deI
Nctc||inc. Ma e ossibiIe, anzi doveroso, orre un'aIlra uguagIianza,
mai avanzala, ch'io saia: quc| ta|crcgiuslizia. Iurlroo deI vaIo-
re a cui nessuno iu lende I'arco si e dello semre aIlro: Iarghezza,
rudenza, magnanimila, corlesia, vaIenla, rodezza, e sorallullo
virlu in genere. Ma come roosi, or son venl'anni, in una |cciura
romana (Casa di Danle, 3 febbraio 1985) coIisce I'assenza di
sazi ammorbidenli lra Ia nolizia deI nome e Ia rofessione di amore
er quc| ta|crc |.j. Quesla cos nella asserzione non uo essere inlesa
in senso generico quanlo aII'oggello deII'amore. II dimoslralivo ha
un'ineIudibiIe carica di secificila
50
.
A arle iI segnaIe di !iriiiancnic vai (I'emislichio, oiche e in
rima immediala con quc| ta|crc anai, evoca Ia !riiiura, come e della Ia
giuslizia anche in Danle: cfr. Par. XX, 121), dovevano e dovrebbero
conlare quesli eIemenli:
1) lulli i ConsigIieri buoni deIIa Ccnnc!ia hanno Ia marca di
giusli: vedi, er es. iI giusic Mardoceo deI canlo che segue, iI XVII, iI
giusic Romeo di ViIIanova (Par. VI, 137), e iI giusic Iier deIIa Vigna
(|nj. XIII, 72).
2) iI disamore er Giuslizia, iI bando e Ia soIiludine in cui Ia si
abbandona formano Ia lemalica reciua deIIa Canzone deIIa Rellilu-
dine, forse Ia iu aulobiografica: I'essiIio che m'e dalo onor mi
legno (v. 76),
3) Ia melafora deII'arcc e roria deIIa giuslizia, a cominciare
daI canlo in cui avviene I'inconlro con SordeIIo da Goilo, dove
abbiamo gia vislo e arimenli Iegala aI ConsigIio: MoIli han
giusiizia in core, e lardi scocca / er non venir sanza ccnsig|ic a I'arcc...
(Purg. VI, 130-131),
4) er chi non ne fosse convinlo vaIga Ia resenza deIIa slessa
melafora deII'arco, er Ia giuslizia, neIIa Iellera (anche sora cilala)
50 IubbIicala in AVIRSANO, Ia quinia rucia, cil., . 24.
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 521
aI CardinaIe NiccoIo da Iralo, che e davvero lulla di Iace e di
ConsigIio
51
.
5) Ia giuslizia come ta|crc e gia resenle a Purg. X, 74, e a
roosilo di Traiano, I'imeralore che non a caso forma I'arco
deI cigIio sueriore deII'AquiIa, simboIo deIIa Giuslizia (Par. XX,
43 sgg.),
6) aIIa giuslizia rimanda, infine, I'aIIegoria medievaIe deII'arco,
cfr., ad esemio, AIano di LiIIa: Arcus iudicium significal (PI,
CCX, 124). Ma non basla. Irearandoci a visionare gIi affreschi di
Lorenzelli, bisognera rocedere a dei conlroIIi neI modo che uno
dei rinci deIIa scnicsi c|||igaia suggerisce: iI comulo slalislico.
S'e dello di Saienza e di Giuslizia: ma di Iace e Concordia, ce
n'e Iungo iI canlo di Marco Lombardo` InoIlre: i reIalivi segni,
quando ci fossero, hanno ienezza IessicaIe, oIlre che lemalica`
I in che raorlo enlrano con gIi aIlri sarsi in lullo iI Ioema`
Ognuno caisce, a queslo unlo, quaIe forza robaliva avrebbe
Ia osilivila dei risconlri. Dunque, Ia caccia e aerla, e ne vedremo
lra oco.
LA SALA DILLA IACI, DANTI I IL SUO RITRATTO
1. Quanlo abbiamo fin qui esoslo ha gia comorlalo iu voIle Ia
nominazione deI Lorenzelli deIIa SaIa deIIa Iace, e I'idea che lra Iui e
Danle sia corso uno slrello Iegame, er concordanza di dollrina,
di oelica e di vedule e inlenli neI fare arlislico. Quando oi si va
ai conlroIIi anaIilici, aare evidenle che iI rimo ha sosalo iI
ensiero elico-civiIe-oIilico-leoIogico che e rorio deI secondo, e
er ogni riguardo: neIIo schema generaIe come neIIa slrullura deIIe
singoIe scene, nei arlicoIari, neIIe significazioni IelleraIi ed aIIegori-
co-embIemaliche, e infine neIIe didascaIie inserile a caralleri d'oro
negIi affreschi.
Si guardi aII'imianlo comosilivo deI uon Governo. L'oera e
51 Cfr. |p. I, 5-7: Il ad quid aIiud in civiIe beIIum corruimus, quid aIiud candida
noslra signa elebanl, el ad quid aIiud enses el leIa noslra rubebanl, nisi ul qui civiIia
iura lemeraria voIulale lroncaveranl el iugo ie Iegis coIIa submillerenl el ad acem
alrie cogerenlur` Quie noslre inlenlionis cusis Iegilima de nervo quem lende-
bamus rorumens quielem soIam el Iiberlalem ouIi fIorenlini elebal, elil, alque
elel in oslerum (I er che aIlro siam corsi neIIa guerra civiIe, che aIlro cercavano Ie
noslre bianche insegne, e erche aIlro rosseggiavano Ie sade e i dardi noslri, se non
erche coIoro che con lemeraria voIulla lroncarono i dirilli civiIi e sollomellessero i coIIi
aI giogo deIIa ia Iegge e fossero coslrelli aIIa ace deIIa alria` Anzi Ia freccia deIIa
noslra inlenzione scoccando daIIa corda che lendevamo era, e e sara in fuluro dirella
aIIa soIa quiele e Iiberla deI ooIo fiorenlino).
Mario Aversano 522
conceila er immagini disosle orizzonlaImenle su lre iani. QueIIo
sueriore si disiega con evidenza neIIo slesso ambilo deIIa leoIogia
calloIica (che Danle gia arofond neIIe scuoIe de Ii reIigiosi di cui
a Ccnt. II, 12, 7). Ambrogio insedia neIIa arle deslra Ia Saienza,
e neIIa sinislra Ie virlu leoIogaIi: Iede, Seranza, e in mezzo, a un
gradino iu aIlo, Carila. Quanlo aIIe virlu cardinaIi, iI oslo Ioro asse-
gnalo e neIIa fascia inferiore, a cominciare da Giuslizia, che e a deslra,
solloslanle a Saienza. Nessuna meravigIia che si risconlri Ia slessa
gerarchia ch'e neI Ioema danlesco, con I'eminenza deIIe lre di iu
aIlo lribo, che miran iu rofondo, suIIe quallro ninfe che menano
iI eIIegrino venulo daIIa lerra agIi occhi di ealrice (Purg. XXXI, 106-
111): nozione canonica e diffusa anche in ambienli di cuIlura non raf-
finala.
Meno correnli debbono dirsi, invece, Ia conliguila e Ia coordina-
zione deIIe virlu leoIogaIi con Ia Saienza, e I'accenlo oslo suI suo
rimalo: queIIo che Danle esrime fin dai Trallali. I Ia inpcra!ricc
di Ccnt. III, XV, 18, della ciicrna|c suIIa scorla bibIica, erche neI
divino ensiero |.j essa era quando (Dio) Io mondo fece. Ma iu
ancora indicaliva e Ia coincidenza deI suo eslendersi, neII'uno e
neII'aIlro quanlo aIIa significazione embIemalica daIIa sfera mela-
fisica a queIIa lerrena: in Lorenzelli con I'immaginario deIIa corda che
da Saienza va a Giuslizia, e oi a Concordia, e infine aI Reggenle,
lramile venliquallro orlalori, in Danle con I'assimiIazione deIIa
Saienza aIIa ji|cscjica auicriia!c che deve congiungersi con Ia inpcria|c
a ben governare i ooIi. Si riIegga seciaImenle Ccnt. IV, VI, 18: I
ero si scrive in queIIo di Saienza: 'Amale Io Iume de Ia saienza voi
lulli che siele dinanzi a' ouIi'. Cio e a dire 'Congiungasi Ia fiIosofica
aulorilade con Ia imeriaIe, a bene e erfellamenle reggere. I abbia-
mo gia vedulo che er Danle Ia condizione di miseria dei morlaIi e
cagionala daI fallo che rncii e liranni non sceIgono come dovrebbe-
ro quanli hanno da affiancarIi er consigIio: queIIi che egIi vede
sollo i suoi occhi baIzare a laIe resligioso ufficio non sono egIi Ia-
menla iu voIle veri Savi, e ercio non hanno voIonla di ben fare.
Non aarlengono, cioe, a queIIa calegoria di huomini amalori el di
ace el di giuslizia dai quaIi ci si asella come da un frammenlo
deIIo Slalulo di Siena deI 1310 che siano conservalori deI buono
slalo deI comune e deI ooIo di Siena. I I'oera danlesca, in aIlri
lermini, che roaganda con Ia maggiore chiarezza come s'e moslra-
lo neIIa rima arle deI resenle arlicoIo iI raorlo slrello lra
Saienza e Giuslizia: una conquisla di cuIlura che robabiImenle risa-
Ie aIIe rime comosizioni deII'esiIio, e segnalamenle aIIa canzone Trc
!cnnc inicrnc a| ccr, generaImenle della deIIa Relliludine. I si uo
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 523
vedere come aIIa messa a fuoco di quesla concezione concorra anche
una iu arofondila conoscenza deIIa Ielleralura anlica, e araIIeIa-
menle deIIe Scrillure, dove Ia binomia Saienza-Giuslizia e iu voIle
alleslala. Si guardi, er essa, Ccntitic III, XV, 18:
I se lulli aI suo (deIIa Saienza) consello venire non olele,
onorale Iei nei suoi amici e seguile Ii comandamenli Ioro, s co-
me queIIi che v'annunziano Ia voIonla di quesla ellernaIe
imeradrice non chiudele Ii orecchi a SaIomone che cio vi
dice, dicendo che Ia via de' giusli e quasi Iuce sIendienle, che
rocede e cresce infino aI die de Ia bealiludine andando Ioro
dielro, mirando Ie Ioro oerazioni, che essere debbono a voi
Iuce neI cammmino di quesla brevissima vila.
Si risconlra aIIora senza difficoIla Ia slrella arenleIa elico-oIilica
che viene a configurarsi fra Danle e iI Lorenzelli che coIIoca neIIa
fascia inlermedia, rima di ogni aIlra immagine, queIIa di IUSTITIA,
e con due ecuIiarila, I'una concelluaIe, I'aIlra saziaIe: Ie fa occuare
iu di un lerzo deIIa sequenza iconografica, e Ia one in raorlo
di discendenza dirella daIIa Saienza. I queslo uno dei segni maggio-
ri deIIa soIidariela ideoIogica e Iinguislica con Danle. Ma Ia crilica
in roosilo ha fallo invece che di quesl'uIlimo iI nome di
ArisloleIe, e oi di Cicerone, di runello Lalini, di san Tommaso e dei
suoi disceoIi oIilici (Igidio Romano, Remigio de' GiroIami, ecc.),
e di aIlri. I cos oi s'e lrovala in difficoIla, erche daIIa verifica
documenlaIe e emerso da una arle che ne in ArisloleIe, ne in
Cicerone, ne in runello affiora I'idea deIIa divinila deIIa Saienza,
e daII'aIlra che ne Tommaso, ne i suoi seguaci loIIerano iI concello
deIIa derivazione da Dio deI saere umano in quanlo e olere
cuIluraIe che si esIela neI ben fare deI ConsigIiere: Ie oerazioni
degIi amici deIIa Saienza (grosso modo queIIi che oggi sono
chiamali inleIIelluaIi) di cui abbiamo vislo. II ruoIo deIIa cuIlura
che s'e scoerlo quaIe esaIlazione lrovi in runello e negIi aulori-
lradullori medievaIi deIIa relorica ciceroniana, e come esIoda
neII'oera danlesca che laIe eredila riceve e slrullura in una visione a
lullo londo, e secie neIIa Ccnnc!ia, divenlandone iI cenlro e iI fuIcro
non viene rilenulo essenziaIe in aIcuno dei lrallali oIilici di mag-
giore aulorevoIezza che generaImenle si aIIegano come fonli di
Lorenzelli: ne anlichi ne moderni. Non se ne scorge lraccia, ad esem-
io, neI Oc rcgininc principun di san Tommaso, e neure in queIIo di
Igidio Romano. Cio erche er I'uno e er I'aIlro vaIe iI rinciio, di
marca lulla leocralica, che reges sacerdolibus debenl esse subiecli.
Mario Aversano 524
La figura deI ConsigIiere in quesli IibeIIi e Ialenle
52
" o ridolla a occu-
azioni di secondo ordine, o coincide con queIIa di aIlri funzionari,
quaIi i comiles, barones, el miIiles feudalari, ai quaIi sella di bada-
re non gia aI governo deI mondo, ma a servigi ralici: ucceIIagione,
caccia e aIlre cose famiIiari (Oc rcg. princ. II, X). ImbIemalica di laIe
ensiero uo considerarsi Ia diversa slima che Tommaso e Danle fan-
no deI bibIico Mardocheo. NeIIa Ccnnc!ia s'e vedulo iI minislro
deI grande Assuero viene sceIlo come iqpus deI buon ConsigIiere,
che ha da essere er ecceIIenza arlefice di concordia, di ace e di giu-
slizia (iI giuslo Mardoceo), invece neI Oc rcgininc principun
Mardocheo riceve menzione, accanlo a Giusee, fra queIIi che hanno
ben merilalo in oere che imegnano iulloslo Ie arli meccaniche,
quaIi difesa miIilare, vellovagIiamenlo, erario (IV, XIII). NuIIa dice
san Tommaso deIIa aroIa ornala, di queIIa che er Danle e I'arma iu
efficace deI ConsigIiere. Viceversa iI Mardoceo deIIa Ccnnc!ia acco-
ia aII'amore er Ia giuslizia I'inlerezza non soIo deI fare (iI ben
fare-oerare su cui lanlo abbiamo indugialo, fino a individuare in
esso uno dei dislinlivi deI ConsigIiere), ma anche deI dire, che daI
fare non uo essere disgiunlo: che fu aI dire e aI far cos inlero
(Purg. XVII, 30). MoIlo gioca, inoIlre, Ia conslalazione che a queslo
lema, e aIIa connessa oIilicila deIIa aroIa, Danle si moslra cos
affezionalo (anche er I'imIicanza aulobiografica, esiIio comreso),
da solloIinearIo erfino in queII'oera che generaImenle e considerala
di lrallalislica uramenle Ielleraria, iI Oc tu|gari c|cqucniia. II voIgare
che egIi roone vorra essere iIIuslre, cos come aare neIIe Canzoni
sue e di Cino da Iisloia: che in quanlo domeslici di laIe idioma sue-
rano in fama reges, marchiones, comiles el magnales quosIibel (II,
XVIII). I iI rimalo ideaIe deIIa cuIlura, e deI ConsigIiere (che non
escIude, ma iulloslo subIima I'esercizio deIIa oesia), di cui s'e
moslrala I'incidenza in lulla Ia roduzione di Danle susseguilasi aIIa
Viia ncta.
Anche er quesli molivi e da condividere senza lenlennamenli
I'oinione di queIIi che (e vanno menzionali sorallullo iI GiIson e iI
Iosler) scorgono neIIa lesi dei due uIlimi Ia feIicila non soIo ceIesle,
ma anche lerrena (Ia |caiiiu!c nuius tiiac) iI verlice deII'umanesimo
di Danle: che er laIe riguardo viene a lrovarsi aI oIo conlrario di san
Tommaso e di sanl'Agoslino. Quesl'uIlimo, infalli, nega che fine uIli-
mo deIIa vila lerrena ossa essere queIIo naluraIe, e neI Oc citiiaic Oci
52 Tommaso condivide quanlo gIi viene riferilo da ArisloleIe suIIa pc|iiia di Hio-
domus: iI quaIe slaluil |...j in ulroque raelorio lam ordinario, quam rinciaIi, ul
iudicia fierenl sine coIIeclione saienlium: ogni cilladino avrebbe dovulo esrimere iI
suo ccnsi|iun in segrelo.
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 525
giunge a soslenere che Ia ace e irreaIizzabiIe daIIe formazioni oIili-
che e daII'Imero (XIX, VII, 11-14).
Sono dali, a noi are, gia sufficienli a che si iolizzi un raorlo
inlerlesluaIe lra Lorenzelli e Danle: giacche gIi affreschi deI uon
Governo sono un inno soIare, reIigioso e Iaico insieme come in
Danle
53
, aIIa feIicila lerrena, Ia quaIe non uo essere conseguila se
manca Ia Giuslizia, Ia virlu che discende er Iegame dirello daIIa
Saienza. Accanlo a quesl'uIlima Ambrogio dunque formalo come
aare aIIa scuoIa di Danle iu che di ogni aIlro rougnalore
deII'idea, e robabiImenle di Cino da Iisloia, che Ie idee di Danle
saccio in Siena lenendovi calledra, com'e nolo, daI 1321 non oleva
non coIIocare Ia figura di Iace: con in mano I'uIivo, e cinla di Iauro
come cinla d'oIiva, si badi, e ealrice aIIorche fa scena neI Iaradiso
lerreslre, venula daI cieIo, iI regno deIIa elerna ace (Par. XXXIII, 8).
I abbiamo vedulo quanlo riIievo si dia neIIa Ccnnc!ia aIIa coia
Giuslizia-Iace. In cio I'uno e I'aIlro aulore, bisogna dirIo, marciano
garanlili daI Libro sacro: ous iusliliae ax (|sa. XXXII, 1). Ma
oi Ambrogio lrovava neIIo scrillo danlesco iu dichiaralamenle oIi-
lico, Ia Mcnarcnia (rima che neIIe aIlre aucicriiaics che gIi sludiosi
cilano in argomenlo), che siccome fra lulli i beni deII'uomo grandis-
simo e queIIo di vivere in ace, come s'e dello sora (I, IV, 2), e queslo
bene oera rinciaImenle Ia giuslizia, quesla ricevera grandissimo
vigore daIIa carila (Mcn. I, XI, 14)
54
. I Ia slessa Carila che, cenlrala
fra Ia Seranza e Ia Iede, Lorenzelli ha soseso suI cao deI buon
Reggenle.
I qui si deve aggiungere a risconlro deIIe domande osle sora,
invilanli aIIa caccia dei vocaboIi ace e concordia che ace
ricorre e come (e non oleva non ricorrere, slanle iI moIlo che se n'e
censilo) a mela deI Ioema, neI canlo di Marco Lombardo: Ie anime dei
enilenli d'ira in erfella concordia invocano I'AgneI di Dio, si ricor-
di, er ace e er misericordia (Purg. XVI, 17).
NeIIa seconda fascia Lorenzelli doo Giuslizia e Iace slagIia,
conlornala daIIe virlu cardinaIi e da Magnanimilas, una figura
maeslosa di vegIiardo, di grande dignila, con scellro e scudo. Issa
raresenla s iI Comune di Siena, ma anche iI uon Reggilore che
53 Non con aIlrellanla assoIulezza, invece, e reeribiIe neIIa Maesla di Simone, che
riviIegia ancora iI sacro. In queslo diinlo sono cenlraIi Ia Madre e iI ambino: menlre
Lorenzelli aIIa Madonna non da aIlro sazio che queIIo deIIo scudo imbraccialo daI
Reggenle. Senza dire che di Sanli ne inserisce ben ochi.
54 Cumque inler aIia bona hominis olissimum sil in ace vivere ul sura di-
cebalur el hoc oerelur maxime iuslilia, karilas maxime iuslisliam vigorabil el olior
olius. Non sfugga Ia resenza deI verbo cpcrari: caIcoIala, giacche si lralla, abbiamo
vislo, d'un lermine quasi lecnico.
Mario Aversano 526
fonda Ie sue azioni suIIe delle virlu, e su queIIa magnanimila che
Danle chiama anche Iarghezza e benignila, e che uo dirsi orna-
menlo reciuo deI suo rololio di rincie, Cangrande deIIa ScaIa
(Par. XVII, 73)
55
. InoIlre: I'aulore deIIe didascaIie che lulli credono un
dollo chiamalo a fare da consuIenle, ma che a Iume di buon senso
oIlre che di documenli slorici non uo non essere Lorenzelli slesso
56
imiega, in queIIa che comincia VOLGIITI GLIOCCHI ARIMIRAR COSTII,
un verbo, reggere, che e rorio Io slesso reeribiIe neI Ccntitic: iI
VOCHI RIGGIITI richiama lroo da vicino Io Oh miseri che aI re-
senle reggele e I'I dico a Voi, CarIo e Iederigo regi (Ccnt. IV, VI,
19-20), essendo anche iena Ia coincidenza lemalica dei reIalivi conle-
sli. II re guerriero senese, buono come iI danlesco |ucnc Augusic, che
ose iI mondo in lanla ace (Par. VI, 80), ricorda eraIlro iI re
saienle er anlonomasia, SaIomone, e insieme iI Mose Iegisla e
ubidienle (|nj. IV, 57).
2. I veniamo aII'uIlima deIIe lre fasce deII'affresco, queIIa inferiore.
Ad arirIa e I'immagine deIIa Ccnccr!ia. Issa raccogIie i fiIi che
Giuslizia Ie assa daI iano sueriore, Ii inlreccia, e Ii orge in forma
di corda !riiia
57
come si Iegge neIIa didascaIia LADOVI STA LIGATA LA
IUSTITIA a venliquallro figure maschiIi che avanzano in rocessione,
a aio, fino ai iedi deI Reggenle, e a Iui Ia consegnano. Issi dunque
raccoIgono quanlo, originalo da Saienza, e disceso direllamenle a
55 Cfr. AVIRSANO, Oanic !accapc, cil., . 27 e sgg.
56 Non si comrende Ia ragione er cui Ia generaIila degIi sludiosi non da eso o
resla oca fede a quanlo e slalo lramandalo a riguardo deIIa cuIlura di Lorenzelli. C'e
un documenlo che dovrebbe alleslarIa in modo inconlroverlibiIe: neI 1347 Ambrogio
figura come membro deI ConsigIio dei Iaciari deI Comune di Siena (Siena, Arch. di
Slalo, Oc|i|crazicni !c| Ccncisicrc, c. 91, 1347). I Iaciaro equivaIe a dire ConsigIiere, neI
significalo che deI liloIo fin qui e emerso. Senza dire che in laIe ConsigIio egIi ronun-
zio un discorso, iI che cerlo non era ermesso a indolli. Ne conlro iI Ghiberli olrebbe
mai reggere I'accusa di arziaIila inleressala, quando scrive: Maeslro Simone fue nobi-
Iissimo iclore el moIlo famoso. Tengono i iclori sanesi fosse eI migIiore, a me arve
moIlo migIiore Ambrogio Lorenzelli el aIlrimenli dollo che nessuno degIi aIlri (Ccn-
ncniari, II, 109). Cos oi, di rincaIzo, Vasari (II, 179-183): i coslumi e Ie incIinazioni di
Ambrogio furono iu loslo di genliIuomo e di fiIosofo che di arlefice. Si sa anche,
eraIlro, che neI 1327 fu a Iirenze (dove aveva soggiornalo gia rima, vivo ancora Dan-
le), e che come Danle venne immalricoIalo neIIa IocaIe Arle dei medici e seziaIi
(Iirenze, Arcnitic !i Siaic, Aric !ci nc!ici c spczia|i, MalricoIe, Iibro D). Ma e oi I'inlero
ccrpus degIi affreschi a far leslo, con Ia decisione e Ia novila assoIula deIIe invenzioni
figuralive: iI che non ole diendere in aIcun modo da suggerilori imosilivi.
57 I non raggroala e ravvoIla (|nj. XVI, 111 sgg.): com'e queIIa che VirgiIio ri-
ceve da Danle e Iancia neI baralro er allrarre Gerione, iI moslro simboIeggianle Ia
frode, e dunque I' inganno di cui neIIe didascaIie di Simone Marlini e di Lorenzelli, e
I'ingiuslizia maggiore.
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 527
Giuslizia e da quesla a Concordia. II messaggio non uo essere che
queslo: oiche i Venliquallro di fallo sono iI ricellacoIo di quanlo
roviene da Saienza-Giuslizia-Concordia, iI buon Reggenle non uo
rinunziare ai Ioro uffici. Di conseguenza essi non loIIerano di essere
idenlificali in mansioni di subordine (come semIici cilladini o ra-
resenlanli di varie cIassi, o magislrali, o funzionari, e aIlre cose deI
genere). Si lrallera forzosamenle di Saggi-Savi-Saienli, chiamali a
consigIiare chi governa. Doveroso, erlanlo, ensare aII'ascendenza
danlesca, slanle che rorio in laI modo, con Ie slesse virlu e quaIila,
Ia figura deI ConsigIiere e deIineala I'abbiamo dello er I'addielro
anche lroo neI Ccntitic e neIIa Ccnnc!ia. I daI Ioro concorde
ben fare che diendono Ia ace e Ia giuslizia neIIe alrie lerrene.
Se ne deve concIudere e sara un aIlro eIemenlo di rova che non
a caso I'invilo aI |cn jarc-cpcrarc e resenle anche neIIa didascaIia
58
che comincia VOLGIITI GLI OCCHI, aI enuIlimo verso, neIIa forma
oeran bene: DA LA SUO LUCII NASCII. IL MIRITAR COLOR COIIRAN
INI.
I qui e lemo di addurre un aIlro graoIo di eIemenli robalivi,
ad avvaIorare ancor iu I'iolesi d'una connivenza inlerlesluaIe di
Lorenzelli con Danle. Si uo cominciare con una domanda moIlo
semIice: quaIe aIlra siegazione si uo dare deI fallo che Ie immagini
deI uono e deI Callivo Governo si snodano in una saIa di aIlo
ConsigIio, queIIa in cui si riunivano i Nove` La ragione non uo esse-
re aIlra, ci sembra, che Ia slessa er cui Ia Macsia di Simone Marlini
(recedenle I'oera di Lorenzelli di circa venl'anni, e dunque indizia-
biIe di aver, come dire, fallo lendenza), e siluala neIIa SaIa deI
Gran ConsigIio: i deslinalari deI messaggio illorico sono innanzilul-
lo, se non unicamenle, i ConsigIieri. Le slesse concIusioni si ossono
lrarre quando si considerino i seguenli dali: 1) neIIa Macsia di Simone,
Gesu infanle ha gIi occhi curiosamenle lorli a sinislra risello aI coro,
che e disoslo fronlaImenle (fig. 2), 2) Ia arle verso cui gIi occhi sono
girali a guardare e queIIa dove sedevano i ConsigIieri, 3) suI carligIio
che iI ambino sroloIa e scrillo Oi|igiic iusiiiian qui iu!icaiis icrran:
cioe iI versello bibIico che come e nolo Ie anime deI danlesco cieIo
deIIa Giuslizia (Par. XVIII, 91-93) vengono a formare con lrenlacinque
Iellere d'oro, 4) Ie slesse Iellere circondano a mo' di iu aIla corona Ia
figura deIIa Giuslizia in Lorenzelli
59
.
58 L'unica riferibiIe con cerlezza aIIa Giuslizia: cosa che, vedremo, non e deII'aIlra,
QUISTA SANTA VIRTU.
59 Cfr. CHIARA IRUGONI, Una |cniana ciiia, Torino, Iinaudi 1983, . 145.
Mario Aversano 528
Iigura 2. Ia Macsia, Simone Marlini (arlicoIare).
Ma c'e anche di iu: queslo diinlo di Simone accogIie una dida-
scaIia in cui a arIare e Maria Vergine, con una duIice rcspcnsic: I'una
rivoIla ai Sanli che hanno regalo erche rolegga Siena, I'aIlra agIi
AngeIi che offrono con Ie mani Ievale rose e gigIi. A quesli uIlimi si
badi Ia risosla non conliene, come ci si asellerebbe, segni di
gradimenlo deIIa genliIe offerla. Maria ronunzia deIIe aroIe (in ler-
zina: iI melro crealo da Danle, e siamo aena aI 1315: discorso che
rirenderemo in aIlra occasione) che da soIe olrebbero mellere fuori
discussione, er anaIogia, I'idenlila dei Venliquallro ersonaggi Io-
renzelliani. La Madre di Gesu dichiara che s, di queI dono fIoreaIe
degIi AngeIi rova diIello: ma non quanlo gIiene ossono rocurare i
|ucn ccnsig|i! Icco iI leslo deIIa didascaIia: LI ANGILICHI IIORICTI ROSI
(I) GIGLI. ONDI SADORNA LOCILISTI IRATO. NO(N) MI DILITTA(N) IIU CHII
UO(N) CONSIGLI. La oIilicila deII'affresco di Ambrogio Lorenzelli,
dunque, assoIula, ha iI reannunzio in queIIa cerlo meno esansa, ma
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 529
uguaImenle manifesla, di Simone Marlini: e in cio enlrambi sono debi-
lori a Danle
60
.
60 Debilore gIi e forse anche Giollo, ma non er Ie lemaliche oIilico-civiIi. Danle e
Giollo, in quanlo allivi in Iirenze e fuori, lra gIi uIlimi decenni deI Duecenlo e i rimi
deI Trecenlo, di cerlo si conobbero. Ma ci si chiede da semre: corse lra Ioro buon san-
gue` Si frequenlarono, scambiandosi idee, Iinee lemaliche, unli di visla leorici e
iconografici, o referirono ignorarsi` I Iecilo slabiIire araIIeIi lra Ie risellive reaIizza-
zioni di oesia e di illura, e arIare di inlerlesluaIila` I se conlalli ci furono, chi diede
e chi rese` O e referibiIe credere che debili e credili siano slali vicendevoIi` Su laIi
queslioni conlinuano a scorrere fiumi d'inchioslro, e lullavia in maleria non abbiamo
ancora aIcuna cerlezza. I iu negano che ci sia slalo inconlro significalivo lra iI oela e iI
illore, e argomenlano come segue. I due cerlamenle seero I'uno deII'esislenza e
deII'oera deII'aIlro: dalo che Danle nomina Giollo neI canlo XI deI Purgaicric. Ma da
queslo a dire che si infIuenzarono, ce n'e di slrada. La nominazione danlesca, oi, risoI-
vendosi neIIa conslalazione che gia neI 1300 Giollo ha sueralo in fama Cimabue, non
ha aIlro obiellivo che di rammenlare Ia caducila deIIa gIoria lerrena. Danle e Giollo,
eraIlro, erano in forle discordanza ideoIogica. II rimo, infalli, considero semre oni-
fazio VIII un usuralore deI |ucgc aaIe Iascialo vacanle da CeIeslino V (Par. XXVII, 27
sgg.: QueIIi ch'usura in lerra iI Iuogo mio), invece Giollo, chiamalo da onifazio a
Iavorare a Roma inlorno agIi anni deI GiubiIeo (1300), non esilo a roagandare con un
affresco Ia Iegillimila deII'eIezione di queslo Iaa. Da un Ialo ci sarebbe iI conservalo-
rismo deI oela (arislocralico), daII'aIlro iI rogressismo deI illore (borghese). Cos, in
definiliva, I'eslensore deIIa voce Giollo neIIa cilala |ncic|cpc!ia !anicsca, iI onigalli:
|.j Ie ersonaIila dei due conlemoranei divergono rofondamenle. Ier conlro chi
ammelle iI raorlo lra i due si e sinlo fino aII'affermazione che essi erano Iegali da
reciroca slima ed amicizia, e sesso Iavorarono consuIlandosi e lenendosi d'occhio. Ma
Ia lesi e fondala urlroo su eIemenli vaghi o non ricevibiIi erche rivi di consislenza
crilica, e laIora si sconfina neII'aneddolica iu arbilraria e neIIa Ieggenda.
Giudichi adesso iI Iellore se Ie concordanze che qui comunico ossano dare quaIche
risosla concrela. Isse riguardano Ie raffigurazioni deII'Invidia, cos come sono slale
reaIizzale da Danle e da Giollo. A me sembra che, aI di Ia dei Iuoghi comuni e inlerdi-
scorsivi, lroo esse coincidano erche ci si ossa iu ronunziare in senso negalivo o
dubilalivo suII'esislenza di un raorlo dirello lra quesli due grandi ilaIiani. Irimo
unlo. NeI Purgaicric di Danle I'invidia e unila er conlraasso, secondo I'elimoIogia
medievaIe deIIa aroIa: invidia ncn ti!cc. Non videro iI rossimo, furono in vila
come ciechi verso gIi aIlri, er mancanza di carila e er cuidigia, e in Purgaicric, er
casligo, hanno gIi occhi cucili con fiI di ferro. Secondo unlo. GIi invidiosi danleschi
aIzano iI cao, vogIiono carire nolizie, lendono Ie orecchie aena senlono quaIcosa
inlorno: cos fa Saa senese, iI ersonaggio che Danle eIIegrino inconlra neIIa seconda
cornice deI Purgaicric, dove si sconla I'invidia: Io menlo a guisa d'orbo in su Ievava
(Purg. XIII, 102). AIza iI menlo er far caire aI venulo daI mondo dei vivi che ha fallo
allenzione aIIe sue aroIe, che Io asella er risondergIi, e che vuoIe saere di Iui (e
sarIare come fara deIIa genle di Siena, che chiamera gcnic tana, cioe vanagIoriosa
e sluida). Terzo unlo. GIi invidiosi danleschi sono anche aragonali a ucceIIi raaci:
... che a lulli un fiI di ferro i cigIi fra / e cusce s, come a sarvier seIvaggio / si fa ero
che quelo non dimora (Purg. XIII, 70-72). Lo sarviero seIvaggio raresenla, oIlre che
Ia raacila e Ia cuidigia, anche I'inquieludine degIi invidiosi, che dice uno degIi Au-
lori iu seguili da Danle, san Gregorio Magno (PI LXXV, 198) ciechi vanno in giro
fuori di casa (caeci exlernis circumeunl). Ne meno indicalivo e iI mezzo verso qucic
Mario Aversano 530
Iorse si olra guardare con iu azienza, adesso, aIIe moIle cose
che Ia rima arle di queslo saggio accogIie, inlorno aI ConsigIio in
Danle, aII'enigma di SordeIIo, e oi a queIIo di Marco Lombardo.
Sono lulli e due dei ConsigIieri, ed hanno in ello massimamenle Ia
giuslizia, Ia concordia e Ia ace: gIi slessi lemi su cui verlono Ie lre
domande rivoIle a Ciacco
61
. Mi singo a rilenere che Lorenzelli non
avrebbe reaIizzalo una cos beIIa e vivida illura deIIa Iace, deIIa
Concordia e deIIa Giuslizia (iI ta|crc che abbiamo dello Marco
Lombardo iu amo), se non si fosse immerso con allenzione grande e
sofferla incoraggialo anche da Cino da Iisloia neIIo sludio deI Ioe-
ma danlesco, e in arlicoIare dei canli oIilici (i sesli) e deI XVI deI
Purgaicric. Ad anaIizzare iI quaIe ci sorrende un aIlro dalo slalislico
riveIalore: I'andala er queslo canlo fa callurare, come si sara nolalo,
non soIo pacc, ma anche ccnccr!ia (s che area lra essi ogne ccnccr-
ncn !incra. Isso manda aIlra Iuce suIIa Ioro sicoIogia, e sveIa Ia comonenle curiosa
deIIa coIa e deI conlraasso: gIi Invidiosi er casligo sono coslrelli aII'immobiIila
erche in vila si andarono imicciando senza osa dei delli e dei falli degIi aIlri, er
dirne maIe, come annola ancora Gregorio: soIIicilis inquisilionis Iaboranl |.j Iercussi
cecilale quasi domos circumeunl, qui invidenles facla diclaque rescrulanlur (PI
LXXV, 198).
Si vada ora aII'Invidia che Giollo ha diinlo a Iadova, neIIa CaeIIa degIi Scrove-
gni. Coincidono con Danle: 1) Ia maIdicenza: Ia donna ha Iingua di serenle, con cui
andando in giro morde e avveIena gIi aIlri, 2) Ia cecila: neIIa raffigurazione giollesca
Ia Iingua-serenle deIIa donna lorna indielro e Ie morde gIi occhi accecandoIa. Che si
lralli di accecamenlo e messo fuori dubbio daIIa didascaIia che e sollo Ia figura:
IATIT HIC INVIDIAI CICAI ..., 3) Ia grande allenzione aII'eslerno: queslo, e non
aIlro, significano gIi orecchi enormi che Ia figura giollesca resenla. GIi invidiosi circo-
Iano aI fine di udire e raccogIiere lulle Ie ossibiIi chiacchiere e rivoIlarIe in danno deI
rossimo, 4) Ia cuidigia e Ia raacila di sarvieri: a queslo aIIudono Ia mano sinislra,
con cui madonna Invidia slringe una borsa (carica evidenlemenle di quallrini o rezio-
si), e Ia deslra. Quesl'uIlima e a zama, e fuoriesce (anche iu deIIa Iingua) daIIa Iinea
verlicaIe deI rellangoIo in cui Ia figura e accamala, iI oIIice e drillo in orizzonlaIe e Ie
aIlre quallro dila fanno arco, rorio a mo' di arligIio. Si veda anche iI rofiIo aggressi-
vo deIIa lesla, che e lulla soslala in avanli risello aII'asse cenlraIe deI riquadro, 5) Ie
fiamme che Ia allaccano daI basso, a cominciare dai laIIoni. La generaIila degIi sludiosi
afferma, e con ogni sicurezza, che Giollo ha voIulo aIIudere aIIe fiamme deII'Inferno
neIIe quaIi gIi Invidiosi saranno unili. Ma basla una semIice domanda er accorgersi
che cos non e: forse che soIo gIi invidiosi, e non anche lulli gIi incorsi in vizi cailaIi,
andranno neI fuoco elerno` Ierche aIIora Giollo non ha revislo fiamme anche er Ie
aIlre figure che raresenlano laIi vizi` Ne consegue che a quesle fiamme bisogna dare
una diversa inlerrelazione: non sono queIIe deII'Inferno, ma Ie slesse che secondo i
Iadri deIIa Chiesa e secondo Danle riardono coIui che in tiia e affello daII'Invidia. I
queI che si Iegge in Purgaicric XIV, 82, a roosilo deI enilenle Guido deI Duca: Iu iI
sangue mio d'inti!ia si riarsc |.j. Si ricordi anche I'invidia che infiammo Ii animi
lulli dei corligiani di Iederico II conlro Iier deIIa Vigna (|nj. XIII, 67).
61 Si dara erlanlo iI maiuscoIo, Oisccr!ia, siccome ersonificazione, a queIIa che ha
lanlo assaIilo Iirenze (|nj. VI, 61).
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 531
!ia), e con Ia forza che aIIa aroIa viene daII'eccezionaIila deII'uso.
Non uo essere un caso, infalli, che ccnccr!ia comaia qui er Ia rima
voIla, e neI Ioema abbia soIo un'aIlra ricorrenza, non riva di oIili-
cila, ad onla deII'aarenza lulla rivala. L'imiego riguarda iI
raorlo coniugaIe di Irancesco con Madonna Ioverla: La Ior ccn-
ccr!ia, i Ior Iieli sembianli. (Par. XI, 76). Da qui Lorenzelli, oIlre che
daIIa lrallalislica in maleria, uo aver ricevulo un incenlivo a regislra-
re gIi sosaIizi, neIIa arele conligua deIIa SaIa dei Nove, lra gIi effelli
deI buon governo, significando I'idea neIIa giovane donna incoronala
che va a nozze su un cavaIIo bianco. Ce ne ossiamo giovare, erlan-
lo, anche er una iu recisa inleIIigenza di aIcune cose danlesche di
cui non s'e coIlo aieno iI significalo. RisuIlera iu ricevibiIe, ad
esemio, Ia quaIificazione che accomagna I'cpra
62
deII'aIlro famoso
ConsigIiere deIIa Ccnnc!ia, Romeo di ViIIanova, dirimellaio dice-
vamo di SordeIIo e di Ciacco: grande e beIIa essa fu in quanlo rese
Ie quallro figIie di Raimondo eringhieri aIlrellanle sose e regine
(Par. VI, 133-135). Noi oggi oco Iodiamo in laIi induslrie, e meno an-
cora neII'uomo di corle che Ie cura: egIi ci si rofiIa aena come un
abiIe e oco esaIlanle mezzano. Ma i conlralli malrimoniaIi a quei
lemi significavano lanlo di iu, di bene e di megIio: Ia concordia e Ia
ace, in quanlo univano famigIie, arli oIiliche, signorie e regni. Lo
slesso Marco Lombardo lrallava Io abbiamo senlilo da envenulo
oIlre che ccnccr!ias, paccs. ci ccnjc!craiicncs, anche ajjiniiaics: vaIe a
dire marilaggi. AIIora si siega megIio oIlre che iI cadere di Danle
come ncric ccrpc dinanzi aIIe Iacrime d'un paciarc mancalo, quaIe fu
IaoIo MaIalesla a Iirenze e in alria, dove rue fede aI allo malri-
moniaIe (come Ie quallro regine addilale neIIo slesso canlo, iI V
deII'|njcrnc) iI fallo che Cacciaguida condanni con lanla durezza
GuaIdrada Donali. A causa dei suoi anlinuziaIi ccnjcrii (vocaboIo che,
si sa, vuoI dire consigIi) Ia Iirenze che si siata in pacc (come racconla
Cacciaguida) erdelle ogni lranquiIIila: o uondeImonle, quanlo maI
fuggisli / Ie nozze sue er Ii aIlrui ccnjcrii (Par. XVI, 139-140). Nean-
che uo deslare meravigIia, in chi ermanga su quesla scia
inlerrelaliva, iI fallo che Danle menzioni er bocca di Iacoo Rusli-
cucci (oIilico anch'egIi, si ricordi) una donna, Ia |ucna Gua|!ra!a
(buona, evidenlemenle, erche animala da voIonla di ace) di cui e
niole Guido Guerra, uguaImenle inlrigalo coI ConsigIio: e cio ro-
rio neI canlo XVI deII'|njcrnc. Quesla simmelria basala suI numero
sedici, consiIiare er ecceIIenza, e da considerare lra queIIe nolabiIi
deIIa Ccnnc!ia.
62 QuaIe accanirsi lerminoIogico, queIIo di Danle!
Mario Aversano 532
3. S'e reso allo che Giuslizia e messa aI cenlro deI Ioema, neI XVI
deI Purgaicric, insieme con Saienza, Iace e Concordia. I s'e anche
vislo che Ccnccr!ia in Lorenzelli consegna Ia fune da lirare in drillo ai
venliquallro Savi-ConsigIieri. Rimane da moslrare come laIe via orli
aIIa scoerla che Ia definizione deIIa Concordia dala daI verseggialore
deIIa SaIa deIIa Iace e rorio queIIa fissala da Danle: in voIgare neI
XVI deI Purgaicric, in Ialino neIIa Mcnarcnia. Occorre, darinciio,
che ci si imegni a moderare Ia sicurezza con cui gIi inlerreli deI di-
inlo senese individuano Ia virlu di cui redica Ia rima
63
didascaIia,
QUISTA SANTA VIRTU. Tulli affermano, mai sfiorali da dubbi, che si
lralla di Giusiizia. Ci sono invece seri molivi er rilenere che laIe virlu
sia iulloslo Ccnccr!ia. Riorliamo iI leslo er inlero:
QUISTA SANTA VIRTU LADOVI RIGGI.INDUCI AD
UNITA, LIANIMI MOLTI.IQUISTI ACCIO RICOLTI.UN
IN COMUN IIRLOR SIGNOR SI IANNO.LOQUAL I(IR)
GOVIRNAR SUO STATO ILIGGI.DINO(N)TINIR GIAM-
(M)A GLIOCHI RIVOLTI.DALO SILINDOR DIVOLTI.DILI
VIRTU CHITORNO ALLUI SISTANNO.I(I)R QUISTO
CONTRIUNIO ALLUI SIDANNO.CINSI TRIUTI ISIGNO-
RII DITIRRI.IIR QUISTO SINCA GUIRRI.SIGUITA IOI
OGNI CIVILI IIIITTO.UTILI NICISSARIO IDIDILITTO.
A me sembra referibiIe ragionare in queslo modo: se gIi anini
nc|ii sono queIIi dei Venliquallro, come deI reslo i iu rilengono,
non si vede erche a indurIi a unila debba essere Giusiizia che e
aI iano sueriore, e dunque anche saziaImenle iu Ionlana daIIa
didascaIia e non iulloslo Ccnccr!ia, che e Ia figura iu vicina ad
essi, e che iu direllamenle Ii imegna. I infalli Concordia, e non
Giuslizia, che assa Ioro Ia corda e Ii fa marciare in ordine, come
in un corleo sacro. GIi anini di cosloro, cioe i Ioro voIeri, ridolli ad
unila, e indirizzali a un soIo fine, si fanno er signore un |cn ccnun,
che e rorio iI ccnnunc |cnun di Mcn. II, V, 2: cuiusIibel solielalis
finis esl comune soliorum bonum. Tullo queslo e figuralo neII'ince-
dere dei Venliquallro che in fiIa er due recano Ia fune aI Reggenle, iI
quaIe deI ene Comune e er cos dire iI braccio, coIui che Io reaIizza.
A fare da sia deIIa convenienza di laIe siegazione concorre in modo
seciaIe iI vocaboIo uniia, e infalli Io slesso che lradizionaImenle defi-
nisce Ia concordia, e che Danle riorla in Mcn. I, XI, 5: Isl enim
concordia uniformis molus Iurium voIunlalum, in qua quidem
63 TaIe e concordemenle rilenula.
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 533
ralione aarel uniiaicn voIunlalum. I si veda Ia concidenza deI nc|-
ii coI p|uriun: aIIa cui base e Ia bibIica nu|iiiu!c dei saienli che
consigIiano iI re, e dai quaIi diende Ia saIvezza deII'orbe: nu|iiiu!c
aulem saienlium sanilas esl orbis lerrarum, el rex saiens slabiIi-
menlum ouIi esl (Sap. VI, 26). Si veda anche er Ia IuraIila e
er iI muoversi concorde dei venliquallro Io homines p|urcs e iI
sinu| nctcri di Mcn. I, XV, 6: ila homines p|urcs 'concordes' dicimus
roler sinu| nctcri secundum veIIe ad unum quo esl formaIiler in
suis voIunlalibus. DeI lullo naluraIe e secondo regoIa e crilerio, aIIo-
ra, va slimalo iI rilorno neI canlo XVI deI Purgaicric di queslo concello
deIIa concordia, come unila di voIeri neIIa parc|a e neI nc!c, imIican-
le Ia musica (cuori e corde vocaIi)
64
: una aroIa in lulle era ed un
modo, / s che area lra esse ogne ccnccr!ia (Purg. XVI, 20-21)
65
.
Si uo aggiungere, er I'idenlificazione deIIa sania tiriu con Ia
Concordia, che se cos non fosse dovremmo ammellere e non sareb-
be oi faciIe darne conlo che I'affresco conlenga non una, ma due
iscrizioni dedicale aIIa Giuslizia, ad essa infalli cerlamenle si riferisce
queIIa che comincia con VOLGIITI GLIOCCHI, cui adiremo lra oco.
Irima e bene cavare lullo iI ossibiIe daIIa riIevazione deI danlismo
in cui orbila Ia Concordia Iorenzelliana (neIIa grammalica figuraIe
come in queIIa verbaIe), e daIIa cIassificazione consiIiare dei Venli-
quallro. SuI unlo non e mancalo, invero, chi ha indollo i venliquallro
seniori danleschi, che simboIeggiano i Libri deII'Anlico Teslamenlo,
cio anche erche Ia coincidenza, oIlre che neI numero, e neI nc!us
cun!i: gIi uni e gIi aIlri rocedono a !uc a !uc (Purg. XXI, 83-84). Ma
non si e ancora aIIegalo, ch'io saia, un incrocio con Danle che non
e meno significalivo, erche ci sosla daI saere riveIalo a queIIo
umano (e cos suffraga uIleriormenle Ia noslra roosla che Lorenzelli
abbia voIulo raffigurare venliquallro savi-consigIieri imegnali neI
governo deIIa cilla): venliquallro di numero sono anche i Saienli che
lroviamo neI CieIo deI SoIe, che e iI CieIo deIIa Saienza aunlo.
Non si dimenlichi che neII'affresco deIIa Iace iI lullo e sovraslalo daI
64 Cfr., er queslo lema, IRUGONI, Una |cniana ciiia, cil., . 147-148.
65 AIlra comunanza con Danle e forse neIIa aroIa effello: che ci invia da un Ialo
aII'cjjciic noI nasconde di Purg. VI, 138 (recedulo com'esso e daIIa nominazione deIIa
ace e deI senno che non ci sono iu neIIa Iirenze diIaniala daIIa guerra civiIe),
daII'aIlro aII'cjjciic fu deI suo consigIio di Par. XX, 41, riferilo aI |cn jarc di Davide. Ma
a queslo canlo danlesco che dovelle avere una immediala e Iarga risonanza vivenle
ancora iI oela e riorlabiIe anche aIlro Iessico deI ezzo di Lorenzelli: 1) DISIRTO:
che 'I giardin de Io 'merio fia !iscric (v. 105), 2) SOSIITTO: coIor gia lrisli, e quesli
con scspciii (v. 108), 3) SCURI: e vedrai Sanlafior com'e cscura: iI che eraIlro gioca
conlro Ie varianli sicura e si cura ove si consideri che a Siena ci invia iI Saniajicr deI verso
danlesco.
Mario Aversano 534
SoIe, e che su Carila occhieggia iI voIlo saienle deI IigIio, iI quaIe
anche a mo' di soIe irraggia. Le anime deI CieIo danlesco sono caralle-
rizzale e non sfugga Ia regnanza deI dalo, reeribiIe in lulli e
cinque i canli che ne lrallano (Par. IX-XIII) daII'essere in ogni cosa
concordi, d'una concordia alliva (cfr. aImeno iI ccnccr!i nuni di Par.
XIII, 31). Cerlo, iI Ioro molo si esIica in senso non relliIineo (come e
invece queIIo dei Venliquallro di Ambrogio), ma circoIare, inlorno a
Danle e a ealrice, ma queslo non comorla Ia canceIIazione deIIa
duaIila, e deI suo significalo aIIegorico: Ie corone di anime sono due,
di dodici ciascuna. II due ho fallo nolare aIlra voIla neIIa numero-
Iogia bibIico-alrislica (che Danle receisce semre di buon grado)
designa Ia Carila
66
: carila di alria, neI noslro caso. I oi nuIIa viela di
ensare che i Venliquallro deIIa SaIa deIIa Iace, consegnala Ia corda aI
reggenle, gIi ruolino aIfine inlorno: come suggerisce, vedremo subilo,
quaIche inlerrele ollocenlesco
67
, e come eraIlro fanno i comonenli
deIIa rocessione danlesca inlorno aII'aIbero deIIa giuslizia (Purg.
XXXII, 46).
Saienli-ConsigIieri, dunque, i Venliquallro Iorenzelliani. Ier essi
da uIlimo va fallo conlo che sono coIIegabiIi coI ConsigIio er un aIlro
asello, che imIica rorio Ie vicende di Siena: neI ConciIio di Imo-
Ii, doo Monlaerli, furono I Venliquallro a riunirsi, er decidere
deIIa sorle di Iirenze, e in queIIa circoslanza si sa quanlo gravi furono
Ie discordie lra i convenuli, e secie lra i danleschi Iarinala e Iroven-
zan SaIvani. Con queslo richiamo si comrenderebbe megIio Ia gran
remura e cura di Lorenzelli neI rilrarre e far marciare in beIIa con-
cordia i suoi Venliquallro: e un ossequio-omaggio a Danle, oela deIIa
Concordia, che savio e consigIiere fu e voIIe essere non bisogna slan-
carsi di dirIo neIIe cilla e neIIe corli, anche Ie iu aIle: con asi-
razione a divenir laIe in queIIa slessa deII'Imeralore.
4. I qui e lemo di informare che quaIcuno accoIse (bisognera a-
urare donde e come) e ridelle molo aIIa lesi che fra quei Venliquallro
Ambrogio abbia inserilo anche Danle, rilraendoIo di naluraIe.
Cos iI cilalo RanaIIi, di cui e uliIe e giuslo ricordare Ie aroIe
68
, er
I'inleIIello e iI cuore che egIi moslra neII'inlerrelazione grossa
66 Cfr. Ia nola a due di Par. XXV, 107 in AVIRSANO, Oanic !accapc, cil., . 44.
67 Cfr. IRANCISCO RANALLI, Sicria !c||c Bc||c Arii in |ia|ia, voI. unico, Iirenze, Socie-
la Idilrice Iiorenlina 1845, . 102: Ambrogio fece un venerando vecchio, cinlo di reaI
corona, er simboIeggiare iI reggimenlo di Siena, e inicrnc a! cssc rilrasse di naluraIe
venliquallro de' iu iIIuslri e benemerili uomini.
68 Rielule oi a! tcr|un daI RANDAZZI (Manua|c !anicscc, II, assano 1865, . 393),
in bibIiografia neIIa gia cil. |ncic|cpc!ia !anicsca, s. v. 'Ambrogio Lorenzelli'.
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 535
deII'oera e deIIa ersonaIila di Danle. Ier iI rofiIo di Ambrogio
Lorenzelli iI RanaIIi sende un'inlera agina, dove scrive, lra I'aIlro,
che finaImenle in queI che diinse neIIa maggior saIa deI IaIazzo di
Siena, s'accorsero che Io sludio deIIe Iellere e deIIa fiIosofia, ch'egIi
fece in giovenlu, Io aiulo gagIiardamenle er esrimere con maggiore
ingegno e saienza Ie grandi assioni. I concIudendo: Quanla di-
scordia non assaIiva in queI lemo Ie noslre rovincie! I Siena, non
meno deIIe aIlre cilla, grondava di sangue cilladinesco. VoIendo
adunque con visibiIe documenlo insegnare aIIa sua alria, che non
aIIe discordi e sciagurale moIliludini, ma ai ochi savi e virluosi cilla-
dini s'affidasse, fece un venerando vecchio, cinlo di reaI corona, er
simboIeggiare iI reggimenlo di Siena, e inlorno ad esso rilrasse di na-
luraIe venliquallro de' iu iIIuslri e benemerili uomini, fra' quaIi era
Danle AIighieri, come coIui, che, avendo megIio d'ogni aIlro, cono-
sciulo Ia maIa radice deIIe discordie d'IlaIia, see aIlres addilare iI
modo di sbarbarIa, in queI oema, che a ragione e slalo chiamalo, deI-
Ia relliludine, e come fu Ia maggiore e iu viva esressione di queI
secoIo, cos divenne secchio di vera civiIla ai secoIi a venire
69
.
Queslo brano invogIia non soIo a cercare lra queIIe dei Venliqual-
lro Ia faccia di Danle, ma anche a lenlare di individuarne quaIche
aIlra, aImeno Ie rime e iu vicine aI Reggenle. Iolrebbero essere dei
Savi slorici (iIIuslri e benemerili uomini), che abbiano avulo di
che sarlire con Siena: runello Lalini, er esemio, iI quaIe neI lerzo
Iibro deI Trcscr giunge ad uliIizzare documenli ufficiaIi deI comune
di Siena
70
. La memoria va anche a Iielro Sano, che a Siena insegno
medicina e lenne uno sludio, egIi e si ricordi I'unico Ionlefice
(Giovanni XXI) deI suo lemo che Danle accogIie in Iaradiso, rorio
neI CieIo deI SoIe, enlro Ia seconda corona dei Saienli (Par. XII, 134).
Ma c'e di iu. II suo imegno non si conlenne negIi orli confessionaIi,
reoccualo com'egIi fu semre di mellere ace lra i regnanli
d'Iuroa (ad esemio lra aIcuni di queIIi che inconlriamo neIIa VaIIel-
la dei Irincii: RodoIfo di Asburgo e CarIo d'Angio, AIfonso X di
CasligIia e IiIio III di Irancia). NeIIo slesso sirilo Iielro diffuse
ArisloleIe, e er Ia definizione deIIa Concordia che abbiamo lrovalo
neIIa Mcnarcnia a ragione si fa nolare che Danle ha innanzi anche iI
ca. III, 34 deI suo manuaIe, Ie sunnu|ac |cgica|cs. Quesla agnizione
farebbe eraIlro cadere un riIievo mosso da iu arli: che Lorenzelli
non abbia dalo oslo in quesli suoi affreschi ad aIcun reIigioso.
runello Lalini e Iielro Isano, aIIora, maeslri oIilici di Danle:
69 Cfr. RANALLI, Sicria !c||c Bc||c Arii in |ia|ia, cil., .102.
70 SIGRI, Ic jcrnc c |c ira!izicni !i!aiiicnc, in Grun!iss !cr rcnancscncn Iiicraiurcn !cs
Miiic|a|icrs, IV, 1, HeideIberg 1968, . 138.
Mario Aversano 536
secie se si da credilo a chi sosella che di Iielro egIi frequenlo Io
sludio. Iolrebbero essere i rimi due deIIa rocessione. Ma e meno
che un'iolesi, e c'e deI ragionevoIe, in fondo, soIo er iI lerzo erso-
naggio, che dovrebbe essere Danle. Ianno da segni di riconoscimenlo
oIlre aI rofiIo, che e conforme in lullo a queIIo ervenuloci daIIa
lradizione (secie er I'arco deI naso), secondo Ie indicazioni fisiono-
miche consegnaleci daI occaccio, magari correlle con Ie uIlime
rosezioni somaliche effelluale daIIa scienza iI suo lendere gIi oc-
chi, che sono i iu isirali e seranzosi, verso iI Reggenle (fig. 1). Ne si
uo disconoscere che, fra lulli i ersonaggi, queIIo che noi sacciamo
er Danle aare iI iu visloso, quasi che su di Iui I'arlisla abbia
voIulo far convergere di iu I'allenzione di chi guarda. Isso infalli: 1)
e I'unico a indossare una manleIIina, e bianca (iI coIore che simboIeg-
gia Ia Giuslizia, come si deduce anche daI suo occorrere nei canli deI
Para!isc che Ia ceIebrano, secie iI XVIII)
71
: dislinlivo di grande resli-
gio, come che se ne vogIia quaIificare Ia sloffa e iI suo embIemalismo
72
,
2) soIo in queslo unlo Ia corda fuoriesce con moIla visibiIila daI
mezzo deIIa fiIa in cui e lenula daIIa mano degIi andanli in coia, Ia
sinislra degIi uni, Ia deslra degIi aIlri, 3) Ia corda aare anche iu
esibila Ia dove cinge iI braccio di coIui che indichiamo come
Danle, caIa giu, assa lra I'indice e iI medio deIIa sua mano, e risaIe a
coinvoIgere Ia figura che sla davanli, 4) queIIa che segue Danle, oi,
ammicca a chi gIi sla a Ialo e unla innanzi oIIice, indice e medio
deIIa deslra, a conlare lre (fig. 1), e come se dicesse aI comagno: coIui
che ci recede ha da fare coI numero lre, 5) iI lre olrebbe indicare Ie
71 Riorlo qui Ia nola che aosi a |ianca !cnna (Par. XXVIII, 65), in Oanic !accapc,
cil.: sinlagma regnanle, sorallullo er I'aggellivo, che ricaIca iI can!csccrc deI modeI-
Io, come moslra I'induzione deI soslanlivo can!cr lre versi doo. N'esce diIalalo iI lema
deIIa giuslizia, solleso neIIo slesso racconlo di Ovidio, che Ia one in anlilesi con Ia
suerbia |.j. Non sfugga ero come iI leslo ago sia assalo er queIIo sacro, in
modo che iI coIore bianco venga a delerminarsi come queIIo reciuo deIIa giuslizia
quaIe e venliIala neIIe Scrillure. II bianco, infalli, in quanlo designa Ia urezza deIIa
coscienza indisensabiIe er esercilare Ia giuslizia, e I'assenza di nacu|a !crrcrc come
da Ccnt. II, XIII, 27: 'I Io cieIo di Giove (queIIo deIIa Giuslizia aunlo) si uo coma-
rare aIIa Geomelria |.j. La Geomelria e |iancnissina in quanlo e sanza nacu|a !crrcrc
|.j' cosliluisce un molivo che e da riorlare in rimo Iuogo ad Apcc. VII, 9: 'Iosl haec
vidi lurbam magnam |.j slanles anle lronum, el in conseclu Agni, amicli sic|is a||is'
Ier I'acquisizione che ne fa Danle basli ricordare come neII'Imireo i Giusli indossino
|iancnc sic|c (Par. XXX, 129). Ma qui I'equazione candoregiuslizia e suggerila sorallul-
lo da un saImo di Davide, Io slesso che forma I'inlerleslo di quesla arle deI canlo |.j:
'Dum discernil ceIeslis reges suer eam, nive deaIbabunlur in SeImon' (Ps. LXVII, 15).
72 Cfr. er queslo IRUGONI, Ic !cccrazicni nura|i ccnc icsiincnianza !i unc Siaius
Sqn|c|, in Un aIazzo, una cilla: iI aIazzo Lanfranchi di Iisa, Iacini Idilore, . 143:
II vaio |.j era iI segno che conlraddislingueva Ia cIasse dei dolli e dei nobiIi.
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 537
lre Canliche deIIa Ccnnc!ia, o i lre Regni che vi sono raresenlali,
6) Ia mano deI releso Danle, insieme aIIa corda, slringe anche un
fazzoIello: cos come queIIa di chi Io recede (dove ero Ia corda non
si vede), 7) iI fazzoIello lornera neII'affresco degIi |jjciii !c| Bucn
Gctcrnc, in mano aIIe danzalrici, che con esso si uniscono e si dislac-
cano er oi riunirsi, semre in ordine rilmico, 8) iI fazzoIello designa
iI allo di concordia e I'armonia quaIe vige neIIa erfezione deI nume-
ro e neII'essenza deIIa Musica e deII'Amore, e dunque e simboIo
conlrario aIIa discordia e aIIa divisione: d'amore e d'accordo, si dice
anche oggi
73
.
5. Iresenza affine aIIa !riiia ccr!a, dunque, iI fazzoIello. II lema
deIIa fune si sviIua gia in un asso deI Tcscrciic che e da moIli cilalo
come una deIIe fonli di Lorenzelli: I'uomo nasce rim(e)ramenle / aI
adre e a' arenli, / e oi aI suo Comuno, / ond'io non so nessuno /
ch'io voIesse vedere / Ia mia cillade avere / deI lullo a Ia sua guisa, /
ne che fosse in divisa, / ma lulli er comune / lirasero una fune / di
ace e di benfare, / che gia non uo scamare / lerra rolla di arle
(vv. 166-179).
II |cnjarc, naluraImenle, rinvia come semre in runello
aII'ufficio resligioso deI ConsigIiere
74
. Quesla Iinea, allraverso Danle,
73 Dio secondo i leorici medievaIi creo iI mondo unendone Ie arli (si ricordi
Par. XXXIII, 86: Iegalo con amore in un voIume), che ermangono insieme aI segno
deIIa erfella armonia musicaIe. I iI fazzoIello come Iegame d'amore e lema anlico, che
giunge come e nolo fino aII'Oic||c di Verdi (Iibrello di A. oilo): iI fazzoIello ch'io Ie
diedi, egno rimo d'amor.
74 Ma iI asso che cilo daII'ed. di Irancesco Mazzoni (AIignano 1967) olrebbe
anche orienlarci er una iu robabiIe chiosa deIIa ccnunc na!rc di Purg. XI, 63, di cui
arIa Omberlo AIdobrandesco, nobiIuomo moIlo inlrigalo coI Comune di Siena. NeIIo
slesso canlo un aIlro senese, Irovenzan SaIvani, dice che fu resunluoso / a recar Siena
lulla a Ie sue mani (vv. 122-123). L'uIlimo verso, a ensarci, Danle (che ben conosce iI
Tcscrciic) uo averIo vergalo guardando aI dislico Ia mia cillade avere / deI lullo a Ia
sua guisa. Di conseguenza sorge iI dubbio che Ia ccnunc na!rc non sia ne Iva, ne Ia
lerra (secondo che vorrebbero Ie nole lradizionaIi), ma Ia roria alria, iI Comune di
Siena. Ci indirizza in laI senso I'affermazione che I'uomo nasce rim(e)ramenle / aI
adre e a' arenli, / e oi aI suo Comuno. Ad avaIIare una laIe siegazione congiura Ia
slalislica: neIIa Ccnnc!ia iI lermine "comune" e imiegalo soIo cinque voIle, e richiama
semre iI ConsigIio o Ia cilla di Siena. II ccnun rincaIzo di |nj. XXIX, 97, infalli, imIi-
ca AIbero da Siena, e Ia morle ccnunc di |nj. XIII, 66 sla in bocca a un ConsigIiere, Iier
de Ia Vigna, coi ConsigIi ha oi a che fare Io ccnunc incarco di Purg. VI, 133. Quanlo
aII'uIlimo dei cinque imieghi, segnalo daII'obiello ccnun di Purg. XXIX, 47, non vaIe
lanlo iI fallo che esso ricorra Ia dove e raresenlala I'avanguardia deIIa rocessione
che accogIie i venliquallro seniori, quanlo queIIo che iI sinlagma roone iI lema
deII'ingannc dei sensi, e di conseguenza deIIa sueriorila deIIa ragione: che e caIeslala
da quanli arIano e agiscono con ira, in modo besliaIe. Id e cio che er runello come
Mario Aversano 538
giunge aI ben oerare che si Iegge neIIa didascaIia VOLGIITI
GLIOCCHI, dove sicuramenle e rilralla Ia Giuslizia:
VOLGIITI GLIOCCHI ARIMIRAR COSTII.VOCHI RIG-
GIITI CHI QUI IIGURATA.I I(IR) SUI CIILLI(N) CIA
CORONATA.LAQUAL SI(MIRA) CIASCUN SUO DRITTO
RINDI.GUARDATI QUANTI IN VINGAN DA LII.ICO-
MI I DOLCI VITA IRIIOSATA.QUILLA DILA CITTA DUI
SIRVATA.QUISTA VI(R)TU KIIIU DALTRA RISIRI(N)-
DI.ILLA GUARD(A) I DIIINDI.CHILII ONORA I LOR
NUTRICA I IASCII.DA LA SUO LUCII NASCII.IL MI-
RITAR COLOR COIIRAN INI. I AGLINIQUI DAR DIITI
IINI.
La concordanza con Danle qui e soslenibiIe oIlre che er iI Vci cnc
rcggcic e er I'oerare bene gia visli (in roosilo si uo aggiungere
iI |cnc cpcran!c di Par. XVIII, 59, non foss'aIlro erche ricorre in uno
dei canli deIIa Giuslizia) anche er Ia vila !c|cc e ripcsaia deIIa cilla
in cui regna Ia giuslizia. Viene in menle ed e slalo gia nolalo Ia Iio-
renza anlica dove nacque Cacciaguida: A cos ripcsaic, a cos beIIo /
viver di ciiia!ini, a cos fida / ciiia!inanza, a cos !c|cc osleIIo. (Par.
XV, 130 sgg.). I forse c'e anche un raorlo lra I(IR) SUI CIILLI(N) CIA
CORONATA, dello di una donna aIIegorica, IUSTITIA, e iI er sua ecceI-
Ienza manifesla di Ccnt. III, I, che quaIifica una crealura non meno
aIIegorica, Ia !cnna gcnii|c. Ma sorallullo lorna a rofiIarsi come in-
lerleslo iI canlo XVI deI Purgaicric. II NUTRICA I IASCII, infalli, e
riorlabiIe aI Iinguaggio di Marco Lombardo, e recisamenle ricaIche-
rebbe gIi emislichi |cn si ncirica (v. 78) e !i quc| si pascc (v. 102), quando
Ii si congiungesse. D'aIlra arle anche neI VOLGIITI GLIOCCHI ARIMI-
RAR COSTII olrebbe esserci un'eco danlesca, e non soIo daI sonello
VoIgele gIi occhi a veder chi mi lira (rugnoIo), dacche Io sliIema e
correnle neIIa Ccnnc!ia: si veda aImeno iI roemiaIe mi voIsi a relro
a rimirar Io asso. AnaIogamenle si uo lrovare un che di danlesco
neI rimo verso deIIa lerza ed uIlima slrofa in |cnc:
SINCA IAURA OGNUOM IRANCO CAMINI.ILAVO-
RANDO SIMINI CIASCUNO. MINTRI CHI TAL COMU-
er Danle, e oi anche er Lorenzelli fanno i callivi ConsigIieri, che non amano ne
cercano Ia verila, e si moslrano soIIecili soIo di onori e guadagni immediali: nemici deIIa
concordia e deI vivere quielo, e ronli semre aII'ingannc (lermine, s'e vislo, di una
deIIe didascaIie) e aII'ingiuslizia. Issi conforlano i liranni, non i buoni reggilori, che, in
quanlo laIi, aIlri invili non ascoIlano se non a bene oerare.
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 539
NO.MANTIRRA QUISTA DON(N)A IN SIGNORIA.CHIL
ALIVATA ARII OGNI ALIA
I richiamabiIe ancora iI canlo XVI deI Purgaicric, che aI verso 118
dice: Or uo sicuramenle ivi assarsi
75
, e oi consideralo che neI
Callivo Governo di Lorenzelli domina Ia figura deI Tiranno, e che Ie
aroIe di Danle sono rivoIle a un ConsigIiere, Guido da MonlefeIlro
anche I'aggellivo jrancc: lra lirannia si vive e slalo jrancc (|nj. XXVII,
54)
76
. Iarimenli filla e Ia serie dei danlismi censibiIi neIIe lre slrofe in
na|c, inserile neII'affresco deI Callivo Governo. Quesla Ia rima:
LADOVI STA LIGATA LA IUSTITIA.NISSUNO ALI(N)
COMUNI GIAMAY SACORDA.NI TIRA ADRITTA COR-
DA.I(I)R O CONVII(N) CHI TIRANNIA SORMONTI.LA
QUAL I(I)R ADIMIIR LA SUA NIQUITIA.NULLO VOLIR
NI OI(IR)AR DISCORDIA.DALLA NATURA LORDA.DI
VITII CHI CO(N) LII SON QUI CO(N)GIONTI.QUISTA
CACCIA COLOR CALIN SON IRONTI.I CHIAMA A SI
CIASCUN CAMALI I(N)TINDI.QUISTA SIMIRI DIIIN-
DI.CHI SIORCA O ROA O CHI ODIASSI IACI.UNDI
OGNITIRRA SUA I(N) CULTA GIACI.
La iu evidenle deIIe uguagIianze e lulli I'hanno schedala e lra
iI CONVII(N) CHI TIRANNIA SORMONTI e iI ccnticn cnc.I'aIlra scrncnii
di |nj. VI, 67-68: iI canlo (oIilico) di Ciacco e deIIe domande e ri-
sosle su Iirenze e Ia giuslizia. A quesla coincidenza cenlraIe fanno
da aIone queIIe di IUSTITIA-giusic (v. 62), DISCORDIA-!isccr!ia (v. 63),
LORDA-|cr!c (v. 31), CACCIA-cacccra (v. 66). Si e oi anche nolalo (ru-
gnoIo) Ia corrisondenza deIIe rime SACORDA-CORDA-LORDA con Ie
uguaIi (|cr!a-sacccr!a-ccr!a) di Purg. VII, 110-114, e di conforlo, ag-
giungo io, iI fallo che esse imegnano iI ConsigIiere SordeIIo e aIcuni
Reggenli acificali neIIa vaIIella dei Irincii. Si uo anche rilenere
ed e conlallo non censilo, a mia nolizia che iI CAMALI I(N)TINDI uo
75 Verso, queslo, che robabiImenle ha suggerilo anche Ia seconda iscrizione deI
Callivo Governo: UNDI I(IR) QUISTA VIA.NO(N) IASSA ALCUN SI(N)CA DU-
IO DIMORTI.
76 Ier danlesco aIcuni fanno assare anche Io in signcria: ma neI caso e megIio ar-
Iare di inlerdiscorsivila. II unlo deboIe che moslrano i censimenli finora condolli sui
danlismi deIIe didascaIie deIIa SaIa deIIa Iace e iI Ioro carallere eisodico, e oco or-
ganico. Non si arle, cioe, da una visione generaIe, ne si ersegue I'individuazione deIIe
basi ideoIogiche e deIIe lemaliche di fondo deII'oera di Lorenzelli comarala a queIIa
danlesca, e cos non viene a gaIIa Ia coincidenza iena deI sislema vaIoriaIe che ne cosli-
luisce I'asse orlanle.
Mario Aversano 540
essere scalurilo er oosizione (slanle I'omoIogia lemalica e Ia com-
onenle aulobiografica deII'esiIio) daI bonum commune inicn!issc
dicendi sunl di Mcn. II, V, 8, riferilo aII'amore deI bene ubbIico de-
gIi iIIuslri Romani.
Ma oIlremodo significalivi aaiono e di queslo neanche c'e
slala riIevazione due incroci che riguardano risellivamenle iI ler-
mine NIQUITIA e I'emislichio CALIN SON IRONTI. Sembra erfino che
non ossiamo giungere aIIa comrensione deI Ioro reaIe significalo se
non azionando Ie Ieve deIIa scnicsi c|||igaia. Quesla mia leoresi imo-
ne di lrovare e raffronlare gIi imieghi di ncquizia neIIa Ccnnc!ia.
Obbedendo, noi rendiamo allo che iI Ioro numero e minimo. Sono
soIlanlo lre, e semre in rima con giusiizia: a Par. IV, 69, dove iI ncqui-
zia e quaIificalo con I'eresia, a Par. VI, 123, dove e ooslo aIIa
concordia e aII'armonia dei eali, e infine a Par. XV, 142, dove e riferi-
lo a Cacciaguida e aIIa |cggc dei Maomellani che rocura a Iui morle e
gIoria, coI conseguimenlo deIIa pacc ceIesle. ConcIusione: in Danle
ncquizia e semre oosla a giusiizia e semre allrae iI concello di di-
visione (che comorla assenza di concordia e di ace), sia essa queIIa
degIi erelici (I'crciica ncquizia), o degIi scismalici di Maomello (|nj.
XXVIII, 35: seminalor di scandaIo e di scisma), o deIIe anime senza
ace deII'Inferno conlraosle a queIIe deI Iaradiso, concordi e aci-
ficale lra Ioro e con Dio. Insorge ercio I'obbIigo di inlendere iI
NIQUITIA di Lorenzelli non come ancora avviene neI significalo
generico di maIvagila, ma neII'accezione oIilica deIIa divisione-
discordia-guerra: i iiiu|i che si lrovano neII'affresco in na|c deIIa Ti-
rannia e dei suoi effelli.
A fronle di laIi coincidenze, er un allimo ci sorrendiamo a
immaginare che Ambrogio abbia conosciulo di ersona Danle e che
da Iui abbia moIlo udilo e oslo in menle: magari in comagnia di
Simone Marlini. Ma oi iI QUANDO IARLA IIGGIO IIIU LODATO,
visibiIe enlro Ia cilala risosla di Maria Vergine neIIa Macsia deI Gran
ConsigIio, davvero non e comrensibiIe (sibiIIino ancora Io si giudica)
senza iI risconlro deIIa mediazione che Io ha fallo nascere: deI
memorabiIe un MarceI divenla / ogne viIIan che arleggiando viene
(Purg. VI, 125-126). Si e gia vedulo come esso faccia cao ai moIlo
arIanli sanza saienza di runello, e non e difficiIe ammellere che
sia ben reslo corso in giro, divenendo roverbiaIe rima in queI di
Siena (dove iI oela fu cerlamenle aII'indomani deIIa arlila da
Iirenze, di rilorno da Roma), e oi in lulla IlaIia, fin daI secondo
decennio deI Trecenlo, se non anche rima. Quesla, naluraImenle, e
fanlasia, ma che riaffiora Ie voIle che si ensa a come iI COLOR CALIN
SON IRONTI non moslri Ia sua reaIe carica semanlica se non quando e
Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a Pacc !i A. Icrcnzciii 541
messo in reIazione con un aIlro Iuogo danlesco. Tulli chiosano iI prcnii
con disosli, e cos ne dimezzano iI vaIore. Ier comrendere, infalli,
bisogna che si vada a Ccnt. I, VIII, 3, dove e insegnala Ia dislinzione
lra iI |cnc e iI prcnic |cnc: dare a uno e giovare a uno e |cnc, ma dare a
moIli e giovare a moIli e prcnic |cnc. Ierlanlo Ia ronlezza va
inlesa neII'accezione lecnica, che e ancora una voIla oIilica. In coIoro
che a| |cn scn prcnii vanno riconosciuli gIi oeralori deI bene ubbIico
(e non rivalo), e secie i ConsigIieri addelli a Iegiferare a laI fine:
onde vedemo Ii onilori de Ie Ieggi massimamenle ur a Ii iu
comuni beni lenere confissi Ii occhi, queIIe comonendo (ivi, 4). Di
qui forse diende anche deII'aIlro, reeribiIe neIIa didascaIia QUISTA
SANTA VIRTU. II bene comune, divenlalo signore degIi anini nc|ii,
eIegge di non lener gIi occhi giammai rivoIli (e dunque da lener
ccnjissi) daIIo sIendore dei voIli deIIe virlu che si slanno inlorno a Iui.
Da uIlimo: uo avere I'ascendenza in Danle anche I'allacco LADOVI
STA LIGATA LA IUSTITIA. I Ia densila fonica di LIGATA che deve guidar-
ci, fino a Purg. XIX, 121: Come avarizia (Ia slessa che cuImina neIIa
Tirannia) sense a ciascun bene (inlenderemo: rivalo e ubbIico) / Io
noslro amore, onde oerar (iI ben fare) erdesi / cos giusiizia qui slrel-
li ne lene / ne' iedi e ne Ie man |cgaii e resi. I Iegala iedi e mani
aare Ia donna che si lrova neIIa arle bassa deII'affresco deI MaI
Governo: figura che lanlo somigIia anche aII'immagine che deIIa Giu-
slizia e resa neIIa cilala canzone Trc !cnnc inicrnc a| ccr.
Ma e lemo di chiudere. Lo faccio nolando soIo aIlre oche cose
77
:
1) iI verso GUIRRI RAIINI TRADIMINTI IN GANNI uo derivare, iu che
da ogni aIlra fonle er esso indicala, da queIIa di Ccnt. I, XII, 10: Ia
ingiuslizia massimamenle e odiala, s come e ira!incnic, ingraliludine,
faIsilade, furlo, rapinc, ingannc e Ioro simiIi, 2) i denli come zanne
che carallerizzano, insieme agIi occhi lorli (forse arenli di queIIi di
Ciacco, che da !iriiii si mulano in |iccni) Ia faccia deIIa Tirannia sono
allribulo demoniaco, come si deduce da |nj. XXII, 55-56: I Ciriallo
78
,
a cui di bocca uscia / d'ogne arle una sanna come a orco / iI fe senlir
come I'una sdruscia. Lo sdrucire, suerfIuo dirIo, rimanda ancora
una voIla aIIa divisione-discordia che iI Tiranno oera lra i suddili.
Riceve conlinuo avaIIo, dunque, Ia lesi che lra Ia illura di Loren-
77 Da sommare ai risconlri che Ia crilica ha gia effellualo, dei quaIi iI iu acquisibiIe
riguarda I'immagine di |urcr. Issa s'e fallo nolare oorlunamenle (IRUGONI, Una
|cniana ciiia, cil., . 143) er essere mela beslia e mela uomo ricorda iI Minolauro
com'e schizzalo a |nj. XII, 11-13: dove simboIeggia aunlo I'ira besliaI, e, si deve ag-
giungere, er aver esso iI coro di cavaIIo, e simiIe anche ai cenlauri che fanno da
guardiani, neIIo slesso canlo, ai VioIenli.
78 Uno dei dieci diavoIi che lroviamo fra i barallieri (|nj. XXII, 122).
Mario Aversano 542
zelli e Ia Oitina Ccnnc!ia corrano Iegami di sangue. I che I'una e
I'aIlra vogIiono essere anche er Ia fede sincera neI dello deI SaImi-
sla: iuslilia el ax obscuIalae sunl (Ps. LXXXV, 11) un gri!c che
come tcnic
79
si Ieva daII'ingegno e daIIa cuIlura degIi uomini di buona
voIonla, a ercuolere Ie cime iu aIle: con I'unico fine di educare aIIa
giuslizia e aIIa ace.
|ia|ianisia, Sa|crnc
79 Sono Ie aroIe con cui in Par. XVII, 133 viene definila Ia oesia deIIa lerza Canli-
ca, se non di lullo iI Ioema.
MARIA CONCOLATO IALIRMO
LA IORTUNA DI DANTI IN INGHILTIRRA
NeII'affronlare un argomenlo moIlo amio e comIesso come
queIIo deIIa forluna di Danle in InghiIlerra, che one una serie di do-
mande reIalive ai lemi, ai modi e aIIa quaIila di quesla conoscenza,
sembra oorluno recisare che I'obiellivo di queslo inlervenlo e soIo
queIIo di offrire una camionalura di dali reIalivi sorallullo aIIa cuI-
lura brilannica, reslera fuori infalli da quesla noslra rifIessione Ia
cuIlura americana, nonche I'afro-americana, er ragioni eslrinseche e
non gia erche Ia forluna di Danle in quesle aIlre reaIla cuIluraIi sia di
minor inleresse. Un dalo er lulli: sono americani aIcuni dei iu viva-
ci cenlri di ricerca odierni su Danle. InoIlre, come ci ha ricordalo di
recenle Levis Walkins, resenlando Tnc Oanic C|u| (2003), iI romanzo
lhriIIer di Mallhev IearI che coinvoIge Ia rima lraduzione danlesca
in America di LongfeIIov: The Danle Sociely of America, of Cam-
bridge, Massachusells, boasls ilseIf lhe oIdesl conlinuous organizalion
in lhe vorId dedicaled lo lhe sludy and romolion of Danle
1
.
Se e ovviamenle indisensabiIe dislinguere Ia resenza e quindi Ia
conoscenza deI nome di un aulore daII'effelliva conoscenza e diffu-
sione deIIa sua oera, cio e lanlo iu vero neI caso di Danle AIighieri
neIIa reaIla cuIluraIe brilannica. S'inconlra sesso infalli neI Medioevo
e neI Rinascimenlo ingIese Ia menzione di una lriade 'Ielrarca, Danle
e occaccio', a cui viene in genere conlraosla una corrisondenle
lriade ingIese 'Chaucer, Gover, Lydgale', a cui oi seguira un'aIlra:
'Wyall, Surrey, SkeIlon', ed aIlre ancora. Ma noi saiamo che si
lralla, er Io iu, di un ncninis un|ra, deIIa rielizione di un icpcs a-
rodalo in InghiIlerra, rovenienle daIIa cuIlura ilaIiana, a cui er
moIlo lemo corrisonde una ben diversa conoscenza di quesli lre
aulori. A differenza di Ielrarca e di occaccio che non sono soIo noli,
ma anche Ielli, lradolli, falli rori neI Quallrocenlo e neI Cin-
quecenlo, Ia conoscenza di Danle e Ia resenza deIIa sua oera e effel-
livamenle moIlo scarsa neIIa cuIlura deI aese in quesli rimi due
1 La Danle Sociely of America |1881j di Cambridge, Massachusells, si vanla di es-
sere Ia iu anlica organizzazione aI mondo dedicala aIIo sludio e aIIa romozione deI
oela fiorenlino, in MATTHIW IIARL, Tnc Oanic C|u|, London, Vinlage 2004, . viii.
Maria ConcoIalo IaIermo 544
secoIi. Iossiamo subilo anliciare che laIe rimarra fino aIIa seconda
mela deI Sellecenlo o megIio ancora aI rimo Ollocenlo, momenlo
daI quaIe iniziera un effellivo amio inleresse er Danle e una sua
enelrazione, a diversi IiveIIi, semre iu caiIIare e diffusa
2
.
Mi sembra oorluno cilare una ballula di un ersonaggio
|onsoniano, Lady IoIilic:
AII our IngIish vrilers, / I mean such as are hay in lhe IlaIian, /
WiII deign lo sleaI oul of lhis aulhor, |sla arIando di allisla
Guarini, I'aulore deI Pasicr |i!cj mainIy: / AImosl as much as
from Monlagnie: / He has so modern and faciIe a vein, / filling
lhe lime, and calching lhe courl-ear! / Your Ielrarch is more as-
sionale, yel he, / In days of sonneling, lrusled lhem vilh much: /
Danle is hard, and fev can undersland him
3
.
Queslo ersonaggio, Lady IoIilic, deIIa famosa commedia di en
}onson Vc|pcnc, viene resenlalo come una donna di mondo, un oco
eccenlrica, ma bene informala. Siamo neI 1606. Ci sembra arlicoIar-
menle indicaliva quesla ballula er cominciare ad inlendere Ie ragioni
deIIa scarsa conoscenza di Danle. Aulore, come si e dello, fin da aIIora
gia nolo, ma consideralo aunlo 'nar!', difficiIe.
A voIer individuare una rima resenza di Danle in InghiIlerra ci
lroviamo davanli aIcuni dali in noslro ossesso che sono sicuri, aIlri
che sono da considerarsi deIIe ragionevoIi iolesi. Ira quesle uIlime
rienlra Ia ossibiIila che Geoffrey Chaucer, iI iu grande oela medie-
vaIe ingIese, abbia riorlalo con se da uno dei suoi viaggi in IlaIia
(negIi anni Sellanla deI Trecenlo) anche un manoscrillo deIIa Ccnnc-
!ia. Si lrallerebbe cos deI rimo leslo danlesco giunlo in queI aese.
L'aIlro eisodio cerlo riguarda invece Ia lraduzione in Ialino di queslo
leslo. AI ConsigIio di Coslanza (1417), Ira Giovanni dei erloIdi da
SerravaIIe, vescovo di Iermo, sarebbe slalo soIIecilalo da NichoIas
abvilh, vescovo di alh, e da Roberl HaIIam, vescovo di SaIisbury, a
2 Ira gIi sludi iu recenli, si vedano Oanics Mc!crn Ajicr|ijc. Recelion and Re-
sonse from Iake lo Heaney, ed. by Nick HaveIy, London, MacmiIIan Iress 1998,
Oanic Mciancrpncscs, Iisodes in a Lilerary AflerIife, ed. by Iric. G. Hayvood, DubIin,
Iour Courls Iress 2003, nonche I'inleressanle anloIogia Oanic in |ng|isn, London, Ien-
guin ooks 2005, ubbIicala lroo lardi erche ce ne olessimo servire.
3 Tulli i noslri scrillori ingIesi, vogIio dire queIIi che ossiedono I'ilaIiano, si de-
gnano di rubare da quesl'aulore rinciaImenle, quasi lanlo quanlo da Monlaigne. Ha
una vena cos faciIe e moderna, adalla ai lemi, che incanla orecchi corligiani! II Ielrar-
ca e iu aassionalo, e ur egIi, nei giorni in cui si facevan sonelli, delle Ioro arecchia
roba a credilo: Danle e difficiIe, e ochi osson cairIo!, in IN }ONSON, Vc|pcnc cr Tnc
|cx, Acl 3, sc. 4.
Ia jcriuna !i Oanic in |ngni|icrra 545
lradurre aunlo Ia Ccnnc!ia in Ialino. Quesla lraduzione, dedicala
ai due vescovi, e accomagnala da un commenlo in cui SerravaIIe er
due voIle asserisce che Danle aveva visilalo I'InghiIlerra
4
. QuaIche
decina di anni doo, neI 1444, Humhrey, Duca di GIoucesler, offr
aIIa bibIioleca di Oxford Ia lraduzione Ialina di SerravaIIe deIIa Oitina
Ccnnc!ia con iI suo commenlo, assieme a lanle aIlre oere che gIi a-
arlenevano
5
. Iossiamo quindi ensare che, in quaIche modo, gia neI
rimo Quallrocenlo, I'oera maggiore di Danle fosse nola, anche se
ovviamenle Ia sua circoIazione doveva essere inesislenle o Iimilala a
ochi forlunali Iellori.
La forluna di un'oera, lanlo iu di un'oera come Ia Oitina Ccn-
nc!ia, e sesso Iegala a fallori aIlamenle casuaIi: uo diendere
daII'inconlro di ersonaIila eccezionaIi, come avremo modo di vedere,
o daIIa resenza di un manoscrillo o di un Iibro aunlo in una
bibIioleca. Saiamo, er esemio, che queIIa deIIa calledraIe di WeIIs
negIi anni Trenla deI Cinquecenlo ossedeva una coia deIIa versione
Ialina di SerravaIIe e che Ia bibIioleca deI re Inrico VIII neI 1542-43
conleneva Danle's vorks in lhe CasliIIan longue (forse Ia lraduzio-
ne in rosa deI ViIIena deI 1428). II calaIogo deI 1596 deIIa bibIioleca
di un nobiIe ingIese (}ohn, aron LumIey) incIudeva un'edizione deI
rimo Cinquecenlo deIIa Ccnnc!ia, menlre }ohn Donne ossedeva
una coia deII'edizione veneziana deI Ccntitic deI 1531
6
. NeI secoIo
successivo MiIlon, su cui lorneremo, usava un'edizione deIIa Ccnnc-
!ia con iI commenlo di DanieIIo deI 1568. Un imorlanle avvocalo e
giudice ingIese, Sir Idvard Coke, ossedeva aIIa sua morle neI 1634,
lra un nolevoIissimo numero di Iibri ilaIiani, un'edizione non megIio
idenlificala deIIe Ioel Danle's Works deI 1568 o 1578
7
.
Iiu robabiIe, neI caso di Danle, e Ia sua conoscenza da arle di
uomini di cuIlura ingIesi che siano venuli neI noslro aese, oIlre che
in missione diIomalica, come neI caso di Chaucer, aIIo scoo di
visilarIo e di conoscerne Ie beIIezze naluraIi e arlislico-cuIluraIi o Ie
scienze deIIa oIilica o deIIe armi. Ci riferiamo ai viaggialori deI Gran!
Tcur, che veniva ralicalo dagIi ingIesi ben rima che neI Seicenlo si
chiamasse cos. Irano s eIIegrini sesso direlli in Terra Sanla che
4 Nei Prcan|u|a aII'oera, SerravaIIe sosliene che Danle fu sludenle di leoIogia ad
Oxford e a Iarigi.
5 Cfr. WIRNIR IAUL IRIIDIRICH, Oanics |anc A|rca! (1350-1850), Roma, Id. di Sl. e
Iell. 1950, . 182.
6 II voIume con Ia sua firma e iI suo mollo si lrova oggi aIIa odIeian Library di Ox-
ford.
7 A queslo roosilo si veda iI saggio di NICHOLAS R. HAVILY, An IlaIian Wriler
againsl lhe Ioe` Danle in Reformalion IngIand, c.1560-c.1640, in Hayvood (ed.), o.
cil., . 127- 49.
Maria ConcoIalo IaIermo 546
allraversavano iI noslro aese, ma a arlire daI rimo Cinquecenlo
erano anche viaggialori che avevano I'IlaIia come rimo obiellivo.
Non e slrano ercio che uno scrillore come WiIIiam Thomas, aulore di
una grammalica deIIa Iingua ilaIiana iI cui liloIo e indicalivo: Principa|
|u|cs cj inc |ia|ian Grannar, uiin a Oiciicnaric jcr inc |ciicr un!crsian!-
ing cj Bcccacc, Pcirarcna, an! Oanic (1550), incIudesse neIIa sua oera
rinciaIe, Hisicric cj |ia|ic, deI 1549
8
, iI resoconlo deIIa fondazione di
Manlova, lrallo daI venlesimo canlo deII'|njcrnc
9
. Una voIla in IlaIia,
dove rimase a Iungo, daI 1545 aI 1549, ebbe iI Thomas Ia Ccnnc!ia lra
Ie mani oure, visilando Manlova, gIi venne menzionalo iI verso
danlesco` I difficiIe dirIo, se si lien conlo ero deI gran numero di
edizioni deIIa Ccnnc!ia in IlaIia in queslo eriodo, e moIlo robabiIe
che egIi abbia olulo consuIlare I'oera.
Queslo che e vero er Thomas, e vero er moIli aIlri aulori deI
Cinquecenlo neIIa cui oera ci sono s riferimenli a Danle, ma er Io
iu brevi e fugaci. Sesso Ie menzioni aaiono in oere di aulori che
conoscono Ia cuIlura ilaIiana e che hanno a Ioro disosizione un nole-
voIissimo numero di oere ilaIiane in lraduzione. Quando Sidney,
neIIa sua Ocjcnsc cj Pccsq (1581), menziona Danle Io fa erche Io cono-
sce o erche I'ha lrovalo cilalo in embo o in aIlri aulori` Ci si
domanda anche che vaIore abbiano Ie sue cilazioni: .lo beIieve vilh
Landino, lhal lhey |oelsj are so beIoved of lhe gods lhal vhalsoever
lhey vrile roceeds of a divine fury
10
e iu avanli: .your souI shaII
be Iaced vilh Danle's ealrice, or VirgiI's
11
, che e anche Ia rima
menzione deI nome di ealrice in un'oera ingIese. Sidney e un oela
che e venulo in IlaIia, in arlicoIare a Venezia e a Iadova, e che e
fornilo di una nolevoIissima cuIlura. Iolrebbe quindi aver conosciulo
direllamenle anche I'oera di Danle. A queslo roosilo uo essere
uliIe ricordare Ia gran diffusione in IlaIia deIIa Ccnnc!ia neII'agiIe
edizione in ollavo ubbIicala da AIdo Manuzio a Venezia neI 1502,
8 II ed. 1560, III 1562, IV 1567.
9 Ier Ia cilla sovra queII'ossa morle, / e er coIei che 'I Ioco rima eIesse, /Manla
I'aeIIar sanz'aIlra sorle. |nj., XX, 91-93: Danle (seakynge lhereof) referrelh lhe
beginnyng of Manla lo Manla, daughler of Tiresia, kynge of Thebes!, in WILLIAM
THOMAS, Tnc Hisicric cj |ia|ic, 1549, f. 201. Ier un'inlroduzione aII'oera deI Thomas si
veda I'edizione curala da George . Iarks, Tnc Hisicrq cj |ia|q, The IoIger Shakeseare
Library, CorneII Universily Iress 1963, . ix-xxviii.
10 .credere con Landino che essi |i oelij sono lanlo amali dagIi dei che quaIun-
que cosa scrivano roviene da furia divina. Sidney si riferisce ad una affermazione di
Landino che aare neI roIogo aIIa sua edizione deIIa O.C. deI 1481.
11 .se credele aIIa forza di quesli oeli, Ia voslra anima lrovera oslo accanlo aIIa
ealrice di Danle e aII'Anchise di VirgiIio (SIR IHILII SIDNIY, Ocjcnsc cj Pccsq, in Sir
Pni|ip Si!ncq, ed. by Kalherine Duncan-}ones, Oxford, O.U.I. 1990, . 249).
Ia jcriuna !i Oanic in |ngni|icrra 547
che fu un'edizione rivoIuzionaria, erche si rifaceva ad un manoscril-
lo, forse Ia coia mandala da occaccio a Ielrarca, curalo aunlo
da Iielro embo, iI cui nome non aare robabiImenle erche Io
scrillore non voIeva che iI nome deIIa sua famigIia, una deIIe iu
resligiose a Venezia, venisse associalo con iI nuovo modo meccanico
di fare Iibri. Iielro embo ero rediIigeva come modeIIi sliIislici
occaccio e Ielrarca, come aare daIIe sue Prcsc !c||a tc|gar |ingua
(1525), infIuenzando cos indirellamenle i suoi Iellori anche aII'eslero.
Ovviamenle c'erano oi i Iibrai. Saiamo, er esemio, di un Ro-
berl Marlin che nei suoi calaIoghi, che roseguono fino aI 1640, eIen-
cava edizioni deI Cinquecenlo e deI Seicenlo deIIa Ccnnc!ia: fra que-
sle, edizioni iccoIe, orlaliIi, come I'in quaric di DanieIIo deI 1568
(oslumo), o bei voIumi in jc|ic come Ie edizioni di Landino (queIIa
cilala da Sidney) e VeIIuleIIo (1544) che, ci ricorda uno sludioso, may
ossibIy have Iain undislurbed on lhe sheIves of arislocralic Iibra-
ries
12
.
Iolremmo soffermarci su innumeri nolizie simiIi, ma esse non ci
dicono oi moIlo suII'effelliva adesione ad un leslo, queIIa che si lra-
duce in Iinfa vilaIe er un aIlro aulore, che divenla fonle isiralrice di
immagini e forme, queIIa cioe che e iI segno deIIa vera enelrazione di
un aulore neIIa cuIlura di un aese.
Dobbiamo quindi fare un asso indielro e lornare a Chaucer. Con
Chaucer che, come ricordavamo, venne in IlaIia e riorlo con se ro-
babiImenle in InghiIlerra I'oera di Danle, ci lroviamo di fronle ad un
aulore che, affascinalo daIIa variela dei lemi e deIIe forme deII' oera
danlesca, sembra aver avulo sesso resenle una arle aImeno dei
Iavori deI oela ilaIiano. Si lralla non soIlanlo di un'affinila siriluaIe,
come olra essere in seguilo er MiIlon o er iI novecenlesco IIiol.
Tulli i crilici solloIineano infalli Ia rofonda diversila di carallere e di
alleggiamenlo nei confronli deIIa vila che conlrassegna i due aulori,
Chaucer e Danle
13
. Come dice Mario Iraz: II Iacido borghese di
Londra |Chaucerj oco doveva simalizzare con Ia sacrosanla indi-
gnazione danlesca conlro imeralori codardi e ai degeneri
14
. C'era
fra Chaucer e Danle una dislanza, come ci ricorda Iielro oilani
15
, non
soIo geografica, ma anche cronoIogica. Sebbene avessero in comune
12 HAVILY, arl. cil., .132- 33.
13 Cfr., er esemio, IRIIDIRICH: Chaucer's characler vas nol one lo be comIele-
Iy allracled lo Danle. He vas nol a hiIosoher, or oIilician, or lheoIogian (o. cil., .
189).
14 MARIO IRAZ, Macniatc||i in |ngni|icrra, Iirenze, Sansoni 1962, . 41.
15 Cfr. IIITRO OITANI, Wnai Oanic Mcani ic Cnauccr, in oilani (ed.), Cnauccr an! inc
|ia|ian Trcccnic, Cambridge, C.U.I. 1983, . 115.
Maria ConcoIalo IaIermo 548
una vasla cuIlura (amavano enlrambi gIi slessi cIassici, VirgiIio e Sla-
zio, conoscevano Ia fiIosofia medievaIe, erano inleressali aIIe scienze),
Danle era in fondo un uomo deI Duecenlo con una sensibiIila e reIi-
giosila ben diverse da queIIe deII'ingIese. Cio nonoslanle, gIi echi dan-
leschi sono moIleIici neIIe oere di Chaucer, anche se non raggiun-
gono 250 casi come quaIcuno ha soslenulo, si lralla in soslanza di echi
e di adallamenli. I neIIa slanza finaIe deI Trcq|us an! Criscq!c (ca.
1380) aII'inizio e aIIa fine di quesla slanza, che lroviamo un adalla-
menlo, che e una lraduzione dei versi 28-30 deI XIV deI Para!isc:
Thov oon, and lvo, and lhree, elerne on Iyve
Thal regnesl ay in lhre, and lvo, and oon,
Uncircumscril, and aI maisl circumscrive
|.j
che e Ia lraduzione di:
QueII'uno e due e lre che semre vive
e regna semre in lre e 'n due e 'n uno,
non circunscrillo, e lullo circumscrive
|.j
e I'uIlimo verso
Ior Iove of mayde and moder lhyn benigne,
che riecheggia invece iI rimo verso deI XXXIII deI Para!isc.
Vergine madre, figIia deI luo figIio |.j
Ma non sono gIi unici echi significalivi. NeIIa Hcusc cj |anc (1384),
lroviamo Ia rima menzione di Danle. Nei Canicr|urq Ta|cs, I'oera di
Chaucer iu nola e iu imorlanle, c'e naluraImenle iu di un richia-
mo. Noi ci soffermiamo su uno soIo che sara arlicoIarmenle redi-
Iello neI corso dei secoIi successivi, dando vila non lanlo a moIlissime
lraduzioni, ma anche, sorallullo a arlire daI Sellecenlo, a disegni,
quadri, bassoriIievi, scuIlure. Si lrova neI Mcnks Ta|c (|acccnic !c|
Mcnacc) che e un insieme di brevi narrazioni, ognuna deIIe quaIi lralla
deIIa cadula di un ersonaggio iIIuslre, da Lucifero a Creso, da Cesare
a Nerone. Ira quesle narrazioni in versi c'e queIIa inliloIala Oc Hugc|i-
nc, Ccniic !c Pizc, che racconla Ia sloria deI conle UgoIino (|njcrnc
XXXIII, 1-90). Quesla I'uIlima arle:
Ia jcriuna !i Oanic in |ngni|icrra 549
And vhan lhe vofuII fader deed il sey,
Ior vo his armes lvo he gan lo byle,
And seyde, 'AIIas, Iorlune, and veyIavay!
Thy faIse vheeI my vo aI may I vyle.'
His chiIdren vende lhal il for hunger vas
Thal he his armes gnov, and nal for vo,
And seyde, 'Iader, do nal so, aIIas!
ul ralher ele lhe fIesh uon us lvo.
Oure fIessh lhou yaf us, lake oure fIessh us fro,
And ele ynough' . righl lhus lhey lo hym seyde,
And afler lhal, vilhinne a day or lvo,
They Ieyde hem in his Iae adoun and deyde.
HymseIf, deseired, eek for hunger slarf,
Thus ended is lhis myghly IrI of Iize.
Irom heigh eslaal Iorlune avey hym carf.
Of lhis lragedie il oghle ynough suffise,
Whoso voI here il in a Ienger vise,
Redelh lhe grele oele of YlaiIIe
Thal highle Danl, for he kan aI devyse
Iro oinl lo oinl, nal o vord voI he faiIIe
16
.
Credo che Ia resa di queslo eisodio da arle deIIo scrillore ingIese
sia un buon esemio di queI rinciio di 'lrasformazione' 'neI lono e
negIi scoi' er cui Chaucer, secondo un imorlanle sludioso dei ra-
orli lra Chaucer e Danle (SchIess), con cura sosla I'enfasi daI
lerrore concenlralo deIIa descrizione di Danle verso una descrizione
simalelica, si olrebbe dire senlimenlaIe, deIIa morle dei figIi di
UgoIino
17
.
16 GIOIIRIY CHAUCIR, Tnc Mcnkcs Ta|c, in Tnc Ccnp|cic Wcrks cj Gccjjrcq Cnauccr,
ed. by WaIler W. Skeal, London, O.U.I. 1957, . 537. I quando iI adre morlo Io vide,
ambo Ie braccia er doIor si morse, e disse: Ahime, forluna, ahime! A mio maIanno Ia
lua faIsa ruola conosco girare!. Credellero i figIi che er fame Ie braccia si fosse morse
e non er doIore, e dissero: Non cos adre, ahime! iulloslo cibali deIIe noslre carni,
lu quesle carni ci desli e lu ce Ie logIi, e saziali! aunlo cos gIi arIarono. I doo
di cio enlro uno o due giorni gIi si slesero in grembo e morirono, ed egIi slesso, disera-
lo, er fame er. In quesla maniera fin queslo olenle conle di Iisa, cui forluna
slrao da aIlo slalo. I di quesla lragedia dello sarebbe a sufficienza, chi iu a Iungo ne
vogIia senlire Iegga iI gran oela d'IlaIia, queII'aIlo Danle, erche egIi lullo sa dire un-
lo er unlo, senza una aroIa che faIIi. Non ci soffermeremo sugIi aselli lecnici
deII'adallamenlo deI verso danlesco aIIa Iingua ingIese. Ci Iimiliamo qui a dire che
Chaucer uliIizza Ia slanza di ollo versi er rendere Ia lerzina di Danle.
17 Cfr. HOWARD H. SCHLISS, Cnauccr an! Oanic. A |cta|uaiicn, Norman, OkIa,
Maria ConcoIalo IaIermo 550
SoIo con MiIlon, neI Seicenlo, lroveremo una conoscenza di Danle,
er cos dire, daII'inlerno. Irima ero vorremmo ricordare una serie
di aulori che menzionano iI nome di Danle neI Cinquecenlo: non soIo
Sir IhiIi Sidney, quindi, ma anche GabrieI Harvey, Roberl Greene e,
non a caso, lulli i lradullori di lesli ilaIiani da Roberl Ielerson (lradul-
lore deI Ga|aicc di Monsignor DeIIa Casa, 1576), a George Iellie
(lradullore deIIa Citi| Ccntcrsazicnc di Slefano Guazzo), a Thomas
Hoby (lradullore deI Ii|rc !c| Ccriigianc di aIdassar CasligIione) ed
aIcuni aIlri (}ames Sandford, lradullore di Lodovico Guicciardini,
1573 Hcrc !i ricrcazicnc e Thomas edingfieId, lradullore deI Machia-
veIIi, 1587). Se si fa un'eccezione er Sir }ohn Haringlon, iI lradullore
deII'Arioslo (Or|an!c |uricsc 1591), che dovelle er cerlo conoscere
I'|njcrnc di cui lraduce in ingIese Ia lerzina iniziaIe, ossiamo invece
rilenere nuIIa o quasi I'infIuenza di Danle su aulori come Senser e Io
slesso Shakeseare. Laddove, e moIli sludi recenli Io solloIineano,
c'e un asello deII'oera di Danle che ha una decisa risonanza in In-
ghiIlerra aI lemo di Shakeseare e quindi in eoca Tudor, e una
risonanza Iegala non lanlo aIIa Oitina Ccnnc!ia, ma aI Oc Mcnarcnia.
Danle come scrillore conlro Roma e un o' Io sIogan che rilro-
viamo in oere di eccIesiaslici roleslanli, come iI vescovo di SaIis-
bury }ohn }eveI, di oIemisli accesi, come iI marliroIogo }ohn Ioxe, iI
famoso aulore aunlo deI cosiddello Bcck cj Mariqrs (1570). Ci sof-
fermiamo raidamenle su queslo asello. NeI 1559, iI famoso slam-
alore Oorinus (}ohann Herbsl) aveva ubbIicalo a asiIea un icco-
Io voIume che conleneva una raccoIla di saggi suI raorlo fra Iaalo
e Imero. II secondo di quesli saggi era iI Oc Mcnarcnia di Danle,
slamalo er Ia rima voIla in quesla occasione (ricordiamo che I'o-
era era aII'Indice daI 1554). L'oera danlesca aarve quindi come se
fosse un ouscoIo deIIa Riforma roleslanle, Ie sue bozze furono ro-
babiImenle correlle da un Iulerano convinlo, come I'aena cilalo
sludioso di Oxford, }ohn Ioxe, che era in queI eriodo a asiIea. Que-
sla nolizia che, neI quadro generaIe che sliamo cercando di lracciare,
olrebbe sembrare marginaIe, divenla inleressanle erche siega
quaIcosa deII'avvenlura deI Iibro, deI suo viaggio fra Ie cuIlure, dei
lramili sesso imrevedibiIi che segnano iI deslino di un'oera. Dan-
le, Io scrillore oggi iu calloIico deIIa noslra cuIlura, divenla cos uno
slrumenlo in mano roleslanle er allaccare iI aalo romano, sede,
agIi occhi dei roleslanli ingIesi, com'e nolo, di ogni nequizia. Id ecco
che Danle divenla cos famoso che Io si vuoI vedere addirillura come
un rofela, aIIorche neI suo Vc|irc si vuoI Ieggere un anagramma deI
IiIgrim ooks 1984, passin.
Ia jcriuna !i Oanic in |ngni|icrra 551
nome di Iuicrc. Queslo lenlalivo di uliIizzare Danle, e Ie sue condan-
ne di aIcuni aselli deIIa Chiesa di Roma, non era ero nuovo:
rienlrava neII'oerazione gia in allo da lemo di recuerare Danle,
assieme ad aIlri aulori deI assalo, in un fiIone di sloria roleslanle.
La riresa deII'inleresse er Danle aI lemo deI ConciIio di Trenlo
forse rienlra in queslo sirilo. Ci sara quaIche voce calloIica in InghiI-
lerra che cerchera di siegare agIi ingIesi che Ia condanna di Danle
riguardava non Ia Chiesa o Ia dollrina calloIica in quanlo laIe, ma soIo
Ia corruzione che, in un cerlo momenlo, aIIignava neIIa Chiesa di Ro-
ma, ma si lralla di voci isoIale e minorilarie. La queslione, moIlo
inleressanle e comIessa, non uo ora essere seguila nei arlicoIari.
Va recisalo ero che neI rifarsi a Danle venne usalo non soIo iI Oc
Mcnarcnia, ma anche assi deIIa Ccnnc!ia che si reslavano aIIo sco-
o. Da queslo unlo di visla, cio rende meno vera I'affermazione deIIa
scarsa conoscenza di Danle aII'eoca, che resla comunque Iegala a
assi isoIali. Uno er lulli: iI asso iu cilalo dagIi scrillori roleslanli
e Ia condanna deIIe vanila e deIIe favoIe dei redicalori falla da ea-
lrice neI canlo XXIX deI Para!isc, 103-08:
Non ha Iiorenza lanli Lai e indi
quanle s falle favoIe er anno
in ergamo si gridan quinci e quindi:
s che Ie ecoreIIe, che non sanno,
lornan daI asco asciule di venlo
|.j
DaI lardo Cinquecenlo aI rimo Seicenlo, quindi, Danle viene con-
sideralo in aIcuni sellori ingIesi .a oIilicaI oonenl of aaI
suremacy |.j a rohelic vilness againsl lhe IaaI Anlichrisl and
ScarIel Woman |.j an unmasker of lhe obscuranlism of lhe Roman
CalhoIic rieslhood
18
. Non e un caso quindi se rilroviamo in Iqci!as,
Ia famosa eIegia di MiIlon, iI iu grande oela ingIese deI Seicenlo,
una uIleriore uliIizzazione di queslo asso deI Para!isc che abbiamo or
ora cilalo:
Iind moulhs! Thal scarce lhemseIves knov hov lo hoId
A shee-hook, or have Iearned aughl eIse lhe Ieasl
Thal lo lhe failhfuI herdsman's arl beIongs!
Whal recks il lhen` Whay need lhey` They are sed,
18 .un oosilore oIilico deIIa suremazia aaIe |.j un leslimone rofelico
conlro I'Anlicrislo IaaIe e Ia Scar|ci Wcnan |roslilula: Ia Chiesa di Romaj |.j uno
smascheralore deII'oscuranlismo deI cIero calloIico romano, in HAVILY, arl. cil., . 142.
Maria ConcoIalo IaIermo 552
And vhen lhey Iisl, lheir Iean and fIashy songs
Grale on lheir scranneI ies of vrelched slrav.
The hungry shee Iook u, and are nol fed,
ul svoIIen vilh vind |.j
19
.
L'obiellivo oIemico di MiIlon, come e nolo, e Ia cosiddella chiesa
Iaudiana, ossia Ia High Church angIicana, che con I'arcivescovo Laud
aunlo si era moIlo avvicinala aIIa chiesa di Roma.
Sembra inevilabiIe rilenere, come ci ricorda un crilico, che gIi scrilli
di MiIlon sono ervasi daIIa resenza danlesca
20
, erche era un uomo
moIlo coIlo, erche amava I'IlaIia, che conosceva bene, e Ia Ielleralura
ilaIiana, erche i suoi lemi echeggiano lanlo da vicino queIIi di Danle,
nonche er iI fallo che Ie ersonaIila dei due oeli sono moIlo affini.
L'oera di Danle e queIIa di MiIlon sono oere in quaIche modo a-
raIIeIe: enlrambe cuIminano nei due grandi oemi che si ergono
soIilari neIIa Ielleralura (Ia Oitina Ccnnc!ia e iI Para!isc Pcr!uic), er-
che, soIi fra i grandi oemi deI mondo, iI Ioro inlenlo era di essere
nulrimenlo deIIa Iiberla umana grazie ad una disciIina divina, falla
di olenza oelica, erede deIIe idee e lradizioni deIIa fede crisliana
21
:
One |Danlej vas so CalhoIic, lhe olher |MiIlonj so Iroleslanl,
yel bolh men resembIed each olher because, beyond being
oels, lhey vere slalesmen in lhe Iargesl sense, each one of
lhem fighling hard for lhe siriluaI vaIues of his counlry, indeed
for lhe veIfare and lhe saIvalion of aII humanily lhe one by ex-
loIIing an emeror and abominaling many oes, lhe olher by
arlecialing in lhe execulion of a king and by embracing lhe
cause of a nev reIigious diclalor
22
.
19 }OHN MILTON, Iqci!as (1639), 119-26. Di seguilo Ia lraduzione ilaIiana di queslo
asso falla da Iranco Iorlini: ocche cieche! Neanche sanno reggere / La mazza deI
aslore e quasi lulla ignorano / L'arle di un fido cuslode di greggia. / Che fare di Ioro`
Che gIi manca` Sono sazi. / I su marci zufoIi sfialali gIi garba / Slridere cerle sloIle arie
meIense, / iI ooIo |Ie ecorej, che ha fame, Ii guarda ma nienle / Io uo nulrire e si
asce di venlo., in Anic|cgia !c||a pccsia ing|csc, dirella da Iranco Marucci, Iirenze,
Gruo IdiloriaIe L'Isresso 2004, I, . 385.
20 STOCKTON AXSON, Oanic an! |ng|isn Iiicraiurc, The Rice Inslilule IamhIel,
VIII (1921), . 227.
21 CHARLIS H. HIRIORD, Oanic an! Mi|icn, uIIelin of lhe }ohn RyIands Library,
Manchesler, 1924.
22 Uno |Danlej era cos calloIico, I'aIlro |MiIlonj cos roleslanle, lullavia enlrambi
si rassomigIiavano erche, oIlre ad essere oeli, erano oIilici neI senso iu amio,
ciascuno dedilo ad una Iolla difficiIe er i vaIori siriluaIi deI suo aese, er iI benesse-
re e Ia saIvezza di lulla I'umanila I'uno innaIzava un imeralore e biasimava moIli
ai, I'aIlro arleciava aIIa condanna a morle di un re e abbracciava Ia causa di un
Ia jcriuna !i Oanic in |ngni|icrra 553
Doo MiIlon, neI corso deI Seicenlo e neI rimo Sellecenlo, conli-
nuiamo a lrovare echi o brevi segni di una conoscenza deI noslro
oela, a voIle anche numerosi e moIlo significalivi. Mi iace ero ri-
cordare che forse Ia rima voce che rivendica con aulorevoIezza
I'imorlanza deI oela Danle suI suoIo ingIese, e in ingIese, e queIIa di
un ilaIiano, iI noslro Giusee arelli.
Imigralo in InghiIlerra, come ricordiamo, egIi ben reslo lrovo
modo di farsi Ieggere suIIa carla slamala deIIa sua nuova alria.
Siamo negIi anni Cinquanla deI Sellecenlo: c'era da lemo neII'aria
una oIemica che risaIiva aI francese VoIlaire, che si era esresso ne-
galivamenle nei confronli deIIa forza deIIa oesia, anche di queIIa
ilaIiana. AIlri avevano gia risoslo oIemicamenle neIIa slessa InghiI-
lerra (lra di Ioro un aIlro esuIe ilaIiano, IaoIo RoIIi, neI 1728), ma
I'inlervenlo deI arelli fu eocaIe. IgIi non si Iimilo ad affermare Ia
forza deIIa noslra oesia ma, arlendo daI resuoslo che Io slesso
VoIlaire arIasse di quaIcosa che in fondo non conosceva, iIIuslro con
vari assi Ie voci ilaIiane iu significalive, rima di lulle queIIa di
Danle, di cui cilo assi in ilaIiano, seguili daIIa sua lraduzione in in-
gIese.
Di seguilo Ia lraduzione deI arelli di un famoso asso danlesco:
Through Me Iies lhe Way lo lhe doIefuI Cily.
Through Me Iies lhe Way lo everIasling Woe.
Through Me Iies lhe Way lo lhose doomed lo Ierdilion.
IlernaI }uslice, omniolenl Iover, consummale Wisdom,
and aII-crealing Love moved lhe AImighly lo make me.
Me, excel his AngeIs, lhe eIdesl of crealed Things.
I am lo aII Ilernily. Ye vho ever enler here, quil Hoe for ever
23
.
Si e dello fin daII'inizio che e soIo in queslo eriodo che comincia
dillalore reIigioso |si riferisce a CarIo I e a OIiviero CromveIIj, in IRIIDIRICH, o. cil.,
. 202.
23 GIUSIIII ARITTI, A Oisscriaiicn upcn inc |ia|ian Pccirq, London, Irinled for R.
DodsIey, MDCCLIII, . 36. OIlre a quesl'oera che conliene una Iunga rifIessione su
Danle, e deI 1753 anche |cnarks cn inc |ia|ian Ianguagc an! Wriicrs (di quaIche anno
rima), insieme a |nirc!uciicn ic inc |ia|ian Ianguagc deI 1755 e a Tnc |ia|ian Ii|rarq deI
1757, recedono iI suo famoso e duraluro Oiciicnarq cj |ng|isn an! |ia|ian Ianguagcs, deI
1760. Grande inlerIoculore ingIese, sodaIe e soslenilore deI arelli in queslo eriodo e
SamueI }ohnson, con cui iI arelli dovelle cerlamenle disculere lulli quesli suoi inler-
venli, come ricaviamo daIIa Ioro corrisondenza. SuI arelli ingIese, vd. MARIA
CONCOLATO IALIRMO, Oi a|cuni aspciii !c| Barciii ing|csc, in Giuscppc Barciii Iciicraic c
Viaggiaicrc, Alli deI Convegno, NaoIi, 15 dicembre 1989, a cura di Arluro MarloreIIi,
Iremessa di ArnaIdo Di enedello, NaoIi, VaIenlino ed. 1993.
Maria ConcoIalo IaIermo 554
un vero arezzamenlo di Danle in InghiIlerra. I Iecilo suorre che
gran merilo di queslo nuovo cIima sia slalo rorio deI noslro arelli,
non soIo grazie ai suoi conlribuli ma anche indirellamenle e che non
sia soIo dovulo aI nuovo guslo er I'orrifico. NeI 1773, in una moslra
aIIa RoyaI Academy, aare infalli un quadro di }oshua ReynoIds, iI
grande illore deII'eoca, che scegIie come lema deIIa sua oera Ia
lragedia deI conle UgoIino. I difficiIe risaIire ai molivi che Io hanno
orlalo a quesla sceIla. ReynoIds era ero grande amico di SamueI
}ohnson, e allraverso }ohnson, anche di arelli, aI unlo da fargIi un
rilrallo, neI 1774, che ha fissalo er noi I'immagine ufficiaIe deI noslro
scrillore
24
. Ci iace ensare che Ie caIde aroIe deIIo scrillore ilaIiano
abbiamo avvialo una riresa d'inleresse er I'oera di Danle a cui iI
quadro deI ReynoIds cerlamenle moIlo conlribu (neI '78 ReynoIds
rilrae anche }ohnson). Sosliene infalli un crilico che iI quadro inliloIa-
lo Ccuni Hugc|inc an! nis Cni|!rcn in inc Oungccn abbia conlribuilo iu
di una dozzina di oeli e crilici messi insieme a divuIgare Ia cono-
scenza di Danle in un cerchio iu amio di ingIesi, non soIo, ma che Ia
slessa sceIla deI lema esrima aI megIio I'oinione iu liicamenle
re-romanlica di un Danle 'oela comballivo'
25
.
Con Ia fine deI Sellecenlo e con I'inizio deII'Ollocenlo, queIIo che
er quanlo riguarda Ia oesia di Danle fino a queI momenlo era slalo
un fenomeno Iimilalo e arziaIe assume una ben diversa consislenza.
DaIIa lraduzione di singoIi assi e eisodi, daIIa serimenlazione di
adallamenli in ingIese deIIa lerza rima (WiIIiam HaiIy, 1782) e da
versioni di assi danleschi o di canliche comIele neI verso ingIese
er ecceIIenza, iI ||ank tcrsc (I'|njcrnc di CharIes Rogers, neI 1782), si
assa aIIa lraduzione di lulla Ia Ccnnc!ia e oi, via via, a queIIa di
aIlre oere di Danle. La Oitina Ccnnc!ia viene lradolla neIIa sua
comIelezza: canlica er canlica rima, oi Ie lre canliche insieme e
non una soIa voIla. A arlire daIIa lraduzione iu efficace, queIIa
deI Cary, er lullo iI secoIo e oi fino ai noslri giorni Ie edizioni
deIIa Oitina Ccnnc!ia rima, e oi di lulla I'oera di Danle, si susse-
guono con un rilmo che ha quasi deII'inverosimiIe. QuaIche sludioso
(Toynbee) ha slalislicamenle riIevalo, er I'Ollocenlo ingIese, una lra-
duzione e quindi un'edizione ogni quallro anni, er non arIare deIIe
24 IRANCIS A. YATIS, neI suo Transjcrnaiicns cj Oanics Ugc|inc, }ournaI of lhe
Warburg and CourlauId Inslilules, 14, 1, 1951, . 92-117, cila un'aIlra oera deI arel-
li, |asq Pnrascc|cgq jcr Ycung Ia!ics (1775), una serie di diaIoghi in ingIese e in ilaIiano
er Ie sue giovani aIIieve. In uno dei diaIoghi, iI ersonaggio deI Gallo informa iI Cane
che iI quadro iu inleressanle aIIa RoyaI Academy e aunlo queIIo deI Conle UgoIino
deI ReynoIds.
25 IRIIDIRICH, o. cil., . 225.
Ia jcriuna !i Oanic in |ngni|icrra 555
edizioni in ilaIiano che aaiono in InghiIlerra (Ia rima neI 1808)
26
.
Si sa che I'ammirazione iu comIela e Ia conoscenza di Danle in
InghiIlerra si ebbe con I'ela romanlica. Nessun lradullore fu iu a-
rezzalo di Henry Irancis Cary, che abbiamo rima ricordalo, iI quaIe
venne definilo iI lradullore di Danle er anlonomasia. Cary inizio Ia
lraduzione in ||ank tcrsc deI Purgaicric neI 1797 e venne via via ub-
bIicandoIa fino aII'edizione comIela deIIe lre canliche neI 1812, con iI
liloIo Tnc Visicn, cr Hc||, Purgaicrq an! Para!isc cj Oanic A|ignicri. Que-
sla lraduzione ero non avrebbe avulo forse Ia risonanza e Ia forluna
che ebbe (una seconda edizione neI '19, una lerza, neI '31, una quarla
neI '44) se un oela di grande rinomanza non I'avesse ubbIicamenle
eIogiala. Ci riferiamo a SamueI TayIor CoIeridge, che dovelle conosce-
re moIlo bene Ia Ccnnc!ia, ma anche Ia Viia Ncta e iI Ccntitic e che fu
forse iI rimo crilico ingIese ad anaIizzare rofondamenle I'oera di
Danle
27
.
Va dello inoIlre che lulli i maggiori oeli e crilici ingIesi deII'Ol-
locenlo, i romanlici rima e oi i villoriani, i modernisli, ecc. si occu-
ano in un modo o neII'aIlro di Danle: da Wordsvorlh a Keals, da
yron a Tennyson, da rovning a Rosselli, er non arIare di Lamb
e HazIill, CarIyIe, Ruskin, ArnoId, Svinburne elc. elc. Ier dare
un'idea deI cIima cuIluraIe deI lemo, vogIiamo soIo ricordare che
CharIes Lamb, iI ceIebre saggisla, in una Iellera deI 1833 aI Cary, rac-
conla come Iui e Ia soreIIa Mary sliano Ieggendo I'|njcrnc con I'aiulo
deIIa sua lraduzione che e, dice,'una sleIIa oIare'
28
.
Non ossiamo non accennare inoIlre aI fallo che vi sono aIlri emi-
grali o megIio esuIi ilaIiani in InghiIlerra che rinvigoriscono uIlerior-
menle I'inleresse er Danle. Ci Iimileremo ovviamenle soIo a menzio-
nare Ie due ersonaIila maggiori: IoscoIo, che ubbIica suIIa Quaricr|q
|cticu arlicoIi su Danle negIi anni Venli, e Mazzini, che Ioda, neI 1837,
IoscoIo er i suoi sludi su Danle e neI 1842 comIelera I'edizione deI-
26 IAGIT TOYNII, Briiains Tri|uic ic Oanic in Iiicraiurc an! Ari. A Cnrcnc|cgica|
|cccr! cj 540 Ycars (c. 1380-1920), London, Melhuen 1921. Ma si veda anche IAGIT
TOYNII (ed.), Oanic in |ng|isn Iiicraiurc. |rcn Cnauccr ic Carq (c. 1380-1844), London,
Melhuen 1909, 2 voIumi.
27 NeI 1818, in una serie di conferenze, CoIeridge arIa deI debilo dei oeli ingIesi
nei confronli di Danle ed eIogia in arlicoIare Ia lraduzione aunlo deI Cary
IRIIDIRICH, o. cil., . 230-31.
28 .scrambIed lhrough lhe Inferno by lhe bIessed furlherance of your oIar-
slar lransIalion (CharIes Lamb lo H.I. Cary, Sel 9lh, 1833), in Tnc Wcrks cj Cnar|cs an!
Marq Ian| (voI.6), Lellers 1821-1842, ed. by I.V. Lucas, London, Melhuen 1912, . 978.
Dobbiamo, eraIlro, ricordare che Ia rivaIulazione di Danle neII'Ollocenlo non e ov-
viamenle soIo secifica degIi ingIesi, ma rienlra in un fenomeno cuIluraIe euroeo di
cui basla qui soIo un nome, accanlo a CoIeridge, queIIo di A.W. SchIegeI.
Maria ConcoIalo IaIermo 556
Ia Ccnnc!ia che iI IoscoIo aveva comincialo ad iIIuslrare e che era
slala inlerrolla da dissensi con I'edilore ingIese rima e oi daIIa sua
morle. Danle divenla, come e er yron, 'iI oela deIIa Iiberla'.
In queslo cIima eslremamenle favorevoIe, nascono in InghiIlerra
anche Ie rime Sociela danlesche (ad Oxford neI 1876, a Londra neI
1881, a Manchesler neI 1906.), nascono i rimi sludi crilici seciaIi-
slici e no (i rimi corsi universilari sono deI 1887), nascono slame e
quadri che iIIuslrano Ia Ccnnc!ia, aIcuni di illori moIlo famosi (a
queIIi di ReynoIds si affiancano Ie iIIuslrazioni deI IIaxman, di Iake, i
disegni e i quadri di IuseIi, i disegni e gIi acquareIIi deI Rosselli.),
nascono comosizioni lealraIi (un Pac|c c |ranccsca di Slehen IhiIIis,
neI 1902) e musicaIi (I'oera Oanic c Bcairicc di Slehen IhiIol, 1918),
che s'isirano aIIa Oitina Ccnnc!ia. Sono anliciazioni di cio che ac-
cadra quando, con Io sviIuo deIIe lecniche novecenlesche, avremo
I'oera di Danle aI cinema (iu in ambilo americano che ingIese) e in
lemi ancora iu vicini in leIevisione (una versione video deII'|njcrnc
si e avula in InghiIlerra negIi anni 1987-90 a ChanneI 4, uno dei regisli
era Ieler Greenavay).
Ricordavamo che i grandi oeli romanlici Ieggono Danle, amano
Danle, Io fanno rorio. Secondo T. S. IIiol (che neI Novecenlo, rie-
lulamenle e in momenli diversi deIIa sua vila si occuera di Danle), iI
maggiore e I. . SheIIey che riesce in aIcune comosizioni a farci
inlendere quanlo egIi abbia assimiIalo I'aIla Iezione danlesca. I ro-
rio IIiol a ricordarci che iI Triunpn cj Iijc, I'uIlimo dei grandi oemi
di SheIIey, rimaslo incomiulo raresenla iI iu grande lribulo
di SheIIey a Danle
29
. Ci Iimilereremo qui invece a roorvi un'aIlra
cilazione eIioliana, daII'|pipsqcni!icn, un oema aulobiografico di
SheIIey che e anche uno sludio deIIo slesso rocesso crealivo:
My Song, I fear lhal lhou viIl find bul fev
Who filIy shaII conceive lhy reasoning,
Of such hard maller dosl lhou enlerlain
30
.
Quesli versi, ci ricorda IIiol, ricaIcano quasi fedeImenle queIIi
deIIa canzone danlesca, Vci cninicn!cn!c i| icrzc cic| nctcic (Ccntitic,
Trallalo secondo, Canzone I, vv. 53-55):
29 .Tnc Triunpn cj Iijc, a oem vhich is SheIIey's grealesl lribule lo Danle, in
Wnai Oanic Mcans ic Mc, in THOMAS STIARNS ILIOT, Tc Criiicizc inc Criiic an! Oincr Wrii-
ings, Nev York, Iarrar 1965, 130, ILIOT, Opcrc, a cura di Roberlo Sanesi, II, . 955.
30 Canzone mia, credo che ne lroverai ochi / adalli a inlendere iI luo ragionamen-
lo, / essendo cos dura Ia maleria che esrimi.
Ia jcriuna !i Oanic in |ngni|icrra 557
Canzone, io credo che saranno radi
coIor che lua ragione inlendan bene,
lanlo Ia arIi falicosa e forle.
IIiol, neI semre suggeslivo saggio ora cilalo, Ccsa signijica Oanic
pcr nc, siega, fra Ie moIle aIlre cose imorlanli, iI suo Iungo raorlo
con iI noslro oela, Ia sua esigenza di farne rori i modi, Ia sua falica
neI lenlare di imilarIo. Ci ricorda che e riuscilo a scrivere in queIIo
sliIe forse una dozzina di versi e che essi non sono 'nienle' di fronle
agIi slessi assi iu 'senli' deIIa Oitina Ccnnc!ia. I ancora IIiol a
segnaIare Ia seconda sezione deIIa sua oera Iiii|c Gi!!ing, I'uIlimo
dei Quariciii, come iI suo lenlalivo iu comiulo d'imilare Danle. Ne
vediamo un breve asso:
In lhe uncerlain hour before lhe morning
Near lhe ending of inlerminabIe nighl
Al lhe recurrenl end of lhe unending
Afler lhe dark dove vilh lhe fIickering longue
Had assed beIov lhe horizon of his homing
WhiIe lhe dead Ieaves sliII rallIed on Iike lin
Over lhe ashaIl vhere no olher sound vas
elveen lhree dislricls vhence lhe smoke arose
I mel one vaIking, Ioilering and hurried.
31
Le considerazioni di IIiol su Danle sono iIIuminanli:
The Divine comedy exresses everylhing in lhe vay of emolion,
belveen deravily's desair and lhe bealific vision, lhal man is
caabIe of exeriencing. Il is lherefore a conslanl reminder lo
lhe oel, of lhe obIigalion lo exIore, lo find vords for lhe
inarlicuIale, lo calure lhose feeIings vhich eoIe can hardIy
even feeI, because lhey have no vords for lhem, and al lhe same
lime, a reminder lhal lhe exIorer beyond lhe fronliers of
ordinary consciousness viII onIy be abIe lo relurn and reorl lo
his feIIov-cilizens, if he has aII lhe lime a firm gras uon lhe
31 NeII'ora incerla rima deI mallino / SuI finir deIIa nolle inlerminabiIe / Quando
ricorre Ia fine di cio che non finisce / Ioi che I'oscura coIomba daIIa Iingua fiammeg-
gianle / Ira sarila aII'orizzonle er lornare aI nido / Menlre Ie fogIie morle ancora
creilavano con rumor di melaIIo / Sora I'asfaIlo dove non era aIlro suono / Ira lre
dislrelli onde s'aIzava iI fumo / Inconlrai uno che camminava, adagio e in frella., in
|cur Quaricis, in ILIOT, Opcrc, ed. cil., . 386-89.
Maria ConcoIalo IaIermo 558
reaIilies vilh vhich lhey are aIready acquainled
32
.
Queslo saggio di IIiol e deI 1950. I suerfIuo soggiungere che
gIi sludi e Ie rifIessioni, Ie suggeslioni deII'oera danlesca conlinuano
in InghiIlerra anche er lullo iI Novecenlo. Ci ricorda ancora Mario
Iraz che e arlicoIarmenle sorrendenle come, grazie aII'infIusso a
sua voIla deIIa oesia di IIiol sui oeli ingIesi e americani conlemo-
ranei e successivi, Danle venga Iello, lradollo, imilalo e cilalo da
moIli. Da MacNeice a Auden, da Yeals a Laurence inyon (a cui si
deve fra I'aIlro una deIIe migIiori lraduzioni moderne deIIa Ccnnc-
!ia), a Seamus Heaney.
Ira Ia fine deII'Ollocenlo e Iungo lullo iI Novecenlo e nei rimi an-
ni deI DuemiIa, si susseguono moIli sludi ilaIiani e slranieri che
affronlano rorio queslo lema deIIa forluna di Danle neIIe, come
oggi si dice, Briiisn |s|cs. Di aIcuni di quesli sludi ci siamo avvaIsi neI
corso deIIa noslra esosizione.
Ma non vogIiamo concIudere senza aver evocalo qui Ia figura di
un oela ingIese conlemoraneo, che cosliluisce un chiaro esemio di
come Ia forluna deIIa oesia di Danle in InghiIlerra conlinui ancora. Si
lralla di Geoffrey HiII, un oela non moIlo nolo in IlaIia, non adegua-
lamenle arezzalo neanche in InghiIlerra, ur essendo Ia sua oera
ubbIicala nei Ienguin ooks e recensila suI TIS. HiII, aulore finora
di nove Iibri di oesia, insegna alluaImenle Lelleralura e ReIigione
aIIa oslon Universily deI Massachusells. Credo che Io si ossa
considerare un ideaIe erede deI Danle di IIiol. I ochi versi che vi
roongo sono lralli da una sua raccoIla deI 2002 che s'inliloIa Tnc
Orcnar!s cj Sqcn:
The Iabours of lhe monlhs are nov memory,
Indigenl vordIay, slubborn, isoIale
Language of inner exiIe
33
.
32 ILIOT, Oanic, in Sc|ccic! Prcsc, ed. by }ohn Hayvard, Ienguin ooks 1955, . 101.
|La Oitina Ccnnc!ia esrime neII'ambilo deII'emozione lullo cio che, comreso lra Ia
diserazione deIIa deravazione e Ia visione deIIa bealiludine, I'uomo e caace di se-
rimenlare. I quindi, er iI oela, una coslanle soIIecilazione: aII'obbIigo di esIorare, di
scorire aroIe er cio che e inarlicoIalo, di afferrare quei senlimenli che Ia genle e laI-
voIla ersino incaace di senlire, erche non ha aroIe er esrimerIi, e neIIo slesso
lemo, uno slimoIo a ricordare che coIui che esIora aI di Ia deIIe fronliere deIIa co-
scienza comune sara caace di lornare e riferire ai suoi concilladini soIlanlo se manliene
coslanlemenle un saIdo aggancio con Ie reaIla aIIe quaIi sono gia abiluali, in Ccsa signiji-
ca Oanic pcr nc, cil., . 957j.
33 Le faliche di mesi sono ora memoria, / misero gioco di aroIe, oslinalo, isoIalo /
Iinguaggio di esiIio inleriore, in GIOIIRIY HILL, Tnc Orcnar!s cj Sqcn, VIII, London,
Ia jcriuna !i Oanic in |ngni|icrra 559
Tnc Orcnar!s cj Sqcn e cosleIIalo di richiami esIicili a Danle.
Dovendo ensare ad una ossibiIe malrice danlesca di queIIi ora ri-
cordali, vengono aIIa menle i versi 121-123 deI canlo XXXIII deI
Para!isc:
Oh quanlo e corlo iI dire e come fioco
aI mio concello! I queslo, a queI ch'i' vidi,
e lanlo, che non basla a dicer 'oco'.
Unitcrsiia !cg|i Siu!i !i Napc|i IOricnia|c
Ienguin ooks 2002, . 8 |Ia lraduzione e miaj.
GIUSIIII GRILLI
QUALCHE CONSIDERAZIONE SULLE TRADUZIONI IN
CATALANO DELLA COMEDA
Chiunque conosca aImeno un o' Ia sloria deIIa oesia calaIana
non credo che ossa nulrire dei dubbi: Danle e Ia sua Ccnc!ia vi
occuano una osizione imorlanle e coslanle neI lemo, lanlo che Ia
Ioro resenza finisce er risuIlare quasi invisibiIe, dello aIlrimenli
ossiamo anche dire che, rorio er I'eccesso di quesla rofonda
inlerferenza, e infIuenza, essa finisce er aarire siIenziosa, se non e
falla assare sollo siIenzio. I iI aradosso uno dei lanli aradossi
che cosleIIa Ia lradizione Ielleraria calaIana. || Oani e un nome che
ricorre sesso lra i calaIani, ma laIvoIla egIi aare quasi come un fan-
lasma inlermillenle, che resenla i suoi conli aII'imrovviso neIIa slo-
ria deIIa oesia, in quesla grande e a voIle ecceIIenle lradizione oeli-
ca che si e manlenula viva neI corso di quasi miIIe anni
1
. Quesla af-
fermazione (con Ia sua carica di radicaIismo) sembra che conlrasli con
Io sazio che Danle occua, unica voce slraniera moderna, neI mag-
giore e iu esleso reerlorio deIIa oesia calaIana, una creslomazia
che abbraccia lulle Ie eoche, mi riferisco aIIa Anic|cgia !c|s Pccics Ca-
ia|ans
2
. InoIlre, qui Danle, iI Danle deIIa Ccnc!ia, e doiamenle re-
senle, da una arle con Ia lraduzione di Andreu Iebrer, neI voIume
dedicalo aIIa oesia medioevaIe, daII'aIlra con Ia versione di }ose
Maria de Sagarra, in queIIo che descrive iI anorama deIIa conlemo-
ranea. isogna riconoscere che si lralla di due lesli, che aI di Ia dei Ioro
regi (o dei Ioro difelli), raresenlano una voce doiamenle emer-
genle, dove accanlo a queIIa originaIe e inimilabiIe deI fiorenlino, si
ascoIla queIIa deII'eoca e deIIa cuIlura che furono deI lradullore e
moIlo sesso Ia slessa voce deII'inlerrele che Io lraduce. C'e un dalo
eslerno, curioso, che melle in reIazione enlrambe Ie lraduzioni e coin-
1 In conlro lendenza si veda Io sludio di IRANCISCO ARDOLINO, Una |iicraiura cnirc
c| !cgna i |ncrcigia. Ics inj|ucncis !c Oanic cn |c|ra !c jcan Maraga||, arceIona, IdiloriaI
CruiIIa 2006.
2 Ideala e dirella da Marli de Riquer, GaIaxia Gullember-CercIe de Leclors, arce-
Iona 1987 (4 voIumi curali oIlre che da Riquer, da Giusee GriIIi e Giusee I. Sanso-
ne).
Giusee GriIIi 562
cide con Ia vaIulazione di aIIonlanamenlo, se non di marginaIismo,
deI danlismo calaIano: sia Iebrer che Sagarra lraducono Ia Ccnc!ia in
una condizione, in un cerlo quaI modo, di esiIiali. Iuori daIIa sua a-
lria si lrova Iebrer, in virlu dei suoi incarichi oIilici in SiciIia e in Ila-
Iia, Ionlano daII'agilazione oIilica deI aese, in uno dei suoi momenli
di maggior fervore, queIIi cenlraIi deI rimo Novecenlo, Sagarra.
InoIlre: enlrambi, quando inlrarendono iI Iavoro di lradurre Danle,
si coIIocano e si riconoscono discosli daI Ioro conleslo Iellerario e oe-
lico d'origine, oiche Ie correnli aIIe quaIi aarlenevano risuIlavano
gia anliquale e Ionlane daIIe mode alluaIi. I, finaImenle, enlrambi
reaIizzano I'oera in una slrella connessione con iI mecenalismo, regio
neI caso di Iebrer, alrizio neI caso Sagarra, che ole giovarsi deIIa
rolezione e suorlo offerlogIi da Irancesc Camb.
Iure aI di Ia di queslo arlicoIare, sono scarsi i momenli che
ossono leslimoniare una conlinuila, come dimoslra Ia bibIiografia
deIIe lraduzioni in calaIano o casligIiano in lulle Ie eoche deI
caoIavoro ilaIiano, anche da arle di lradullori o edilori calaIani
3
.
Non e che non ci siano slale diversila e roIiferazione di inlenzioni, e
che esse si sono coIIocale aII'eslerno deI cenlro oelico deIIa oesia
calaIana, sono cioe significalive neIIa sloria deIIe lraduzioni, assai
meno in queIIa deIIa evoIuzione deIIa Iingua oelica
4
. Queslo fenome-
no incuriosisce, se si liene conlo deIIa coslanle raresenlazione deIIa
cuIlura calaIana assorla neI suo milo isoIazionisla, neIIa sua ossessio-
ne oIilica, cui ben oleva offrire una sonda iI Danle voIgare deI
romanzo aulobiografico e miIilanle. In laI senso baslera qui ricordare
che I'uIlima grande sloria deIIa Ielleralura ilaIiana, reaIizzala con iI
conlribulo dei massimi seciaIisli e sludiosi, queIIa dirella da Inrico
MaIalo, concIude iI cailoIo suIIa Ccnc!ia con una affermazione
nazionaIisla, er nienle equivoca e che oleva offrire una sonda
3 Cfr. ANNAMARIA GALLINA, Inlroducci a Danle AIighieri, Oitina Ccnc!ia, ar-
ceIona, arcino (IIs Noslres CIassics) 1989, v. I. Si veda anche ID., Iresenlaci a Danle
AIighieri, Divina Comedia, versi de }OSII MARIA DI SAGARRA, arceIona, Idicions 62-
La Caixa (MOLU) 1986, v. I (cilo daIIa coia che ossiedo, Ia rima edizione deIIa ver-
sione fu ubbIicala in 3 voII. daIIa casa edilrice AIha di arceIIona, lra iI 1950 e 1952,
isirala da Camb). Si deve anche lenere conlo deIIo sludio di }OAQUIN ARCI, Oanic cn
|spaa, deI 1976, rirodollo in versione casligIiana come aendice aII'edizione Caledra
(Lelras UniversaIes) deI oema danlesco, lradollo da LUIS MARTINIZ DI MIRLO (1 ed.
1984), seguendo iI leslo rearalo da Giorgio Ielrocchi. Diverse, anche se di sommo
inleresse, sono Ie considerazioni che AngeI Creso aggiunge aIIa fine deIIa sua edizione
e lraduzione deIIa Ccnc!ia (arceIona, Seix arraI 1973-1977, ma cilo daIIa riedizione
IIanela 2002, . 597 e sgg.).
4 IncIudo in quesla Iisla Ia versione iu recenle, di }OAN I. MIRA (arceIona, Iroa
2000, anche quesla e basala suI leslo deIIa edizione di Ielrocchi).
Qua|cnc ccnsi!crazicnc su||c ira!uzicni in caia|anc !c||a Comeda 563
erfellamenle neIIa miloIogia alriollica che ho menzionalo
5
.
Iorse I'eccezionaIila deI caso ne e anche Ia sua giuslificazione. So, e
osso affermarIo, in quanlo sono slalo uno dei coIIaboralori
deII'Anic|cgia, che iI fallo slraordinario deIIa resenza di Danle e dei
suoi lradullori si deve aII'isiralore deII'oera, Marli de Riquer, che
voIIe che aIIa versione di Iebrer, er lanli aselli crealiva fino aI unlo
di lradire sia I'originaIe di Danle che Ia slrullura Iinguislica deI
calaIano
6
, si aggiungesse queIIa di Sagarra, chissa se come eIogio e
riscallo deI suo, d'aIlro canlo grandioso, anlecedenle. L'affermazione
di quesla fedeIla a Danle e uno dei lralli deIIa conlinuila deIIa Iellera-
lura calaIana aIIa quaIe Riquer ha consacralo una arle reonderanle
deI suo Iavoro, che olrebbe erfino sembrarci eccessiva. Quesla vo-
Ionla merila ero una gIossa, siego iI quaIificalivo di eccessivo ricor-
dando soIo che Ia migIiore Iellura, una Iellura che sa farsi inlerrela-
zione, deIIa oesia di CarIes Riba che ho avulo Ia forluna di ascoIlare,
e slala quando iI fiIoIogo medioevaIisla recila, ovviamenle a memoria,
i meravigIiosi lesli deIIe |sianccs. Quindi I'infrazione non occuIla af-
fallo Ie regoIe di un obIio deI leslo deIIa Ccnc!ia da arle di queIIo che
olremmo definire iI guslo deI Iellore calaIano moderno. Non vorrei
esagerare affermando che queslo e un aIlro aneIIo mancanle di una
diendenza deI mercalo calaIano daIIa sua aulonomia riguardo aIIe
mode gIobaIizzalrici e, iu concrelamenle, aII'infIuenza deIIa cuIlura
di Iingua sagnoIa in quanlo cornice inlegralrice. Ierche una cerla
marginaIizzazione di Danle non e un fenomeno calaIano, bens ri-
sonde ad una lendenza iu generaIe e diffusa, anisanica e forse
anche ilaIiana. anaIizzando olremmo dire che Danle e Ia Ccnc!ia
sconlano Ia revaIenza di un'inlerrelazione semIicislica deI elrar-
chismo come Iinea di lendenza egemone. Ma Danle resla vivo, fuori
daII'ossequio accademico, magari soslenulo neIIa sua conlinuila daI
favore ooIare, er nienle reoccualo deIIe difficoIla deIIa slrullura
leoIogica deII'oera.
Non e queslo iI Iuogo er una disserlazione suIIe Iinee di conlinui-
la o di rollura di una lradizione lanlo comIessa come queIIa calaIana,
ne er lracciare, er quanlo er sommi cai, una sloria deIIe reIazioni
lra oesia ilaIiana e oesia calaIana. I mi iace ricordare che I'IlaIia e
slala, ed e resenle, in cerla misura, neIIa enisoIa enlagonaIe qui
condivido e adollo Ia definizione deI grande comaralisla Mario Iraz
5 Cfr. INRICO MALATO, Sicria !c||a |ciicraiura iia|iana. Oa||c crigini a Oanic, Roma,
SaIerno edilrice 1995, voI. I, 2 (cilo daIIa rislama de || Sc|c 24 crc, MiIano 2005, . 1028).
6 Conlinua ad essere imrescindibiIe Io sludio di ANTONI ADIA MARGARIT, Ia
tcrsicnc !c||a Oitina Ccnnc!ia !i An!rcu |c|rcr (scc. XV) c |a |ingua |ciicraria caia|ana, in
Aiii !c||V||| Ccngrcssc Nazicna|c !i Siu!i |cnanzi, Iirenze 1958, . 8-9.
Giusee GriIIi 564
con una solliIe e sollerranea vena che I'idenlifica come Sefarad: Ia
Sefarad di Isriu e risaIendo aII'indielro neI lemo queIIa dei
crisliani nuovi, cos come dei coIIaboralori ebrei dei re deI casa| di ar-
ceIIona lanlo imorlanli neIIa sloria deIIa CalaIogna lrionfanle neIIa
sua fase esansionislica e imeriaIe
7
.
Sono quesle sicuramenle digressioni, e come laIi semre imerli-
nenli, ma senza una laIe remessa, non si olrebbe comrendere
Ia rivendicazione che qui mi roongo, queIIa di un Danle che are
Ie orle aI grande Ausias March con Ia radicaIila deIIa sua aroIa,
moderna, senza inlraIci o comromessi, ma er queslo er nienle
inlimidila aI cosello dei cIassici. Id e di nuovo Ia voce di Danle, con
Ia mediazione di Sagarra, ad arricchire e orlare a comimenlo iI so-
gno deI nuovo umanesimo orsiano di }ose Carner, resliluendo aIIa
Iingua una sonorila deurala dai barbarismi, da cacofonie, da durezze
non necessarie: ancora radicaIe, ma gia resa iu soave e diaIoganle
neIIe sue corrisondenze. I di nuovo iI aradosso fa caoIino, erche
Sagarra neIIa sloria evoIuliva (o evoIuzionislica) deIIa Ielleralura cala-
Iana si one come iI maggior oosilore, er quanlo giganleggi,
aI cosello deIIa revaIenza assoIula deI ncuccniisnc er lulla Ia
durala deI XX secoIo, una durala abnorme, sicuramenle favorila daIIa
coIlre di slalicila imosla daIIa Iunga fase di inleriorizzazione imosla
daI franchismo
8
.
I queslo iI molivo di maggior eso che mi ha indollo a scegIiere
I'uIlimo canlo deIIa Ccnc!ia er aIcune considerazioni suII'inse-
rimenlo esIicilo di Danle neIIa lradizione oelica calaIana. Ierche iI
Para!isc, neI lraccialo gIobaIe deIIa oesia danlesca, occua iI Iuogo
iu aarlalo, giacche, se quaIcosa ermane neIIa memoria deI Iellore,
aarliene aII'|njcrnc e, sebbene in misura minore, aI Purgaicric, er Ie
sue imIicazioni conlesluaIi e er i moIli riferimenli suscellibiIi di ia-
cere a orecchie allralle daI reaIismo e daIIa maIinconia.
Da un'aIlra roselliva iu essenziaIe, I'|njcrnc e iI Purgaicric si
carallerizzano, inoIlre, er una forza rimaria, neIIa misura in cui
resenlano una loografia deII'ilinerario deI rolagonisla imbricala
neIIa lrama slessa deIIa coslruzione narraliva. NeI Para!isc iI cammino
deI rolagonisla narralore si risoIve invece su di un iano comIela-
7 IncidenlaImenle ricordo che Ie Iellure novecenlesche di Danle si coIIocano in con-
lemoranea con Ia grande uloia di Americo Caslro di re-inlerrelazione gIobaIe deIIa
sloria oIilica e cuIluraIe deIIa IenisoIa in una chiave di casia, cfr. AMIRICO CASTRO! Ia
Spagna nc||a sua rca|ia sicrica, Iirenze, Sansoni 1955 (I ed. in sagnoIo, 1948).
8 AI riguardo, cfr. NARCIS GAROLIRA-IULALIA MUMRU, jcscp Maria !c Sagarra, Va-
Iencia, IIiseu CIimenl 2003. Lo slesso GaroIera si e converlilo neII'edilore crilico e vin-
dice deII'Opcra cnnia di Sagarra, di cui sono gia uscili i rimi voIumi.
Qua|cnc ccnsi!crazicnc su||c ira!uzicni in caia|anc !c||a Comeda 565
menle melaforico e ai Iimili sensoriaIi di coIui che cammina si deve
escIusivamenle Ia !ispcsiiic di un lerrilorio allraversalo come una
dimensione saziaIe, con Ia sua durala lemoraIe correIala. In aIlre
aroIe: iI viaggio di Danle, se Io si rende in considerazione in una
roselliva reaIislica, si concIude neI Purgaicric, neI Para!isc iI suo
ercorso non ha ne uo avere aIlro significalo che queIIo di una co-
slanle raresenlazione melaforica deIIe idee soggiacenli
9
. DaI mio
unlo di visla quesla aslrazione che domina I'uIlima Canlica, invece,
ermelle di erceire megIio Ie ossibiIila di lrasorlare iI leslo dan-
lesco neII'ambilo di uno sliIe (scrillura, con un lermine iu recenle e
aIIa moda), calaIanizzalo dai lradullori.
D'aIlra arle, Io slesso Sagarra, are iI suo commenlo aI canlo in
queslione: Par. XXXIII (e si dovrebbe ricordare semre che iI suo Iavo-
ro di lradullore si riafferma in ogni canlo grazie ad una annolazione
unluaIe deI leslo danlesco) con una dichiarazione che olrebbe risuI-
lare slrana, coIIocala aIIa fine deI oema, giacche si riferisce aI caralle-
re slesso deIIa scrillura di Danle
10
.
Senza relendere di effelluare una |cciura Oaniis deI canlo, mi
ermello di indicare neIIa coslruzione deII'uIlima arle deI oema, in
esso imIicila, Ia chiave er comrendere Ia slessa sfida deIIa lradu-
zione. I Ia fine deI oema non si aIIonlana da una idenlificazione con
Ia slrullura generaIe, erche Ia slraordinaria grandezza deII'oera
risiede giuslamenle neIIa caacila di affermare e manlenere una con-
linuila di sliIe nonoslanle Ie sue divisioni inlerne e Ie sue IocaIizzazio-
ni secifiche.
In queslo senso e ossibiIe indicare aIcune sezioni significalive
deIIa lerza Canlica, Ie cui coslanli ermellono di verificare I'in!iti-
!ua|iia deI oema, Ia sua vaIidila originaIe, singoIare, neII'ambilo deIIa
grande variela lemalica che Io arricchisce e che Io sinlelizza. Da qui
che Ia coslruzione deI finaIe roceda con armonia, sebbene non ossa
evilare Ia rollura deIIa verlicaIila deI oema, disonendosi aI cuImine
deIIa sua deslinazione leoIogica. I olremmo affermare che quesla
sinlesi si reaIizza giuslamenle neIIe ma anche grazie aIIe sue disIo-
cazioni arziaIi. La rima e sicuramenle queIIa deII'incipii, con iI rife-
rimenlo aIIa Vergine, che si concIude, in erfella coerenza con lullo
I'ilinerario inleIIelluaIe danlesco, con I'evocazione di ealrice. In que-
slo quadro, non ochi crilici, e lra i iu allenli e ersicaci, hanno se-
gnaIalo un cerlo ossibiIe regresso sliInovisla di quesla comarsa de-
9 IndimenlicabiIi er me Ie Iezioni di SALVATORI ATTAGLIA raccoIle in |scnp|ariia c
aniagcnisnc nc| pcnsicrc !i Oanic, NaoIi, Liguori 1966.
10 Si Ieggano Ie . 418- 419.
Giusee GriIIi 566
Iineando in concrelo una Iinea di riscallo de Ia tiia nucta
11
. Ierche se
ossiamo considerare ancora alluaIe e vigenle Ia definizione di Auer-
bach a roosilo deI carallere figuraIe di quesle lerzine come eIogio
deIIa Vergine, reghiera, orazione
12
, e ossibiIe ensare che Ia sua no-
vila Iilurgica conlenga Ia forma roria (relorica) deII'esordio. Si lral-
la, in ogni caso, di una delerminala rivendicazione deI moderno, ma
che cerca anche un equiIibrio comensando iI suo effello, aIcuni versi
iu in Ia con Ia resenza di aragoni dove sicca Ia miloIogia cIassica
grazie aIIa cilazione degIi argonauli. Ovviamenle mi riferisco qui ad
uno dei |cci iu conlroversi deII'esegesi danlesca reIaliva a queI canlo,
recisamenle aI lermine |ciargc e aIIa icrzina che Io conliene
13
. Id e
imossibiIe eIudere queslo viaggio aIIa ricerca deIIa saIvezza milica,
uno degIi aneIIi di coIIegamenlo neIIa coslruzione deIIa loografia
come slrullura deI leslo Iellerario, seguendo iI modeIIo deII'O!issca,
ralificalo da Danle a arlire daII'|njcrnc
14
e che ora, nonoslanle un
conleslo cos diverso, conlinua ad essere resenle. Infine, con I'am-
Iiamenlo deIIa melafora resenle negIi uIlimi versi come chiave ma-
lemalica, si concIudono sia iI canlo che I'inlero Ioema.
Sono quesli i unli che mi servono come caisaIdi er anaIizzare Ie
inlerrelazioni dei lradullori, non gia con I'inlenzione di vaIulare Ia
Ioro adronanza deIIa Iingua, bens di delerminare Ia Ioro caacila di
seIezionare Ia versione iu adeguala o, in ogni caso, er dislinguere iI
carallere iu o meno ersonaIe deIIe Ioro ozioni.
Irocedo mellendo a confronlo Iebrer e Sagarra, eslendendo Ia
comarazione ad aIcuni lradullori che doo di Iui hanno affronlalo Ia
slessa sfida con I'ausiIio, aImeno olenziaIe, di nuovi e iu ricchi
suorli crilici ed ermeneulici, a arlire daII'edizione Ielrocchi, deIIa
quaIe ovviamenle Sagarra non ole avvaIersi. Vedremo che Ie soIu-
zioni oeliche di Iebrer e Sagarra sono, in un cerlo senso, isoIale e
singoIarmenle ersonaIi, sebbene non Ie si ossa definire arbilrarie, Ia
11 Cfr. ROIRTO MIRCURI, Bcairicc, !ranaiis pcrscna !c||a Ccnc!ia, in Maria Iicchio
SimoneIIi (a cura di), Bcairicc nc||cpcra !i Oanic c nc||a ncncria curcpca. 1290-1990, Nao-
Ii-Iirenze, IUO-Cadmo edizioni 1993, . 157-182. In una Iinea di lendenza non oosla
si muove anche RAIIAILI IINTO, || tiaggic !i riicrnc. P!. XXX|||, 142-145, Tenzone,
n. 4 (2003), . 199-225, deIIo slesso ricordo iI saggio maggiore: Oanic c |c crigini !c||a
cu|iura |ciicraria nc!crna, Iaris, Chamion 1994.
12 IRICH AUIRACH, Ia prcgnicra !i Oanic a||a Vcrginc (Par. XXX|||) c! aniccc!cnii
c|cgi, in ID., Siu!i su Oanic, MiIano, IeIlrineIIi 1966.
13 Si veda, aI riguardo, I'annolazione di SAGARRA (o. cil., . 420- 421) e Ie osle-
riori edizioni deI oema in casligIiano, seciaImenle queIIa di AILIO ICHIVIRRIA, Ma-
drid, AIianza ediloriaI 1995, . 628.
14 Rilengo uliIe ricordare che ANTONINO IAGLIARO sceIse er iI suo grande Iibro
danlesco iI liloIo di U|issc. |iccrcnc scnaniicnc su||a Oitina Ccnnc!ia, Messina-Iirenze,
D'Anna 1967.
Qua|cnc ccnsi!crazicnc su||c ira!uzicni in caia|anc !c||a Comeda 567
quaI cosa Ie rende lanlo iu inleressanli daIIa roselliva qui adollala.
UliIizzo un sislema di sigIe moIlo semIice er dislinguerIe, Iimi-
landomi a cilare qui iI nome deI lradullore e I'anno deIIa rima edi-
zione deI suo Iavoro (neI caso di Iebrer, ovviamenle deIIa coia ma-
noscrilla, in quanlo a Sagarra, saiamo che iI suo Iavoro inizio moIlo
rima di vedere Ia Iuce come Iibro):
C: AngeI Creso (1973-1977)
|: AbiIio Icheverria (1995)
MM: Luis Marlinez de MerIo (1984)
|: Andreu Iebrer (1429)
S: }ose Maria de Sagarra (1950-1952)
Mir: }oan I. Mira (2000)
Iniziamo con iI confronlo deIIe risellive versioni deII'incipii
(vv. 1-3):
Vergine Madre, figIia deI luo figIio, (v. 1)
Oh, virgen madre, hi|a de lu hi|o (C)
Sanla Virgen y Madre, Hi|a de lu Hi|o (I)
Oh Virgen Madre, oh Hi|a de lu hi|o (MM)
Verge Mare, e fiIIa deI leu fiII (I)
Oh Verge Mare, IiIIa deI leu IiII (S)
Verge mare, i fiIIa deI leu fiII (Mir)
umiIe e aIla iu che crealura, (v. 2)
humiIde y aIla mas que olra crialura, (C)
aIla y humiIde como no hay crialura, (I)
aIla y humiIde mas que olra crialura, (MM)
aIla e humiI Ius que aIlra crealura, (I)
Ia mes humiI i exceIsa crialura, (S)
aIla i humiI mes que ca crialura, (Mir)
lermine fisso d'ellerno consigIio, (v. 3)
deI conse|o elernaI lermino fi|o, (C)
deI Ian elerno de Dios lermino fi|o, (I)
lermino fi|o de elerno decrelo, (MM)
lerme affix de I'elernaI consiII, (I)
d'elern conseII inaIlerabiIe esiII! (S)
Giusee GriIIi 568
lerme immulabiIe d'un design elern, (Mir)
Come si evince, e nonoslanle Ie dichiarazioni ressoche concordi
da arle dei lradullori riguardo aII'indoIe deI leslo danlesco, basalo
suII'unila minima deIIe lerzine, che e da rilenersi iI maggior vincoIo di
fedeIla aI leslo di arlenza, ho adollalo iI crilerio di una disosizione
inlerIineare deIIe diverse versioni, verso er verso, er rendere conlo
di un dalo evidenle e significalivo: Ia forle diendenza daII'originaIe
deIIa slrullura sinlallica, morfoIogica e IessicaIe deIIe lraduzioni
moderne, cos come di queIIa anlica di Iebrer, che segue, cos come si
riele neIIa bibIiografia magari con un eccesso di insislenza, iI crilerio
medioevaIe di lradurre tcr|un tcr|c.
RisuIla sorallullo degno di nola che neI v. 3 Sagarra ola er
I'inlroduzione, aI oslo deI danlesco icrninc jissc che Iebrer conserva
medianle I'inversione deII'ordine aggellivo-soslanlivo, di un'immagi-
ne che uo evocare moIlo direllamenle iI Iinguaggio oelico ausias-
marchiano: cspi||. Quesla innovazione, abbondanlemenle giuslificala
da Sagarra neI suo commenlo, si manliene ancor oggi isoIala neII'am-
bilo deIIe lraduzioni seIezionale, incIudendo anche Ia iu recenle di
Mira. Ma non credo sia corrello inlerrelare Ia sceIla di Sagarra soIo in
una chiave oelica lradizionaIe, senza imIicazioni di ermeneulica
danlesca. In reaIla saiamo che iI leslo di Danle e ineslricabiIe e in-
comrensibiIe fuori daIIa sua slrullura comIessa di cuIlura. La di-
slinzione lra una soIida quercia e una fogIia briIIanle non ermelle di
comrendere iI vaIore deII'oera. Cos, neI noslro caso e ossibiIe (fi-
nanche con iI ricorso aII'esame comaralivo deIIe lraduzioni) segnaIa-
re Ia correnle verlicaIe deIIa Iingua oelica deI lradullore. I d'uoo
anche ricordare che Ia figura spccu|un e iscrilla neII'|pisiu|a a! Ccrin-
incs come chiave deIIa ercezione (visione mislica) di Dio
15
. I d'aIlra
arle, saiamo fino a che unlo quesla robIemalica e rilornala a
slare aI cenlro deI diballilo crilico conlemoraneo, con conlribuli deci-
sivi di Auerbach, Corli o Dronke
16
.
In un assaggio successivo, che si are con un lermine assunlo daI-
Ia crilica come fondanle deIIa oesia di March
17
, c| scnni, Ie versioni di
15 Cfr. MALATO, o. cil., . 966, dove si comara iI leslo di San IaoIo con iI discorso
di San ernardo neI canlo immedialamenle anleriore, iI XXXII, moIlo vaIorizzalo neI
commenlo di Sagarra.
16 I d'uoo ricordare anche iI saggio ionierislico di MARIO CASILLA, II canlo
XXXIII deI Iaradiso, in AA.VV., Icciura Oaniis Sca|igcra, |||: Para!isc, Iirenze, Sanso-
ni 1965, . 2021-38, che seIeziono anche er iI Iegame deI fiIoIogo fiorenlino con Ia
cuIlura calaIana dei rimi decenni deI secoIo XX (cfr. ID., Saggi !i |ciicraiura prctcnza|c c
caia|ana! ari! Adrialica edilrice 1966).
17 Cfr. GIUSIIII GRILLI, Cancicncrcs nisp4niccs (Marcn q Garci|asc). iras |as nuc||as !c|
Qua|cnc ccnsi!crazicnc su||c ira!uzicni in caia|anc !c||a Comeda 569
Iebrer e Sagarra discreano curiosamenle a favore, da arle di Iebrer,
di una digressione inlorno a una conlesluaIizzazione cavaIIeresca
deIIa simiIiludine danlesca. Iorse e qui che risiede iI vaIore suggeslivo
deI febreriano c|iragc, gia segnaIalo da Annamaria GaIIina come
ilaIianismo
18
. In ogni caso Ia forzalura uo giuslificarsi con Ia ro-
ensione aIIa melafora, cosicche Ia lraduzione e aI lemo slesso una
iercorrezione deI leslo. I inleressanle vedere come aIlri lradullori
moderni evilano di comIicarsi Ia vila e ci danno un lagIio:
QuaI e coIui che sognando vede, (v. 58)
Como aqueI que esla viendo mienlras suea, (C)
Como cuando soamos nos sucede (I)
Como aqueI que en eI sueo ha vislo aIgo, (MM)
QuaI es aqueI qui somia veser, (I)
I com aqueII que surl de Ia balaIIa (S)
I com aqueII que veu aIguna cosa en somnis, (Mir)
che doo 'I sogno Ia assione imressa (v. 59)
que lras eI sueo Ia asin imresa (C)
eI conservar Ia sensacin imresa (I)
que lras eI sueo Ia asin imresa (MM)
e res deI son Ia assi imressa (I)
d'un somni, i si en manle Ia assi (S)
i que desres Ii'n queda Ia imressi (Mir)
rimane, e I'aIlro a Ia menle non riede, (v. 60)
queda, mienlras eI reslo se desdea, (C)
que sin aenas deI reslo nada quede, (I)
ermanece, i eI reslo no recuerda, (MM)
roman, e I'aIs no orl |es relener, (I)
lol eI reslanl en eI record Ii faIIa, (S)
ero no le ca record de Ia resla, (Mir)
L'anliciazione reaIislica deI sogno di Danle, un sogno che secon-
do Sagarra ermane e svanisce in una Iolla, in uno sconlro dove soIo
Canzcnicrc !c Pcirarca, in IATRIZIA OTTA ci a|ii (eds.) Canzcnicri i|crici, A Corua, ibIio-
leca IiIoIgica, Toxosoulos 2001, voI. II, . 119-139.
18 Id. cil., voI. VI, . 225, nola 57.
Giusee GriIIi 570
uo vincere chi ossiede e imiega maggior tirius
19
, forse e Ia chiave
er inlendere iI senso rofondo e aIquanlo enigmalico deI rilorno
aIIa miloIogia imIicilo neII'aIIusione aIIa novila, er Nelluno, deI
viaggio di Giasone, eIemenlo che si lrova aII'aIlezza deI verso 94 (Un
unlo soIo m'e maggior Ielargo / che venlicinque secoIi a Ia 'imresa /
che fe' Nelluno ammirar I'ombra d'Argo), un giro sorrendenle e
imrorio neI Iuogo ceIesliaIe deI Canlo.
Iiu comIesso e iI finaIe deIIa Canlica: aulenlica aoleosi deI oe-
ma che one, ovviamenle, i lradullori di fronle ad uno dei momenli
iu difficiIi deIIa Ioro imresa. Ierche lerminare e semre un imegno
imossibiIe, una sfida er Ia quaIe non e necessaria nessuna reIica (o
riscrillura). Se I'uIlimo verso, con iI suo esIicilo rinvio aIIa fine deIIe
aIlre due Canliche sleIIe, non ammelle variazioni di aIcun lio,
nemmeno Ia magislraIe simiIiludine geomelrico-malemalica uo (o-
lrebbe) delerminare soIuzioni che si aIIonlanano daI semIice caIco
Iinguislico, essendo queslo soIo aarenlemenle garanzia di fedeIla,
in quanlo Ia sua overla inlrinseca lradisce semre
20
. Iorse er queslo
Iebrer anlicia Ia suggeslione deII'immagine lecnica deIIa difficoIla di
Danle (vv. 133 135) con un'eIaborazione ersonaIe deIIa difficoIla
deII'c|ccuiic (vv. 121 123):
O quand es curl esl dir e rauc que loch
aI meu concele! e o, a aIIo que vi,
es lanl, que no basla soI a dir 'och'.
Le sonorila deI calaIano deI Quallrocenlo qui ci forniscono una
reIica originaIe (forse I'unica immaginabiIe) di queIIa Iuce umana,
queIIa deIIa voce narraliva dinanzi aIIa Iuce infinila di cio che e
divino
21
. AI conlrario, Sagarra riesce a rimandare aIIa lerzina suc-
cessiva (vv. 124 -126) Ia resonsabiIila di consegnare Ia grazia di quaI-
cosa di enigmalico e significalivo aIIo slesso lemo: Io olliene recue-
19 A laI roosilo sembra veramenle slrano che a queslo unlo iI Circu|c !c
Iccicrcs riroduca Ia lraduzione deI 1967 di Iernando Gulierrez dove si semIifica
I'inlerrelazione di Sagarra fino ad eslremi che roducono una enosa imressione di
overla (. 678). Cfr. anche Ia versione Creso (o. cil., . 593 commenlo a . 596 )
che, basandosi su Saegno, adolla una soIuzione meno comIessa di queIIa di Sagarra.
20 II riferimenlo aII'insufficienza deIIa cuIlura scienlifica e, gia si sa, lradizionaIe in
Danle (Ccntitic II XIII, Oc Mcnarcnia III 2). SoIilamenle qui si considera come un argo-
menlo in favore deIIa visione mislica, come unica orla ossibiIe verso I'inleIIigenza di
Dio da arle deII'uomo.
21 Ricordo, a queslo roosilo, iI cailoIo moIlo suggeslivo di ATTAGLIA, |scnp|a-
riia c aniagcnisnc nc| pcnsicrc !i Oanic, gia ricordalo sora, inliloIalo L'umano e iI divi-
no neII'uIlimo canlo deI Iaradiso.
Qua|cnc ccnsi!crazicnc su||c ira!uzicni in caia|anc !c||a Comeda 571
rando daI leslo danlesco una aroIa slraordinaria neII'ambilo deI
Iessico oelico deI calaIano moderno (da MaragaII a Isriu, as-
sando er Carner, er arodare oi in Gimferrer e Comadira): iI
scnriurc.
Oh LIum Ilerna en Tu soIa vius,
soIa l'enlens, i de Tu coneguda
i enlenenl-le, l'eslimes i somrius!
Iorse, fiducioso di quesla anliciazione, aIcuni versi iu avanli si
arrischia ad indicare (con Ia forza aggiunla deII'accavaIIamenlo)
nctc||cs ruics in un unlo che finanche iI migIiore inlerrele casli-
gIiano deI oema, AngeI Creso, risoIve rudenlemenle con nuc||as.
Siamo giunli ad un Iimile che non oso suerare. I robIemi e/o
i suggerimenli che I'esercizio deIIa lraduzione evidenzia queIIi che
sono via via emersi neI camione cos ridollo che abbiamo esami-
nalo rimandano a robIemi di grande enlila, reIalivi aII'inlerre-
lazione deI canlo (Par. XXXIII) e che imIicano direllamenle e indirel-
lamenle Ia Iellura gIobaIe deI Ioema. Vengono qui a roosilo su|
spccic i noli equiIibri e squiIibri deIIa Ccnc!ia. La sua idenlila di
ja|u|a e iI suo conlrario di nisicria. Tullavia, non credo sia corrello a-
rofillare deI Iavoro dei lradullori er addenlrarsi in laIi queslioni.
Ma mi sembra inleressanle evidenziare che iI leslo di Danle e laI-
menle denso di significalo che non uo non suscilare, incIuso neIIe
lraduzioni, indiendenlemenle daIIe differenze deIIa Iingua, deI
conleslo e sensibiIila oelica, nuove simiIiludini aIimenlale daIIa
vila inlerna deI oema neI corso dei secoIi. Ierche Ia Ccnc!ia vive
e soravvive aIIe diverse Iellure e inlerrelazioni, cos come neIIe
sue lraduzioni, ersino neIIe Ioro risoIuzioni negalive. D'aIlro canlo,
se Ia lradizione lesluaIe deII'oera resisle con Ia sua conlamina-
zione recoce ad ogni sforzo di disorre in sequenza i codici er
ricoslruire uno sicnna affidabiIe, nemmeno abbiamo olulo ollenere,
er Ie lraduzioni anliche, una sislemalizzazione adeguala. Cos, ri-
suIla imossibiIe delerminare a quaIe leslo deIIa Ccnc!ia si allenne
Iebrer e se ne consuIlo iu di uno. Queslo fallo mi sembra embIe-
malico, erche nonoslanle quanlo finora si e dello, credo che ci risuI-
lerebbe semre incerla un'allribuzione deIIe lraduzioni moderne a
recise correnli crilico-inlerrelalive, cos come risuIla davvero arduo
fissare con recisione iI Iuogo deIIa lradizione manoscrilla in cui
si siluano queIIe anliche. Godiamo, aIIora, dei Ioro suggerimenli,
senza chiedere che si dichiarino in maniera escIusiva a favore di
queslo o queI ramo deIIo slemma, oure deII'esegesi crilica e inler-
Giusee GriIIi 572
relaliva. Ierche, sebbene iI Ioro aulore slesse rivoIgendosi verso
Ia nisicria, Ia ralica deI suo esercizio finirebbe forzalamenle er sin-
gerIo verso Ia ja|u|a. Tradurre e, in fin dei conli, un Iavoro Iellerario
senza sconli ossibiIi.
Unitcrsiia !cg|i Siu!i |cna Trc
Lectura Dantis 2005
a cura di Anna Cerbo, Aleksandra abjek e Ciro Di Fiore
"#$%&' &$#()%)
*$ &#'&)$+$ , *$ &'#+,-)$. ($%+, ()%$%/)
$**0)-*$12 +#$ 1$'1,++' , )* -$*$()%'
(3456 $789:86;8 :3 <8==>5? 84 @864? 87 A;>A8376 B?B645? 84 A>8 73
A>75>;3 A;8=5834?C735843 6D 6>;?@63 =8 5;?<3<3 D8434E8 3 >43 =6;86 D8
B>53B6458 6@?A378F D3 >4 735? 87 G3778B645? D6773 A;?A8353 84 +6;;3=34C
532 98H @;?=@65535? D37 =6A?4D? A?4A878? D8 *8?46 377?;A:I J;69?;8?
K @;?@?=6 D8 ;3AA?9786;6 8 ncncran!un =>773 G3558L8785H D67708B@;6=32
=34A85? 8B@78A853B6456 D3 M?48G3A8? N))) 377?;A:I2 A?7 J8>L876? D67
OPQQ2 84D8AR 3773 &;8=583485H >43 @?==8L8785H D8 3B@83 =6 4?4 5?5376
=?=585>E8?46 D67 @67769;843998? 96;?=?78B8534? A?4 S>677? ;?B34? 6
7698558B35? 6=@78A853B6456 D37 A?4A878? D8 N86446 A?4 7? =A8?978B645?
D6770';D846 56B@73;6 6 7084564=8G8A3E8?46 T=?=534E837B6456 U3756;4358C
<3V 3773 A;?A8353W D6773 7?553 37706;6=83 6 38 46B8A8 8456;48 3773 sccicias
cnrisiiancrun, U@6998?;8 D68 =3;3A648VX D3770375;? S>677? D67 ;3D8A3B64C
5? D6978 8D6378 A?;56=8CA3<3776;6=A:8 ;8=?758 84 56;B848 B8=58A8 467 Ii|rc
!c||Or!inc !c||a cata||cria D8 #38B?4D? *>77?2 467 S>376 Y L64 <8<3 73
B6B?;83 D8 S>67706489B358A? 56=5? D>6A6456=A?2 70Or!cnc !c cncta|cric,
467 S>376 Z9? A?456 D8 +8L6;83D6 <6=56 A3<3786;6 87 -373D84?. *3 A;?A83C
53 4?4 Y B38 =5353 >43 U9>6;;3 D8 ;67898?46V2 4?4 :3 B38 56=? 3773
A?4<6;=8?46 A?3553 D6978 84G6D678X 6D Y =5353 sanciun |c||un =?7? 46773
B8=>;3 84 A>8 sanciun 6;3 70?99655? A?456=? 5;3 A;8=58348 6 =3;3A6482 87
Sanciun Scpu|cnrun, 73 Sancia Citiias D8 J6;>=376BB62 73 Tcrra Sancia.
%?4 A0Y 5>553<83 D>LL8? A:6 46773 A?=A864E3 D67 56B@? G?==6 <8<3 708D63
A:6 70U8498>=58E83V A:6 3<6<3 @;6@?=5? 3773 @6;D853 D67 A?45;?77? A;8C
=5834? =>773 &855H -3453 6;3 =5353 D?<>53 37 D8GG?4D6;=8 D6773 @6;<6;=3
@;6D8A3E8?46 D8 13?B655?. +>55? A8R D656;B843<3 >4 846=5;8A3L876 4?C
D? D8 A?45;3DD8E8?48F A?B6 @?56<34? B38 978 84G6D6782 3D6@58 D0>4
894?L876 A>75? D0?;89846 6;658A3762 D8B?=5;3;=8 5345? =@6==? >?B848
<8;5>?=8 6D 6==6;6 76378 6 A?;3998?=8 A3<3786;82 <8<6456 6 B843AA8?=?
;8B@;?<6;? 38 A;8=58348 A:62 D65645?;8 D6773 N6;85H2 =8 B?=5;3<34? 5345?
=@6==? B6D8?A;82 <878 6 B37<398 468 G3558[ -8 @?46<3 375;6=\ >4 @;?L76B3
D8 56?D8A63F J6;>=376BB6 6;3 34D353 @6;D>53 @6; U98>=53 <64D6553V
D8 (8?2 pcccaiis ncsiris cxigcnii|us, 70845;84=6A3 B37<3985H D6770)=73B
A?4<8<6<3 A?4 76 <8;5] D68 =3;3A6482 A:06;34? 6 ;6=53<34? 5>553<83
";34A? &3;D848 ^_`
U96456 5>;@3V2 A?B6 D8A6 (34562 84 S>345? =69>3A8 D8 >4 848S>? @=6>C
D?@;?G653X B3 D0375;3 @3;56 a 6 S>8 (3456 =3;6LL6 =535? =69>85? D3
5>553 73 9;34D6 A>75>;3 D67 4?=5;? 'AA8D64562 D37 M?AA3AA8? 37 *6==849 a
87 -373D84? =8 @;?@?46<32 A?4 76 =>6 <8;5] D8 9646;?=85H 6 D8 B394348C
B85H2 A?B6 =@6AA:8? 6 B?D677? D8 @6;G6E8?46 A3<3776;6=A3 3978 =56==8
A;8=583482 @>; 6==64D? A?7>8 A:6 3<6<3 A3AA835? 467 OOb_ 8 A;?A8358 D3
J6;>=376BB6.
*3 Oitina Ccnnc!ia =8 =85>3 37 A645;? D8 S>6=5? 4?D? @;?L76B358A?2
6=@78A8535? =83 46773 A?77?A3E8?46 D67 -373D84?2 =83 @>; U=?7?2 84 @3;56V2
5;3 978 -@8;858 B3948 D6770$4584G6;4?2 =83 46773 G6;B3 A?4D3443 D8 13?C
B655? A?B6 =6B8435?;6 D8 =A8=B8 =6A?4D? 8 AH4?48 D6773 =>3 A676L;6
769964D32 =83 46773 7?D6 3758==8B3 38 B3;58;8 A;?A8358 467 &867? D8 13;562
6 =?@;355>55? 37703<? &3AA839>8D3.
13 3 S>6=5? @>45? >4 @;?L76B3 =8 @?46F A:6 A?=3 =3@6<32 A?4 @;6C
A8=8?462 (3456 D67 B?4D? B>=>7B34?[ -64E3 D>LL8? @?A:6 A?=6F
A?B6 @8] ? B64? 5>558 8 =>?8 A?456B@?;3468 6978 =8 ;3BB3;8A3<3 D67
G3778B645? D6776 A;?A83562 A>8 3<6<3 @3;56A8@35? >4 =6A?7? 6 B6EE?
@;8B3 87 A3@?=58@856 D6773 =>3 G3B89783
O
2 6 73B6453<3 A:6 8 B>=>7B348
4?4 G?==6;? 34A?;3 @;?458 3773 A?4<6;=8?462 A?B6 D8A:83;3 467 A345? K)
D6773 56;E3 &3458A3 D6773 Oitina Ccnnc!ia2 S>6773 D6D8A353 37 c3;3D8=?2
@3;734D? D6773 <8=853 D8 ";34A6=A? D0$==8=8 37 =>7534? 3dd>L8D6
D0,9855?. )4 3@@3;64E32 76 =>6 A?4?=A64E6 =>770)=73B 6;34? @6;5345?
=A3;=6 6 A?4<64E8?43782 B?75? 84G6;8?;8 3 S>6776 A:6 D8 6==? =8 @?56<34?
3<6;6 46773 -@3943 ? 46773 -8A8783 D67 =>? 56B@?. ,978 6;3 >4 ;3@@;6C
=6453456 D6773 A?;;6456 @?658A?CG87?=?G8A3 D67 U(?7A6 -587 %?<?V2
@;?G?4D3B6456 34A:6 =6 84D8;6553B6456 A?446==3 3773 @?6=83 3;3L?C
8L6;8A3 6 3;3L?C=8A878343 6 8B@;694353 D8 G87?=?G83 3<6;;?8=53 B3 4?4
@;8<3 D8 A?446==8?48 A?4 87 =>G8=B?2 A?B6 4?8 B?D6;48 L64 =3@@83B?
e
F
B3 D8 5376 ;3@@?;5? 4?4 =6BL;3 3<6; 3<>5? @;6A8=3 A?4=3@6<?76EE3.
(34562 A:6 3<6<3 3AS>8=535? D8B6=58A:6EE3 A?4 73 G87?=?G83 =A?73=58C
A3 46978 Siu!ia D?B648A34? 6 G;34A6=A34? D8 "8;64E62 A?4?=A6<3 6
A?4D8<8D6<3 87 98>D8E8? =>770)=73B 6=@;6==? D3773 Sunna ccnira gcnii|cs
D8 +?BB3=? D0$S>84?2 84 @3;58A?73;6 73 56=8 D67 ;3@@?;5? 5;3 87 =>AA6=C
=? D6773 4>?<3 G6D6 6 73 @;656=3 78L6;5H =6==>376 D37 c;?G653 A?4A6==3 38
=>?8 G6D678. )7 98>D8E8? D3 7>8 6=@;6==? => 1>:3BB6D2 A:6 6978 ;858646
>4 6;658A? A;8=5834? 6 >4? =A8=B358A? 6 A?77?A3 3770)4G6;4? 467 A345?
O Par., XV.
e Cfr. GIUSEPPE TARDIOLA, Ancor nel libro suo che Scala ha nome, Letteratura
italiana antica, I, 2000, pp. 59-67, part. p. 64, per il rinvio agli studi di Maria Corti e di
Rocco Montano, ma soprattutto di HENRY CORBIN, Limagination cratrice dans le soufisme
dIbn Arabi, Paris 1958, e i due saggi di ELMIRE ZOLLA, Amori soprannaturali in terre
islamiche e La Dama e lamor cortese, in IDEM, Lamante invisibile, Venezia 1986, pp. 101-13.
Ia Crcciaia c |a Ccricsia. Oanic !inanzi a|||s|an. ^__
KKN))) D6773 @;8B3 &3458A32 4?4 3<6<3 4>773 D8 ?;8984376F =8 ;8G3A6<3
3773 A?B@76==3 U769964D3 46;3V A:6 ;89>3;D? 3 7>8 A8;A?73<3 84 'AA8C
D64562 6 76 B?756 <6;=8?48 D6773 S>376 A?4?=A83B? 9;3E86 3 >403B@83
B6==6 D8 =5>D8 A;858A82 3 @3;58;6 D3 >4 A676L;6 =3998? D67 G87?7?9? 853783C
4? $76==34D;? (0$4A?43 6D85? 467 Obbf
P
.
(0375;?4D62 37A>48 84D8E8 ;8<6734? A:6 87 =>? 98>D8E8? 37 ;89>3;D?
4?4 6;3 A?=\ A:8>=?2 78B8535? 6 469358<? A?B6 G84 S>8 @?5;6LL6 3@@3;8C
;6. &8 =8 Y A:86=58 =6 6978 4?4 3LL83 @?5>5? 84A?45;3;62 4677? Siu!iun
D?B648A34? 3446==? 37 A?4<645? D8 -3453 13;83 %?<67732 >4? D68
@;8B82 @8] A676L;8 6 @8] 8B@?;53458 A?BB64535?;8 D67 &?;34?2 G;356
#8A?7D? D3 1?456A;?A62 ;6D>A6 D3 >4 7>49? <83998? A:6 7? 3<6<3 A?4C
D?55? G84? 3 M39:D3D. 132 34A:6 =6 A8R G?==6 3AA3D>5? a 6 4?4 46
3LL83B? 76 @;?<6 a2 ;6=53 D3 D?B34D3;=8 A:6 A?=3 84 A?4A;65? 6978 3C
<;6LL6 @?5>5? 8B@3;3;6 D3 S>37A:6 @8] ? B64? 7>493 A?4<6;=3E8?46.
&8R 4?4?=534562 6978 B348G6=53 =6 4?4 375;? ;8=@655?2 A?4=8D6;3E8?46
6 @6;G84? D6<?E8?46 468 A?4G;?458 D8 37A>48 ;3@@;6=6453458 D67 B?4D?
B>=>7B34?. c;6=64534D? 467 A345? )N D6773 @;8B3 &3458A32 70|njcrnc2 73
=5;>55>;3 D67 ;694? =?556;;346? D68 D3443582 6978 A0845;?D>A6 37 *8BL?2
D?<6 ;8=86D?4? A?7?;? A:62 =64E3 A?7@32 4?4 :344? A?4?=A8>5? 87 &;8C
=5?F 8 G34A8>778 B?;58 =64E3 L3556=8B? 6 8 9;34D8 =@8;858 D67 B?4D?
@3934?. g>6=58 >758B8 D8B?;34? 84 >4 7>?9? ?=A>;? B3 =6;64?2 84
>403B@83 @;356;83 ;8=A:83;353 D3 >4 9;34D6 G>?A?
h
2 37708456;4? D8 >43
A?4G?;56<?76 ;6=8D64E32 87 U&3=5677? D6978 -@8;858 13948V. +;3 7?;? <8
=?4? 8 9;34D8 @?658 @393482 A?B6 'B6;? 6 7? =56==? N8;9878? 9>8D3 D8
(3456 467 <83998? ?75;6B?4D34?X 8 @;84A8@8 6 A3@8 B87853;8 D67703458C
A:85H2 A?B6 &6=3;6X 8 G87?=?G82 S>378 $;8=5?56762 -?A;356 6 c735?46
^
. ,LC
L6462 5;3 8 @;84A8@8 A:6 (3456 4?4 @>R G3; =378;6 84 c3;3D8=? B3 4?4
?=3 A?4D3443;6 3770)4G6;4? <0Y 34A:6 87 -373D84?2 @6; 87 S>376 6978 :3
6=@;6==? 3BB8;3E8?46 34A:6 84 375;6 ?@6;62 A?B6 87 Ccntitic, 6 A:6 87
B6D8?6<? ?AA8D645376 :3 <646;35? A?B6 =@6AA:8? D6776 <8;5] A3<3776C
;6=A:6. ,2 5;3 8 G87?=?G8 6 8 =3@864582 4?B843 34A:6 $<8A64432 )L4 -8432 6
P ALESSANDRO DANCONA, La leggenda di Maometto in Occidente, edizione originale
1889, nuova edizione a cura di Andrea Borruso, Roma 1994. Cfr. inoltre: PAOLA
LOCATIN, Maometto negli antichi commenti alla Commedia, LAlighieri XX, 2002, pp. 41-
75; CLAUDIA DI FONZO, Dalla terza redazione inedita dellOttimo Commento. Il canto di
Maometto: una nuova fonte, Studi danteschi, LXVI, 2001, pp. 35-62; ROBERTA MOROSINI,
Il Roman de Mahomet (1258) tra tradizione e riscrittura nei commenti danteschi del XIV
secolo e nella Cronica di Giovanni Villani, Letteratura italiana antica, VI, 2005, pp. 293-
317. Per ledizione della nota fonte duecentesca romanzesca francosettentrionale, cfr.
ALEXANDRE DU PONT, Le Roman de Mahomet, n. d. tr. et prsentation de Yvan G. Lepage,
Louvain 1996.
h Per il simbolo del fuoco nel medioevo e la relativa, sterminata bibliografia, cfr.
JEAN-PIERRE. LEGUAY, Le feu au Moyen ge, Rennes 2008, passim.
^ Cfr. Inf. IV, vv. 129-144.
";34A? &3;D848 ^_b
435>;37B6456 $<6;;?Y2 )L4 #>=:D2 A:6 6978 ;8A?;D3 6=@78A853B6456 @6;
87 =>? 9;34D6 A?BB645? 3;8=5?5678A?
`
. (6773 A?4?=A64E3 D8 A?BB6453C
5?;8 9;6A8 D8 $;8=5?56762 @;?<6486458 D3 1?45C-3845C18A:67 ? D3 375;?<62
46770?@6;3 D8 (3456 4?4 <0Y 5;3AA83.
+>55? A8R =3;6LL6 G?;=6 @?A3 A?=32 B3 =8A>;3. +>553<832 A0Y D6770375;?.
,2 A?B6 5>558 =344?2 S>37A?=3 D8 B?75? 8B@?;53456. )7 B?D677? 37 S>376
(3456 =8 Y 8=@8;35? @6; 73 =>3 8BB64=3 A?4A6E8?46 9646;376 D6773
=5;>55>;3 D6770$7D87H. i L64 4?5? A?B6 6978 =8 =83 3GG8D35? 3978 6=6B@8
G?;4858978 D3773 5;3D8E8?46 735843 T84 @;8B? 7>?9? 70|nci!c D8 N8;9878?W2
4?4A:I 38 56=58 6 3776 B6B?;86 ?;378 D0?;89846 =?@;355>55? A6758A3 6
96;B348A3 A:6 A?=585>8<34? >4 <3=58==8B? D6@?=85? D8 769964D6 G?7j7?C
;8A:6.
132 34A:6 3773 7>A6 D6776 ;6A6458 @?76B8A:62 Y 46A6==3;8? ;8A?;D3;6 6
=?55?78463;6 A?4 G?;E3 A?B6 3 S>6=5? @35;8B?48? D8 G?458 A;8=58346
6 @;6A;8=58346 <3D3 3998>4532 D3 ?;B38 S>3=8 >4 =6A?7?2 73 A?4=3@6<?C
76EE3 A:6 87 56B3 D67 UN83998? ?75;6B?4D34?V Y >4? D68 G?4D3B645378
46776 5;3D8E8?48 =?;56 D37 A6@@? 3L;3B858A?
_
2 6 A:6 4?4 A0Y S>84D8 D3
=5>@8;=8 4?4 =?7? A:6 6978 =8 =83 8=@8;35? 34A:6 3 >43 G?456 B>=>7B3432
B3 3DD8;855>;3 A:6 5376 8=@8;3E8?46 =83 =5353 @;8B3;83.
$770848E8? D67 KK =6A?7? >4 3;3L8=53 =@394?7?2 189>67 $=k4 c373C
A8?=2 =5>D8R 7>493B6456 73 Oitina Ccnnc!ia 8B@;6==8?435? D3776 B?7562
3B@86 6 @;?G?4D6 =?B897834E6 6=8=56458 G;3 73 =5;>55>;3 D68 ;6948 ?7C
5;6B?4D348 A?B06;34? @;6=645358 D3 (3456 6 A?B6 <648<34? ;3GG89>C
;358 467706=A35?7?983 B>=>7B343. +378 =?B897834E6 6;34? 5;?@@6 6
5;?@@? =8=56B358A:6 @6; 3@@3;8;6 A3=>378 ? G;>55? D0>43 9646;8A3 A8;A?C
73E8?46 D8 56B8 6 D08BB39848. %6 43AS>6 >4 78L;? 6D85? 467 OfOf2 Oanic
q c| |s|an2 84 =69>85? @8] <?756 ;8@>LL78A35? 6 5;3D?55? 84 B?756 7849>6
b
.
,==?2 @6; S>345? ;8AA? D0845677896458 ?==6;<3E8?48 6 D0>43 =56;B84353
6;>D8E8?462 =>=A85R <8<3A8==8B6 @?76B8A:6 A:6 7? =5>D8?=? @3==R
D87896456B6456 6 4?4 =64E3 nuncur 84 ;3==69432 @>45>37B6456 ;6@78C
A34D?<82 84 >4 =>AA6==8<? =5>D8? D67 Ofeh
f
. )7 @>45? D6L?76 D6773 56=8
D6770$=k4 c373A8?= A?4=8=56<3 467 G355? A:06978 4?4 6;3 =535? 84 9;3D?
D084D8A3;6 37A>4 56=5? =@6A8G8A? A:6 3<6==6 @?5>5? =6;<8;6 3 (3456 S>3C
76 B?D677? 8=@8;35?;6F A8R 4?4 978 A?4=6458<3 D8 G?;B>73;6 37A>43 56=8
=A86458G8A3. ) =>?8 ;8786<8 ;8B346<34? @6;5345? 37 78<677? D6770849694?=3
8@?56=8 6 D6773 ;3AA?753 D084D8E8 6;>D858.
` Averrois, che l gran comento feo (Inf. IV, 144).
_ Cfr. GERSHOM SCHOLEM, Jewish gnosticism, Merkhabah mysticism et talmudic tradi-
tion, New York 1960; IOAN P. COULIANU, Psychanodia I, Leiden 1930.
b MIGUEL ASN PALACIOS, Dante e lIslam, traduzione italiana, voll. 2, Parma 1994,
con una densa e lucida Introduzione di Carlo Ossola.
f ID., Historia y critica de una polemica, Madrid 1924 (che costituisce il vol. II della
traduzione italiana, cit. supra).
Ia Crcciaia c |a Ccricsia. Oanic !inanzi a|||s|an. ^_f
13 >43 4>?<3 =A?@6;53 B?D8G8AR S>6=5? S>3D;?. 1?758 =5>D8?=82
=<87>@@34D? 76 8D66 D6770$=k4 c373A8?=2 =8 6;34? A:86=58 S>376 @?56==6
6==6;6 87 56=5? B>=>7B34? @8] 3D355? 3 A?=585>8;6 >4 B?D677? @6; 70$78C
9:86;8F 6 98H &73>D8? -l4A:6E $7L?;4?E
OQ
2 G84 D37 Ofh`2 3<6<3 8@?58EE3C
5? @?56==6 5;3553;=8 D67 Kiia| a|-Miraj. -8 5;3553 D8 >43 =8456=8 5;3 73 ->;3
O_ D67 &?;34?2 73 ->;3 A|-|sr2 87 UN83998? 4?55>;4?V2 6 >43 =6;86 D8
na!iin ;89>3;D3458 87 nirajF A8?Y 7m3=A64=8?46 4?55>;43 D67 c;?G653 1>C
:3BB3D2 84 =6773 37 A3<377? M>;3S2 D3773 U-@834353 D67 +6B@8?V D8
J6;>=376BB62 87 Haran csn-Snarij, 37 A867?. *m?;8984376 3;3L? A:6 A??;C
D843 S>6=53 =6;86 D8 ;3AA?458 Y 34D35? @6;D>5?2 3BB6==? A:6 =83 B38
<6;3B6456 6=8=585?F 5>553<83 46 A?4?=A83B? <3;86 <6;=8?48
OO
4?4A:I >43
=6;86 D8 56=582 =83 D?558 =83 @?@?73;82 A:6 5;35534? 87 B6D6=8B? 56B32 G;3 8
S>378 87 Viaggic nc| |cgnc !c| |iicrnc D8 -34n0o2 D67 @;8B? K)) =6A?7?
Oe
2 ?
87 Viaggic nciiurnc 6 76 |itc|azicni !c||a Mccca D8 1>d3D84 8L4 p$;3L82
D6773 @;8B3 B65H D67 (>6A645?.
"8437B64562 467 Ofhf ,4;8A? &6;>7782 ?;8645378=53 6 8=73B8=53 8537834?
=@6A8378=53 =?@;355>55? D8 A>75>;3 658?@8A32 @>LL78AR 7034677? B34A3456
D6773 A35643. -8 5;3553 D6773 <6;=8?46 =83 735843 =83 G;34A?C=655645;8?4376
D67 Kiia| a|-Miraj, 87 585?7? 73584? D6773 S>376 =>?43 3@@>45? Ii|cr
!c Sca|a
OP
F 6 A:6 A?4 5376 585?7? 6;3 A?4?=A8>53 G?;=6 98H 46773 -8A8783
=<6<32 6 A?B>4S>6 37B64? D37 +;6Cg>355;?A645?2 A?B6 56=58B?4834?
37A>48 3>5?;8 =83 85378A8 =83 8L6;8A8 S>378 "3E8? D6978 ZL6;58 467 Oiiia-
ncn!c, ";34A8=A ,8q8B648= 467 Ii|rc !c| Crisiia, $7G?4=? D3 -@843 467
|cria|iciun |i!ci
Oh
.
,4;8A? &6;>778 84D8<8D>R 6 =5>D8R 5376 56=5? 467 A?;=? D8 7>49:6 ;8C
A6;A:6 A?4D?556 5;3 87 Ofh` 6 87 Ofh_ 46773 M?D76d34 *8L;3;d D8 *?4D;32
46773 M8L78?5:YS>6 %358?4376 D8 c3;898 6 46773 M8L78?56A3 $@?=5?78A3
N358A343. )7 A?D8A6 A?4=6;<35? 46773 N358A3432 ?75;6 37 Ii|cr !c Sca|a,
A?458646 34A:6 >43 A?@83 D6773 A?=8DD6553 Cc||cciic Tc|ciana ?2 @6; B6C
978? D8;62 D6773 Cc||cciic C|uniaccnsis. %677? =56==? Ofhf2 r?=I 1>s?E
-64D84? @>LL78A3<3 >43 <6;=8?46 A3=58978343 D677? =56==? 56=5?
O^
.
c;?=69>64D? 87 =>? 73<?;? A?4G?;535? D3 375;8 =5>D8?=8
O`
2 87 &6;>778
OQ CLAUDIO SNCHEZ ALBORNOZ, La Espaa musulmana, Buenos Aires 1946, p. 305.
OO Cfr. Il Libro della Scala di Maometto, tr. it. di Roberto Rossi Testa, Intr. di Carlo Sac-
cone, Milano 1991; Le Livre de l'chelle de Mahomet, tr. fr. Gisle Besson - Michelle
Brossard-Dandr, Paris 1991.
Oe HAKIM SAN , Viaggio nel Regno del Ritorno, a cura di Carlo Saccone, Parma 1993.
OP ENRICO CERULLI, Il Libro della Scala e la questione delle fonti arabo-spagnole della Di-
vina Commedia, Citt del Vaticano 1949.
Oh Cfr. TARDIOLA, Ancor nel libro suo, cit., p. 62.
O^ JOS MUOZ SENDINO, La Escala de Mahoma, Madrid 1949.
O` Cfr., per es., GIORGIO LEVI DELLA VIDA, Aneddoti e svaghi arabi e non arabi, Milano-
Napoli 1959, pp. 149-61, con integrazioni bibliografiche al Cerulli, e soprattutto i
";34A? &3;D848 ^bQ
@6;<648<3 37A>48 3448 @8] 53;D8 3 B6978? @;6A8=3;6 87 A?456=5? 467 S>376
6;34? B35>;356 76 <6;=8?48 ?AA8D645378 D67 Kiia| a|-Miraj
O_
. )7 D?55? $C
L;3:3B $7G3S>8B 46 3<6<3 A?B@8735? @6; ?;D846 D8 $7G?4=? K c| Sa|ic,
;6 D8 &3=5897832 >43 ;8D>E8?46 D377m3;3L? 37 A3=5897834? =>773 S>376 <6;C
=? 87 Oe`h M?43<645>;3 D3 -86432 !cnini rcgis nciarius ci scri|a 3773 A?;56
D8 $7G?4=?2 3<6<3 ;8A3<35? >43 <6;=8?46 735843 6 >43 G;34A6=6. %?4 Y
8B@?==8L876 A:6 M?43<645>;3 G?==6 >4 9>67G?2 6=>76 D3773 =>3 -8643
377?;3 46776 B348 D68 9:8L677848 9>8D358 D3 c;?<64E34? -37<348. ) 9:8C
L677848 =646=8 6 G8?;645848 3<6<34? L355>5? 3 1?453@6;58 467 Oe`Q 8
9>67G8F 84 =69>85? 3 A8R 6;3 84 S>6978 3448 6=>76 @;6==? $7G?4=? K2 D3
"8;64E62 34A:6 87 9>67G? M;>4655? *35848 A:62 <8399834D? 84 -@3943 37
56B@? D8 S>6773 L355397832 A:6 3<6<3 =69435? 7m848E8? D8 >4 @6;8?D? D8
9?<6;4? 9:8L67784? 46773 =>3 A855H2 3<6<3 @;6G6;85? 4?4 5?;43;6 84 @3C
5;83. $7G?4=? K 6;3 B?75? 8456;6==35? 37 Ii|cr !c Sca|a, A:6 >5878EER 467
=>? 73<?;? 64A8A7?@6D8A? Sciicnaric, @>;5;?@@? 84A?B@8>5?2 D6=58435?
@;?L3L87B6456 3 84G7>64E3;6 87 Trcscr 73584834?
Ob
.
%?4 =3@@83B? =6 46773 L8=3AA83 D8 M;>4655? *358482 A:6 ;8645;R 3 "8C
;64E6 467 Oe`_ 6 D8<6446 84 =69>85? 3B35? B36=5;? D8 (34562 <8 G?==6
>43 A?@83 D67 Ii|cr !c sca|a2 ? >4m6@85?B62 ? D6978 3@@>458X 4?4 =3@C
@83B? @6; S>376 <83 7037786<? =83 @6;<64>5? 3 A?4?=A6;6 87 A?4564>5? D8
>4 56=5? @?==6D>5?2 ? ;83==>45?2 ? A?B>4S>6 ;8A?;D35? D37 B36=5;?.
&6;5? Y A:6 76 3437?986 5;3 87 Ii|cr 6 73 Oitina Ccnnc!ia =?4? 5378 6 53456
?;B38 D3 A?4=6458;A8 D8 3GG6;B3;6 A?4 A6;56EE3 A:6 7m3=A64=8?46 D67
c;?G6532 ;856==>53 6 ;843;;353 355;3<6;=? >43 =6;86 D8 =>AA6==8<8 ;3AA?4582
=83 >4? D68 G?4D3B6458 a 87 @8] @;?G?4D? G?;=6 a D67 @8] 9;34D6 @?6B3
D67 16D8?6<? ?AA8D645376. *08@?56=8 D6770$=k4 c373A8?=2 98H G6;?A6B64C
56 A?456=53532 =8 Y 5;3=G?;B353 84 >4 D35? ?;B38 73;93B6456 @6; S>345?
7>498 D37706==6;6 >4348B6B6456 3AA65535? D3773 B3998?; @3;56 D68 A;8C
58A8F A?B6 :344? D8B?=5;35? 34A:6 76 ;8A6;A:6 D8 37A>48 =5>D8?=8
853783482 5;3 8 S>378 <344? ;8A?;D358 37B64? ";34A6=A? J3L;8678
Of
2 &6=3;6
puntuali rilievi di SILVIO PELOSI, Dante e la cultura islamica, o analogie tra la Divina
Commedia e il Libro della Scala, Roma 1965; cfr. anche la sintetica rassegna di VITO
SALIERNO, Dante e lIslam, LEsopo, XII, 1991, 52, pp. 28-31.
O_ CERULLI, Nuove ricerche sul "Libro della Scala" e la conoscenza dell'Islam in Occidente,
Citt del Vaticano 1972; IDEM, Dante e lIslam, Atti dellAccademia delle Scienze di
Torino, Cl. di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, n. 107, 1973, I, pp. 383-402.
Ob &fr. PIETRO G. BELTRAMI, Appunti su vicende del Trsor: composizione, letture, ri-
scritture, in Lenciclopedismo medievale, a cura di Michelangelo Picone, Ravenna 1992, pp.
311-328.
Of FRANCESCO GABRIELI, Nuova luce su Dante e Islam, in IDEM, Il mondo dellIslam,
Milano-Napoli, 1954, pp. 156-72; cfr. ora CARMELA BAFFIONI, Aspetti delle cosmologie
islamiche in Dante, in AA.VV., Il pensiero filosofico e teologico in Dante Alighieri, Milano,
s.d., pp. 103-122.
Ia Crcciaia c |a Ccricsia. Oanic !inanzi a|||s|an. ^bO
-69;6
eQ
2 13;83 &?;58
eO
2 &3;7? -3AA?46
ee
2 *>898 1?;37D8
eP
2 J8>=6@@6
+3;D8?73
eh
.
13 3 S>6=5? @>45? >4 @;?L76B3 =08B@?46. (34562 37786<? D8 +?BC
B3=? D0$S>84? 6 D8 S>67 A645;? D8 =5>D8 D?B648A348 A:06;3 7? Siu!iun
D8 -3453 13;83 %?<67732 7>?9? 467 S>376 73<?;3<3 708=73B8=53 6 A?45;?C
<6;=8=53 #8A?7D? D8 1?456A;?A62 3<6<3 @8643 A?=A864E3 D8 S>6773 A:6 37
=>? 56B@? 6;3 98>D8A353 70845;84=6A3 B37<3985H D6770)=73B. (67 ;6=5?2
6978 6;3 >4 G6;B? G3>5?;6 D6773 @;?=6A>E8?46 D6776 8B@;6=6 A;?A8356 84
+6;;3=3453 6 ;8B@;?<6;3<3 3 M?48G3A8? N))) D8 G3; 9>6;;3 38 A;8=58348 a
377>D64D? 3773 A;?A8353 D37 @3@3 L34D853 A?45;? 8 &?7?443 a 34E8A:I 38
=3;3A648. *3 =?7>E8?46 4?4 =53 34A?;3 46770K) D67 Para!isc, 84 S>345?
";34A6=A? <8 Y <8=5? @;6D8A3;6 U46773 @;6=64E3 D67 =?7D34 =>@6;L3VF 6
73 =>@6;L83 Y <8E8? ;3D8A37B6456 ?@@?=5? 3776 <8;5] A?;56=8. ,==3 =53 467
;3@@?;5? @;?G?4D? 5;3 87 -373D84? @?=5? 5;3 978 -@8;858 13948 6 978
6;?8 A;?A8358 A:62 467 &867? D8 13;562 =?7A34? A?B6 7>A8 G>798D8==8B6 73
A;?A6 7>B84?=3 A:6 ;3AA?9786 76 348B6 D68 A3D>58 84 L35539783 A?45;?
978 84G6D6782 A?B6 =6 5;3 76 @3;?76 U13;56V 6 U13;58;8V =8 =53L878==6
8B@78A853B6456 >4 ;3@@?;5? 3DD8;855>;3 658B?7?98A?2 G37=? =64E3 D>LC
L8?2 B3 @=8A?7?98A3B6456 6 B?;37B6456 D0>43 G?;E3 6 D0>43 @;?G?4C
D85H A:6 =?;@;64D?4? 6 =A?4<?79?4?. %67 4>A76? @;?G?4D? D8 5>55? A8R
;8=86D6 87 riiicr|icncs Tugcn!sqsicn D3456=A?2 73 A?4A6E8?46 D67 46==?
D8;655? 6 84=A84D8L876 G;3 <8;5] A?;56=62 56=58B?4834E3 A3<3776;6=A3 6
<?A3E8?46 37 B3;58;8?.
Unitcrsiia !cg|i Siu!i !i |ircnzc
eQ CESARE SEGRE, Viaggi e visioni doltremondo sino alla Commedia di Dante, in IDEM,
Fuori dal mondo. I modelli nella folla e nelle immagini dellaldil, Torino 1990, pp. 25-48.
eO MARIA CORTI, La Commedia di Dante e loltretomba islamico, Belfagor, I, 1995, 3,
pp. 208-9.
ee CARLO SACCONE, La Divina Commedia e una Commedia musulmana, Studia
patavina, XXXIX, 1992, 3, pp. 85-119.
eP LUIGI MORALDI, LAldil delluomo, Milano 1985.
eh TARDIOLA, I viaggiatori del Paradiso, Firenze 1993.
MIRKO TAVONI
DANTISIARCH:
IL CORIUS DILLI OIIRI VOLGARI I LATINI DI DANTI
LIMMATIZZATI CON MARCATURA
GRAMMATICALI I SINTATTICA
1. CODIIICA DIL CORIUS I SISTIMA DI INTIRROGAZIONI:
UN'IMIRISA IN DIVINIRI
II 6 ariIe 2005 lenni aII'OrienlaIe, invilalo da Vincenzo IIaceIIa,
una |cciura Oaniis aliica, daI liloIo: Le oere voIgari e Ialine di
Danle con marcalura grammalicaIe: uno slrumenlo onIine er Io
sludio deIIa Iingua di Danle. Consisleva neIIa resenlazione di un
dala-base lesluaIe deIIe oere di Danle, che un gruo di ricerca da
me coordinalo aveva reaIizzalo. I rinciaIi molivi di inleresse di
queI nuovo slrumenlo erano lre: che iI corus era comIelo, e in
arlicoIare incIudeva Ie oere Ialine, moIlo meno reeribiIi cn |inc
di queIIe voIgari, che i lesli digilaIi garanlivano un'affidabiIila diversa
daIIa massa dei lesli inconlroIIalamenle reeribiIi in rele, essendo
slali accuralamenle coIIazionali con Ie edizioni di riferimenlo esislenli
aII'eoca (in arlicoIare, Ia Ccnnc!ia corrisondeva esallamenle aI
leslo deIIa seconda edizione Ielrocchi, deI 1994), e sorallullo che i
lesli erano slali, grazie aI Iavoro di un gruo di giovani sludiosi, non
soIo Iemmalizzali, ma anche arricchili di una marcalura grammalicaIe
moIlo caiIIare, che consenliva di svoIgere suII'cpcra cnnia di Danle
ricerche Iinguisliche fino ad aIIora imossibiIi.
A dislanza di quaIche anno, neI momenlo in cui queIIe |cciurac
Oaniis vengono ubbIicale in onore di Vincenzo IIaceIIa, desidero
ricordare Ia circoslanza che orlo aI noslro inconlro, e quindi aII'invilo
a lenere queIIa conferenza. Vincenzo IIaceIIa era slalo nominalo daI
MIUR (aIIora MURST) revisore deI rogello di ricerca di inleresse
nazionaIe (IRIN 1999) di cui ero slalo coordinalore nazionaIe negIi
anni 2000-2001, inliloIalo Ia ncncria icsiua|c. |!izicni, siu!i c siruncnii
pcr |ana|isi ccnpuiazicna|c !c| pairincnic iia|ianc, rogello che orlo
aIIa creazione di moIle coIIezioni e slrumenli di fiIoIogia digilaIe
resso diverse Universila ilaIiane, fra cui iI nucIeo di queIIa che
Mirko Tavoni
584
divenlera oi Ia Bi||icicca iia|iana, Ia iu grande bibIioleca digilaIe di
lesli deIIa Ielleralura ilaIiana (hll://vvv.bibIiolecailaIiana.il/).
Ier Ia verila, queI rogello di ricerca aveva gia avulo un revisore,
come revislo daIIa normaliva, iI quaIe aveva regoIarmenle concIuso
Ia sua revisione con un giudizio moIlo osilivo. Ma neI noslro caso iI
MURST decise, anni doo, er una seconda revisione, non revisla e
credo non consuela. Iu in queII'occasione che conobbi IIaceIIa, iI
quaIe adem aI comilo minisleriaIe ricevulo in modo eslremamenle
scruoIoso e arofondilo. II risuIlalo, neI noslro caso, fu una reIa-
zione se ossibiIe ancor iu osiliva di queIIa che iI rimo revisore
aveva scrillo quaIche anno rima. Issa leslimoniava I'assoIula robila
deI suo eslensore. II risvoIlo iu iacevoIe di queII'eisodio fu Ia
conoscenza ersonaIe con Vincenzo IIaceIIa e i conseguenli scambi di
idee sui comuni inleressi danleschi.
Invilalo a mellere er iscrillo Ia mia conferenza di cinque anni fa,
ho concordalo con i curalori deI voIume di non scrivere queIIo che
dissi aIIora aI ubbIico deII'OrienlaIe, che sarebbe oggi deI lullo sue-
ralo vislo che queI dalabase lesluaIe si e uIleriormenle evoIulo, ma di
descrivere Io slrumenlo neI suo slalo aggiornalo a oggi. I rogressi
inlervenuli si olranno misurare confronlando Io slalo alluaIe con iI
recedenle, descrillo in un mio arlicoIo conlemoraneo, aunlo, aIIa
conferenza lenula aII'OrienlaIe
1
. TaIi rogressi risuIlano da conlribuli
individuaIi (sollo secificali) aggiunlisi neI lemo e da aIlri, fra cui Ia
comIela rislrullurazione deI molore di ricerca, reaIizzali neII'ambilo
deI IRIN 2009 Mcrjcsiniassi c ccrpcra injcrnaiici !c||iia|ianc aniicc
coordinalo da Lorenzo Renzi (coordinamenlo oi assalo a me in
corso d'oera er ensionamenlo di Renzi). Chiunque si coIIeghi aI
silo hll://danle.di.unii.il:8080/DanleSearch/ (usando come brovser
MoziIIa Iirefox, erche IxIorer da robIemi di visuaIizzazione
dovuli aI codice rorielario Microsofl), doo aver cIiccalo su Nuova
1 MIRKO TAVONI, Un nuctc siruncnic injcrnaiicc pcr |c siu!ic !i Oanic (ccn una
prcpcsia inicrprciaiita pcr Inf. |V 69), in Oanic in |ciiura, a cura di Giusee De Malleis,
Ravenna, Longo edilore 2005, . 217-229. Cfr. anche ID., Ccnccr!anzc c|ciircnicnc c
inicrprciazicni icsiua|i. Scnc!c pcr |a Commedia, in Oanic !a |ircnzc a||a|!i|a. Aiii !c| icrzc
Scninaric !anicscc inicrnazicna|c (|ircnzc, 9-11 giugnc 2000), a cura di MicheIangeIo
Iicone, Iirenze, Cesali 2001, . 183-201, e ID. con ILINA IIIRAZZO, LITIZIA LIONCINI,
IAOLO IIRRAGINA, IVAN OSCAINO, MIRKO TAVOSANIS, An cn-|inc Ia|craicrq jcr
Iinguisiic |cscarcn - Ccnp|cic ucrks cj Oanic |cnnaiizc!, In AIIC/ACH 2004. Ccnpuiing
an! Mu|ii|ingua|, Mu|iicu|iura| Hcriiagc, Tnc 16in jcini |nicrnaiicna| Ccnjcrcncc, Gcic|crg
Unitcrsiiq, 11-16 junc 2004, Ccnjcrcncc A|siraci, Gleborg, Gleborg Universily 2004, .
137-143.
Ringrazio Marla D'Amico che mi ha assislilo neI descrivere Ia versione di
DanleSearch aggiornala aI IugIio 2011.
OanicScarcn. i| ccrpus !c||c cpcrc tc|gari c |aiinc !i Oanic.
585
ricerca si lrova davanli a una schermala (Iig. 1) divisa in due arli:
Ricerca grammalicaIe e Ricerca sinlallica. La rima corrisonde
soslanziaImenle, saIvo I'aggiunla di nuove funzioni di ricerca iu
sofislicale, a quanlo resenlai aII'OrienlaIe cinque anni fa, Ia seconda e
comIelamenle nuova.
Iigura 1
2. LA RICIRCA GRAMMATICALI
La ricerca grammalicaIe, neI senso di morfoIogica (con nolazioni
anche morfo-sinlalliche, come queIIe suIIa reggenza degIi aggellivi,
sui comIemenli relli da reosizioni e sui comIemenli frasaIi relli
da reosizioni e congiunzioni), si fonda suI corus comIelo deIIe
oere voIgari e Ialine di Danle Iemmalizzale e dolale di elichelle
grammalicaIi in formalo XML-TII.
Ricordo che iI Consorzio TII-Texl Incoding Inilialive (hll://vvv.
lei-c.org/index.xmI) is a consorlium vhich coIIecliveIy deveIos and
mainlains a slandard for lhe reresenlalion of lexls in digilaI form.
Ils chief deIiverabIe is a sel of GuideIines vhich secify encoding
melhods for machine-readabIe lexls, chiefIy in lhe humanilies, sociaI
Mirko Tavoni
586
sciences and Iinguislics. La conformila a queslo slandard inlernazio-
naIe e un requisilo imrescindibiIe er quaIunque imresa di fiIoIogia
digilaIe: soIo grazie ad esso lullo cio che rogellano e roducono i iu
vari cenlri di ricerca neIIo nunaniiics ccnpuiing neI mondo e reso in-
diendenle daIIe lecnoIogie, hardvare e soflvare, in conlinua evoIu-
zione, e dunque ermane neI lemo, e scambiabiIe fra rogelli di
ricerca diversi che usano lecnoIogie diverse, divenla riusabiIe anche a
fini diversi da queIIi er i quaIi e slalo rodollo, e rende ossibiIe Io
sviIuo dei iu disarali soflvare di ricerca, archiviazione, resen-
lazione, che lrovano iI Ioro minimo comun denominalore neI vincoIo
che si auloimongono di aIicarsi a quaIunque archivio digilaIe
crealo risellando queslo slandard.
L'universaIe condivisione deIIo slandard TII e quindi, er Ia
comunila inlernazionaIe deIIa ricerca neIIo nunaniiics ccnpuiing, una
condizione chiave er iI rorio sviIuo, er Iiberare lulle Ie olen-
ziaIila crealive e rodullive che ossiede e er Iiberarsi dai vincoIi e
daIIe diendenze araIizzanli cosliluili dai soflvare rorielari. Iur-
lroo quando abbiamo comincialo non ne eravamo abbaslanza con-
saevoIi, e I'errore di esserci iniziaImenle Iegali a un soflvare rorie-
lario, eraIlro rodollo e romosso daI iu imorlanle islilulo di
ricerca ubbIico dedicalo aIIa Iinguislica comulazionaIe, ci coslo oi
moIla falica er riconverlire lullo neI formalo giuslo
2
.
2 Desidero ricordare i nomi di lulli i ricercalori che neI lemo, allraverso varie
slralificazioni, hanno reaIizzalo Ia Iemmalizzazione e codifica grammalicaIe e sinlallica
deIIe oere voIgari e Ialine di Danle e iI reIalivo soflvare di inlerrogazione: 1. Lemma-
lizzazione e marcalura grammalicaIe (e morfo-sinlallica). Cccr!inancnic !c||a |cnnaiiz-
zazicnc in jcrnaic OBT: SamueIa runamonli. Icnnaiizzazicnc ccn narcaiura grannaiica|c
!c||c singc|c cpcrc: Ccnnc!ia: Inrica CaIchini, Ccntitic e |inc: SamueIa runamonli, Viia
nucta: Sara GigIi, |icrc e Ociic !Ancrc: SiIvio MeIani, Oc Vu|gari ||cqucniia ed |g|cgnc:
Lelizia Leoncini, Mcnarcnia, |pisic|c, Qucsiic !c aqua ci icrra: Lara NiccoIini. Ocjinizicnc c
inp|cncniazicnc !c| nc!c||c !i cc!ijica grannaiica|c XMI-T||, cccr!inancnic !c||a ccntcrsic-
nc !a| jcrnaic OBT a| jcrnaic XMI-T||, IIena Iierazzo. Marcaiura siniaiiica !c||c prcpcsi-
zicni cnc inirc!uccnc ccnp|cncnii: CIara CoraIIo. Marcaiura siniaiiica !c||c ccngiunzicni c
!c||c prcpcsizicni cnc inirc!uccnc ccnp|cncnii jrasa|i: Sara GigIi. Marcaiura siniaiiica !cg|i
aggciiiti: CarIa Morelli. Unijcrnazicnc !c||a narcaiura !c||c cpcrc tc|gari: SamueIa runa-
monli e AIessandra De Rosa. Unijcrnazicnc !c||a narcaiura !c||c cpcrc |aiinc: Lelizia Leon-
cini. 2. Molore di ricerca XCDI (XmI Comressed Documenl Ingine) (hll://danle.-
di.unii.il/ricerca/): IaoIo Ierragina e Andrea Maslroianni. Siruiiurazicnc !c| sisicna !i
inicrrcgazicnc: IIena Iierazzo con I'assislenza di Ivan oscaino. 3. Marcalura sinlallica
(lii di roosizione e gradi di subordinazione). Ocjinizicnc c inp|cncniazicnc !c| nc!c||c
!i cc!ijica siniaiiica XMI-T||: Sara GigIi ed IIena Iierazzo. Marcaiura siniaiiica !c||a
Commedia: Sara GigIi (lesi di dolloralo, 2004). Marcaiura siniaiiica !c| Convivio, |i|ri | c
||: Irancesco Iiumara (lesi di Iaurea seciaIislica, 2006). Marcalura sinlallica deIIe |inc:
Marla D'Amico (2010). 4. Marcalura sinlallica dei discorsi dei ersonaggi deIIa
Ccnnc!ia: Marla D'Amico (lesi di Iaurea seciaIislica, 2010). 5. Molore di ricerca
OanicScarcn. i| ccrpus !c||c cpcrc tc|gari c |aiinc !i Oanic.
587
Vediamo dunque, in DanleSearch, come funziona Ia ricerca gram-
malicaIe, erede deI Iavoro comiulo aIIora da queI gruo di ricerca.
NeIIa Ricerca grammalicaIe iI rimo camo ermelle di scegIiere lra
ricerca er Iorma o er Lemma, e iI secondo lra ricerca er Iaro-
Ia (s'inlende aroIa inlera), Solloslringa (cioe quaIunque arle di
aroIa), Irefisso o Suffisso (naluraImenle non in senso morfoIo-
gico, ma risellivamenle neI senso di arle iniziaIe o finaIe di aroIa),
o Isressione regoIare (una modaIila di ricerca iu comIessa, che
vedremo iu avanli), o Tulle Ie occorrenze (Ia cui funzione aarira
chiara fra oco) (Iigg. 2a, 2b).
Iigura 2a
Iigura 2b
DanleSearch (hll://danle.di.unii.il:8080/DanleSearch/): CIaudio Corsi.
Mirko Tavoni
588
Ier esemio, osso digilare neI rimo camo Ia slringa forluna
come Iorma e come IaroIa, iI che mi dara come risuIlalo 44 occor-
renze deIIa aroIa inlera forluna in 11 oere, sia in voIgare (come
ne Ie braccia de Ia forluna, VN XII 8) sia in Ialino (come donec
forluna ermisil, V| I xii 4). Iosso digilare andare come Lemma
e come IaroIa, ollenendo 586 occorrenze in 8 oere, evidenlemenle
soIo in voIgare. I osso digilare arli di aroIe (arli quaIunque, o
iniziaIi, o finaIi), come forme o come Iemmi. II risuIlalo di una ricerca
di queslo lio aare iniziaImenle in forma di eIenco dei lesli che
conlengono Ia aroIa, o arle di aroIa, o insieme di aroIe richiesli,
coI reIalivo numero di occorrenze: eIenco che uo essere ordinalo,
cIiccando suIIa riga in aIlo, o er Teslo (cioe in Ordine aIfabelico er
liloIo di leslo), o er Ordine cronoIogico (cioe secondo Ia
successione deIIe dale di comosizione dei lesli), o er Numero
occorrenze (cioe ordinando i lesli er numero decrescenle di
occorrenze conlenule in ciascun leslo). Ier esemio Ie Iigure 3a e 3b
danno i risuIlali deIIa ricerca di andare come Lemma ordinali er
Teslo e er Numero occorrenze.
Iigura 3a
OanicScarcn. i| ccrpus !c||c cpcrc tc|gari c |aiinc !i Oanic.
589
Iigura 3b
A arlire da un eIenco di queslo lio, si ossono scegIiere due
diverse visuaIizzazioni deIIe occorrenze. La rima si olliene cIiccando
suI londino con freccella a fianco deI singoIo leslo, e consisle neIIa
visuaIizzazione di lulle Ie occorrenze enlro iI leslo, in ordine di leslo,
evidenziale in giaIIo enlro conlesli di oche righe rilagIiali daI leslo
(Iig. 4). La seconda visuaIizzazione si olliene cIiccando su un liloIo di
leslo deII'eIenco. Si are aIIora neI menu a lendina I'arlicoIazione
inlerna deIIe sezioni (cioe canli, cailoIi, ecc.) di queI leslo in cui e
resenle aImeno una occorrenza deIIa slringa ricercala. CIiccando su
una di quesle, neIIa fineslra a deslra comare iI leslo inlegraIe deIIa
sezione, neI quaIe Ie occorrenze deIIa slringa ricercala sono
evidenziale in giaIIo e ossono essere visionale assando daII'una
aII'aIlra con iI comando, in aIlo a deslra, Trovale. occorrenze neI
documenlo. Vai aIIa numero.: (Iig. 5).
Mirko Tavoni
590
Iigura 4
Iigura 5
OanicScarcn. i| ccrpus !c||c cpcrc tc|gari c |aiinc !i Oanic.
591
Dunque, lornando aIIa agina iniziaIe (Iig. 1), i rimi due cami
neIIa riga di ricerca (Lemma/Iorma e IaroIa/Solloslringa, ecc.)
servono er Ia ricerca IessicaIe. II lerzo camo inlroduce Ia vera
novila: Ia ricerca er calegorie grammalicaIi. Ogni occorrenza di ogni
aroIa neI leslo, infalli, e slala elichellala come aarlenenle a una
arle deI discorso, e iu secificamenle come carallerizzala dai corri-
sondenli ossibiIi lralli morfoIogici. II lerzo camo deIIa riga, che
aare iniziaImenle occualo daIIa dizione Tulle Ie calegorie,
ermelle di scegIiere fra VoIgare e Lalino e aII'inlerno deII'uno o
deII'aIlro fra Verbo, Soslanlivo, Aggellivo, ecc., oerala quesla seIe-
zione, cIiccando suI Iink a deslra Calegoria si are una fineslra che
consenle di seIezionare i lralli morfoIogici rori di queIIa calegoria
ovvero arle deI discorso. Ier esemio, neIIa Iig. 6 si vedono quaIi
sono i lralli seIezionabiIi er iI Verbo voIgare e neIIa Iig. 7 quaIi i
lralli seIezionabiIi er iI Soslanlivo Ialino.
Iigura 6
Mirko Tavoni
592
Iigura 7
La ricerca IessicaIe e queIIa grammalicaIe ossono essere allivale
I'una indiendenlemenle daII'aIlra, oure in combinazione. Se vo-
gIio cercare lulle Ie occorrenze che risondono a una cerla definizione
grammalicaIe, senza orre nessuna reslrizione di lio IessicaIe, sce-
gIiero, neI secondo camo, Tulle Ie occorrenze, iI che neulraIizza Ia
seIezione IessicaIe (infalli iI rimo camo divenla grigio, a significare
che nessuna reslrizione er forme o er Iemmi e alliva). Ier esemio,
se seIeziono Ironome VoIgare e oi Dimoslralivo, senza aIlra
secificazione, ollengo lulli i ronomi dimoslralivi voIgari (che sono
2.995 in 8 oere), se seIeziono soIo i femminiIi singoIari si riducono a
550, soIo i maschiIi IuraIi 306, e cos via. Oure osso orre a quesla
ricerca grammalicaIe una reslrizione IessicaIe. In queslo caso non
seIezionero, neI secondo camo, Tulle Ie occorrenze ma er esem-
io Irefisso, er reslringere Ia ricerca dei ronomi dimoslralivi a
queIIi che iniziano con, oniamo, ccsi-: che risuIlano essere 148 (ccsiui,
ccsiu, ccsici, ccsic, ccsicrc, ccsicr) in 7 oere.
Un esemio eurislico di ricerca combinala er lralli grammalicaIi e
slringa IessicaIe consisle neIIa ricerca degIi imerfelli indicalivi deIIa
III, o in aIlernaliva deIIa II coniugazione, con Ia reslrizione che si lralli
di forme lerminanli in -ia (Iig. 8). Ne risuIla che gIi esemi deIIa III
coniugazione sono moIlo numerosi: 82 occorrenze dislribuile su lulle
Ie oere voIgari lranne iI Ociic. Invece gIi esemi deIIa II coniugazione
sono ochissimi, cioe 6. Una soIa occorrenza di ri!ia neI |icrc (CXLI 5,
R: nia : ria : na|inccnia). Quallro neI Ccntitic, che si riducono in reaIla
a due soIe forme: tc!ia (R: gia), neIIa canzone deI secondo lrallalo Vci
cnc nicn!cn!c, v. 17, che oi ricomare cilala una voIla neI commenlo,
in II vii, e sc|ia (R: nia : tia), neII'incipii deIIa canzone deI quarlo
OanicScarcn. i| ccrpus !c||c cpcrc tc|gari c |aiinc !i Oanic.
593
lrallalo Ic !c|ci rinc !Ancr cni sc|ia, che oi ricomare cilala una
voIla neI commenlo, in IV i. Si lralla di due siciIianismi erfellamenle
araIIeIi a queIIo di tui in rima con |ui aI v. 8 deIIa slessa canzone Vci
cnc nicn!cn!c. L'uIlima occorrenza e in |nj. IV, 69 ch' emiserio di
lenebre vincia (R: iuiiatia : tia), ma soIo erche iI codificalore, se-
guendo Ia maggioranza degIi inlerreli, ha inlerrelalo tincia come
voce deI verbo tinccrc e non di tincirc 'avvincere', inlerrelazione
minorilaria. Ma queslo quadro d'insieme deone forlemenle a favore
di quesla seconda inlerrelazione, erche non c'e in lulla Ia Ccnnc!ia,
oIlre a queslo caso dubbio, neanche un caso sicuro di imerfello deIIa
II coniugazione in -ia, er siciIianismo (Iig. 9)
3
.
Iigura 8
Iigura 9
3 Trallazione iu amia di queslo unlo in TAVONI, Un nuctc siruncnic injcr-
naiicc., . 224-229.
Mirko Tavoni
594
Iin qui abbiamo vislo singoIe ricerche, di nalura IessicaIe e/o gram-
malicaIe, esrimibiIi su una soIa riga deIIa maschera di ricerca. Ma
quesla ne annovera ben cinque. Su ogni riga si uo formuIare una
ricerca, e due o lre o anche quallro o cinque ricerche si ossono com-
binare con i cIassici oeralori booIeani AND, OR, NOT, NIAR. Da
nolare che Ia ricerca AND da come risuIlalo quaIunque comresenza
di aroIe aII'inlerno deIIa sezione deII'oera (un inlero canlo deIIa
Ccnnc!ia, cailoIo deI Ccntitic, ecc.). Ier cercare, come accade iu
sesso di voIer fare, risuIlali comresenli a breve dislanza, bisogna
usare I'oeralore NIAR. II quaIe, una voIla seIezionalo, fa arire iI
box Dislanza, cioe a quanle aroIe di dislanza aI massimo devono
cooccorrere Ie aroIe ricercale, con Ia ossibiIila di indicare se devono
comarire neII'ordine in cui ho formuIalo Ia richiesla oure no.
Ier esemio, neII'ambilo di una ricerca suIIa fenomenoIogia deIIa
visione, mi uo inleressare cercare quanlo sesso cooccorrono, e
quanlo da vicino, e in quaIi oere, i verbi tc!crc e parcrc (che in ila-
Iiano anlico ha noloriamenle un vaIore iu forle, fisico: non 'sembrare'
ma 'aarire', con imallo visivo). Scrivero dunque quesli due verbi,
come Iemmi, in due righe successive, e Ii cerchero con Ia funzione
NIAR. Iosso rielere Ia ricerca variando Ia dislanza, e lrovero che Ie
cooccorrenze sono numerosissime, e in lulle Ie oere voIgari: a dislan-
za 20 sono 322, a dislanza 10 sono 201, a dislanza 5 sono 114. In Ialino,
invece, i Iemmi apparcc e ti!cc che reslringero aIIa dialesi alliva,
seIezionando Verbo Ialino quindi, sollo Calegoria, Dialesi: alli-
vo (Iig. 10), er non incIudere ti!ccr, che faIserebbe lullo non
cooccorrono mai, nemmeno a dislanza di 20. Quesla mulua allrazio-
ne deI vedere e deII'aarire e iI orlalo di un'ossessione sliIno-
vislica, cavaIcanliana, che resla viva er lulla Ia carriera oelica, ma
soIo oelica, di Danle, e non comare mai in un universo di discorso
rofondamenle diverso come queIIo deIIa lrallalislica Ialina.
Iigura 10
OanicScarcn. i| ccrpus !c||c cpcrc tc|gari c |aiinc !i Oanic.
595
3. LA RICIRCA SINTATTICA
Iassiamo ora aIIa ricerca sinlallica. La slrada er quesla risorsa,
comIelamenle nuova, e slala aerla da Sara GigIi, che aIIa codifica
sinlallica esausliva deIIa Ccnnc!ia, con lulli i robIemi inlerrelalivi
che essa evidenlemenle comorla, ha dedicalo Ia roria lesi di
dolloralo
4
. Sara GigIi, rendendo a riferimenlo I'imianlo leorico-
descrillivo deIIa Gran!c grannaiica iia|iana !i ccnsu|iazicnc di Renzi e
aIlri
5
, si e osla iI robIema di come aIicare queII'aaralo di
calegorie e nozioni sinlalliche aI leslo deIIa Ccnnc!ia e lradurIo in un
sislema di codifica caace di descrivere iI leslo er inlero, in lulla Ia
sua comIessila e variela di aselli. Con Ia coIIaborazione di IIena
Iierazzo er quanlo riguarda iI formaIismo XML-TII, Sara GigIi ha
orlalo a lermine in modo ecceIIenle un comilo lanlo oneroso quanlo
irlo di robIemi inlerrelalivi, fiIoIogici e Iinguislici, e con cio ha
messo a disosizione deIIa comunila scienlifica uno slrumenlo unico e
sofislicalissimo.
AIIa codifica sinlallica deIIa Ccnnc!ia si sono oi aggiunle, er
ora, queIIa dei rimi due Iibri deI Ccntitic, eseguila da Irancesco
Iiumara er Ia sua lesi di Iaurea seciaIislica
6
, e queIIa deIIe |inc,
reaIizzala da Marla D'Amico neII'ambilo deI IRIN Mcrjcsiniassi c
ccrpcra injcrnaiici !c||iia|ianc aniicc cilalo aII'inizio.
Come si vede neIIa Iig. 1, iI lerzo e iI quarlo camo deIIa maschera
er Ia ricerca sinlallica sono quasi in comune con i rimi due di
queIIa er Ia ricerca grammalicaIe: cioe anche Ia ricerca er calegorie
sinlalliche uo essere combinala con reslrizioni di lio IessicaIe. La
differenza e che iI lerzo camo ammelle soIo Ia ricerca er forme
(differenza che commenleremo sollo), Ia ricerca er forme uo essere
oi secificala, neI quarlo camo, come IaroIa o Solloslringa. Se
invece vogIio fare una ricerca escIusivamenle er calegorie sinlalliche,
senza reslrizioni IessicaIi, anche qui, come neIIa ricerca grammalicaIe,
neI quarlo camo seIezionero Tulle Ie occorrenze. I cami er Ia
ricerca sinlallica sono iI rimo, dedicalo aI lio di roosizione, e iI
4 SARA GIGLI, Cc!ijica siniaiiica !c||a Commedia !anicsca, ScuoIa di dolloralo in
Sludi ilaIianislici deII'Universila di Iisa, lesi arovala neII'a.a. 2003-4 (Commissione
comosla dai roff. Maurizio Dardano, Giusee Ialola, Mirko Tavoni).
5 Gran!c grannaiica iia|iana !i ccnsu|iazicnc, a cura di Lorenzo Renzi, GiamaoIo
SaIvi, Anna CardinaIelli, 3 voII., oIogna, II MuIino 1988-95. Ier gIi uIleriori sviIui
deI rogello bisognera ora fare lesoro deIIa Grannaiica !c||iia|ianc aniicc, a cura di
GiamaoIo SaIvi e Lorenzo Renzi, oIogna, II MuIino 2010.
6 IRANCISCO IIUMARA, Ia siniassi !c| Convivio, lesi di Iaurea seciaIislica in Lingua
e Ielleralura ilaIiana, Universila di Iisa, a.a. 2005-6.
Mirko Tavoni
596
secondo, dedicalo aI grado di subordinazione.
La Iig. 11 moslra in arle iI menu a lendina che si are cIic-
cando suI rimo camo:
Iigura 11
Ma e qui necessario dare, se non I'eIenco comIelo deIIe ozioni
ossibiIi (erche e lroo Iungo, richiederebbe numerose agine),
aImeno I'eIenco comIelo dei macrolii sinlallici e dei lii sinlallici
che si coIIocano risellivamenle suI rimo e suI secondo IiveIIo di
queslo eIenco slrulluralo e numeralo:
I. IRINCIIALI I COORDINATI A UNA IRINCIIALI
A. DICHIARATIVA
B. ISCLAMATIVA
C. INTIRROGATIVA
D. IUSSIVA
E. OTTATIVA
II. SUORDINATI I COORDINATI A UNA SUORDINATA
A. AVVIRSATIVA
B. CAUSALI
OanicScarcn. i| ccrpus !c||c cpcrc tc|gari c |aiinc !i Oanic.
597
C. COMIARATIVA
D. CONCISSIVA
E. CONSICUTIVA
F. ICCITTUATIVA
G. IIISIGITICA
H. ISCLUSIVA
I. IINALI
J. INTIRROGATIVA
K. IIOTITICA
L. LIMITATIVA
M. DI MANIIRA
N. MODALI
O. OLIQUA
P. OGGITTIVA
Q. IRIDICATIVA
R. RILATIVA
S. SOGGITTIVA
T. STRUMINTALI
U. SUORDINATA CON IUNZIONI DI RIIRISA
V. TIMIORALI
III. ISIUDOCOORDINATI
A. ISIUDOCOORDINATA
IV. IARINTITICHI I COORDINATI A UNA IARINTITICA
A. IARINTITICA CON VALORI DI SUORDINATA
B. IARINTITICA MODALIZZANTI
Id ecco, a liloIo esemIificalivo, I'esansione dei rimi lre lii
sinlallici in sollolii, che cosliluiscono iI lerzo IiveIIo deII'eIenco
slrulluralo e numeralo:
I. IRINCIIALI I COORDINATI A UNA IRINCIIALI
A. DICHIARATIVA
1. dichiaraliva
2. dichiaraliva iIIoculiva
3. coordinala asindelica dichiaraliva
4. coordinala avversaliva dichiaraliva
Mirko Tavoni
598
5. coordinala concIusiva dichiaraliva
6. coordinala congiunliva dichiaraliva
7. coordinala congiunliva dichiaraliva iIIoculiva
8. coordinala conseculiva dichiaraliva
9. coordinala correIaliva dichiaraliva
10. coordinala disgiunliva correIaliva dichiaraliva
11. coordinala disgiunliva dichiaraliva
12. coordinala esIicaliva dichiaraliva
B. ISCLAMATIVA
1. escIamaliva
2. coordinala asindelica escIamaliva
3. coordinala congiunliva escIamaliva
C. INTIRROGATIVA
1. inlerrogaliva aIlernaliva
2. inlerrogaliva aIlernaliva relorica
3. inlerrogaliva di lio x
4. inlerrogaliva di lio x relorica
5. inlerrogaliva disgiunliva
6. inlerrogaliva disgiunliva relorica
7. coordinala asindelica inlerrogaliva aIlernaliva
8. coordinala asindelica inlerrogaliva aIlernaliva relorica
9. coordinala asindelica inlerrogaliva di lio x
10. coordinala asindelica inlerrogaliva di lio x relorica
11. coordinala asindelica inlerrogaliva disgiunliva
12. coordinala avversaliva inlerrogaliva di lio x
13. coordinala avversaliva inlerrogaliva di lio x relorica
14. coordinala congiunliva inlerrogaliva aIlernaliva
15. coordinala congiunliva inlerrogaliva di lio x
16. coordinala congiunliva inlerrogaliva di lio x relorica
17. coordinala disgiunliva inlerrogaliva aIlernaliva
18. coordinala disgiunliva inlerrogaliva di lio x
19. coordinala disgiunliva inlerrogaliva disgiunliva
I sollolii sinlallici codificali sono in lullo iu di 300. II sislema
ermelle di inlerrogare iI corus su due IiveIIi: er lii sinlallici (DI-
CHIARATIVA, ISCLAMATIVA, INTIRROGATIVA, ecc.) e er sollo-
lii (dichiaraliva iIIoculiva, coordinala congiunliva escIamaliva, inler-
rogaliva di lio x, ecc.). La rima ricerca, er lii, consenle di ricercare
OanicScarcn. i| ccrpus !c||c cpcrc tc|gari c |aiinc !i Oanic.
599
(e conleggiare) lulle Ie reIalive insieme, lulle Ie conseculive insieme,
lulle Ie ioleliche insieme, ecc., Ia seconda consenle di ricercare
sollolii di roosizione in modo eslremamenle anaIilico. Isisle an-
che Ia ossibiIila di formuIare inlerrogazioni di IiveIIo inlermedio fra
queIIo dei lii e queIIo dei sollolii, sfrullando I'oeralore OR, che
ermelle di combinare aIcuni sollolii sinlallici, lrovando lulli i
Iuoghi dove comare I'uno o I'aIlro di essi.
II secondo camo deIIa ricerca sinlallica (neIIa Iig. 12 vediamo
disiegalo iI suo menu a lendina) ermelle di secificare iI grado di
subordinazione aI quaIe si vuoIe reslringere Ia ricerca deI sollolio di
roosizione definilo neI camo recedenle (iI camo, infalli, si uo
seIezionare soIo avendo seIezionalo rima un sollolio, non un lio).
Ier esemio vogIio vedere Ie inlerrogalive aIlernalive, ma soIo queIIe
che siano subordinale di III grado. Ce ne sono soIo 3, di cui una neI-
I'|njcrnc: Dinlorno mi guardo, come laIenlo / avesse di veder sa|iri
cra nccc, X, 55-56. Si aggiunga Ia ossibiIila di usare gIi oeralori
AND e NIAR, che consenlono di ricercare cooccorrenze di lii di
roosizione, a una delerminala dislanza I'uno daII'aIlro ed evenluaI-
menle neII'ordine voIulo er esemio una causaIe immedialamenle
seguila da una finaIe (come QuaI si Iamenla pcrcnc qui si ncia / er
viver coIa su, non vide quivi., Par. XIV, 25-26) e si erceira iI
numero verliginoso di combinazioni di ricerca sinlallica che si os-
sono coslruire, er risondere ai iu vari ercorsi menlaIi deI ri-
cercalore, aIimenlando una calena virluosa di risosle a curiosila di
ricerca, a Ioro voIla assibiIi di slimoIare nuove inluizioni e nuove
domande.
Vediamo un soIo esemio di una ricerca sinlallica generaIissima, in
queslo caso finaIizzala a una verifica moIlo secifica. In un mio Iavoro
di quaIche anno fa
7
ho rooslo un argomenlo sinlallico che non era
mai slalo addollo a roosilo deIIa vessalissima queslione di forse
cui Guido voslro ebbe a disdegno (|nj. X, 63): e cioe queIIa che i
grammalici generalivi chiamano Ia insuIarila deIIe reIalive, rinci-
io secondo iI quaIe nessun eIemenlo aarlenenle a una frase reIali-
va uo essere disIocalo a sinislra deI ronome reIalivo che Ia inlrodu-
ce.
7 TAVONI, Ccniri|uic siniaiiicc a| !is!cgnc !i Gui!c (If X 61-63). Ccn una ncia su||a
grannaiica|iia c |a |cggi|i|iia !ci c|assici, Nuova Rivisla di Lelleralura IlaIiana, V/1,
2002, . 51-80.
Mirko Tavoni
600
Iigura 12
In arlicoIare, un avverbio che modifichi iI verbo deIIa reIaliva,
mai e oi mai uo essere disIocalo aI di fuori deIIa reIaliva, rima deI
ronome reIalivo. Queslo mi aariva, e lullora mi aare, con lulla
evidenza, un molivo dirimenle, che escIude una deIIe due Iellure
sinlalliche che sono slale dale di queslo verso, e cioe Ia Iellura, accoIla
daIIa maggior arle degIi inlerreli, '.a coIui che forse iI voslro
Guido ebbe a disdegno'.
AII'eoca non disonevo deIIa ricerca sinlallica di DanleSearch, e
ho coslruilo Ia mia argomenlazione in modo diverso, con gIi eIemenli
che olevo reerire. Oggi e ossibiIe solloorre Ia mia lesi a una
verifica esausliva, semIicemenle richiamando insieme lulle Ie roo-
sizioni reIalive in lulla Ia Ccnnc!ia. Lancio dunque Ia ricerca sinlal-
lica: ReIaliva (senza uIleriore secificazione) Tulle Ie occor-
renze. II risuIlalo e (Iig. 13) un lolaIe di 4.201 frasi reIalive neIIa
Ccnnc!ia. Iurlroo, aI momenlo non e ossibiIe chiedere aI sislema
di fare anche I'uIlima oerazione maleriaIe er noi, cioe chiedergIi di
eslrarre da quesle 4.201 frasi queIIe in cui evenluaImenle iI ronome
reIalivo ncn occui Ia rima osizione. Non resla dunque che scorrere
lulle quesle frasi, daIIa rima aII'uIlima: oerazione che comunque
non richiede iu di quaIche ora. NeIIa Iig. 14 aaiono, neI corso di
un laIe scorrimenlo di lulli i conlesli deII'|njcrnc, queIIi comresi in
una lrenlina di versi deI X canlo fra cui iI noslro.
OanicScarcn. i| ccrpus !c||c cpcrc tc|gari c |aiinc !i Oanic.
601
Iorse quesla verifica, se avra Ia azienza di comierIa, insliIIera
quaIche dubbio anche in Inrico MaIalo, che aI mio arlicoIo ha
riballullo riroonendo meri argomenli di nalura Ielleraria, senza
rendere in considerazione iI unlo deIIa mia argomenlazione, che e
Iinguislico e reIiminare, e cioe iI !aic !i jaiic deIIa insuIarila deIIe
reIalive
8
. L'insensibiIila deII'iIIuslre danlisla di fronle aI ragionamenlo
Iinguislico da me sviIualo, in nome deIIa fanlasia invenliva di
Danle neII'uso Iinguislico, serimenlala in miIIe occasioni (. 176),
olrebbe magari incrinarsi una voIla reso allo che su 4.201 frasi
reIalive deIIa Ccnnc!ia non ce n'e una soIa in cui Danle, er esercilare
Ia sua fanlasia invenliva neII'uso Iinguislico, abbia scrillo un avverbio
o un comIemenlo aarlenenle a una reIaliva fuori e rima deIIa
reIaliva slessa.
Iigura 13
8 INRICO MALATO, Nuctc prcspciiitc !cg|i siu!i !anicscni. Ioslfazione aIIa II edizione
di Oanic c Gui!c Cata|canii. || !issi!ic pcr |a Vila nuova c i| !is!cgnc !i Gui!c, Roma,
SaIerno Id. 2004, . 175-183.
Mirko Tavoni
602
Iigura 14
Vediamo ora quaIche esemio di ricerca sinlallica che conlenga
anche un eIemenlo IessicaIe. Come ho gia nolalo, neIIa maschera deIIa
ricerca sinlallica iI rimo camo revede soIo Ia ossibiIila di ricerca-
re er forma, non er Iemma. Queslo significa che Ia Iemmalizzazione
non e fruibiIe aII'inlerno deIIa ricerca sinlallica, come non Io e Ia
marcalura morfoIogica. Queslo erche Ia Iemmalizzazione-marcalura
morfoIogica da una arle, e Ia marcalura sinlallica daII'aIlra, sono
slale reaIizzale su due dislinle coie (in arlenza idenliche) deIIo
slesso corus lesluaIe. Sarebbe slalo imossibiIe sovraorre Ie due
marcalure I'una suII'aIlra: e queslo un Iimile deI formaIismo di codifi-
ca XML che rende imossibiIe, aIIo slalo deII'arle, inlerrogare insieme
er Iemmi, er calegorie morfoIogiche e er calegorie sinlalliche.
Sarebbe invece inleressanlissimo oler combinare quesli diversi lii di
ricerca. AI momenlo, quindi, si ossono ricercare soIo jcrnc aII'inlerno
di frasi. Una inlera cIasse di ricerche di queslo lio e queIIa che
dislingue un cerlo lio di frase a seconda deIIe congiunzioni o
reosizioni che Ie inlroducono. Ier esemio Ie frasi concessive (a
Ioro voIla disaggregabiIi in concessive falluaIi, condizionaIi e a-con-
dizionaIi) inlrodolle da anccra (cnc), attcgna cnc, pcrcnc o sc ecc. ecc.
(rendo queslo esemio daIIa lesi di dolloralo di Sara GigIi, che
dedica un cailoIo aII'arofondimenlo deIIe concessive in raorlo
aIIe Ioro variela inlerne e ai vari inlrodullori). Un esemio aIIa Iig. 15.
OanicScarcn. i| ccrpus !c||c cpcrc tc|gari c |aiinc !i Oanic.
603
Iigura 15
QuaIcosa si uo fare, er inlrodurre neIIa ricerca sinlallica una
condizione IessicaIe un o' iu olenle risello aIIa singoIa forma, ri-
correndo aIIo slrumenlo deIIe esressioni regoIari. Quesle ermel-
lono oerando soIo suIIa forma deIIe aroIe di ricercare aroIe che
risondano a cerli requisili anche comIessi definili voIla er voIla.
Ier esemio ricercare I'esressione regoIare /qua(Ie+Ii+i+I)/ (digilando
quesla slringa di caralleri neI lerzo camo e seIezionando Sollo-
slringa neI quarlo) equivaIe ralicamenle a ricercare Ie forme qua|c,
qua|i, quai, qua| Iegale daIIa funzione OR, ovvero equivaIe quasi a
ricercare iI Iemma qua|c. Iosso quindi, neIIa ricerca sinlallica, combi-
nare quesla ricerca IessicaIe negIi uIlimi due cami con iI lio sinlal-
lico reIaliva neI rimo camo, e ollerro lulle Ie frasi reIalive inlro-
dolle daI ronome reIalivo iI quaIe (Iig. 16).
Mirko Tavoni
604
Iigura 16
I numeri di quesle occorrenze, confronlali coI numero lolaIe deIIe
roosizioni reIalive neIIa Ccnnc!ia e neI Ccntitic, dimoslrano che Ie
reIalive con iI quaIe neIIa Ccnnc!ia sono, in roorzione, circa 6
voIle meno numerose che neI Ccntitic, erche queslo ronome e
moIlo iu frequenle in rosa che in oesia. In reaIla I'equivaIenza non
e erfella, erche, come moslra rorio iI rimo esemio deIIa Iig. 16,
qua| che lu sii, od ombra od omo cerlo!, una reIaliva indiendenle
acondizionaIe come quesla non e inlrodolla da i| qua|c ma da qua|c.
Iosso avvicinarmi aIIo slesso risuIlalo, con iu recisione, digilando
Ia slessa esressione regoIare neIIa ricerca grammalicaIe, reslringendo
Ia ricerca a Ironome voIgare + Calegoria: ReIalivo, ollenendo con
cio di isoIare, fra lulli i ronomi reIalivi, i| qua|c e Ie sue forme fIesse:
ricerca che evidenzia Ia nella sroorzione neII'uliIizzo di queslo
ronome reIalivo neIIe oere in rosa e in queIIe in oesia (anche
neIIa Viia ncta Ie occorrenze di i| qua|c sono quasi lulle neIIe arli in
rosa).
Iiu in generaIe, er avvicinare in quaIche modo ricerca gramma-
licaIe e ricerca sinlallica, neII'alluaIe imossibiIila di fonderIe in una
ricerca unica, abbiamo crealo Ia ossibiIila, neI corso di quaIunque
ricerca sia grammalicaIe sia sinlallica, di arire in una fineslra araI-
IeIa Ia corrisondenle orzione di leslo con I'aIlra codifica: sinlallica
se sliamo effelluando una ricerca grammalicaIe, e viceversa. Cos, se
neIIa ricerca grammalicaIe cerco lulli i ronomi reIalivi (Tulle Ie
occorrenze + Ironome voIgare + Calegoria: ReIalivo), quindi
cIicco su Commedia Inferno (1.030 occorrenze), quindi su uno dei
OanicScarcn. i| ccrpus !c||c cpcrc tc|gari c |aiinc !i Oanic.
605
canli deII'|njcrnc, melliamo iI XII, a queI unlo in aIlo si are iI Iink
Moslra codifica sinlallica (Io vediamo qui, in una schermala deIIo
slesso lio, neIIa Iig. 5). Se vi cIicco, ollengo di affiancare, aIIa rima
fineslra in cui e visuaIizzalo iI XII canlo con codifica grammalicaIe,
una seconda in cui e visuaIizzalo Io slesso leslo con codifica sinlallica.
Ioiche iI leslo codificalo, scorrendovi iI mouse, moslra Ia codifica
grammalicaIe deIIa aroIa su cui iI mouse si osiziona, o Ia codifica
sinlallica deIIa frase su cui iI mouse si osiziona, osso in quaIche
modo combinare informazioni grammalicaIi e sinlalliche. Ier esemio
(Iig. 17), osso verificare suIIa seconda fineslra che lio di roo-
sizione reIaliva e queIIa inlrodolla da ognuno dei ronomi reIalivi
evidenziali neIIa rima fineslra: iI cnc deI v. 4 inlroduce una reIaliva
reslrilliva con anlecedenle, iI cni deI v. 9 una reIaliva indiendenle, e
cos via.
Iigura 17
3. LA RICIRCA SINTATTICA SUL IARLATO DII IIRSONAGGI
Infine, er dare un'idea deIIe ossibiIila offerle daIIa ricerca sinlal-
lica Iimilala ai discorsi o ensieri ronunciali o ensali da ersonaggi
deIIa Ccnnc!ia, codifica recenlemenle inlrodolla da Marla D'Amico,
vediamo anzilullo che, cIiccando su DiaIoghi neIIa maschera di
ricerca, si are un box che ermelle di seIezionare i Iersonaggi
(lulli i ersonaggi deIIa Ccnnc!ia vi comaiono in ordine aIfabelico)
e/o Ia TioIogia di discorso. Lanciamo er rima cosa una ricerca
Mirko Tavoni
606
sinlallica scegIiendo, neIIa Iineslra DiaIoghi, QuaIsiasi ersonag-
gio e QuaIsiasi lioIogia di discorso, er andare a verificare Ia
resenza e dislribuzione di un cerlo lio di roosizione er
esemio Ie roosizioni rinciaIi inlerrogalive aII'inlerno deIIe
arli mimeliche deI oema (Iig. 18). II risuIlalo neIIa Iigura 19: 133
frasi rinciaIi inlerrogalive neII'|njcrnc, 116 neI Purgaicric, 30 neI
Para!isc. La discreanza fra Ia lerza canlica e Ie rime due e
cIamorosa, e rende evidenle (cio che resla invece invisibiIe a occhio
nudo) Ia diversa condizione cogniliva dei beali risello ai dannali e
ai enilenli.
Iigura 18
OanicScarcn. i| ccrpus !c||c cpcrc tc|gari c |aiinc !i Oanic.
607
Iigura 19
I soIo un esemio. La lesi di Iaurea seciaIislica di Marla D'Ami-
co
9
esIora una grande messe di dali desumibiIi daI sislema di
inlerrogazione, combinandoIi con aIlri dali, come gIi inlrodullori, i
lemi e i modi verbaIi, Ia semanlica deIIe frasi, ricavabiIi er aIlra via,
lraendone concIusioni moIlo inleressanli circa Ia carallerizzazione
Iinguislica in raorlo aII'idenlila slorica dei ersonaggi, indivi-
duaImenle e er calegorie in senso Ialo sociaIi, circa i fenomeni di
mimesi deI arIalo che I'aulore sfrulla graduandoIi saienlemenle, e
circa i diversi, aunlo, sliIi cognilivi che rifIellendosi in slrullure
sinlalliche riviIegiale quaIificano i discorsi deIIe lre Canliche.
4. UN SISTIMA AIIRTO
DanleSearch e dunque un sislema aerlo. Aerlo ad arricchirsi di
nuove informazioni, lradolle in codifiche lesluaIi, seguendo (e aI
lemo slesso rendendo ossibiIi) nuove Iinee di ricerca suIIa Iingua di
Danle aerle da nuovi ricercalori, in un'ollica coIIaboraliva Ia cui
forza e di saer lenere insieme (grazie aI risello e insieme aI
olenziamenlo degIi slandard di codifica) lulli i successivi sviIui
9 MARTA D'AMICO, Ia siniassi !c||a|!i|a. Siu!ic su||a siniassi pcric!a|c !ci !isccrsi !irci-
ii !c||c aninc nc||a Commedia !i Oanic, lesi di Iaurea seciaIislica in Lingua e Ielleralura
ilaIiana, Universila di Iisa, a.a. 2008-09, in corso di slama resso ITS (AIIa giornala.
Sludi e lesli di Ielleralura ilaIiana), Iisa.
Mirko Tavoni
608
senza incrinare Ia coerenza funzionaIe deII'insieme. I aerlo ad
arricchirsi di nuove funzioni di ricerca, seguendo i rogressi dei
sislemi di injcrnaiicn rciricta|, che neII'aIicazione a sofislicali saeri
umanislici lrovano slimoIi di crescila, in osmosi con quanlo avviene
nei vivaci ambienli deII'informalica umanislica (nunaniiics ccnpuiing)
inlernazionaIe.
Mi fa iacere dedicare queslo aggiornamenlo a Vincenzo IIaceIIa,
che di quesla imresa e slalo uno dei rimi eslimalori.
Unitcrsiia !cg|i Siu!i !i Pisa
MARIA MASLANKA-SORO
DANTI I LA TRADIZIONI DILLA TRAGIDIA
ANTICA NILLA COMM|O|A
1. L'obiellivo di queslo arlicoIo e I'anaIisi deIIa resenza e deIIa
nalura dei Iegami lra Ia lragedia anlica, rima di lullo queIIa greca, e
Ia Ccnnc!ia di Danle. Vorrei subilo chiarire che e iI carallere deI lragi-
co nei suoi vari aselli in aIcuni eisodi deII'|njcrnc che sla aIIa base
deI mio aroccio crilico e rima di affronlare I'argomenlo indicalo
neI liloIo rilengo necessario giuslificare Ia sua Iegillimila sia daI
unlo di visla slorico che melodoIogico.
I suerfIuo ricordare che Danle non conosceva Ia Pcciica di Arislo-
leIe e che non aveva neanche Ia conoscenza dirella deIIe oere dei lre
grandi lragediografi (neI suo oema menziona soIo Iuriide)
1
, aIIa
maggior arle deIIe quaIi ossono essere aIicale Ie calegorie e Ie
norme arisloleIiche. Tanlo iu are sorrendenle iI fallo che neIIa
macroslrullura deIIa Ccnnc!ia rilroviamo deIIe microslrullure lragi-
che che resenlano diverse affinila con Ia lragedia neIIa sua forma
archeliica. Iolremmo iolizzare che cio sia dovulo ad una slraordi-
naria inluizione arlislica deI noslro Ioela, ma credo che si ossa dare
una risosla iu recisa. Saiamo che egIi aveva una conoscenza
dirella di aIcune oere deII'anlichila cIassica, lra cui queIIa deII'|iica
Niccnacnca di ArisloleIe e dei grandi oemi di VirgiIio, Slazio, Luca-
no, oeli er ecceIIenza lragici secondo i dellami deIIa relorica me-
dievaIe, infalli, sia I'|nci!c che Ia Tc|ai!c e Ia |arsag|ia sono scrille in
uno sliIe aIlo, lrallano di falli e di ersonaggi iIIuslri e Ia Ioro narra-
zione non e riva di comonenle lragica. Ma er quanlo sia imor-
lanle Ia resenza di quesli ed aIlri lesli di riIievo (come Ie Mciancrjcsi
di Ovidio) neI lessulo oelico deIIa Ccnnc!ia, non meno nolevoIe e Ia
resenza di una imonenle lradizione indirella, deIIe cui dimensioni e
carallere Danle non oleva essere deI lullo consaevoIe. Se neI caso
deIIa rima si uo arIare deIIa inlerlesluaIila, er Ia seconda iu a-
rorialo sembra iI lermine inlerdiscorsivila, rooslo da Cesare
Segre e accoIlo da Maria Corli a roosilo deIIa lradizione araba neIIa
1 Cfr. Purg. XXII, 106.
Maria MasIanka-Soro 610
Ccnnc!ia
2
. Sembra iu che vera er Danle un'osservazione di IauI
VaIery: rien de Ius originaI, rien de Ius sci que se nourrir des au-
lres
3
, ma essa va forse inlegrala con iI ensiero che iI suo caoIavoro
e come un aIinseslo deIIa memoria in cui i segni di una cuIlura si
sovraongono a queIIi di un'aIlra, conservandoIe enlrambe.
Infalli, grazie aIIa mediazione degIi aulori Ialini o dei commenli Ia-
lini ad ArisloleIe in cui confIuiscono moIli eIemenli deIIa cuIlura
greca, sia suI iano conlenulislico che su queIIo formaIe (basli ensare
aII'infIuenza di Omero dai cui oemi ArisloleIe iolelizzava che si
olesse rilagIiare iu di una lragedia)
4
, ossiamo rilrovare neII'|njcrnc,
a IiveIIo di inlerdiscorsivila, un diaIogo con Ia lragedia greca, er
quanlo riguarda Ia visione deIIa reaIla, Ia concezione di aIcuni erso-
naggi, gIi eIemenli slrulluraIi deIIe Ioro narrazioni o degIi eisodi a
cui aarlengono, iI carallere dei confIilli, queIIo deIIa coIa e deIIa
ena, iI concello di kainarsis ecc.
2. A queslo unlo e oorluno orsi Ia domanda, se iI liloIo slesso
deI caoIavoro danlesco non escIuda iI discorso suI lragico. Saiamo
ero che esso, cos come Ie definizioni danlesche deI genere comico
falle suIIa scia deIIe leorie reloriche deII'eoca Iasciavano erIessi
gia i commenlalori lrecenleschi
5
. II crilerio conlenulislico di cui Danle
2 Cfr. MARIA CORTI, Ia 'Ccnnc!ia' !i Oanic c |c|ircicn|a is|anicc, eIfagor, L
(1995), . 301, IADIM, Scriiii su Cata|canii c Oanic, Torino, Iinaudi 2003, . 85, nola 3,
dove viene cilalo CISARI SIGRI, |ncricsiua|c/|nicr!isccrsitc. Appunii pcr una jcncnc-
nc|cgia !c||c jcnii, in Alli deI convegno di semiolica organizzalo daII'AISS suI lema:
Iinicricsiua|iia, 1982.
3 IAUL VALIRY, Canicrs, voI. 2, Iaris, GaIIimard 1945, . 1002-1003.
4 Cfr. Pcci., 23, 1459b 2-4.
5 Cfr. DANTI, V|, II, IV, 5-6: er lragediam sueriorem sliIum inducimus, er
comediam inferiorem |.j Si lragice canenda videnlur, lunc assumendum esl vuIgare
iIIuslre |.j Si vero comice, lunc quandoque mediocre quandoque humiIe vuIgare
sumalur (Con 'lragedia' inlendo Io sliIe sueriore, con 'commedia' queIIo inferiore
|.j Se e un argomenlo da canlare in sliIe lragico, aIIora bisognera assumere iI voIgare
iIIuslre |.j Se invece Io sliIe e comico, si rendera ora un voIgare mezzano ora queIIo
umiIe), iI leslo cilalo in originaIe e in lraduzione e lrallo daII'ed.: DANTI, Oc tu|gari
c|cqucniia, inlrod., lrad. e nole di Villorio CoIelli, MiIano, Garzanli 2000
4
(1991), . 64-
65, cfr. anche |p. X|||, 10: Tragedia in rinciio esl admirabiIis el quiela, in fine seu
exilu esl felida el horribiIis |.j ul alel er Senecam in suis lragediis. Comedia vero
inchoal aserilalem aIicuius rei, sed eius maleria rosere lerminalur, ul alel er
Terenlium in suis comediis |.j SimiIiler differunl in modo Ioquendi: eIale el subIime
lragedia, comedia vero remisse el humiIiler |.j Il er hoc alel quod Comedia dicilur
resens ous. Nam si ad maleriam resiciamus, a rinciio horribiIis el felida esl quia
Infernus, in fine rosera, desiderabiIis el grala, quia Iaradisus, ad modum Ioquendi,
remissus el humiIis, quia Ioculio vuIgaris in qua el muIiercuIe comunicanl (La
lragedia e aI rinciio ammirabiIe e Iacida, aIIa fine o concIusione felida e orribiIe |.j
com'e chiaro da Seneca neIIe sue lragedie. La commedia oi inlroduce I'acerbila di
Oanic c |a ira!izicnc !c||a iragc!ia aniica nc||a Commedia 611
arIa neIIa |pisiu|a XIII (se si ammelle che Iui ne sia I'aulore)
6
I'orribiIe e felido inizio e iI rosero e desiderabiIe fine fece consla-
lare a Gianfranco Conlini che lemalicamenle I'|njcrnc e Ia arle lragica
deIIa Ccnnc!ia
7
. II crilerio sliIislico che allribuisce ad essa Io sliIe umi-
Ie (remissus el humiIis), ammelle una cerla |iccniia sii|isiica, Iaddove
Danle, richiamandosi aII'aulorila di Orazio, cila quallro versi deIIa
sua Ars Pcciica:
Inlerdum lamen el vocem commedia loIIil,
iralusque Chremes lumido deIiligal ore,
el lragicus Ierunque doIel sermone edeslri,
TeIehus el IeIeus |.j (93-96)
(TaIora ero anche Ia commedia aIza Ia voce,
e I'iralo Cremele rimrovera con lumido Iinguaggio,
e iI lragico sesso si duoIe con discorso edeslre
TeIefo e IeIeo, elc. )
8
.
Ma a differenza deI oela romano, Danle fa deII'eccezione una re-
goIa, cosicche si uo arIare di IuraIismo sliIislico
9
o di sliIe
mislo
10
ovvero di uso di vari regislri Iinguislici a seconda deIIa lema-
lica di un dalo eisodio, deI genere e carallere deI ersonaggio
rinciaIe, deIIa nalura deIIo sazio ecc. I se in moIli eisodi
deII'|njcrnc domina Io sliIe comico che melle in riIievo Ia visione
aIcuna cosa, ma Ia sua maleria lermina roseramenle, come aare da Terenzio neIIe
sue commedie |.j Differiscono simiImenle neI modo d'esrimere: Ia lragedia in modo
eIevalo e subIime, e Ia commedia in modo iano e umiIe |.j I er cio e chiaro che Ia
resenle oera si dice Commedia. Infalli se guardiamo aIIa maleria, e orribiIe e felida aI
rinciio, erche Inferno, rosera, desiderabiIe e accella aIIa fine, erche Iaradiso, aI
modo d'esrimere, e iI modo iano e umiIe, erche Ia Iingua voIgare in cui discorrono
anche Ie donnelle), iI leslo cilalo in originaIe e in lraduzione e lrallo daII'ed.: DANTI,
Tuiic |c cpcrc, a cura di Luigi Iasucci, MiIano, Sansoni 1993, . 344-45.
6 Cfr. er es. AMILCARI A. IANNUCCI, Oanics Tnccrq cj Gcnrcs an! inc Oitina
Ccnnc!ia, Danle Sludies, voI. XCI (1973), . 23, nola 1, HINRY ANSGAR KILLY,
Tragc!q an! Ccnc!q jrcn Oanic ic Pscu!c-Oanic, erkeIey-Los AngeIes-London, Univ. of
CaIifornia Iress 1988, . 1 sgg., ZYGMUNT ARANSKI, Ncics cn Oanic, inc |pisi|c ic
Cangran!c an! Mc!icta| Ccnc!q, Leclura Danlis, voI. VII (1990), . 72-95.
7 Cfr. GIANIRANCO CONTINI, Uni!ca !i Oanic, Torino, Iinaudi 1976, . 126.
8 DANTI, Tuiic |c cpcrc, cil., . 345.
9 Cfr. CONTINI, Varianii c a|ira sii|isiica. Una raccc|ia !i saggi (1938-68), Torino,
Iinaudi 1970, . 171.
10 Isaminalo, lra I'aIlro, da IRICH AUIRACH, Iiicrarq Ianguagc an! |is Pu||ic in Iaic
Iaiin Aniiquiiq an! in inc Mi!!|c Agcs (lil. orig.: Iiicraiurspracnc un! Pu||ikun in !cr
|aiciniscncn Spaianiikc un! in Miiic|a|icr, ern 1958), London, RoulIedge & Kegan IauI
Ild. 1965, . 25-66.
Maria MasIanka-Soro 612
deI caos moraIe e siriluaIe, ed e sesso I'esressione deI disrezzo di
Danle-narralore er aIcuni dannali
11
, in queIIi invece coslruili inlorno
ad aIcuni ersonaggi che non mancano di una cerla nobiIla d'animo
(abilanli deI Limbo, Irancesca da Rimini, Iarinala degIi Uberli, Iier
deIIa Vigna, runello Lalini, UIisse ed aIcuni aIlri), Io sliIe divenla
mimelico assumendo una dimensione subIime ed aIla, iI che conlri-
buisce a creare iI cIima lragico e rende iu convincenli Ie aroIe dei
ersonaggi che si senlono rolagonisli di una lragedia. Cio comIica
Ia comrensione deI senso rofondo dei singoIi eisodi, lanlo a Danle-
eIIegrino, quanlo aI Iellore imIicilo, iscrillo neI leslo e richiede che
laIe senso venga consideralo neIIa roselliva comica che com-
rende anche iI Purgaicric e iI Para!isc.
Nei delli eisodi Ia quaIifica di lragico sella non soIamenle
aIIo sliIe, ma inoIlre ad aIcuni eIemenli slrulluraIi, nonche a cerli lralli
dei ersonaggi slessi e dei discorsi che quesli rivoIgono a Danle-
eIIegrino. In iu, ci sono dei resuosli, come suggeriscono aIcune
ricerche reIalivamenle recenli
12
, ma che si riaIIacciano aIIe considera-
zioni falle da envenulo da ImoIa, er rilenere che iI liloIo slesso non
escIuda Ia comonenle lragica. Secondo queslo commenlalore lrecen-
lesco Ia Ccnnc!ia, grazie aII'amio sellro dei molivi e ersonaggi di
cui lralla, olrebbe essere chiamala commedia, lragedia o salira ed e
quesl'uIlima denominazione che egIi riliene Ia iu aroriala:
Sicul in islo Iibro esl omnis ars hiIosohie, ul diclum esl, ila
esl omnis ars oelrie. Unde si quis veIil subliIiler invesligare,
hic esl lragedia, salyra, el comedia. Tragedia quidem, quia
describil gesla onlificum, rincium, regum, baronum, el
aIiorum magnalum el nobiIium, sicul alel in lolo Iibro.
Salyra, idesl rerehensoria, rerehendil enim mirabiIiler el
audacler omnia genera viciorum, nec arcil dignilali, oleslali,
veI nobiIilali aIicuius. Ideo convenienlius ossil inliluIari Saiqra
quam Tragc!ia veI Ccnc!ia
13
.
11 Cfr. ad esemio I'eisodio dei ai simoniaci neIIa lerza boIgia deII'ollavo cer-
chio o queIIo dei barallieri neIIa quinla boIgia deI medesimo cerchio (risellivamenle
nei canli XIX e XXI-XXII).
12 Cfr. MIRKO TAVONI, || iiic|c !c||a Ccnnc!ia !i Oanic, Nuova Rivisla di
Lelleralura IlaIiana, voI. I (1988), fasc. 1, . 17-34, ARANSKI, Oanic an! Mc!icta|
Pcciics, in Oanic. Ccnicnpcrarq Pcrspcciitcs, ed. by AmiIcare A. Iannucci, Toronlo-
uffaIo-London, Univ. of Toronlo Iress 1997, . 13 sgg., in arlicoIare . 13-14.
13 INVINUTO DA IMOLA, Ccncniun supcr Oaniis A|!igncrij Ccncc!ian, a cura di
Iacob IhiIi Lacaila, voI. I, IIorenliae, arbera 1887, . 19 (Come in queslo Iibro c'e
ogni genere di fiIosofia, come si e dello, cos c'e ogni genere di oesia. Iercio se
quaIcuno voIesse indagare iu solliImenle, c'e qui lragedia, salira, commedia. La
Oanic c |a ira!izicnc !c||a iragc!ia aniica nc||a Commedia 613
Quesla considerazione si uo siegare con iI fallo che neI Medioe-
vo rorio Ia salira assava er uno dei due generi di commedia,
come Ieggiamo neIIe |iinc|cgic di Isidoro da SivigIia, neI Iibro VIII
(vii, 6-7) arIando dei oeli comici, accanlo a queIIi anlichi (tcicrcs),
IIaulo e Terenzio, egIi one i nuovi (ncti), lra cui annovera gIi aulori
deIIe salire Orazio, Iersio e GiovenaIe, i quaIi neIIe Ioro oere biasi-
mano vilia |.j deIicla |.j eccala. II iu vicino di Ioro a Danle,
quanlo aIIa vena oelica e aIIo sirilo crilico, sarebbe GiovenaIe, |au!a-
icr icnpcris acii, che non esila a crilicare asramenle avidila e
corruzioni di ogni genere neIIa Roma dei suoi lemi, causa di disgra-
zie umane, deIilli e comorlamenli iu sregevoIi. II suo sliIe osciIIa
lra alelico e voIgare (neIIe invellive), lra subIime e umiIe e cosliluisce
I'esemio di uno sliIe mislo lra lragico e comico
14
. Si nola ure
un'aIlra anaIogia con Io sliIe danlesco: GiovenaIe richiamandosi aI
assalo Io fa sesso in funzione deI resenle.
Si uo quindi dire che lanlo Ie ricerche anliche quanlo queIIe iu
recenli orlano aIIa concIusione che iI genere comico era moIlo ca-
ienle neI Medioevo: oleva incIudere ogni argomenlo e senlimenlo, e
uliIizzava una vasla scaIa di regislri formaIi. Iercio Ia comonenle
lragica neII'oera di Danle vi sarebbe resenle non maIgrado Ia sua
dimensione comica, ma er cos dire in funzione di essa.
3. Doo quesli chiarimenli Ia queslione non meno imorlanle che
si one rima di affronlare i Iegami deIIa Ccnnc!ia con Ia lragedia
anlica e che are slrellamenle connessa con Ia nalura deI lragico in
Danle, e iI carallere deIIa nincsis ivi resenle. asandomi sui risuI-
lali anche recenli deIIe ricerche riguardanli iI difficiIe robIema
deII'imilazione in Ielleralura
15
e, aIIo slesso lemo, rimanendo vicino
lragedia, in quanlo descrive azioni dei ai, rincii, re, baroni e di aIlri magnali e
nobiIi, come aare in lullo iI Iibro. La salira, cioe queIIa che biasima, biasima, infalli,
mirabiImenle e coraggiosamenle lulli i generi di vizi, senza badare aIIa dignila, olere e
origine nobiIe di quaIcuno. Iercio |quesl'oeraj olrebbe iulloslo orlare iI liloIo di
salira che non queIIo di lragedia o commedia: lrad. mia).
14 NeIIa Saiira VI, 634-37, egIi e ben consaevoIe di suerare i Iimili deI genere
salirico: Iingimus haec aIlum salura sumenle colhurnum / sciIicel, el finem egressi
Iegemque riorum / grande SohocIeo carmen bacchamur hialu, / monlibus ignolum
RuluIis caeIoque Lalino` (Sono io che invenlo quesle cose er caIzare aIIa salira
I'auIico colurno e, suerando i Iimili fissali dai miei redecessori, er Ievare invasalo,
con I'enfasi d'un SofocIe, un aIlo canlo, ignolo ai monli ruluIi ed aI cieI Ialino`), iI leslo
cilalo in originaIe e in lraduzione e lrallo daII'ed.: DICIMO GIUNIO GIOVINALI, Ccnirc |c
!cnnc (lil. orig.: Saiura VI), a cura di Cesare VivaIdi, Roma, Nevlon Comlon 1993, .
90-91, cfr. TAVONI, o. cil., . 30 sgg.
15 Cfr. CHARLIS ALTIIRI, Aci an! Qua|iiq. A Tnccrq cj Iiicrarq Mcaning an!
Hunanisiic Un!crsian!ing, Amhersl 1981, MICHAIL RIIIATIRRI, |nicricxiua| |cprcscn-
Maria MasIanka-Soro 614
aI concello di nincsis in ArisloleIe
16
, arlo daI resuoslo che essa
sia una raresenlazione fillizia deIIa reaIla, creala neIIa menle
deII'aulore, in cui Ia lrasosizione di un sislema di segni in un aIlro
avviene grazie aI ragionamenlo anaIogico, lramile I'uso di varie slra-
legie Iinguisliche e sliIislico-reloriche. II fenomeno deI lragico neIIa
Ccnnc!ia, e iu recisamenle neII'|njcrnc, uo essere siegalo con un
melodo arlicoIare deII'imilazione, iI reaIismo figuraIe formuIalo da
Irich Auerbach e da Iui aIicalo aI caoIavoro danlesco, ma che
risaIe ai rimi Iadri deIIa Chiesa
17
. Queslo melodo inlerrelalivo
slabiIisce er cilare Auerbach fra due falli o ersone un nesso
in cui uno di essi non significa soIlanlo se slesso, ma significa anche
I'aIlro, menlre I'aIlro comrende o ademie iI rimo
18
. RiferendoIo
aIIa reaIla raresenlala neII'|njcrnc si uo conslalare che gIi evenli e i
ersonaggi conservano iI Ioro senso slorico o melaslorico neI mondo
uIlralerreno, divenlando aI lemo slesso veicoIi deIIa reaIla universaIe
ed elerna. NeIIa roselliva escaloIogica Ia vila lerrena e visla come
refigurazione deI Ioro essere pcsi ncricn, e queII'uIlimo come adem-
imenlo deIIa figura lerrena di ciascuno. Quindi Ia oesia deI oema
sacro dovrebbe, suIIa scia deIIa ibbia, far vedere in che modo iI
mondo lerreno lrova Ia sua iena reaIizzazione oIlremondana, in
quanlo I'aIdiIa fa arle deI iano divino e nei suoi confronli lulli
i fenomeni lerreni hanno carallere unicamenle figuralivo. Conforme-
menle a queslo genere di reaIismo iI senso IelleraIe deIIa Ccnnc!ia
siaius aninarun pcsi ncricn (|p. XIII, 8) esrime I'essenza deIIa vila
lerrena di ciascuno, Ia quaIe funge da jcrna pcrjcciicr di queIIa figura.
II segno maleriaIe deI suo ademimenlo divenla iI conlraasso: allra-
verso iI significalo simboIico esso riveIa non soIo Ia quaIila deIIa ena,
ma anche Ia verila su ogni essere umano, fissala in elerno.
La nincsis neII'|njcrnc consisle neIIa raresenlazione dei drammi
umani che, come in una lragedia, sono deslinali a non avere una soIu-
zione osiliva. Issi si svoIgono neIIa coscienza deIIe anime dannale
Ie quaIi, grazie aIIa memoria, sono in ossesso di lulla Ia Ioro vila.
In quesla esislenza immulabiIe e alemoraIe (deII'elerno resenle)
irrome incessanlemenle lramile i ricordi Ia reaIla slorica e Ia ro-
bIemalica fusione di enlrambe Ie dimensioni lerrena ed uIlralerrena
iaiicn. On Mincsis as |nicrprciaiitc Oisccursc, CrilicaI Inquiry, voI. XI (1984), LUIZ
COSTA LIMA, Sccia| |cprcscniaiicn an! Mincsis, Nev Lilerary Hislory, voI. III (1985),
Mincsis u !qskursic |iicrackin, a cura di CzesIav NiedzieIski, }erzy Seina, Torun, Wyd.
Univ. MikoIa|a Koernika 1996, RYSZARD NYCZ, Tcksicuq suiai, Krakv, Universilas
2000
2
.
16 SviIualo in modo arlicoIare nei rimi cailoIi deIIa Pcciica.
17 Cfr. AUIRACH, Siu!i su Oanic, MiIano, IeIlrineIIi 1993
10
(1963), . 176-226.
18 Ivi, . 209.
Oanic c |a ira!izicnc !c||a iragc!ia aniica nc||a Commedia 615
orla con se una Iacerazione diaIellica. I un confIillo aIimenlalo da
assioni vioIenle che sono conlinuazione di queIIe resonsabiIi deIIa
morle siriluaIe dei dannali, quesl' uIlima divenlera lolaIe doo iI
Giudizio UniversaIe, neI momenlo in cui Ie anime enlreranno se-
condo S. Agoslino (Ie cui idee in roosilo Danle-aulore sembra
assimiIare) in uno siaius ncricn!i che corrisonde aIIa seconda mor-
le che ciascun grida (|nj. I, 117)
19
. L'immensa lensione non lrova
nessuno sbocco neIIe azioni che ossano essere indirizzale ad un de-
lerminalo fine.
II confIillo iu significalivo e, crediamo, queIIo lra Ia figura e iI suo
ademimenlo, vaIe a dire lra Ia vila lerrena e Ia forma che I'anima e
coslrella ad assumere neII'aIdiIa. Isso genera aIlri confIilli, come queI-
Io lra resenle e assalo, lra vaIori oggellivamenle osilivi, aar-
lenenli a queI assalo, come amore, assione oIilica, onore, desiderio
deIIa conoscenza ed aIlri, e I'alluaIe condizione dei dannali, lra neces-
sila soggelliva che fece Ioro solloorre quei vaIori ai fini che gIi
nascosero Ie verila uIlime e Ia necessila oggelliva che ne risuIlo pcsi
ncricn. Quesli confIilli sono lragici` S e no. S, se vengono considera-
li daI unlo di visla dei eccalori, che e anche iI unlo di visla di
Danle-eIIegrino, deslinalo ero a subire una conlinua evoIuzione neI
rocedere deI cammino. No, se si assume Ia roselliva di Danle au-
lore-narralore
20
, iI quaIe lramile diversi arlifici relorico-sliIislici caral-
lerizzanli i dannali, nonche allraverso Ie Ioro aroIe, fa comromelle-
re quei vaIori senza che Ioro ne siano consaevoIi, effelluando uno
smonlaggio di cio che e lragico. Iercio a quesli confIilli si sovraone
anche queIIo lra Danle-narralore e Danle-eIIegrino che non rimane
mai slalico, ma lende a diminuire rogressivamenle con iI rocedere
deIIa narrazione fino aI riconoscimenlo (da arle di quesl'uIlimo) deI-
Ia giuslizia divina iI cui carallere oggellivo cosliluisce aIIa Iuce
deIIa dollrina deI Iibero arbilrio iI erno deIIa visione crisliana che
sla aIIa base deII'inlero oema.
4. DeI lragico neIIa Ccnnc!ia si uo infalli arIare soIo in lermini
di un gioco iIIusorio in cui aIcuni dei dannali cercano di lrascinare
Danle-eIIegrino. Una funzione significaliva svoIge qui Ia relorica
scnsu |argc, Ia quaIe non si Iimila soIo aII'eIemenlo verbaIe, ma com-
19 Cfr. S. AGOSTINO, Oc citiiaic Oci XIII, 11. Tulle Ie cilazioni deIIa Ccnnc!ia neI
resenle arlicoIo sono lralle daII'ed.: DANTI ALIGHIIRI, Ia Ccnnc!ia scccn!c |aniica
tu|gaia, Idizione NazionaIe a cura deIIa Sociela Danlesca IlaIiana, MiIano, Mondadori
1966-67.
20 Si lralla di un'unica calegoria deI cosiddello aulore imIicilo: cfr. ANGILO
MARCHISI, Icjjicina !c| racccnic, MiIano, Mondadori 1998 (1983), . 76-80.
Maria MasIanka-Soro 616
rende gesli, sguardi, relicenze varie. Issa si nulre, er cos dire, deI
paincs neI senso arisloleIico deIIa aroIa, cioe deIIa sofferenza, coslrin-
gendo Danle-eIIegrino ad una Iolla conlinua con iI senlimenlo di
iela e sesso anche con queIIo di aura. Significalivamenle iI suo
cammino allraverso iI rimo regno uIlralerreno viene chiamalo
aII'inizio deI Canlo II, che funge da roemio aIIa rima canlica, Ia
guerra / s deI cammino e s de Ia ielale (|nj. II, 4-5) e rorio queslo
senlimenlo one Ie basi er una kainarsis, Ia quaIe qui, come neIIa
lragedia greca, divenlera fonle di una nuova consaevoIezza. Nono-
slanle ero cerle rassomigIianze (che riguardano sorallullo Ia sua
funzione, vaIe a dire iI raggiungimenlo di una nuova consaevoIezza),
Ia kainarsis danlesca si aIIonlana da queIIa arisloleIica er iI diverso
vaIore e sessore semanlico. Non enlrando qui neIIa discussione suI
comIesso robIema deIIa kainarsis arisloleIica, ci Iimileremo soIlanlo
a conslalare che neIIa lragedia greca essa ossiede un senso rima di
lullo inleIIelluaIe ed eslelico, e riguarda iI Iellore (Io sellalore),
in quanlo iI oela deve rodurre iI iacere che si da grazie
aII'imilazione da iela e aura
21
(Pcci., 14, 1453b 10-11), secondo una
deIIe inlerrelazioni rilenule iu vaIide
22
Io sellalore divenlalo
coscienle che Ia disgrazia deII'eroe lragico, fonle deII'c|ccs e pnc|cs,
sia un fallo che riguarda Ia finzione mimelica, ne rende Ie dislanze,
iI che coincide con Ia sua Iiberazione dai delli senlimenli. In queslo
modo viene reaIizzalo I'obiellivo rinciaIe deIIa lragedia, conforme-
menle aIIa sua definizione neIIa Pcciica (6, 1449b 24-29). NeII'|njcrnc,
invece, Ia kainarsis si rivesle sorallullo deI senso elico-conoscilivo e
riguarda Danle-eIIegrino (e soIo allraverso Iui I'umanila smarrila), iI
quaIe dovrebbe caire grazie agIi inconlri con i dannali Ia nalura e
iI senso rofondo deI maIe e deI eccalo er vincerIi in se slesso e non
cedere ad essi in fuluro.
La kainarsis non e I'unica calegoria roria deIIa lragedia, lra-
mile cui iI oema danlesco resenla cerle affinila con Ia lradizione
deIIa lragedia anlica. Un'aIlra sarebbe iI paincs che, secondo ArisloleIe,
cosliuisce Ia condizione sinc qua ncn di una siluazione lragica (cu
iragikcn, apaincs gar: Pcci., 14, 1453b 38-39), ma non e Ia condizione
sufficienle. Che iI iu grande paincs olesse essere rivo deI senso lra-
gico, Io saeva bene Io Slagirila, secondo cui Ia sofferenza di un uomo
maIvagio non uo suscilare ne iela ne aura (Pcci., 13, 1453a 1-4).
II modo in cui i rolagonisli dei grandi eisodi deII'|njcrnc si
21 II leslo e cilalo daII'ed.: ARISTOTILI, Pcciica, inlrod., lrad. e nole di Diego Lanza,
MiIano, UR 2002 (1987), . 163.
22 QueIIa inleIIelluaIislico-eslelica di IIIRRI SOMVILLI, |ssai sur |a Pcciiquc !Arisic-
ic ci sur quc|qucs aspccis !c sa pcsicriic, Iaris, Vrin 1975, . 92-96.
Oanic c |a ira!izicnc !c||a iragc!ia aniica nc||a Commedia 617
resenlano a un Danle-eIIegrino, ancora non ienamenle consaevo-
Ie dei meccanismi iu rofondi deIIa giuslizia divina riguardo ad una
delerminala coIa, ha Ie carallerisliche rorie di un eroe lragico neI
senso arisloleIico deIIa aroIa. NeIIa Pcciica I'eroe viene definilo come
coIui che, non dislinguendosi er virlu o er giuslizia, non e voIlo in
disgrazia er vizio o maIvagila, ma er un errore
23
(Pcci., 13, 1453a 8-
10). Quesla nanariia va inlesa sia in lermini elici, come Ia nq|ris, Ia lra-
sgressione cioe dei Iimili imosli aII'uomo daIIa divinila, oure neI
senso inleIIelluaIe, come errore di vaIulazione, mancanza di consae-
voIezza/conoscenza. Ma er Io Slagirila ogni rocesso moraIe e
riconducibiIe ad un modeIIo inleIIelluaIe, in quanlo deIIe due calego-
rie deIIe virlu (eliche e dianoeliche), queIIe iu aIle sono Ie virlu deIIa
ragione
24
. II carallere di un uomo viene abiluaImenle discusso in ler-
mini di cio che egIi sa. NeIIe due massime fondamenlaIi deII'oracoIo
deIfico uomo conosci le slesso (gn5ini scauicn) e non fare nienle
che ossa suerare Ia lua condizione umana (nc!cn agan) e imIicila
Ia fusione fra conoscere e agire rellamenle
25
. L'inleIIelluaIismo elico
resla, come e slalo coIlo daIIa crilica
26
, una coslanle di lulla quanla Ia
fiIosofia e Ia cuIlura greca. L'eroe di una lragedia greca (e queslo e
vero sorallullo in riferimenlo aIIe lragedie di SofocIe) non lanlo
commelle quanlo cade in una coIa, lullavia egIi rimane resonsabiIe
deII'effello deIIe sue azioni. I cos anche (semIificando un o') si uo
siegare iI fallo che Ia divinila non resla er Iui un unlo di riferimen-
lo osilivo, erche Ia nanariia e sesso iI frullo deII'accecamenlo
rovocalo dagIi dei e Ia cadula deII'eroe e aIIora conceila in lermini
di un delerminismo falaIislico che agisce sia daII'inlerno (erche
coincide con iI suo cincs, i vaIori in cui crede e che Io singono a deler-
minale azioni) sia daII'eslerno, indiendenle daIIa sua voIonla, Ia
quaIe deI reslo, in virlu deIIo slesso inleIIelluaIismo elico, e I'effello
deI saere o deIIa sua mancanza: I'allo comiulo a rorio iacimen-
lo e I'allo eseguilo rorio maIgrado si definiscono |.j in lermini di
conoscenza ed ignoranza |.j L'inlenzione coIevoIe, che delermina iI
deIillo, non aare come voIonla maIvagia, ma come iena conoscen-
za di causa
27
.
23 ARISTOTILI, Pcciica, cil., . 157-59.
24 Cfr. ivi, . 158 (nola).
25 Cfr. ALVIN GOULDNIR, || sisicna agcnisiicc grccc. nc!c||i cu|iura|i, in Ia iragc!ia
grcca. Gui!a sicrica c criiica, a cura di CharIes R. eye, Roma-ari, Lalerza 1976, . 184-
85.
26 Cfr. GIOVANNI RIALI, Ia sicria !c||a ji|cscjia aniica, voI. V, MiIano, Vila e Iensiero
1989 (1980), . 144-45.
27 }IAN-IIIRRI VIRNANT, A||czzi !c||a tc|cnia nc||a iragc!ia grcca, in }IAN-IIIRRI
VIRNANT, IIIRRI VIDAL-NAQUIT, Miic c iragc!ia nc||aniica Grccia, Torino, Iinaudi 1976,
Maria MasIanka-Soro 618
I grandi ersonaggi deII'|njcrnc ragionano non di rado in lermini
simiIi a quesli, a causa deIIa Ioro elica aganeggianle, er cui vedo-
no Dio come una forza nemica e sembrano ignorare iI senso deI Iibero
arbilrio, una fondamenlaIe scoerla deI mondo crisliano, che escIude
ogni delerminismo. Che Ia siluazione dei dannali vada visla rorio
in funzione deIIa dollrina deI Iibero arbilrio (a cui Danle-aulore dedi-
ca lanlo sazio nei canli cenlraIi non soIo deI Purgaicric XVI, XVII,
XVIII ma deII'inlera Ccnnc!ia), si dice esIicilamenle neII' |pisiu|a
XIII, 8, dove viene siegalo iI senso aIIegorico deI oema: Si vero
acciialur ous aIIegorice, subieclum esl homo roul merendo el
demerendo er arbilrii Iiberlalem iuslilie remiandi el uniendi
obnoxius esl
28
.
5. Iassando aII'iIIuslrazione di aIcuni araIIeIismi lra Ia oelica deI
lragico (sora deIineala) e queIIa deII'|njcrnc danlesco, mi soffermo a
liloIo di esemio sui ersonaggi di UIisse e UgoIino. Reslo lullavia
ben consaevoIe che iI lragico danlesco divenla veicoIo dei conlenuli
che Io lrascendono (e iI segno di queslo sueramenlo e Ia lensione lra
Danle-narralore e Danle-ersonaggio).
Ier UIisse mi concenlro suI senso IelleraIe, queIIo iu immedia-
lamenle ricavabiIe daI leslo, in quanlo anche se i due sensi diven-
lano inscindibiIi neIIa vaIulazione uIlima di queslo ersonaggio
iI lragico che lrasare daI senso aIIegorico si riferisce ad un aIlro
momenlo cuIluraIe, queIIo deII'elica averroisla e quindi resenla
sviIui diversi.
IgIi e I'unico (I'alro e Iicuro, ma non e un ersonaggio vero e
rorio) lra i grandi deII'anlichila cIassica a non avere Ia roria
dimora neI Limbo, deslinalo ai agani virluosi, bens neI basso In-
ferno vicino aI fondo, recisamenle neII'ollava boIgia deI enuIlimo,
ollavo cerchio, dove si lrovano i cosiddelli consigIieri fraudoIenli. I
una rova che i crileri con cui viene vaIulalo iI suo incs hanno subilo
una melamorfosi risello aII'originaIe omerico. Iure Ia conce-
zione di queslo ersonaggio resenla moIli Iegami con I'eoca a cui
aarleneva iI suo archelio eico e queIIa successiva, dominala
daIIa scena lragica che er quanlo riguarda moIli concelli e vaIori
lrovava Ia sua isirazione neIIa lradizione omerica. La risemanlizza-
zione oerala da Danle-aulore a IiveIIo IelleraIe ne fa (sorallullo se
. 43-44.
28 Se oi I'oera si rende aIIegoricamenle, iI soggello e I'uomo secondo che
merilando o demerilando er Ia Iiberla d'arbilrio e soggello aIIa giuslizia deI remio e
deI casligo, iI leslo originaIe e in lraduzione e lrallo daII'ed.: DANTI, Tuiic |c cpcrc, cil.,
. 344.
Oanic c |a ira!izicnc !c||a iragc!ia aniica nc||a Commedia 619
consideriamo I'inlenzione iscrilla neI leslo) un ersonaggio lragico
secondo i crileri vigenli neIIa cuIlura cIassica greca (neII'eica e lrage-
dia).
L'innovazione fondamenlaIe riguarda iI racconlo deII'uIlimo
viaggio di UIisse lerminalo con iI naufragio. NeI oema omerico Ia
queslione deIIa fine deII'eroe rimane aerla, daI momenlo che
I'O!issca accenna aIIa sua morle venula daI mare (O!. XI, 134). Cio
ha aerlo Ia slrada, gia neII'anlichila, a varie versioni ioleliche che
olevano essere nole a Danle allraverso sorallullo due aulori: Servio
in quanlo commenlalore deII'|nci!c
29
e Seneca moraIe, aulore deIIe
Iciicrc a Iuci|ic (|p. LXXXVIII, 6-7). L'idea deI naufragio uo risaIire
anche, come ersuasivamenle ha dimoslralo GugIieImo Gorni
30
,
aIIa sloria di UIisse e CaIyso racconlala neI secondo Iibro deII'Ars
anaicria (123-42), dove Ia ninfa, er lrallenere a se iI vecchio reduce
deII'imresa Troiana, gIi rofelizza un naufragio, in un conleslo un
o' gaIanle e scherzoso.
Nei oemi omerici UIisse e, sia neII'||ia!c che neII'O!issca, un eroe
osilivo: abiIe oralore e vaIoroso guerriero, versaliIe ed aslulo,
fallo er vincere semre e daerlullo grazie aIIe numerose quaIila
deI suo cincs, come un'accorla e rudenle ragione, un eccezionaIe
sirilo di adallamenlo, ingegnosila, ecc. In breve, e un magnanimo
(ncga|cpsqcncs) neI senso arisloleIico deIIa aroIa
31
, che asira a grandi
cose e Ie merila. I rorio Ia sua magnanimila sara fonle deIIa sua
lragicila in Danle, come essa Io e er moIli eroi di SofocIe, ma rima
di Ioro er iI grande AchiIIe omerico, iI rimo ersonaggio lragico in
assoIulo deIIa Ielleralura greca.
NeI eriodo romano Ia sleIIa di UIisse inizia a decIinare, Ie sue doli
machiaveIIiche, ingegnosila faIIace e doIosa, iacciono meno e cio si
siega con una diversa menlaIila dei Romani e con Ie ovvie lendenze
fiIolroiane, confIuile sorallullo neII'|nci!c (e conlinuale in Ovidio,
Lucano, Slazio, er dire soIo dei maggiori oeli) dove, come ha un-
luaImenle riIevalo Giorgio Iadoan, egIi viene chiamalo !urus, sactus,
pc||ax (II, 90), !irus (II, 261), scc|crun intcnicr (II, 164), jan!i jicicr (IX,
602)
32
. Irorio iI oema virgiIiano (iI secondo Iibro) e Ia fonle danlesca
29 Cfr. Scrtii Grannaiici, qui jcruniur in Vcrgi|ii carnina ccnncniarii, a cura di Georg
ThiIo e Hermann Hagen, Lisiae, Teubner 1881-84, voI. I, . 222-23, voI. II, . 24.
30 Cfr. GUGLIILMO GORNI, Iciicra, ncnc, nuncrc (|cr!inc !c||c ccsc in Oanic), oIo-
gna, II MuIino 1990, . 189 sgg.
31 Cfr. ARISTOTILI, |in. Nic., IV, 3, 1123b 1-2.
32 Ier iI vaIore umano e moraIe di UIisse neIIa lradizione Ielleraria Ialina cfr.
GIORGIO IADOAN, U|issc jan!i jicicr c |c tic !c||a sapicnza, in IDIM, || pic |nca, |cnpic
U|issc, Ravenna, Longo 1977, . 170 sgg., dove si nola anche (. 179, nola 22) che a
roosilo deIIa fraudoIenza di UIisse quasi lulli i commenlalori lrecenleschi deIIa
Maria MasIanka-Soro 620
iu imorlanle er due dei lre misfalli fraudoIenli er cui egIi subisce
Ia ena deI foco furo (|nj. XXVII, 127), rinchiuso in una Iingua di
fuoco biforcula in quanlo nascondenle anche Diomede, comIice di
moIli dei suoi deIilli:
|.j La denlro si marlira
UIisse e Domede, e cos insieme
a Ia vendella vanno come a I'ira,
e denlro da Ia Ior fiamma si geme
I'aggualo deI cavaI che fe Ia orla
onde usc de' Romani iI genliI seme.
Iiangevisi enlro I'arle er che, morla,
Dedama ancor si duoI d'AchiIIe,
e deI IaIIadio ena vi si orla.
(|nj. XXVI, 55-63)
Si lralla deI rallo deI IaIIadio, slalua di Alena che roleggeva
Troia (ricordalo da Sanl'Agoslino in Oc cit. Oci I, 2, come esemio di
sacriIegio) e deII'inganno deI cavaIIo di Iegno (59) che ha comromes-
so Ie sorli deIIa cilla. Un aIlro misfallo, meno nolo, e queIIo allinlo
robabiImenle daII'Acni||ci!c di Slazio (II, 153 sgg.), che consisleva neI
convincere con I'asluzia AchiIIe di Iasciare I'isoIa di Sciro e Deidamia
di Iui innamorala, er andare a Troia, assicurando cos ai Greci Ia vil-
loria, ma a se slesso una morle cerla.
I da nolare che iI eso deII'inganno eIencalo er rimo viene alle-
nualo daI commenlo di VirgiIio suI suo ruoIo sloricamenle osilivo
che si iscrive in iu in quanlo delerminanle er Ia fondazione di
Roma nei iani deIIa Irovvidenza
33
. Queslo fallo, vislo daIIa ro-
selliva eslranea aII'eoca di Danle, ma vicina a queIIa a cui rimanda
iI conleslo immedialo deII'eisodio di UIisse, ricorda una concezione
deIIa coIa moIlo anlica, resenle in aIcune lragedie greche suerslili,
e sorallullo neII'Agancnncnc di IschiIo, conformemenle aIIa quaIe un
allo di dismisura verso gIi dei o gIi uomini, quaI e Ia nq|ris, uo
divenlare slrumenlo deIIa voIonla divina che se ne serve er i rori
fini, ma cio non fa allenuare Ia sua coIevoIezza. In quesli lermini
viene resenlala, neIIa arodo deIIa lragedia cilala sora, I'imresa di
Agamennone e MeneIao, nonche iI sacrificio di Ifigenia, condizione
necessaria aI roseguimenlo deII'armala greca verso Troia. Ma aI
lemo slesso I'uccisione deIIa roria figIia e Ia dislruzione deIIa cilla
Ccnnc!ia cilano VirgiIio, Ovidio e Slazio, e che Ia maggior arle degIi aggellivi
concernenli UIisse nei oemi Ialini e di lono sregialivo.
33 Cfr. anche |nj. II, 13 sgg.
Oanic c |a ira!izicnc !c||a iragc!ia aniica nc||a Commedia 621
vengono considerale daI coro (neIIa arodo e neI rimo slasimo) come
alli maIvagi ed emi che richiedono Ia unizione di Agamennone da
arle deIIo slesso Zeus, iI quaIe rima, servendosi deII'esercilo greco
ha voIulo unire Ia coIa di Iaride: Di Zeus e iI coIo, ossono ben
riconoscere queslo i Troiani, e faciIe seguirne Ia lraccia. Ibbero essi Ia
sorle che iI dio slabiI
34
.
In quesla ollica, roria deIIa grande lragedia greca, che crea len-
sioni senza uno sbocco osilivo, rienlrerebbe non soIo I'aggualo deI
cavaIIo, ma lulli e lre i misfalli di UIisse, erche ognuno ha conlribui-
lo aIIa sconfilla lroiana e quindi aIIe sue conseguenze sloriche. Ma
cio che fu un aradosso lragico in queIIa reaIla, non e iu laIe se silua-
lo in un conleslo cuIluraIe in cui esisle una nella searazione lra una
coIa che si commelle e queIIa in cui si cade, dove viene escIuso a
pricri iI confIillo di inleressi lra Ia voIonla umana guidala daI Iibero
arbilrio e queIIa divina, non iu inlesa come una necessila imosla
daII'eslerno. Cio che neIIa reaIla escaloIogica deII'|njcrnc rende lragica
Ia condizione di UIisse non e cerlo Ia sua allivila fraudoIenla, dala
er sconlala come condannabiIe senza mezzi lermini. I che are anzi
I'unica er cui egIi deve subire iI marlirio deIIa fiamma. VirgiIio,
infalli, Iascia chiaramenle inlendere che UIisse era gia erdulo rima
deI naufragio
35
. Ma con Danle Ie cose non sono mai semIici e cos e
anche neI caso di queslo conlraasso, ricco di significali, nonche in
queIIo deIIa erdizione di UIisse che sembra avere dei Iegami direlli
con cio che viene narralo daI ersonaggio slesso. Infalli Ia Iingua di
fuoco aIIude anche ad un'aIlra coIa, racconlala da UIisse e in modo
laIe da aarire lragica secondo i crileri cIassici. Issa e si lralla deI
suo ardore deIIa conoscenza resenla dei unli di conlallo con iI
rimo alleggiamenlo coIevoIe (Ia fraudoIenza), che avrebbe una fun-
zione slrumenlaIe risello ad essa, se ammelliamo che I'esorlazione
rivoIla da UIisse ai suoi comagni sia aI lemo slesso iI suo uIlimo
consigIio fraudoIenlo. In queslo caso iI naufragio uo essere vislo co-
me una vera e roria unizione, una sanzione infIilla com'aIlrui
34 ISCHILO, Ag., 367-69 in IDIM, Orcsica, lrad. di Manara VaIgimigIi, inlrod. di
Vincenzo Di enedello, MiIano, UR 1989 (1980), . 93.
35 SuI senso moraIe deI lermine erdulo neI v. 84, riferilo aIIa morle siriluaIe,
cfr., lra gIi aIlri, }OHN IRICCIRO, Oanic. Ia pcciica !c||a ccntcrsicnc (lil. orig.: Tnc Pcciics cj
Ccntcrsicn, Cambridge 1986), oIogna, II MuIino 1989, . 208, DANTI ALIGHIIRi,
Ccnnc!ia, con iI commenlo di Anna Maria Chiavacci Leonardi, oIogna, ZanicheIIi
2001, comm. aII'|nj. XXVI, 84, . 456. Invece Iio Ra|na Io coIIega aIIa sorle dei cavaIieri
dei romanzi deI cicIo brelone, erdulisi senza lraccia duranle Ie Ioro qucics: cfr. IIO
RA}NA, Oanic c i rcnanzi !c||a Tatc|a |cicn!a, Nuova AnloIogia, voI. LV (1920), n.
1157, . 224, cfr. anche DANTI ALIGHIIRI, Ia Oitina Ccnnc!ia, a cura di NalaIino
Saegno, voI. I (|njcrnc), Iirenze, La Nuova IlaIia 1984, comm. aII'|nj. XXVI, 84, . 291.
Maria MasIanka-Soro 622
iacque (141). DaI racconlo olrebbe infalli risuIlare che in lulli gIi
anni che sono lrascorsi lra gIi evenli di Troia e iI naufragio, I'eroe non
ha erso iI suo vizio di ingannare gIi aIlri er lrarne un rofillo e ne
sarebbe rova Ia sua orazion iccioIa falla a regoIa d'arle, secondo
crileri relorici che lrovano in essa Ia Ioro rigorosa aIicazione:
aII'iniziaIe calalio benevoIenliae, dove si ricordano ericoIi su-
erali insieme, segue un incilamenlo aII'imresa che lrova Ia sua
unla iu aIla neIIa famosa lerzina finaIe: Considerale Ia voslra
semenza: / falli non fosle a viver come bruli, / ma er seguir virlule e
canoscenza (|nj. XXVI, 118-20). Non si smelle di disculere suI vaIore
fraudoIenlo o meno di quesla orazion iccioIa, a cui si rilornera iu
avanli, ambigua come Io e ure Ia slessa arle di ersuadere. Se si
ammelle che si lralli di un discorso faIIace (e lanlo iu se si ammelle
iI conlrario), e che I'eroe sia ben consaevoIe deII'eslrema difficoIla
deII'imresa, cio lullavia non imedisce di cogIiere neIIa sua narra-
zione aIcuni eIemenli che ne fanno un ersonaggio lragico secondo i
crileri riconosciuli daIIa lradizione cIassica.
6. NeI cilalo discorso di VirgiIio (55-63) UIisse viene resenlalo
in una Iuce negaliva, suIIa scia deI modeIIo cuIluraIe Ialino, dove I'uso
deIIa ragione er fini disonesli e condannabiIe. NeI suo discorso
UIisse riesce a far lrionfare Io sirilo greco, e iu recisamenle aI-
cuni suoi modeIIi elico-esislenziaIi. II racconlo inizia da I, dove I'ha
Iascialo inlerrollo neI XIV Iibro deIIe Mciancrjcsi Macareo, un er-
sonaggio invenlalo da Ovidio, comagno di UIisse, uno che aveva
rifiulalo di seguirIo neIIe uIleriori avvenlure marine. Queslo inizio Ia
arlenza daII'isoIa di Circe segna un momenlo osilivo, iI riacquislo
deI dominio deIIa ragione suIIe assioni (ncia |cnc iI conlrario di queI-
Io che succede a Irancesca da Rimini, Ia quaIe sommelle Ia ragion aI
laIenlo), I'inleresse rivoIlo verso Ia reaIla sueriore, I'abbandono dei
vaIori deIIa carne er queIIi deIIo sirilo. II conlroIIo sui rori imuI-
si e I'agire basalo suIIa ragione, se non rorio suI caIcoIo razionaIe,
crea un lio di ersonaIila cuIluraImenle iu ammirala dai Greci. Cio
e esresso osserva AIvin GouIdner ad esemio, neII'immagine
odisseica che IericIe da degIi aleniesi |in Tucididej, come asluli slra-
leghi che non si lrovano mai in imbarazzo di fronle aIIe difficoIla deIIa
vila
36
. II robIema se I'inganno e Ia menzogna siano accellabiIi come
slralegia er conseguire i rori fini e resenle neIIa sociela aleniese e
in genere resso i Greci, cosicche da queI Ialo UIisse danlesco sarebbe
da vaIulare come innocenle. Invece iI modo in cui rosegue iI suo rac-
conlo Iascia inlendere iu di una siluazione di confIillo crealo daIIa
36 GOULDNIR, o. cil., . 203.
Oanic c |a ira!izicnc !c||a iragc!ia aniica nc||a Commedia 623
sua ferma voIonla di divenir deI mondo eserlo / e de Ii vizi umani e
deI vaIore (98-99). Dai versi 94-96 aare chiaro che iI suo ardore deI-
Ia conoscenza si oone aI mondo degIi affelli famiIiari
37
e ne esce
vincenle suI iano di una necessila che corrisonde aI suo rofondo
essere, vincoIandoIo daII'inlerno. I un confIillo lragico fra Ie virlu
conoscilive e queIIe moraIi suI iano domeslico. UIisse si riaIIaccia a
un delerminalo modeIIo di comorlamenlo: in iu di una lragedia
greca si osserva Ia siluazione in cui I'eroe o I'eroina sono ronli a sa-
crificare i Iegami affellivi iu cari e erfino Ia vila er i vaIori che
aagano iI Ioro desiderio di auloreaIizzazione e di conseguenza iI
conseguimenlo deIIa gIoria osluma un surrogalo deII'immorlaIila.
TaIe sarebbe Anligone er Ia quaIe I'amore er IoIinice divenla in
reaIla veicoIo di aIlri vaIori, lra cui anche queIIo deIIa gIoria (k|ccs)
38
,
essa sacrifica invece senza esilazione I'amore di Imone, er Aiace
I'onore e iu caro degIi affelli famiIiari. Ier quanlo riguarda, invece, iI
vaIore che er i Greci ha iI raggiungimenlo deIIa conoscenza, non
c'e migIior esemio di queIIo di Idio che con lulli i mezzi e senza
lener conlo deI rezzo che dovra agare, lende a scorire I'inlera veri-
la su se slesso. Danle ur non conoscendo quesle lragedie ne ha
lullavia in quaIche modo coIlo iI senso er esemio I'arovazione
er chi sacrifica lullo aIIa conoscenza deI vero allraverso gIi scrilli di
Cicerone
39
, grande romolore e ammiralore deIIa fiIosofia greca, iI cui
ensiero e resenle in vari assi deI Ccntitic e deIIe |pisic|c
40
.
Si uo quindi nolare che I'UIisse danlesco si iscrive in una Iunga
lradizione, risaIenle ad Omero, che non fa una nella dislinzione lra Ia
sfera elica e queIIa inleIIelluaIe
41
ed in cui Ia lrasgressione da arle
deII'uomo dei Iimili conoscilivi equivaIe aIIa dislruzione deII'ordine
slabiIilo dagIi dei. A quesla nq|ris (lracolanza, dismisura) segue Ia
ena, moIli mili iIIuslrano laIe siluazione e er lulli basla ricordare
queIIo di Aracne o deI saliro Marsia, i quaIi significalivamenle vengo-
no cilali da Danle lra gIi esemi deIIa suerbia unila (Purg. XII, 43-
37 Cfr. |nj. XXVI, 94-99: ne doIcezza di figIio, ne Ia iela / deI vecchio adre, ne 'I
debilo amore / Io quaI dovea IeneIoe far Iiela, / vincer olero denlro a me I'ardore /
ch' i' ebbi a divenir deI mondo eserlo / e de Ii vizi umani e deI vaIore. L'abbandono
deIIe ersone care fa aumenlare Ia coIevoIezza di UIisse agIi occhi dei commenlalori
anlichi deIIa Ccnnc!ia: qui si nola Io sconlro lra Ia cuIlura greca er cui gIi affelli
vengono sollomessi aIIe virlu rilenule sueriori, e queIIa crisliana in cui I'amore inleso
come cariias e Ia virlu maggiore lra lulle.
38 Cfr. SOIOCLI, Ani., 37-38, 96-97, 502 sgg.
39 Cfr. CICIRONI, Oc jini|us |cncrun ci na|crun V, XVIII, 48-49, Oc cjjiciis III, XXVI,
97.
40 Cfr. er es. Ct. I, I, 4 e |p. XII, 4.
41 Cfr. GOULDNIR, o. cil., . 184.
Maria MasIanka-Soro 624
45, Par. I, 19-21). La navigazione di UIisse oIlre Ie coIonne di IrcoIe
sarebbe in lermini greci rorio una laIe nq|ris, anche se essa, neI
racconlo danlesco e fiIlrala da un'ollica crisliana ed assume iI senso
melafisico.
L'orazion iccioIa in cui iI molivo chiave e queIIo deIIa virlu e
canoscenza (|nj. XXVI, 120), convince quindi queIIi che sono gia con-
vinli, in quanlo locca Ia corda sensibiIissima er Ia vaIulazione
deII'essere umano secondo i crileri greci, si uo nolare che i due ler-
mini si risoIvono in una ncn!ia!qs, er cui si olrebbe arIare deIIa
conoscenza come virlu in ragione deII'inleIIelluaIismo elico di cui si e
accennalo sora. A quesla esressione verrebbe quindi resliluilo iI
conleslo originaIe greco, indiendenlemenle daII'inlenzione di Danle-
aulore e cioe daI fallo che essa suI iano slorico si riferisce
aII'alleggiamenlo dei raresenlanli deII'arisloleIismo radicaIe, nuovi
sapicnics nun!i, come Ii chiama oezio di Dazia. QuaIche asso deIIa
Quacsiic 5 dei suoi Mc!i signijican!i resenla risondenze quanlo aI
conlenulo e aIIa forma con iI verso danlesco
42
.
II lraassar deI segno (Par. XXVI, 115-17) di UIisse aarliene
anche ad un secondo confIillo, queIIo lra una forza oscura e iI deside-
rio di reaIizzare Ia roria umanila allraverso una eserienza
conosciliva eccezionaIe. Gia neII'anlichila recIassica, in Iindaro, si
Iegge un avverlimenlo imIicilo conlro queII'allo di dismisura: Ii
oIlre / neI mare imervio non si va deI lermine / dov' IracIe segno i
suoi riguardi (Ncn. III, 20-22)
43
. Chiamando queII'allo foIIe voIo
egIi sembra ora consaevoIe deIIa roria lracolanza, I'alleggiamenlo
a cui i Greci saevano orre un freno con I'ubbidienza aIIa s5pnrcsqnc
moderazione assieme moraIe ed inleIIelluaIe. NeIIa lragedia greca
non mancano gIi esemi deIIa foIIia inlesa in quesli lermini, su cui
oggia iI vaIore lragico di queslo o queI ersonaggio: foIIe viene
chiamalo Agamennone eschiIeo neII'allo di sacrificare Ia figIia
44
, ma-
Ialo di menle Iromeleo, quando oone Ia roria voIonla a queIIa
di Zeus
45
, Ia foIIia neI caso di Aiace neII'omonima lragedia di SofocIe e
mandala da Alena in risosla aI foIIe roosilo deI Greco di uccidere
Odisseo e Agamennone, foIIe viene rilenula anche Anligone er esser-
si oosla a Creonle
46
, e moIli aIlri esemi sarebbero da cercare
sorallullo neIIe lragedie di SofocIe e di Iuriide.
42 Cfr. CORTI, Scriiii su Cata|canii c Oanic, cil., . 279.
43 | |irici ccra|i grcci, lrad. di IiIio Maria Ionlani, Torino, Iinaudi 1993
2
(1976), .
233-34.
44 Cfr. ISCHILO, Ag., 221-23.
45 Cfr. ISCHILO, Prcn., 472, 977.
46 Cfr. SOIOCLI, Ani., 99, 562.
Oanic c |a ira!izicnc !c||a iragc!ia aniica nc||a Commedia 625
La calaslrofe che segue si resenla quindi come I'effello di una ne-
cessila falaIe che oera daII'inlerno e che si uo idenlificare con I'cincs
deI rolagonisla (e dei suoi comagni che sono iI suo rifIesso)
47
. Irima
deIIa fine funesla sorge in Ioro Ia seranza iIIusoria di oler arrivare
aIIa conoscenza lanlo desiderala, daI momenlo che comare aII'oriz-
zonle Ia monlagna bruna che a IiveIIo aIIegorico corrisonde, come
e risaulo, aIIa monlagna deI Iaradiso Terreslre e quindi aI simboIo
deIIa verila lrascendenle, imossibiIe da raggiungere con iI soIo slru-
menlo deIIa ragione. TaIe andamenlo deII'azione in cui Ia svoIla finaIe
(pcripcicia, er usare iI lermine arisloleIico che qui si addice) e rece-
dula da un momenlo in cui affiora Ia seranza in una Iiela fine, e
liico deIIe lragedie di SofocIe, dove laIe ironia deIIa sorle fa crescere
Ia lensione drammalica. Se si deve ammellere (come vuoIe una arle
deIIa crilica) che iI discorso di UIisse rivoIlo ai comagni sia un in-
ganno (I'uIlimo deIIa serie dei consigIi fraudoIenli), in queI caso egIi
sarebbe un !cccpicr !cccpius e avremmo qui una Iogica oeranle neIIa
lragedia greca.
InoIlre, se si ammelle che I'ardore deIIa conoscenza sia una ne-
cessila che oera daII'inlerno singendo I'eroe verso Ia calaslrofe, Ia
coIa si resenla come un errore di vaIulazione e, di conseguenza,
corrisonde aIIa nanariia dei Greci. Infine, iI naufragio aare neI di-
scorso di UIisse come una falaIila eslerna, segno di un voIer divino
(come aIlrui iacque: 141) che rislabiIisce un ordine infranlo daIIa
lroa audacia umana.
7. Ier I'eroe di una lragedia vorrebbe assare anche UgoIino deIIa
Gherardesca neI canlo XXXIII deII'|njcrnc, ma queslo suo lenlalivo si
sconlra con iI rifiulo da arle di Danle-eIIegrino che non e in grado
di rovare er Iui nessuna iela. L'eisodio di cui egIi e rolagonisla
assoIulo resenla, iu di ogni aIlro neII'|njcrnc, affinila semanliche
e slrulluraIi con Ia lragedia greca. II suo racconlo forlemenle dramma-
lizzalo, iI iu Iungo deIIa rima canlica, divenla una vera e roria
messa in scena che lrae in arle Ia sua slraordinaria forza esressiva
dai mezzi non verbaIi di comunicazione.
Ier farsi credere Ia villima innocenle deII'arcivescovo Ruggieri e,
in un conleslo iu amio, deIIa giuslizia divina, egIi invenla una
ja|u|a
48
facendosi aI lemo slesso garanle deIIa sua aulenlicila (imos-
sibiIe da verificare), in quanlo leslimone ocuIare dei falli accaduli
neIIa Torre dei GuaIandi (Ia Muda) che, come neI caso di un nqincs
(inleso neI senso arisloleIico), gIi servono er coslruire Ia roria lra-
47 Cfr. CHIAVACCI LIONARDI, Ia gucrra !c |a piciaic, NaoIi, Liguori 1979, . 161.
48 Cfr. MARCHISI, o. cil., . 84 sgg.
Maria MasIanka-Soro 626
gedia
49
. La ja|u|a inizia, come neIIe migIiori oere di SofocIe (Aiacc,
Aniigcnc, |!ipc), in nc!iis rc|us
50
, in mezzo ai falli che conducono
inevilabiImenle aIIa calaslrofe morle er fame, dalo I'inchiodare
deII'enlrala deIIa orribiIe lorre cui c'e un cenno neIIa lerzina cenlra-
Ie: e io senl chiavar I'uscio di sollo a I'orribiIe lorre (46-47). TaIe
inizio inlroduce fin dai rimi versi una lensione drammalica: UgoIino
e da arecchi giorni rinchiuso neIIa lorre con i figIi e i nioli (iu Iu-
ne gia: 26) e sla er avere un sogno, simboIico e remonilore (che
deI fuluro mi squarcio 'I veIame: 27) in cui Ruggieri con Ie olenli
famigIie isane (GuaIandi, Sismondi, Lanfranchi) da Ia caccia a Iui e ai
figIi, immaginali come un Iuo con i Iuicini (anche queslo e un dalo
significalivo besliaIe) e ad un cerlo unlo Ie cagne degIi inseguilori,
magre, sludose e conle (31), squarciano i fianchi agIi animaIi slre-
mali. II sogno e un eIemenlo slrulluraIe non infrequenle neIIa lragedia
greca. In queslo caso credo che sia non iIIegillimo dala una simiIe
funzione fare un accoslamenlo con iI sogno di CIilemeslra neIIe Ccc-
jcrc di IschiIo (526 sgg.) in cui essa si vede arlorire un serenle che,
subilo doo, assieme aI Ialle Ie succhia anche iI sangue. Anche qui iI
senso e chiaro: iI serenle simboIeggia Oresle che Ia uccidera. Ma
I'accoslamenlo e forse giuslificalo anche er quaIche aIlro molivo: in
enlrambi i casi iI soggello che sogna e un lradilore lradilo
51
, inoIlre,
simiIe in enlrambi sembra anche iI meccanismo di soslamenli lem-
oraIi lramile I'ana|cssi e Ia prc|cssi: iI ricordo di cio che e gia avvenulo
(neI caso di UgoIino, deIIa ersecuzione subila duranle Ia vila) accanlo
aI resenlimenlo deI lragico eiIogo, soIo che neI caso deI conle lulla
quesla roiezione viene falla daIIa roselliva escaloIogica e quindi si
uo arIare deI fuluro neI assalo. II sogno sia I'uno che I'aIlro
acquisla iI vaIore di un segno che refigura Ia morle, in iu, neI caso
deI soIo UgoIino, refigura ure Ia forma deIIa dannazione
52
(Ia ridu-
zione in uno slalo besliaIe). NeII'eisodio danlesco anche i fanciuIIi
hanno ciascuno un sogno, Ia menzione di queslo fallo fa a UgoIino
nolare er Ia rima voIla neI corso deI racconlo Ia Ioro resenza
neIIa lorre (ianger senli' fra 'I sonno i miei figIiuoIi / ch'eran con
meco: 38). Iiu avanli riveIa che ognuno di Ioro aveva aura a causa
deI rorio sogno (45).
49 Anche se egIi Ii resenla come veri, iI Iellore uo rilenerIi faIsi soIo in base aI
oslo (bassissimo) da Iui occualo neIIa scaIa moraIe deII'|njcrnc danlesco (incIinazione
aIIa frode aI massimo grado), cos non ci si aIIonlana di moIlo daI rinciio arisloleIico
di verosimigIianza e necessila: cfr. ARISTOTILI, Pcci., 9, 1451b 1-3.
50 Cfr. ARISTOTILI, Pcci., 23, 1459a 15 sgg.
51 II lermine a roosilo di UgoIino viene adoeralo da IMILIO IASQUINI
neII'arlicoIo || canic XXX||| !c|||njcrnc, Lellure cIassensi, voI. IX/X (1982), . 203.
52 Cfr. IRICCIRO, o. cil., . 220.
Oanic c |a ira!izicnc !c||a iragc!ia aniica nc||a Commedia 627
Iroseguendo con aIlre carallerisliche lragiche noliamo che I'a-
zione deIIa ja|u|a, che e Iineare, si svoIge inleramenle neIIa Muda (uni-
la di Iuogo), iI fiIo narralivo e uno soIo e anche cio e conforme aI
modeIIo arisloleIico
53
. L'iIIusione scenica viene, ero, er lre voIle
inlerrolla (ma cio are mellerIa anzi in risaIlo) daIIe escIamazioni deI
conle (40-42, 66, 70). TaIe forma esressiva ha una recisa funzione
relorica neIIa lragedia vera e roria, affidala di soIilo agIi evenli sles-
si: si lralla di suscilare Ia iela, senlimenlo chiave con cui Io sellalore
risonde aIIe sofferenze deI rolagonisla
54
. Qua, invece, iI eIIegrino
viene soIIecilalo a manifeslare Ia iela dala Ia sua imassibiIila di
fronle a cio che ode e uo immaginare grazie aIIa eccezionaIe Iaslici-
la deI racconlo. La rima deIIe delle escIamazioni e una aoslrofe
dirella a Iui (en se' crudeI, se lu gia non li duoIi / ensando cio che
'I mio cor s'annunziava, / e se non iangi, di che ianger suoIi`), Ia
seconda e soIo un rimrovero rivoIlo aIIa lerra (ahi dura lerra, erche
non l'arisli`). Cos i rolagonisli sofocIei (ad esemio Anligone,
Idio, Aiace, IiIollele), senlendosi incomresi e abbandonali, invoca-
no sesso Ia nalura circoslanle. II lerzo lenlalivo di enlrare in conlallo
emolivo con iI eIIegrino (e come lu mi vedi), faIIilo anch'esso, si
sciogIie in un aragone. La mancanza di quaIsiasi reazione da arle
deI eIIegrino duranle iI drammalico racconlo aare se si vuoIe
assumere iI unlo di visla deI rolagonisla in conlraslo con Ia soffe-
renza e iI doIore di cui esso si fa carico. Infalli, se ancora una voIla ci
riferiamo aIIe agine deIIa Pcciica di ArisloleIe, ossiamo conslalare
che qui si lralla deIIa lragedia da Iui definila come alelica (painciikc)
55
in cui iI paincs (inleso come sofferenza o avvenimenlo che Ia orla),
ribadilo iu voIle con i lermini che indicano iI doIore, e I'unico imor-
lanle eIemenlo deIIa nincsis lragica, menlre manca iI riconoscimenlo
(anagn5risis) e una svoIla imrovvisa deIIazione (pcripcicia). Se non si
uo arIare deIIa seconda nei lermini in cui essa avviene neIIe lrage-
die, daI momenlo che Ia Ioro sorle e gia decisa, non e ero deI lullo
escIuso un cerlo riconoscimenlo che rafforza iI resenlimenlo lerribiIe
avulo rima neI sogno, lullavia ci sarebbe anche una cerla svoIla:
quando UgoIino senle iI rumore deIIa orla che viene serrala, guarda
in siIenzio i bambini e iI suo cuore si indurisce: ond' io guardai / neI
viso a' mie' figIiuoi sanza far mollo. / Io non ianga, s denlro ime-
lrai (47-49). Diversamenle da come avviene neIIa lragedia greca,
dove iI riconoscimenlo segna Ia unla massima deIIa sofferenza e fa
53 Cfr. Pcci., 8, 1451a 30-32, 10, 1452a 15-18.
54 Secondo ArisloleIe, come e nolo, Ia causa finaIe deIIa lragedia: cfr. Pcci., 6, 1449b
27.
55 Cfr. Pcci., 18, 1455b 35.
Maria MasIanka-Soro 628
nascere iI bisogno da arle deI rolagonisla di condividere iI rorio
doIore con chi gIi sla vicino, qui esso da invece inizio a una chiusura
nei confronli dei figIi che divenlera comIela.
Un aIlro lrallo che avvicina iI dramma di UgoIino aI genere lragico
e un Iinguaggio aIlo con unle addirillura subIimi, sorallullo nei
riecheggiamenli dei rolagonisli deII'|nci!c, iI oema a cui Danle
slesso da aIlrove iI nome di lragedia (|nj. XX, 113). Gia Ia rima frase
con cui iI conle risonde aII'invilo di Danle-eIIegrino di resenlarsi e
di riveIare Ia causa deI suo odio feroce verso I'avversario (Tu vuo'
ch'io rinoveIIi / diseralo doIor che 'I cor mi reme: 4-5) e, come
hanno nolalo i crilici, una arafrasi deIIe aroIe di Inea che quesli
rivoIge a Didone rima di racconlarIe gIi uIlimi lragici momenli di
Troia: Infandum, regina, iubes renovare doIorem (Acn. II, 3). La gia
cilala aoslrofe aIIa lerra (66), er dare un aIlro esemio, rirende, a
sua voIla, Ie aroIe di Giulurna che iange Ia morle deI fraleIIo Turno
ucciso da Inea
56
e ricorda anche queIIe di Tiesle, rolagonisla deI-
I'omonima lragedia di Seneca, doo che egIi viene a saere Ia verila
suIIa morle dei rori figIi
57
. Queslo lono eIevalo, ricco di riecheggia-
menli cIassici, e ben caIcoIalo er suscilare Ia iela, senlimenlo che
dovrebbe sancire iI significalo lragico deIIa siluazione.
8. Nonoslanle moIli aselli che avvicinano iI dramma narralo da
UgoIino ad un genere lragico, iI ersonaggio slesso e anlilragico.
Ier coslruire Ia roria immagine egIi si serve deIIa figura relorica
deIIa pracicriiic
58
, che consisle neII'omissione di un ensiero, in queslo
caso dei suoi lradimenli. Annunciando esressamenle I'inlenzione di
non arIare degIi evenli che condussero aI suo imrigionamenlo, con
iI releslo che Ia cosa sia ben conosciula (Che er I'effello de' suo'
mai ensieri, / fidandomi di Iui, io fossi reso / e oscia morlo, dir non
e meslieri: 16-18), egIi slravoIge imIicilamenle iI Ioro significalo mo-
slrandosi villima deIIe erfide macchinazioni di Ruggieri, chiamalo
esressamenle ira!iicr (8), come se queslo aeIIalivo non sellasse, e
a maggior liloIo, anche a Iui. AIIa sua coIa di oIilico senza scruoIi,
che diede inizio ad una calena di lradimenli, aIIude genericamenle
Danle-aulore neII'invelliva conlro Iisa che sla a chiusura di queslo
eisodio (79 sgg.), dove accusa i isani di aver condannalo a morle
56 Cfr. VIRGILIO, |nci!c XII, 883-84.
57 Cfr. SINICA, Tnq, 1006-1009. Ier quesla ed aIlre reminiscenze, cfr. |ncic|cpc!ia
!anicsca, s.v. UgoIino, a cura di Umberlo osco, voI. V, Roma, Islilulo deII'IncicIo-
edia IlaIiana 1976, . 799, anche IIITRO OITANI, || iragicc c i| su||inc nc||a |ciicraiura
nc!icta|c, oIogna, II MuIino 1992, . 68-69.
58 Cfr. HIINRICH LAUSIRG, ||cncnii !i rcicrica, oIogna, II MuIino 1969, . 228.
Oanic c |a ira!izicnc !c||a iragc!ia aniica nc||a Commedia 629
alroce i bambini innocenli. Le cronache deII'eoca ne avevano Iascialo
addirillura I'immagine di un lradilore muIliIo: rima dei ghibeIIini,
successivamenle anche dei gueIfi e con Ioro deI rorio niole (figIio
di una deIIe figIie) Nino Visconli e infine di AnseImo di Carrara, figIio
di sua soreIIa
59
. Irendendo in considerazione vari fallori si uo con-
slalare che egIi non risonde aIIa concezione deI ersonaggio lragico
secondo Ia definizione di ArisloleIe er cui quesli dovrebbe cadere in
rovina non a causa deIIa sua maIvagila, essendo elicamenle mediocre,
ma er aver commesso un errore (nanariia)
60
. D'aIlra arle Ia maIvagi-
la di UgoIino non Io comromelle soIo suI iano che si olrebbe
chiamare slorico (e che concerne queI che Iui lace), ma anche in quan-
lo rolagonisla deIIa roria ja|u|a.
NeII'eisodio danlesco egIi, voIendo iIIuslrare Ia erfidia di
Ruggieri e Ia sua elerna vendella, in effelli non sla facendo aIlro che
siegare Ia ragione deI Ioro ersonaIe conlraasso, resenlalosi da
subilo aI eIIegrino come besliaI segno, che sono coslrelli a subire
enlrambi oIlre aIIa ena deI ghiaccio in cui sono immersi, sconlala
assieme a lulli gIi aIlri lradilori. Lui slesso non sembra essere consa-
evoIe deI fallo che iI suo racconlo assume significali diversi da queIIi
che inlende dargIi. Avremmo qui a che fare con un aIlro esedienle
relorico non raro neIIa lragedia cIassica, queIIa sofocIea in modo arli-
coIare, e cioe con una ironia lragica, Ia quaIe ero viene qui adoerala
in funzione anlilragica facendoIo vedere come un essere moslruoso.
9. La oIemica anlilragica coinvoIge sorallullo iI suo conlraas-
so ersonaIe e iI concello di doIore (che, accanlo a queIIo di fame, e iI
molivo chiave di lullo I'eisodio). Cio che egIi riliene una sua vendel-
la ersonaIe e, dala Ia sua condizione di dannalo che non ha iu Ia
ossibiIila di agire Iiberamenle, una unizione infIilla sia a Ruggieri
che a Iui slesso. Issa e Iegala aIIa coIa e i crilici moderni, doo aver
reso in esame lulli gIi indizi Iinguislico-semanlico-slrulluraIi, sono
semre iu incIini a riconoscere neIIa lormenlala frase oscia, iu
che 'I doIor, ole 'I digiuno (75), I'uIlima ronunciala daI conle,
un'aIIusione voIulamenle ambigua aIIa sua lecnofagia
61
. Infalli, se Iui
e inlenzionalo soIamenle a dire che Ia morle er fame ose fine aI suo
doIore, erche non Io annuncia aerlamenle in modo da rendere iu
59 Cfr. OITANI, o. cil., . 48-49.
60 Cfr. Pcci., 13, 1453a 7-10.
61 Cfr., fra I'aIlro, I'argomenlazione di IRICCIRO, o. cil., . 222 sgg., OITANI, o.
cil., . 65 sgg., IZIO RAIMONDI, Ic jigurc inicrnc !i Ugc|inc, Lellure cIassensi, voI.
XXV (1996), . 94 sgg., lra i commenlalori anlichi, cfr. Ccnnc!ia !i Oanic !cg|i A||agncrii
cc| ccnncnic !i jaccpc !c||a Iana, a cura di Luciano ScarabeIIi, oIogna, Ti. Regia 1866,
. 501.
Maria MasIanka-Soro 630
esanle I'accusa deII'arcivescovo, che, oIlrellullo, e iI suo obiellivo
rimario` Ma Ie rove iu concrele si ricavano daI leslo e, rima di
lullo, daIIa cornice deI racconlo di UgoIino, dove negIi uIlimi versi
deI canlo XXXII e nei versi 76 sgg. deI XXXIII si fa cos suggeslivamen-
le dominanle iI molivo deI besliaI segno, Iegalo non soIo aII'odio,
ma anche aIIa fame, con Ia melamorfosi finaIe deI dannalo
I'immagine di un cane-Iuo che divora Ia carne umana, con cui iI nar-
ralore sembra chiarire iI senso oscuro deIIe uIlime aroIe deI conle
62
:
Quand'ebbe dello cio, con Ii occhi lorli
rirese 'I leschio misero co' denli,
che furo a I'osso, come d'un can, forli.
(|nj. XXXIII, 76-78)
A noslro avviso non e deI lullo adegualo inlerrelare Ia simiIiludi-
ne (|nj. XXXII, 130-32) che recede Ia domanda rivoIla aI dannalo, di
riveIare I'idenlila roria e deI nemico, nonche Ia ragione deI suo
odio, come queIIa che aggiunge una nola lragica aIIa scena
63
. L'im-
magine di Tideo che rode er odio Ia lesla di MeIanio e, naluraI-
menle, d'isirazione cIassica (lralla, com' e nolo, daIIa Tc|ai!c di
Slazio, VIII, 716 sgg.), ma queslo molivo non sarebbe olulo mai di-
venlare neIIa lradizione cIassica iI nucIeo di una siluazione lragica,
er esemio Tideo in IschiIo si resenla come ersonaggio decisa-
menle negalivo
64
. I invece vero che Ia simiIiludine in queslione,
essendo un riecheggiamenlo di un asso cIassico, reannuncia iI
lono eIevalo deII'eisodio che segue, iI lono ben caIcoIalo er suscilare
Ia iela, senlimenlo che dovrebbe sancire iI carallere lragico deIIa
siluazione.
Un aIlro argomenlo che dovrebbe indurre ad inlerrelare Ie aroIe
deI conle deI verso 75 neI senso dello sora e iI molivo ossessivo deIIa
fame, ben resenle in lullo I'eisodio, comreso queIIo deIIa bocca
(aII'inizio deI canlo XXXIII), che mangia e rode, ma anche che raccon-
la, cos che si ha imressione che Ia sloria si svoIge come aII'inlerno di
essa
65
.
10. II molivo deIIa fame e Iegalo a queIIo deI doIore di UgoIino.
62 Cfr. ure |nj. XXXII, 127-29: e come 'I an er fame si manduca, / cos 'I sovran
Ii denli a I'aIlro ose / Ia 've 'I cerveI s'aggiunge con Ia nuca.
63 Cfr. DANTI ALIGHIIRI, Ia Ccnnc!ia, a cura di ianca GaraveIIi, con Ia suer-
visione di Maria Corli, voI. I (|njcrnc), MiIano, omiani 1993, comm. aII'|nj. XXXII, 130-
32, . 471.
64 Cfr. ISCHILO, Scpicn, 380 sgg.
65 L'osservazione e di OITANI, o. cil., . 66.
Oanic c |a ira!izicnc !c||a iragc!ia aniica nc||a Commedia 631
II modo in cui viene resenlalo da Danle-aulore (inp|iciic) fa, credia-
mo, arle deIIa oIemica anlilragica. Occorre nolare che Ia lermi-
noIogia Iegala a queslo concello rimane in funzione deII'obiellivo
rinciaIe deII'inlero discorso, queIIo relorico-ersuasivo di dare di se
un'immagine osiliva. II rorio doIore, di cui egIi arIa nei versi 5
(diseralo doIor), 9 (arIare e Iagrimar vedrai insieme), 56 (doIo-
roso carcer), 58 (Ie man er Io doIor mi morsi) e infine neI gia cilalo
verso finaIe 75, viene da Iui conlraoslo aII'alleggiamenlo indifferen-
le deI eIIegrino neIIa lerzina 40-42 ronunciala suI lono lragico:
en se' crudeI, se lu gia non li duoIi
ensando cio che 'I mio cor s'annunziava,
e se non iangi di che ianger suoIi`
In reaIla, Ia esanle accusa qui formuIala viene neulraIizzala iu
avanli, semre neI conleslo deI doIore, da una imIicila auloaccusa
che Danle-aulore gIi fa rivoIgere a se slesso, senza che Iui ne sia con-
saevoIe:
Io non ianga, s denlro imelrai:
iangevan eIIi, e AnseImuccio mio
disse: Tu guardi s, adre che hai`.
Iercio non Iagrimai ne risuos'io
lullo queI giorno ne Ia nolle aresso,
infin che I'aIlro soI neI mondo usco.
(|nj. XXXIII, 49-54)
Queslo asso moslra Ia crisi nei suoi conlalli con i figIi (da scorgere
anche neI suo slrano modo di guardarIi) iI cui aice e neIIa inerle as-
senza di iela, quando uno dei figIi, slremalo, rima di morire gIi si
gella ai iedi cercando invano un conforlo affellivo con Ia domanda
Iadre mio, che non m'aiuli` (69).
Reslando indifferenle aI ianlo dei figIi e rifiulando di orlare Ioro
iI conforlo neI doIore, egIi ne sfrulla ero Ia sofferenza come releslo
er accusare iI eIIegrino deIIa mancanza di iela (40-42).
Conlrariamenle a cio che UgoIino afferma aI verso 9 (arIare e
Iagrimar vedrai insieme), egIi non iange mai, ne menlre racconla
ne come rolagonisla deI racconlo. Duranle gIi uIlimi giorni di vila
non rivoIge ai figIi neanche una aroIa, nonoslanle Ia Ioro diserala
ricerca deI conlallo emolivo con Iui. II siIenzio uo essere un segno
eIoquenle di grande sofferenza e, infalli, neIIa lragedia greca esso
assume sesso queslo significalo. Iamoso e iI siIenzio di Iromeleo
Maria MasIanka-Soro 632
neIIa omonima lragedia di IschiIo, ma e in SofocIe che esso divenla
un molivo quasi loico: neIIe lre lragedie su selle a noi giunle esso
recede iI momenlo in cui Ia rolagonisla si logIie Ia vila
66
. Ma neI
caso di UgoIino I'idenlificazione lra siIenzio e doIore e robIemalica, i
suoi alleggiamenli inquielanli, come gIi sguardi che fanno aura, gel-
lali sui figIi (51), che in un cerlo momenlo recedono iI geslo di
mordersi Ie mani (56 sgg.), inlerrelalo dai bambini come segno di
fame, fanno soslare iI doIore verso Ia ra|ics !c|cris, come aveva gia
nolalo envenulo da ImoIa
67
. Quesli mezzi non verbaIi di comunica-
zione Io avvicinano aIIa beslia in cui si sla ian iano lrasformando:
emelle Ie grida soIo doo Ia Ioro morle brancoIando sui cori senza
vila: ond'io mi diedi, / gia cieco, a brancoIar sovra ciascuno, / e due
d Ii chiamai, oi che fur morli (72-74). AIIa base di quesla melamor-
fosi c'e iI suo moslruoso egoismo di cui si ha Ia rova gia nei assi
inlrodullivi aI discorso, dove egIi arIa deIIa sua ncric, di Ruggieri che
I'ha offeso (20-21). AII'inizio deI racconlo i figIi sono assenli dai suoi
ensieri, Ia Ioro menzione, come si e gia vislo, viene falla lardi e con Io
scoo di far scallare Ia iela di Danle-eIIegrino.
A misura in cui UgoIino divenla umanamenle semre iu irra-
giungibiIe er i figIi, iI Ioro comorlamenlo subisce un'evoIuzione neI
senso conlrario, che va daIIo savenlo aIIa generosa offerla dei Ioro
cori, quando Io vedono morsicarsi Ie mani (61-63). AIcuni crilici han-
no dimoslralo, lrovando araIIeIismi lra Ie aroIe dei bambini ed
aIcuni assi deIIa ibbia
68
, che quesla offerla rova deII'amore senza
Iimili sia da accoslare aII'Amore di Crislo, aI Sacrificio Iucarislico e
aIIa morle in Croce. Non ci sarebbe qui nessun invilo aIIa lecnofagia,
di er se inconciIiabiIe con iI concello di amore, ma, aI conlrario, una
richiesla indirella di accellare queslo amore e quesla croce
69
, con Ia
conseguenle rinuncia aII'odio e aIIa diserazione. II rifiulo deI adre
non Ii aiula affallo ad accellare serenamenle queslo sacrificio er
cui iI grido di Gaddo deI quaIe si e arIalo rima, olrebbe essere in-
lerrelalo anche in quesli lermini.
L'innocenza dei figIi fa ensare che in queslo eisodio, se c'e quaI-
che lragedia, non uo essere se non Ia Ioro. Ma cio sarebbe difficiIe da
ammellere ragionando secondo I'ollica crisliana di Danle, dove Ia vila
in lerra ha iI suo ccniinuun pcsi ncricn. D'aIlra arle, anche ArisloleIe
66 Iuridice neII'Aniigcnc, De|anira neIIe Tracninic, Giocasla neII'|!ipc |c.
67 Cfr. RAIMONDI, o. cil., . 95.
68 Cfr. IRICCIRO, o. cil., . 215 sgg., RAIMONDI, o. cil., . 93 sgg., OITANI, o.
cil., . 60 sgg.
69 NeII'invelliva danlesca conlro Iisa si arIa, infalli, deIIa croce (v. 87) in rife-
rimenlo aIIa morle dei bambini.
Oanic c |a ira!izicnc !c||a iragc!ia aniica nc||a Commedia 633
considera aI di fuori deIIa siluazione lragica i casi deIIa sofferenza
immerilala, concIudendo che essa non uo suscilare ne iela ne lerro-
re, ma unicamenle indignazione
70
. I Danle-aulore, neIIa sua invelliva
conlro Iisa, iena aunlo di indignazione, are conciIiare come
laIvoIla gIi caila neIIa Ccnnc!ia I'uno e I'aIlro unlo di visla.
Unitcrsiia jagc||cnica !i Cracctia
70 Cfr. Pcci., 13, 1452b 35-36.
DANIILI ROTA
IL CANTO XIII DILL'!"#$%"&
()* +,- ./01,20304. 5670.15
-,84240 6946+ 841060,5 ()*
1
()* 9,2 8,1. :3/,1, 841060,5 +304+ ,+0
;63+4 310,5 374;635 94+4 6031, ()*
2
NeII'4924<40 deII'anaIisi crilica o anche semIicemenle deIIa resen-
lazione anloIogica di un leslo Iellerario, si e soIili rielere che si lralla
di brano arlicoIarmenle imegnalivo, di non faciIe commenlo, ecc.
Ovviamenle non fa eccezione iI XIII canlo deII'!9=,19. che e noloria-
menle lra i iu comIessi e anche lra i iu indagali deIIa >.55,-43?
a vario liloIo. La sua disamina, infalli, inlereIIa non soIo Ia Ielleralura
e Ia oelica, ma Ia sloria, Ia cuIlura miloIogica, I'anlrooIogica, Ia
recellislica curiaIe e corlese ed aIlre disciIine ancora, creando un
inlreccio di suosizioni e di comonenli erudile che sembrano oi
confIuire in un ormai rassegnalo grovigIio di robIemaliche lullora
insoIule e forse insoIubiIi.
Ier rendersene conlo basli reIiminarmenle osservare che suIIe sue
lerzine, in arlicoIare su laIune di iu diffusa divuIgazione, lanlo da
conoscerIe a memoria fin dai banchi deI Iiceo, si sono imegnali
con esili dubilalivi, i iu noli e i iu aculi sludiosi deI Ioema, daI oc-
caccio deII'ela malura, che vi accenna sia neI @130030,77. 49 736-, -4
A390, (1357/62) in lulle e lre Ie redazioni in cui I'oerella e ervenula
e, in maniera iu amia, neII'$+<.+4B4.9, +.<13 73 >.55,-43 (1373-74,
anno deIIa morle), uIlima deIIe sue comosizioni, che, come nolo,
raccogIie Ie Iezioni da Iui imarlile er incarico deI Comune, neIIa
Iirenze danlesca, sollo Ie voIle maeslose di S. Slefano in adia, ove,
er I'occasione, resenlo e iIIuslro i rimi diciasselle canli deII'!9=,19.,
quindi anche iI XIII, cui dedica nolevoIe allenzione anche er iI
carallere di alluaIila che Ie vicissiludini quasi a Iui conlemoranee, ivi
narrale o adombrale, ancora resenlavano. Cerlo occaccio saeva,
1 CORNILIO NIIOTI, C3994/37?1.
2 CICIRONI, A, %, <6/7423? 1, 2.
DanieIe Rola 636
era informalo dei enosi e vioIenli accadimenli narrali neI XIII canlo,
Io si evince anche da aIlri assi di sue oere sufficienlemenle noli,
er cui e Iogico concIudere che quanlo egIi suggerisce o Iascia inlra-
vedere in roosilo, qui e aIlrove, e quanlo di iu allendibiIe e verisi-
miIe Ia crilica successiva ossa disorre. Avendo ero ben resenle
che iI occaccio resuone gia nolo cio che er iI Iellore dei secoIi
successivi nolo non e, cioe iI sicuro susseguirsi deIIe sequenze che
scandiscono iI lragico evenlo in esame, cioe Ia briIIanle carriera di cor-
le e iI finaIe suicidio di Iier deIIe Vigne.
I commenlalori e gIi erudili successivi, direllamenle o meno, ma
quasi lulli si rifanno aIIe chiose e aIIe didascaIie, aIIe annolazioni e aIIe
rubriche 3 730,1,, deI nolo e aassionalo noveIIiere, conlemoraneo e
ammiralore di Danle, iI quaIe, dunque, e doveroso annolarIo, disse e
scrisse Ia sua uIlima aroIa a Iode deII'oera oelica che egIi er ri-
mo, con feIice inluilo, defin -48493D e che, con caarbiela infIessibiIe,
suerando ogni iniziaIe, vaga lergiversazione deII'iIIuslre deslinala-
rio, voIIe ersonaImenle coIIocare in osizione di sicco, neIIa
bibIioleca, che ne era srovvisla, deII'ormai universaImenle ceIebre
Ielleralo suo conlemoraneo e confidenle: Irancesco Ielrarca. Un au-
lografo di vaIore ineslimabiIe e di slraordinario significalo neIIa
noslra sloria Ielleraria.
Gia Ie coordinale comosilive deI canlo XIII danlesco e Ia lemisli-
ca di svoIgimenlo deIIe sue azioni, che qui di seguilo brevemenle si
richiamano er una sua unluaIe resenlazione, ossono risuIlare
sufficienlemenle indicalive deIIa cenlraIila narraliva che gode neII'am-
bilo deII'inlera >.55,-43 e deII'affIalo arlislico che Io ha isiralo e Io
ermea. Si direbbe che anche neII'imianlo narralivo di queslo canlo,
Danle suera se slesso: I'armonia e Ia simmelria deIIe arli, Ia Iucidila
deII'imoslazione, I'erudizione sconfinala, Ia consequenziaIila Iogica,
fisica e melafisica deII'inlera narrazione, coIgono qui iu che aIlrove,
di sorresa iI Iellore, che si senle lrasmigrare neI regno deII'assoIulo.
Si uo reIiminarmenle osservare che iI ercorso narralivo deI canlo,
anche in cio che Io recede e Io segue, ha Ie cadenze deI siIIogismo
erfello.
Sellimo girone, lriarlilo:
VioIenli conlro iI rossimo
neIIa ersona aIlrui (omicidi e ferilori),
neIIe cose (guaslalori e redoni) / canlo XII.
VioIenli conlro se slessi
neIIa ersona roria (suicidi) /canlo XIII,
neIIe cose (sciaIacqualori).
VioIenli conlro Dio
!7 2390. E!!! -,77FInferno 637
neIIa ersona (beslemmialori) / canlo XIV,
neIIa nalura (sodomili) / canlo XV XVI,
neII'arle (usurai) / canlo XVII.
II leslo e iI conleslo che racchiude Ia narrazione o Ie narrazioni cos
scoIaslicamenle riarlile sono quanlo di iu Iugubre e lenebroso iI
oema resenli: Ia seIva dei suicidi, infeslala da sleri e invasa da ar-
ie. La ena deI conlraasso, aesa agIi aIberi, vi e resa aII'evi-
denza, in uno scenario di cue visioni e di sofferenze lransumane:
Ier quae eccaveril homo, er haec el lorquelurG
3
H
L'inlroduzione deI rolagonisla oi, neI suo genere e neIIa sua
secie, e di queIIe che, neIIa Ioro immediala efficacia e sobriela, assu-
mono vaIore e significalo aradigmalico:
Uomini fummo, ed or sem falli sleri
4
Un verso soIo, comoslo da soslanlivi e verbi di uso comune, cos
abiImenle correIali lra di Ioro, che esrimono aII'evidenza un immen-
so dramma di inaudila lragicila. Un'abiIila quesla che viene aI
narralore direllamenle daI grande VirgiIio, maeslro sommo in laI
genere di fugaci e scuIloree resenlazioni. asli far riferimenlo, ad
esemio, aI rimo canlo deII'$9,4-,, ove Inea inconsaevoImenle in-
conlra Ia madre Venere, che si riveIa aI figIio ignaro, neI lrallo divino:
$0 8,13 492,++6 <30640 -,3G
5
H Anche in quesla evenienza oelico-
narraliva virgiIiana, Ia lerminoIogia e assoIulamenle semIice e conci-
sa, ma suscila neIIa fanlasia deI Iellore un'immagine di movenze ed
eIeganze sovrumane.
Ira gIi innumerevoIi crilici che, allraverso i secoIi, lenlarono
un'adeguala Iellura degIi eIemenli esosilivi accennali, er rimanere
in lemi e in conoscenze iu vicine, si uo risaIire a Irancesco De
Sanclis (1817-1883), nolo uomo oIilico, ma sorallullo uno fra i iu
grandi Iellerali deI suo lemo. Gia aIIievo di asiIio Iuoli
6
, di cui ac-
coIse sorallullo I'indirizzo aIIo sludio allenlo deIIa Iingua, riuscendo
a ricoslruire in laIe roselliva iI rogressivo sviIuo deIIa Ielleralu-
3 I3<4,9B3? 11,17.
4 Verso 37.
5 Libro I, 405.
6 NobiIe marchese naoIelano (1782-1847), consideralo iI iu aulorevoIe raresen-
lanle deI urismo. NeI suo grandioso aIazzo in NaoIi aerse una scuoIa di relorica e
di eIoquenza, daIIa quaIe uscirono aIcuni lra i migIiori Iellerali deI lemo. OIlre aI De
Sanclis, anche IasquaIe ViIIari, Vilo Iornari, Luigi Sellembrini furono suoi aIunni. Nole
Ie sue oere, di nolevoIe inleresse e di grande risonanza non soIo nazionaIe, lra Ie quaIi,
in rimo Iuogo: %,J.7, ,7,5,90314 -,773 749J63 40374393 e anche A,77F310, -,77. +2148,1,H
DanieIe Rola 638
ra e, suerando iI concello romanlico, giunse a definire Ia arle che
neII'oera d'arle ha Ia fanlasia deII'aulore, in quanlo si comone in
una forma in cui I'idea e gia assala. IgIi dedico aIIa >.55,-43 nole-
voIe considerazione gia in una deIIe sue rime e iu forlunale
ubbIicazioni K3 741423 -4 A390, deI 1855, seguila a dislanza da K,B4.94
49,-40, +6773 A48493 >.55,-43? ubbIicale oslume neI 1938. Doo
queslo nolo esemio di crilica a carallere revaIenlemenle inlro-
sellivo, della comunemenle desanclisiana, due dolli maeslri deIIa
successiva scuoIa slorica, Irancesco Novali (1859-1915) e Irancesco
D'Ovidio (1849-1925), arofondirono I'esame Iinguislico e slorico
deI canlo, facendo Iuce, in arlicoIare, sui caralleri deI singoIare
Iinguaggio, liicamenle cavaIIeresco e curiaIe deI rolagonisla, quaIe
rimalore rovenzaIeggianle, senza ero ervenire a una vaIulazione
unilaria deI canlo, nonoslanle Ie vaIide e osilive iIIuminazioni e
inluizioni slorico-sliIisliche deIIa oesia che esso esrime, sorallullo
in raorlo aIIe sue fonli e aIIa sue scalurigini cIassiche.
Chi, a noslro avviso, in lemi recenli, ha megIio saulo cogIiere
I'unila oelica e Iirica deII'eisodio, evidenziandoIa in maniera esem-
Iare, e Leo Silzer (1887-1960), Iinguisla e crilico Iellerario auslriaco,
che segna una svoIla, un nuovo modo di Ieggere e inlerrelare iI can-
lo, neIIa sua unila insieme oelica, sliIislica e sicoIogica
7
. Cerlo egIi si
e moIlo avvanlaggialo dei recedenli sludi, sorallullo deI De Sanclis,
deI Novali, deI D'Ovidio e non soIo, ma suo grande merilo e I'esser
riuscilo a individuare I'unilariela di queIIa arlicoIare, forse unica,
roduzione di Iinguaggio scrillo e sollinleso che Danle in queslo
canlo allribuisce aII'uomo-ianla, iI quaIe conserva inlalla e Iucida
Ia coscienza umana, ur avendo erdulo iI sembianle di uomo. Lo
Silzer, infalli, allraverso iI confronlo crilico e Ia differenziazione
accenluala con Ie fonli ovidiane e virgiIiane, anaIizza anzilullo iI
rocesso di melamorfosi che cuImina neII'immagine degIi uomini-
ianla. Melle in chiara evidenza come, a differenza deIIe recedenli,
anaIoghe simuIazioni oeliche, aunlo Ie cIassiche melamorfosi,
neII'invenzione danlesca, non ci lroviamo iu di fronle ad un aIbero
ch'era rima un essere umano o viceversa, bens a un nuova reaIla Ia
quaIe unisce in un unico, moslruoso soggello I'uno e I'aIlro, i quaIi ivi
grollescamenle convivono, ci lroviamo cioe di fronle a una crealura
nuova, inedila in Ielleralura e in arle, che neI suo insieme e nei arli-
coIari, e lulla uomo e lulla ianla, non cioe un ibrido in cui si
mescoIano due nalure: queIIa umana e queIIa arborea, ma un vero e
rorio /4+ 49 4-,5 in cui ognuna deIIe due individuaIila originarie
7 LIO SIITZIR, !7 2390. -,4 +6424-4, in KHA., voI. I, Iirenze, Sansoni 1955.
!7 2390. E!!! -,77FInferno 639
conserva inaIlerala Ia sua roria idenlila e nalura, aunlo queIIa
vegelaIe e queIIa inleIIelliva. Di qui iI 5.9+0165D in senso elimoIogi-
co, che isira e sovrasla I'inlero canlo, raggiungendo unle di lragicila
e di Iiricila comIemenlari e reciroche, forse uniche, sicuramenle
senza recedenli. I Ia melamorfosi slessa, inlesa in senso cIassico, che
viene in se slessa suerala. II gioco di aroIe uo sembrare lauloIogi-
co, ma I'idea esressa e queIIa.
Iassando quindi aII'anaIisi oelica e sliIislica deI canlo, Io sludioso
d'oIlraIe, ravvisa, neII'accumuIarsi dei suoni asri e cui e deIIe
onomaloee, neIIe esressioni conlorle e lorluose, neI ricorso in gene-
re ad arlifici relorici iulloslo comIessi, non soIo un lenlalivo di
carallerizzare sloricamenle e oelicamenle Ia figura e I'oera di Iier
deIIe Vigne, aulore di rose e versi dollamenle eIaborali, non semre
Iineari, ma anche e sorallullo un mezzo arlislico, Iinguislicamenle
significalivo er esrimere Ia confusione moraIe, Ia moslruosila e Io
slravoIgimenlo deII'ordine naluraIe che iI suicidio, ogni suicidio, ma
in arlicoIare anche iI cIamoroso e ur ieloso suicidio er infamia di
Iier deIIe Vigne, raresenla agIi occhi di Danle e che I'immagine
moslruosa coslanlemenle resenle deII'uomo-ianla moslra aII'e-
videnza. Danle dunque esrime Ia sua nella condanna deI suicidio
non allraverso aslrazioni o deduzioni di scoIaslica malrice, aIiene aIIa
comune comrensione, ma con immagini di immediala lrasarenza e
di sicura efficacia. I nolo che Ia raffigurazione immaginifica s'im-
rime neIIe menle in maniera iu efficace deII'argomenlazione aslral-
la. Tullo iI ricco reerlorio Iellerario ed esegelico deIIe araboIe
evangeIiche e non soIo, ne e Ia rirova. Una melodoIogia didallica,
comunicaliva e raresenlaliva quesla che non e frequenlissima in
Danle: neIIe sue aIlre oere, seciaImenle di carallere iu divuIgalivo
che oelico, come, ad esemio, neI >.98484. e anche neI A, L.9312:43?
rocede soIilamenle con 37013 2:4.+3GH L'esemIificazione orlerebbe
Ionlano. Qui e sorallullo I'immagine che arIa e che conla, che esri-
me verila rilenule cos +6/7454 da richiedere non aroIe, ma figurazio-
ni Ie quaIi, emolivamenle, facciano breccia neIIa memoria e neIIa
coscienza deI Iellore. Verila esislenziaIi e universaIi, che slanno oIlre iI
lemo e Io sazio, non aarlengono aI divenire, ma aII'essere, non
sono ercio falle di aroIe che assano, ma di reaIla erenni, vere o
suosle laIi, oco imorla, urche esrimano Ie cerlezze assoIule di
cui I'arlisla, con inluizione ura, fa Ioro carico. II suicidio er Danle e
una di quesle: non sono ammesse allenuanli: anche quando viene
erelralo in condizioni eslreme, come neI caso in esame, iI suicidio e
semre e soIlanlo un 5.9+0165: non aarliene aIIa nalura umana,
che ne rimane slravoIla e concuIcala. Un alleggiamenlo di assoIulo
DanieIe Rola 640
rigorismo che neure Ia moraIe iu severa osa assumere. La dislin-
zione fra eccalo e eccalore, I'allenzione aIIe circoslanze delerminan-
li, iI caIcoIo oggellivo deIIe allenuanli soggellive, in queslo caso non
vengono neure resi in considerazione da Danle. La sua granilica
relliludine moraIe ne esce confermala, non senza quaIche inquieludi-
ne da arle deI Iellore, sgomenlo er laIe e lanla rigidila.
La condanna nella e senza aeIIo deI suicidio, rieliamo, quaIun-
que ne siano Ia causa e Ie circoslanze che Io delerminano, e una chiave
di Iellura deI canlo XIII di nolevoIe inleresse, che ne sveIa forse
I'arcano iu inleriore e ne suggerisce I'angoIalura e Ia roselliva iu
roria. I iI unlo di arlenza e di arrivo che da Ia ragion d'essere
deII'insieme e deIIe sue arli, in un conleslo che I'arle oelica rende
lrasarenle. Iochi crilici in verila vi hanno oslo menle ed e forse er
queslo che iI leslo, in numerosi assaggi, conlinua ad essere giudicalo,
er dirIo coI IoscoIo, un nebuIoso enigma. Senza quesla avverlenza
reIiminare risuIla vano se non addirillura forvianle ogni ur vaIido
lenlalivo di accoslamenlo e di comrensione. La Iuce rimane senla,
Ia confusione diIaga e un vociferare lumuIluanle di sleriIe crilica si
slemra in innumerevoIi quanlo inconcIudenli chiose, er Io iu rie-
lilive. Danle ne rimarrebbe sluilo e amareggialo.
Come lulle o quasi lulle Ie nuove roosle inlerrelalive Iellerarie,
anche queIIa deIIo Silzer, che abbiamo cercalo di sinlelizzare essen-
ziaImenle e di comIelare in arle, ebbe i suoi seguaci e i suoi
correllori. Indichiamo lra i rimi noli commenlalori, uno er lulli:
NalaIino Saegno (1901-1990), menlre lra i secondi, i correllori, ri-
meggia Illore onora (1915-1998), iI quaIe cerca di individuare i unli
eslremi d'ingegnosila e di arbilrio deI crilico auslriaco, sorallullo Ia
ove egIi riduce Ia grandezza lragica di Iier deIIe Vigne inslaurando
un raorlo dirello lra iI segrelario suicida e Danle. Tesi quesla che,
forse, deriva aIIo Silzer daI suo alleggiamenlo in arle oIemico, ma
soslanziaImenle favorevoIe verso Ie leorie di Leonardo OIschki (1885-
1940), nolo fiIoIogo e docenle universilario a Roma e aII'eslero, iI qua-
Ie aveva vislo neIIa riabiIilazione di Iier deIIe Vigne che iI canlo
veIalamenle, ma efficacemenle roone, un anaIogo lenlalivo deIIa
riabiIilazione di Danle slesso, caIunnialo, offeso e sorallullo condan-
nalo a morle in conlumacia dai suoi concilladini nei sommari rocessi
fiorenlini di arle, deI 27 gennaio 1302 e successivi sviIui. onora
nega quesli araIIeIismi esislenziaIi giudicandoIi deI lullo arbilrari.
I aena iI caso di osservare che, doo lanlo suo Iavoro crilico e av-
versalivo, Io slesso onora rilorna ero aIIa visione e dislinzione
romanlica deI leslo, quando afferma che aena lace neI canlo Ia voce
di Iier deIIe Vigne, lace anche Ia oesia. L'unila deI canlo, in laI
!7 2390. E!!! -,77FInferno 641
modo, e rimessa in discussione, in omaggio aunlo aI melodo ro-
manlico-ideaIislico che vuoI dislinguere neI leslo Ia slrullura daII'arle.
Ne, in queslo senso, Cesare AngeIini (1886-1976) sembra abbia quaIco-
sa mulalo, er cui I'aculezza deIIa Iellura deIIo Silzer resla saIda-
menle in lesla, crediamo, ad ogni uIleriore aroccio.
A buon giudizio sembra inoIlre che negare Ie anaIogie lra i lravagIi
oIilici di Danle con queIIi di Iier deIIe Vigne, anche se di esilo ben
diverso, significhi chiudere gIi occhi aII'evidenza, Ia quaIe, er defini-
zione, non ha bisogno di essere dimoslrala. La assione vioIenla e Ia
condivisione dirella che ermeano iI canlo sono laIi da non oler esse-
re ne siegale, ne comrese senza un coinvoIgimenlo ersonaIe e
dirello deII'aulore. Anche erche in queslo, crediamo, slia Ia scaluri-
gine iu rofonda e iu aulenlica deIIa sua vibranle comosizione,
unica e senza eguaIi, ne rima, ne doo Ia commossa e commovenle
narrazione deI XIII canlo deII'!9=,19.H Non si uo negare che se neIIa
A48493 >.55,-43 esisle un 370,1 ,J. di Danle, quesli vada ricercalo e si
idenlifichi con assoIula arossimazione in Iier deIIe Vigne. Qui
I'isiralo aulore che scrive, come i grandi illori d'un lemo, oIlre
I'aulografo, ci ha Iascialo iI suo sofferlo aulorilrallo moraIe e civiIe,
umano ed esislenziaIe. aslerebbe, er renderne conlo, far riferimen-
lo, ad esemio, aIIa immedialamenle successiva resenlazione di
runello Lalini, che ure fu maeslro iIIuslre di Danle, er cogIiere nei
suoi confronli, a rima Iellura, un comorlamenlo e un accoslamenlo
deI disceoIo assoIulamenle indifferenle e un occhio deI lullo eslra-
neo a queIIa severa, ma er nuIIa commovenle ena. CoeIum non
animum mulanl qui lrans mare currunl
8
.
Illore Iaralore (1907-2000), nolo Ialinisla di fine e Iucido inluilo, in
armonia con I'inlerrelazione deIIo Silzer che giudica iI canlo XIII
come queIIo deII'universaIe slravoIgimenlo naluraIe e umano! anaIiz-
za con visione disincanlala Ie fonli virgiIiane deII'eisodio, mellendo
in Iuce, con Ie variazioni inlrodolle daIIa fanlasia danlesca nei con-
fronli deI modeIIo rimilivo, iI suo aIIonlanarsi da VirgiIio ur neIIe
anaIogie deII'invenzione e deI Iinguaggio, rinviando a una visione deI
mondo radicaImenle diversa. Anche in queslo sla Ia slraordinariela
deI canlo: si one aIIa fronliera di due mondi e segna iI confine lra due
immensi universi. Iiu roriamenle, vi si cogIie iI confronlo lra Ia
menlaIila agana e queIIa crisliana in raorlo aI cosmo e aII'uomo,
aIIa vila e aIIa morle che ne conseguono. Due menlaIila e due cuIlure
assoIulamenle diverse, in nessun modo e misura sovraonibiIi, che
Danle ercio non inlende unificare o conciIiare in una assurda sinlesi
8 ORAZIO, $<4+0673, I, 11, 27.
DanieIe Rola 642
recirocamenle deformanle, anzi ne rimarca i confini, ma ne suera i
Iimili, ervenendo ad una creazione oelica di rara efficacia, lulla
immaginifica.
Iaralore, infine, si richiama a lesli deIIo slesso M313-4+. danlesco, in
arlicoIare deI canlo V e deIIa sua cerchia che consuonano singoIar-
menle con frequenli assi deI canlo in esame, ervenendo cos a
lracciare un ricco quadro deII'ambienle cuIluraIe e Iinguislico in cui e
malurala e si e esressa Ia nuova, grande e unica creazione danlesca
che iI canlo XIII deII'!9=,19. raffigura.
Tullo cio remesso, er un'adeguala comrensione anche IelleraIe
deI leslo oelico, sembra indisensabiIe aggiungere quaIche, er aIlro
scarno e gia nolo dalo informalivo suIIa figura e I'oera deI rolago-
nisla, che Ie lerzine riroongono e che sicuramenle Danle aveva ben
resenle. Iier deIIe Vigne o, secondo aIcuni, Iier -,773 N4J93? occorre
riconoscerIo, e ersonaIila sloricamenle ancora in gran arle da sco-
rire: scarse Ie nolizie biografiche, nuIIe o quasi Ie cerlezze sloriche.
Nessun documenlo ossediamo er slabiIire, ad esemio, Ia dala di
nascila e gIi accadimenli deII'infanzia, soIo risvoIli Ieggendari e
quaIche diffusa lradizione di difficiIe verifica. In arlicoIare, Guido
onalli deI XIII secoIo, lenulo in gran conlo, lra gIi aIlri, da Guido da
MonlefeIlro e da IzzeIino da Romano e che anche Danle ben conosce-
va, lanlo che Io ricorda in !9=,19.? canlo XX, verso 118, cerchio VIII,
onendoIo lra gIi indovini, coIevoIi di frode in chi si fida, Io dice na-
lo overissimo, figIio di madre abbandonala, coslrella a mendicare
er soravvivere. La nolizia e riorlala come cerla da lulli i iu noli
commenlalori deIIa >.55,-43? a arlire daI nolissimo Scarlazzini
(1873-1901).
Saiamo con quaIche maggior robabiIila iI nome deI adre: Iie-
lro. Con Io slesso nominalivo viene indicalo nei regislri deII'eoca a
noi ervenuli, un 46-,O a Caua, sembra ercio essere slalo uomo
deII'amminislrazione normanno-sveva e non di infimo grado. Iuo
essere, lullavia, che, come era coslume deI lemo, iI adre, forse sem-
Iicemenle naluraIe, non si sia curalo deI figIio, abbandonalo escIu-
sivamenle aIIa genilrice di basso rango e ercio riudiala. Di qui
I'indigenza deII'ela infanliIe cui accenna Ia lradizione coslanle. Anche
laIuni assaggi deI suo maluro eisloIario sembrano confermare que-
sle scarne lradizioni.
Nessuna cerlezza slorica quindi sui dali anagrafici d'inizio. A se-
guilo di ricerche e di arofondimenli vari, sembra, lullavia, che Ia
dala di nascila iu robabiIe sia iI 1190. Gode di maggior cerlezza Ia
coIIocazione deII'imrigionamenlo lerminaIe a Iavia, aII'anno 1248,
quasi sicura Ia dala deI suicidio, I'anno successivo, iI 1249. Ioiche
!7 2390. E!!! -,77FInferno 643
Danle nacque neI 1265, e evidenle che si lralla di ersonaggio Ia cui
memoria, ai giorni in cui egIi ne scriveva, era ancora viva, anche a mo-
livo deIIa sconvoIgenle fine, che, er Ia vasla noloriela deII'infeIice
suicida, aveva rofondamenle lurbalo I'oinione ubbIica, come risuI-
la da numerose leslimonianze deII'eoca, quesle ure riorlale dai
vari commenlalori sorallullo deIIa scuoIa slorica. Danle quindi
rende in considerazione un argomenlo di cronaca, un soggello anco-
ra ben resenle neII'immaginario ooIare, circonfuso da un vago
aIone di mislero e di gIoria che ne milizzava iI vissulo. II oela non
esila ad immergere Ia enna con ambo Ie mani in queslo bacino di
memorie vive er lenlarne, con esili eccezionaIi, una rievocazione slo-
rica e oelica ad un lemo, che allinge i verlici deII'arle Ielleraria,
sosinlo Danle, neIIa sua veemenza arlislica, daIIa cerlezza di andare
inconlro ure aIIe allese dei concilladini ancora increduIi, ma anche di
rivivere e arimenli nobiIilare, in conlemoranea, anche iI suo erso-
naIe lrascorso oIilico, burrascoso, sommamenle iniquo e mai dimen-
licalo.
In quesla roselliva, Iier deIIe Vigne non e soIo 69 ersonaggio,
bens e 47 ersonaggio deII'inlera rima Canlica danlesca, rieliamo, ai
confini lra due mondi, leso fra finilo e infinilo, lra I'arcano milo e Ia
fosca reaIla. II simboIo erenne deIIa villima ura che naufraga nei
vorlici deIIa corruzione curiaIe. Come laIe, in grado di arIare, inse-
gnare e commuovere, narrando Ia sua funesla vicenda, in cui Danle si
risecchia e si rivoIge agIi uomini onesli di semre, che furono, che
sono, che saranno. II racconlo divenla cos embIemalico e di vaIenza
universaIe. Di qui iI suo resiro senza lemo, iI quaIe va ben oIlre gIi
sazi che Io deIimilano. La doIenle sloria si idenlifica con I'elernila in
cui si rifIelle.
II rolagonisla, oIlre iI milo ooIare, ben radicandosi neII'esi-
slenle, maluro Ie sue caacila e alliludini allraverso una severa
disciIina di formazione. Raggiunse giovanissimo Ia dolla oIogna
(recedendo di quaIche decennio I'emuIo Ielrarca, ma non soIo) er
affronlare gIi sludi giuridici e cos, robabiImenle, er conlinuare Ia
rofessione alerna che, a queI lemo, godeva deI beneficio deII'ere-
dilariela.
II roIungarsi deI soggiorno a oIogna, I'iscrizione e Ia frequenza
ai corsi universilari richiedevano neI lemo, risorse finanziarie di cui
Ia malricoIa di rovenienza Ionlana non disoneva. Secondo consue-
ludine, chiese ercio aiulo ad un nolo ersonaggio deI lemo: erardo
di Casacca, arcivescovo di IaIermo, olenle consigIiere di Iederico II,
che conosciulone iI laIenlo, Io inlrodurra oi a corle ove fece iI suo
ingresso quasi sicuramenle neI 1221, anche se neII'organico ufficiaIe a
DanieIe Rola 644
noi nolo, vi figura soIo a far arle daI 1243.
II suo soggiorno a corle si riveIa fin daII'inizio arlicoIarmenle for-
lunalo e innumerevoIi sono Ie leslimonianze di una sua resenza
alliva e delerminanle neIIe vicissiludini inlerne ed eslerne deI reame.
en reslo, enlro Ie severe mura deI aIazzo, si deIinea un binomio
dominanle e non scomonibiIe: Iederico II, iI grande, Iier deIIe Vigne,
iI olenle neIIa iIIuslre corle. Un milo neI milo. MoIli alli ufficiaIi di
modesla, ma anche di nolevoIe enlila, in lulli gIi anni di sua erma-
nenza, recano congiunlamenle Ia firma deIIo slesso Iederico II e Ia sua
che ne cerlificava I'aulenlicila, riveIando lra i due firmalari una lolaIe
consonanza di inlenli e di reciroca slima e fiducia. Iu oi coslanle-
menle a fianco deII'Imeralore in numerose deIegazioni ufficiaIi,
come fiduciario di Sua AIlezza. Irolagonisla di rimo iano, assieme
aI sovrano, in inizialive di grande Iungimiranza e sensibiIila cuIluraIe,
quaIe, ad esemio, Ia fondazione deII'Universila di NaoIi neI 1224.
Cerla anche Ia sua delerminanle mediazione neI fidanzamenlo er
rocura di Iederico con IsabeIIe, Ia soreIIa maggiore di Inrico III
d'InghiIlerra, che si concIudera iI 15 IugIio 1235 con queI malrimonio
che ha segnalo Ia sloria.
Imorlanle e forse, in laIune arlicoIari verlenze, anche decisiva,
Ia sua mediazione nei difficiIi raorli lra I'imeralore e iI aa Gre-
gorio IX, UgoIino dei Conli di Segni (1227-1241) che, caso unico neIIa
sloria, Io scomunico er ben lre voIle: neI 1227, oi neI 1229 e, in fine,
neI 1239, giudicandoIo oressore recidivo deIIa Chiesa e infido insi-
dialore dei comuni ilaIiani.
L'uIlimo allo da Iui rogalo, come fiduciario di corle, di cui si abbia
memoria, reca Ia dala: Iavia, gennaio 1249. Ioi iI mislero.
Danle cerco di soIIevarne iI esanle veIo riorlando in Iuce e in
gIoria Ia sua commossa e commovenle figura in cui senliva risec-
chiarsi lanla arle di se. Occorre anche aggiungere, er amore di
verila, che laIe rievocazione in chiave evidenlemenle e voIulamenle
eIogialiva, comorlava difficoIla non comuni. Teslimoni ocuIari, non
semre disinleressali, deII'oscuro dramma, ancora vivenli, vigiIavano
con crilico inlendimenlo suIIe memorie di recuero deII'inlera vicenda
o di arle di essa. Ira ercio d'obbIigo allenersi ai falli, aII'oinione
dominanle, ena Ia sconfessione in dirella, suI camo.
AI di Ia oi deIIa misleriosa, ma cerlo vioIenla morle deI fedeIe se-
grelario e deIIe reaIi molivazioni che Ia delerminarono di cui Danle,
ur con Iinguaggio cifralo, moslra di essere erfellamenle informalo,
I'imresa commemoraliva resenlava anche difficoIla oggellive. In
rimo Iuogo Danle aradossaImenle si rooneva di rendere gIoria a
un dannalo, iI che sembrerebbe una conlraddizione in lermini. InoIlre
!7 2390. E!!! -,77FInferno 645
Iier deIIe Vigne aariva come ersonaggio dai miIIe voIli, non fa-
ciImenle sovraonibiIi: Ielleralo, oela, giurisla, uomo di corle e di
olere, daIIe innumerevoIi comelenze, senza Iimili di ingerenza e di
delerminazione neI suo ambilo. La corle in cui oero non ebbe er Iui
ne misleri, ne ambili roibili: .ambo Ie chiavi deI cor di Iederico
9
furono saIdamenle neIIe sue mani er decenni, ne avrebbero olulo,
secondo Danle, lrovarsi in mani migIiori. Visse cos, con somma
dignila e comelenza, er anni, giorno doo giorno, a fianco deI
monarca forse iu sIendido, ma anche iu robIemalico, discusso
e sorallullo infido deI lemo: Iederico II di Svevia (}esi 1194 - Iio-
renlino, IugIia 1250) Ia cui corle viene lull'ora evocala lra Ie iu son-
luose, Iungimiranli e inlriganli di lulli i lemi, lanlo da assurgere a
simboIo di un olere assoIulo e assoIulamenle corrollo in cui regnava
Io sIendore ambiguo e ambivaIenle deIIa vanila coIla e deII'inlrigo
oIilico di malrice medioevaIe. Come iI robo Iier deIIe Vigne slesse
aI gioco, non e dalo saere: non e imrobabiIe che, a un cerlo unlo,
ne abbia rovalo disguslo e si sia ribeIIalo. O abbia aImeno lenlalo di
farIo. Danle ero Io one lra i suicidi, non lra i lradilori o i conleslalo-
ri. II arlicoIare non sembra lrascurabiIe, a vario liloIo.
CoIIoca invece iI suo rincie, Iederico II aunlo, fra gIi eresiar-
chi, seoIli enlro arche infuocale
10
, anche se moslra er Iui quaIche
riverenziaIe considerazione. Iier deIIe Vigne, infalli, suo fedeIe segre-
lario (chi megIio di Iui avrebbe olulo giudicarIo`), anche in mezzo ai
alimenli infernaIi, Io ricorda con indubbia considerazione: Vi giuro
che mai non rui fede / aI mio Signor, che fu d'onor s degno
11
.
Giudizio condiviso, aImeno in arle, anche neI A, N67J314 $7.;6,9043
che cos si esrime: Siquidem iIIuslres heroes, Iedericus cesare el
bene genilus eius Manfredus, nobiIilalem ac recliludinem sue forme
andenles, donec forluna ermisil, humana seculi sunl, brulaIia dedi-
gnanles
12
.
Non uIlimo molivo di lanlo oslenlala ammirazione sla forse neI
fallo che queIIa sua corle fu anche una deIIe sedi iu erudile deI lem-
o, o aImeno laIe e aarsa, non soIo agIi occhi dei conlemoranei,
ma anche dei osleri i quaIi unanimemenle rilengono che ivi,
aII'eoca, nacque Ia oesia in voIgare Iellerario, divenendo cos uno
dei maggiori cenlri cuIluraIi euroei di lulli i lemi. Cio indienden-
lemenle daI basso lenore di vila dei funzionari e corligiani, noli e
meno noli. Vero e che aIcuni suoi dignilari incominciarono a comor-
9 Vv. 58-59.
10 !9=. X, 119-120.
11 !9=. XIII, 74-75.
12 Libro II, 19.
DanieIe Rola 646
re versi, a scrivere oesie, lra essi e lra i rimi, Io slesso Iier deIIe Vi-
gne che diede indubbiamenle rova di un laIenlo oelico non
comune, benche di genere iulloslo comIesso, magniIoquenle, ersi-
no amoIIoso, coImo di erudile cilazioni cIassiche, di aIIegorie
reloriche, di simiIiludini che finiscono coI renderIo lorluoso e, non di
rado, goffo. La crilica successiva non fu induIgenle nei suoi confronli:
nei giudizi erudili si regislrano iu dubbi che arovazioni. II merilo
che nessuno gIi uo negare in ambilo Iellerario e che fu a cao di una
nuova cordala, deslinala oi a giungere ai verlici deII'arle. Un'arle
ero che Danle non moslra di ammirare arlicoIarmenle, lanlo che neI
canlo XIII, Ie fa Ia voce, iI verso, non senza quaIche veIala ironia, come
moIli commenlalori fanno nolare. La conslalazione e nolevoIe, soral-
lullo se si liene resenle che egIi, neII'!9=,19. non ride mai: sosliluisce
iI riso con I'ironia: un esedienle che laIvoIla gIi consenle di giungere
aIIa caricalura vera e roria. Non e Ia oesia di Iier deIIe Vigne che
ammagIia Danle, ma Ia sua vila e Ia sua morle, Ia sua onesla lradila, Ia
sua fine cos funesla e immerilala.
IarlicoIarmenle noli e sludiali, e moIlo ben resenli a Danle, sono i
due comonimenli amorosi di Iier deIIe Vigne: P5.1, 49 264 -,+4.) e
P539-. 2.9 =49 2.1, , 2.9 +<,139B3 che neI lemo assurgono a modeIIi
esemIari deI nuovo modo di oelare, di cui, rieliamo, Ia corle di
Iederico e aunlo rilenula cuIIa e vivaio.
MoIlo iu foIla Ia messe eisloIare deI segrelario di corle, in cui
forse emerge iI megIio di Iui, come uomo di fine erudizione, dolalo
di rara diaIellica. Con i disceoIi e i subaIlerni, lullavia, Ia corrison-
denza, secondo I'uso inveleralo deIIe corli, e quasi comIelamenle in
Iingua Ialina ed ha er maeslro Cicerone, sorallullo Ia ove asserisce:
$<4+0673 9.9 ,16/,+240
13
. Lo sliIe, infalli, e schiello e fIuenle, Ie silua-
zioni concrele vengono affronlale con eslremo reaIismo, laIvoIla, si
direbbe, con disinvoIlura. L'indiscusso e indisculibiIe maeslro di relo-
rica cIassica deII'era imeriaIe sla fisso suIIo sfondo deI leslo e deI
conleslo, regisla di un'arle sicura che si esrime in forme Iimide e
convincenli, grammalicaImenle esalle, sinlallicamenle inecceibiIi.
Nessuna cadula d'inlensila, nemmeno I'ombra deIIa Iicenza sliIislica.
GIi sludi che ne sono slali falli, ne riveIano una erfezione formaIe
assoIula, senza riserve e senza eccezione. Anche a queslo roosilo e,
lullavia, doveroso osservare, a rirova di quanlo aena asserilo, che
Io sliIe eisloIare di Danle e ben diverso: Ie sue lredici $<4+0673,
sliIislicamenle non hanno nuIIa in comune con queIIe deII'iIIuslre re-
cursore: Io scrillore fiorenlino non fu ersuaso da queI Iinguaggio
13 P- K6247465? IV, 2.
!7 2390. E!!! -,77FInferno 647
scrillo, freddo e neulro e si rifiulo di seguirne Ie orme. Anche queslo
conferma che I'ammirazione di Danle roviene da aIlre sonde.
L'inleressanle disamina deII'arle Ielleraria deIIa corle federiciana
e deIIe benemerenze deI suo iu iIIuslre segrelario olrebbe singersi
ben oIlre, revaricando ero i confini deI resenle conlribulo, er
cui e doveroso far cenno ad arofondimenli bibIiografici, noli e
comIemenlari, di uliIe e comensaliva informazione: in laI senso,
er una anoramica dellagIiala suIIa cuIlura e Ia oesia aIIa corle
di Iederico II si uo far riferimenlo, lra i moIli aIlri, aIIo sludio esem-
Iare anche se non esauslivo di Anlonino de Slefano, K3 2670613 3773
2.10, -4 #,-,142. !! !5<,130.1,
14
, neIIa rima e successive riedizioni, men-
lre er Ia oesia e I'arle Ielleraria di Iier deIIe Vigne neI suo insieme,
uliIe Ia consuIlazione deIIa monografia di runo Ianini, M.,04 40374394
3773 2.10, -4 #,-,142. !!
15
.
Rilornando aIIa narrazione danlesca, iI unlo iu robIemalico e
conlroverso deII'inlera vicenda, rimane Ie causa uIlima deIIa fine
drammalica deI rolagonisla deI canlo. Le nolizie cerle sono, come
remesso, assoIulamenle scarse, laIvoIla conlraddillorie. Sicuramenle
fu arreslalo a Cremona neI 1248, aII'allo deII'arreslo, i cremonesi, fana-
lici soslenilori deII'imeralore, are che lenlassero di IaidarIo, ma
Iederico II ne ordino I'eslradizione, medilando forse una unizione
esemIare e lremenda: I'accecamenlo e Ia gogna suI ubbIico aliboIo,
con esemIare esecuzione, laIe da scoraggiare ogni anaIoga e forse
sereggianle lenlazione di corle.
Di cerlo risuIla decedulo aIIa dala deI 26 giugno 1249, aIIorquando
viene emesso un mandalo imeriaIe che disone Ia confisca e
I'incameramenlo dei beni suoi e dei arenli, rilenendoIi ad arle, sub-
doIamenle accanlonali. Danle, rieliamo, cerlamenle conosceva Ia
verila dei falli e robabiImenle Ia conoscevano anche i suoi rimi Iel-
lori, ma I'aIone di mislero in cui iI ersonaggio voIulamenle, a noslro
avviso, rimane, ne accresce a dismisura iI fascino. La reaIla divenla
simboIo e sfuma in Ionlananze misleriose, che abbagIiano. Manzoni
saeva sicuramenle chi era I'!99.54930. eure iI suo vero nome ri-
mane seoIlo nei chiaroscuri di una narraloIogia ad effello. I I'!9=4940.
di Leoardi, che 2.77, non e, ur suscila immedialamenle neI Iellore
sensi di verligini.
TaIuni crilici, ricorrendo aI iIIazioni e deduzioni di incerla consi-
slenza, coIIocano Ia dala deIIa sua morle neI marzo deI 1249, ma
nessuno, aIIo slalo alluaIe deIIa ricerca, sembra in grado di azzardare
iolesi definilive e condivisibiIi suI come e suI dove sia avvenula. La
14 oIogna, 1950.
15 NaoIi 1994 e successive riedizioni.
DanieIe Rola 648
biografia Ieggendaria e nolevoIe, sufficienlemenle nola, allraversa
orizzonlaImenle e verlicaImenle I'inlera vicenda, ma non sembra al-
lendibiIe, ne merila aIlra allenzione deIIa ura e semIice curiosila
narraliva.
La forlezza di S. Minialo viene comunemenle indicala come Ia ri-
gione e Ia IocaIila iu robabiIe deIIa lragica fine. Se rima fosse slalo
accecalo, non e cerlo, e ero convinzione di moIli slorici e crilici. AI-
cuni dei quaIi avanzano anche I'iolesi deIIa molivazione deI suicidio:
er sollrarsi aIIa ferocia deII'imeralore, crudeIe e sanguinario lorlu-
ralore dei suoi avversari o resunli laIi, di cui iI segrelario, a molivo
deIIa sua recedenle famiIiarila con Iui, era erfellamenle a conoscen-
za.
SuIIe cause o accuse che hanno olulo delerminare iI suicidio,
comunque cerlo, si avanzano aImeno lre robabiIi iolesi, searala-
menle, ma anche congiunlamenle: I'invidia, Iier deIIe Vigne cioe fu
villima di una congiura di corle, molivala daII'enorme olere e daIIa
delerminanle infIuenza che iI segrelario aveva via via acquisilo
suII'imeralore, semre iu succube deIIe sue ambiziose e non imar-
ziaIi mire. Secondo Ia maggioranza dei crilici sembra quesla Ia lesi
adombrala daIIa narrazione danlesca. I deI reslo Iuogo comune che
I'invidia sia iI larIo deIIe corli, iI quaIe miele Ie sue villime in aIlo e
in basso, ma lendenziaImenle fra Ie ersonaIila di sicco, Ie iu eIeva-
le. Danle ercio avrebbe riveslilo di concrelezza una comune e diffusa
credenza che vedeva in Iier deIIe Vigne iI simboIo e Ia villima di
una corle maIvagia, rielulamenle scomunicala, e ercio in odio a
Dio e agIi uomini, che sacrifica i suoi uomini migIiori suI aliboIo
deII'ignominia, divorando e demoIendo conlemoraneamenle se sles-
sa.
Una seconda iolesi deIIa condanna e deIIa fine suicida si aeIIa
aIIa corruzione, come se Iier deIIe Vigne avesse cedulo a ricalli o a
richiesle di favorilismi, inlerni ed eslerni aIIa corle, dielro disonesli
comensi, in denaro o in lerreni, di qui Ia confisca <.+0 5.10,5 di lulli i
beni residui, suoi e dei suoi famiIiari.
La lerza e ancor iu infamanle suosizione e iI lradimenlo: come
se iI iu fidalo e inlrodollo dei corligiani, avenle funzione di segrela-
rio e di confidenle, con subdoIa erversione e avvaIendosi di quesla
sua osizione di favore, avesse congiuralo conlro I'Imeralore er
logIierIo di mezzo, lesi che sembra avvaIorala daIIe leslimonianze deI-
Io slesso Iederico, Iaddove, in numerose Iellere susseguenli aI
suicidio, Io definisce <1.-40.1D-lradilore: vocaboIo che neIIa lradizione
cIassica e osl-cIassica indica aunlo iI cosiralore conlro I'aulorila
cosliluila.
!7 2390. E!!! -,77FInferno 649
Orazio are iI Iibro deIIe &-4
16
con un avverlimenlo di semre uliIe
richiamo, ma che neI canlo in esame si riveIa arlicoIarmenle adegua-
lo: Tu ne quaesieris, scire nefasG. Un leslo queIIo deI canlo XIII
esresso in un Iinguaggio revaIenlemenle cifralo, non a lulli nolo,
ancora in gran arle da indagare, er esaIlare una vicenda lenebrosa
e avvoIla neI mislero, che laIe rimane, doo iu di selle secoIi di
disamine e nonoslanle Ie faliche e i lenlalivi di chiarificazione e di
comrensione di slorici, Iellerali e crilici.
Q948,1+40R -,J74 I06-4 -4 S,1J35.
16 >315493? I, 11.
IRANCISCO IISILLI
IL CANTO XV DILL'!"#$%"&
'
&))*+,-. ,/0-. +1 )*+,-. 2.3,+ 14/51+5/6-
}acoo deIIa Lana da ArisloleIe
Quesla Lellura lrallera aIIa slregua di oggelli ed evenli reaIi Ie
arvenze inlrodolle da aIcune imorlanli simiIiludini. IIIuslrera Ie
conlraosizioni slrulluraIi carallerisliche deI canlo, sia neIIo scenario
comIessivo, sia neI confronlo ersonaIe fra Danle e runello, che
reinlerrela. Iresuone Ia conoscenza generaIe deI leslo.
Come saiamo daI canlo recedenle, faIde incendiarie slanno
caIando, da chi sa quaIe cieIo seoIlo, suIIe arene deI girone, che
rendono fuoco. La fisica d'eoca sieghi I'inusilalo fenomeno, ma
resla, e forse iu imressionanle, Ia dissonanza fra eIemenli e rincii
naluraImenle osliIi a confronlo.
La caIala incendiaria e della
Come di neve in aIe sanza venlo
(!678 XIV, 30)
Con Ia fusibiIe frigidila deI lermine di aragone si are ancora una
dissonanza. A un lemo viene suggerilo che Ie faIde siano bianche: aI
caIor bianco, iI massimo, aunlo.
NeI sabbione si inoIlra uno scoImalore (+-91--. :*55,., !678 XIV, 117),
innominalo, deI IIegelonle. La boIIenle .5;/. 9*++. (!678 XIV, 134) che
conliene avra corso e lemo er diIuirsi e raffreddarsi rima di finire
uIlimalamenle neI Cocilo.
Cosi 5*4*9.-* da sangue iI Ioela aveva vislo iI lorrenle Arbia (!678 X,
86), ma queIIo, sebbene anch'esso 9.55.)9,55,.6-e (!678 XIV, 78) e forse
ure anlicio di cose infernaIi, non boIIiva.
I numeri arabi aosli senza aIlra indicazione si riferiscono a versi deI canlo XV.
Sono in corsivo i lermini danleschi riorlali neI leslo correnle, sono in londo i versi
isoIali.
Irancesco IiseIIi 652
Vengo aII',65,),- deI noslro canlo.
01 Ora cen orla I'un de' duri margini
NeI lemo degIi evenli, ora e un :*2.6,. Siamo difalli enlrali in In-
ferno ,19 2.--,6. (52). Reslano indielro urIa, canzonacce, deIiqui,
bufere, aIudi infelle, Ia nera foresla gemenle, Iussuriosi, iracondi,
inelli, suicidi e bIasfemi, liranni, omicidi, suicidi.
&9., e siIenzio.
I Transilanli si incamminano, neI senso deIIa correnle che e iI senso
deI Viaggio: non erderanno I'orienlamenlo!
SoraeIevali come slanno, godono di un'ollima visione circoslanle,
non meno che siano visibiImenle esosli. Marciano, come imone iI
solliIe violloIo arginaIe, uno dielro I'aIlro, non affiancali (</93. XII, 1).
VirgiIio va in lesla. Si guarda a deslra.
L'avverlenza che sliano marciando su /6* dei margini, sarebbe o-
ziosa, se non comrendessimo che queI margine e seciaIe, e queIIo
che necessariamenle )*9-. iI Ioro 7.-.41 .6:.91 (!678 V, 22). IorlandoIi
consenle e redisone laIuni inconlri con Ie bande abilanli deI Iuogo,
in arlicoIare con queIIa di runello Lalini.
La sua durezza garanlisce da sgreloIamenli che facciano scivoIare,
a deslra a sinislra non imorla: semre in collura si finirebbe. Id e
laImenle soIido erche lullo I'arlefallo si Iaslrica e cinge di robusla
ancorche 4,=,:. (!678 XIX, 14) ielra, forse neI genere deI macigno (63)
che si cava resso I'anlialica IiesoIe. Nessun ensiero andrebbe a
marmo, che, lerso, si addice a un regno migIiore (</93. IX, 95).
02 e 'I fummo deI rusceI di sora aduggia,
03 s che daI foco saIva I'acqua e Ii argini
II fiIo di Iiquido sanguigno giu neI canaIe non si Iascia incendiare:
>/--1 7,.221441 .22*9-. (!678 XIV, 90). I Ie .22*9-. grazie ad un
ombreIIo isoIanle gassoso? laIe da roleggere I'aIveo nonche Ie isle
marginaIi, e con queIIe chi Ie frequenla. Immune, I'acqua rossa scoIa
via senza aIbergare -*9216-, e -*9216-.-, (!678 VI, 4), verso I'*99,@,41
+59*+5,* (!678 XVII, 119) concIusivo.
Verrebbe islinlivo rilenere che iI 7/22* aIlro non sia se non vaore
emesso daI rusceIIo riscaIdalo daIIe faIde ignee. Ma non uo essere,
saiamo infalli che Ie 7,.221441 sono ammorlale rima che locchino
I'acqua rossa. Iorse dobbiamo ensare a fumo che si soIIeva daIIe
sabbie in combuslione` Si soIIeva cerlamenle, in secie Ia dove Ia caIa-
la ignea va a mirare e scollare Ie bande in cammino (v. 117), ma non
!4 5.6-* AB :144CInferno 653
vedo erche si debba concenlrare rorio sora I'acqua e gIi argini.
Ier me, allribuisco I'eboIIizione ad una febbre deI sangue, dovula ad
eccesso deI suo caIore animaIe. Qui (v. 30), iI fenomeno e aragonalo
aII'effervescenza deIIa fonle lermaIe in uIicame (!678 XIV, 81), menlre
in IIegelonle aare, non ornalo da simiIiludini, cuamenle =192,34,*
(!678 XII, 101), erche Ia riboIIe sangue aIIo slalo uro.
CaIore animaIe, caIore igneo, orrendo sangue vivenle, sabbia ne-
mica di ogni vila: ecco degIi incomalibiIi che mai olrebbero sus-
sislere insieme, ma I'argine Ii liene ben dislinli.
04 QuaIi Iiamminghi.
07 e quaIi Iadoan.
10 a laIe imagine eran falli queIIi,
11 lullo che ne s aIli ne s grossi,
12 quaI che si fosse, Io maeslro feIIi.
Con abbondanle amIificazione, iI Ioela esaIla Ia soIidila dei mar-
gini, ari a queIIa di grandiose aIificale e dighe, sebbene non siano
quesli aIlrellanlo imonenli. Id effellivamenle iI margine che fa da
isla e un murello lanlo basso e slrello da consenlire a runello di
afferrare faciImenle Ia vesle deI Ioela. Grande ingegnere e slalo coIui
che Io lracciava, laIe da merilare iI liloIo di 2.1+-9* (v. 12), aIIa ari con
VirgiIio (v. 97). NeIIe lremende condizioni IocaIi, infalli, Ia sua iccoIa
e forle oera non ha cerlamenle dovulo essere meno imegnaliva di
queIIe che resingono disaslrose mareggiale ed esondazioni suI Iilora-
Ie di Wissanl, oure suIIa sonda deIIa renla.
L'irruzione di fredde acque ha conlrarialo I'eIemenlo deI forno a
fuoco sora e fuoco sollo, con fragore ne ha sconvoIlo iI siIenzio.
13 Gia eravam da Ia seIva rimossi
14 lanlo, ch'i' non avrei vislo dov'era,
15 erch'io in dielro rivoIlo mi fossi,
16 quando inconlrammo d'anime una schiera
17 che venan Iungo I'argine.
Due assenze: Ia +14=. scomarsa aII'orizzonle e Ia mossa soIlanlo
iolelica deI guardarsi aII'indielro.
Rilengo, er anaIogia (v. 117) che slia marciando sollo una coIonna
di fumo, quesla +5D,19., 7.2,34,.? 2.+6.:., comosla da eminenli er-
sonaggi accomunali da simiIe, oIlre che vizio, aIla osizione sociaIe e
Irancesco IiseIIi 654
cuIluraIe (vv. 102-113). NeI cIub, si lende a comorlamenli condivisi,
in secie verso eslranei, ed eccoIi dunque lulli insieme che .:*55D,.6*
gIi aIieni in assereIIa.
17 .ciascuna
18 ci riguardava come suoI da sera
19 guardare uno aIlro sollo nuova Iuna,
20 e s ver' noi aguzzavan Ie cigIia
21 come 'I vecchio sarlor fa ne Ia cruna.
26 .ficcai Ii occhi er Io collo asello.
II Ioela reIeva Ia scarsa Iuminosila IocaIe, Ia deura daI fumo,
Ia lrasferisce in mile chiarore serolino. La difficoIla di visione, neII'una
e neII'aIlra Iuce, imIica gesli di ammiccamenlo rieluli da lre diversi
soggelli, neIIa Ianda dai marcialori deIIa +5D,19., e da Danle, in
mezzo daI sarlo, resenle IocaImenle soIlanlo come aIIogeno che ro-
viene da 4E +F :, +*)9., daII'ambienle urbano, immagino fiorenlino.
L'aIIillerazione sera (v. 18) - serena (v. 49) deve essere regislrala.
II sarlo e, neI suo iu umiIe mesliere, un 2.1+-9* non meno che
I'ingegnere deII'argine. Ambedue sono allori di Iavoro rodullivo neI
ieno deIIo serero lermico unilivo.
La dissonanle scenella sla ronla er I'ingresso di Ser runello,
uomo di cilla.
23 fui conosciulo da un, che mi rese
24 er Io Iembo.
II Iavoro deI sarlo imIica una resenza di sloffa, che eraIlro
manca sollo I'ago non meno che suIIe nudila degIi indigeni, e sussisle
soIlanlo come idea. L'idea in cerca di esislenza si maleriaIizza neI aI-
abiIe vesliario enduIo, manlo o lunica che sia, deI Iassanle. Una
mano si aIIunga, ne afferra iI 412@*, e queIIa di Ser runello. Mano
inleIIigenle, che locca uno sessore morbido, si senle lirare e lira, con-
ferma iI sosello che non slia lransilando un'ombra vana (</93. II, 79).
I cos che, allraverso I'esigua cruna di gesli in se lrascurabiIi, Ia
narrazione abbandona iI subIime fisico e va ad assolligIiarsi neI lenue
sicoIogico.
24 .QuaI maravigIia!
30 .Siele voi qui, ser runello`
!4 5.6-* AB :144CInferno 655
Siamo in una sera di rima Iuna a Iirenze, guarda Ia iI sarlo sla an-
cora a lirare I'ago, che ci si rilrova che sembra ieri. soravviene un
coIIoquio Ievigalo da manierismi, affabiIila, 6*6 -, :,+),.55,., =16 )915*,
cauli +1/+1 simmelrici, =*,? -/, 7,34,/*4, +191, sosle, giravoIle, aIIocuzioni
onderale, inlimamenle caulo e leso.
46 .QuaI forluna o deslino
47 anzi I'uIlimo d qua giu li mena`
48 e chi e quesli che moslra 'I cammino`.
49 La su di sora, in Ia vila serena,
50 risuos'io Iui, mi smarri' in una vaIIe,
51 avanli che I'ela mia fosse iena.
52 Iur ier mallina Ie voIsi Ie saIIe:
53 quesli m'aarve, lornand'o in queIIa,
54 e reducemi a ca er queslo caIIe.
runello, con Ia decisione che si e gia manifeslala quando afferrava
senz'aIlro iI Ioela er Ia vesle, azzarda una dirella inlerrogazione e-
sIicila.
Ha gia inluilo che I'ignolo, che insieme aII'AIighieri marcia su
er iI murello, fosse Ia sua guida. Ioi, Ia nolizia reziosa: Io sla ricon-
ducendo . 5.+.. Cio significa che queI giovanollo di beIIe seranze,
suo ex aIIievo aImeno a cerli momenli, sia asceso a quaIila moIlo eIe-
vala, lanlo che gIi si assegna una guida seciaIe in osli aIlrimenli
inaccessibiIi a vivenli. DeIIa guida, non erde lemo a farsi migIiore
idea, non si inleressa: unla aII'AIighieri, che una voIla lornalo in
suerficie uo essergIi di inallesa grande uliIila.
La circoslanza non giunge sicoIogicamenle favorevoIe, AIighieri
beIIo sano e ben veslilo, aIlo suII'argine, Iui decadulo e ignudo neI
sabbione, fa nienle, in comenso si comorlera da grand'uomo. II coI-
Ioquio deve essere inlrallenulo subilo, con arle, ed efficacia, erche
non si rielera mai iu ed iI lemo disonibiIe e minimo.
58 .s'io non fossi s er lemo morlo,
59 veggendo iI cieIo a le cos benigno,
60 dalo l'avrei a I'oera conforlo.
Recila Ia sua senlenziosa aIIocuzione: Tu rorio er Ie lue ecceIIenli
quaIila, verrai in odio ai essimi comalrioli, ma aIIa fine andra lullo
er iI megIio, Ie fazioni finiranno coI ricorrere a le, se sarai slarlene,
Irancesco IiseIIi 656
con inleIIigenza, da arle er un cerlo lemo. Di assaggio, AIighieri
slesso e fiorenlino, non sla bene derecare lroo Ia genle che e doo-
lullo Ia sua, aIIora gella un beI o' di coIe suI nefaslo infIusso deIIe
@1+-,1 fiesoIane. Cosi, sedullivo, runello.
55 .Se lu segui lua sleIIa,
56 non uoi faIIire a gIoroso orlo.
65 .lra Ii Iazzi sorbi
66 si disconvien frullare aI doIce fico
76 .Ia semenla sanla
77 di que' Roman.
La sua aIIocuzione non si e avvaIsa di seciaIe rescienza (!678 X,
100), e neure di soslegno argomenlalivo. Si affidava a delermini-
smo genelico, rimandava aIIa buona forluna non senza un izzico
aslroIogico, che e ancora delerminismo. II :1+-,6* (46), e cosi che
runello Io conceisce` Quanlo ai Iiberi merili ersonaIi deII'AIighieri
non sembrano resi in considerazione.
88 Cio che narrale di mio corso scrivo.
99 oi disse: ene ascoIla chi Ia nola.
Con una unla di risenlimenlo miligala neI lono di risello, Ia ri-
sosla chiarisce: Non vi faccio oIlraggio, runello, rifiulando di
inleressarmi aIIa voslra aIIocuzione. La lengo a menle, affinche Ia va-
Iuli una sueriore aulorila, non chiedelene iI nome, non fa er voi.
Commenlo soIamenle che non mi avele dello quaIcosa di rorio
nuovo, e quanlo aIIa Iorluna in cui credele lanlo, vada come Ie iace,
io mi ergo ronlo a lullo, urche sia semre saIva Ia mia coscienza.
Una mossella di VirgiIio, finora siIenzioso, ma allenlo ad ascoIlare,
ed iI conciso: TienleIo er dello, Nolaio.
79 Se fosse lullo ieno iI mio dimando,
80 risuos'io Iui, voi non saresle ancora
81 de I'umana nalura oslo in bando,
82 che 'n Ia menle m'e filla, e or m'accora,
83 Ia cara e buona imagine alerna
84 di voi quando neI mondo ad ora ad ora
!4 5.6-* AB :144CInferno 657
85 m'insegnavale come I'uom s'ellerna:
86 e quanl'io I'abbia in grado, menlr'io vivo
87 convien che ne Ia mia Iingua si scerna.
Iiu non sono, i nobiIi insegnamenli regressi, isirali da una vo-
Ionla di elerno, di quando iI Ioela andava a rendere resso runello,
ogni lanlo, islruzione di vila e cuIlura. QuaIe differenza risello
aII'odierna decIamazione! RifIellere su lullo queslo fa maIe? .55*9..
Ma neure, quegIi insegnamenli si ossono, *9. iI Ioela se ne ac-
corge, manlenere. IncuIcava iI sere una secie di esaIlazione, sia ur Ia
iu nobiIe, fomenlala dai suoi sludi slorici, oIiloIogici, cIassicisli`
Islruiva iI sere suIIe rocedure uliIi a conseguire fama o gIoria duralu-
re, un'immorlaIila consegnala, diciamo, aIIe rorie oere Iellerarie o
oIiliche` II Ioela, e vero, liene neI debilo conlo Ia 7.2. (107), ed am-
melle che ossa durare ;/.6-* ,4 2*6:* (!67. II, 59), sebbene non in
elerno: ma non ignora quanlo di fallo oco giunga a vaIere, fieno che
reslo si essicca (</938 XI, 115). Iiu rofondamenle, non e ne accella-
biIe, e neure conceibiIe che quaIcuno ossa elernarsi grazie a cerle
rocedure meramenle umanisliche. Le voslre, runello.
119 Sieli raccomandalo iI mio Tesoro.
QueI che reslava di inesresso, ma era essenziaIe, e gridalo aena
rima che ci si seari. La elizione, mossa da un cruccio di aulore che
si vuoIe 1--196.91 neI ricordo meramenle slorico e umano, aIIa IoscoIo,
runello se I'era formala in eclore, forse gia rorio aI momenlo che
vide rocedere vivo I'AIighieri, oi saIdamenle deIiberala, enso, ve-
nendo a saere che slava lornando a casa, a Iirenze: non ensava ad
aIlra casa, infalli. L'aveva rearala con Ia sua sedullrice aIIocuzione.
120 .e iu non cheggio.
121 Ioi si rivoIse, e arve di coIoro
122 che corrono a Verona iI drao verde
123 er Ia camagna, e arve di cosloro
124 queIIi che vince, non coIui che erde.
NuIIa hanno iu da dirsi.
Adesso Ia sloffa assenle sollo I'ago sarloriaIe migra a maleriaIiz-
zarsi, a mo' di siario, rendendo una linla vegelaIe aIlrimenli roi-
bila daIIo sleriIissimo sabbione (!67. XIV, 9).
L'energia fisica e sicoIogica deI canlo, doo una iroella, defIui-
Irancesco IiseIIi 658
sce lrasmulala in veIoce odismo. La frella fa erdere ogni soIennila
(</938 III, 11), ma iI noslro sere vince eguaImenle. Si e degnamenle
esercilalo in eIoquenza, e riuscilo a chiedere queI che gIi inleressava, e
I'ollerra daI robo AIighieri, ne e sicuro.
Sei slalo acconlenlalo, runello. II luo >1+*9* eccoIo cilalo, aI verso
119. Sei ceIebre, aggiungo, non soIlanlo er queII'oera. Dicono ersi-
no che avresli orlalo lu, lu, a Iirenze, e direllamenle o indirella-
menle aIIungalo aI Ioela un riIevanle esemio isIamico. Mah.
G6,=19+,-E :134, H-/:, :, <.92.
MARIO AVIRSANO
IL CANTO XVII DILL'|N|||NO
Canlo dei iu nolevoIi, iI XVII deII'|njcrnc, ma anche dei meno for-
lunali deIIa Ccnnc!ia. DaIIa danlislica esso ci giunge, bisogna dirIo,
Iargamenle inesIicalo (laIe esso aare a chi Io affronli coi mezzi deI-
Ia leoria-melodoIogia crilica che lemo fa ebbe corso con I'eigrafe di
Scnicsi c|||igaia)
1
. Cio a causa di non ochi vuoli neIIe riIevazioni di
base, di queIIi davvero regiudizievoIi, d'ordine inlra e inlerlesluaIe,
e er aIcuni reconcelli. II rimo dei quaIi va indicalo neIIa convin-
zione che non sia ossibiIe risconlrarvi un ccniinuun narralivo, e
lanlo meno quaIche segno arezzabiIe di oIilicila, dovendo esse-
re consideralo irriIevanle o in diversione quanlo ne residua daII'ac-
cidenlala lramalura. I invece da riballere fin d'ora che queslo canlo
ha una comagine non soIo unilaria come deI reslo lulli gIi aIlri deI
Ioema, nessuno escIuso ma anche d'una geomelria erfella, caIala
in una dimensione che di cerlo e moraIe, ma anche, e er queslo, acu-
lamenle oIilica, e che esso aare conceilo e lraccialo, aImeno neIIe
Iinee fondamenlaIi, in conseguenza di evenli che non soIo sanno di
urgenza slorica, ma neIIa misura iu nella: che e quando c'enlra
I'aulobiografia. Ier iI che converrebbe anche rilenerIo dei iu anlichi
deIIa Ccnnc!ia quanlo aI rogello, se non aIIa dalazione. Anliciia-
mo, rinciiando coI dire (con ochi mezzi lermini, aI fine di essere
iu comrensibiIi, e brevi come ci viene richieslo) che I'eisodio degIi
Usurai non sezza affallo iI canlo, erche non vi giace a mo' di nolizia
di rilo o arenlelica, e che Gerione, iI moslro che aIIegorizza si sa
Ia Irode, con seciaIe riferimenlo aII'Iocrisia, non e dislraibiIe daI
ianela Usura.
Non dovrebbe esserci difficoIla ad ammellere che, di frode e di
iocrisia ubbIica, Danle fece eserienza ben reslo, fin daIIe rime
assunzioni deI ccnunc incarcc in Iirenze: aIadino deI vero, deIIa giu-
slizia e deIIa Iiberla quaIe inlendeva essere, e quaI era nei falli,
checche ne diffondano vecchi e nuovi uIili, semre disosli (e non
semre er ura incomelenza) a disgiungere Ia grandezza deI oela
1 Cfr. MARIO AVIRSANO, Oanic crisiianc. Ia sc|ta, |ranccsca, U|issc, c |a siruiiura
!c|||njcrnc, Roma, iI CaIamaio 1994, . 5 sgg., e passin.
Mario Aversano 660
daI rofiIo deII'uomo e deII'inleIIelluaIe. Irode e iocrisia, e invidia,
egIi al in crescendo, a mano a mano che iI suo resligio di oralore
imegnalo nei consigIi cilladini monlava, neII'agilala lemerie a ca-
vaIIo lra iI XIII e iI XIV secoIo. II che ci avvia a comrendere come, una
voIla raggiunlo da faIse accuse e coslrello a arlirsi (Par. XVII, 46-
48), cioe a dividersi, slaccarsi daI Iuogo nalio, e erdule Ie seranze
d'un rienlro acifico in alria, I'cxu| inncriius assi dai lrallali aIIa
oesia, e non veda I'ora di menar coIi !ctc |a rcgna, sveIando Ia fac-
cia crudeIe, vioIenla o farisaica, deIIe cuidigie che gIi hanno fallo
guerra.
I buoni commenlalori non a lorlo invilano a riconoscere neI milo-
Iogico Gerione lrasformalo in jicra (di serenle-scorione-Ieone e
d'aIlro ancora di besliaIe e iI suo coro) una ioslasi di Lucifero, ma
non arrivano a ensare, a mia nolizia, che Danle ci figurasse una razza
reciua di individui. QueIIa dei suoi nemici, a cominciare dai iu
direlli e iu olenli: aa onifazio (iI drago daIIa coda na|igna di
Purg. XXXII, 130-135), e iI suo emissario a Iirenze, CarIo di VaIois (iI
noveIIo Giuda che, come si Iegge a Purg. XX, 73-75, ha fallo sccppiar |a
pancia aIIa cilla). A quesle equazioni Lucifero-Gerione onifazio-
CarIo di Irancia uo far cao iI rimo eIemenlo cerlo da cogIiere e
da vaIulare er ogni aroccio resonsabiIe aI canlo: iI fallo che,
comoslo com'e I'|njcrnc di 34 unila, Ia noslra, in quanlo diciasselle-
sima, ne forma iI cenlro malemalico, e da ognuno e ammesso iI vaIore
che Danle allribuisce a laIi sedi demarcalive. I una cenlraIila che con
evidenza I'Aulore e chiamalo a geslire in senso aerlo, a coinvoIgere
non soIo iI rima e iI oi deIIa Canlica, lirando e riIanciandone Ie
somme, ma anche iI macrocosmo deII'inlero Ioema, e che rende ra-
gione anche di un aIlro dalo slalislico, in genere non disalleso, ma oi
non curalo quanlo merila: Io sazio slraordinario che Gerione occua
neIIa slrullura deIIa Ccnnc!ia. I evidenle si Iegge in |nc. !ani., III,
su| tccc (redalla da I. SaIsano) I'imegno deI oela nei confronli
deII'inconlro e deI ersonaggio, oiche vi sende lanle lerzine (|nj.
XVI, 94-136, XVII, 1-27 e 79-136) quanle di soIilo occorrono er un in-
lero canlo. Iresa d'allo a cui vanno addizionale aIlre concomilanze,
non meno significalive. Queslo sazio che imegna due canli er
rima cosa va oslo in reIazione con I'aIlrellaIe dei corrisondenli deI
Purgaicric e deI Para!isc, sui quaIi gella Iume in queIIa slessa che ne
riceve. A quesle sei unila simmelriche Danle aulore conferisce iI rivi-
Iegio deI mezzo neIIe Canliche con un chiaro obiellivo: deorvi iI
messaggio a cui liene di iu, e che cosliluisce Ia ragione cailaIe deIIa
Ccnnc!ia. Issa e ensala e scrilla, non ci slancheremo di rocIamarIo,
come un quinlo vangeIo, iI vangeIo deIIa Iace. Non e un caso che aI
|| canic XV|| !c||Inferno 661
suo conlrario, Ia guerra, vediamo associalo Gerione fin daIIa sequenza
iniziaIe deI canlo, che fa da reIudio in risello di una sceIla di oe-
lica che lroviamo osservala er ciascuno dei cenlo incipii deI Ioema
aIIa sua lemalica orlanle, e che vi sarga aroIe e immagini beIIi-
che erenlorie e vislose: dai nuri e daIIe arni di v. 2, aI |itcrc che
sassciia a jar sua gucrra di v. 22, aIIo arnata di v. 27, aI sanguc di v. 62,
aI cata|icr di v. 72, aI finaIe diIeguarsi deI moslro ccnc !a ccr!a cccca (v.
136). Gerione e I'avversario iu grande e insidioso di chi Iavora er
I'edificazione deIIa ace lra gIi uomini: che Danle riliene non uloica,
come e in quanlo rifIesso ed arra di queIIa ceIesle. A reaIizzarIa e
chiamala Ia oIilica, che er Iui si esrime a ben Ieggerne I'oera
non in due, ma in lre auicriia!i: non soIo I'inpcriun e iI saccr!ciiun, ma
anche Ia sapicniia, queIIa in cui si invera Ia fiIosofia, come si Iegge neI
quarlo Iibro deI Ccntitic. Issa e dono ceIesle in quanlo ingcgnc e scn-
nc, ma anche inleIIelluaIila e saere che si raggiungono con Io siu!ic
(Ccnt. IV, VI, 17-19), ed e indisensabiIe nei consorzi civiIi affinche si
viva ccn pacc e in roserila. Iiu recisamenle essa lrova esressione
neI ben fare neIIa cosa ubbIica, concrelizzandosi neI ruoIo deI Ccn-
si|iun. La ace, in aIlri lermini, diende daIIa saienza e daII'amore
deIIa giuslizia di chi governa, e di chi a |aic gIi sic!c pcr ccnsig|ic (Ccnt.
IV, VI, 20). DaIIa bonla deI ConsigIiere diende iI feIice corso deIIa
natc !c |unana ccnpagnia, che non olra giungere in orlo senza Ie
veIe deIIe virlu eliche e leoIogaIi, e senza Ia cura e Ia sele deIIa verila.
II Vero ha iI suo nemico rorio neIIa frode, neIIa menzogna, Ia cui
alernila Danle ascrive a Lucifero, e non a caso neI conleslo narralivo
degIi Iocrili (|nj. XXIII, 142-144): e iI duaIismo che ha sceIlo er
inlrodurre Gerione, aIIa chiusa deI canlo XVI. Non vedo aIlra siega-
zione IausibiIe deI deciso quanlo inoinalo inserlo deI tcr cnna jaccia
!i ncnzcgna (v. 124), a quesla scadenza che comunica e non e !cncr
pccc argcncnic anche iI liloIo deII'Oera, Ccnc!ia. Senza Ia verila
soravanzano I'ira e Ia guerra: con I'immancabiIe effello degIi odi,
deIIe ersecuzioni e deIIe condanne inique. La genle smelle di guar-
darsi con amicizia (Purg. VI, 115), si fa cieca e lrascorre aIIe lenzoni,
con sbocco falaIe neI sangue (|nj. VI, 64-65): vien meno Ia concordia, e
con essa iI bene suremo deIIa Iace. Cose, lulle quesle, che ho gia
segnaIalo lrovano uno slreiloso rieiIogo nei ceIebri affreschi deI
Governo di Ambrogio Lorenzelli a Siena, che aI risconlro aaiono
inleramenle danleschi neI fondamenlo concelluaIe e neIIe immagini
(vedi in quesla ubbIicazione iI mio Oanic c i| suc riiraiic nc||a Sa|a !c||a
Pacc !i A. Icrcnzciii).
Ora lulli sanno come iI XVI e XVII deI Purgaicric, canli deII'Ira (iI
vizio cailaIe che imedisce di oerare con giuslizia) cosliluiscano iI
Mario Aversano 662
cenlro deIIa Canlica, ma anche deII'inlero Ioema. II che obbIiga a
chiedersi: che ufficio mai riveslirono in lerra i ersonaggi che vi han-
no camo, Marco Lombardo su lulli (XVI), ma oi Mardoceo, Acab e
Amala (XVII)` AIIa verifica si score che furono dei ConsigIieri.
Quanlo ai canli corrisellivi deI Para!isc, non aIlro essi ci roongono
che iI anorama deIIa buona Iirenze anlica da una arle, e daII'aIlra Ia
sua gcnic nucta, che non arIando nai tcrc, er dirIa coI runello
Lalini deIIa |ciicrica ha generalo confusioni, conlese e confIilli civiIi,
e conseguenlemenle condanne ed esiIi ingiusli. QueIIo deI oela e
voIulo e cercalo, si rammenli, da aa onifazio (Par. XVII, 49-
51). I dei lanli veri deI Ioema (un quaniun quasi da ossessione: er
cui c'e da sluirsi che non grande sia slala Ia venlura crilica deI lema),
queIIi aulobiografici disseminali neI erimelro di queslo ceIebre can-
lo di Cacciaguida sono i iu sofferli, e ercio i iu soIenni e vibrali,
daI rimo che scomoda C|incnc, aI c|cu che se ne regislra aI v. 54:
.ma Ia vendella / fia leslimonio aI tcr che Ia disensa. Comunque
si vogIia inlendere Ia reIaliva che Io accomagna, queslo vero ha deI
sacraIe e quasi iI lono d'un suggc| cncgni ucnc sganni.
Slo rocedendo er sommi cai (occorrerebbe iu che un arlicoIo
er una disserlazione comiula), e da chi ci Iegge olra essere recIa-
malo un maggior conlo deI oc'anzi esoslo araIIeIismo consiIiare:
dov'e iI ConsigIio (con iI lanlo che, s'e vedulo, Ia aroIa allrae) neI
XVI deII'|njcrnc, e dove neI noslro XVII` Cominceremo indirizzando a
un lermine chiave che e imianlalo a |nj. XVI, 59: a queII'cpra che iI
oela afferma di aver rilrallo e ascoIlalo ogni voIla con affezione,
e che e revenlivamenle convaIidala daIIo slesso VirgiIio. Issa riferi-
la com'e a lre fiorenlini anlichi, e di rifIesso ad aIlri cncraii ncni, di
Guido Guerra e deIIa |ucna Gua|!ra!a non olra serare in una gIos-
sa convincenle ove non Ia si faccia coincidere coI ben fare neI citi|
ncgczic. I I'azione consiIiare quaIe fu roria di quesli esonenli deIIa
vecchia generazione che suscila neI oela dacche fu vaIorosa e
assennala iI desiderio di abbracciarIi. C'e neIIe sue non oche
frasi eIogialive Ia graliludine-riconoscenza deII'aIunno, er I'inse-
gnamenlo elico-oIilico che da essi ha reso, e che vuoI essere acco-
slalo senza esilazioni a queIIo di ser runello (|nj. XV, 85).
Ma cos e dalo anche di fare un aIlro asso avanli. Se qui ricorre iI
nome di Gua|!ra!a, e aggellivalo in |cnc, e erche queslo allribulo
neIIa Ccnnc!ia cade generaImenle in sinonimia con Ia quaIifica
di coslrullore di ace, e oi affinche I'oera deII'ava di Guido
Guerra, coI suo riecheggiare neI XVI deII'|njcrnc, faccia da pcn!ani, in
corrisondenza di coIIocazione, a queIIa di un'aIlra e ben diversa
GuaIdrada: Ia Donali deI XVI deI Para!isc. Di Iei Danle menziona
|| canic XV|| !c||Inferno 663
I'agire, ma non iI nome: iI siIenzio che di regoIa riserva aIIe ersone
indegne, e iI maI fare di quesla donna e consislilo rorio neI maI
consigIiare. I suoi ccnjcrii, infalli, furono esiziaIi erche rovocarono
I'insorgere deIIe Iolle civiIi in Iirenze, e Ia fine deIIa sua ace (Par.
XVI, 140-141). Ordinale cos Ie carle, non credo sia dubilabiIe che
neII'aIlro canlo dirimellaio, iI XVI deI Purgaicric, a beIIa osla com-
aiano (grazie a un rilagIio che e aarso curioso, ma che laIe non e:
lanlo si scorge bene, adesso, iI caIcoIo comosilivo), iI |ucn Gncrar!c e
Ia jig|ia Gaia (vv. 138-140).
I iI ConsigIio neI canlo XVII deII'|njcrnc, loccaloci in Iellura` Dov'e
mai in esso ci si chiedera I'uomo oIilico, iI coIIega di queIIi che
abbiamo aena indicali` Oera di riconciIiazione lra Ie arli avverse
aveva I'obbIigo di svoIgere, inlanlo, iI Viia|ianc dei vv. 67-68, erche fu
odesla a Iadova neI 1307: carica noloriamenle conferila, Io dice Dan-
le slesso, er conservar Ia ace d'una comunila (|nj. XXIII, 107), e
non er darsi aII'usura. I debbono assare er vocali in consigIi anche
gIi aIlri usurai che giacciono neI lerzo girone deI sellimo cerchio sollo
iI fuoco: erche c'e da orre in raorlo di anlilesi I'aric misla di vio-
Ienza e fraudoIenza degIi Usurai, con I'oera dei ConsigIieri, con Ia
Ioro arle acificalrice
2
, oIlre che con I'arle (si caisce, e Io si vedra)
come Iavoro umano in genere. Ma iu ancora inlriga un'aIlra rosel-
liva, in quanlo riorla aIIa gia nominala aulobiografia oIilica. In
roosilo giova essere ancora una voIla immediali: iI sosellabiIe di
ConsigIio in queslo canlo e da cercare in Danle medesimo, che cerlo
avra ianificalo di roagandarsi con una sua ersonaIe cenlraIila
neII'|njcrnc. Come vialore, infalli, egIi si aIIinea con quanli neI Ioe-
ma, dannali o saIvi, hanno svoIlo quesl'ufficio, da inlermediari acifi-
cisli o da guerrafondai: come sono i liranni di Romagna, sinlomalica-
menle cilali in lemerie di faIso consigIio, e in una coI onifazio deIIa
guerra conlro IaIeslrina. A fare i conli, ConsigIieri sono lulli i erso-
naggi di riIievo che egIi inconlra e con i quaIi diaIoga: da Ciacco a
Iarinala, a Iier deIIa Vigna, a runello Lalini, a UIisse, a Guido da
MonlefeIlro, a eIlrando daI ornio, a SordeIIo, a Saia, a Romeo di
ViIIanova, lacendo dei gia menzionali, e massime di Marco Lombar-
do, iI iu cenlraIe, che asso Ia vila ce Io riferiscono i rimi commen-
lalori a dirimere conlese, a slringere alli (anche malrimoniaIi, come
iI suo amico Romeo), er conservare o rislabiIire Ia ace. I con laIe
rofessione, ricordiamoIo, che Danle si rocuro da vivere. Consi-
gIiere egIi fu semre, rima a Iirenze, oi neIIe corli dove lrovo asiIo,
2 Si ricordi I'aric infeIicemenle falla da GueIfi e GhibeIIini (Par. VI, 103), lanlo
derecala da Giusliniano, e conlraosla, in imIicilo ma innegabiImenle, aI ben fare
deI giusic Romeo di ViIIanova.
Mario Aversano 664
a cominciare da queIIa dei MaIasina, che egIi acifico (ce ne resla
documenlo scrillo deI 1306) coI Vescovo di Luni, e fino aIIa morle,
avvenula in seguilo a un'ambasceria di mediazione lra i Da IoIenla di
Ravenna e Venezia.
Ma quesla arenleIa consiIiare si Iascia oi cogIiere aI megIio
quando si secifica in un senso aggiunlo, che e coerlo, ma non ercio
meno eccezionaIe. II oela venliIa Ia nolizia che Ia Irovvidenza Io ha
sceIlo siccome ha a che fare, er iI ramo lemoraIe, con Inea e coi
buoni Romani (|nj. XV, 73-78), ma Iascia oi inlendere deII'aIlro: che
arimenli iIIuslre e anche Ia sua rogenilura crisliana, erche egIi
ha una radice in IaoIo, iI tas !c|czicnc che due voIle neIIe sue Lellere
(|n. XI, 1 e Pn. III, 5) si dichiara aarlenenle aI scncn di Abramo, di
Davide e di eniamin, iI figIio minore di Giacobbe. Ne consegue
un'aIlra e iu Iusinghiera discendenza: daIIa slessa Vergine Maria.
NeI Ioema Ie equazioni Danle-Davide e Danle-eniamin sono s veIa-
le, ma conlinue
3
! quesl'uIlima secie nei canli di Cacciaguida. I a
riguardo Ia verifica slrulluraIe risuIla robanle: aII'enlrala neI cieIo di
Mercurio, che e queIIo degIi Sirili allivi er iI conseguimenlo deIIa
gIoria lerrena, coI resuoslo nei fini deIIa giuslizia e deIIa ace (se-
gnalamenle in oIilica, e in aura di ConsigIio: iI che fa megIio caire iI
binomio Danle-Romeo di ViIIanova), I'Aulore resenla un Giuslinia-
no che aoslrofa I'aIIievo di ealrice con un O |cnc naic che e lanlo
imrovviso quanlo inequivocabiIe, e con iI non meno lemeslivo ro-
cIama che egIi e oggello di grazia (Par. V, 115-117). Quesla aroIa
rinvia, come e nolo, aI roIogo deI viaggio, aIIe lre |cnc!ciic (aIlro
vocaboIo indicalivo) che curano deI pcrcgrinus neIIa corle deI CieIo,
ma iu in arlicoIare a Maria Vergine, Ia donna genliIe che Io ha ro-
mosso: e oi coslanlemenle neI Ioema aIIa sua grandezza e aI suo
vaIore. Senza una laIe crealura ed anche si sa ogni disianza
tuc| tc|ar sanza|i (Par. XXXIII, 13 sgg.), lanlo e vero che Io slesso er-
nardo, sirilo dei iu aIloIocali neI Iaradiso, a Iei si rivoIge (e non a
Dio direllamenle) er imelrare grazie aI venulo daIIa lerra. Lo con-
ferma iI seguilo, neIIa sua reghiera, d'un vocaboIo, |cnigniia, che
semre e iu aerlamenle ancora di benedello riaggancia, in-
sieme aII'aggellivo |cnignc, iI nome di eniamin. I qui vorrei di nuovo
ricordare che Ia Ccnnc!ia, in quanlo oema deIIa Iace, e anche
oema mariano, daI rimo verso (iI rilrovarsi neIIa sc|ta cscura e
grazia e riconciIiazione con Dio ollenula er inlervenlo deIIa Madre)
aII'uIlimo, che ceIebra Ia villoria finaIe di Lei concedenle aI morlaIe di
vedere I'effige deI IigIio, coIui che coI suo marlirio (deciso neI ccnsi-
3 Cfr. AVIRSANO, Oanic !accapc, AlriaIda, WM Grou 2000, . 24-31, e passin.
|| canic XV|| !c||Inferno 665
sicric !c |a Triniia!c) rislabiI Ia ccnccr!ia lra cieIo e lerra (Ct. IV, V, 4).
Ccnsisicric e ccnccr!ia: si rifIella su quesli lermini, coi quaIi viene a
oIilicizzarsi anche Ia iu aIla leoIogia.
I arrivo aI dunque. II XVII deII'|njcrnc disiega Ia sua cenlraIila
lulla aulobiografica neII'accezione oIilico-consiIiare, e ercio slesso
mariana er ecceIIenza, fin daIIa rima lerzina. Lo allesla un dalo as-
soIulamenle indicalivo neIIa sua unicila. SoIo iI noslro canlo, in lulla
Ia Ccnnc!ia, comincia con |ccc:
|ccc Ia fiera con Ia coda aguzza,
che assa i monli, e rome i muri e I'armi,
cccc coIei che lullo 'I mondo auzza!
Di queslo Iemma Ia crilica non ha mancalo di solloIineare Ia
rovenienza bibIica, ma non s'e accorla, ch'io saia, o non ha dalo
eso a laIe riviIegio d'imiego, e si e Iasciala sfuggire Ia sua riIevan-
za: esso imIica forzosamenle Ia Madonna. Lo dimoslrano falli
diegelici inequivocabiIi: che un oco a conoscere Ia Iogica inlrale-
sluaIe dominanle neIIa Ccnnc!ia dovevamo asellarci. Maria,
infalli, inlerviene lulle Ie voIle che iI cammino neII'AIdiIa resenla un
assaggio a rischio. I in roosilo noleremo che iI assare, in
queslo canlo a verso 2 (e neI senso rorio, non di lraforare), e
conlinuo neI sislema lemalico riguardanle iI viaggio: aII'Acheronle
(|nj. III, 92 e 117), aIIo Slige (|nj. VII, 21), aI IIegelonle (|nj. XII, 139),
aIIa zona dei Tradilori (|nj. XXXII, 19), ad ogni svoIla ilineraIe che o-
one difficoIla da suerare, e iI Iemma ecco Io slesso deI VangeIo
di Luca (II, 48) manifeslanle Ia virlu conlraria aII'ira, Ia mansueludine,
e ercio aunlo lrasIalo in Purg. XV, 91 fa iu voIle da segnaIe
deIIa resenza luleIare deIIa Madre, lemeslivo come iI oela Io
convoca quando c'e aroIa di adiulori o di forze imedienli. Si
va daII'cccc di |nj. I, 31, rima ricorrenza neI Ioema, che riguarda
I'imedimenlo deIIe lre fiere, aI successivo cccc di |nj. III, 8, che
annunzia I'oslacoIo di Carcn !incnic
4
(a cui non senza revisione
slrulluraIe fa da conlrario un aIlro nocchiero, I'Angc| !i Oic, rooslo
con lriIice ecco in Purg. II, 13, 29, 119), agIi ecco aena cilali che
aIIerlano iI eIIegrino er I'avvenlo di Gerione, iI moslro iu ericoIo-
so, er via deIIa sua coIIeganza con Lucifero. La quaIe, non sfugga, e
slabiIila medianle un'aIlra ecuIiarila slalislica: soIo er Gerione e er
Lucifero Io |ccc ricorre due voIle di seguilo. Cos, infalli, a |nj. XXXIV,
19-21:
4 Cfr. AVIRSANO, Oanic sccncsciuic. Carcn !incnic ira prcgiu!izi c |ucgni ccnuni,
L'areoago Iellerario, XXV, 2009, . 9-11.
Mario Aversano 666
|ccc Dile, dicendo, ed cccc iI Ioco
ove convien che di forlezza l'armi.
I cos iI gioco dei conlalli e deIIe corrisondenze e ribadilo ed esle-
so: er iI di iu che e comorlalo daI soslanlivo jcriczza, e er iI lema
che esso veicoIa. Anche quesla voIla e referibiIe rocedere in modo
schemalico: 1) qui, davanli a Lucifero, VirgiIio ingiunge aI suo disce-
oIo di armarsi: non uo lrallarsi di un generico coraggio, che
sarebbe fin banaIe, dobbiamo ensare a quaIcosa di iu secifico,
di nalura anche elica, 2) Ia slessa cosa caila aI cosello di Gerione:
'Or sie jcric e ardilo' (|nj. XVII, 81), 3) in nessun aIlro cailoIo deI
Ioema si regislra er ben lre voIle iI forle come aggellivo, 4) jcrii
neII'|njcrnc ricorre soIo qui, neI senso maIo, e er designare Gerione
(v. 42), 5) e ercio d'obbIigo cogIiere Ia resenza, ora che siamo neIIa
zona cenlraIe deIIa Canlica, deIIa |criczza in quanlo virlu cardinaIe.
A queslo unlo iI crilico coscienzioso non olra esimersi da un
accerlamenlo: come si molivi Ia cosliluzione d'un laIe inlraleslo im-
ernialo suIIa Iorlezza. Noi lroviamo che non uo esserci aIlra
risosla, doo quanlo s'e fin qui dedollo, che Ia seguenle: c'enlra di
nuovo Ia Madonna, e con Iei Ia slire dei beniamini, e ercio
slesso c'enlra Danle in queI che aarliene a queslo novero di eIelli
ed e uomo di buon ConsigIio. Ier essere brevi, orremo subilo
un'aIlra equazione: neIIa Ccnnc!ia forlezza-franchezza-ardimenlo
equivaIgono in sinlesi, come dire, subIimala a un'aIlra aroIa che
vedo oco allesa, ma che er Ia cruciaIila dei Iuoghi dove ricorre esige
un inlervenlo chiarificalore, eIusa o maIlrallala come Ia lroviamo
neIIa generaIila dei Commenli. AIIudo aI soslanlivo baIdezza (con
I'aggellivo baIdo). Ma andiamoci muovendo dai rimi lermini
deII'equazione. La lriade aena evinla deIIa Iorlezza indica requisili
che VirgiIio osluIa come irrinunciabiIi affinche siano vinle Ie resi-
slenze degIi avversari demoniaci e Ie aserila dei Iuoghi uIlralerreni, e
che ercio agIi eIelli vengono richiesli e relesi senza deroghe. Danle
e avverlilo di doverIi rilrovare, e dovra anche esercilarIi er lullo iI
suo jaia|c an!arc, fino aIIa visione deI Iadre. A soslenerne Ia Iuce, non
assi inosservalo, egIi deve farsi iu ar!iic (Par. XXXIII, 79-81). I
queslo grazie a Maria, che Io soccorre in quanlo e fogIia deI suo aIbe-
ro, dei beniamini-benedelli. Si deve risaIire a |nj. II, 123-125 (erche
ar!irc c jrancnczza non hai / oscia che lai lre donne |cnc!ciic / curan di
le ne Ia corle deI cieIo.), e a |nj. II, 13-132 (e lanlo |ucnc ar!irc aI cor
mi corse, / ch'io cominciai come ersona jranca.), lornare aIIa cilala
forlezza di queslo canlo, rocedere fino a |nj. XXIV, 60, zona, si ba-
di, degIi Iocrili (e disse: 'Va, ch'i' son jcric c! ar!iic), er giungere
|| canic XV|| !c||Inferno 667
a queIIa, ure della, che e richiesla er iI sueramenlo di Lucifero, e
oi aIIa forza deII'animo che iI eIIegrino ha maluralo, se uo dichia-
rarsi |cn iciragcnc ai cc|pi !i tcniura (Par. XVII, 24). Di qui, doo quesla
escursione, iI saIlo quaIilalivo: aIIa rima baIdezza che e affacciala a
Par. XV, 67 (Ia voce lua sicura, |a|!a e Iiela), e a queIIa di Par. XVI, 17
('Voi siele iI adre mio, / voi mi dale a arIar lulla |a|!czza). Issa e-
merge come una sorla di coronamenlo deIIa Iorlezza, in quanlo e lo-
laIe e soIIeva iI eIIegrino aI di sora di se slesso: 'Voi mi Ievale s,
ch'i' son iu ch'io' (Par. XVI, 18). AIIora di quesla immissione deIIa
baIdezza nei canli di Cacciaguida, Iegala aIIa lemalica deI sangue
recenle e Ionlana, non sara da meravigIiarsi: cos come deIIa nomina-
zione di Maria rolellrice deI arlo deIIa madre deI lrisavoIo, donde
con iu evidenza egIi esce inserilo neIIa Iisla dei beniamini: 'Maria
mi die, chiamala in aIle grida' (Par. XV, 33). Segmenlo mariano, que-
slo, che non ci vuoIe moIla falica a congiungere con queIIo deIIa |cnc-
!ciia che s'incinse neI oela e che e garanle deIIa sua a|na: definila s!c-
gncsa, vaIe a dire rorio come I'hanno lulli gIi uomini di ConsigIio
iscrilli neI Ioema
5
.
Ma Ia baIdezza, che finora aIIo sogIio e aarsa aIIogala soIo nei
canli di Cacciaguida, si fa schedare concIusivamenle a Par. XXXII, 109,
in un lerrilorio che di iu rossimi aIIa Vergine non ce n'e: aI sommo
deII'Imireo, Ia dove Ia beIIa crealura deII'Annunciazione, GabrieIe,
canla I'Atc Maria. Danle chiede a ernardo, I'uIlima sua guida:
.quaI e queII'AngeI, che con lanlo gioco / guarda ne Ii occhi Ia no-
slra regina, / innamoralo s che ar di foco`. I ernardo, neI rison-
dergIi, comincia rorio con quesla aroIa, che aIIora non uo non es-
sere considerala dimoslraliva: Ba|!czza e Ieggiadria.. Issa orla a
riconoscere un oslo neIIa geneaIogia deIIa Madonna anche aI iu
Ieggiadro dei Serafini, sceIlo da Dio er recarIe I'annunzio deIIa ver-
ginila feconda: erche Ia |a|!czza, e non aIlra virlu, Danle one come
dislinlivo maggiore deIIa jcnnina deslinala ad essere cancra !c| |i-
g|iuc|c !i Oic. II asso che Ia enuncia va riorlalo senza lagIi, denso
com'e anche di aIlri maleriaIi erlinenli:
VoIendo Ia inmisurabiIe bonla divina I'umana crealura a se
riconformare, che er Io eccalo de Ia revaricazione deI rimo
uomo da Dio era arlila e disformala, eIello fu, in queIIo
aIlissimo e congiunlissimo consislorio de Ia Trinilade, che 'I fi-
gIiuoIo di Dio in lerra discendesse a fare quesla concordia. I
ero che, ne Ia sua venula, Io mondo (non soIamenle Io cieIo,
5 Cfr. AVIRSANO, Brunciic Iaiini s|rigaiitc? Maccnc, in Agire, 18 IugIio 2004, . 8.
Mario Aversano 668
ma Ia lerra) convenia essere in ollima disosizione e Ia ollima
disosizione de Ia lerra si ha quando eIIa e monarchia, cioe lul-
la ad un rincie, come dello e di sora , ordinalo fu er Io di-
vino rovvedimenlo queIIo ooIo e queIIa cillade che cio do-
vea comiere, cioe Ia gIoriosa Roma. I ero che anche I'aIbergo,
dove iI ceIesliaIe rege inlrare dovea, convenia essere mondissi-
mo e urissimo, ordinala fu una rogenie sanlissima, de Ia qua-
Ie, doo moIli merili, nascesse una femmina ollima di lulle I'aI-
lre, Ia quaIe fosse camera deI IigIiuoIo di Dio: e quesla rogenie
e queIIa di David daI quaI nascelle Ia |a|!czza e I'onore de I'u-
mana generazione, cioe Maria. I ero e scrillo in Isaia: Nasce-
ra virga de Ia radice di Iesse, e fiore de Ia sua radice saIira, e
Iesse fu adre deI soradello David. I lullo queslo fu in un
lemoraIe che David nacque e nacque Roma, cioe che Inea ven-
ne di Troia in IlaIia, che fu origine de Ia cillade romana, si come
leslimoniano Ie scrillure. Ier che assai e manifeslo Ia divina eIe-
zione deI romano imerio er Io nascimenlo de Ia sanla cillade,
che fu conlemoraneo a Ia radice de Ia rogenie di Maria.
(Ct. IV, V, 3-7)
Id e lemo di dire che iI fiIo mariano ci orla ad un aIlro eIemenlo
affermalivo deIIa cenlraIila di Danle consigIiere, neI raorlo anlileli-
co con Gerione da cui Ia resenle Iellura ha reso inizio. Ier renderIo
anche iu manifeslo I'Aulore ci consegna un sinlagma con evidenza
miralo, che aI conlroIIo risuIla essere un apax sia neI canlo, sia neIIa
fonle da cui roviene, Ia ibbia. Mi riferisco aI jcra pcssina che quaIifi-
ca Ia beslia moslruosa aI v. 23. Isso lrova faciImenle oslo neIIa
memoria di chi aderisce con assione aIIe agine deI Gcncsi in cui e
racconlala Ia sloria di Giusee figIio di Giacobbe, anche erche iI
sinlagma vi e dello e rielulo: jcra pcssina devoravil eum (Gcn.
XXXVII, 20), jcra pcssina comedil eum (Gcn. XXXVII, 33). Giusee
dicono i suoi fraleIIi, menlendo e slalo divoralo daIIa eggiore deIIe
fiere. Ier comrendere iI caIco danlesco, che sarebbe ingeneroso rile-
nere forluilo, e sufficienle vedere come negIi scrilli dei Iadri e dei
Dollori, e neIIa Ielleralura civiIe deI Medioevo, iI bibIico Giusee
affezionalissimo, ognuno Io ricorda, aI minore e iu innocenle dei suoi
fraleIIi, eniamino assurga ben reslo a rololio deI buon minislro,
er Ia saggezza dei suoi moIli consigIi in lerra d'Igillo: in una, er iI
suo fare voIlo semre aI benessere e aIIa ace lra Ie genli. Si uo
andare, er un es., aI Oc rcgininc principun di san Tommaso (IV, XIII),
o anche aI Ii|cr a! ncncrcn Augusii di Iielro da IboIi, iI quaIe fa dire a
un anlisvevo oIilicamenle imegnalo, I'Arcivescovo di SaIerno:
|| canic XV|| !c||Inferno 669
}oseh nunc vobis pacijcr aIler ero (v. 1158)
6
. Divenla faciIe e dove-
rosa, aIIora, I'assimiIazione di Danle ersonaggio beniamino chia-
malo aIIa rova deIIa ferinila essima di Gerione aI Giusee deI
Gcncsi" Danle buon consigIiere come Giusee: un a|icr |cscpn acifica-
lore. I suI ericoIo di vila che comorla Ia visla di Gerione e iI voIo
suIIa sua groa non dovrebbero sorgere dubbi, anche se iI lema non
semre o non recisamenle e enucIealo dai Iellori deI canlo. Viene
osla in gioco, occorre solloIinearIo, Ia saIvezza deI viaggialore, che
sla I I er erdere Ia Iorlezza ed essere vinlo daIIa paura (|nj. XVII,
85-88 e 106), non si badi iI saIvifico iincr Oci, che genera Ia conver-
sione, Ia comunzione deI cuore (|nj. I, 15), ma Ia paura na|a, queIIa
che conduce aIIo sladio deIIa coscienza iu rossimo aIIa ncric: Ia di-
serazione. I I'effello che roduce Ia lerza fiera, Ia Iua (|nj. I, 54),
ercio definila Ia |csiia sanza pacc. Ne fanno avverlenza, deI reslo, Ie
aroIe definilive di VirgiIio, inequivocabiIi: Ricordali, ricordali. e se
io / soresso Gerion li guidai sa|tc. (Purg. XXVII, 22-23).
Ma debbo acceIerare: e vado aII'esame deI XVII deII'|njcrnc neIIo
secifico deII'usura, con un'idea che oso dire, e m'avvio a dimoslrar-
Io Io discore come iI canlo che I'Aulore ha ensalo e reso in lermini
s di concIusione, ma anche di ricailoIazione di quanlo in maleria ha
gia esoslo, a cominciare daI rimo ordinamenlo deIIa VioIenza, che
risaIe vedremo aII'ingresso neIIa cilla di Dile. Ho accennalo in
remessa a regiudizi che oslacoIano Ia corrella inleIIigenza deI leslo.
I lra i iu incredibiIi va censilo queIIo che riguarda Ia disosizione
danlesca verso Ia ralica deII'usura. L'argomenlo e da lulli riconosciu-
lo di queIIi difficiIi, ma oi cosa slrana non Io si reula degno di
seciaIi riguardi e faliche criliche: lanl'e che Ia bibIiografia di merilo
ancora non va oIlre un modeslo numero di inlervenli, e cerlo non
comele con queIIe slrabocchevoIi che si vedono er lanle zone deI
Ioema. DuoIe, lra I'aIlro, che finanche i suoi Iellori iu avveduli non
abbiano quesla voIla ne comreso ne arezzalo I'inleIIello e iI cuore
di Danle. Tra Ie idee inaccogIibiIi che lullora circoIano, due sono
arlicoIarmenle inesalle, ed offendono I'uomo, iI cilladino e I'inleI-
IelluaIe, oIlre che iI oela: che gIi Usurai abbiano ricevulo neIIa
Ccnnc!ia ben oca udienza, uno sazio irrisorio risello aIIa gravila
deI fenomeno, e che I'Aulore, er giunla, non versi una Iacrima sui
danni che I'usura rovoca
7
" Ma Ia ricerca, se falla con azienza, orla
6 Cfr. AVIRSANO, Picirc !a ||c|i. un nacsirc, ancnc pcr Oanic, in AA. VV., ||c|i.
Pa|ccsccnicc pc!agcgicc c tccc !i!aiiica, a cura di Anna Rila CarrafieIIo e Vincenzo Di
Gerardo, IboIi, I CircoIo Didallico 2005, . 23-88.
7 Cos in GIORGIO IADOAN, || canic XV|| !c|||njcrnc, in Icciura Oaniis Ncapc|iiana,
I, NaoIi, Loffredo 1986, . 286.
Mario Aversano 670
a risuIlali che consenlono di affermare, invece, iI conlrario: mai oela,
fiIosofo, credenle ha vislo con aIlrellaIe chiarezza e senlilo con mag-
gior doIore Ie conseguenze deII'usura su ogni forma deII'umano
consorzio, daIIa famigIia, aIIa cilla e via via fino aIIe organizzazioni
slalaIi iu grandi: coI che viene ad essere imIicala, insieme aII'elica,
Ia oIilica icui ccuri.
SuIIa rima Iagnanza un insufficienle imegno quanlilalivo
neIIa lrallazione deII'usura (si e finanche suoslo che Danle I'abbia
rimossa) Ia reaIla deIIe cose viene reslo a gaIIa quando si riveda-
no i comuli che di soIilo vengono eseguili, e si guardi megIio aIIa
IelleraIila dei canli che I'Aulore dedica aIIa VioIenza: enlro iI cui ambi-
lo remelliamoIo I'usura vuoI essere in rima islanza ricondolla.
Si afferma a lorlo da moIli che Danle, doo I'esosizione deI lema
neII'XI deII'|njcrnc, non ne arIi iu, e se ne ricordi oi soIo neI canlo
XVII, e che I'eisodio debba rilenersi secondario, e come una aren-
lesi neI racconlo deI viaggio oIlremondano, eraIlro inallesa
8
: un
inlermezzo deII'eisodio di Gerione
9
. Ma da uno sogIio iu accor-
lo si deduce una siluazione moIlo diversa, che e cos riferibiIe:
1) inlroducendo I'usura neI canlo XI, I'Aulore non si Iimila ai versi 28-
33 (in cui Ia discrimina lra Ie forme generaIi deIIa VioIenza unila neI
seslo e neI sellimo cerchio)
10
e ai versi 46-51 (dove Ia sislema in queIIe
arlicoIari deI lerzo girone),
2) egIi rende I'usura anche oggello di una siegazione che Danle er-
sonaggio chiede aI suo maeslro (vv. 91-96),
3) laIe domanda non soIo e avanzala neIIa arle finaIe deI canlo (che
insieme aII'inizio, si sa, ne cosliluisce Ia sede iu rimarchevoIe), ma e
anche |unica davvero secifica che I'Aulore seIeziona riguardo a lulle
Ie coIe deII'|njcrnc,
4) Ia risosla di VirgiIio iI quaIe chiarisce e iIIuslra Ia nalura e i con-
fini deII'usura aIIa Iuce deIIa iu aIla secuIazione anlica e crisliana
(ArisloleIe e iI Gcncsi) occua ben cinque lerzine (vv. 97-111): sazio
lanlo iu ragguardevoIe ove si consideri che queslo e iI canlo
deII'inlera maa deII'|njcrnc, ed anche iI iu breve deI Ioema (di soIi
115 versi), e che slanno a arle i 15 versi iniziaIi, di caeIIo.
5) Ia raresenlazione deII'usura comincia neI canlo XIV, e si rolrae
er 39 versi (vv. 4-42), nei quaIi I'Aulore comunica iI Iuogo e iI modo
8 Ivi, . 290: Ia arenlesi deII'inconlro con gIi usurai, lra I'arrivo di Gerione e iI
saIire dei due oeli suIIa sua groa, viene a inserirsi deI lullo inallesa.
9 Cfr. IAOLO SOLDATI, || canic XV|| deII'|njcrnc, in Icciura Oaniis Sca|igcra,
Iirenze, Le Monnier 1961, . 8.
10 Che Ia vioIenza neII'|njcrnc cominci non daI sellimo, ma daI seslo cerchio, dove
sono gIi Irelici, cfr. u|ira, e soslenulo in AVIRSANO, Oanic crisiianc, cil., . 82-83.
|| canic XV|| !c||Inferno 671
deIIa ena in cio che sarlisce con Ie aIlre vioIenze condannale neI
lerzo girone deI sellimo cerchio: Suin giacea in lerra aIcuna genle, /
aIcuna si sedea lulla raccoIla, / e aIlra andava conlinuamenle (vv.
21-24),
6) deII'usura Danle riarIa neI canlo XVI, e in modo aIlrellanlo dirello.
La nolazione loografica conlenula neIIa rima lerzina, infalli (Gia cra
in |ccc ctc su!ia i| rin|cn|c.), abbozza subilo Io sfondo iu rorio
deII'eisodio degIi Usurai quaI e neI canlo successivo: ne diremo lra
oco con decisione, anche se deIIa cosa non si lrova cenno nei com-
menli e neIIe |cciurac,
7) laIe nolazione e riresa a |nj. XVI, 91 e svoIla er aIlre cinque lerzi-
ne (vv. 91-105). Isse hanno suscilalo un generaIe maIconlenlo nei
Iellori, i quaIi ancora non sanno siegarsi erche I'Aulore descriva
un Iuogo infernaIe con lanla coia di eIemenli geografici, Ie slesse di-
fese queIIa deI Marli, er es.
11
aaiono lull'aIlro che effi-
caci, erche non ci si e accorli deI Iegame che iI oela slabiIisce lra
iI aesaggio fisico deIIa ena e queIIo elico-oIilico deII'usura, e
deII'imIicazione dirella e forle deI conlraasso,
8) Ia scena che immedialamenle segue (|nj. XVI, 106-114), queIIa
misleriosa deIIa ccr!a e deI suo Iancio neII'aIlo |urraic, fa arle inle-
granle deI discorso che I'Aulore conduce suII'Usura,
9) neI canlo XVII e reaIizzala una raffigurazione degIi Usurai che va
er una sequenza di ben sedici lerzine (vv. 31-78).
Ora, lirando Ie somme, dobbiamo conslalare che Danle neII'|njcrnc
ha revislo, er I'usura, un lemo narralivo lull'aIlro che lrascurabiIe
(ne discorre comIessivamenle er 147 versi), e che iu vaIe er un
numero di canli davvero insoIilo: oIlre aII'XI, anche iI XIV, iI XVI e iI
XVII, e si moslrera di qui a oco come anche nei canli XII, XIII e XV i
riferimenli aII'usura non manchino, e che e ossibiIe affiancarne anche
aIlri a queIIi aena censili. Aggiungasi che suI laslo deII'usura Danle
balle, e non deboImenle, aImeno in aIlri due Iuoghi deIIa Ccnnc!ia,
che chiamano in causa ersonaggi dei iu aulorevoIi, san enedello e
san Iielro: risellivamenle a Par. XXVII, 58-60, e a Par. XXII, 76-81. In
quesl'uIlimo caso iI vocaboIo usura riemerge er Ia seconda e uIlima
voIla, e dunque coI eso indiziaIe che hanno gIi apax neIIa Canlica, iI
che fa ensare a un sasso liralo verso iI geografico San enedello / de
I'AIe di |nj. XVI, 100: lerra di Usurai, quesla che I'Acquachela allra-
versa`
Ma conviene aIIegare sorallullo una coincidenza che e di non
oco momenlo, e che da soIa varrebbe a smenlire Ia laccia di scarso
11 Cfr. MARIO MARTI, Siu!i su Oanic, GaIalina, Congedo Idilore 1984, . 72-73.
Mario Aversano 672
inleresse da arle di Danle er Ia iaga deII'usura: e un sinlomo non
Ieggero che Ia raresenlazione iu amia degIi Usurai inconlro coi
ersonaggi, Ioro asello, disIocazione, aroIe e gesli ricorra rorio
neI noslro canlo, e si giovi deI dello riviIegio deIIa sua cenlraIila
neII'|njcrnc. Che oi laIe raresenlazione imegni Io abbiamo vislo
anche iI canlo XVI, e un fallo che rivesle uguaIe olenza di segnaIa-
zione, erche da modo di cogIiere un'aIlra ecuIiarila rogrammala.
C'e, neIIe innegabiIi concordanze che abbiamo evidenzialo coi cailoIi
mediani deIIe aIlre due Canliche, I'idenlila deIIa maleria in essi osla
in versi: iI croIIo di Iirenze, e deI mondo, er Ia erdila d'ogni virlu, e
sorallullo deIIa Giuslizia, a causa deIIa divinizzazione deI denaro, e
er I'uso vioIenlo che ne fanno Ie nuove cIassi sociaIi: inconciIiabiIe
con ogni convivenza che vogIia essere acifica, e imronlala a udici-
zia e sobriela (Par. XV, 97-99).
Ho congelluralo che allinenze con I'usura siano reeribiIi anche in
conlesli ai quaIi I'argomenlo arrebbe aI rimo sguardo deI lullo
eslraneo: neIIe illure dei VioIenli conlro iI rossimo (canlo XII), con-
lro se slessi (canlo XIII), e conlro nalura (canlo XV), e che sarebbe
coerlo, aIIora, lullo I'arco dei canli che va daII'XI aI XVII, iIIuslralivi
deI sellimo cerchio. Ma non basla: I'usura olrebbe enlrare anche neI
seslo, queIIo dove si sconla I'Iresia. Quesl'uIlima infalli come ho
dimoslralo aIlra voIla
12
cosliluisce Ia rima forma deIIa VioIenza,
queIIa conlro Ia divina Scrillura. Avremmo, cos, una suiic di ben ollo
canli, daI X aI XVII, lulla aII'insegna deIIa VioIenza: e I'usura, in quan-
lo ne e arle, verrebbe a siluarsi a cao di laIe serie, er scallare infine
aI suo aice, come uIlimo aneIIo deIIa calena, a un margine condiviso
con Ia Irode, e s'e accennalo, ma rirenderemo iI discorso, aIIa sua
marca usuraia. Un'iolesi inlerrelaliva di laIe comIessila e orla-
la lroverebbe Iegillimazione e sarebbe fin doverosa quando si
giungesse a delerminare un |ciinciit allraversanle I'inlero coro deIIa
VioIenza, e a individuare iI lraccialo d'una qucrc||c revisla fin daIIo
schizzo iniziaIe deI Ioema. Si uo muovere da un eIemenlo gia acqui-
silo. AI mezzo deIIa Ccnnc!ia che, ricordiamoIo ancora, cade lra iI
XVI e iI XVII deI Purgaicric Danle aulore ha caIalo una lerna di lemi-
chiave che gIi aaiono inlimamenle connessi, e che si riveIano come
queIIi su cui oggia lulla I'imaIcalura elico-fiIosofica e leoIogica deI-
Ia sua oera: Ia Giuslizia, iI ConsigIio e iI en fare, Ia Iace.
Non rielero Ie cose che ho gia moIlo soslenulo
13
. SoIo invilerei a
considerare un fallo non secondario: aII'usura era dedila in isecie Ia
12 Cfr. Ia nola 10.
13 A cominciare daIIa fine degIi anni Ollanla, cfr. AVIRSANO, Ia quinia rucia. Siu!i
su||a Ccnnc!ia, Torino, Tirrenia Slamalori 1988.
|| canic XV|| !c||Inferno 673
gcnic nucta, queIIa che, venula daI conlado, e arricchilasi coi faciIi
guadagni, aveva dislrullo I'inlero codice dei vaIori deIIa Iirenze d'una
voIla, generalo iI cuIlo deI denaro e aIIa Giuslizia sosliluilo iI suo con-
lrario (Purg. XIX, 118-123), Ia Cuidigia e Ia Suerbia. A ralicarIa
senza scruoIi i neoricchi onevano |i ngcgni, incuranli degIi edilli e
deIIe rediche che Ia dichiaravano massimamenle offensiva deI ben
jarc, deI Iavoro umano quaI e rescrillo neI Libro di Dio: I'aric di cui
VirgiIio disquisisce a |nj. XI, 109-111. Danle sa bene degIi effelli che un
laIe crimine roduce: coIui che non conla suI rorio Iavoro, non
si affida nani|us suis, ma disrezza I'arle e in aIlro on Ia sene
(|nj. XI, 111), conlribuisce e iI fallo-chiave che occorre solloIineare
non aIIa fondazione, ma aIIa dislruzione deIIa citiias e deI suo vivere
in ace. Id e beIIo conslalare come laIi concelli e vocaboIi rovengano
daI lerreno sacro, e siano gIi slessi che iI Saienle (|cc|i. XXXVIII,
35 sgg.) imiega er i buoni Iavoralori: Omnes hi in nani|us suis
spcratcruni, el unusquisque in aric sua saiens esl. Sine his omnibus
ncn ac!ijicaiur citiias. L'omoIogia iena deI lema e dei conlenuli, e
I'incrocio deIIo in aIlro pcn |a spcnc con Io in nani|us suis spcratc-
runi, mi sembra che non Iascino adilo anche in considerazione degIi
aIlri reIievi che I'Aulore ha effellualo daIIo slesso cailoIo bibIico a
che s'invochi Ia coincidenza invoIonlaria. Vediamo qui iu che mai
conlraosli, aIIora, i due iani, in prcspcrc e in na|c, deI fare e
deII'uso deIIo ingegno, che semre neIIa Ccnnc!ia si fronleggiano,
laIora convivenli in uno slesso ersonaggio. Iarinala degIi Uberli di
sicuro fece bene neI difendere Iirenze a tisc apcric, ma rocuro an-
che moIlo danno aIIa sua alria: non comrese Ia necessila deIIa ace
e deIIa concordia inlerna, e oero Iacerazioni, in quanlo erelico, neIIa
slessa famigIia calloIica, Io indica anche una aroIa che egIi ronunzia
aena si Ieva daI seoIcro infuocalo: nc|csic (|nj. X, 27). NeIIa Ccn-
nc!ia Ia moIeslia equivaIe, in lulli i suoi imieghi come aIlra voIla
ho fallo conslalare a semina di discordie, a frallure e divisioni irre-
arabiIi. I non megIio Iarinala si disose nei confronli di Dio,
negando Ia soravvivenza deII'anima. IgIi, in definiliva, non fu un
giuslo, e imiego I'ingegno a mo' degIi esseri ferini: Dico che inlra
lulle Ie besliaIiladi queIIa e sloIlissima, viIissima e dannosissima, chi
crede doo quesla vila non essere aIlra vila (Ccnt. II, VIII, 8). Ma su
lullo bisogna ricordare er iI coIIegamenlo isliluibiIe lra gIi Irelici
(aIIogali neIIa rima paric deI seslo cerchio) e gIi Usurai (che slanno
aII'aIlro cao deIIa VioIenza, aII'orIo eslremo deI sellimo cerchio)
che i Iadri non di rado accomunano quesle due calegorie di rerobi
individuandoIi, in sorasenso, neIIa pcr!ix deI rofela (|crcn. XVII,
11), Ia quaIe ruba Ie uova aII'aIlra ernice, figura di chi si arricchisce,
Mario Aversano 674
ma in modo disoneslo. Si veda aImeno I. Canlore, PI CCV 133:
CIamal erdix, fovil, quod non eeril fecil divilias, el non in
iudicio |...j. Ierdix avis immunda, er quam sicui nacrciicus, iia
jcncraiar accipi pcicsi, qui congregal divilias aIienas.
Da arle Ioro i vioIenli conlro Ie ersone fisiche e i beni aIlrui siamo
assali aI canlo XII furono besliaIi aI lullo: uccisero i rori simiIi,
slraziarono Ie comunila, oerarono con sirilo di guerra e di di-
scordia, semre cedendo aII'ira: nemica reciua deIIa giuslizia,
rieliamoIo, come ibbia insegna (|ac. I, 20).
Ma Danle con geslo deciso one in quesla jcssa dove scorre iI
IIegelonle, iI fiume di sangue: e si comrende megIio erche deI
suo rcsscrc egIi dice di aver raccariccio ancora menlre comone
(|nj. XIV, 78) con aIese inlenlo di secuIarila, uno dei rololii deI
ben fare, deII'agire con ingegno rello da virlu: iI cenlauro Chirone. I
qui giunge a conforlo deI noslro ercorso inlerrelalivo un aIlro dalo
singoIare, quanlo Ia risoIuzione slessa di eIevare iI maeslro di AchiIIe
aIIa signoria deI rimo girone: non c'e ersonaggio deIIa Ccnnc!ia deI
quaIe si risconlri, come er Iui, un numero di nominazioni cos aIlo
neIIo slesso canlo, quallro in oco iu di lrenla versi (|nj. XII, 65, 71,
77, 97), cui seguira queIIa arimenli embIemalica di Purg. IX, 37. II
dalo lanlo iu risaIla quando Io si raorli aII'assenza lolaIe di ana-
grafe er gIi Usurai, riconoscibiIi aena er gIi ammicchi ai coIori
di famigIia. I aIese che I'Aulore ha raccoIlo I'eco suasoria deIIa
lradizione cIassica e medievaIe che faceva di Chirone iI soIo cenlauro
risellabiIe, e er conlo suo ha guardalo s aIIo iusiun senem ovi-
diano (|asi. V, 384), ma sorallullo a Slazio: iI doIce oela che dico
da lemo e slalo sceIlo e anleoslo ad ogni aIlro savio anlico, come
guida er I'uIlimo lragillo urgaloriaIe, erche deIoro gIi odi lebani
e Ia fraudoIenza dei consigIi (segnalamenle queIIa di UIisse, neII'A-
cni||ci!c) e canlo gIi affelli domeslici e Ia ace. In quesla Iuce Danle Io
vede e Io inlerrela, e ercio Io orla suIIa scena deIIa Ccnnc!ia ara-
gonandoIo a Gesu, e onendogIi suIIe Iabbra iI saIulo crisliano deIIa
ace (Purg. XXI, 7-13).
L'oerare Iegalo aIIa giuslizia lorna neI canlo successivo, nei gemi-
li deI suicida Iier deIIa Vigna. Iu anch'egIi un giusic, voIlo aI ben
fare (|nj. XIII, 73-75), che I'invidia dei corligiani Ia slessa dei Iioren-
lini verso iI oela (|nj. XV, 64) rese ingiuslo: ingiuslo fece me conlra
me giusic (|nj. XIII, 72). I iI suo ruoIo, si badi, fu di consigIiere: come
Chirone, e Iarinala, e Guido Guerra, Iacoo Ruslicucci, Arrigo, iI Mo-
sca, Ciacco, e lulli gIi aIlri sora menzionali, e come Danle rielia-
|| canic XV|| !c||Inferno 675
moIo in Iirenze e neIIe corli dove lrovo riaro. I neII'esiIio, aggiun-
giamo, che egIi riscore, aI lemo slesso che conceisce iI Ioema, Ia
dimensione sacra di queslo g|cricsc cjjizic, iI concello che ne redicano
non i IibeIIisli curiaIi o Ie ecore bianche deIIa leoIogia lonsurala, ma
gIi Scrillori di Dio (|sin. I, 12-13, Ccnt. IV, VI, 19-20).
Anche Ia vioIenza di Caaneo (e siamo aI canlo XIV), che grida
avverso Dio, si coIora Slazio di nuovo isliganle deIIa rabbia irra-
zionaIe voIla conlro gIi uomini, deIIa assione oIilica che si fa odio e
genera discordia e guerre fralricide: egIi fu, ricorda VirgiIio, I'un d'i
selle regi / ch'assiser Tebe (|nj. XIV, 68-69). I cos giunge erfella-
menle in chiave, daIIa visuaIe che abbiamo sceIlo, anche Ia sequenza
deI vegIio di Crela (lroe voIle considerala soIo come un amio e
aulonomo inciso): sloria di guasic deII'umanila doo I'evo di Salurno,
di cui Ia decadenza fiorenlina e ilaIiana, dovula aI non governo, e iI
simiIe, iI rielersi slorico che i Libri sacri revedono, aI modo di queI-
Ia deI mondo inlero di cui arIa Marco Lombardo. Di Iui Ia rima cosa
che ci viene della e che amo quc| ta|crc, Ia Giuslizia (Purg. XVI, 46
sgg.), a cui iu nessuno lende. Id e suerfIuo indurre iI coinvoIgimen-
lo accoralo deI XV deII'|njcrnc, dove er bocca di ser runello hanno
onoranza iI ben fare, e Ia benignila deI oela.
La comarsa, da uIlimo, di Gerione s'imianla in quesla lrama Io-
gica deII'oerare: egIi e aragonalo aI |itcrc che s'assella a jar sua
guerra (|nj. XVII, 23), e Ia vioIenza come azione deII'uomo conlro
I'uomo in cui ure si esIica I'ira besliaIe (|nj. XVII, 131-132), ma ades-
so anche soccorsa daIIa frode: aIIa cui ombra gIi usurai fanno Ioro
arle, e Gerione assurge quasi a rololio degIi oeralori iniqui, Ia cui
Iisla neI Ioema merila di essere aIIungala.
Ci si are, adesso, er quanlo e venulo a giorno suI fare nei due
cerchi deIIa VioIenza, una migIiore visla e ossibiIila d'inleIIigenza
deI quadro lerminaIe deII'Usura (|nj. XVII, 31-78). Si ammellera che
non senza ianificazione I'Aulore avvia I'eisodio con I'imiego im-
medialo deI verbo fare (e diece assi jcnnc in su Io slremo), e
chiama oi ncna, cioe maneggio, iI comorlamenlo degIi Usurai (v.
39), e che a sludio oi induce Ie arli deI coro disosle aI fare, Ie
nani (v. 47): di qua, di Ia soccorrien con Ie nani / quando a' vaori e
quando aI caIdo suoIo.. Abbiamo gia saulo, a |nj. XIV, 40-41, deIIa
lresca / de Ie misere nani, riferila ai eslemmialori e ai Sodomili,
ma anche agIi Usurai: aIlro segno che accomuna lulli i VioIenli. Ma
ivi queIIe mani sono coIle unicamenle neI geslo di scuolere da
se I'arsura fresca (v. 42). Qui viene inserilo un dellagIio nuovo: gIi
Usurai imiegano Ie mani a difendersi non soIo dai tapcri, ma anche
daI ca|!c suc|c. Cio comorla, mi sembra, che quesli dannali, osli
Mario Aversano 676
come sono a sedere in lerra, si avvaIgano deIIe mani non soIo er
arroslarsi, ma anche er caIcare suI suoIo iI fuoco che iove daI-
I'aIlo: oro ben diverso qui igiano elernamenle Ie Ioro aIme. Que-
slo si uo dedurre, eraIlro, da |nj. XIV, 34-39: sia er queIIo sca|piiar
|c suc|c che AIessandro comando, a segnere Ie !i|aiaic ja|!c, sia er
I'accendersi deIIa rena ccncsca / sciic jcci|c. II aragone riguarda gIi
Usurai iu che gIi aIlri VioIenli deI girone, Io si deduce anche
daII'imiego d'un vocaboIo, csca, che e di queIIi lecnici deII'usura bi-
bIico-alroIogica, allinlo a Ocui. XXIII, 19: Non exiges a fralre luo
usuran ecuniae, el usuran cscarun, cui Ambrogio: el csca usura
esl (PI XIV, 607). AvvaIora inoIlre quesla gIossa iI cenno ai iedi
neI raffronlo coi cani che or coI ceffo, or coI ie (v. 50) si difendono
da uIci, mosche e lafani. In queslo vanno scorle due indicazioni:
gIi Usurai neIIa riscossione deI denaro non ebbero mani, ma zame
(Gerione ha soIlanlo due |rancnc), e non diedero asso, non cammi-
narono come locca ad ogni uomo er rocurarsi di che vivere, erche
sceIsero di sfrullare Ia falica aIlrui. I forse e anche da sosellare un
ammicco a quanlo di secuIalivo s'era insinualo neIIe slesse Arii fio-
renline.
Ier quesli canaIi, suIIa Iinea lemalica deI fare, Ia condolla degIi
Usurai viene ad essere congiunla a queIIa degIi aIlri eccalori di Vio-
Ienza, e a riveIarsi come Ia iu grave: ragion er cui I'Aulore Ii coIIoca
a||u|iina pcsia deI sellimo cerchio. Cos disonendoIi, aI sommo di
Ma|c|c|gc, dov'e Ia IraudoIenza, egIi ha inleso dire che quesl'uIlima
non e che confini, come e invaIso dire, ma si congiunge coi lraffici
usurai. Si lralla di un aIlro molivo reso daIIe esosizioni alrisliche,
ancoralo aI leslo bibIico (cfr. aImeno Ambrogio, PI XVI, 843). Isso
circoIa gia nei rimi Commenli, er es. in envenulo da ImoIa, che
addila concrelamenle gIi Usurai come frodalori in queI che negano
lemus, numerum, acla, inslrumenla, scriluram, el ila de muIlis:
er cui, egIi deduce, Danle bene osuil eos in exlremilale arenae
roinquos Gerioni, quia arlecianl de ulraque cuIa. I do nolizia
che di recenle e aarso un arlicoIo di VeseIovski|, iI quaIe un secoIo e
mezzo fa riroose iI binomio usura-frode, osservando lra Ie aIlre
che neIIe DecrelaIi I'usura e accomunala, oIlre che aI briganlaggio e aI
Ialrocinio, anche aI crincn ja|si
14
.
I conviene non dismellere, seguilando, Ia ricerca inlerlesluaIe,
anche erche e cerlo che I'Aulore nuIIa riferisce dei eccalori d'|njcrnc
rilrallo fisico e sicoIogico, coIa, Iuoghi deIIa ena, conlraasso,
ecc. che non sia offerlo e garanlilo daI Vecchio e daI Nuovo Tesla-
14 Cfr. RINZO RAONI, Un ariicc|c !i A.N. Vcsc|ctskij, Lellere IlaIiane, LX, 2008,
. 502-509.
|| canic XV|| !c||Inferno 677
menlo
15
. Si olra riarlire daI cenno ai iedi (che a Gerione manca-
no: finisce in serenle-scorione) e aII'umano oerare. Danle in
roosilo si regoIa ne abbiamo avulo oco fa un saggio secondo Ie
rescrizioni deII'|cc|csiasiicc, aderendo a queI cailoIo che redica Ia
reIigione deII'arle, essa e addilala neI Iavoro deI jigu|us che con Ie
mani lrasforma I'argiIIa, e coi iedi Ia schiaccia, e deI ja|cr che usa iI
lemo deIIa giornala a iegare iI ferro, egIi adoera iI na||cus (|cc|i.
XXXVIII, 29 sgg.): un vocaboIo, quesl'uIlimo, che ben uo aver sugge-
rilo iI marleIIo di |nj. XI, 90, imugnalo da Cc|ui cnc iuiic nctc, daI
Iabbro uno e lrino. I Ia slessa figura che, si noli, I'Aulore evoca er i
VioIenli conlro Dio, a |nj. XIV, 52 sgg.: iI buon VuIcano, con Ia sua
fucina in MongibeIIo. Sicche mani e iedi, che neII'esercizio deII'usura
non furono oneslamenle imiegali, qui aII'Inferno er conlraasso si
muovono con gesli che richiamano in senso deslilulivo queIIi degIi
arlieri bibIici.
DaI Libro divino e resa nolizia e non oleva essere aIlrimenli
anche er gIi aIlri aselli deI conlraasso, a cominciare daI sedere a
lerra (|nj. XVII, 35-36, 45, 70, |nj. XIV, 23). I di cerlo richiamalo iI bi-
bIico slare degIi Usurai, dei nunnu|arii che sedevano (|can. II, 14)
aI banco con iasca e |i|rc, ma aII'Inferno Danle Ii fa immobiIi, come
suggerisce iI SaImisla (Ps. XIV, 5): Qui ecuniam suam non dedil ad
usuram, el munera suer innocenlem non acceil. Qui facil hoc, ncn
nctc|iiur in acicrnun. I sedulo, ma di fronle aII'incudine e er
Iavoro Iecilo, e iI ja|cr in cui abbiamo scorlo, con |cc|i. XXXVIII,
28-29, uno dei rololii deI Iavoralore: faber ferrarius sc!cns iuxla
incudem. Un oco anche di qui, dobbiamo credere, ossono essere
derivali i arlicoIare deI fuoco che brucia Ie carni (I'inveslimenlo
dei cori, caIdi di denaro in vila, coI men iacevoIe caIdo che iove
daII'aIlo), e dei tapcri (v. 48), e finanche Ia ballagIia che i dannali
soslengono con Ie fiamme, oIlre che iI guardare fisso aIIe lasche dov'e
iI frullo dei lraffici usurai (v. 57): Sic faber ferrarius sedens iuxla
incudem, el ccnsi!crans cpus jcrri el tapcr ignis urci carncs cius, el in
ca|crc fornacis ccnccriaiur.
Ma er Ia ena deI fuoco si deve arIare di oIigenesi bibIico-
alroIogica, erche Iadri e Dollori, scrivendo degIi Usurai, inviano
anche ad aIlri Iuoghi deIIa ibbia. II fuoco sacro induce, er es., an-
che Iielro Canlore (PI CCV, 131-133), un aucicr che Danle moslra iu
voIle di conoscere, e da cui ora iu allinge, erche vi lrova I'equazione
oro-fuoco, iI !i qua, !i |a (v. 47) deIIa ioggia, se non anche uno sunlo
er orre gIi Usurai in lerzo Iuogo, doo eslemmialori e Sodomili:
15 AVIRSANO, Un nuctc Oanic. || rca|isnc icc|cgicc !c|||njcrnc, Roma, iI CaIamaio
1992.
Mario Aversano 678
Comaralur eliam igni sacrc, hoc esl exsecrabiIi el inexslinguibiIi |.j
Tcriia pcna eril eis in gehenna: quod aurun |u||icns suer isos |.j
effundelur abundanler, el cx cnni paric. Ier icrza pcna, siega semre
Canlore, s'inlende che Ie Ioro ricchezze non arriveranno aIIa lerza ge-
nerazione. La Ielleralura anliusuraia deII'ela di mezzo si aeIIa an-
che a |zccn. XXII, 21 e 29, e a Sap. XVI, 9 sgg., dove iI lema deIIa uni-
zione coI fuoco si mescoIa con queIIo deIIe iaghe er morsi di
Iocusle, mosche e serenli. NeII'esegesi crisliana, oi, non era infre-
quenle che si coIIegasse I'usura con I'ignavia, suIIa scorla deI racconlo
evangeIico deI servo callivo che sollerra iI suo laIenlo: gIi Ignavi, si
ricordi, neII'|njcrnc danlesco sono aggredili daIIa slessa secie d'insel-
li, ncsccni c tcspc (|nj. III, 65-66). ibIico e ure I'accoslamenlo ai cani,
vocaboIo che sla a cao deIIa serie iu nulrila di ricorrenze IessicaIi
animaIesche che si rubrichi in lullo iI Ioema: cani (v. 49), pu|ci, ncscnc,
iajani (v. 51), |ccnc (v. 60), cca (v. 63), scrcja (v. 64), |cccni (v. 73), |uc (v.
75). Si veda aImeno |sa. LVI, 10: SecuIalores eius caeci omnes, ne-
scierunl universi: cancs muli non vaIenles Ialrare. Di qui Danle ha
olulo ricevere anche conferma ne abbiamo accennalo a non dire iI
nome di aIcuno degIi Usurai inconlrali (cerlo a sregio, come fa er
gIi Ignavi, e, s'e vislo, er Ia maIa GuaIdrada): ncscicruni unitcrsi. Sen-
za dimenlicare, ad ogni modo, che si lralla d'un Iuogo comune deIIa
IibeIIislica suII'usura, e che a generarIo e anche iI modeIIo rincie che
lulli seguono, iI Oc Tc|ia di Ambrogio, neI quaIe e deIoralo iI vezzo
che gIi usurai hanno di dire, deI debilore reso schiavo, non Io cono-
sco (PI XIV, 593): frase che, oIlre a riallivare iI molivo deIIa menzo-
gna, sligmalizza ure Ia maIa coscienza che non riconosce neII'aIlro
nalura d'uomo. L'irradiazione bibIica e visibiIe anche neI geslo di
scherno fallo con Io slorcere Ia bocca e lrarre fuori Ia |ingua (vv. 74-75),
essa e cavala da |sa. LVII, 4 sgg., un asso che uo aver conciIialo an-
che, vedremo lra oco, Ia disIocazione degIi Usurai in rossimila
deII'acqua che discende neI |urraic, e I'anlilesi con iI giuslo che e ve-
nulo a visilarIi: Iuslus eril, el non esl qui recogilel in corde suo |.j
Suer quem |usisii? Suer quem diIalasli cs, el ciccisii |inguan?.
Id evado infine Ia romessa di moslrare come iI aesaggio fisico
deIIo scoscendimenlo con cascala e gran rcn|c deI IIegelonle, che
are e avvia aI lermine iI canlo XVI, inleressi in modo dirello ed
escIusivo Ia gcnic usuraia, che sla roinqua aI Ioco scemo (|nj.
XVII, 36), e aIIa eslrema lesla / di queI sellimo cerchio (|nj. XVII, 43-
44). Quesla delerminazione Iocaliva sembra reaIizzare un'indicazione
di Isaia: In arlibus lorrenlis ars lua (LVII, 6). Ma iu sara da cilare
in roosilo iI ca. XL di Giobbe siegalo da Gregorio (PI LXXVI,
1094 sgg.), dove e reeribiIe un silo anaIogo, che neIIa arle inferiore
|| canic XV|| !c||Inferno 679
accogIie iI Levialano, moslro deIIe acque cerlo accoslabiIe a Gerione,
anche erche e sensibiIe aII'amo che gIi si gella: fonle da cui uo esse-
re scalurilo un o' deII'immaginario deIIa ccr!a e Io sunlare deI mo-
slro che fara da eIicollero er scendere aII'ollavo cerchio. UguaImenle
acquisibiIe I'omoIogia lra quanlo si risconlra a |nj. XVI, 103-104 (cos
giu !una ripa !isccsccsa / lrovammo risonar queII'acqua linla) e iI rigo
recedenle neI aragrafo di Isaia ora cilalo (LVII, 5): subler eminen-
les pciras. Quesle picirc sono Ie slesse, oi, che formano iI condominio
lra I'usura e Ia frode, a |nj. XVII, 24: cos Ia fiera essima si slava / su
I'orIo ch'e di picira e 'I sabbion serra. Avremmo conlo anche deI er-
che laIe nolizia venga resa in maniera cos marcala, lramile due ro-
osizioni reIalive. I Ia slralegia cui semre Danle ricorre quando vuo-
Ie avvisare che sla marciando er dellalura d'un modeIIo sacro, e che
manliene Ia slessa cifra aIIegorica lrasmessagIi dai Iadri: neI caso, Ia
ielra indica Ia durezza di cuore degIi usurai. Si veda er lulli iI Iuogo
di Iielro CrisoIogo (PI CII, 468) in cui e menzionala Ia citiias pcrji!iac
(evocanle Ia danlesca cilla di Dile), essa ha, lra i muri che Ia circon-
dano, queIIo di seIce deIIe Usure: In civilale ergo erfidiae sela
muris, suerbiae lurribus communila, indurala si|ici|us usurarun.
Lo slesso uo dirsi deIIa rima informazione che I'Aulore da deIIa
gcnic rea d'usura: aIcuna si sedea lulla raccoIla (|nj. XIV, 23). II iuiia
raccc|ia, a voIerIo inlendere bene neIIa Iellera e neII'aIIegoria, va ab-
bordalo con Ia bussoIa d'un Iuogo di Ambrogio, daI quaIe riceve
siegazione anche iI resunlo anlicio con cui, a della deIIa genera-
Iila dei danlisli, Gerione arriverebbe: Iaddove, oiche quesla fiera
raresenla I'ollavo e iI nono cerchio, I'Aulore avrebbe fallo megIio
si dice ure a farIa comarire non rima, ma doo aver narralo
deII'inconlro con gIi Usurai. La verila e che Gerione arriva aI momen-
lo giuslo, erche, raffiguralo con coro di scrpcnic, er mela designa
anche I'Usura, cos come e rilralla in Ambrogio (PI XIV, 604): Non
minus fIexuosa quam scrpcns, alque in orbem icia sc cc||igcns, ul caul
servel. Come si vede, a arle iI caIco deI scrpcnic suI scrpcns, Ia di-
endenza deI iuiia raccc|ia daI icia sc cc||igcns e inlera, e ercio I'allo
vorra indicare un modo di conlrarre Ie membra a saIvare iI cao e ad
offrire un minor bersagIio aI fuoco. Infine: considerando che caIali in
un Iuogo Ia cui conformazione, er quanlo e dello a |nj. XVII, 66, e di
jcssa gIi Usurai sono come nascosli aII'occhio aIlrui, olremo rilenere
non imrobabiIe un'eco deI nascondimenlo deI ia|cniun di Maiin.
XXV, 25: aIlro asso di menzione corriva neIIe agine medievaIi
suII'usura. I Iadri deIIa Chiesa avverlono, in roosilo, che I'usura ha
moIli nascondigIi (cfr., ad es., Iielro Canlore, PI CCV, 131).
Ma oi I'Aulore lrasferisce iI rimbombare deI IIegelonle neIIa
Mario Aversano 680
scena d'esilo daII'usura, a |nj. XVII, 71: I'anonimo adovano dice che i
Iiorenlini gIi 'nircnan |i crcccni. Issi debbono urIare er farsi inlende-
re, slanle che I'acqua deI fiume di sangue 'n oc'ora avria I'orecchia
offesa (|nj. XVI, 105). Aare manifeslo che laIe offesa e una como-
nenle essenziaIe deI casligo comminalo agIi Usurai, una degna aga
er quanli in vila ebbero I'orecchio leso unicamenle aI linlinno dei
denari, e sordo ad ogni iela er iI rossimo: lroe voIle iI dalo acu-
slico ricorre (|nj. XVI, 92-93, XVI, 100, XVI, 104, XVII, 71) erche si
ossa dubilare che faccia arle deI conlraasso anliusuraio. Id an-
che di queslo lema Ia rovenienza e scrilluraIe. Issa va riconosciula
innanzilullo in |cc|i. XXXVIII, 30: Vox maIIei innctai aurcn cius. I
qui lraccialo iI rofiIo deI buon fabbro, figura oosila aII'usuricrc,
erche non dimenlica I'avviso di Dio (Gcn. II, 5 e 15), iI quaIe ha revi-
slo er I'uomo I'cpcrari fin daIIa Creazione. Ma oi sara da indurre
come fa Ambrogio (PI XIV, 605) anche |cc|c. I, 8, con cui Danle ha
olulo sinlonizzarsi anche er iI conlraasso deI vedere, a |nj.
XVII, 57 (e quindi ar che 'I |crc cccnic si pasca): Ncn saiia|iiur ccu-
|us, inquil, ti!cn!c, ci ncn saiia|iiur auris au!iiu: nec feneralor exIelur
acciiendo, nec affeclus eius quolidiano numerandi aeris salialur au-
dilu. Iunizione deIIa visla e degIi orecchi, dunque, che Danle e feIice
di mellere in versi, con obbedienza iena e convinla aIIa ibbia alro-
Iogica.
Resla da lrovare I'ascendenza degIi oggelli canonici deII'usuraio:
iasca, |crsa, saccnciic (|nj. XVII, 56, 59 e 64), e bisognera, naluraImenle,
ricercare neIIa ibbia, con I'aiulo degIi scrilli alroIogici suII'usura,
che, come abbiamo vislo, e imrescindibiIe. Issi rinviano a vari assi,
ma secie a Ic. XII, 33: Iacile vobis saccu|cs qui non velerascunl. I
saccnciii degIi Usurai, con evidenza, sono d'aIlra sloffa che queIIa
evangeIica: immarcescibiIi non in cieIo, bens aII'Inferno. Ma, infine,
che avra oi da sarlire con I'usura Io sciogIimenlo e iI Iancio deIIa
ccr!a, quaIi si risconlrano aI decIinare deI canlo XVI` Troe sono Ie
coincidenze riIevabiIi erche non si ensi anche a debili da scio-
gIiere, e diinlo e sedullivo e Gerione neIIa eIIe deI voIlo e neI cor-
o come Ia Ionza daIIa pc||c !ipinia, coerla !i pc| nacu|aic. Aarenze
enlrambe di inganno, sia ure er guadagni diversi. Ma andare oIlre
esuIa daI mio comilo di Iellore deI canlo XVII. Ci si olra lornare in
aIlra occasione. SoIo accennerei aI fallo che di una corda vediamo cin-
la ai fianchi Ia ersona di Danle neII'affresco deIIa Iace reaIizzalo da
Ambrogio Lorenzelli, e che in esso laIe corda e lirala a !riiia (come
iI illore slesso recila in didascaIia) cioe in una soIa direzione, in
concordia, senza che aIcuno diverga da venliquallro ConsigIieri
marcianli in fiIa er due. Danle e ressoche in lesla aI corleo, e iu di
|| canic XV|| !c||Inferno 681
lulli guarda con occhi seranzosi aI buon Reggenle, iI quaIe riceve in
consegna Ia corda er farsi braccio deIIa Ioro saienza. I un'icono-
grafia che ha radici neI ensiero oIilico di runello Lalini, e si loIIeri
che neI congedarmi io sceIga di riorlare, se non e lroo, iI Iuogo deI
Tcscrciic dove essa viene roosla (vv. 170-179, ed. Mazzoni):
Ond'io che so nessuno
ch'io voIesse vedere
Ia mia cillade avere
deI lullo a Ia sua guisa,
ne che fosse in divisa,
ma lulli er comune
lirassero una fune
!i pacc c !i |cnjarc,
che gia non uo scamare
lerra rolla di arle.
A senlire queslo runello, fa caoIino un dubbio, ma forse a lorlo:
si lrova neI Rinascimenlo, e neI doo, un rogello di accordo lra
cuIlura e olere iu suggeslivo e alluaIe`
|ia|ianisia, Sa|crnc
SUZANA GLAVAS
IL VIAGGIO DI DANTI IN CROAZIA
TRA RIALTA I IIOTISI
A||a ncncria !i |tan Icrciic (Oc|ranjc 1941-Zagrc| 2009)
|.j }er sIaveci na|veceg TaIi|ana mi u|edno sIavimo veIikog
borca za sIobodu ov|eka, za ob|edu ov|enosli i bralslva
medu I|udima i narodima, sIavimo univerzaInosl I|udskih
os|eca|a u v|eno| oezi|i
1
.
|.j Ioiche ceIebrando iI iu grande IlaIiano noi aI conlemo
ceIebriamo un grande comballenle er Ia Iiberla deII'uomo, er
Ia villoria deII'umanila e Ia fraleIIanza lra Ie genli e i ooIi, ce-
Iebriamo I'universaIila dei senlimenli umani neII'elerna arle
oelica
2
.
I. DANTI I I CROATI
Nonoslanle gIi IlaIiani e i Croali siano i rimi vicini di casa a
risaIire daI VII secoIo, gIi anlichi scrillori ilaIiani non menzionano i
Croali er svariale ragioni
3
. GIi IlaIiani non conoscevano i Croali in
modo sufficienle, ma nemmeno si inleressavano a queI ooIo a Ioro
lanlo eslraneo e da Ioro lanlo dissimiIe, che viveva ai confini deIIa
IenisoIa Aenninica. I Croali erano lullavia abbaslanza noli ai
Veneziani er ragioni oIiliche ed economiche, iI che si evince dai Ioro
numerosi documenli
4
, nonche dai documenli offerli dai cronisli
1 DaII'invervenlo Oanic i ni (Oanic c nci) di MIRKO DIANOVIC, decano deII'IlaIiani-
slica croala, in Oanic i ni, c 700-gc!isnjici rc!cnja, Zagreb, ed. }ugosIavenska Akademi|a
Znanosli i Um|elnosli 1965, . 21.
2 La lraduzione e mia, come di lulle Ie aIlre cilazioni neI leslo.
3 Le nolizie riguardo a queslo argomenlo sono slale abbondanlemenle fornile da
ARTURO CRONIA in varie fonli quaIi: Pcr |a sicria !c||a s|atisiica in |ia|ia (Zara 1933),
Nciizic iia|ianc inicrnc a||a Crcazia, in |ia|ia c Crcazia (Roma 1942), Ia Crcazia tisia !ag|i
|ia|iani (Roma 1942), Ia ccncsccnza !c| ncn!c s|atc in |ia|ia, in Bi|ancic sicricc-|i||icgrajicc
!i un ni||cnnic (Iadova 1958).
4 MoIli di quesli sono slali dali aIIa Iuce daII'Accademia }ugosIava in Mcnuncnia
Suzana GIavas 684
deII'eoca
5
.
Ad iIIuslrazione deI secoIare raorlo lra Danle e i Croali vogIio
ricordare aIcuni nomi chiave che ne riveIano un conlallo dirello o in-
dirello.
NeI 1399 iI roniole di Danle, NicoIo, fonda a Zagabria Ia rima
farmacia, accanlo aIIe mura di cinla deI borgo anlico Ia Cilla AIla.
SuII'edificio, in Via dei Gesuili (Isusovaka uIica), in cui ha sede Ia
farmacia, cameggia una larga con Ia scrilla: II roniole di Danle
NicoIo AIighieri, niole deI figIio rimogenilo deI oela, Iielro, orlo
Ia voce dirella suI ceIebre avo a Zagreb, dove visse sosalo ed ebbe Ia
farmacia neI 1399
6
.
A iu di un decennio rima, ovvero aI 1385, risaIe invece Ia rima
annolazione scrilla suII'esislenza di una coia deIIa Oitina Ccnnc!ia
ossedula daI draiere zaralino MihoviI Ielrov, leslimonianza che
riveIa iI rimo conlallo dirello di un Croalo con iI Pccna danlesco
7
.
II documenlo e slalo rinvenulo quaranlacinque anni fa neII'Archi-
vio deI Monaslero di Sanla Maria a Zara daIIo sludioso zaralino }akov
Sliisic. La scoerla lralla I'invenlario dei beni aarlenenli a MihoviI
Ielrov, un grosso e beneslanle draiere zaralino. La slesura deI dello
invenlario, risaIenle aII'anno 1385, in sinlonia con quanlo a quei lemi
spcianiia nisicrian S|atcrun ncri!icna|iun !a| 1868 in pci.
5 La iu inleressanle di laIi cronache risuIla iI Cnrcniccn Vcnciun (fino aI 1008) ad
oera deI iu anlico cronisla veneziano GIOVANNI DIACONO (X-XI secoIo) iI quaIe
vedeva i Croali quaIi avversari oIilici dei Veneziani (aIcuni brani sono slali ubbIicali
da IRAN}O RACKI in Occuncnia nisicriac cnrcaiicac pcric!un aniiquun i||usiraniia, Zagreb
1877). Ai Croali fa cenno un aIlro cronisla veneziano, Andrea DandoIo, neI Trecenlo,
menlre gIi aIlri cronisli ilaIiani deI Medioevo Ii menzionavano aena o er nienle
affallo.
6 La larga e slala osla daI Comune di Zagabria neI 1989. DegIi AIighieri a Zagabria
neI Trecenlo si sono occuali in arlicoIare due emerili ilaIianisli croali, Irano CaIe e
Male Zoric, allingendo ai documenli d'archivio sui discendenli veronesi di Danle.
Ier Ie nolizie iu arofondile a riguardo si invila a consuIlare Ie seguenli fonli: IRANO
CALI-MATI ZORIC, Oanic nc||a |ciicraiura crcaia, Sludia romanica el angIica zagrabien-
sia, Zagreb, IacoIla di Lellere e IiIosofia 1956, nn. 41-42, . 464, IRANO CALI-MATI
ZORIC, Oanic A|ignicri. Ojc|a || (saggio inlrodullivo aII'edizione croala deII'oera omnia
di Danle), Zagreb 1976, . 767, IRANO CALI, G|i A|ignicri a Zaga|ria nc| Trcccnic, in Oanic
i s|atcnski stijci/Oanic c i| ncn!c s|atc, Alli deI convegno inlernazionaIe lenulosi a Du-
brovnik daI 26 aI 29 ollobre 1981, a cura di Irano CaIe, Zagreb, ed. Accademia
}ugosIava deIIe Scienze e deIIe Arli, Sezione di Lelleralura 1984, . 71-80.
7 Nolizie reziose ed arofondile suII'argomenlo vengono fornile da }AKOV
STIIISIC in Prti pcznaii !c!ir s Oaniccn u Hrtaia, in Oanic i s|atcnski stijci/Oanic c
i| ncn!c s|atc, |a!cti nc!unarc!ncg sinpczija/Aiii !c| Ccntcgnc |nicrnazicna|c Ou|rctnik
26-29. X. 1981, Simozi| |ugosIavenske Akademi|e znanosli i um|elnosli/Convegno
deII'Accademia |ugosIava di Scienze e Arli, riredio/a cura di Irano CaIe, Zagreb, ed.
}ugosIavenska Akademi|a Znanosli i Um|elnosli 1984, voI. II, . 629-637.
|| tiaggic !i Oanic in Crcazia ira rca|ia c ipcicsi 685
veniva rescrillo daIIo Slalulo deIIa prccuraria ccnunis |a!rac, riveIa
su 260 agine comIessive non soIo I'eIenco dei beni osseduli in vila
da Micncti||us Pciri !rapparius, ma aI conlemo risuIla una deIIe iu
inleressanli e reziose fonli er conoscere Io slalo inlerno di Zara neI
Trecenlo.
MihoviI era di origine croala, e Ia sua Iingua madre era iI croalo.
L'imressionanle eIenco di oggelli in oro, argenlo e ielre reziose, in
suo ossesso, riveIa I'immagine d'un mercanle cosmooIila divenu-
lo un vero e rorio ncnc nctus. Non aarlenenle aI celo alrizio,
aveva lullavia un rorio slemma e Ia dicilura scr davanli aI nome
8
.
L'eIenco dei Iibri menzionali neII'invenlario sono inoIlre Ia chiara
immagine di un raffinalissimo guslo ed inleressamenlo Iellerario deI
defunlo rorielario, come ure I'indice deI vaslo orizzonle cuIluraIe
di un ricco e coIlo raresenlanle deI recoce celo borghese suI suoIo
deII'Adrialico orienlaIe. Ira i Iibri eIencali fanno sicco due coie deI
Trcscr di runello Lalini, maeslro di Danle (a cui neI XV canlo
deII'|njcrnc sono dedicali aIcuni versi), ed una coia deIIa Oitina
Ccnnc!ia, con dellagIiala descrizione (!) in Iingua Ialina:
Ilem Iiber unus in carlis edinis cum labuIis Iigneis coerlis corio
viridi cum brochelis de ramo reIevalis deauralis el cum qualuor
seraIiis, qui Dans aeIIalur, qui inciil: NeI meco deI camin. Il
finil: Qui finisse iI aradiso de Danle, in quo sun infernus, ur-
galorium el aradisus.
II draiere zaralino MihoviI Ielrov ossedeva, dunque, una coia
deIIa Oitina Ccnnc!ia, neII'invenlario chiamala semIicemenle Oans
appc||aiur, riIegala in eIIe di carello, con quallro fibie di chiusura o
di rolezione. IrobabiImenle era di formalo grande e forse con deco-
razioni o decorala di iniziaIi, er cui ricorda iI nolo manoscrillo deIIa
ibIioleca TrivuIsiana di MiIano. La crilica croala e lullora aII'oscuro
se Ia cilala coia sia conservala in quaIche bibIioleca aI mondo. I dali
riorlali neII'invenlario fanno invece caire che gIi aIlri due Iibri os-
seduli da MihoviI Ielrov erano riveslili di eIIe verde ed erano dolali
di quallro fibie di chiusura, iI che fa resuorre che rovenissero
daIIa slessa bollega di arle Iegaloria insieme aI Trcscr di runello La-
lini ed iI Ii|cr !csiruciicnis Trcic.
II menzionalo Oans appc||aiur e leslimonianza deIIa iu remola
memoria di Danle aI di fuori dei confini deII'IlaIia, a conferma che i
Croali, soIo a dislanza di ochi anni risello agIi IlaIiani, ebbero modo
8 Cfr. STIIISIC, Prti pcznaii !c!ir s Oaniccn u Hrtaia, in o. cil., . 629-630.
Suzana GIavas 686
di conoscere Ia Oitina Ccnnc!ia.
I documenli deII'archivio reIalivi aII'allivila di MihoviI Ielrov di
Zara leslimoniano che egIi negIi anni Trenla deI Trecenlo si recava a
Iirenze, Iadova, Manlova e aIlrove er comrare lessuli e sloffe fio-
renlini, adovani, manlovani. I aIlrellanlo IausibiIe ensare che Ia
beIIissima coia deI Pccna danlesco iI mercanle zaralino avrebbe o-
lulo rocurarseIa addirillura quaIche anno doo Ia morle di Danle suI
suoIo ilaIiano, o che di Danle avrebbe senlilo arIare neIIa slessa cilla
di Zara. Ira queIIo iI eriodo in cui a Zara fioriva Ia cuIlura: doo Ia
ace ivi sliuIala lra i Veneziani e Ludovico I d'Angio neI 1358, Ie con-
dizioni erano favorevoIi er Io sviIuo deIIe arli in genere e si ro-
sello iI eriodo iu feIice deIIa sloria medioevaIe zaralina. Con Ia
Iace di Zara fu infine raggiunla, doo secoIi di guerre e di mulamenli
suIIe carle geografiche, I'unila slalaIe deIIa quasi lolaIila deIIa Croazia
medioevaIe.
Danle fu Iello seciaImenle dagIi islruili Croali-DaImali che slu-
diavano in IlaIia. NeI Quallrocenlo, Ia arleciazione degIi umanisli
croali aIIa Ialinila euroea favor cerlamenle Ia conoscenza deIIe re-
gioni croale da arle degIi IlaIiani. AIlrellanlo merilevoIi furono i
Croali di ogni celo, che neI frallemo erano arodali neIIa IenisoIa
9
.
I menlre iI lermine Chroala, Croala, nolo in IlaIia sin daII'eoca deIIo
slalo medioevaIe croalo, andava rogressivamenle scomarendo daI-
I'uso con I'eslinzione di laIe enlila oIilica (doo Danle iI lermine riaf-
fiora raramenle nei documenli ilaIiani) semre iu sovenle si ricor-
reva aI nome di Schiavoni, lermine che, insieme aI cIassico IIIirico,
reslo asso a designare I'elnia dei Croali in IlaIia
10
.
Croali, IIIiri, Schiavi, Schiavoni, SIavi, MorIacchi, Scili ed aIlri
ancora erano gIi svariali nomi con cui gIi IlaIiani erano soIili de-
nominare Ia vicina elnia sIava. II iu frequenlemenle usalo lermine
Schiavoni nacque, come e nolo, daI lardoIalino SIavus, ScIavus. OIlre
aI significalo elnico, queIIa denominazione acquis reslo anche iI
significalo di cIasse, ovvero di aarlenenza aI celo sociaIe deIIo
schiavo. Queslo erche Ia maggior arle degIi schiavi, roriela dei
9 Tra gIi sIavisli ilaIiani che hanno lrallalo I'argomenlo si invila a consuIlare
ARTURO CRONIA, Oanic nc||a |ciicraiura scr|c-crcaia, L'Iuroa OrienlaIe (I, 1921), suc-
cessivamenle sollo forma di eslrallo Oanic nc||a |ciicraiura scr|c-crcaia, da Oanic nc|
ncn!c, a cura di Villore ranca e Illore Caccia, Iirenze, Leo S. OIschki Idilore 1965,
ITTORI LO GATTO, I|ia|ia nc||c |ciicraiurc s|atc, Nuova AnloIogia, Iirenze 1929, n. 6, e
neI voIume Siu!i !i |ciicraiurc s|atc, Roma 1931, III. Li cila anche iI decano
deII'ilaIianislica croala MIRKO DIANOVIC neI suo Iavoro Oanic c i Crcaii, II Ionle. Rivi-
sla mensiIe di oIilica e Ielleralura dirella da Iiero CaIamandrei, Iirenze, ed. La
Nuova IlaIia 1955, nn. 8-9, . 1424-1430.
10 In merilo aII'argomenlo si consuIlino Ie ricerche svoIle da Mirko Deanovic.
|| tiaggic !i Oanic in Crcazia ira rca|ia c ipcicsi 687
numerosi conquislalori e mercanli deI Medioevo, erano aunlo gIi
SIavi. II aa Gregorio I, neI VI secoIo, usava iI nome ScIavus er
indicare Io SIavo meridionaIe e chiamava cos i Croali, neI secoIo
VIII Io usava ad esemio IauIus Diaconus. DaIIa fine deI secoIo X
ero, neI sud deIIa IenisoIa, iI lermine ScIavus inizio ad essere usalo
er denominare anche Io schiavo
11
. Nei diIomi riIasciali neI nord
IlaIia, risaIenli aI IX e aI X secoIo, ScIavus aveva unicamenle iI si-
gnificalo elnico. Iu cos che iI nome schiavo, schiavone, come ure iI
nome croalo, e una voIla anche servo (er serbo), acquis un signifi-
calo eggioralivo, Schiavi e Servi, nomi che aiono di maIedizione
ambedue, affermo NiccoIo Tommaseo in Canii icscani, ccrsi, grcci,
i||irici, edili a Venezia neI 1841. Con queslo nome soIilamenle veni-
vano chiamali i Croali dai vicini Veneziani: essi addirillura, rima deI
XIII secoIo, diedero nome Riva degIi Schiavoni a queIIa arle deIIa
riva in cui arodavano Ie imbarcazioni daIIa sonda orienlaIe
deII'Adrialico. NeIIe differenli regioni deIIa IenisoIa aIIa aroIa
furono allribuili aIlri significali ancora, come ad esemio: s'ciavoni
er i reggimenli croali neII'esercilo veneziano, s'ciona er fandonia,
uva schiavona er una sorla di uva, neI Seicenlo neIIa Serenissima
veniva usalo iI lermine s'ciavona er Ia sciaboIa dei Croali neIIa
guardia deI doge, iI sinlagma Iingua schiavona veniva usalo con
riferimenlo aIIa Iingua aIeosIava, nei diaIelli veneli, ad esemio, Io
scarafaggio si chiama s'ciavo, in queIIo friuIano scIaf (cos come i
Croali, ad esemio, er Io slesso insello usano Ia aroIa svaba
ovverosia svevo)
12
. AgIi inizi deI Novecenlo nei diaIelli ilaIiani e suIIe
sonde orienlaIi deII'Adrialico iI lermine S'ciavo non era soIo
sinonimo di Croalo, i signori deIIa regione IriuIi-Venezia GiuIia
usavano queslo lermine disreggialivo (Scavo) non soIo er indicare i
conladini croali e serbi bens anche una cIasse di oerai roIelari
senza dislinzione di aarlenenza elnica
13
. Cos iI nome riacquislo
neIIe bocche di laIi IlaIiani iI vaIore semanlico di cIasse. NeII'odierno
saIulo comune degIi IlaIiani 'ciao' (servo, servus), di origine veneziana
(s'ciavo, s'sciao) coI significalo di 'sono voslro schiavo' non si avverle
11 Con queslo significalo fu aunlalo in un documenlo deI 1088, ma Io soslamen-
lo semanlico si sara avveralo anche rima.
12 DaIIo slesso vocaboIo si hanno varie derivazioni elimoIogiche quaIi schiavina,
I'abilo deI eIIegrino croalo, oi una secie di drao e 'coerla', menlre a Venezia
s'ciavonelo significa un manlo femminiIe, come ure Io si rilrova nei modi di dire quaIi
vender s'ciavine 'arIare a vanvera' oure cor conlenlo e s'ciavina in saIa er 'e feIice
coIui che si acconlenla di oco'.
13 Ne sono conferma i voIumi di ANGILO VIVANTI, |rrc!cniisnc a!riaiicc (Iirenze
1912) e I|ia|ia c|irc ccnjinc (Torino 1914) dove aunlo si dice Lo sIavo, sinonimo di
conladino....
Suzana GIavas 688
iu Ia sua derivazione elimoIogica da schiavo.
Rari sono lullavia gIi aulori ilaIiani deI Medioevo che nominano i
Croali.
II. QUAL I COLUI CHI IORSI DI CROAZIA VIINI...
Danle AIighieri saeva ben dislinguere Ia Croazia daIIa Rascia e
daIIa Schiavonia. NeI suo Pccna egIi dedica aIcuni versi ad un semIi-
ce eIIegrino deIIa Croazia che avrebbe olulo vedere con i rori oc-
chi neI gruo di genli croale neII'anno giubiIare 1300 a Roma
14
. In
uno scenario di grande fesla e commozione Danle aragona iI suo in-
limo slalo d'animo aIIo slalo d'animo di un fervenle eIIegrino croalo,
eslasialo neII'ammirare iI voIlo di Gesu Crislo suI fazzoIello di
Veronica.
QuaI e coIui che forse di Croazia
viene a veder Ia Veronica noslra,
che er I'anlica fame non sen sazia,
ma dice neI ensier, fin che si moslra:
Signor mio Iesu Chrislo, Dio verace,
or fu s falla Ia sembianza voslra`,
laI era io mirando Ia vivace
carila di coIui che 'n queslo mondo,
conlemIando, guslo di queIIa ace.
(Par. XXXI, 103-111)
Chi si e occualo recenlemenle deI ManuaIe deI eIIegrino e deI
eIIegrinaggio er Ia rocIamazione deI rimo Anno Sanlo neI mondo
calloIico da arle di aa onifacio VIII ha olulo soIo immaginare, in
base agIi scarni e Iunghi eIenchi di IocaIila degIi iiincraria a! |inina
apcsic|crun, gIi esercili di eIIegrini, ricchi e overi, sani e ammaIali,
14 Nolizie inleressanli ed uliIi suI eIIegrinaggio reaIe a Roma e suI manuaIe deI
eIIegrino neI rimo Anno Sanlo deI mondo calloIico ci vengono fornile da WIRNIR
GOIZ in 'Manua|i !i tiaggic nc!iccta|i pcr i| pc||cgrinaggic a |cna, in Ia |ciicraiura !i tiag-
gic, a cura di M. Inrica D'Agoslini, MiIano, Guerini e Associali 1987, . 151-160. Vi
Ieggiamo che i ManuaIi di viaggio er iI eIIegrinaggio a Roma sono eIenchi nudi, Iisle
di IocaIila e di dislanze, 'Ilineraria'.ero, gIi 'Ilineraria' che lacciono su lullo, annolano
soIlanlo iI nome deIIa fermala successiva. |.j. II eIIegrinaggio a Roma si reaIizzava
ercorrendo Ie slrade iu frequenlale deII'Iuroa cenlraIe, frequenlale da lanli mercan-
li, reli, corrieri, Iegazioni aIIa corle deI onlefice, soIdali. Non era 'lerra incognila'
come Ia Sagna |.j. I ManuaIi dei eIIegrini a Roma sono documenli eslremamenle
concenlrali suIIo scoo io deI eIIegrinaggio. Ier queslo saiamo ben oco deIIe
arlicoIarila deI eIIegrinaggio a Roma. O. cil., . 159, 160.
|| tiaggic !i Oanic in Crcazia ira rca|ia c ipcicsi 689
vecchi e giovani, lulli sinli daI io desiderio deIIa remissione dei ec-
cali, deIIa saIvezza elerna, deII'essere accoIli da Dio e dai suoi sanli
15
.
Le due lerzine deI Para!isc, neI Iasso di lemo di cenlo anni (1909-
2009) lradolle in croalo ben 12 voIle
16
, sono slale neI lemo inler-
relale in svariali modi. L'emerilo slorico croalo Grga Novak ha affer-
malo ad esemio che Danle conosceva benissimo Ie lerre croale e ne
ensava moIlo bene
17
, iI buon danloIogo croalo Miho G|uranec ha
commenlalo i cilali versi dichiarando che Danle si e esresso suIIa
Croazia megIio e in un conleslo migIiore che non su Iirenze o suI-
I'IlaIia
18
, Io slorico Iellerario AlliIio MomigIiano ha solloIinealo che iI
eIIegrino croalo e una deIIe figure indimenlicabiIi deI Ioema
19
.
Conlrariamenle a quesli, neI Risorgimenlo, iI DaImala NicoIo Tomma-
seo da Sebenico, neI suo Ia Ccnnc!ia !i Oanic A|ignicri cc| ccnncnic
!i N. Tcnnascc (voI. III, Venezia 1837) arafrasava i versi dando ai
Croali deIIa genle seIvalica e scoslumala, neIIa riviera deI mare
Adrialico
20
.
Resla lullavia iI voIere deI Sommo aragonare in Para!isc, davanli
agIi occhi deIIa eala Vergine e di ealrice, Ia roria enfasi aII'enfasi
di un credenle deIIa Ionlana Croazia, che voIevasi definire nazione
barbarica.
NeII'|njcrnc iI Quarnaro e menzionalo quaIe confine orienlaIe
deII'IlaIia verso Ia Croazia: Carnaro ch'IlaIia chiude e suoi lermini
bagna (|njcrnc, IX, 113-114) menlre in Purgaicric i venli che soffiano
daI Nord-Isl sono definili venli schiavi (Purgaicric, XXX, 87), in Oc
tu|gari c|cqucniia (Iibro I, ca. 8) si fa riferimenlo a ScIavones che o-
oIano iI lerrilorio fra iI Danubio e Ie lerre ilaIiane.
Suscila curiosila ricordarsi che quaIche decennio doo Danle, iI
narralore Iranco Sacchelli (inlorno aI 1334-1400), figIio exlraconiugaIe
di un mercanle fiorenlino e di madre Ragusina, nalo neIIa ReubbIica
di Ragusa (Dubrovnik), in una oesia comosla suI IiloraIe croalo
descrive con disrezzo e ribrezzo Ie sue imressioni suII'ambienle
15 WIRNIR GOIZ, o. cil., . 160.
16 Cfr. MIRKO TOMASOVIC, Qua| c cc|ui cnc jcrsc !i Crcazia. Oanic, Para!isc, XXX|,
103-8 (Kcncniaicrski i ira!ukic|cski aspcki, in Qua| c cc|ui cnc jcrsc !i Crcazia., Zagreb, ed.
MaIa kn|iznica DHK 2010, . 27-58.
17 Cfr. GRGA NOVAK, Oanic A|ignicri u pctijcsii, in Oanic i ni (c 700-gc!isnjici rc!cn-
ja), Zagreb, ed. }AZU 1965, . 10-11.
18 Cfr. MIHOVIL (MIHO) G}URANIC, Oanic u pratcnc stjci|u. Prc!atanja, Zagreb 1935,
. 204.
19 Lo riorlano gIi ilaIianisli croali Irano CaIe e Male Zoric, curalori deII'edizione:
Danle AIighieri, Bczansitcna kcnc!ija i !ruga !jc|a, Zagreb 1991, . 113-114.
20 L'argomenlo e slalo arofondilamenle lrallalo da Mirko Tomasovic, iI iu au-
lorevoIe romanisla croalo vivenle, cfr. Qua| c cc|ui cnc jcrsc !i Crcazia., cil., . 31-33.
Suzana GIavas 690
alriarcaIe sIavo, lanlo diverso daI raffinalo conleslo sociaIe deII'IlaIia
coeva. Va ricordalo inoIlre che quasi conlemoraneamenle anche iI
ceIebre Ielrarca in una sua eisloIa fece cenno aII'aIlra sonda
deII'Adrialico, ma soIo er resingere Ia roosla di un amico che Io
regava di onorare un dollo DaImala di una sua missiva. Ielrarca, che
viaggiava er I'Iuroa come un lurisla dei noslri lemi, e che in aIlre
occasioni aveva saulo Iasciarsi rendere daII'ammirazione er iI di-
verso e iI nuovo, in queIIa sede si Iimila a dire che ai DaImali non uo
scrivere erche e comune iI mare, ma oosle sono Ie sonde, gIi
animi, gIi ingegni, non sono simiIi infine ne iI modo di vivere ne queI-
Io di arIare (Ielrarca, da Ic jani|iari, Urbino 1974).
III. LA IRIMA TISTIMONIANZA LATINA DILLA IORTUNA DI DANTI
IN CROAZIA
AII'eoca umanislica, in cui i Iellerali in DaImazia scrivono
aII'insegna deI lriIinguismo, risaIe Ia rima versione Ialina aulografa
deI rimo canlo deII'|njcrnc. Si lralla deIIa versione in esamelri Ialini
Principiun cpcris Oaniis A|igicrii !c j|ucniinc scrncnc in |aiinun ccntcr-
san pcr M. Maru|un alleslala ben cinquecenlo anni doo Ia scomarsa
deI lradullore. Se i Croali ossono da semre considerarsi i migIiori
conoscilori deIIa Iingua e deIIa Ielleralura ilaIiana in lullo iI mondo
sIavo, come afferma iI Deanovic
21
, Ia versione Ialina ad oera deI
adre deIIa Ielleralura croala, in quanlo lenlalivo di un umanisla
Ialinisla a saIvare iI voIgare danlesco, ha assicuralo a Marko Maru-
Iic (MaruIo) un oslo di riIievo neII'|ncic|cpc!ia !anicsca (ben 23 righe)
nonche un oslo di riviIegio neIIa sloria deIIa forluna deIIa Oitina
Ccnnc!ia
22
. Secondo Mirko Deanovic si lralla iu che aIlro di una
arafrasi secondo iI guslo deI lemo, in cui e slalo aIleralo Io sliIe ser-
ralo danlesco
23
, lesi in seguilo orlala avanli sia da Mirko Tomasovic
che da SmiI|ka MaIinar, Ia quaIe sosliene che MaruIic ha riformuIalo
iI leslo di Danle, eredilando quei modeIIi che a Iui, umanisla coIlo e
oela Ialino, erano maggiormenle affini
24
. La versione Ialina di
MaruIic, eseguila con Ia iena consaevoIezza su lulle Ie insidie e Ie
difficoIla deIIa resa Iinguislica e versificaloria, e slala addirillura ar-
21 In Oanic c i Crcaii, o. cil., . 1424.
22 Cfr. MIRKO TOMASOVIC, Prcpjcti Oanica i Pcirarkc in Markc Maru|ic Maru|, Zagreb-
SIil, ed. Irasmus in coedizione con Kn|izevni krug SIil-MaruIianum e Zavod za zna-
nosl o kn|izevnosli deIIa IacoIla di Lellere e IiIosofia deII'Universila degIi Sludi di
Zagabria 1999, . 235-240.
23 In Oanic c i Crcaii, cil., . 1424.
24 SMIL}KA MALINAR, Maru|icct prijctc! prtcga pjctanja Bczansitcnc kcnc!ijc, br.
51-52, Zagreb 1983, slr. 87.
|| tiaggic !i Oanic in Crcazia ira rca|ia c ipcicsi 691
gomenlala daII'aulore, sollo forma di un aunlo leorico
25
lradullo-
Iogico neI coro deI leslo di accomagnamenlo aIIa versione Ialina di
A! tirgincn |caian di Ielrarca
26
, slamala in fondo aII'|tangc|isiariun.
I che a Marko MaruIic (MaruIo) Danle fosse servilo da modeIIo Io
alleslano, oIlre aIIa cilala versione Ialina, iI melodo arafraslico nei
confronli deIIa sloria bibIica di ju!iia, oema eico scrillo in croalo
ciacavo ed edilo a Venezia neI 1501, deIIa quaIe in un'eisloIa
aII'amico Ciiko dichiara che anche Ia Iingua sIava ha iI suo Danle
27
.
AIIievo a SaIalo deII'ilaIiano Tideo Acciarini, MaruIic comIelo
gIi sludi a Iadova, che Iascio segni indeIebiIi suIIa sua formazione.
DaI suo leslamenlo si rinviene che ossedeva oere di Lorenzo VaIIa,
Ioggio raccioIini, Guarino Veronese e Iielro embo.
L'umanisla saIalino si inleresso lanlo aIIa vila ed aIIa ersona deI
Iiorenlino che ben reslo acquislo anche una coia deIIa Viia !i Oanic
scrilla da occaccio. A differenza di lanli suoi concilladini non diven-
ne mai un oela gaIanle. Amo invece iI Sommo e Io lradusse in Ialino
ai lemi in cui occuarsi di Iui in modo crilico in IlaIia risuIlava cosa
assai rara.
Icco come comincia Ia sua versione Ialina:
HUMANAI SIACIUM VITAI CONCISSIRAT AITAS }AM
MIDIUM, TINIROSQUI MIHI SUDUXIRAT ANNOS, IIR
LOCA QUUM TINIRIS OSCURA ATQUI ASIIRA SILVIS
MI MISIRUM IRRANTIM SINSI, GRISSUQUI RIIRISSO
INCIRTUSQUI VIAI MINTIM CONIUSUS INHAISIIT
CIRCUMLUSTRAVI OCULIS IAVITANTIUS. HORROR
25 Cfr. MIRKO TOMASOVIC, o. cil., . 236. La cilazione deII'aunlo e slala resa nola
da Radovan Vidovic in Maru|icct |aiinski prcpjct Oanica, Mogucnosli, SIil 1956, n. 4,
. 309, oi riresa da Tomasovic neIIa fonle cilala. MaruIic vi dichiara: Ioslo|e neke
vIaslilosli |ezika od naravi lako odredene, da mnoge od n|ih ko|e su u |ednom |eziku
zgodne, rikIadne i Ii|eo izrazene, kad se renesu u drugi, izgIeda|u izoaene i neo-
lune (Isislono deIIe arlicoIarila di una Iingua malerna cos definile che moIle di esse
che in una Iingua sono carine, adalle e ben esresse, una voIla lrasferile neII'aIlra Iin-
gua, sembrano snalurale e incomIele).
26 MaruIic Io melle er iscrillo neIIa missiva aII'amico IaaIic in cui gIi manda Ia
sua versione Ialina di Vcrginc |c||a. Nolizie imorlanli in merilo aIIe osizioni
lradulloIogiche di MaruIo confronla iI rimando di MIRKO TOMASOVIC a Maru|c|cskc
ira!ukic|cskc pcsiatkc, nola 39, . 63-68, in TOMASOVIC Qua| c cc|ui cnc jcrsc !i Crcazia.,
cil., . 58 nola 58.
27 NeII'eisloIa a }eroIim Ciiko deI 19 IugIio 1501 I'aulore solloIinea Ie anaIogie fra
Ia sua ju!iia e Ia Oitina Ccnnc!ia. L'argomenlo e slalo lrallalo da TONKO MAROVIVIC in
Oikc icr nta|jcnja, SIil 1986, . 11-18, aIlrellanlo da IVO IRANGIS in Oanic, Ka|icctic,
Maru|ic, in Cc||cquia Maru|iana, V, . 129-130, nonche da ANTONILLO CAVALLOTTO,
Markc Maru|ic, i| Oanic crcaic, in |nsicnc, Roma, s.a., I, n 0, A I-C, . 7.
Suzana GIavas 692
NON TANTUM SIICTASSI IUIT: MIMORANDO IAVORIS
OIIIRTUS IACIIS IT ADHUC CONTIRRITA IULSAT
CORDA MITUS, VIX IISA MAIS MIHI DURA VIDIRI MORS
IT ACIRA IOTIST.
28
IV. DUI ISTRIANI INTIRIRITI DI DANTI NIL CINQUICINTO
TIDISCO
Due sono gIi islriani coraggiosi e imorlanli er I'esegesi danlesca.
Mallhias IIacius IIIricus (VIaic), nalo neI 1520 ad AIbona (Labin)
in Islria, fu disceoIo, amico e successore di Lulero. Comili gIi sludi
a Venezia, si reco in Germania, a Willenberg, dove, aII'ela di 24 anni,
ollenne Ia calledra di Iingua ebraica, asso oi a }ena ad insegnare Ia
sloria deI Nuovo Teslamenlo. Ira in Iolla con MeIanchlone e difese
senza comromessi I'orienlamenlo leoIogico e oIilico di Lulero.
Ierseguilalo e caccialo da }ena, mor overo e isoIalo a Irancoforle neI
1575, Iasciando un Caia|cgus icsiiun tcriiaiis in cui menziono Danle.
Comoslo su inizialiva di Lulero, iI Caia|cgus si rooneva di rare-
senlare Ia rova slorica di come Ia vera chiesa fosse slala deformala da
queIIa faIsa, nonche di alleslare Ia ura verila evangeIica conlro iI a-
alo e conlro iI ceIibalo dei chierici. Va ricordalo che neI 1552, selle
anni rima deIIa ubbIicazione deIIa edilio rinces deIIa Mcnarcnia
di Danle, IIacius imIorava un suo disceoIo di rocurargIi un mano-
scrillo deIIa Mcnarcnia. II Caia|cgus usc a asiIea neI 1556, Ia Mcnarcnia
fu slamala neI 1559, lre anni doo. II asso su Danle neI Caia|cgus
cila Ia Mcnarcnia, come rova orlala da Danle su come iI Iaa non e
sueriore aII'imeralore e non ossiede aIcun dirillo suII'imero.
IIacius fece richiamo anche aI ensiero danlesco esresso neI Ccntitic,
reIalivo aI malrimonio (Iibro IV, ca. XXVIII 9) in cui Danle avrebbe
equiaralo iI malrimonio aI ceIibalo, e in cui si dice:
I non si uole aIcuno scusare er Iegame di malrimonio, che in
Iunga elade Io lenga, che non lorna a reIigione ur queIIi che a
sanlo enedello, a sanlo Auguslino, a sanlo Irancesco e a sanlo
Domenico si fa d'abilo e di vila simiIe, ma eziandio a buona e
vera reIigione si uo lornare in malrimonio slando, che Dio non
voIse reIigioso di noi se non Io cuore
29
.
Irima di IIacius, un aIlro islriano di Caodislria (Koer), nalovi
28 Cfr. CARLO DIONISOTTI, M. Maru|c ira!uiicrc !i Oanic, in Miscc||anca I. |crrari, Ii-
renze 1952, . 235.
29 Cfr. Ic cpcrc !i Oanic, Iirenze, Sociela Danlesca IlaIiana 1960, . 289.
|| tiaggic !i Oanic in Crcazia ira rca|ia c ipcicsi 693
neI 1498 da nola famigIia, aveva chiamalo Danle anlagonisla deIIa
chiesa romana. Iu Iielro IaoIo Vergerio, Iaurealo in leoIogia e in diril-
lo a Venezia, eIello oi vescovo di Modrus e di Caodislria, e daI 1532
aI 1536 aI servizio deIIa Curia di Roma, oi nunzio aIIa corle di Vienna
resso iI fuluro imeralore Iederico I. Irocessalo daII'Inquisizione,
mor a Tbinga neI 1564. In un suo Iibrello suII'IdoIo di Lorelo, sleso a
Tbinga neI 1554, si lrova Ia rima segnaIazione di Danle neI Cinque-
cenlo ledesco: Ia cilazione deII'|njcrnc, XIX 106-114, in ilaIiano con
versione Ialina
30
. Queslo asso suII'avidila di denaro dei reli voIeva
dimoslrare che anche er Danle, come sosliene Ia sludiosa MarceIIa
Roddeig, Ia Roma deIIa Curia era idenlica aIIa grande merelrice
deII'AocaIisse
31
. InoIlre, secondo Vergerio, ne Danle ne Ielrarca ne
occaccio avevano mai arIalo deI lrasferimenlo miracoIoso deIIa casa
deIIa madre di Dio da Nazarelh a Iiume neI 1291, oi lre anni iu lar-
di deII'aIlro lrasferimenlo miracoIoso da Iiume aIIa Marca d'Ancona
(Lorelo). I se Vergerio era conlro Ia credibiIila deI cuIlo deIIa Sanla
Casa, come era ure conlro iI cuIlo dei Iiorelli e di San Irancesco
32
,
Danle sosliene Ia sludiosa deI Vergerio non avrebbe mai arova-
lo iI viIiendio deI cuIlo e non avrebbe mai voIulo aboIire iI aalo
33
.
Sla di fallo che i due inlerreli di Danle in OIanda, dai Ioro avversari
chiamali fugiaschi sIavi, allraverso Ie Ioro inlerrelazioni arziaIi e
anliaaIi hanno agilo in maniera iu efficace che non ammiralori e
conoscilori iu rofondi deIIe oere danlesche
34
.
V. LA LITTURA DI IVAN LIROTIC DILLA DANTISCA DIVINA
CROAZIA
NeI 2004 usciva a Zagabria, er i lii deIIa edilrice iakova, iI
voIumello Oanic i nrtaiskc zcn|jc (Oanic c |c icrrc crcaic) di Ivan Lero-
lic
35
. NeIIa cilala sede Io sludioso croalo ribaIla aIcune inlerrelazioni
30 Oc i!c|c |aurcianc, quc! |u|iun |||. |cna. |pisccpun ncn pu!uii in iania |ucc |uangc-
|ij un!iquc crunpcnic, uc|uii in ccnicnpiun Oci aiquc ncninun, apprc|arc. Vcrgcrius iia|icc
scripsii, Iu!cuicus cius ncpcs ucriii. Anno M. D. LIIII, Lubingae, . 49-53.
31 MARCILLA RODDIWIG, in Maiiia ||acic |||iricc. jcriuna !un inicrprcic !anicscc nci
pacsi !c| Ncr!, in Oanic i s|atcnski stijci/Oanic c i| ncn!c s|atc, cil., . 553-559, cil. 555.
32 Oisccrsi scpra i jicrciii !i San |ranccscc, nc qua|i !c||a sua tiia c !c||c suc siignaic si
ragicna, anon., s 1., 1549. Cfr. MARCILLA RODDIWIG, o. cil., . 555 nola 13.
33 enche Danle non sia fra i leslimoni deI lrasferimenlo deIIa Sanla Casa, non
avrebbe mai arovalo iI viIiendio deI cuIlo. enche abbia crilicalo dei ai e Ia cor-
rulleIa deIIa chiesa con voce di Ieone, non ha mai voIulo aboIire iI aalo, in Maiiia
||acic |||iricc. jcriuna !un inicrprcic !anicscc nci pacsi !c| Ncr!, in Oanic i s|atcnski sti-
jci/Oanic c i| ncn!c s|atc, cil., . 553-559: 555.
34 Ivi, . 556.
35 AII'eoca in cui rearavo quesla Icciura Oaniis Ivan Lerolic viveva a Zagabria.
Suzana GIavas 694
ed iIIumina aIcuni assi deIIa Oitina Ccnnc!ia rimasli iulloslo oscu-
ri
36
.
CoI verso O menle, che scrivesli cio ch'io vidi (|njcrnc II, v. 8),
Lerolic riveIa subilo Ia sua chiave di Iellura: lullo sla scrillo neI leslo
di Danle, lullo fu daI oela vislo e vissulo, e nei 100 canli deII'esuIe
fiorenlino vi sono lracce evidenli, seur mascherale da melafore e
rime, di un viaggio reaIe in Croazia.
Danle slesso un aio di voIle esIicilamenle richiama I'allenzio-
ne deI Iellore suIIa comIessila deI discorso aIIegorico che sla svoI-
gendo:
O voi ch'avele Ii 'nleIIelli sani,
mirale Ia dollrina che s'asconde
sollo 'I veIame de Ii versi slrani,
(|nj. IX, vv. 61-63)
AvendogIi comunicalo che avrei arIalo deIIe sue ricerche a NaoIi, ne era conlenlo ed
onoralo. Mi ha anche aiulalo a comrendere megIio iI suo Iibro, qui resenlalo, scrillo a
mo' di aunli iu che come un vero saggio. Mi ha inoIlre rearalo un romemoria
con cose er Iui imorlanli da lrallare e cilare. NeII'allesa che queslo conlribulo uscisse
negIi alli, Ivan ci ha Iasciali. Rimangono Ia sua oera e Ia sua assione er arIarci di
Danle, e lra Ie aIlre cose, cio che Io faceva inorgogIire, Ia coincidenza neI eriodo di na-
scila (er Lerolic iI 24 maggio). La Iingua, ero, non gIi era comune, Ie conoscenze di
Lerolic deIIa Iingua ilaIiana erano assive. Tengo a recisare che lulli gIi sludi e Ie ricer-
che da Iui effelluali sono slali svoIli in base aIIe lraduzioni croale deIIe oere di Danle
(forlunalamenle lradolle lulle) e che Io sludioso croalo si e servilo ben oco di fonli cri-
liche e slorico-Iellerarie ilaIiane su Danle. Iure, vedremo iu in Ia, come Ie sue 'rive-
Iazioni' combaciano in aIcuni unli con Ie ricerche svoIle da grandi nomi, lra cui ad e-
semio queIIa deIIa coia di rinomali sIavisli RICCARDO IICCHIO-MARIA IICCHIO
SIMONILLI: | ccnjini cricnia|i !c| ncn!c !i Oanic di cui si arIa in seguilo neI coro deI
leslo.
36 Nalo neI lurbinio deIIa guerra, ha vissulo e frequenlalo Ie scuoIe a Imolski (relro-
lerra daImala) e a SIavonski rod (SIavonia). Si e iscrillo oi aII'Accademia Iedagogica
e ha frequenlalo Ia IacoIla di Giurisrudenza. Ioela e illore, negIi uIlimi dieci anni
deIIa sua vila ha suscilalo inleresse e oIemiche con Ie sue rifIessioni slorico cuIluroIo-
giche. Tra gIi sludi i iu imorlanli risuIlano: Oanic i nrtaiskc zcn|jc, Bascanska p|cca,
Sa|cri Hrtaia u Cisii Vc|ikcj, e lemi riguardanli gIi esordi deIIa sloria croala, da Iui rein-
lerrelali con originaIila, quaIi Oc a!ninisiran!c inpcric !i Kcsianiinc Pcrjircgcncic in
Bizaniski car Kcnsianiin V|| Pcrjircgcnci i Hrtaii (2008) e Pctijcsi Hrtaia (2009).
II suo amico e comaesano IVAN IKAVAC ASIC, fiIoIogo cIassico, ha ubbIicalo un
senlilo |n ncncrian accomagnalo deII'eIenco deIIe ubbIicazioni di Lerolic, lra cui
siIIogi di oesia e sceIle di brani Iellerari e slorico-Iellerari resenli in varie anloIogie.
Riguardo aIIe ricerche su Danle, vi si ricordano Ie seguenli ubbIicazioni: Oanicctc siazc
pc Hrtaiskcj . nctc stjci|c (2001), Oanic u Hrtaiskcj . Augusiin Kazciic, tc!ic . isirazitanja
(2002), Oanic i nrtaiskc zcn|jc (2004), Oaniccta carc|ija cu!csa . stjci|cn nirisa Bcairicc
Oanicctc Bczansitcnc kcnc!ijc a|iii Vc!ic Oanicctcn |czansitcncn Hrtaiskcn (2007). Cfr.
IVAN IKAVAC ASIC, |n ncncrian |tan Icrciic, in Ictrccki |i|ar, Zagreb, ed. Duslvo Lo-
vrecana Zagreb 2009-10, . 152-154.
|| tiaggic !i Oanic in Crcazia ira rca|ia c ipcicsi 695
ma anche suIIa lrasarenza deII'aIIegoria:
Aguzza qui, Iellor, ben Ii occhi aI vero,
che 'I veIo e ora ben lanlo solliIe,
cerlo che 'I lraassar denlro e Ieggero.
(Purg. VIII, vv. 19-21)
V.I. IL TRASIIRIMINTO DILLA SANTA CASA DA TRSAT-RI}IKA/ IIUMI
A LORITO
Uno dei unli chiave deIIa ricerca deI Vero neI Pccna deI Iiorenli-
no e Ia queslione deI lrasferimenlo deIIa Sanla Casa da Trsal-Ri|eka/
Iiume a Lorelo. Di queslo evenlo, secondo Lerolic, Danle sarebbe
slalo addirillura leslimone ocuIare.
SuIIa scia deIIe aIesi lracce deI vissulo di Danle imresso neIIa
Ccnnc!ia, Lerolic roone Ia lesi che vedrebbe Danle lrascorrere, neI-
Ia vila reaIe, un anno quasi in eIIegrinaggio er Ie lerre croale (lra iI
1304 e i 1305) a seguilo deI suo VirgiIio reaIe. II VirgiIio deI Pccna in
reaIla sarebbe slalo iI vescovo croalo Anlun Kazolic, nalo a Trau neI
1260, formalosi neII'ordine dei domenicani a SaIalo e oi aIIa Sor-
bonne di Iarigi, guida dei eIIegrini croali er iI giubiIeo di Roma neI
1300, e daI 1301 in servizio diIomalico a carico deIIa Sanla Sede con iI
cardinaIe occaIini (aa enedello XI) neI Regno di Croazia e in
queIIo ungarico. Danle avrebbe re-inconlralo Kazolic in lerra sIovena,
nei ressi deIIe Grolle di Ioslumia o queIIe di Skoc|an. Si iolizza che
Danle avrebbe avulo modo di conoscere Kazolic di ersona in IlaIia,
se non rima deI giubiIeo aIIora er queIIa dala a Roma. Le lracce deI
viaggio reaIe deII'esuIe Danle si erdono a Verona lra iI 1304 e iI
1305
37
. In queI eriodo Kazolic (forse di rilorno da Treviso`) era direl-
lo a Zagabria, dove quaIche mese rima era slalo nominalo vescovo
er voIere deI aa enedello XI.
QuaI e coIui che forse di Croazia
viene a veder Ia Veronica noslra,
37 Cfr. IVAN LIROTIC, Oanic i nrtaiskc zcn|jc, cil., . 32. NeIIa nola 48 deIIa cilala a-
gina Lerolic inlerrela i versi 79-81 deI canlo X deII'|njcrnc (Ma non cinquanla voIle fia
raccesa / Ia faccia deIIa donna che qui regge / che lu sarai quanlo queII'arle esa). La
Iellura di Lerolic e Ia seguenle: Non asseranno cinquanla mesi, rofelizza Iarinala,
che a le locchera Ia medesima sorle. Siccome Ia conversazione si svoIge, secondo iI
Ioema, neII'ariIe 1300, queslo ci orla aII'anno 1304. Danle fu esiIialo neI 1302, e doo
aIcuni invani lenlalivi di rilorno, lenlali dai suoi seguaci, egIi si congedo da lulli i com-
agni deI arlilo neII'eslale 1304 rimanendo er semre un esiIialo.
Suzana GIavas 696
che er I'anlica fame non sen sazia,
ma dice neI ensier, fin che si moslra:
Signor mio Iesu Crislo, Dio verace,
or fu s falla Ia sembianza voslra`,
laI era io mirando Ia vivace
carila di coIui che 'n queslo mondo,
conlemIando, guslo di queIIa ace.
Danle qui si lrova neII'Imireo e San ernardo gIi aare in quaIi-
la di uIlima guida, neIIa fase decisiva deI viaggio, er condurIo aI
momenlo risoIulivo deIIa conlemIazione dei iu aIli misleri divini.
L'oscuro eIIegrino, secondo MomigIiano una deIIe figure non di-
menlicabiIi deI oema
38
, er Lerolic non e aIlri che iI vescovo croalo
Kazolic. Sarebbe slalo Iui a fare da guida reaIe a Danle in Islria, ovve-
ro neII'allraversamenlo deIIe lerre rima croale, oi sIovene e oi di
nuovo croale. II vescovo croalo avrebbe orlalo Danle di ersona a vi-
silare Ie Grolle di Ioslumia, enlrando ero da Iazin, versanle croalo
deII'Islria. Si sarebbe quindi lrallalo di una visione reaIe deI mondo
sollerraneo e queIIa avrebbe Iascialo suII'esuIe errabondo, corroso or-
mai neIIa saIule deI coro e in queIIa deII'animo, un'imressione cos
forle
39
.
Ier me si va ne Ia cilla doIenle,
er me si va ne I'ellerno doIore,
er me si va lra Ia erdula genle.
Giuslizia mosse 'I mio aIlo fallore,
fecemi Ia divina odeslale,
Ia somma saenza, e 'I rimo amore.
Dinanzi a me non fuor cose creale,
se non ellerne, e io ellerno duro.
Lasciale ogne seranza, voi ch'inlrale.
(|nj. III, vv. 1-9)
II coincidere e I'incrociarsi dei ercorsi ersonaIi lra Danle e
Kazolic, in base ai dali slorici, induce Lerolic a inlerrelare neIIa sim-
boIica e aIIegorica figura di VirgiIio Ia ersona di Kazolic, uno degIi
uomini e reIali iu islruili e carismalici deI suo lemo, deslinalo a
Lucera neI 1322 daI aa Giovanni XXII er difendere Ia crislianila, vi
mor neI 1323 a causa di una ferila e fu seoIlo, Iasciando leslimonian-
38 Da MIRKO DIANOVIC, Oanic c i Crcaii, II Ionle. Rivisla mensiIe di oIilica e Iel-
leralura dirella da Iiero CaIamandrei, Iirenze, La Nuova IlaIia 1955, nn. 8-9, . 1429.
39 Cfr. IVAN LIROTIC, Oanic i nrtaiskc zcn|jc, cailoIo Pazin, cil., . 46-47.
|| tiaggic !i Oanic in Crcazia ira rca|ia c ipcicsi 697
ze di grandi miracoIi comiuli suIIa ooIazione deI Iuogo
40
.
Allienli ben, che er colaIi scaIe,
disse 'I Maeslro, ansando com'uom Iasso,
conviensi diarlir da lanlo maIe.
Ioi usc fuor er Io fro d'un sasso,
e uose me in su I'orIo a sedere,
aresso orse a me I'accorlo asso.
Io Ievai gIi occhi, e credelli vedere
Lucifero com'io I'avea Iascialo,
e vidiIi Ie gambe in s lenere.
(|nj. XXXIV, vv. 82-90)
Seguendo Ie lae deI viaggio narralo da Danle, Lerolic idenlifica
Ie IocaIila di Ioslo|na e Skoc|an in lerra sIovena coI fiumicino Iivka e
iI monle }avornik
41
a raresenlare I'ingresso e I'uscila deII'|njcrnc:
com'era quivi, che se Tambernicchi
vi fosse s cadulo, o Iielraana,
non avria ur da I'orIo fallo cricchi.
(|nj. XXXII, vv. 28-30)
Rirendendo iI discorso suIIa Sanla Casa, si sosliene che Danle
avrebbe inlrareso iI suo reaIe viaggio di rilorno daIIa Croazia iI gior-
no deI Venerd Sanlo deI 1305. A leslimoniarIo, afferma Io sludioso
croalo, sono Ie uIlime lre canliche deIIa Ccnnc!ia, ove iI Sommo sollo-
Iinea che nuIIa fu un caso in queI viaggio, essendo slalo Iui abbagIialo
daIIa Iuce divina a leslimoniare di un miracoIo.
A queslo unlo risuIla inevilabiIe rievocare due Ieggende: una se-
condo cui Irancesco d'Assisi, in viaggio aIIa voIla deIIa Siria (1212),
doo una bufera infernaIe neI GoIfo deI Quarnaro, avrebbe lrovalo
riaro a Trsal, un quarliere di Ri|eka/Iiume in Croazia, e vi avrebbe
avulo Ia visione deI lrasferimenlo deIIa Casa di Nazarelh a Trsal, a-
unlo, I'aIlra secondo cui a Trsal, iI 10 maggio 1291, come iombala
daI cieIo, comarve Ia Casa di Nazarelh, ma che gIi angeIi, iI 10 di-
40 Cfr. LIROTIC, Oanic i nrtaiskc zcn|jc, cailoIo Tkc jc Augusiin Kazciic?, cil., . 53-
56.
41 Cfr. LIROTIC, Oanic i nrtaiskc zcn|jc, cailoIo Pcsicjna, . 57-59. NeIIa nola 64,
. 58, Lerolic ricorda Ie due iolesi suIIa IocaIila di Tabernicchi: c'e chi sosliene che si
lralli di Tovarnik/Iruska Gora neIIa regione serba deIIo Sri|em, c'e invece chi sosliene
che si lralla di }avornik resso Ioslo|na, daII'elimo Iielraana (AIe Aunana, Ial. Ielra
Auana, lra iI Serchio e Ia Magra) e rimanda aII'|ncic|cpc!ia S|ctcna.
Suzana GIavas 698
cembre 1294, da Trsal Ia orlarono via er IasciarIa a Lorelo.
Rievocando i dali slorici, Lerolic ricoslruisce I'evenlo nei seguenli
lermini:
A nome deII'IsIam, neIIa cilla sanla di GerusaIemme, con Ie
sciaboIe sguainale enlrarono a cavaIIo er rimi i Turchi neI
1071. La ferila inferla aIIa Terra Sanla indusse i ai e i sovrani
euroei ad aIIarmarsi, cos ebbero inizio Ie guerre dei crociali
(1095-1217) fedeIi conlro gIi infedeIi. A rolezione dei eIIegrini
euroei fu fondalo I'ordine cavaIIeresco dei TemIari (1119).
AIIorquando gIi isIamici conquislarono Ia IaIeslina, con
I'uIlima roccaforle e orlo di Accra (1291), cadde in mano Ioro
I'uIlimo baIuardo dei crociali in Terra Sanla. Coslrelli a rilirarsi,
i crociali e sorallullo i cavaIieri TemIari, con i monaci france-
scani e queIIi cislercili orlarono con Ioro in Iuroa Ie reIiquie
deIIa Terra Sanla, Ie ielre di Nazarelh, Ie mura deIIa Casa deIIa
Sacra IamigIia. Danle leslimonia che Ie ielre sacre sono slale
orlale a Trsal daIIa IaIeslina grazie ai reli cislercili, fraleIIi
deI maeslro San ernardo
42
.
Lerolic sosliene che soIlanlo un cislercila avrebbe olulo racconla-
re a Danle lulla Ia sloria inlorno aII'accadulo in Terra Sanla e,
ricordando iI verso 102 deI XXXI canlo deI Para!isc Ierocch'io sono iI
suo fedeI ernardo, one Ia domanda suI erche rorio un mislico
avrebbe dovulo fungere da guida di Danle neII'Imireo. I si aulori-
sonde con una domanda relorica:
Chi aIlri oleva essere iu merilevoIe in quaIila di guida er Ie
corli di Maria` |.j ernardo era iI iu imorlanle ensalore
deI XII secoIo, gIi venivano chiesli consigIi da arle dei re e dei
ai. Si imegnava a che fosse onoralo iI nome di Maria (Ia ce-
lra di Maria). AIIa donna, aIIa madre, rileneva, bisognava dare
iI oslo che er nalura Ie sella. Ad onorare Ia donna-madre
anche Danle ha dalo iI suo conlribulo |.j. Iercio neII'Imireo
un fraleIIo di ernardo diviene guida e inlerrele aI sommo
oela
43
.
NeIIa ricoslruzione slorica roosla daI Noslro iI lrasferimenlo
deIIa Sanla Casa sarebbe in verila andalo cos:
42 LIROTIC, Oanic i nrtaiskc zcn|jc, cailoIo Trsai-|ijcka-Icrcic, . 171-172.
43 Ivi, . 172-173.
|| tiaggic !i Oanic in Crcazia ira rca|ia c ipcicsi 699
I cuslodi deIIa Casa si imbarcano suIIa nave di un armalore gre-
co e giungono neII'Adrialico sellenlrionaIe. Sbarcando a Ri|eka,
coIIocano Ia Casa a Trsal neII'IIIricum ovvero neII'odierna
Croazia (10 maggio 1291). II rorielario di Trsal e i frali fran-
cescani agano i crociali TemIari chiamali servilori di Dio e
quesli oi se ne lornano a casa Ioro Iungo I'Iuroa. NeI 1292
CarIo MarleIIo d'Angio, er voIere dei regnanli croali, viene
rocIamalo re dei Croali. La Casa di Nazarelh si lrova ancora a
Trsal erche non e slalo agalo I'armalore greco. A Lorelo si
conserva iI dalo che neI 1294 iI desola di Iiro, Niceforo
AngeIi, cede Ia figIia come romessa sosa a IiIio di Taranlo,
figIio di CarIo II d'Angio, re di NaoIi, e vi lrasorla una serie
di doni lra cui anche Ie sacre ielre orlale via daIIa casa deIIa
eala Vergine Maria
44
.
Che iI rorielario deIIa nave su cui sono slale lrasorlale Ie sacre
ielre fosse slalo Niceforo AngeIi, rimane un dalo ignolo, ma una cosa
e cerla, concIude Lerolic:
|.j Ie sacre ielre si lrovano indicale neII'eIenco dei doni, di-
venlando cos roriela deIIa dinaslia regaIe di CarIo MarleIIo
d'Angio, gia a cao deI regno ungaro-croalo. CarIo MarleIIo
muore neI 1295 senza aver mai messo iede in Croazia |.j. SuI
lrono croalo neI 1301 saIe iI figIio di CarIo MarleIIo, CarIo I Ro-
berlo, e oIlre ai nobiIi croali Io conferma iI aa onifacio VIII.
Si sara verificalo un conlrallare fra gIi Angio e Roma` Le sacre
ielre er Ia corona` La Casa di Nazarelh er iI regno croalo`
45
A quesla serie di domande reloriche si cerca subilo di dare riso-
sla.
Roma daI re croalo CarIo I Roberlo chiede che siano risellali
i alli. L'esecuzione deI allo e iI agamenlo deI debilo e re-
vislo er Ia Iasqua deI 1305 e Ia Casa di Nazarel viene lra-
sferila da Trslal in IlaIia. La Casa suIIa nave greca da Trsal-
Ri|eka/Iiume naviga verso Venezia, oi aIIa voIla di Ravenna,
conlinuando oi er iI orlo aaIe di Ancona, ovvero Lorelo.
Sara slala indirizzala a Roma`
46
44 Ivi, . 173-174.
45 ||i!.
46 Cfr. ivi, . 174-175.
Suzana GIavas 700
AI quesilo soIIevalo Lerolic ronlamenle risonde: Irolella da
Nelluno, dio romano deI mare, Ia nave greca e sicura che iI sacrc caricc
e deslinalo ad arodare neI orlo reslabiIilo. In Danle si lrova Ia
leslimonianza deIIa fesla asquaIe deI 1305
47
:
Un unlo soIo m'e maggior Ielargo
che venlicinque secoIi a Ia 'mresa,
che fe Nelluno ammirar I'ombra d'Argo.
(Par. XXXIII, vv. 94-96)
La ricoslruzione slorica degIi evenli offre di quesli versi I'originaIe
(azzardala`!) esegesi di Lerolic secondo cui quesl'immagine danlesca,
di slraordinaria vaIenza oIisemica, iI Ioela I'avrebbe ensala cos:
Un soIo allimo lrascorso neIIa conlemIazione di Dio, ha causa-
lo in me meravigIia maggiore di queIIa che negIi uomini, doo
venlicinque secoIi, uo rovocare I'imresa degIi Argonauli.
Argo si chiamava Ia nave degIi Argonauli. L'immagine deI
verso 96 riveIa come Nelluno, dio deI mare, rimane incanlalo
neI vedersi assare I'ombra deIIa nave Argo sora Ia lesla. La
nave Argo lrasorlava gIi Argonauli e iI veIIo d'oro. I I'ombra
di queIIa rima nave che soIcava Ie onde deI mare riem Nel-
luno di sluore. Ma iI momenlo descrillo da Danle e di sluore
ancor iu grande di queIIo deI dio romano deI mare. IgIi ram-
menla Ia meravigIia di Nelluno neI caso deI lrasorlo deI sacro
carico deI veIIo d'oro suII'anlica nave greca aIIo sluore da Iui
rovalo dinnanzi aI lrasorlo deI carico sacro deIIa Sanla Casa
da Trsal in Croazia verso Ancona
48
.
Lerolic sosliene che Danle, aI rienlro daIIa Croazia in IlaIia, si sa-
rebbe lrovalo a arleciare, er voIere deI caso, aI lrasorlo deIIe
reziose ielre. La scarsa nolizia di Lorelo suIIa Casa di Nazarel deI
1294 uo essere considerala una leslimonianza suIIe modaIila deI
lrasorlo onde evilare confIilli.
Sosliene inoIlre Io sludioso croalo che in Danle vi e Ia leslimonian-
za che Ia Sacra Casa di Lorelo fu lrasorlala da Trsal in Croazia
neII'anno 1305. La navigazione non era un eIIegrinaggio semIice e
isoIalo. Vi era lulla una rocessione di navi con Ia dovula sorvegIian-
za. I, slando cos i falli, concIude Lerolic, e slalo queIIo un lrasorlo
da Trslal decisamenle aslulo e saggio assai. I iI lullo accade nei giorni
47 Cfr. ivi, . 175.
48 Ivi, . 175-176.
|| tiaggic !i Oanic in Crcazia ira rca|ia c ipcicsi 701
in cui si naviga aIIa voIla di Venezia er Ia fesla asquaIe deIIo so-
saIizio di Venezia con iI mare. Iesleggianli, eIIegrini e nobiIla croala
in viaggio verso Venezia er arleciare aIIa fesla, commenla Lerolic,
e Ia nave, come Ia nave Argo deIIa miloIogia greca che lrasorlo iI
veIIo d'oro. SlavoIla ero, rolelli daI dio romano di Nelluno, lrasor-
lano Ie sacre ielre a Venezia, Ravenna e oi ad Ancona, er IasciaIe
er semre a Lorelo. Assisi e Roma sono iu dislanli, siega Lerolic,
er cui rimangono rivali di quesla reziosa reIiquia.
I signori di Trsal, i conli Irancoan (Irangeani), robabiImenle
sono, suone Lerolic, i condonalori deIIa Casa aI Iaa, con Io scoo
di assicurare Ia Iiberla aIIa Croazia. O iI lullo sara slalo fallo aIIa Ioro
insaula. A quesla ennesima domanda relorica, iI Noslro da Ia sua
risosla definiliva: Roma e Ia Croazia, Ia Croazia calloIica! Grande
neIIa fede e neIIa generosila.
49
.
Secondo Lerolic un dalo e cerlo: Ia leslimonianza di Danle suIIa
sua arleciazione aI lrasorlo deIIa Casa daIIa Croazia in IlaIia. Se
invece ci fossero slale leslimonianze scrille, non ci sarebbe slalo iI
miracoIo. Ma iI miracoIo e accadulo, affinche non fosse rinnegala Ia
Verila. Danle, quindi, leslimone e scriba in una soIa ersona
50
.
Dovesse I'inlerrelazione di Lerolic corrisondere aI Vero, si lro-
verebbe qui anche Ia risosla aI Vergerio, iI quaIe ricordiamoIo si
era domandalo, meravigIialo aIquanlo, come mai deI lrasorlo deIIa
Sacra Casa non fosse rimasla lraccia scrilla ne in Danle, ne in Ielrarca,
ne in occaccio.
V.II. I CROATI NILL'IMIIRIO
Anche I'Imireo e dedicalo ai Croali, nominali come barbari
deII'aIlra sonda deII'Adrialico:
Se i barbari, venendo da laI Iaga
(Par. XXXI, v. 31)
Irano ero dei barbari che rimanevano sluefalli dinnanzi aIIa beI-
Iezza degIi edifici e deIIe vesligia deII'anlica Roma:
veggendo Roma e I'arda sua ora,
sluefaciensi, quando Lalerano
a Ie cose morlaIi ando di sora,
(Par. XXXI, vv. 34-36)
49 Cfr. ivi, . 177.
50 Cfr. i|i!.
Suzana GIavas 702
Come queI Croalo che si riosa daIIe faliche deI Iungo e ericoIoso
viaggio davanli aI sanluario, mela deI suo eIIegrinaggio:
I quasi eregrin che si ricrea
neI lemio deI suo volo riguardando,
e sera gia ridir com'egIi slea...
(Par. XXXI, vv. 43-45)
Id infine, in uno dei momenli di subIimazione, I'immagine deI
Croalo eslasialo dinnanzi aI Sudario deIIa Veronica:
QuaIe e coIui che forse di Croazia
viene a veder Ia Veronica noslra,
che er I'anlica fame non sen sazia,
ma dice neI ensier, fin che si moslra,
'Segnor mio Ies Crislo, Dio verace,
or fu s falla Ia sembianza voslra`'
(Par. XXXI, vv. 103-108)
NeII'immagine deI devolo Croalo Lerolic rinviene Ie sembianze deI
vescovo Kazolic, che neII'anno deI giubiIeo si lrovava a Roma ad
accogIiere i eIIegrini deIIa Croazia. Un guarilore maleriaIe e siri-
luaIe
51
negIi anni iu difficiIi deII'esislenza deI Iiorenlino, sua guida
reaIe er I'Islria e Ie lerre sIovene e croale fino a Zagabria, infine suo
generoso anfilrione neI vescovado di Zagabria
52
.
I due, se non rima, si sarebbero conosciuli a Roma, in seguilo
avrebbero concordalo di recarsi insieme a }urandvor er visilare iI
sanluario di Sanla Lucia suII'isoIa di Krk/VegIia in Islria. I quesli ver-
si, secondo Lerolic, sarebbero iI ringraziamenlo di Danle aIIa giovane
comunila calloIica, I'unica aI mondo che neI 679 aveva sliuIalo un
allo con iI Iaa Agalon er non allaccare i ooIi vicini, cosa di cui
esisle leslimonianza scrilla Iasciala daII'imeralore bizanlino Coslan-
lino Iorfirogenelo VII neI X secoIo in Oc A!ninisiran!c |npcric.
Icco erche rorio i Croali, quei barbari in eIIegrinaggio a
Roma neI 1300 olevano essere resi ad esemio er Ie Ioro doli
umane e iI Ioro fervenle credo reIigioso, degni di ogni risello nonche
di essere aoslrofali, gIorificali. I calloIici Croali sin daI rinciio deI
51 I dalo risaulo che Kazolic gia aII'eoca dei suoi sludi a Iarigi era eserlo di
medicina. I aIlrellanlo risaulo che subilo doo I'assassinio a Lucera giunse aIIa Chiesa
Ia richiesla dei fedeIi er Ia sua rocIamazione a sanlo. Cfr. anche LIROTIC, Oanic i
nrtaiskc zcn|jc, cil., . 53-56.
52 Cfr. LIROTIC, Oanic i nrtaiskc zcn|jc, cailoIo Zagrc|, cil., . 62-68.
|| tiaggic !i Oanic in Crcazia ira rca|ia c ipcicsi 703
Ioro esislere come nazione vivevano in un regno, con a cao iI sovrano
TomisIav a cui iI aa Giovanni II confer iI liloIo di rcx (fra iI 914 e iI
925). I curioso nolare che Io slesso aa fece con TomisIav cio che
non fece con iI suo conlemoraneo vicino di casa, iI serbo Miha|Io
Zahumski, aI quaIe allribu iI semIice liloIo nobiIiare di !ux. Sara
slalo erche Miha|Io era sovrano di un lerrilorio sollo Ia giurisdizione
bizanlina, e TomisIav invece di queIIo sollo Ia giurisdizione deIIa
Chiesa di Roma`!, si chiede Lerolic
53
.
A favore di quesla inlerrelazione arIa una ricerca svoIla da
Riccardo Iicchio e sua mogIie Maria Iicchio SimoneIIi
54
, di cui Lerolic
di cerlo non era aI correnle
55
. CoI lema scollanle de | ccnjini cricnia|i !c|
ncn!c !i Oanic
56
Ia coia di iIIuslri sIavisli inlerrela iI messaggio
ideoIogico di Danle. Non ossiamo non concordare con Ioro quando
affermano, semre in base a quanlo Danle slesso riferisce neIIa Ccn-
nc!ia e neIIe aIlre sue oere, che i Iimili deIIa sua geografia siriluaIe
erano incenlrali escIusivamenle su una crislianila daIIe lradizioni
Ialino-germaniche. Occidenle ed Orienle crisliano erano ai lemi deI
Iiorenlino ancora imegnali in conlinue schermagIie diIomaliche e
miIilari che arevano sesso reIudere ad un confIillo finaIe. La osla
in giuoco era iI conlroIIo non soIo deIIa ormai rislrella area di dirello
dominio coslanlinooIilano, ma di buona arle aImeno deIIa crislia-
nila sIava orlodossa
57
. Icco come Io commenlano i Iicchio:
L'unico concrelo riferimenlo oIilico aI mondo sIavo-baIcanico
riguarda MiIulin (Slefano Uros II) di Serbia: ...queI di Rascia /
che maIe ha vislo iI conio di Vinegia, (Para!isc, XIX, vv. 140-
141). Ier vaIulare megIio quesla sceIla (che concIude una
lerzina di nolevoIe amiezza geografica: I queI di IorlogaIIo e
di Norvegia... queI di Rascia...) sara uliIe osservare che queI
di Rascia era un imorlanle aIIealo, conlro I'imeralore An-
dronico II, di aa CIemenle IV e di CarIo di VaIois. Che Danle
seguisse con dirella assione ogni mossa oIilica deI VaIois
sembra iu che robabiIe. II rincie serbo aIIealo di CarIo di
VaIois non oleva essere ben vislo daII'esuIe fiorenlino che
rorio aII'ex emissario di aa onifacio, ora relendenle aI
53 Cfr. LIROTIC, Oanic i nrtaiskc zcn|jc, cailoIo |z nrtaiskc pctijcsii (600-1320), .
69-74.
54 RICCARDO IICCHIO I MARIA IICCHIO SIMONILLI, | ccnjini cricnia|i !c| ncn!c !i
Oanic, in Oanic c i| ncn!c s|atc/Oanic i s|atcnski stijci, Aiii !c| ccntcgnc inicrnazicna|c a
cura !i |ranc Ca|c, Zagreb, ed. }AZU 1984, . 13-29.
55 La conferma me I'ha dala a voce.
56 Cfr. IICCHIO - SIMONILLI, o. cil., . 13-29.
57 Cfr. ivi, . 13.
Suzana GIavas 704
lrono di isanzio come soso di Calerina di Courlena, doveva
Ia sua rima condanna. Iino a queI unlo I'essere conlro iI
VaIois (e quindi conlro queI di Rascia) oleva imIicare una
quaIsiasi simalia er Ia causa deII'Imeralore Andronico II`
58
I Iicchio solloIineano aIlrellanlo che Danle deIIe zone sIave
comrese neIIa giurisdizione reIigiosa Ialina, nomina, oIlre aIIa
oemia che era area nellamenle imeriaIe, Ia Croazia: QuaIe e coIui
che forse di Croazia / viene a veder Ia Veronica noslra.... Affermano
anche che Ia ancora correnle inlerrelazione di quesli versi danle-
schi, secondo cui Croazia indicherebbe una lerra slraniera e Ionlana,
in genere, olrebbe lullavia moslrarsi erronea
59
. La Ioro lesi viene
argomenlala nei seguenli lermini:
Se i confini deI mondo danlesco che abbiamo messo in Iuce
hanno un quaIche significalo, Ia Croazia era cerlamenle arle
deIIa comunila occcidenlaIe di cui Danle direllamenle si occua
in uno sirilo, olremmo dire (aroIe di Iicchio), di malurala
discriminazione lra quanlo si lrova aI di qua e aI di Ia di una
fronliera oIilico-reIigiosa. I eIIegrini di Croazia aarleneva-
no aIIa caloIicila Ialina e ad uno slalo, queIIo ungaro-croalo, che
faceva arle di queIIo che Danle considerava essere iI suo er
quanlo rislrello ecumene oIilico-reIigioso. L'accenlo aIIa
Croazia dovrebbe dunque essere inleso come un'uIleriore deIi-
milazione di fronliera, e quindi come una recisazione, neI
senso che Ia Croazia ncn era Ionlana, ma siriluaImenle Iegala
aII'IlaIia, aII'Imero e a Roma
60
.
Occorre ricordare che Danle, oIlre a menzionare iI goIfo deI Quar-
naro come iI confine orienlaIe deII'IlaIia verso Ia Croazia: Quarnaro /
ch'IlaIia chiude e suoi lermini bagna (|njcrnc, IX vv. 113-114) nomina
anche IoIa, a queII'eoca roriela deI alriarca di AquiIeia: Si
com'a IoIa resso deI Quarnaro, / |...j / fanno seoIcri lullo iI Ioco va-
ro, rovine deIIa decadula gIoria e olere deII'Imero Romano. Sicco-
me, e qui riferisco Ie aroIe deIIo sludioso Lerolic, iI grande cimilero
di IoIa ubicalo in riva aI mare non e ossibiIe scorgerIo daIIa direzio-
ne deI mare, i cilali versi sarebbero Ia conferma che Danle fosse slalo
fisicamenle a IoIa
61
.
58 Cfr. ivi, . 22.
59 Cfr. ivi, . 24.
60 Ivi, . 24-25.
61 Cfr. LIROTIC, Oanic i nrtaiskc zcn|jc, cailoIo Pu|a, cil., . 48.
|| tiaggic !i Oanic in Crcazia ira rca|ia c ipcicsi 705
II molivo rinciaIe deI viaggio di Danle in Croazia, neI eriodo
asquaIe fra iI 1304 e iI 1305, sarebbe slalo secondo Lerolic comie-
re iI volo a Sanla Lucia coI eIIegrinaggio aI suo lemio a }urandvor
suII'isoIa di Krk/VegIia in Croazia. Chiedeva rimedio aIIa visla degIi
occhi e a queIIa degIi occhi deIIa menle. I da iolizzare anche che Ia
sua guida avrebbe olulo suscilare in Iui Ia curiosila di vedere Ia Ia-
sira !i Baska resso iI sanluario di Sanla Lucia a }urandvor.
V.III. ASCANSKA ILOCA/LA LASTRA DI ASKA DI }URANDVOR
62
GIi immigrali Croali, i barbari deII'Adrialico orienlaIe, accoIgono
neI VII secoIo i maggiori vaIori deI mondo anlico e deI crislianesimo.
NeII'accellare Ia cuIlura anlica non seguono gIi aIlri ooIi euroei,
ma addirillura Ii recedono, iI che e visibiIe dai monumenlaIi edifici
ivi coslruili, secie di imronla reIigiosa.
NeIIa chiesa di S. Lucia a }urandvor suII'isoIa di Krk/VegIia si
lrovavano due Iaslre con lesli in Iingua voIgare croala lrascrilli con
I'aIfabelo gIagoIilico. Se ne e conservala Ia Iaslra sinislra. Sanla Lucia e
rolellrice deIIa visla, fondamenlo deIIa saienza e deII'iIIuminazione.
La Iasira leslimonia che i reli gIagoIili dicevano Ie Ioro Iilurgie in
Iingua velerosIava inlrisa di eIemenli di Iingua voIgare croala.
A favore di quesla lesi riferisce una disula deI conciIio eccIesiasli-
co a SaIalo (anni 924-925) in cui fu messa in queslione I'allivila dei
reli gIagoIili. Su queIIe basi lullavia comincio a sviIuarsi I'aIfabe-
lizzazione croala reIaliva aIIa chiesa, ai suoi rili, di cui in modo esIi-
cilo si esrime Ia Iasira !i Baska risaIenle aII'anno 1000
63
.
L'aIfabelizzazione in gIagoIilico era maggiormenle senlila neIIa
arle cenlraIe deIIa Croazia adrialica, essendo slalo iI suo cenlro eccIe-
siaslico (vescoviIe) a Nin (Nona) nei ressi di Zara. Cos, conlraria-
menle a lullo iI mondo calloIico deII'Iuroa coeva, che neIIa chiesa
adoerava escIusivamenle Ia Iingua Ialina, quesl'oasi croala ermel-
leva iI servizio divino in Iingua voIgare, ovvero velerosIava di recen-
62 Ho riassunlo sollo queslo liloIo Ie uIlime 50 agine deI voIume di Lerolic in cui
sono lrallale, in cailoIi a se, inlerrelazioni inleressanli reIalive aII'isoIa di Krk/VegIia
e Ia riselliva chiesa benedellina (con monaslero) di Sanla Lucia. Ier iIIuslrare anche Io
sliIe deII'aulore, mi e iaciulo racconlare 'a modo suo' gIi argomenli lrallali neI cilalo
voIume. Cfr. LIROTIC, Oanic i nrtaiskc zcn|jc, cil., . 128-178.
63 ASCANSKA ILOCA/LA LASTRA DI ASKA, in ielra caIcarea, e aIla 99 cm, Iarga 197
cm e sessa 8 cm. Doveva essere coIIocala neIIa chiesa di S. Lucia, coslruila daII'abale
Dobrovil. I slala rinvenula neI 1851 neIIa avimenlazione deIIa chiesa benedellina.
SuIIa Iasira e slala annolala Ia rima nolizia in assoIulo suI re croalo Zvonimir. InoIlre
essa e Ia rima leslimonianza suIIa resenza dei benedellini neIIe regioni occidenlaIi
deIIa Croazia.
Suzana GIavas 706
sione croala, iI che era moIlo imorlanle er Ia reservazione deII'i-
denlila nazionaIe e er Io sviIuo di una secifica cuIlura nazionaIe.
I aIlrellanlo comIelamenle comrensibiIe che a laIe chiesa nazio-
naIe si oose, e fece resislenza, iI cIero Ialino. Iressioni di queI gene-
re furono avverlile gia neI 925 quando aI conciIio di SaIalo fu richie-
slo di reinlrodurre Ia Iingua Ialina nei rili sacri. La resislenza fu avver-
lila anche aI Nord deI aese, secie quando neI sec. XI fu fondalo a
Zagabria iI vescovado con iI comilo rimario di comballere iI gIago-
Iismo ivi roromenle. Cio nonoslanle, iI gIagoIismo riusc a resislere
(grazie anche aIIa concessione deI aa neI Duecenlo) su un vaslo ler-
rilorio deI IiloraIe croalo fino ai confini eslremi deII'Islria e addirillura
fino aIIa regione deIIa Lika con iI fiume Krbava, in aIcuni unli fino aI
Sellecenlo.
La Iasira !i Baska e iI rimo monumenlo aIeografico a carallere
Iaico, non eccIesiaslico, deII'aIfabelismo suI suoIo deIIa Croazia. Scrilla
in caralleri gIagoIilici, quesla rima leslimonianza eigrafa suII'uso
deIIa viva Iingua deI ooIo croalo riveIa neI conlenulo Ia nolizia
deII'abale Drziha suIIa donazione di un lerreno aIIa chiesa benedellina
di S. Lucia a }urandvor suII'isoIa di VegIia da arle deI re Zvonimir.
Vi e scrillo inoIlre che I'abale Dobrovil ha coslruilo Ia chiesa insieme
ai suoi nove fraleIIi aI lemo deI rincie Kosmal, sovrano di lulla Ia
regione, e neII'aendice, che iI sanlo MikIa vi era aIIora in comunila
con sanla Lucia.
La Iasira !i Baska leslimonia ure che i frali benedellini neIIe re-
gioni croale sellenlrionaIi erano gIagoIili (come si evince dai nomi di
due abali cilali), cosa di cui si ha conferma neI 1252 in una Iellera deI
aa Innocenzo III che IegaIizzava iI Ioro oeralo. La dalazione deIIa
Iasira, che fu scoIila in lemi oIilicamenle incerli e lurboIenli, neI
eriodo fra Ia morle deI re Zvonimir 1089 e Ia cadula deII'isoIa di Krk
(VegIia) sollo iI dominio deIIa Serenissima neI 1116, e comunemenle
allribuila aII'anno 1100.
Si iolizza che Danle avrebbe voIulo onorare Ia Iasira, gia in Iin-
gua voIgare (ciacavo) e in lre aIfabeli mischiali: gIagoIilico londo, gIa-
goIilico quadralo e aIfabelo Ialino. NeIIa forma originaIe deI rasonel-
lo, essa neI conlenulo si riveIa AIfa e Omega, inizio e fine deIIa causa,
deIIa seranza, deIIa fede e deII'amore er Ia rinascila deIIa indien-
denza e deIIa Iiberla deIIa Croazia.
Io dissi: AI suo iacere e loslo e lardo
venga remedio a Ii occhi, che fuor orle,
quand'eIIa enlro coI fuoco ond'io semr'ardo.
Lo ben, che fa conlenla quesla corle,
|| tiaggic !i Oanic in Crcazia ira rca|ia c ipcicsi 707
AIfa e O e di quanla scrillura
mi Iegge Amore o Iievemenle o forle.
(Par. XVI, vv. 13-18)
Trascrizione deIIa Iasira !i Baska
La Iasira comincia con Ia Iellera AIfa e finisce con Ia Iellera Omega.
II leslo conliene 100 aroIe.
La scrillura deIIa Iasira richiama Ia sonorila deI verso dodecasiIIa-
bo.
La Iasira comincia con Ia Sanla Trinila bibIica e riferisce che Ia
chiesa di S. Lucia e coslruila dai benedellini. I un documenlo di
donazione, di conlenulo giuridico. DeIIa donazione sono leslimoni iI
arroco, iI giuano, iI duca e i deIegali. Riferendo che iI re croalo
Zvonimir dona un ezzo di lerra aI convenlo di Sanla Lucia, si lesli-
monia cha Ia Croazia e regno indiendenle con a cao iI re Zvonimir.
DaI unlo di visla deI conlenulo si riferisce che I'organizzazione
oIilica deI nuovo regno croalo e conceila su rincii arislocralico-
democralici, con a cao iI olere dei cieIi: Iadre, IigIio e Sirilo Sanlo.
La rima organizzazione oIilica, reaImenle esislila, su basi arislocra-
lico-democraliche roosle da IIalone.
A aska Danle si sarebbe congedalo da Kazolic. Semre a aska, iI
Suzana GIavas 708
Sommo avrebbe inconlralo Ia conlessa ealrice di VegIia, deIIa nobiIe
famigIia dei Irankoan/Irangeani.
V.IV. VINODOLSKI ZAKONIK/IL CODICI DI VINODOL
|| Cc!icc c |a Icggc !i Vinc!c| e fra i rimi documenli a carallere
slorico-IegisIalivo in Iingua croala, scrillo in caralleri gIagoIilici.
L'originaIe non si e conservalo, menlre Ia lrascrizione in gIagoIilico
risaIe aI sec. XVI. Dai dali che vi si racconlano si evince che fu como-
slo iI 6 gennaio deI 1288 da una commisione di 42 membri, eIelli da
nove comuni di VinodoI in Islria. II Cc!icc narra deIIa voIonla degIi
abilanli di codificare Ie Ioro anliche usanze neII'ambilo deI feudo in
mano ai conli di Krk (VegIia), successivamenle chiamali Irankoan. II
Cc!icc !i Vinc!c| e di eslrema imorlanza er Ie ricerche suI feudaIe-
simo in Croazia, menlre come monumenlo cuIluraIe riveIa che gia aIIa
fine deI Duecenlo i Croali avevano una Legge, comosla in Iingua
voIgare a carallere Iaico IegaIe. II Vinc!c|ski zakcnik nasce ero come
esigenza di codificazione deIIe vecchie Ieggi in armonia con nuove
condizioni verificalesi neI celo feudalario dei conli di VinodoI. O me-
gIio, neI 1225 iI re ungaro-croalo Andrea II donava aI conle di VegIia
Vid ed ai suoi successori Ia sovranila suI feudo di VinodoI e di Mo-
drus. Cos VinodoI divenlo oggello deI sislema di donazione feuda-
laria deIIa varianle ungaro-croala deI feudaIesimo deII'Iuroa Occi-
denlaIe. Con queIIa donazione deI re fu fallo un inlervenlo rofondo
neIIe condizioni sociaI-economiche e di conseguenza queIIe reIalive ai
raorli IegaIi. Iino a quei lemi gIi abilanli di VinodoI vivevano in
una slrullura comunilaria con forli reIilli deI sislema lribaIe. II lerrilo-
rio aarleneva aI medioevaIe banalo deIIa SIavonia e Ia ooIazione
era sollomessa aI bano. Con Ia donazione deI 1225 essi divenlano servi
deIIa gIeba dei conli di VegIia. Ira i nuovi servi deIIa gIeba e i nuovi
signori feudalari si verificavano inevilabiIi sconlri e conlese. Doo 63
anni (daI 1225 aI 1288) sia i servi deIIa gIeba che i Ioro signori cairono
che er enlrambe Ie arli sarebbe slalo megIio regoIare i Ioro raorli
con un Codice in modo consensuaIe. TaIe accordo fu regoIalo aunlo
con iI Cc!icc !i Vinc!c| in cui si nolificano i dirilli e i doveri di ambo Ie
arli, e si mellono a norma lulli i cami IegaIi in cui i Ioro inleressi
erano conlesi.
NeI Cc!icc !i Vinc!c|, unico aI mondo er i lemi in cui e slalo
comoslo, e er iI conlenulo che racchiude, si Iegge Ia difesa dei dirilli
umani. In oche aroIe, con esso si Iimila I'uso deIIa forza nei con-
fronli degIi abilanli deIIa comunila, si Iimilano Ie sanzioni er i reali,
non vi e cenno aIIe lorlure e aI cosiddello giudizio divino ralicalo
|| tiaggic !i Oanic in Crcazia ira rca|ia c ipcicsi 709
daII'inquisizione, si risellano i beni deI ooIo, Ia dignila deII'uomo,
in arlicoIare Ia dignila deIIa donna.
CONCLUSIONI
Lerolic ci offre una chiave iu che documenlala e credibiIe suII'an-
no 1304/05 in cui Danle, arlilo da Verona, si ensava fosse riaralo a
Iadova, e invece no: egIi lrovo riaro in Croazia, resso quei barbari
che 700 anni fa risellavano iI allo di non allaccare i vicini e di ricor-
rere aIIe armi soIo neI caso venissero allaccali er rimi, quei barbari
che avevano Ia roria scrillura e Ia roria Iingua, avevano iI ro-
rio regno, sebbene reslo neII'unione con un aIlro regno, avevano
una Iegge con cui veniva rolello ogni cilladino, e in arlicoIar modo
Ia donna quaIe madre e quaIe essere umano.
Quesla Ia chiave di Iellura deIIa rima lriade deIIe donne in Iara-
diso:
RacheIe, Lucia, ealrice
I deIIa seconda lriade deIIe donne:
ealrice di Iirenze, amore elerno, che inlroduce Danle neII'in-
ferno deIIe ene d'amore
ealrice Aragonese, che offre a Danle Ia seranza che gIi Angio
Suzana GIavas 710
sono Ia fulura seranza deI Regno unilo d'IlaIia e oi d'Iuroa
ealrice di VegIia dei Irankoan, che si moslro generosa neI
momenlo in cui rimase soIo a }urandvor, resso i benedellini deI con-
venlo di S. Lucia, doo iI congedo daIIa sua guida reaIe er Ie lerre
croale, I'arcivescovo di Zagabria Auguslin Kazolic.
suslanze e accidenli e Ior coslume,
quasi confIali insieme, er laI modo
che cio ch'i' dico e un semIice Iume.
(Par. XXXIII, vv. 88-90)
Unitcrsiia !cg|i Siu!i !i Zaga|ria
Unitcrsiia !cg|i Siu!i !i Napc|i IOricnia|c
ALIKSANDRA ZA}IK
IL O| VUIGA|| |IOQU|NT|A IN SLOVINIA
Come riveIa iI liloIo slesso deI mio conlribulo inlendo iIIuminare
un eriodo arlicoIare deIIo sviIuo Iellerario sIoveno aII'inizio
deII'Ollocenlo con i necessari 'assaggi' indielro neI lemo erche
raresenlano un lull'uno neI Iungo cammino deIIo sviIuo deIIa
Iingua sIovena. Irorio duranle iI Romanlicismo i due raresenlanli
iu imorlanli deIIa Ielleralura sIovena, Mali|a Co e Irance Ireseren,
decisero di eIevare Ia Iingua IocaIe, da Danle chiamala nc|i|c e da Iui
rilenula neI rimo Iibro deI Oc tu|gari c|cqucniia come queIIa
|.j che i bambini arendono da chi sla Ioro inlorno daI mo-
menlo che cominciano ad arlicoIare i suoni, oure er essere
iu brevi, Ia Iingua voIgare e queIIa che, senza bisogno di rego-
Ie, imariamo imilando Ia noslra nulrice
1
aI IiveIIo di una Iingua Ielleraria inlernazionaImenle riconosciula ser-
vendosi deII'esemio deI oela ilaIiano di cinque secoIi rima. Non e
che iI mondo cuIluraIe sIoveno fosse slalo fermo er lulli quesli secoIi.
Non Io e slala nemmeno Ia Iingua deI ooIo, considerala 'oco ar-
moniosa' aIIe orecchie fini dei moIli Iellerali che oeravano suI
lerrilorio sIoveno. II assaggio deIIa Iingua voIgare neI senso di Iingua
deI ooIo rima a Iingua comune, oi a Iingua Ielleraria allraverso Ia
sceIla di voIla in voIla di uno dei numerosi diaIelli in uso
2
(successi-
1 DANTI, Oc tu|gari c|cqucniia, MiIano, Garzanli 2000, . 2-3: |.j eam qua infan-
les assuefiunl ab assislenlibus cum rimilus dislinguere voces inciiunl, veI, quod
brevius dici olesl vuIgarem Ioculionem asserimus quam sine omni reguIa nulricem
imilanles acciimus.
2 Ier non aIIonlanarmi daI eriodo Romanlico cos imorlanle er Ia Iingua
sIovena, e sufficienle anaIizzare Io schizzo deIIa Ielleralura sIovena er erceire Ie
diverse varianli deIIa Iingua lullora esislenli. Co isoIa cinque grui fondamenlaIi
dislinguendo esIicilamenle iI comIesso sislema vocaIico che ancora oggi divide Ie
varianli diaIellaIi. Na vsak nain misIim, da bi moraIi raunali s elimi razIiicami: z
goren|sino, doIen|sino, nolran|sino, korosino in sla|ersino ka|li obeh zadn|ih
golovo nikakor ne moremo rislevali h goren|sini aIi doIen|sini, obe (namre ko-
rosina in sla|ersina) imala ceIo svo|i gramaliki (Gulsmannovo in Dan|kovo), rva ceIo
AIeksandra Zab|ek 712
vamenle coslruila con ollimi esemi Iellerari), e slalo moIlo Ienlo
e graduaIe, oslacoIalo sesso daIIa noncuranza e osliIila deIIe aulo-
rila IocaIi (asburgiche, ilaIiane o ungheresi), a causa deIIa arIala oco
comrensibiIe e Iimilala neII'uso e neI lerrilorio dei suddili. Tanlo iu
sorrendenli ossono aarire aIIora aIcune deIIe Ieggende che cir-
coIavano daI Medioevo in oi lra un ooIo oco o er nienle islruilo,
come queIIe su Danle
3
, erche sono in nello conlraslo con I'oinione
Iargamenle diffusa sugIi anlenali sIoveni come genle cafona, inca-
ace di una quaIsiasi allivila cuIluraIe di un cerlo IiveIIo. II sommo
Ioela, senz'aIlro, non si era rodigalo arlicoIarmenle er iI ooIo,
er coIoro che facevano falica a comrenderIo. Non ne aveva nemme-
no bisogno. I suoi sforzi furono rivoIli aIlrove. MoIli ooIi duranle
iI Medioevo conoscevano uno slralo sociaIe coIlo di cui arIa Io slu-
dioso sIoveno Mali|a Co aII'inizio deI Romanlicismo, aI quaIe era
rivoIla un'imorlanle roduzione Ielleraria menlre iI ooIo, che ne
era escIuso, oleva godere dei rori comonimenli con eroi oo-
Iari, iu vicini e iu comrensibiIi ad esso, senza seguire necessaria-
menle I'aIlra roduzione Ielleraria deI oslo. Ma non gIi sIoveni
4
.
II caso Ioro, ero, daI unlo di visla cuIluraIe, fu iu comIesso dalo
che I'allivila Ielleraria IocaIe si sviIuo a Iungo in Ialino, in ledesco, e
ai margini deI lerrilorio in ilaIiano o in ungherese. Iu un'allivila a-
raIIeIa dei celi abbienli e islruili che non inlacco quasi iI dinamismo
ooIare. Quei ochi raresenlanli sIoveni che riuscirono a sludiare,
rima neIIe iccoIe cilla sIovene
5
, chiaramenle in una Iingua slranie-
svo| Iaslni sIovar (Gulsmannov), druga a ga bo kmaIu imeIa (Murkovega) / In ogni
modo enso che bisognerebbe conlare cinque varianli diaIellaIi: carnioIano sueriore,
carnioIano inferiore, carnioIano inlerno, carinziano e sliriano oiche Ie uIlime due (iI
carinziano e Io sliriano) senz'aIlro non si ossono mellere insieme aI carnioIano sue-
riore o carnioIano inferiore, ambedue (ovvero iI carinziano e Io sliriano) disongono
erfino di una grammalica roria (di Gulsmann e di Dan|ko), Ia rima ha ersino un
risellivo vocaboIario (di Gulsmann) menlre I'aIlra ne redisorra ben reslo (di Mur-
ko). ANTON SLODN}AK, Pisna Maiija Ccpa, 2, L|ubI|ana, SAZU, 1989, . 162 (La
lraduzione deI brano, quando non indicalo diversamenle, e deII'aulrice). Cfr. anche
MATI}A COI, Pisna in spisi, L|ubI|ana, MIadinska kn|iga 1983.
3 ALIKSANDRA ZA}IK, Oanic in S|ctcnia, in Icciura Oaniis 2002, I lomo di quesla
ubbIicazione.
4 Sergi| ViIfan neI suo saggio suI conladino feudaIe (Ockuncnii s|ctcnsita, 1994, 81)
afferma che un conladino sIoveno medievaIe non fu moIlo diverso dagIi aIlri in Iuroa,
seciaImenle non lanlo da aarire escIusivamenle una arle di un semIice ooIo di
conladini indifesi come invece gIi sIoveni si resenlano sesso neIIa Ielleralura o neIIa
ubbIicislica varia, riresa dagIi scrilli in ledesco. Secondo Iui un conladino sIoveno si
nolava iu er Ia sua allivila economica non uramenle agraria, ovvero er iI lrasorlo,
Ia rivendila deIIa merce, a voIle er I'arligianalo che Io rendevano risello agIi aIlri
consimiIi euroei deI lemo meno conladino e iu un iccoIo imrendilore medievaIe.
5 Anche oggi soIo due cilla hanno iu di 100.000 abilanli: Maribor e L|ubI|ana. Se-
|| De VuIgari IIoquenlia in S|ctcnia 713
ra
6
, aII'inizio in Ialino, in un secondo momenlo in ledesco o in ilaIiano
ed ungherese, oi neIIe universila
7
, er Io iu auslriache, Iimilavano
I'uso deIIa Iingua madre ai conlalli oraIi famiIiari o con iI ooIo. SoIo
Ienlamenle Ia Iingua oraIe si ar aIIa varianle scrilla che allraverso
i secoIi cerco una forma definiliva, rilrovala con I'aiulo di Co e
Ireseren aII'inizio deII'800. L'allivila Ielleraria degIi sIoveni in una
quaIsiasi deIIe Iingue slraniere cilale sora, ebbe er Iungo lemo un
deslinalario delerminanle: iI ooIo che a oco a oco veniva islruilo,
educalo e quindi abilualo a risuIlali semre iu raffinali.
Iinche cioe una Iingua rimane Iimilala soIlanlo ai concelli di un
semIice conladino e non e adalla aII'uso neIIe sfere iu aIle
deIIa vila e deIIa scienza come mezzo di comunicazione
8
non
uo relendere di essere considerala una Iingua di cuIlura (a-
recchie Iingue dei seIvaggi Io merilerebbero er Ia urezza
slessa deIIa Iingua). Una Iingua divenla di cuIlura quando Ien-
lamenle enlra in quesle sfere. Una laIe cuIlura finora manca aIIa
Iingua carnioIano sIovena iu che ad una quaIsiasi aIlra Iin-
gua sIava (ad eccezione forse deI sorabo o deIIo sIavo Iusaziano)
di cui ognuno si uo accerlare da soIo lenlando di scrivere in
uno sliIe aIlo, e non che sia er caso un'oera scienlifica bens
una semIice Iellera, anche se Io si riesce a fare senza difficoIla
erfino neI croalo e rorio erche I'inleIIighenzia I arIa e
scrive iI diaIello iu sesso di quanlo ne succeda con iI noslro
9
.
condo I'Ufficio di slalislica nazionaIe gIi sIoveni hanno raggiunlo soIo a arlire deI lerzo
miIIennio i 2 miIioni di abilanli suI rorio lerrilorio.
6 II Iiceo in cui si insegnava Ia Iingua sIovena fu crealo a Lubiana soIo neI 1817, do-
o Ia 'feIice' eserienza deIIe Irovince iIIiriche (1809 1813). 'IeIice' erche i francesi
duranle i quallro anni deIIa Ioro invasione ermisero che iI ooIo imarasse iI francese
servendosi deIIa roria Iingua. Si dice anche che Ia rima grammalica scienlifica deIIa
Iingua sIovena di Koilar sia slala iI frullo deIIe Iezioni rivale aIIa figIia deI governalo-
re francese.
7 L'universila iu vicina era a Iadova, lullavia Io sludio in IlaIia fu er gIi sIoveni
moIlo iu cosloso risello a Vienna, che e divenlala ben reslo anche er gIi sIoveni un
inconlraslalo cenlro degIi sludi universilari. Non a caso i grandi sIovenisli aII'eslero,
lio }erne| Koilar o successivamenle Iran MikIosi, er non arIare semre dei rimi
scienziali medievaIi, lendevano a soffermarsi rorio neIIa grande cailaIe imeriaIe.
8 DANTI dice (DVI, 2000, 5): Se in effelli si considera allenlamenle cio che si fa
quando si arIa, si vedra che di nuII'aIlro si lralla se non di comunicare aI rossimo
quanlo Ia noslra menle ha ensalo / Si elenim ersicaciler consideramus quid cum
Ioquimur inlendamus, alel quod nihiI aIiud quam noslre menlis enucIeare aIiis con-
celum.
9 MATI}A COI, Pisna in spisi, L|ubI|ana, cil., . 115: DokIer namre osla|a |ezik
ome|en na lo, da izraza samo o|me reroslega kmela, in ni rimeren za rabo v vis|ih
krogih zivI|en|a in znanosli za soroevaIno orod|e, se a se ne more olegovali za ime
AIeksandra Zab|ek 714
scriveva Mali|a Co neI 1833 suII'|||iriscncs B|aii enlrando ersonaI-
menle neIIa 'Guerra deII'aIfabelo' con iI suo Nuctc !iscacciancnic !i
|ciicrc inuii|i. Oas isi S|cucniscncr ABC Kricg
10
, I'uIlima fase deIIa for-
mazione di una Iingua Ielleraria.
Cio che Ie grandi nazioni occidenlaIi avevano raggiunlo duranle iI
medioevo gIi sIoveni hanno dovulo guadagnarseIo secoIi iu lardi. II
rilardo iniziaIe ha obbIigalo moIli a risondere agIi slimoIi eslerni
anche quando iI mondo sIoveno non era deI lullo ronlo. Chiaramen-
le non lulli i eriodi furono uguaIi. Nonoslanle Ie rime disule
riguardo Ia alernila deIIa scoerla dei grandi manoscrilli medievaIi
aII'inizio deII'Ollocenlo, oggi i Monumenli di Irisinga/rizinski so-
meniki si rilengono iI documenlo sIavo scrillo in caralleri Ialini iu
anlico. La sua Iingua e Io sIoveno deI X secoIo. Quando Io sIoveno
}erne| Koilar, grande fiIoIogo sIavo, aII'inizio deII'Ollocenlo sludiava
i lesli sIoveni in un codice Ialino
11
, iI ercorso deIIa sloria Ielleraria fu
gia slabiIilo in base aIIe oche conoscenze reesislenli, non semre
correlle
12
. I monasleri medievaIi furono lra i maggiori cenlri siriluaIi,
omikanega |ezika (ki bi ga zaradi goIe islosli zasIuziI ludi marsikaleri od |ezikov
div|akov). }ezik more dobili ravo omikanosl samo s lem, ko |e oslooma veI|an v le
kroge. Taka omikanosl a do zda| man|ka kran|sko sIovenskemu |eziku v ve|em ob-
segu kakor kaleremu si ze bodi drugemu sIovanskemu (kve|emu bi mogoe Iahko
izvzeIi sorbsino aIi Iuzisko sIovansino), o emer se Iahko vsak sam reria, e
oskusi naisali v omikanem sIogu, a ne mogoe kaksno znanslveno deIo, lemve
samo ismo, erav lo brez lezav Iahko naravimo na rimer se ceIo v hrvasini, in
sicer ravno zalo, ker lam izobrazenci ogosle|e govori|o in ise|o lo nare|e, kakor se
doga|a z nasim.
10 II leorico sIoveno sludiando e conoscendo bene Ia siluazione ilaIiana grazie aIIe
conlinue informazioni deII'amico goriziano Irancesco LeooIdo Savio rese in reslilo
iI liloIo da AgnoIo IirenzuoIa che neI 1524 si oose aII'eisloIa di Trissino suIIe Iellere
nuovamenle aggiunle neIIa Iingua ilaIiana risondendo aunlo con iI suo Oiscaccia-
ncnic. La vecchia oIemica ilaIiana sembro a Co vicina aIIa queslione sIovena er Ia
voIonla di risoIvere iI rissoso robIema deII'aIfabelo che aveva invaso I'inlero mondo
cuIluraIe sIoveno e neI conlemo Ionlana, lrallandosi di due reaIla Iinguisliche comIe-
lamenle diverse, laIe da ermellere una soIuzione migIiore, iu indoIore er gIi sIoveni,
aImeno aarenlemenle.
11 II codice Ialino deI vescovo Abramo fu cuslodilo neIIa calledraIe ledesca fino aI
1803. SoIo quando fu lrasferilo neIIa ibIioleca nazionaIe di Monaco di aviera neI 1807
si scorirono anche i lesli scrilli in Iingua sIovena.
12 Co rearo, su roosla di Koilar, er Ia rassegna di SAIARIK Gcscnicnic !cr
s|auiscncn Spracnc un! Iiicraiur in a||cn Mun!aricn deI 1826 un resoconlo deIIa Ielleralura
sIovena Iiicraiur !cr Win!cn tcn Prcj. u. B|i||. Main. Zncp in Iai|acn, che uo essere con-
sideralo Ia rima sloria crilica deIIa Ielleralura sIovena, uIlimandoIo neI 1831. Sed una
coia a Safafik, che si lrovava a Novi sad, iI 27/06/1831 allraverso Vienna dando in que-
slo modo Ia ossibiIila a Koilar di aggiungere Ie rorie osservazioni. II deslinalario
ricevelle Ia rassegna sIovena di Co, allenlamenle commenlala da Koilar, iI mese suc-
cessivo, ovvero neI IugIio deI 1831. Ne Safafik ne Co ur conlinuando a Iavorarci
|| De VuIgari IIoquenlia in S|ctcnia 715
cuIluraIi e reIigiosi fino aI Quallrocenlo, quando anche in SIovenia
inizio ad affermarsi Ia cuIlura urbana. La rima diocesi nacque suI
lerrilorio sIoveno neI 1461/1462 a Lubiana conlro Ia voIonla deI
alriarca di AquiIeia. L'imeralore Iederico III Ia creo voIendo aslu-
lamenle arreslare I'infIuenza deI alriarca, esonenle deIIa oIilica
veneziana, suI suoIo asburgico. Iino ad aIIora Ie sedi reIigiose si
lrovavano aI di fuori deI lerrilorio elnico sIoveno con ovvie conse-
guenze er Io sviIuo, seciaImenle cuIluraIe deI ooIo. InoIlre Ie
cilla medievaIi furono iccoIe, come Io sono d'aIlronde anche oggi.
AlluaImenle soIo due cilla, Ia cailaIe Lubiana e Maribor suerano i
100.000 abilanli. Le aIlre IocaIila bens considerale ncsia, ncsicca/|a
ciiia, |a ciiia!ina o irg /i| |crgc rimangono moIlo circoscrille se confron-
lale con i cenlri occidenlaIi o orienlaIi dei ooIi iu numerosi
13
.
Ovviamenle, Ia SIovenia soIo oggi suera i 2 miIioni di abilanli. Men-
lre una cerla roserila lra I'XI e iI XII secoIo consenl Ia nascila e Io
sviIuo di nuove cilla aII'inlerno deI lerrilorio, doo i burrascosi
mulamenli ai lemi deIIe grandi migrazioni medievaIi, o vecchie neI
LiloraIe, Iaddove Ie cilla e i borghi meno esosli ai forli cambiamenli,
abilali dai vecchi abilanli re-sIavi, furono slrellamenle Iegali aIIa Ioro
relrolerra in cui si sono successivamenle insediali i nuovi arrivali,
revaIenlemenle sIavi.
L'allivila cuIluraIe dei numerosi monasleri sIoveni
14
duranle lullo
iI Medioevo non si offr soIo in quaIila di cenlri di coialura bens
come romolori deI ensiero anlico e nuovo. Issa e leslimoniala da
moIli manoscrilli, rovenienli revaIenlemenle dai due grandi cenlri
monaslici di Slina e Zie e daIIa ricchezza deIIe bibIioleche, risconlra-
la lardi, aIIa chiusura ollocenlesca dei monasleri. Ier ovvi molivi iI
mondo ooIare sIoveno rimaneva ai margini.
Vari celi sociaIi medievaIi hanno miralo a diversi generi cuIluraIi,
di conseguenza in Iingue diverse. In Ialino, successivamenle in
ledesco, i celi Iaici e reIigiosi iu coIli deII'Ollocenlo, Ie corli e gIi
scienziali, menlre aIIe Iingue voIgari veniva concessa revaIenlemenle
Ia rassi reIigiosa, I'allivila ooIare e da aIcune arli anche Ia oesia
riuscirono a slamare iI maleriaIe. SoIo }osef }ireek ubbIico neI 1864 neI rimo Iibro
deIIa rislama deII'oera di Safafik iI leslo S|cucniscncs un! g|agc|iiiscncs Scnrijinun, un
leslo rearalo da Co, commenlalo da Koilar, con deIIe correzioni di Safafik.
13 NeI Quallrocenlo si slima che Ia ooIazione carnioIana urbana ammonlasse so-
Io aI 10%.
14 GIi sIoveni erche si lrovavano suI suoIo ooIalo dagIi sIoveni anche se Ie aIle
gerarchie slraniere hanno semre badalo moIlo aIIa roria allivila che non aveva moI-
lo a che fare con iI ooIo circoslanle e Ie sue necessila cuIluraIi. Non invano si dice che
gIi sIoveni erano un ooIo di conladini erche CarIomagno fece suI serio iazza uIila
deIIa oca nobiIla sIovena!
AIeksandra Zab|ek 716
dei nobiIi o dei cilladini. L'inlera cuIlura medievaIe ha Iascialo Ie sue
lracce vilaIi, leslimonianze scrille ben visibiIi ad escIusione deII'allivi-
la ooIare, lramandala oraImenle e regoIarmenle rirodolla in moIle
varianli soIlanlo daII'Ollocenlo in oi. Lo sIoveno ha documenli me-
dievaIi in Iingua imorlanli, ma ochi esemi comIeli di generi che
fanno ercio aarire I'inlera allivila cuIluraIe incomIela. II suo feu-
daIesimo rediIigeva cuIluraImenle aIlre Iingue menlre in Iuroa si
affermavano Ie Iingue voIgari. Le condizioni oIiliche indubbiamenle
imonevano I'uso di aIlre Iingue. Si dice che I'imeralore MassimiIia-
no I ebbe buone inlenzioni di imarare anche Io sIoveno, non si sa
ero se e in che misura iI suo desiderio fu reaIizzalo (Ockuncnii
s|ctcnsita, 1994, 95). Oggi si conoscono revaIenlemenle lesli d'uso
rammalico anche se I'inizio sembro moIlo romellenle oiche Io svi-
Iuo sIoveno risello agIi aIlri ooIi vicini non ebbe rilardi. Non si
lralla di soIe iolesi nonoslanle I'usuaIe scarsila dei documenli scrilli,
liica di lullo iI mondo sIavo che imedisce una ricoslruzione iu
esalla e veIoce deIIa siluazione rima deII'anno 1000. Iure non e
deI lullo imossibiIe inlravedere I'eroico assalo degIi anlenali. II
monaco Hrabar deIIa seconda generazione dei disceoIi dei Sanli fra-
leIIi di SaIonicco, CiriIIo e Melodio, divenlalo arcivescovo deIIa chiesa
annonica, neI suo scrillo suIIe Iellere arIo deII'uso sIavo deIIe Iellere
greche e Ialine rima deIIa creazione ciriIIiana deII'aIfabelo gIagoIili-
co. IgIi non reciso esressamenle i Iuoghi in cui si servirono deII'aI-
fabelo Ialino, senz'aIlro ero si rifer aIIa zona solloosla aII'infIuenza
occidenlaIe doo Io scisma d'orienle deI 1054, ovvero aIIa SIavia callo-
Iica. I un indizio imorlanle. Un uIleriore aiulo er quanlo riguarda
Ia ricoslruzione deI assalo che orla ad una migIiore e iu esalla co-
noscenza deII'ambienle sIoveno, Io si lrova in un nolo brano deIIa
chiesa saIisburghese suIIa conversione dei avaresi e dei Caranlani,
inliloIala Ccntcrsic Bagcaricrun ci Caraniancrun deI 871 in cui si uo
Ieggere che daIIa Iannonia Inferiore furono scacciale fiIosoficamenle
Ie Iellere Ialine rorio grazie aII'oeralo di Melodio, esallamenle
queIIe Iellere iI cui uliIizzo non risuIlo da nessuna aIlra arle sIava
con Ia quaIe ebbero conlalli i due fraleIIi
15
.
15 GIi SIavi deIIa Caranlania e deIIa Iannonia Inferiore aI nord deI fiume Drava su-
birono neII'VIII e neI IX secoIo d.C. Ia crislianizzazione daIIa chiesa di SaIisburgo
secondo iI melodo irIandese che lenne conlo deIIe condizioni cuIluraIi IocaIi. Ne fa fede
iI Paicrncsirc deI Mancscriiic !i K|agcnjuri, risaIenle verosimiImenle aI eriodo caroIin-
gio. II leslo e rivo deIIa aroIa kra|jcsitc neI senso di rcgnun, derivala direllamenle
daIIa aroIa kra|j che enlro neIIa Iingua IocaIe soIo con iI nome di CarIo Magno/KareI
VeIiki er indicare Ie ersone di suo rango. La aroIa e fino ad aIIora sconosciula agIi
sIoveni. La lradizione ciriI-melodiana uso Ia aroIa ccsarsitc risello a |cgasitc deI Ma-
ncscriiic lrecenlesco !i K|agcnjuri. II riformalore IRIMOZ TRUAR neI suo calechismo
|| De VuIgari IIoquenlia in S|ctcnia 717
II X secoIo segno una Ienla erdila deII'allivila chiericaIe in Iingua
IocaIe, rimasla ormai Iegala aIIe varie annolazioni e robabiImenle
aIIe lrascrizioni. L'indeboIimenlo di queslo lio di allivila regislro
invece un nello migIioramenlo deII'allivila cuIluraIe cavaIIeresca.
NaluraImenle si lralla di una roduzione sIovena eisodica, incenlra-
la su aIcuni nomi quaIi UIrich von Lichenslein con iI suo oema
Vrcuucn !icncsi/A| scrtizic !c||a !ana conlenenle un verso sIoveno Bugc
uaz prini, gra|ta Vcnus che rirende iI saIulo Oic ti acccnpagni, rcgina
Vcnus deI duca carinziano ernhard Sanheim quando neI 1227 saIulo
Ia foIIa a Vrala, lraveslilo da Venere. L'uIlimo Minncsangcr OsvaId
WoIkenslein, invece, ando assai fiero deIIe sue conoscenze Iinguisliche
che incIudevano Io sIoveno. La roduzione Ielleraria medievaIe non e
deI lullo anaIizzala dala Ia difficoIla di reerire i vari frammenli dei
comonimenli nei Codici o neIIe aIlre oere slraniere, disersi neIIe
svariale bibIioleche, sesso aI di fuori deI lerrilorio sIoveno. Una laIe
anaIisi da arle dei crilici iIIumina conlinuamenle sia Ia Iingua sia Io
sviIuo Iellerario, iu sorrendenli deI revislo, duranle iI eriodo
deIIe grandi riveIazioni leoriche e raliche occidenlaIi. In queslo
Iavoro minuzioso, urlroo, non mancano deIusioni. Igor Grdina
(Ockuncnii s|ctcnsita, 1994, 100) menziona con rammarico un fram-
menlo oco IeggibiIe di un Minncsangcr deI Quallrocenlo, comreso
neI Mcnuncnic !i Aucrspcrg/Turjaski rckcpis. II leslo, forlemenle dan-
neggialo e conservalo neIIa ibIioleca nazionaIe universilaria di
Lubiana, sign. 45-59. L'unica decodificazione che ermelle sono singo-
Ie aroIe o brevi insiemi di aroIe. Grdina Io reula un esemio
doIenle deIIa noncuranza sIovena verso i rori gioieIIi in un cIima
generaIe di mancanza di documenli scrilli.
Di un amaIgama aarenlemenle ben riuscilo lra iI ooIo e Ia
nobiIla IocaIe arIa, invece, I'anlica cerimonia deII'inveslilura deI duca
carinziano, chiamalo s|ctcnski gcspc!/i| signcrc s|ctcnc, viva fino aI
1414. Ne arIo neIIa sua oera Oc |urcpa anche iI fuluro aa Iio II,
Inea SiIvio IiccoIomini
16
. II rilo e un ricordo deII'organizzazione
Kaicnisnus z !tcjna iz|agana deI 1575 Iamenlava ancora I'uso deIIa aroIa.
16 II 18 marzo deI 1414 un conladino sIoveno confer er I'uIlima voIla iI olere ad
un duca carinziano secondo Ie vecchie usanze servendosi deI lrono di ielra a Maria
GaiI resso iI casleIIo di Krn in Carinzia. (II lrono e oggi raresenlalo anche sui 2 cen-
lesimi sIoveni). Duranle iI rilo, mai arlicoIarmenle amalo daIIa nobiIla IocaIe, sia iI
conladino che i raresenlanli deI fuluro signore feudaIe deIIa regione si servono deIIo
sIoveno come Iingua soIenne di inveslilura. L'inconsuelo uso oraIe di una Iingua abi-
luaImenle obbIigala a slare lra Ie mura deIIe case e deIIe chiese, suscila arecchie
inlerrogazioni. L'inveslilura slessa fu considerala gia dai rimi cronisli un omaggio
originaIe aI signore feudaIe deI oslo. Cos Io hanno conceilo in seguilo IiccoIomini
neI Quallrocenlo, iI leorico e slorico francese }ean odin neI Seicenlo o iI democralico
AIeksandra Zab|ek 718
Iibera caranlana, formaImenle Iegalo aIIe usanze di aIlri ooIi sIavi
sia i croali e i serbi che i cechi e i russi. II lrono deI signore, un lrono in
funzione giudiziaria, raresenla un simboIo, e iI simboIo deI suo
olere. L'ascesa aI lrono deI nuovo signore feudaIe IocaIe e chiara-
menle Iegala aII'inveslilura. La Iingua ooIare come Iingua deI
riluaIe che sosliluisce Ie due Iingue di aIla cuIlura deI lemo, iI Ialino
e iI ledesco, in una ceIebrazione cos soIenne ed imorlanle, ha una
doia vaIenza: slorica e Iinguislica. Una comunicazione oraIe ov-
viamenle non riveIa e non risella Ie consueludini liiche di una
Iingua scrilla quaIe uo essere Ia base deIIa noslra queslione ollocen-
lesca I'aIfabelo, denola ero Ia naluraIe differenza lra una Iingua
arIala e una Iingua scrilla. II caso sIoveno rende lullo ancora iu
difficiIe dalo che iI Medioevo dislingue i due usi aII'inlerno di una
reaIla ooIare regionaIe, dominala a Iungo da aIlre Iingue di cuIlura.
II Cinquecenlo ovvero iI breve eriodo deIIa Riforma orlo agIi
sIoveni queII'indiscusso sviIuo deIIa Iingua scrilla che duranle i
secoIi a venire ermise anche un chiaro risvegIio Iellerario. La dinami-
ca di quasi ogni ooIo conosce momenli di siIenzio iu o meno
ercellibiIe. Non ne sono rimasli immuni nemmeno suI suoIo ilaIiano
neI miIIennio rima di Danle! La oco visibiIe energia deIIa ausa
sesso irrome imrovvisamenle rendendo un camo arido fiorilo. A
voIle basla un semIice ensiero. Ierfino I'imeralore Irancesco
Giusee medilando suII'arrelralezza deIIa Iingua sIovena si senl
dire garbalamenle daI Iinguisla Mali|a Murko che Ia Iingua rimiliva
disoneva di una lraduzione deIIe Sacre Scrillure risaIenli aIIo slesso
eriodo deIIo slimalissimo ledesco e forse oi non era cos barbara
come si ensava comunemenle. II fallo siega aImeno in arle Ia
fierezza deI ooIo er queI cenlennaIe, unico mezzo di riconoscimen-
americano Thomas }efferson neII'Ollocenlo. Secondo Ie nolizie deI Mancscriiic !i Gicsscn
deIIa seconda mela deI Quallrocenlo Ia forma conosciula iu anlica deII'inveslilura
risaIe aII'XI secoIo. Doo Ia morle deI duca i kcsczi, un celo sociaIe arlicoIare deIIa so-
ciela sIovena, sceIsero un raresenlanle/un giudice con cui disculere e vaIulare Ia
roosla deI sovrano ledesco riguardo iI nuovo signore feudaIe regionaIe. SoIo in segui-
lo fu conferilo iI definilivo olere aI signore feudaIe IocaIe in nome deI ooIo a Maria
GaiI/Gosa svela a ochi chiIomelri a nord di KIagenfurl. II nuovo duca rima di essere
messo su una cavaIIa e condollo lre voIle inlorno aI lrono di ielra dovelle indossare
er I'inveslilura i veslili conladini bicoIori deI ooIo, un anlaIone, una giacca, un
manleIIo, un caeIIo e una iccoIa bisaccia grigi con una cinlura rossa e scare da
conladino con i Iacci deIIe scare rossi. II ooIo inlorno canlava un kiric|cjscn in sIove-
no anlico, ricoslruilo daIIo slorico Ivan Grafenauer: Cesl i hvaIa bogu vsemogonemu,
ize slvori nebo i zemI|o, da daI |esl nam i nase| dezeIe knez i gosod o nase| voI|i /
Onore e grazie aI Dio onniolenle che ha crealo iI cieIo e Ia lerra, che ha dalo da man-
giare a noi e aIIa noslra lerra, iI duca e iI signore secondo Ia noslra voIonla (Occuncnii
s|ctcnsita, 1994, 37).
|| De VuIgari IIoquenlia in S|ctcnia 719
lo elnico che rese gIi sIoveni arlicoIarmenle Iegali aIIa roria Iingua
voIgare, Ienlamenle divenlala uguaIe aIIe aIlre. Quando Irimoz
Trubar neI 1550 si rivoIse con iI suo calechismo a lulli gIi sIoveni:
Vsem SIovenzom Gnado, Myr, MyIhosl inu rauu Soznane boshye
skusi }ezusa Chrislusa rossim / Irego er lulli gIi sIoveni Ia grazia,
ace, cIemenza e iI giuslo riconoscimenlo divino allraverso Gesu
Crislo
17
, fin definilivamenle Ia rima fase deIIo sviIuo Iinguislico
sIoveno rivo di unila! Inizio iI rocesso di euroeizzazzione concIu-
sasi anche oIilicamenle iI 1 maggio 2004 a Gorizia, ai confini ilaIo-
sIoveni. II Iegame medievaIe lra iI ooIo che roduce er iI ooIo
con I'aiulo finanziario deIIa nobiIla e deIIa cilladinanza slraniera
diede ollimi frulli che non soIo ermisero aI iccoIo ooIo sIavo di
vivere bens gIi assicurarono un'ininlerrolla resenza suIIa scena
cuIluraIe mondiaIe. MoIlo si e scrillo suII'oera e suIIa vila di Irimoz
Trubar, suIIa sua imorlanza er Io sviIuo deIIa Iingua Ielleraria,
sui suoi caricci resunli o veri, suIIe difficoIla che dovelle suerare,
suII'abiIila diIomalica, ma non si dira mai abbaslanza deIIe sue sceIle
Iinguisliche coraggiose, a voIle zoicanli, rielulamenle correlle che
hanno dalo inizio a moIle oIemiche e si sono in arle concIuse con Ia
'guerra deII'aIfabelo'.
La queslione dei vari sislemi di scrillura in quanlo raresenlazio-
ne grafica di un Iinguaggio umano che riveIa iI modo di scrivere e
fissa un conlenulo oraIe fIuido, soggellivo e lransilorio, e assai Ionlana
neI lemo er i grandi ooIi
18
. Non e er nienle marginaIe dalo che e
Ia scrillura queIIa che racchiude in se un messaggio, sia Ia scrillura a
mano che Ie Iellere slamale doo Gulenberg. GIi sIoveni non si sono
mai mossi lroo daII'ambilo Ialino. NeI Medioevo hanno adoeralo
diversi caralleri seguendo gIi aIlri ooIi vicini in cerca di una scrillu-
ra che fosse adeguala aIIa roria Iingua. Non e slalo semre faciIe
unire i suoni sIavi ai grafemi Ialini. La confusione duro quasi lre secoIi
finche neII'Ollocenlo, Co e Ireseren non osero decisamenle fine aIIa
queslione, ahime con una guerra. Se Irimoz Trubar voIendo indicare i
suoni sIoveni |, s, zj guardo aIIa scrillura ledesca deI lemo serven-
dosene a rorio iacimenlo, i suoi successori quaIi Sebasli|an KreI|,
}uri| DaImalin, Adam ohori lenlarono di riuIire I'aIfabelo er
renderIo iu chiaro. Siccome ognuno cercava d'imorre Ie rorie
17 IGOR GRDINA, Prcicsianiska in kaic|iska rcjcrnacija, in Ockuncnii s|ctcnsita, . 101.
18 L'aIfabelo fonelico e slalo invenlalo in Siria o in IaIeslina nei rimi secoIi deI se-
condo miIIennio a.C. Le iu anliche leslimonianze risaIgono aIIa cilla di ibIo e sono
dalabiIi lra iI XV e iI XIV secoIo a.C. I greci aggiunsero aII'aIfabelo fenicio Ie vocaIi ed
esso asso in IlaIia con Ie modifiche romane. I Io slesso sislema che viene uliIizzalo
oggi neIIa maggior arle deI mondo senza delerminare Ia ronuncia.
AIeksandra Zab|ek 720
soIuzioni Iegale aI lio di oera inlrareso, aIIa varianle Iinguislica
conosciula, non ci fu mai un fiIo rosso ad unire i vari lenlalivi. La
scarsa islruzione in Iingua sIovena cerlamenle non fu di aiulo. Una
queslione banaIe minacciava di divenlare un robIema ricorrenle. I
Iinguisli sludiando Ia Iingua in lulle Ie sue dimensioni si resero conlo
deII'inevilabiIila di una vaIida soIuzione, ma conlinuarono a girare a
vuolo. Ierfino i iu grandi. La reaIla sIovena ricevelle Ie sue gramma-
liche e i vocaboIari ai quaIi non si uo rimroverare semre soIo Ia
scienlificila, rimanendo scoerlo iI diIemma deII'aIfabelo.
L'IIIuminismo individuo I'urgenza e I'alluaIila neIIa queslione
Iinguislica, resenlalasi doo Ie riforme di Giusee II e Ia consaevo-
Iezza ormai cerla deIIa non sufficienza deI ledesco come eIemenlo
unificalore dei diversi ooIi sollomessi agIi Asburgo. I Iinguisli
sIoveni si smossero senza lrovare ero una soIuzione definiliva, di
consenso generaIe. Inizio un azienle Iavoro grammalicaIe che si con-
cIuse neI 1809 con I'uscila deIIa grammalica koilariana Grannaiik !cr
s|atiscncn Spracnc in Krain, Karcnicn un! Sicicrnark, Ia rima gramma-
lica sIovena scienlifica in Iingua ledesca. Issa lullavia non risoIse iI
robIema iniziaIe deII'aIfabelo. I lemi doo Ia rivoIuzione francese
che lravoIse I'Iuroa, scorirono in frella i robIemi sIoveni senza
dare Ia ossibiIila di indugiare. La queslione Iinguislica andava risoIla
in lolo, in queI cIima comIesso di diversila regionaIe, daII'inlerno deI
aese, e non come visla daI cenlro a Vienna. L'Ollocenlo orlo un
aerlo rinnovamenlo cuIluraIe in Iuroa lrascinando I'inlero mondo
sIoveno neIIa roria senlimenlaIila e sonlaneila. Le ruole deI
muIino cuIluraIe iniziarono a girare iu veIoci senza lenlennare, Ia
siluazione era malura, bravi rolagonisli furono resenli, iI mondo
sIavo si era risvegIialo. II successivo rinnovamenlo oIilico, avvenulo
aIIa mela deI secoIo, e chiamalo dagIi sIoveni Pcn|a! narc!ct/|a Prina-
tcra !c||c nazicni nonoslanle gIi scarsi risuIlali ollenuli, come er dare
un buon ausicio aI subbugIio euroeo che avrebbe orlalo ad un
rofondo rimodernamenlo deIIa sociela e deIIa cuIlura. QuaIche
decennio rima un movimenlo siriluaIe iI Romanlicismo aveva
delerminalo iI rinnovamenlo Iellerario generaIe e deIIe aIlre manife-
slazioni arlisliche, di cui usufruirono abbondanlemenle gIi sIoveni.
Invesl lulla Ia vila dei vari ooIi in quanlo ricerca di modernila o
deI assalo eslendendosi daIIa Germania e coinvoIgendo inevilabiI-
menle lulli. L'esislenle raorlo lra Ia vila di un uomo e iI suo
Iinguaggio divenne immedialo. C'era un nello redominio deIIa oe-
sia, neIIa sua nuova concezione di una oesia che oleva esislere soIo
neII'ambilo deIIa roria sloria. Un oela, Iibero da vincoIi eslerni,
non obbediva che aI suo senlimenlo oelico. L'ambilo sIoveno oero
|| De VuIgari IIoquenlia in S|ctcnia 721
sollo queslo rofiIo reaIizzando i rori bisogni e i sogni. Ier Ia rima
voIla una coia ben affialala di un fiIoIogo, slorico Iellerario e di un
oela caovoIse Ia siluazione in favore deIIa Iingua voIgare, naluraIe
che sarebbe divenlala Ia Iingua Ielleraria di un inlero ooIo. I roman-
lici sono slali voIli ad esIorare Ia ricchezza deIIa roria vila in-
leriore con un imIicilo senlimenlo nazionaIe, divenlalo in seguilo
essenziaIe. GIi slessi eIemenli avrebbero delerminalo Ia guerra Iingui-
slica sIovena. I I'esemio di Danle Iinguisla fu indisensabiIe.
NeI lerzo decennio deII'Ollocenlo I'ambienle sIoveno resenlo
un'anomaIia: invece di rodurre un aIfabelo comune er lulle Ie
regioni in cui veniva usalo Io sIoveno come eIemenlo di unione, si-
miImenle aII'IlaIia, abbondo con 3 aIfabeli diversi che minacciarono di
dividere definilivamenle non soIo cuIluraImenle Ia iccoIa reaIla.
L'uso deIIa vecchia scrillura, Ia cosiddella |cncricica, resislelle nono-
slanle iI fallo che si lrallasse di un vecchio aIfabelo Ialino usalo dai
roleslanli in oi. La Iingua che cambia nei secoIi non e una novila,
gia Danle affermo che iI mulamenlo deIIa Iingua vi si reaIizza soIo in
un Iunghissimo arco di lemo
19
. L'insieme deIIe Iellere Ialine usale
dagIi sIoveni er iu di due secoIi veniva indicalo anche ai lemi di
Irance Ireseren con iI nome deI Iinguisla roleslanle, Adam ohori,
che I'aveva idealo. Sia Iranc MeleIko che Ieler Da|nko, consaevoIi
deII'arlificiosila e deII'inadegualezza deIIa roria scrillura, incorag-
giali daIIo slesso }erne| Koilar, anche se non aIIa sua aIlezza scien-
lifica, lenlarono di rinnovare Ia scrillura, di semIificarIa dando un
grafema er ogni fonema. Tullavia, Ie due roosle invece di risoIvere
Ia queslione orlografica, Ia orlarono suII'orIo deI reciizio daI quaIe
si saIvo soIo con una breve e cruenle guerra. Le due nuove scrillure
resero iI nome dagIi aulori. La ncic|cica, un aIfabelo di 32 Iellere Iali-
ne con aIcune nuove, rese daII'aIfabelo ciriIIico e greco, fu conleslala
erfino eslelicamenle. Ironicamenle fu chiamala krct|jica/!a||c gan|c
sicric. Conobbe ochi esemi slamali e fu bandila daIIa scuoIa e daIIa
chiesa grazie rorio aII'abiIila e aIIa leslardaggine di Co e Ireseren.
La !ajncica, I'aIlra scrillura, considerala meno imorlanle deIIa rifor-
ma meleIkiana, non er queslo meno comballula, fu invece Iegala
moIlo ad una varianle regionaIe deIIa Iingua sliriana (gcrnjcra!gcnska)
e come laIe inaccellabiIe er lulli gIi sIoveni. Le differenze Iinguisliche
aII'inlerno di un iccoIo lerrilorio furono cos grandi da escIudere au-
lomalicamenle una soIuzione regionaIe erche lroo ridulliva.
Danle slesso osservo giudicando Ia siluazione ilaIiana che Ia Iingua
deIIa arle deslra d'IlaIia e diversa da queIIa deIIa arle sinislra: infal-
19 DANTI, Oc tu|gari c|cqucniia, cil., . 24: |.j cum sermonis varialio |.j non sine
Iongissima lemorum successione auIalim conlingal |.j.
AIeksandra Zab|ek 722
li, a un modo arIano i Iadovani e a un aIlro i Iisani
20
. Cio che suc-
cedeva neII'IlaIia sua deI Trecenlo, conlinua a succedere in SIovenia.
La Iingua si divide uIleriormenle rorio come annolo Danle:
|.j e erche differiscano neI arIare ersino queIIi che abilano
iu vicino, come i MiIanesi e i Veronesi, i Romani e i Iiorenlini
e addirillura genle deIIa slessa razza, come i NaoIelani e i
Gaielani, i Ravennali e i Iaenlini e, cio che e anche iu sluefa-
cenle, queIIi che abilano in una slessa cilla come i oIognesi di
orgo San IeIice e queIIi di Slrada Maggiore
21
,
iI che rende Ia giuslizia aIIa queslione aarenlemenle banaIe
deII'aIfabelo. La riforma deI Iinguisla Da|nko fu meno draslica, non
er queslo meno conlraslala su lullo iI lerrilorio sIoveno.
Mali|a Murko ubbIico neI 1825 a Graz, in |cncricica, Ia sua gram-
malica S|cucniscnc Spracn|cnrc un! S|cucnisn - Ocuiscncs Han!ucricr-
|ucn affermando neII'inlroduzione:
Do zda| smo biIi mi sla|erski SIovenci ludi v isavi lesn zvezani
s Kran|ci kakor smo v |eziku se zmera|, lako n|ihovi kakor nasi
isaleI|ski izdeIki so biIi skuna Iaslnina nas vseh. Zda| a se |e
oslaveIa med nas Iilerarna IoiIna regrada enako ogubna za
|ezikovno in I|udsko kuIluro SIovencev, ki grozi, da bo kakor
nekaksen kila|ski zid enkral za vseIe| odraviIa znanslveno
skunosl, ki |e do zda| obsla|aIa in |e lako nu|no olrebna za
naredek in usevan|e |ezikovne in I|udske omike, sa| si riza-
deva|o, da bi drug drugemu na kI|ubovan|e, rav golovo a ne
v rid znanosli in skune slvari SIovencev, veI|aIi na Sla|er-
skem Da|nkovo, na Kran|skem a MeleIkovo melodo isan|a in
|o na vse kriI|e oskusa|o uveI|avili, da bi biIi na sIosno sre-
|eli in z uvedbo v I|udske soIe vceI|eni I|udslvu v srce. Od vseh
slrani nam kIie|o:samo enolna abeceda in vse drugo ride
samo od sebe, a vendar si rizadeva|o ulemeI|ili novi, ravno
lako lezki abecedi, ki bosla mogoe ravno lako maIo kakor do
zda| obslo|ea isava drugih sIovenskih narei| oskusaIi sIoh
20 Ivi, . 23: |.j ulra deslrae IlaIianae Ioculio ab ea quae esl sinislrae (nam aIiler
Iadani el aIiler Iisani Iocunlur).
21 ||i!.: |.j el quare vicinius habilanles adhunc discreanl in Ioquendo, ul Medio-
Ianenses el Veronenses, Romani el Iiorenlini, nec non convenienles in eodem genere
genlis, ul NeaoIelaniel Caielani, Ravennales el Iavenlini, el, quod mirabiIius esl, sub
eadem civiIilale moranles, ul ononienses urgi Sancli IeIicis el ononienses Slrale
Maioris.
|| De VuIgari IIoquenlia in S|ctcnia 723
kda| odravili medsebo|ne Ioilve
22
.
In SIovenia ci fu bisogno di una 'guerra' er risoIvere una queslio-
ne uramenle Iinguislica. 'La guerra deII'aIfabelo' che gIi anlagonisli
di Co e Ireseren lenlarono di ridicoIizzare a arlire daI liloIo in cui
infaslidiva erfino I'aggellivo "#$%&'$ dalo che Ia guerra di carla e
d'inchioslro si svoIse chiaramenle in Iingua ledesca, e Iegala aIIe sorli
deIIa rivisla Ielleraria Kranjska C|c|ica/|Apc carnic|ana. La rivisla si
rodigo a ubbIicare vaIidi esemi oelici di giovani aulori er dimo-
slrare I'indiscusso vaIore eslelico deIIa Iingua voIgare, in grado di
divenlare una Iingua Ielleraria, ari aIIe aIlre. Anche se Ie rime
ballagIie iniziarono suIIe agine deI giornaIe di KIagenfurl Carininia
neI 1831 allraverso gIi arlicoIi di }akob Zuan e }ozef urger, effelli-
vamenle fu Ia crilica Ielleraria deIIa rivisla a enna di CeIakovsky
a soIIevare iI confIillo. La crilica osiliva di Kranjska C|c|ica/|Apc
carnic|ana di Iranlisek LadisIav CeIakovsky, ubbIicala suIIe agine
deI giornaIe Cascpis Ccskcnc Muscuna deI 1832, . 443-454, rislamala
lradolla in ledesco e rivedula con aIcune annolazioni, suI giornaIe Iu-
bianese |||qriscncs B|aii deI 1833 urlo iI gruo sIoveno redominanle,
rolello da Koilar, che avrebbe referilo un aIlro lio di roduzione
Ielleraria, iu Iegala aI gIorioso assalo menlre ahime aI di fuori dei
confini sIoveni veniva arezzalo rorio iI fallo ker nismo imeIi
rav nobenih redhodnikov in vodnikov na domaem Iarnasu, lako
da so z Iaslno mo|o sloiIi na esnisko ol
23
. II mondo Iellerario
sIoveno degIi anni venli e lrenla deII'Ollocenlo era in ieno sviIuo,
urifico iI Iessico e regoIo aIcune forme grammalicaIi come succede
regoIarmenle in ogni Iingua, non er queslo andava reIegalo aIIe
sonde conladine di una voIla.
22 MATI}A COI, Pisna in spisi, cil, . 152: Iinora noi sIoveni sliriani eravamo forle-
menle Iegali ai carnioIani anche allraverso Ia scrillura, come Io siamo lullora con Ia
Iingua. I frulli Iellerari sia noslri che Ioro furono comuni. Ora e sorla ero una barriera
Ielleraria, falaIe sia er Ia cuIlura Iinguislica che ooIare degIi sIoveni. Issa minaccia
come una secie di muragIia cinese a sorimere una voIla er semre Ia comunila
scienlifica, fino ad oggi viva e necessaria er Io sviIuo e Ia crescila deIIa cuIlura Iin-
guislica e ooIare. In Sliria si lenla inlrodurre, uno conlro I'aIlro, e sicuramenle non a
favore deIIa scienza ne deIIa cosa comune sIovena, iI melodo di scrivere di Da|nko men-
lre in CarnioIa queIIo di MeleIko. Si lenla con lulli i mezzi di alluarIi affinche fossero
accellali da lulle Ie arli e inneslali neI cuore deI ooIo inlroducendoIi neIIa scuoIa
ooIare. Si dice che bisogna avere soIo un aIfabelo comune, lullo iI reslo viene da
se, eure si lenla di creare i due nuovi aIfabeli difficiIi che forse lenderanno oco a
dislruggere Ie barriere reciroche come Io fa Ia scrillura finora esislenle deIIe aIlre va-
rianli sIovene.
23 Ivi, . 111: |.j che non abbiamo avulo nessun recursore o guida deI rorio
Iarnaso e quindi si sono incamminali con Ie Ioro forze suI senliero deIIa oesia.
AIeksandra Zab|ek 724
II confIillo Iellerario duro due anni e si svoIse in iu fasi. Vide ar-
leciare iI fior fiore deIIa cuIlura sIovena di aIIora, si serv di lulli i
mezzi a disosizione e si eslese su lullo iI lerrilorio inleressalo daIIa
Iingua. II Romanlicismo richiamo Danle oela che ero in SIovenia
non rilorno semIicemenle con Ie rime lraduzioni deI suo Divino
oema
24
bens si fece slrada rima da Iinguisla. II suo lrallalo fiIosofi-
co Oc tu|gari c|cqucniia, nolo a ochi sirili eIelli in SIovenia, lra cui
Co, raresenlo un'ollima base di aoggio, scienlificamenle e
Iellerariamenle soslenula, er lulla Ia serie di iccoIe manovre voIule
dai due giovani comballenli sIoveni. La dura ballagIia ebbe un doio
esilo: queIIo immedialo, rislrello ai arlecianli e queIIo osilivo e a
Iungo lermine, vaIido er lulli gIi sIoveni che ermise aIIa Iingua voI-
gare ed iIIuslre di divenlare Ielleraria conlribuendo a fare deI ooIo
una nazione. oris Ialernu neI suo Iibro su Ireseren scrive:
NeIIa siluazione sIovena di aIIora, I'ingresso in scena deIIa oe-
sia di Ireseren raresenlo un fallore di novila, laImenle
isoIalo ero, da rovocare una forle reazione conlraria. II en-
siero conservalore, con Ie forli ersonaIila ed isliluzioni che
oleva mellere in camo, divenne un freno aIIa diffusione deIIa
Iibera esressione oelica, e Ireseren dovelle er forza scon-
lrarsi con esso, anche in forma ubbIica e dirella |.j
25
.
La seconda fase deIIo sconlro vide enlrare suIIa scena i due grandi
rolagonisli deIIa Ielleralura, Co e Ireseren, se si vuoIe semIificare
da leorico iI rimo, da abiIe eseculore Iellerario iI secondo. Co, uomo
coIlo ma schivo, dedico Ie uIlime forze deIIa sua breve vila aI assag-
gio definilivo di una Iingua oco evoIula dei 'acifici agricoIlori'
neII'accezione deIIo slorico ingIese A.}.I. TayIor
26
, aIIa Iingua degIi
inleIIelluaIi, aerla a crileri eslelici. II genio arlislico, Ireseren invece,
adrone dei iu vasli orizzonli deIIa cuIlura siriluaIe e Ielleraria
euroea, creo Ia oesia evoIula assicurando Ie basi necessarie aIIa co-
slruzione di un ooIo indiendenle. L'azione dei due fu congiunla.
Co, oco incIine aIIa scrillura ubbIica, infalli Ia sua allivila rinci-
aIe si esaur con una vasla corrisondenza revaIenlemenle in
24 GIi sIoveni sono slali lra i rimi sIavi, doo i oIacchi, ad avere lraduzioni di aI-
cuni canli danleschi e lra gIi uIlimi a godere di una lraduzione comIela deIIa Oitina
Ccnnc!ia.
25 ORIS IATIRNU, |rancc Prcscrcn, Gorica, Goriska Mohor|eva druzba 1999, . 121.
26 Lo slorico TayIor neI suo Iibro suIIa monarchia asburgica sosliene che aIcuni dei
ooIi auslriaci, aarsi duranle Ia 'Irimavera deIIe nazioni', furono creali da Iellerali e
da inleIIelluaIi di rovenienza conladina.
|| De VuIgari IIoquenlia in S|ctcnia 725
ledesco, in moIli rogelli di cui soIo due scrilli, Ia gia menzionala ras-
segna crilica deIIa Ielleralura sIovena er Safafik e gIi scrilli con i
quaIi arlecio aIIa guerra deII'aIfabelo, successivamenle rislamali in
forma searala sollo iI liloIo Nuctc !iscacciancnic !i |ciicrc inuii|i, !as
isi. S|cucniscncr ABC Kricg. La rislama comrese lulli i conlribuli
che neI 1833 uscirono suIIe agine deII'|||qriscncs B|aii, concernenli
Kranjska C|c|ica/|Apc carnic|ana e Ia ncic|cica e si concIusero con iI cicIo
salirico reserniano Iiicrariscnc Scncrzc in Augusi Wi|nc|n t. Scn|cgc|s
Manicr/Scncrzi |ciicrari a||a nanicra !i A.W. Scn|cgc|.
La lerza fase concIusiva segno oi una schiaccianle villoria deIIo
schieramenlo giovane, aarenlemenle iu deboIe, con Ia roibizione
deIIe due nuove scrillure, roosle daI gruo iu rinomalo e vincen-
le suIIa carla, dei due coIIaboralori sIoveni deIIo sforlunalo grande
Iinguisla sIavo }erne| Koilar. La Commissione scienlifica resso Ia
Corle di Vienna iI 6 novembre 1833 emano un decrelo con iI quaIe
roib I'uso deII'aIfabelo meleIkiano. II divielo arrivo a lulle Ie aulori-
la scoIasliche iI 4 febbraio 1834 con effello immedialo. Le due scrillure
scomarvero daIIa circoIazione. GIi sIoveni olarono er Ia nuova
scrillura ceca, iu aroriala aIIa Iingua e gia serimenlala in
Croazia da L|udevil Ga|, Ia cosiddella gajica o s|ctcnika, lullora in uso.
Non si uo concIudere Ia queslione aIfabelica sIovena senza sof-
fermarsi brevemenle su aImeno due sonelli con i quaIi Ireseren,
indubbiamenle iI iu grande oela sIoveno, I'equivaIenle di Danle,
con iI beneIacilo deII'amico, arlecio aIIa guerra. Co e Ireseren
non furono comIemenlari soIo er Ia Ioro oera, leorico I'uno e rali-
co I'aIlro ma anche er carallere. Co era sicuramenle iu diIomalico
deII'amico che non riusciva a fermare i suoi frequenli imeli d'ira,
sesso lrasformali in svariali comonimenli oelici che hanno accom-
agnalo iI doIoroso evoIversi deIIa sua carriera sia oelica che
rofessionaIe.
I romanlici amavano iI sonello, Ia slessa forma oelica iaceva a
Mali|a Co che in seguilo Io raccomando aII'amico oela. IgIi defin iI
sonello una deIIe forme Iellerarie iu beIIe deII'Iuroa meridionaIe,
amala da moIli grandi oeli a arlire deI Duecenlo. Lo considero una
forma erfella in grado di esrimere lullo. Non si sa esallamenle
quando Ireseren scrisse iI suo rimo sonello in sIoveno, non fu nem-
meno iI rimo a farIo
27
. Ovviamenle sceIse iI modeIIo elrarchesco
erche consideralo iI iu erfello. II suo inleresse er Ielrarca e iu
27 }ovan VeseI Koseski neI 1818, venlenne, ubbIico neIIa sua unica raccoIla oelica
in Iingua, uscila a LeooIi, iI rimo sonello sIoveno con Ia riselliva lraduzione in lede-
sco.
AIeksandra Zab|ek 726
ercellibiIe dei fiIi solliIi che Io Iegano a Danle
28
, si lralla ero di un
Iegame esleriore. Ireseren rese iI sonello sIoveno. La oesia receden-
le non fu coIla e non infIu su Ireseren quanlo Ia oesia ooIare. II
suo ollimo senso deIIa siluazione e deIIa versificazione gIi suggeriro-
no una cerla lecnica mnemonica. IgIi ca erfellamenle I'imorlanza
deIIe aroIe rimale che si resenlavano sollo un nuovo asello. La sua
forza slava neI fallo di oler coIire con Ie aroIe indislinlamenle
coIui che era iI bersagIio di lurno. Se ne serv abbondanlemenle neIIa
'guerra deII'aIfabelo'. Isaminando i due sonelli Apc| pc!c|c na cg|c!
pcsiati/Apc||c nciic i| suc !ipinic in ncsira e A| prat sc pisc kaua a|i
kasna/Si scritc |cnc kaua c kasna emerge rorio quesla abiIila deI
oela. I comonimenli fanno arle dei sonelli salirici deII'unica rac-
coIla di oesie, redalla da Iui slesso e uscila neI dicembre deI 1846. II
rimo e chiaramenle rivoIlo conlro I'indiscussa aulorila deI mondo
sIavo }erne| Koilar. AeIIe fu idealo ancora rima deIIa 'guerra
deII'aIfabelo', neI 1830, quando Ireseren see iI giudizio negalivo
koilariano suIIe sue oesie. Decise di rendersi gioco di Iui. SceIse un
aneddolo di IIinio iI Vecchio suI illore greco AeIIe che ermise ad
un ciaballino di giudicare Ie scare rirodolle neI quadro. Ireseren
voIeva richiamare Koilar a non uscire daII'ambilo deIIe sue come-
lenze fiIoIogiche negandogIi Ia ossibiIila di esrimere un giudizio
eslelico suIIa oesia. Gioco con iI suo cognome usando i sinonimi, i
diminulivi, Ie melafore. VoIIe ubbIicare iI sonello neI lerzo voIume
deIIa rivisla KC, I'amico, iu caulo, ero gIieIo sconsigIio. L'ira deI
oela coI I'amico (Ie Iellere di KIagenfurl deI 1832), vinse ero Ia
ragione e Ireseren riliro di maIavogIia iI sonello asellando una
nuova occasione di ubbIicazione. Non dovelle asellare moIlo.
L'occasione giusla gIi si resenlo I'anno doo aIIa fine deIIa 'guerra
deII'aIfabelo' quando Co Io fece ubbIicare iI 27 IugIio 1833 come
suIemenlo deII'|||qriscncs B|aii in risosla Ielleraria agIi avversari
con un liloIo in ledesco:
AeI odobo na ogIed oslavi,
ker boI| resnico I|ubi kakor hvaIo,
zad skril vse vrek osIusa, ka| zi|aIo
neumno, ka| umelni od n|e ravi.
Ired n|o s koili evI|arek se vslavi,
Ker ogIedu|e smIec obuvaIo,
28 Ne sa quaIcosa iI bosniaco arigino, KoI|a Mievi, che lradusse Danle e Ireseren
in francese. La sua lraduzione reserniana suscilo moIle oIemiche in SIovenia erche
frullo di un'inlerrelazione crilica sui gcncris, Ionlana daIIa crilica ufficiaIe sIovena.
|| De VuIgari IIoquenlia in S|ctcnia 727
|ermenov meni, da ima remaIo,
kar on oila, ko| AeI oravi.
Ko ride drugi dan sel moz koilni,
namesl' da bi seI daI| o svo|i oli,
ker evI|i so ogodu, me se Ioli,
zavrne ga obraznik imenilni,
in lebe z n|im, kdor n'en si oilar,
reko:Le evI|e sodi na| Koilar!
29
NeI rilrarre saliricamenle Ia figura deII'avversario, nonoslanle si
lrallasse di un grande Iinguisla sIavo, Ireseren invenla un ungenle
gioco con iI suo cognome, usalo chiaramenle neII'aforisma deII'uIlimo
verso || cia|aiiinc giu!icni sc|ianic |c scarpc! menlre rima iI cognome
viene ridollo ad un nome comune kcpiiar, un lermine disregialivo
er indicare un caIzoIaio. II gioco conlinua a IiveIIo fonico e IessicaIe
er finire con I'escIamazione concIusiva, ormai divenlala una massi-
ma comune in SIovenia er indicare una ersona che relende di
giudicare quaIcosa che non caisce. II chiaro riferimenlo a Koilar non
finisce qui, I'uso deI diminulivo cct|jarcck recedulo daII'aIlro soslan-
livo s kcpiii/ccn |c jcrnc !i |cgnc pcr |c scarpc indica anche I'aIlezza fisica
deIIa ersona in queslione. DaI unlo di visla formaIe iI sonello e
rigidamenle slrulluralo, iI verso e |aski cnajsicrcc, un endecasiIIabo con
Ia rima abbracciala AA deIIe quarline e CDD, CII deIIe lerzine.
L'aIlro sonello A| prat sc pisc kaua a|i kasna/Si scritc |cnc kaua c
kasna fu scrillo rorio aII'occasione deIIa riforma aIfabelica uliIizzan-
do I'aIfabelo di MeleIko e iI vecchio aIfabelo di ohori er indicare
una soIa cosa: iI migIio. Anche quesla voIla Ireseren si rifugio neIIa
Grecia anlica dove si lrovava Abdera, una cilla lrislemenle nola er Ia
semIicila dei suoi abilanli. Si dice che I ebbe inizio iI famoso roces-
so suII'ombra deII'asino oiche non era chiaro se affillando I'asino
I'uomo affilla anche Ia sua ombra o deve affillarseIa a arle. La furbi-
zia di Ireseren sla anche quesla voIla neIIa sceIla deII'argomenlo,
decisamenle Iegalo aIIa queslione: MeleIko aveva rooslo neIIa sua
grammalica Ia slessa sloria deII'ombra di un asino cilando Isoo
menlre iI suo aIfabelo iniziava con Ie Iellere A, , D, I. La Iingua e di
sliIe inferiore risello aI rimo sonello. L'immagine iniziaIe si riferisce
aI mondo conladino dove kaua c kasna/i| nig|ic, scrilla in un modo
o neII'aIlro, non cambia affallo. II sonello e di nolevoIe imegno arli-
29 IRANCI IRISIRIN, Pcczijc, L|ubI|ana, Iresernova kn|iznica 1952, . 106.
AIeksandra Zab|ek 728
slico. II verso e Io slesso deI sonello recedenle, Ia rima deIIe quarline
rimane Ia slessa AA menlre neIIe lerzine divenla CCD e IID.
Ireseren ama cambiarIa. La comosizione e lemalica con un soIo un-
lo nodaIe. Le esressioni kaua, kasna c A|!criii sono ben visibiIi. Tulle
evocano iI robIema in queslione. IarIare deII'aIfabelo chiaramenle
non significa arIare soIo deII'aIfabelo bens affronlare lulla Ia silua-
zione sIovena con i suoi rolagonisli.
AI' rav se ise kaa aIi kasha,
se soIa novorkar|ev srdila
z I|udmi reira novega koila,
kdo n|ih a ravo lrdi, lo se rasa.
Io ameli |e laka sodba nasa:
Ak' |e od kashe kaa boI|'ga zila
In boI|s' obdeIana in boI| oIila,
na| se ne ise kasha, amak kaa.
Ak' a o rki boI|sa |ed ne bode,
in zavoI| rke ne lri ni skode,
obda|a laka miseI nas SIovence,
da ravda|o se li moz|e znabili,
za kar so se nekdan|i Abderili
v sIovei ravi od osIve sence
30
.
I nuovi aIfabelisli che si basavano suI coIIegamenlo lra Ia vecchia
scrillura e I'inquinamenlo moraIe deII'ambienle sIoveno, raresenla-
lo daIIa oesia d'amore di Ireseren, non soorlarono I'inlernazio-
naIizzazione deI robIema che divenlo inevilabiIe con I'inlervenlo di
CeIakovsky e Ia ubbIicazione in ceco rorio deI sonello AI' rav se
ise kaua a|i kasna/Si scritc |cnc kaua c kasna delerminando cos una
soIuzione malura, non arbilraria. L'aIfabelo elimoIogico rese di nuovo
gIi sIoveni vicini I'uno aII'aIlro senza badare aIIa ronuncia abiluaIe
deIIe diverse IocaIila. NeI conlemo scegIiendo una lerza, nuova scril-
lura, quesla voIla sIava, si avvicinarono ad aIlri ooIi sIavi come si
ausicava gia iI fraleIIo di Co, }anez, in una sua Iellera a Mali|a da
Vienna rendendosi conlo dei vanlaggi di una laIe sceIla er un iccoIo
ooIo. Come Danle divenlo semre iu concrelo neI suo lrallalo Oc
tu|gari c|cqucniia, arIando neI secondo Iibro lra I'aIlro dei oeli degni
30 Ivi, . 105.
|| De VuIgari IIoquenlia in S|ctcnia 729
di usare iI voIgare, degIi argomenli ammessi, deI melro e degIi sliIi,
cos iI landem Co Ireseren asso daIIa leoria aIIa rassi oelica,
risoIvendo slrada facendo aIcune queslioni aarenlemenle margina-
Ii, lio iI robIema deII'aIfabelo, che ermisero a lulla Ia sociela sIove-
na di esIodere cuIluraImenle aII'inizio deII'Ollocenlo. La soIuzione
Iinguislica danlesca aiulo gIi sIoveni a lrovare Ia roria slrada neI
rendere una Iingua voIgare Ielleraria. L'iIIuslre esemio serv a lullo
un ooIo er dimoslrare iI vaIore generaIe deIIe sue affermazioni e Ia
nobiIla slessa di una Iingua voIgare. Danle, anche se cinque secoIi iu
lardi, aiulo iI coraggio di due comballenli di una iccoIa Iingua in
ascesa.
Unitcrsiia !cg|i Siu!i !i Napc|i IOricnia|c
AIeksandra Zab|ek 730
RIIIRIMINTI ILIOGRAIICI
MATI}A COI, Pisna in spisi, L|ubI|ana, MIadinska kn|iga 1983.
Maiija Ccp 1797 1835, }esenice, Muze| }esenice 1997.
DANTI, Oc tu|gari c|cqucniia, MiIano, Garzanli 2000.
Ockuncnii s|ctcnsita, L|ubI|ana, Cankar|eva zaIozba 1994.
KOL}A MIIVI, Prcscrcn, na|c !rugacc,L|ubI|ana, MK 2004.
ORIS IATIRNU, |rancc Prcscrcn, Gorica, Goriska Mohor|eva druzba
1999.
IRANCI IRISIRIN, Pcczijc, L|ubI|ana, Iresernova kn|iznica 1952.
ANTON SLODN}AK }ANKO KOS, Pisna Maiija Ccpa, 1,2, L|ubI|ana,
SAZU, 1986.
ALIKSANDRA ZA}IK, Oanic in S|ctcnia, in Icciura Oaniis 2002, neI I
lomo di quesla ubbIicazione.
LUCIO SISSA
ORGIS I DANTI: UNA SINTONIA SOSIITTA
orges ha avulo un'inlensa allivila di crilico, ma soIo a Danle ha
dedicalo un inlero Iibro di saggi. C'e da aggiungere che Ie agine
criliche di orges risaIgono sorallullo ai suoi anni giovaniIi, menlre i
Nctc saggi !anicscni
1
(iI numero e un evidenle omaggio aI oela fioren-
lino) vedono Ia Iuce neI 1982, cioe quasi aIIa fine deIIa sua lraielloria
arlislica, e iI fallo che si sia lrallalo di un recuero e sislemalizzazione
di maleriaIi recedenli leslimonia che I'inleresse er Danle ha accom-
agnalo orges Iungo lulla Ia sua vila.
Credo che iI verlice deIIa Ielleralura e deIIe Ielleralure sia Ia
Ccnnc!ia. Queslo non significa che io ne condivida Ia leoIogia o
sia d'accordo con Ie sue miloIogie. Ci sono Ia miloIogia crisliana
e queIIa agana mescoIale, ma non e queslo iI unlo. II unlo e
che nessun Iibro mi ha offerlo emozioni esleliche cos inlense. Io
sono un Iellore edonisla, e nei Iibri cerco emozioni. La Ccnnc-
!ia e un Iibro che lulli dobbiamo Ieggere. Non farIo e rivarsi
deI migIior dono che Ia Ielleralura ossa offrirci, e abbandonar-
si a uno slrano ascelismo. Ierche negarci Ia feIicila di Ieggere Ia
Ccnnc!ia`
2
Se mi dicessero di saIvare un soIo Iibro, saIverei Ia Commedia,
dira iu lardi a Domenico Iorzio
3
.
Iochi dubbi suI fallo che Ia Oitina Ccnnc!ia sia er orges iI Iibro
dei Iibri. QueI che ci reme solloIineare e che I'argenlino nulre er
Danle un affello sosello, che va aI di Ia deI vaIore Iellerario mo-
numenlaIe deII'oera danlesca, in quanlo Ia senle come inlima aI di
Ia deII'eslelico. Convinli di cio, ce ne chiediamo iI erche, ci chiediamo
1 Nuctc cnsaqcs !anicsccs (1982), in O|ras ccnp|cias (d'ora in avanli O. C.), voI. III,
arceIona, Imece 1989.
2 }ORGI LUIS ORGIS, Sicic nccncs (1980), O. C., voI. III, . 217. |Ia ira!uzicnc c nia,
ccnc iuiic quc||c cnc scguiranncj.
3 DOMINICO IORZIO, Inlroduzione a orges, Tuiic |c cpcrc, MiIano, Mondadori
1989, voI. I, . LXV.
Lucio Sessa 732
cioe come mai orges fosse cos inlimamenle reso daIIa Oitina
Ccnnc!ia.
Queslo Iavoro sara un lenlalivo di risondere a laIe domanda,
ammesso e non concesso che essa sia fondala.
Iniziamo coI racconlare iI rimo inconlro di orges con Danle. II
Iuogo e aIquanlo rosaico: un lram che agIi inizi degIi anni Quaranla
ercorreva uenos Aires daIIa zona nord (dove Io scrillore abilava)
aIIa zona sud (dove Iavorava come bibIiolecario, finche iI governo di
Iern, saIilo aI olere neI 1946, non Io mise in mobiIila, nominando-
Io isellore di oIIi e conigIi in un mercalino rionaIe deIIa cilla).
In lram, er ingannare iI lemo, I'imiegalo endoIare }orge Luis
orges de Acevedo Iegge, in un'edizione lascabiIe, Ia Oitina Ccnnc-
!ia. La Iegge in ingIese, con leslo a fronle, rocedendo cos: rima una
lerzina in ingIese, oi Ia slessa in ilaIiano, arrivalo in laI modo aIIa fine
deI canlo Io riIegge er inlero, semre rima in ingIese e oi in origi-
naIe. Verso Ia fine deIIa seconda canlica, quando Danle si congeda da
VirgiIio, orges si congeda daI lradullore, CarIyIe: e in grado di ro-
seguire da soIo, dando di lanlo in lanlo uno sguardo aIIa lraduzione.
Quando giunsi aIIa vella deI Iaradiso lerreslre, quando giunsi
aI Iaradiso deserlo, Ia, neI momenlo in cui Danle e abbandona-
lo da VirgiIio e si lrova da soIo e Io invoca, in queI momenlo
senlii che olevo Ieggere iI leslo direllamenle in ilaIiano e dare
soIo di lanlo in lanlo uno sguardo aI leslo ingIese
4
.
Dunque Danle Iascia VirgiIio, orges Iascia CarIyIe, I'uno si lrova
ora neI Iaradiso lerreslre, I'aIlro in un lram, ma enlrambi neII'emisfe-
ro auslraIe.
Quesla sara Ia sua rima Iellura deI leslo danlesco, iI momenlo
deIIa scoerla, d'ora in avanli Io Ieggera ininlerrollamenle, cos come
Ieggera svariali commenli, e Ia cosa non e riva d'imorlanza erche
anch'essa riveIa un riviIegio accordalo aI oela fiorenlino. Infalli,
orges e s Iellore onnivoro, ma non recisamenle di crilica Ielleraria,
verso Ia quaIe, sesso, si moslra scellico e oco inleressalo, o aImeno e
quanlo afferma a iu rirese. Dello di assaggio, lra i commenlalori
deI leslo danlesco, I'argenlino dichiara di referire MomigIiano e
Grabher.
Racconla deIIa sua assione er Danle anche Domenico Iorzio,
osile a casa deI oela cieco e coslrello a IeggergIi canli su canli
deIIa Ccnnc!ia, con annessi svariali commenli.
4 ORGIS, O. C., voI. III, . 209.
Bcrgcs c Oanic. una sinicnia scspciia 733
Mi chiede, indicandomi una zona deIIa Iibreria, di disorre suI
lavoIo Ie sue edizioni deIIa Divina Commedia. Sono una mezza
dozzina, di cui una iIIuslrala: deIIo Scarlazzini, deI MomigIiano,
deI Casini-arbi, deI IrovenzaI, deI Saegno, deI Grabher.
Irendiamo anche Ia lraduzione ingIese deI LongfeIIov. La no-
slra umiIe Ieclura Danlis consisle in queslo: Ieggo allenlamenle,
sesso rielendo, aIcune lerzine, un canlo o una sua arle, con-
lroIIando e mellendo a confronlo, su richiesla deI mio
ascoIlalore, Ie nole neIIe varie edizioni disonibiIi. Quindi ri-
Ieggo iI canlo senza iu inlerruzioni. Mi accorgo che orges sa a
memoria gran arle deIIe lerzine, che mormora a voce bassa. In
iu sedule Ieggeremo aIcuni canli deII'Inferno e I'uIlimo deI Ia-
radiso, vedendone anche Ia lraduzione, sesso esemIare, deI
LongfeIIov
5
.
Come mai orges non usi aIcuna lraduzione sagnoIa Io racconle-
ra iu lardi Io slesso Iorzio, riorlando quesle aroIe borgesiane:
I Iellori di Iingua sagnoIa devono rassegnarsi a Ieggere Danle
neII'originaIe, Ie due Iingue sono lroo affini. La lraduzione di
Milre e ridicoIa. CarIos Maslronardi, un buon oela, lradusse iI
rimo canlo deII'Inferno, ma non risello nemmeno gIi endeca-
siIIabi
6
.
Qui forse iI oela riveIa un o' di snobislica angIofiIia, che lanle
voIle, a lorlo o a ragione, gIi e slala rimroverala. Infalli, lra Ie lanle
versioni casligIiane deIIa Oitina Ccnnc!ia ce n'e aImeno una, ad oera
deI oela sagnoIo AngeI Creso, che e decisamenle mirabiIe, ed e
slala ubbIicala a mela degIi anni sellanla, quindi diversi anni rima
deI suo coIIoquio con Iorzio.
Ma enlriamo ora in argomenlo, anaIizzando aIcune significalive
resenze danlesche neIIa narraliva borgesiana. La rolagonisla (con-
lumace) di uno dei suoi racconli iu ceIebri, L'AIeh, si chiama
ealriz Vilerbo, e iI racconlo si are con Ia nolizia deIIa sua morle: II
lorrido mallino di febbraio in cui ealriz Vilerbo mor
7
. L'io narranle
deI racconlo si chiama orges, e verso ealriz soffriva di amore non
corrisoslo: QuaIche voIla, Io so, Ia mia vana devozione I'aveva esa-
serala, morla, olevo consacrarmi aIIa sua memoria, senza seranza,
5 IORZIO, o. cil., voI. II, . XIII-XIV.
6 ||i!.
7 ORGIS, || A|cpn (1949), in O. C., voI. I, . 617.
Lucio Sessa 734
ma anche senza umiIiazione
8
. orges (iI ersonaggio orges, nalu-
raImenle) conlinua a frequenlare iI cugino di ealriz, individuo
arecchio eccenlrico e oela da slraazzo, che afferma di cuslodire
I'aIeh neIIa canlina deIIa vecchia casa alerna, che corre iI rischio di
essere abballula. L'aIeh viene da quesli descrillo come uno dei
unli deIIo sazio che conliene lulli i unli
9
. orges ensa che CarIos
Argenlino Daneri (queslo iI nome deI cugino di ealriz Vilerbo) sia
azzo e referisce assecondarIo, er cui acconsenle ad andare da Iui
er vedere queslo mislerioso aIeh. Giunli a casa, arofilla di un
momenlo di soIiludine er rivoIgere una sorla di slruggenle re-
ghiera Iaica e noslaIgica a un rilrallo di ealriz: ealriz, ealriz IIe-
na, ealriz IIena Vilerbo, ealriz adorala, ealriz pcr!uia pcr scnprc,
sono io, sono orges
10
. Doodiche scende giu in canlina, senza con-
vinzione, anzi un o' savenlalo, ma con sua somma sorresa Io vede
davvero, I'indescrivibiIe aIeh.
Iccomi aI cenlro ineffabiIe deI mio racconlo, qui inizia Ia mia
diserazione di scrillore. Ogni Iinguaggio e un aIfabelo di sim-
boIi iI cui esercizio resuone un assalo che gIi inlerIoculori
condividono, come lrasmellere agIi aIlri I'infinilo AIeh, che Ia
mia limorosa memoria abbraccia maIamenle` |!icirc |a ncncria
ncn puc irc}. In queII'islanle giganlesco, ho vislo miIioni di alli
diIellevoIi o alroci, nessuno mi ha meravigIialo lanlo quanlo iI
fallo che lulli occuassero Io slesso unlo, senza sovraosi-
zione o lrasarenza. QueI che i miei occhi hanno vislo era
simuIlaneo: queI che lrascrivero, successivo, erche iI Iinguag-
gio e cos
11
.
Confronliamo queslo racconlo con quanlo orges scrive neI roIo-
go ai saggi danleschi:
Immaginiamo, in una bibIioleca orienlaIe, una minialura di
moIli secoIi fa. Iorse e araba e ci dicono che in essa sono raffi-
gurale lulle Ie slorie deIIe MiIIe e una nolle, forse e cinese, e
saiamo che iIIuslra un romanzo con cenlinaia o migIiaia di
ersonaggi. NeI lumuIlo deIIe sue forme, quaIcuna un aIbero
che assomigIia a un cono rovescialo, moschee rossaslre su un
muro di ferro richiama Ia noslra allenzione e da essa assia-
8 ||i!.
9 Ivi, . 623.
10 Ivi, . 624 |ccrsitc !i rc!azicncj.
11 Ivi, . 625.
Bcrgcs c Oanic. una sinicnia scspciia 735
mo ad aIlre. DecIina iI giorno, Ia Iuce si affalica e man mano che
ci addenlriamo neII'incisione comrendiamo che non c'e cosa
deIIa lerra che non conlenga. QueI che e slalo, e e sara, Ia sloria
deI assalo e queIIa deI fuluro, Ie cose avule e queIIe che avro,
lullo cio ci asella in quaIche unlo di queI Iabirinlo sereno
|.j. Ho vagheggialo un'oera magica, una minialura che sia
anche un microcosmo, iI oema di Danle e quesla minialura
d'ambilo universaIe
12
.
La somigIianza lra I'aIeh e iI oema danlesco e imressionanle,
anzi diremmo che sono Ia slessa cosa. La differenza sla neI fallo
che Danle ha avulo iI dono ma anche Ia nq|ris di racconlare
I'ineffabiIe, di irasunanar, cosa vielala aI ersonaggio di nome orges.
Torneremo suII'aIeh, doo una digressione suIIa nq|ris di Danle-
UIisse neII'inlerrelazione di orges.
LA HYB||S DI DANTI-ULISSI
II XXVI canlo deII'|njcrnc e lra i iu drammalici deI oema,
e orges moliva Ia risaula idenlificazione di Danle con UIisse
allraverso aIcuni aculi riIievi, nolando cioe che UIisse quaIifica Ia
roria imresa come jc||c, e neI canlo XXVII deI Iaradiso c'e un
riferimenlo aI tarcc jc||c !U|issc: I'aggellivo e Io slesso che Danle
usa neIIa seIva oscura, arIando con VirgiIio: icnc cnc |a tcnuia
ncn sia jc||c, quando Danle si lrova neIIo slesso Iuogo di UIisse,
suIIa slessa siaggia che iI greco aveva inlravislo rima di morire,
riferisce che VirgiIio Io cinge con un giunco ccna|irui piacquc, e
sono Ie slesse aroIe ronunciale da UIisse quando narra Ia sua
lragica fine. Iin qui orges, che rirende e cila I'inlerrelazione di
CarIo Sleiner:
Danle non avra ensalo a UIisse, naufragalo in visla di queIIa
slessa siaggia` Ovviamenle s. Ma UIisse aveva voIulo giun-
gervi confidando suIIe sue soIe forze, sfidando i Iimili osli
aII'umano olere. Danle, noveIIo UIisse, vi mellera iede da
vincilore, cinlo d'umiIla, e non Io guidera Ia suerbia, bens Ia
ragione, iIIuminala daIIa grazia
13
.
Ioi cila Augusl Regg:
12 ORGIS, O. C., voI. III, . 343.
13 Ivi, . 355.
Lucio Sessa 736
Danle e un avvenluriero che, come UIisse, ercorre slrade non
ercorse, mondi non visli da uomo aIcuno e asira aIIe mele
iu difficiIi e remole. Ma iI aragone finisce qui. UIisse inlra-
rende avvenlure roibile a rorio rischio e ericoIo, Danle si
Iascia condurre da forze sueriori
14
.
orges afferma che laIi inlerrelazioni sono Iogiche ma conlengo-
no un errore di fondo, in quanlo
I'azione di UIisse e indubilabiImenle iI viaggio di UIisse, erche
UIisse non e aIlro che iI soggello di cui si redica laIe azione,
ma I'azione o I'imresa di Danle non e iI viaggio di Danle, bens
I'esecuzione deI Iibro. II dalo e ovvio, ma si lende a dimenlicar-
Io, erche Ia Ccnnc!ia e redalla in rima ersona, e I'uomo che
e morlo e slalo oscuralo daI rolagonisla immorlaIe. Danle era
leoIogo: sovenle Ia scrillura deIIa Ccnnc!ia gIi sara arsa non
meno ardua, forse non meno azzardala e falaIe, deII'uIlimo
viaggio di UIisse. Aveva osalo discellare su arcani che Ia enna
deIIo Sirilo Sanlo a slenlo menziona, queI roosilo oleva
ben nascondere una coIa. Aveva osalo equiarare ealrice
Iorlinari aIIa Vergine e a Gesu. Aveva osalo anliciare i della-
mi deII'imerscrulabiIe Giudizio IinaIe, che i beali ignorano,
aveva giudicalo e condannalo Ie anime di ai simoniaci saI-
vando queIIa deII'averroisla Sigieri, che aveva insegnalo iI
lemo circoIare. I lullo queslo er Ia gIoria, cosa lanlo effime-
ra!
15
L'inluizione borgesiana risuIla iIIuminanle, convincenle: s, Danle
s'idenlifica con UIisse, rova Io slesso senso di sconfinamenlo, di deIi-
rio (elimoIogicamenle !c-|ira chi esce daI sc|cc, in Ialino |ira). Id e
queslo limore, queslo eso emolivo che conferisce aI canlo Ia sua lre-
menda virlu, erche Danle fu UIisse e in quaIche modo lemelle
anaIogo casligo, concIude orges.
Se iI viaggio deI Danle ersonaggio era aulorizzalo, nessuno aveva
aulorizzalo Danle AIighieri a scrivere iI oema.
IATRIZ VITIRO - IATRICI IORTINARI
II orges rolagonisla deI racconlo cilalo vive in modo slruggenle
Ia morle di ealriz Vilerbo. Come Danle AIighieri queIIa di ealrice
14 ||i!.
15 ||i!.
Bcrgcs c Oanic. una sinicnia scspciia 737
Iorlinari. I orges sosella che Danle abbia edificalo iI migIior Iibro
deIIa sloria deIIa Ielleralura er inframmezzare quaIche inconlro con
I'irrecuerabiIe ealrice
16
. Ma doo averIa rinconlrala Ia rierde
e er semre. |Ccsi crai, c quc||a, si |cniana / ccnc parca, scrrisc c riguar-
!cnni, / pci si icrnc a||ciicrna jcnianaj. Ier orges sono i versi iu
alelici che Ia Ielleralura ci abbia mai dalo. Li incIude iI canlo XXXI
deI Para!isc e, sebbene cos famosi, nessuno sembra aver cailo iI do-
Iore che conlengono, nessuno Ii ha mai ascoIlali inleramenle
17
.
Riconsideriamo Ia scena. Danle, con ealrice accanlo, si lrova
neII'Imireo. Sora di Ioro si disiega, incommensurabiIe, Ia Rosa dei
Giusli. La Rosa e Ionlana, ma Ie forme che Ia ooIano sono nilide.
Quesla conlraddizione, anche se giuslificala daI oela (Para!isc XXX,
118), cosliluisce forse iI rimo indizio di un'inlima discordia. ealrice,
imrovvisamenle non e iu accanlo a Iui. Un vecchio ha reso iI suo
oslo |crc!ca tc!cr Bcairicc c ti!i un scncj
18
.
Danle riesce a slenlo a chiedere dove sia ealrice. Otc c||a`,
grida. L'anziano gIi moslra uno dei cerchi deII'aIlissima rosa.
L, aureoIala, c'e ealrice, ealrice, iI cui sguardo soIeva coImar-
Io di inloIIerabiIe bealiludine, ealrice, che amava veslire di
rosso, ealrice, a cui aveva ensalo lanlo che Io sgomenlo con-
siderare che aIcuni eIIegrini, da Iui inconlrali un mallino a
Iirenze, non avevano mai senlilo arIare di Iei, ealrice, che
una voIla gIi aveva negalo iI saIulo, ealrice, che era morla a
venliquallro anni, ealrice di IoIco Iorlinari, andala in sosa a
ardi. Danle Ia scorge Iassu, iI chiaro firmamenlo non e iu Ion-
lano daI iu rofondo deI mare che Iei da Iui. Danle Ia rega
come regasse Dio, ma anche come una donna desiderala: O
!cnna in cui |a nia spcranza tigc / c cnc scjjrisii pcr |a nia sa|uic / in
injcrnc |asciar |c iuc tcsiigc |.j. ealrice aIIora Io guarda un
islanle e sorride, er oi voIgersi aII'elerna fonle di Iuce
19
.
II momenlo in cui Danle vede aIIonlanarsi ealrice e er Iui fonle
di indicibiIe lrislezza, nonoslanle Ie rassicuranli inlerrelazioni aIIe-
gorico-leoIogiche. orges cila Iielrobono, De Sanclis, Guido VilaIi, che
danno un'inlerrelazione lulla aIIegorica aIIa scena, er cui Danle,
una voIla raggiunla Ia divinila, non avrebbe iu bisogno deIIa fede,
cioe di ealrice, come rima, avendo Ia fede (ealrice), non aveva iu
16 ORGIS, O. C., voI. III, . 373.
17 Ivi, . 372.
18 Ivi, . 373.
19 ||i!.
Lucio Sessa 738
bisogno deIIa ragione (VirgiIio). Cila De Sanclis: Quando ealrice si
aIIonlana, Danle non rofferisce Iamenlo: ogni arle lerrena e in Iui
arsa e consumala
20
. Ma anche qui, come neI caso deII'inlerrelazione
deI canlo di UIisse, orges seara iI Danle ersonaggio daII'aulore,
er cui se cio che sosliene De Sanclis e vero er iI ersonaggio, non Io
e er iI oela in carne e ossa.
Soffermiamoci su un fallo inconlroverlibiIe, un soIo fallo umi-
Iissimo: Ia scena e slala innaginaia da Danle. Ier noi, e moIlo
reaIe, er Iui, moIlo meno. (La reaIla, er Iui, era che rima Ia
vila e oi Ia morle gIi avevano slraalo ealrice). Assenle er
semre da ealrice, soIo e forse umiIialo, immagino Ia scena
er immaginarsi insieme a Iei. Disgrazialamenle er Iui, feIi-
cemenle er i secoIi che I'avrebbero Iello, Ia coscienza che
queII'inconlro era immaginario deformo Ia visione. Da qui Ie
circoslanze alroci, lanlo iu infernaIi, naluraImenle, in quanlo
accadono neII'Imireo: Ia scomarsa di ealrice, iI vecchio che
ne rende iI oslo, Ia sua brusca ascesa aIIa Rosa, Ia fugacila
deI sorriso e deIIo sguardo, iI diIeguarsi elerno deI vIlo
21
.
La slessa cosa era accadula in occasione deI rimo inconlro di
Danle con ealrice, neI Iaradiso lerreslre, canlo XXX deI Purgaicric, Ia
rocessione racconlala e inquielanle, forse anche un o' sinislra,
senz'aIlro fuori Iuogo, neI senso IelleraIe deI lermine, vislo che, doo
lanlo eregrinare er i gironi infernaIi e urgaloriaIi, si e arodali
finaImenle aI Iaradiso lerreslre. Scrive TheohiI Soerri: Senza
dubbio Io slesso Danle aveva revislo diversamenle queII'inconlro.
NuIIa indica neIIe agine recedenli che I'asellava Ia eggior umiIia-
zione deIIa sua vila
22
. orges ha una sua siegazione, doo aver,
ancora una voIla, scruoIosamenle enumeralo e scarlalo Ie inlerrela-
zioni degIi aIIegorisli, dice:
Danle, morla ealrice, pcr!uia pcr scnprc ealrice, gioco con Ia
finzione di inconlrarIa, er miligare Ia roria lrislezza, io ri-
lengo che edifico Ia lriIice archilellura deI suo oema er
inframmezzare laIe inconlro. GIi accadde aIIora cio che suoIe
accadere nei sogni, macchiandoIi di lrisli oslacoIi. TaIe fu iI caso
di Danle. Rifiulalo er semre da ealrice, sogno ealrice, ma
Ia sogno severissima, ma Ia sogno inaccessibiIe, ma Ia sogno su
20 Ivi, . 374.
21 ||i!.
22 Ivi, . 371.
Bcrgcs c Oanic. una sinicnia scspciia 739
un carro liralo da un Ieone che era un ucceIIo ed era lullo ucceI-
Io o lullo Ieone quando gIi occhi di ealrice Io asellavano |.j.
Infinilamenle esislelle ealrice er Danle. Danle ochissimo,
forse nuIIa, er ealrice, lulli noi roendiamo er iela, er
venerazione, a dimenlicare quesla comassionevoIe discordia
indimenlicabiIe er Danle
23
.
II sinlagma pcr!uia pcr scnprc e Io slesso usalo in L'AIeh. La
differenza consisle neI fallo che Danle e riuscilo neIIa mirabiIe imre-
sa di descrivere I'aIeh che ha vislo, sorla di oIlremondo, e riuscilo a
irasunanar, ha scrillo Ia Ccnnc!ia, ma non e riuscilo a recuerare
ealrice, che era iI suo vero obiellivo, essendo iI reslo uro schermo.
I cerchi deI casligo e iI Iurgalorio auslraIe e i nove cerchi concenlrici
e Irancesca e Ia sirena e iI grifone e erlrand de orn sono accidenlaIi,
un sorriso e una voce, che egIi sa erdule, sono Ia cosa fondamenla-
Ie
24
. en diversa Ia sorle di IaoIo e Irancesca, unili er semre
neII'Inferno |qucsii cnc nai !a nc ncn jia !itiscj, ed e quesla sorle che
Danle conlemIa con savenloso amore, con ansia, con ammirazio-
ne, con invidia
25
. Id e a causa di queslo ensiero, insoorlabiImenle
verliginoso, insoorlabiImenle ardilo, che subilo doo Danle ca!c
ccnc ccrpc ncric ca!c.
Se Danle e riuscilo a rammemorare I'aIeh e a lrovare Ie aroIe er
dirIo, iI orges ersonaggio deI racconlo omonimo non ce I'ha falla.
Ha erdulo ealriz e non ha scrillo iI oema. Ma iI orges aulore
invece ce I'ha falla, Ia sua Ielleralura I'ha scrilla, come Danle. Sara un
caso che rorio neI racconlo cilalo orges aaia come ersonaggio,
esallamenle come Danle neIIa Ccnnc!ia` Resla iI dalo che ealriz
Vilerbo e pcr!uia pcr scnprc da orges, come ealrice Iorlinari e
pcr!uia pcr scnprc da Danle. Iorse sliamo cominciando a risondere
aIIa domanda iniziaIe suI erche orges fosse cos reso daIIa Oitina
Ccnnc!ia.
TRA INCANTO I DISINCANTO
orges, in un cicIo di conferenze lenulo neI '77, iI cui rimo oggel-
lo e rorio Ia Ccnnc!ia, ironizza su un'osservazione di IauI CIaudeI,
23 ||i!. |ccrsitc !i rc!azicncj.
24 ||i!.
25 I. 371. |iI sinlagma savenloso amore, cspanicsc ancr, ci fa venire in menle i
versi finaIi di una oesia di orges (nc ncs unc c| ancr sinc c| cspanic / scr4 pcr csc quc |a
quicrc ianic) rivoIla a uenos Aires, amala da orges, lemula da orges, come si uo
amare e lemere una donnaj.
Lucio Sessa 740
iI quaIe ha scrillo, in una agina indegna di IauI CIaudeI, che gIi
sellacoIi che ci allendono doo Ia morle cororea non assomigIie-
ranno, senza dubbio, a queIIi che Danle ci moslra neII'Inferno, neI
Iurgalorio, neI Iaradiso
26
. Danle sarebbe slalo d'accordo con Iui,
commenla ironicamenle orges. Ier iI oela fiorenlino Ia raresenla-
zione deIIa Ccnnc!ia era un'evidenle aIIegoria, e Io dimoslrano
I'eisloIa a Cangrande deIIa ScaIa e Ia Iellera aocrifa deI figIio (di
Danle) Iacoo. I evidenle che Danle non oleva credere in un aIdiIa
fallo di coni rovesciali, di siagge urgaloriaIi e ascensioni varie, e in
cui avrebbe olulo conversare di sloria fiorenlina con gIi osili dei lre
regni e in lerzine loscane. Com'e ossibiIe che IauI CIaudeI sia slalo
cos ingenuo`, si chiede dunque orges. I risonde scrivendo che
I'inlensila deI leslo danlesco e laIe da indurci a credere che I'aulore
immaginasse I'aIlro mondo rorio come ce Io raresenlava neIIa
sua oera. Crederci dice orges e saIvare iI iacere deIIa Iellura, e
alluare queIIa che CoIeridge chiamava Ia sosensione d'increduIila
senza Ia quaIe non si darebbe aIcuna calarsi arisloleIica. I d'aIlra
arle, Io slesso orges, moIli anni rima, in una raccoIla oelica deI
'64, aveva guardalo aIIa Ccnnc!ia con occhi incanlali, scrivendo i
seguenli versi: .AIIorche diran Ie lrombe iI Giudizio UniversaIe, / Ia
lerra sveIera iI suo grembo e i ooIi / risorgeranno lulli daIIa oIvere
/ obbedendo aIIa occa inaeIIabiIe, / gIi occhi non vedranno i
nove cerchi deIIa monlagna rovesciala.
27
. Ividenlemenle, aveva
commesso Io slesso errore di CIaudeI, reso daII'inlensila deI leslo.
II fallo curioso e che orges riele I'errore anche nei saggi danle-
schi, oche agine doo aver ironizzalo suI oela-ambascialore
francese. Lo fa neI saggio inliloIalo II nobiIe casleIIo deI canlo quar-
lo quando scrive:
en iu rofonda e Ia differenza lra iI canlo deI casleIIo e i se-
guenli. NeI canlo V, Danle ha fallo arIare in modo immorlaIe
Irancesca da Rimini, neI recedenle, quaIi aroIe non avrebbe
olulo far dire ad ArisloleIe, a IracIilo o a Orfeo, se avesse gia
ensalo a queII'arlificio
28
.
Qui orges ci sorrende, erche e chiaro che se aI Danle ersonag-
gio era vielalo riercorrere a rilroso i gironi infernaIi, I'aulore s che
oleva lornare suII'oera er modificarIa, e non c'e dubbio che vi sia
26 ORGIS, La Divina Commedia, in Sicic nccncs (1980), in O. C., voI. III, . 207.
27 ORGIS, DeI inferno y deI CieIo, in || circ, c| nisnc (1964), in O. C., voI. II, .
243.
28 ORGIS, O. C., voI. III, . 349.
Bcrgcs c Oanic. una sinicnia scspciia 741
lornalo incessanlemenle. Come mai orges non si accorge deII'in-
congruenza, anche in considerazione deI fallo che neIIe inlerrelazio-
ni recedenli reIalive a UIisse e a ealrice ha smascheralo I'ambiguila
lra iI Danle ersonaggio e iI Danle aulore, guardando Ie cose daI un-
lo di visla deI secondo` Qui, invece, comie I'oerazione inversa, e
er giunla subilo doo aver rimroveralo IauI CIaudeI di avere in-
lerrelalo come egIi slesso di I a oco inlerrelera. DifficiIe dare una
risosla, o forse Ie risosle sono due, Ia rima e che I'inlensila deI le-
slo danlesco ha rireso iI soravvenlo, come accadulo nei versi cilali
in recedenza, er cui Ie criliche a CIaudeI sarebbero slale soIo un in-
lervaIIo di disincanlo, Ia seconda e che orges si sia enlilo di aver
rollo, con Ie criliche a CIaudeI, iI allo non scrillo deIIa sosensio-
ne d'increduIila e abbia voIulo ricomorre I'infranlo. D'aIlra arle,
orges insisle sesso suIIa necessila di Ieggere Ia Ccnnc!ia con occhi
innocenli, ur neIIa consaevoIezza che laIe innocenza ci e vielala.
Ma resliamo neI nobiIe casleIIo, neI Iimbo in cui lrovano sazio gIi
sirili magni, e iI Iellore uo immaginare I'emozione di Danle quando
si lrova di fronle VirgiIio, Omero, Orazio, Ovidio, Lucano, seslo lra
colanlo senno. Come lrascorrono iI lemo quesli sirili magni` Scrive
orges che arIano inlerminabiImenle di Ielleralura (cos'aIlro osso-
no fare`). Hanno Iello I'||ia!c o Ia |arsa|ia o scrivono Ia Ccnnc!ia, sono
magislraIi neII'esercizio deIIa Ioro arle, e lullavia si lrovano neII'In-
ferno erche Ii dimenlica ealrice
29
.
Di nuovo: Ia Ielleralura non consoIa deI erdulo amore, erche ri-
fugio lemoraneo e non aaganle. Ci aare chiara I'idenlificazione
di orges con laIe lemalica: e I'amore fruslralo er ealrice che orla
Danle a scrivere Ia Ccnnc!ia, secondo orges, sono gIi amori fruslrali
di orges ad avvicinarIo a Danle, secondo noi, a senlirIo come anima
gemeIIa, come chi e aIIa ricerca deII'aIeh a comensazione di una
vila senlimenlaIe infeIice. Una rosa di orges olrebbe far aarire
meno eregrina quesla iolesi.
IL MINACCIATO
I I'amore. Dovro nascondermi o fuggire.
Crescono i muri deI suo carcere, come in un scgnc airccc. La
beIIa maschera e cambiala, ma come semre e I'unica. A cosa
mi serviranno i miei laIismani: |cscrcizic !c||c |ciicrc, |a taga
cru!izicnc, I'arendimenlo deIIe aroIe usale daII'asro Nord
er canlare i suoi mari e Ie sue sade, |a scrcna anicizia, i
29 Ivi, . 350.
Lucio Sessa 742
ccrri!ci !c||a Bi||icicca, Ie cose comuni, Ie consueludini, iI giova-
ne amore di mia madre, I'ombra miIilare dei miei morli, Ia nolle
inlemoraIe, iI saore deI sogno`
Slare con le o non slare con le e Ia misura deI mio lemo.
Gia Ia brocca si rome suIIa fonle, gia I'uomo si Ieva aI canlo
deI gaIIo, gia si sono scurili i vIli aIIe fineslre, ma I'ombra non
ha orlalo Ia ace.
I, Io so, I'amore: I'ansia e iI soIIievo di senlire Ia lua voce,
I'allesa e iI ricordo, |crrcrc !i titcrc succcssitancnic.
| |ancrc ccn |c suc niic|cgic, |c suc piccc|c nagic inuii|i.
C'e un angoIo di slrada dove non oso assare.
Gia mi accerchiano gIi esercili, Ie orde.
(Quesla slanza e irreaIe, Iei non I'ha visla.)
II nome di una donna mi denuncia.
Mi fa maIe una donna in lullo iI coro
30
.
Dunque |cscrcizic !c||c |ciicrc, i ccrri!ci !c||a Bi||icicca, sono laIisma-
ni inuliIi er sfuggire aII'amore, sono vani, I'unica cosa che conla e
ealrice, e ealrice e irraggiungibiIe, I'amore e Ia reaIla, che e simuIla-
nea, iI Iinguaggio invece e successivo, e quindi non I'afferra, non c'e
cubismo o simuIlaneismo che lenga, queIIe sono iIIusioni giovaniIi e
avanguardisliche che orges ha ben reslo riudialo, rassegnandosi a
canlare I'assenza, a inseguir aroIe come chi insegue farfaIIe, come chi
insegue fanlasmi di cose, simuIacri. In L'AIeh I'io narranle arIa
deII'imossibiIila di racconlare quanlo ha vislo, erche iI Iinguaggio e
successivo, e anche qui, in quesla rosa, si arIa deII'orrore di vivere
successivamenle. La reaIla e I'amore, ma iI oela e incaace di viverIa,
e non gIi resla che rassegnarsi aIIa Ielleralura. Anch'egIi ha scrillo Ia
sua Ielleralura er inconlrare Ia sua ealriz, ma Ia Ielleralura consoIa
soIo arziaImenle. Ier queslo i canli danleschi menzionali sono venali
d'incubo, erche Danle, come orges, caisce che e lullo inuliIe, er
queslo neI canlo XXXI deI Para!isc ci sono i versi iu alelici che Ia
Ielleralura ci abbia mai dalo.
Ma lorniamo aI canlo deI Purgaicric in cui avviene I'inconlro con
ealrice, Danle enlra neI Iaradiso lerreslre, aIIa vella deI Iurgalorio,
quando arriva iI carro che lrasorla ealrice. Lasciamo Ia aroIa a
orges:
II carro si arresla e una donna veIala aare, Ia sua vesle e coIor
di fiamma viva. Non aIIa visla, ma aIIo sluore deI rorio
30 ORGIS, II amenazado, in || crc !c |cs iigrcs, 1972, in O. C., voI. II, . 485. |Ccr-
siti !i rc!azicncj.
Bcrgcs c Oanic. una sinicnia scspciia 743
animo e aI rimescoIarsi deI rorio sangue, Danle comrende
che e ealrice. SuIIa sogIia deIIa GIoria senle I'amore che lanle
voIle I'aveva lrafillo a Iirenze. |Ccncscc i scgni !c||aniica jian-
na}. Cerca I'aiulo di VirgiIio, come un bimbo savenlalo, ma
VirgiIio non gIi e iu accanlo
31
. |Ma Virgi|ic natca |asciaii sccni
/ !i sc, Virgi|ic !c|cissinc pa!rc, / Virgi|ic a cui pcr nia sa|uic
!icnij.
Come iI rolagonisla de II minaccialo, Danle cerca rifugio nei
suoi laIismani, cos'e infalli VirgiIio se non I'esercizio deIIe Iellere, Ia
serena amicizia, i corridoi deIIa bibIioleca nei quaIi cercare un (vano)
rifugio` (L'anacronismo di Ieggere Danle a arlire da orges e lullo
borgesiano: ogni oera crea i suoi recursori).
Scrive orges:
Innamorarsi e creare una reIigione iI cui dio e faIIibiIe. Che
Danle abbia rofessalo er ealrice un'adorazione idoIalrica e
una verila inconlroverlibiIe, che Iei una voIla si sia burIala di Iui
e un'aIlra voIla I'abbia schernilo sono falli che racconla Ia Vila
nuova. C'e chi sosliene che quesli falli siano immagini di aIlri,
se fosse cos, sarc||c anccr piu rajjcrzaia |a ncsira ccriczza !i un
ancrc stcniuraic c supcrsiizicsc
32
.
C'e una vaga assonanza lra I'ancrc stcniuraic c supcrsiizicsc che
I'argenlino allribuisce a Danle e Ia tana !ctczicnc di orges er ealriz
Vilerbo. I c'e anche iI verso e I'amore con Ie sue miloIogie, Ie sue
iccoIe magie inuliIi.
Torniamo ai canli incriminali deI Purgaicric. I'aarizione di
ealrice e recedula neI XXIX canlo da una rocessione aIquanlo
sinislra, e moIli commenlalori Io nolano, er esemio CarIo Sleiner:
Una donna con lre occhi e un moslro, ma qui iI freno deII'arle
non lralliene iu iI oela, erche gIi sla iu a cuore esrimere Ie mora-
Iila che gIi sono care. Segno evidenle che neII'anima di queslo gran-
dissimo arlisla non I'arle leneva iI rimo oslo, ma I'amore deI
bene. I VilaIi: Lo sforzo di aIIegorizzare orla Danle a invenzioni di
dubbia beIIezza. Tullavia, orges afferma che Danle voIeva che
Ia rocessione fosse beIIa: |Ncn cnc |cna !i carrc ccsi |c||c / ra||cgrassc
Ajricanc, c tcrc Augusic, / na quc| !c| Sc| saria pctcr ccn c||cj.
I invece
31 ORGIS, O. C., voI. III, . 369.
32 Ivi, . 371.
Lucio Sessa 744
Ia rocessione e di comIicala brullezza: un grifone Iegalo a
una carrozza, animaIi con aIi cosleIIale d'occhi aerli, una don-
na verde, un'aIlra cremisi, un'aIlra che ha lre occhi in viso, un
uomo che cammina addormenlalo, sembrano meno rori aIIa
GIoria che ai vani cerchi infernaIi. Non ne sminuisce I'orrore iI
fallo che aIcune di laIi figure rovengono dai Iibri rofelici e aI-
lre daIIa RiveIazione di san Giovanni
33
.
Tulli i commenlalori hanno solloIinealo Ia severila di ealrice,
infalli, Ie rime aroIe che gIi rivoIge sono dure (Oanic, pcrcnc Virgi|ic
sc nc ta!a / ncn piangcr ancc, ncn piangcrc anccra, / cnc piangcr ii ccnticn
pcr a|ira spa!a) e iI reslo non e iu lenero, lanlo che Io fa iangere di
nuovo, sollomellendoIo a una secie di aulodafe, aIlri commenlalori
hanno solloIinealo Ia brullezza di cerli embIemi, secondo orges, si
lralla di due anomaIie che hanno un'origine comune, ossia I'amore
svenluralo e suerslizioso di Danle er ealrice che macchia d'incubi
un sogno ambienlalo neI Iaradiso lerreslre. QueI sogno e divenlalo
un scgnc airccc, come accade aI minaccialo.
Un incubo che si fissa e si diIala neI canlo successivo. ealrice
sarisce, un'aquiIa, una voIe e un drago allaccano iI carro, Ie
ruole e iI limone si corono di iume, iI carro, aIIora, lira fuori
selle lesle, un giganle e una roslilula usurano iI oslo di
ealrice
34
.
IROSTITUTI
NegIi anni sagnoIi giovaniIi, queIIi riudiali, orges racconla con
enfasi Ia visila a un Iuanare
35
, e I'andirivieni lra erolismo e Ielleralura
e incessanle, a arlire daIIa orla |deI Iuanarej ubbidienle, che cede
con Ia dociIila di un Iibro che si are aIIa agina gia abusala e sciuala
daI lroo sludio, I'almosfera deI Iuanare e come una oesioIa in
cui doIore fa rima con amore, e inlanlo ci deIiziano Ie curve faciIi di
una ragazza, essenziaIe e scoIila come una frase di Quevedo, menlre
Ia lenularia maiuscoIa e geslicoIanle ci inlralliene e accella senza
lradire Ia minima sorresa I'ossidala monela faIsa deIIa noslra Io-
gorrea.
33 ||i!.
34 ||i!.
35 ORGIS, Casa ||cna, ubbIicalo suIIa rivisla UIlra, Madrid, Ao 1, n. 17, 30 de
oclubre, 1921, in Tcxics rccc|ra!cs (1919-1929), uenos Aires, Imece 1997, . 112-113
|lulle Ie cilazioni che seguono sono lralle da queslo lesloj.
Bcrgcs c Oanic. una sinicnia scspciia 745
Di I a oco, un breve sazio, un rigo saIlalo e si arriva aI dunque,
che orges racconla cos:
Ioi I'incaslro carnaIe. Con quesle due aroIe ho finilo, giacche
iI iacere, sfuggendo aIIa memoria, non Io si uo lrallenere
racchiudendoIo in una formuIa. DeII'inlera malassa sensoriaIe,
Ia memoria immagazzina soIo dali udilivi e visivi. GIi aIlri
iacere, doIore, slali lermici ersislono soIo se lradolli nei
Iinguaggi reIalivi aII'udilo o aIIa visla. D'aIlra arle, che
imorlanza avranno mai Ie inleriezioni e Ia cangianle Iaslicila
deIIe fasi deI congiungimenlo, se laIi cose hanno un vaIore
unicamenle risello aI iacere, che e I'unica cosa essenziaIe, e
che nessuno riuscira mai a callurare in un ordilo arlislico`
ealrice, Venere voIgare o ceIesle che sia, non uo essere canlala,
non uo essere raresenlala arlislicamenle: I'arle faIIisce Io scoo,
er definizione, giacche I'unica cosa essenziaIe, iacere o amore che
sia, non olra mai essere callurala da un ordilo arlislico, dice orges.
Sara er queslo che orges non arIa quasi mai d'amore nei suoi
lesli` I Ia cosa si coIIega aIIa sua oelica deII'assenza, aIIa denuncia
incessanle deIIa fragiIila deI Iinguaggio, deII'imossibiIila di dire se
non allraverso iIIusorie congellure` Vila e morle sono mancale aIIa
mia vila / da qui, da quesla indigenza iI mio amore er laIi minuzie,
scrivera orges, Iaddove naluraImenle Ie minuzie sono Ia Ielleralura.
I orges, a lorlo o a ragione, vedra in Danle, e neIIa sua sloria svenlu-
rala con ealrice, unc nc sccur, come direbbero i francesi. Da qui Ia
sua assione er Danle (abbiamo finaImenle risoslo aIIa domanda
iniziaIe), da qui Ia sua acula inlerrelazione o se referile i suoi
frainlendimenli deII'oera danlesca.
Unitcrsiia !cg|i Siu!i !i Napc|i IOricnia|c
TOMMASO IISANTI
DANTISMO IN AMIRICA
Iolrebbe er moIli aselli aarire singoIare iI fallo che un inleres-
se er Danle sia slalo in quaIche modo resenle, sin daII'inizio, in
America, neI Nuovo Mondo. Ne bisogna Iasciarsi fuorviare da
un'immagine di un'America lulla eslroversa e un o' fracassona.
L'America ha dielro di se comonenli comIesse e anche lorluose, e
conlinua a essere allraversala, in un modo o neII'aIlro, da queIIa che
Ierry MiIIer defin Ia sollerranea correnle cosliluila daIIe sue ecu-
Iiari lensioni elico-reIigiose coIIegale d'aIlronde con Ie sue slesse
origini, coI suo slesso sviIuo
1
.
Nacque I'America deI reslo, come milo reIigioso iu che russoiano,
e si configuro darima come rogello di una nuova pc|is lransocea-
nica, di una Nuova GerusaIemme desiderala con agosliniana inlensila
e vigore, aI lemo slesso dinamico-allivislico. La tasiiiu!c ancricainc
(Ia chiamo cos Chaleaubriand) fu camo simuIlaneamenle di un
avvenluroso muoversi e di reIigiose lensioni e simboIogie
2
. I benche
miIioni di emigrali si siano oi riversali neI Nuovo Mondo, resla
delerminanle aunlo aIIa base I'avvenluroso sbarco dei grui di
urilani ingIesi che erseguilali allraversarono neI 1620, iI furioso
Oceano. I i urilani erano zeIanli, rigorosi, esaseravano iI rinciio
roleslanle deIIa Iibera coscienza, deI raorlo dirello-drammalico lra
I'uomo e Dio, e sorallullo er quanlo lendevano ad inquadrare even-
li siluazioni e ersone in relicoIi di simboIi e aIIegorie. IIemenli che
aarivano ben evidenziali, er I'aunlo, in un Danle er queI che
oleva fiIlrare consideralo ressoche unico er rigore elico e oIe-
mica fierezza, in un anorama ilaIiano-rinascimenlaIe che ad essi, i
urilani, aariva dominalo da uno sirilo di rofanila. DeI reslo,
Ia ubbIicislica roleslanle si era gia aroriala, anzi, di alleggia-
1 Si vedano di IIRRY MILLIR i due fondamenlaIi sludi suIIo sirilo deIIa Nuova
InghiIlerra, || Sciccnic e Oa cc|cnia a prctincia, oIogna, II MuIino 1962. SuII'America
urilana rimando aI mio Ic spcccnic c i| ragnc. Iciicraiura ancricana !c||c crigini, NaoIi,
Guida 1977.
2 TOMMASO IISANTI, o. cil., . 8. Ier Ia pc|is lransoceanica rimando aI beI Iibro di
GIORGIO SIINI, Auic|icgrajia !c||a gictanc Ancrica, Torino, Iinaudi 1968.
Tommaso Iisanli 748
menli e squarci danleschi. Id un esemio e offerlo da }ohn Collon,
I'eminenle leoIogo e redicalore, che incIuse Danle in un eIenco di
anlicialori aunlo deIIa Riforma
3
.
Ma si andavano assorbendo, via via, anche aIlri aselli, aIlre
islanze cuIluraIi, e andra aIlres diIalandosi, in generaIe, iI raorlo
fra Dio e Ia umana ragione, er gIi effelli esercilali daIIa fisica
nevloniana, daIIa fiIosofia di Locke, in arle daII'iIIuminismo slesso,
e lermini come Iiberla e saIvezza andranno cos configurandosi
semre iu Iungo iI Sellecenlo, in senso ormai iu oIilicizzalo. Malu-
rarono in laIe lemerie, Ia rivoIla deIIe coIonie e I'idea, Ia Iolla er
I'indiendenza americana. IaraIIeIamenle, e subilo doo, vanno dif-
fondendosi Ie lensioni e inquieludini reromanliche e romanliche, con
iI guslo come in Iuroa, er iI subIime, I'orrido e iI alelico e lra i
oeli anlichi e moderni si Iegge suI |rccnans jcurna| deI 17 dicembre
1783 nessuno come Danle offre in cos rimarchevoIe esemio deI ve-
ro subIime e deI vero alelico
4
. Ne meravigIia iI fallo che Ia rima
rieIaborazione-lraduzione di un eisodio danlesco aarsa in Ameri-
ca sia queIIa deI conle UgoIino. Traduzione-rieIaborazione in dislici
con rima baciala. Aarve neI 1792, suI Ncu Ycrk Magazinc e I'aulore
fu WiIIiam DunIa, scrillore, illore, imresario lealraIe, con lendenza
naluraImenle neIIa sua lraduzione aII'amIificazione in chiave dram-
malica: Occp in inc !c|cju| icucr cj gui|is | saic
5
.
I va inlanlo mulando I'immagine slessa deII'ilaIiano, va assumen-
do i lralli deI alriola ardenle e ugnace. Inlanlo, in una iccoIa Nev
York di aIcune migIiaia di abilanli veniva a slabiIirsi Lorenzo Da
Ionle, che doo i lrionfi come Iibrellisla er Mozarl a Vienna aveva
dovulo lrasferirsi a Londra, con Ia mogIie ingIese, neI 1792. Ma doo
aIcuni anni di allivila resso iI lealro ilaIiano, erseguilalo dai credi-
lori e da infinile aIlre cabaIe, si decise infine a lrovare rifugio aI di Ia
deII'Oceano
6
. Si diede Da Ionle a dare in Nuova }orca anche Iezioni
di ilaIiano e ad organizzare raresenlazioni lealraIi. I fu infine
chiamalo ad insegnare ilaIiano aI CoIumbia CoIIege. Trovandosi cos a
risludiare coI iu grande fervore queI divino oema di Danle e a
3 Vi sono incIusi anche Ielrarca e MarsiIio da Iadova. Ier una iu amia lrallazio-
ne deII'argomenlo rimando anche aI mio voIume Oaniisnc ancricanc c a|iri saggi,
NaoIi, Loffredo 1979 e Iun |iic c |a|irc, NaoIi, Liguori 1995.
4 Si veda GUIDO CAIIONI, Ia jcriuna !i Oanic aiiratcrsc |c ritisic !c| pcric!c cc|cnia|c
ancricanc, Sludi danleschi, XXXI (1953).
5 La versione aarve soIo con Ie iniziaIi W. D., neIIe quaIi }oseh G. IuciIIa idenli-
fico aunlo iI DunIa (|ia|ica, VIII, 1931, . 40-41), ora Siu!ics an! ncics, NaoIi-Roma
1953.
6 Si veda in generaIe RODIRIK M. MARSHALL, Iia|q in |ng|isn Iiicraiurc, NevYork
1934.
Oaniisnc in Ancrica 749
schiarirne Ie oscurila e i assi difficiIi. I su cio ubbIico, neI 1825,
una Criiiquc cn ccriain Passagcs in Oanic, suIIa Ncu Ycrk |cuicu
7
.
Nei rimi decenni deII'Ollocenlo, coI diffondersi deI Romanlici-
smo, I'inleresse er Ia Ccnnc!ia si va aIimenlando anche in America
di un guslo vivido er Ie grandi sinlesi, er una oesia che ne sia voce
ed esressione. I come in Iuroa, e I'|njcrnc queIIa deIIe lre canliche
ad essere esaIlala maggiormenle, senza lullavia che venga meno, in
America, un inleresse anche di carallere elico. I sara rorio qui che iI
danlismo americano scavava una sua ecuIiare zona di arofondi-
menlo, rorio in chiave di simboIi e aIIegorie. DaII'InghiIlerra
giungeva inlanlo Ia lraduzione deII'inlera Ccnnc!ia ad oera di Hen-
ry Cary (1814 e 1819) Iodala daI CoIeridge, e daI IoscoIo: un liico
rodollo romanlico, in cui iI rocedimenlo di lraduzione e come una
sorla di secchio magico
8
. Venne rislamala neI 1822 a IiIadeIfia.
Menlre IoscoIo cominciava a ubbIicare i suoi saggi danleschi, CoIe-
ridge rirendeva inlanlo iI araIIeIo Danle-MiIlon, con nuove acule
considerazioni. CoIeridge dislingueva lra I'orribiIe e iI lerribiIe
(con revaIenza neII'|njcrnc deII'orribiIe). Risonanze di laIi idee si
rilrovano anche in America, in vari saggi ed arlicoIi, menlre andava
rendendo consislenza che aver Iello soIo I'|njcrnc non significa aver
Iello Danle
9
. Sara George Ticknor, rofessore di Iingue e Ielleralure
moderne ad Harvard, che dedichera a Danle neI 1831 un rimo seci-
fico corso di Iezioni
10
. I iI eriodo anche in cui Ie risonanze dei moli
risorgimenlaIi e Ia resenza slessa di numerosi alrioli ilaIiani esuIi in
America suscilano I'immagine di un'IlaIia nuova, iu vicina aIIa nin!
americana
11
.
A succedere aI Ticknor fu chiamalo neI 1835 iI oela Henry
Wadsvorlh LongfeIIov, aIIora famoso e moIlo arezzalo
12
. I a Dan-
le, er iI quaIe nulriva una ammirazione grandissima, egIi voIIe dare,
7 Da Ionle era nalo a Ceneda (ora Villorio Venelo) neI 1749. Mor a Nev York neI
1838. Le Mcncric furono ubbIicale da Da Ionle slesso a Nev York neI 1823 e oi neI
1830 in edizione ridolla. Si veda anche Mcncric c! a|iri scriiii, a cura di Cesare Iagnini,
MiIano 1971.
8 WILLIAM }. DI SUA, Oanic inic |ng|isn. A Siu!q cj inc Trans|aiicns cj inc Oitinc Cc-
nc!q in Briiain an! Ancrica, ChaeI HiII 1964.
9 WiIIiam Irescoll in una Iellera a George Ticknor. Si veda iI voIume di ANGILINA
LA IIANA, Ia cu|iura ancricana c ||ia|ia, Torino, Iinaudi 1938.
10 Ticknor si voIgera oi sorallullo aIIa Ielleralura sagnoIa. Viaggio moIlo in Iu-
roa e fu varie voIle in IlaIia. Rimando aI mio saggio G. Ticknor: iI rimo danlisla, neI
cilalo voIume Oaniisnc ancricanc c a|iri saggi.
11 Duranle iI decennio daI 1830 e aI 1840 I'ilaIiano fu sesso aI secondo oslo
neII'insegnamenlo deIIe Iingue ad Harvard, doo iI francese.
12 Si veda in WIRNIR IRIIDIRICH, Oanics |anc A|rca!, Roma 1950. Rimando anche
aIIa mia voce su LongfeIIov neIIa |ncic|cpc!ia !anicsca, Treccani, voIume III.
Tommaso Iisanli 750
in Iingua ingIese, una lraduzione comIela deI divin oema. OIlre
ai vari arlicoIi e saggi che dedico a Danle, i suoi rimi saggi di lradu-
zione risaIgono aI 1839, ma Ia lraduzione deII'inlero oema sara
uIlimala soIo venli anni doo, neI 1865, rorio in occasione deI seslo
cenlenario deIIa nascila di Danle. Sembro, Ia lraduzione, sueriore a
queIIa deI Cary in ||ank tcrsc (iI verso scioIlo ingIese), ma e naluraI-
menle Ionlana daIIa lerzina danlesca. Ma anche LongfeIIov aveva
rinuncialo aII'ardua lerza rima, difficiIe da conservare in una Iingua
come I'ingIese, cos ricca di monosiIIabi. NeI lradurre Danle, bisogna
rassegnarsi a rinunciare a quaIcosa. AIIa mirabiIe rima che fiorisce,
come iI carifogIio suIIe siei, aIIa fine di ciascun verso. S cerlo, se cio
uo servire a conservare quanlo di iu rezioso ancora: Ia fedeIla..
Ma e rorio su laIe crilerio che cominciarono a circoIare dissensi e
riserve. Come soggiogalo daI grande modeIIo, LongfeIIov aveva con-
dollo Ia sua versione con sirilo di quasi esaseralo IelleraIismo, con
umiIe disonibiIila e insieme con comiacimenlo di rirodurre er
quanlo ossibiIe, iI gran modeIIo: fino a forzare Ie sue slesse carenze
Iinguisliche deII'ingIese con Ie sue inversioni sinlalliche, e Ia referen-
za er aroIe di origine Ialina anziche sassone-germanica. I I'inizio
deI oema suona cos: Mi!uaq upcn inc jcurncq cj cur |ijc | jcun! nqsc|j
uiinin a jcrcsi !ark |.j. I Cary: |n inc ni!uaq cj inis cur ncria| |ijc, |
jcun! nc in a g|ccnq ucc!, asiraq |.j. Quasi araIIeIamenle aIIa lradu-
zione di LongfeIIov rocedeva inlanlo queIIa di Thomas WiIIiam
Iarsons (neI 1843 erano aarsi i rimi dieci canli deII'|njcrnc) e neI
1867 fu ubbIicala Ia rima canlica, ne iI lradullore ando oIlre. AI con-
lrario di LongfeIIov, Iarsons diIalo in chiave di diIuizione romanlica
Ia slringalezza deII'originaIe (adoero ersino Ia quarlina con rima
aIlernala, con lenlalivo ero di animazione crealiva). I Iarsons ebbe
anche er queslo suoi soslenilori. Traduzione, insomma, aIIa LongfeI-
Iov o aIIa Iarsons` II fiorire di sludi e ricerche, che ha iI suo cenlro
aIIa Harvard Universily e neI gruo degIi scrillori bosloniani, ha in-
fine iI suo sbocco neIIa fondazione deIIa Oanic Scciciq cj Ancrica. Ne
furono fondalori LongfeIIov slesso (e ne sara iI rimo residenle),
}ames RusseII LoveII e CharIes IIiol Norlon. LoveII che successe a
LongfeIIov come rofessore ad Harvard, scrisse un saggio su Danle
(1886), in cui si riroone con fermezza I'inleresse er gIi aselli
aIIegorici e simboIici deIIa Ccnnc!ia. Quanlo a Norlon si deve a Iui un
iu deciso orienlamenlo di carallere fiIoIogico. Tradusse anche Ia Viia
Nucta, e in rosa Ia Ccnnc!ia (1891-92) e iI |cpcri annuaIe ubbIicalo
daIIa Oanic Scciciq divenlo semre iu imorlanle slrumenlo di con-
Oaniisnc in Ancrica 751
suIlazione
13
. Ma I'inleresse er Danle era avverlilo anche da aIlre an-
goIazioni e Iungo aIlre direzioni. Danle esercilava cos forli sug-
geslioni anche in quanli ricercavano forme di originaIila americana
verso un Iinguaggio reaIislico e insieme ricco di significalo, e Danle
offriva sorrendenli suggeslioni anche in laIe direzione
14
. I RaIh W.
Imerson osciIIa lra un suo rifiulo di Danle (quaIe sielala minuzia di
orribiIi dellagIi!) e iI suo recuero in chiave di energia vilaIe, di
un'energia unila aIIa simmelria (Danle ha un'immaginazione di lio
oeralivo, Danle e iI oela iu vicino a mani e iedi che si sia mai
vislo). Si va cos rofiIando un recuero di Danle in chiave di con-
lemoraneila e di Ielleralura miIilanle che locchera i verlici, neI
quadro deIIe eserienze novecenlesche, con Izra Iound e T. S. IIiol.
Anche WaIl Whilman cos leso verso iI fuluro, vede in Danle da un
Ialo un cuo mondo da suerare, ma era aIlres coIilo daIIo sliIe e da
una imression of bonafide in aII lhal he says, in lullo cio che Danle
dice. Iiu direlli infIussi sono in MeIviIIe. II simboIismo di Mar!i non e
robabiImenle eslraneo aII'infIusso deIIo sliInovimo e di Danle. La
Nev York di Picrrc e una cilla di Dile, e iI raorlo Iierre-IsabeIIe e
ricaIcalo su IaoIo e Irancesca, senza dire che iI finaIe di Mc|q Oick,
con queII'oceano che roIIed as il roIIed five lhousands years ago,
neIIa lraduzione di Cesare Iavese, riorla immedialamenle aI danle-
sco infin che iI mar fu sovra noi richiuso. Quanlo aII'orrido di I.
A. Ioe e a cerle cue almosfere di Havlhorne, non mancano riferi-
menli danleschi: ma queII'orrido e queI cuo senso deIIe cose
rovengono da aIlre lensioni e radici.
Si uo dire che si siano infine cosliluile come due direllrici. Una,
queIIa di derivazione harvardiana-bosloniana, e andala via via svi-
Iuandosi allraverso Ia fondazione deIIa Oanic Scciciq, una Iinea
fiIoIogica e crilica. L'aIlra condurra invece, come accennalo, a ricallu-
rare in Danle eIemenli anche in senso alluaIe e miIilanle, er
uliIizzare in chiave conlemoranea, er cos dire, suggeslioni e lecni-
che deIIa taricias e oIisemia dei regislri sliIislici danleschi. I qui si
ensa subilo, naluraImenle, a Izra Iound e a T. S. IIiol. Doo sconlri
e oIemiche, Ie due direllrici si sono inlercaIale e iI danlismo iu con-
saevoIe (in un SingIelon, oniamo), ha dalo sviIuo oggi, in
13 SuIIa Oanic Scciciq si veda GIORGI H. GIIIORD Hisicrq cj inc Oanic Scciciq, Annua|
|cpcri, 1956 e IRANCISCO MAZZONI, Ia Sccicia Oanicsca iia|iana c |a jcrnazicnc !c||c sccic-
ia !anicscnc siranicrc, Alli deI I Congresso nazionaIe di sludi danleschi, Iirenze 1962.
14 Si vedano }OHN C. MATHIWS, Tnc inicrcsi in Oanic sncun |q inc 19in-Ccniurq Mcn
cj Iciicrs, Siu!i ancricani, XI, 1965, GLAUCO CAMON, Oanic nc||a |ciicraiura ancricana, ||
Vc|irc, IV 1960, DANTI DILLA TIRZA, Siu!i !anicscni in Ancrica, Rassegna deIIa Iellera-
lura ilaIiana, LXIV, 1960.
Tommaso Iisanli 752
enlrambe Ie direzioni.
A arle Ia ubbIicazione deII'Annua| |cpcri, Ia Oanic Scciciq ha aI-
lres rooslo Ia ubbIicazione di saggi e ricerche (iI saggio di V.
Cioffari suIIa |criuna, iI saggio slesso di SingIelon suIIa Viia Nucta).
Senza dire deI conlribulo fondamenlaIe offerlo daIIa reziosa serie
deIIe Concordanze, da queIIa deI Iay (1888) a queIIa di SheIdon e
While (1905), daIIa concordanza deIIe oere Ialine, a cura di Rand WiI-
Iiams e While (1912) aIIa Ccnccr!ancc ic inc Oitinc Ccnc!q di I. H.
WiIIins e Thomas ergin (1965), in coIIaborazione con Ia Sccicia Oanic-
sca iia|iana, Ia Oanic Scciciq ha romosso I'edizione deI commenlo
inedilo di Guido da Iisa (a cura di V. Cioffari e I. Mazzoni). Una
buona e Iarga messe, insomma, di inizialive. I Ia Oanic Scciciq svoIge
anche allivila di romozione, e geslisce un Oanic Prizc, er lesi di Iau-
rea e ricerche su argomenli danleschi. II danlismo nordamericano e
insomma ervenulo a una sua ienezza di indagini fiIoIogico-criliche
e ha dalo ormai conlribuli riIevanlissimi. Ai nomi indicali vanno ag-
giunli queIIi di CharIes Dismore e di CharIes Grandgenl, aI quaIe si
deve Ia rima edizione americana annolala deI leslo deIIa Ccnnc!ia
(1907-13 e 1932). Kennelh McKenzie ubbIico Ia rima edizione,
commenlala, deIIa Viia Nucta (1922), Herberl Auslin e aulore di un
fillo ccrpus di sludi e inlervenli. A arle aIcune iu disculibiIi conside-
razioni soggellive, si Iegge semre con inleresse iI saggio di George
Sanlayana su Danle fiIosofico. Dino igongiari ha avanzalo roo-
sle iIIuminanli suI leslo deIIa Mcnarcnia. AI di Ia sia di una esegesi
slorico-biografica, sia di ogni frammenlazione di Iellure soIo Iiriciz-
zanli, iI danlismo americano ha svoIlo cos un discorso enelranle di
arofondimenlo e di deIineazione deIIe comonenli e di cuIlura e
sicoIogico-menlaIi deII'ela lardo-medievaIe e deI Ioro imallo
suII'immaginazione danlesca. In laIe direzione hanno indagalo }effer-
son IIelcher, Irancis Iergusson, HeIen Dunbar, }. A. Mazzeo, e aIlri
15
.
I. R. Curlius ha erfino arIalo di una sorla di noslaIgia, er gIi ame-
ricani, di un assalo che essi non hanno avulo. Si e magari anche
lroo accenluala laIe direzione, er cui Thomas ergin
16
ha giusla-
menle invilalo a lener resenle, a non erdere di visla in Danle Ia
forza e iI eso deIIe cnciicns, deI raorlo lra or!cr e iniuiiicna| tiia|iiq,
ordine slrulluraIe.
Ne vanno laciuli, si inlende, gIi infIussi, sesso fondamenlaIi,
esercilali da maeslri euroei di origine, quaIi un Leo Silzer e un
Irich Auerbach, che er vari anni insegnarono in America. Le varie
15 Si uo vedere in aendice aII'edizione americana di |urcpaiscnc Iiicraiur un!
|aiciniscncs Miiic|a|icr, Nev York 1953.
16 THOMAS IRGIN, Oanie, Nev York 1965, . 264.
Oaniisnc in Ancrica 753
comonenli si rilrovano, er cos dire, rifiIlrale e fuse neIIa finissima
rele di risuIlanze cui e ervenulo iI danlismo di CharIes SingIelon,
con Ie sue indagini e considerazioni su ealrice, con Ia rigorosa, fon-
damenlaIe dislinzione lra I'aIIegorismo oelico e I'aIIegorismo
leoIogico (o bibIico): neI rimo, Ia Iellera, iI significalo IelleraIe e jiciic
e cio che iu conla e iI significalo che e solleso a queIIa jiciic, neI se-
condo lio, che e queIIo a cui Danle erviene, si ha invece una erfella
concomilanza di due verila: neI senso che non e vero soIlanlo iI sol-
leso significalo simboIico, ma anche queIIo IelleraIe slesso, che non e
dunque jiciic e vesle esleriore. Cos, neI leslo bibIico Ia resenza degIi
Ibrei in Igillo e vera gia di er se slessa, neI suo significalo slorico-
Iellerario oIlre che simboIico: ed e un laIe lio di verila che Danle,
secondo SingIelon, allribuisce aI suo viaggio
17
. Indicazioni e sunli
sono sesso offerli, come accennalo, anche daI danlismo miIilanle
Iancialo da Izra Iound e da T. S. IIiol
18
. I cos iI Ioro eIogio di aIIego-
rismi e simboIismi si imone come visuaIizzazione, come senso di una
c|jcciitc tisicn e non cerlo come negazione di oesia, aI di Ia di ogni
vaorosila lardo-decadenle. Infine, Iound fece sesso ricorso a
cilazioni e caIchi danleschi neIIa sua roria oesia
19
. II suo rimo
Iibro di oesie, A |unc spcnic, ubbIicalo neI 1908, ha iI suo liloIo da
un verso danlesco (Purg. III, 132). I, a arle Ie aIIusioni ai singoIi
versi e a siluazioni, e cerlo coIIegala aII'infIusso danlesco I'idea di
una IuraIila e moIleIicila di siluazioni, di unli di visla e sceIle
sliIisliche, con I'idea di un mondo da vedere e visilare neIIa sua
frammenlazione: che e I'idea cenlraIe dei Canics. I Canics XIV e XV
lraggono direllamenle sunlo daIIe MaIeboIge. I iI molivo danlesco
deIIa Iuce offre ossibiIila a Iound er Iucide melafore (crqsia| |c!q cj
inc air e Dio snincs/ in inc nin! cj ncatcn). Anche se vi e oi, neI oela
moderno, un senso di roleiforme, arossislica ramificazione risello
aI rigore dei iani danleschi.
Si e anche avverlila, infine, I'esigenza di nuove lraduzioni. I
I'eIemenlo crilico che e revaIso, naluraImenle, con I'allenla conside-
razione dei robIemi secifici deI Iinguaggio. MeIviIIe Anderson
ubbIico, infine, neI 1921, una lraduzione in lerza rima, che ur con Ie
sue difficoIla e forzalure sembro rimuovere I'oslacoIo. I seguiranno,
semre in lerza rima, Ie lraduzioni in InghiIlerra di ickerslelh, di
17 I rinciaIi sludi danleschi di SingIelon sono raccoIli in Ia pccsia !c||a Oitina
Ccnnc!ia, oIogna, II MuIino 1978.
18 Ier IIiol si rimanda aI saggio di MARIO IRAZ, T. S. ||ici c Oanic, Macniatc||i in |n-
gni|icrra c a|iri saggi, Iirenze 1962.
19 Ier uIleriori considerazioni rimando aI mio saggio |zra Pcun! c Oanic, in Oanii-
snc ancricanc c a|iri saggi, cil.
Tommaso Iisanli 754
inyon, di Sayers. NegIi Slali Unili IIelcher ubbIico, neI 1933, una
Oitinc Ccnc!q in lerza rima modificala, cioe con Ia soressione deIIa
rima aIIa fine deI secondo verso, menlre Louis Hov e }ohn Ciardi
scegIievano forme iu moderne e coIIoquiaIi. ergin ha adoeralo iI
||ank tcrsc, iI verso scioIlo, con assaggi in rosa
20
. Numerose Ie ver-
sioni in rosa, e lra quesle sicca queIIa caIibralissima e vivace
insieme, di CharIes SingIelon. In nessuna Iingua, quindi, Danle e lra-
dollo quanlo in ingIese, e Ia maggior arle deIIe iu recenli lraduzioni
e americana.
Unitcrsiia !cg|i Siu!i !i Sa|crnc
20 Tnc Oitinc Ccnc!q, Irincelon Universily Iress 1975.
INDICI DII NOMI
NeII'Indice sono slali regislrali i nomi rori di aulori e di sludiosi, di erso-
naggi slorici, bibIici, miloIogici e Iellerari. Non e slalo inserilo iI nome di Danle,
che ricorre frequenlemenle.
Sono slali indicizzali anche i nomi dei Iuoghi geografici (lerreni e oIlremon-
dani) che sono oggello di allenzione neI corso deIIe !"#$%&'".
Sono indicale con i numeri romani in minuscoIo Ie agine che rinviano aIIa
Irefazione e aIIa Inlroduzione.
Abramo 664, 714
Acciarini, Tideo 691
Acheronle 665
AchiIIe 468-469, 619-620, 674
Adamo 329, 383, 436
Agamennone 620-621, 624,
Agoslino, sanlo 334, 341-343, 347,
349-353, 355, 357, 434, 447, 492,
524, 615, 620
Aiace 623-624, 626-627
AIano di LiIIa 444, 521
AIbero (AIberlo) da Siena 537
AIberlo Magno, sanlo 343, 375,
436, 449, 451-452, 464-465
AIdobrandesco, Omberlo 497, 537
AIdobrandi, Tegghiaio 420
AIessandro di HaIes 435, 451
AIessandro Magno 342
AIexander Nequam (AIessandro
Neckam) 392
AIfonso da Sina 579
AIfonso X di CasligIia 499, 535,
580
AIichino 411
AIighieri, Iacoo (Iacoo di
Danle) 404-405, 740
AIighieri, NicoIo 684
AIlieri, CharIes 613
Aman 495, 513
Amala, regina 495
Ambrogio, sanlo 342, 343, 676,
678-680
Anaslasio II, aa 428, 445
Anchise 509, 546
Anderson, MeIviIIe 753
Andrea II, re ungaro-croalo 708
Andrea Lancia (($$)*+ -+**".$+)
404-405, 407, 409, 457-458, 513,
577
AngeIini, Cesare 641
AnseImo da Carrara 629
Anligone 623-624, 626-627, 632
Anlonio Abale, sanlo 354
AoIIonio, Mario 397
Aracne 623
Arce, }oaquin 562
Ardissino, Irminia 343, 349
ArdoIino, Irancesco 561
Argenlo, Dario 475-476
Argo 570, 700-701
Argonauli 700
Arianna 469
Arioslo, Ludovico 385
ArisloleIe 432, 435-436, 444, 449-
450, 453, 523, 535, 577-578, 610,
614, 616-617, 619, 620, 626-627,
629, 632, 651, 670, 740
ArnoId, Mallhev 555
Arrigo dei Lamberli 497
Arrigo di CornovagIia 486
Arrigo VII di Lussemburgo,
imeralore 403
Asin IaIacios, MigueI 578-580
Assisi 701
/.0)#" 0") .+*) 756
Assuero 513, 524
Alanasio iI Grande, sanlo 342, 354
Alreo 363
Auden, Wyslan Hugh 558
Auerbach, Irich 349, 354, 356,
358-359, 406, 566, 568, 611, 614,
752
Auguslo, Gaio GiuIio Cesare
Ollaviano, imeralore 375,
493, 495, 516, 517, 526
Auslin, Herberl 752
Averroe (Ibn Rushd) 424, 465, 578
Aversano, Mario 489-542, 659-681
Avicenna (Ibn Sin) 577
Axson, Slocklon 552
Azzo VIII d'Isle 478, 486
abvilh, NichoIas 544
accheIIi, Riccardo 409-410
adia Margaril, Anloni 563
affioni, CarmeIa 580
aIbus, }ohannes 372
aranski, Zygmunl 431, 611-612
arelli, Giusee 554
aron LumIey, }ohn 545
arzizza, Gasarino 446
arzizza, Guiniforle 458, 463, 464-
469, 473
asiIio Magno 342
aska (!'1$&' 0)) 705-707
allagIia, SaIvalore 565, 570
ealrice Aragonese 710
ealrice di VegIia dei Irankoan,
conlessa 708, 710
ealrice Iorlinari 319, 321-323,
326, 328, 330, 336, 339, 345, 358,
377, 400-401, 419, 422-423, 425-
426, 429, 432-434, 437-439, 496,
522, 524, 534, 546, 556, 565-566,
664, 689, 694, 707, 709, 736-739,
741-745, 752
eda iI VenerabiIe 342-343
edingfieId, Thomas 550
ekavac asic, Ivan 694
eIIini, Inzo 344
eIlrami, Iielro G. 580
eIlrando daI ornio 663, 739
embo, Iielro 546-547, 691
enedello, sanlo 347, 353-354, 465,
671, 692
enedello XI, aa 516, 696
eniamino, fraleIIo di Giusee
668
enincasa da Lalerina 497
envenulo da ImoIa 364, 373-374,
404, 500, 513, 519, 531, 612, 632,
676
erardo di Casacca, arcivescovo
di IaIermo 643
ergin, Thomas 752, 754
ernard, CharIes Andree 344
ernardo, sanlo 323, 326, 343, 405,
492, 568, 667, 696, 698
ernardo SiIveslre 416, 418
erloIdi da SerravaIIe, Giovanni
dei 544
erlram daI ornio, vd. eIlrando
daI ornio
esson, GiseIe 579
ellini, Maurizio 365
eye, CharIes R. 617
iagi, IIario 364, 367, 375
ignone, Illore 470
igongiari, Dino 752
iIIanovich, Giusee 393
inyon, Laurence 558, 754
Iacalz (ser) 498, 504, 506, 514
occaccio, Giovanni 366, 381, 406,
410, 457, 459, 461, 465, 467,
470-471, 473, 478, 480, 485, 487,
536, 543, 547, 576, 635-636, 691,
693, 701
odin, }ean 717
oezio, Anicio ManIio Severino
/.0)#" 0") .+*) 757
342-343
ohori, Adam 719, 721
oilani, Iielro 547, 628-630, 632
oilo, Arrigo 537
onagiunla Orbicciani da Lucca
317, 440
onavenlura da Siena 412-413,
580
onavenlura, sanlo 343, 435, 451,
455
onifacio VIII, aa 575, 581, 688,
699, 704
oni, Marco 496, 498, 504, 514, 515
ono Giamboni 405, 498
orges, }orge Luis 731-745
orruso, Andrea 577
orso d'Isle 458
orzi, IlaIo 352-353
osco, Umberlo 471-474, 481, 628
olla, Ialrizia 568
olliceIIi, Sandro 403
raccioIini, Ioggio 691
ranca, Villore 393, 457, 686
rossard-Dandre, MicheIIe 579
rovning, Roberl 555
rugnoIi, Giorgio 364-366, 368-
370, 374, 376-377, 379-381, 385-
386, 388-392, 394-395
runello Lalini 393-394, 418, 438,
451-452, 495-497, 502-504, 507,
509-510, 516, 518, 523, 535, 580,
612, 641, 652, 662-663, 667, 681,
685
runo, sanlo 505-506, 509
rulo, Lucio Giunio 373
rulo, Marco Giunio 361
uonconle da MonlefeIlro 499
aI-urq 579
urger, }ozef 723
usa, Roberlo 449
usneIIi, Giovanni 431
uli, Irancesco vd. Irancesco da
uli
Caccia, Illore 686
Cacciaguida 386, 389, 419, 428,
439, 495, 531, 538, 540, 576, 662,
664, 667
Caco 472
CaIamandrei, Iiero 686, 696
CaIcabrina 411
CaIe, Irano 684, 703
CaIenda, Corrado 432
CaIyso 619
Camb, Irancesc 562
Cambon, GIauco 751
Cangrande deIIa ScaIa 318, 324,
326, 357, 361, 363, 368, 370, 395,
525, 611, 740
Canlore, Iielro 674, 677-679
Caaneo 675
Caoni, Guido 748
Cardini, Iranco 405, 575-581
CarIo di VaIois 660, 704
CarIo d'Angio 494, 513, 526, 535
CarIo I d'InghiIlerra 553
CarIo I Roberlo, re croalo 699
CarIo Magno 715-716
CarIo MarleIIo 699
CarIyIe, Thomas 555, 732
Carner, }ose 564
Caronle 433
CarrafieIIo, Anna Rila 669
Cary, Henry Irancis 554-555, 749-
750
Casa di Nazarelh 698-700
CaseIIa, Mario 568
Casini, Tommaso 398
CasleIIani, Arrigo 400
CasleIIano di assano 395
CasleInuovo, Inrico 489
CasleIvelro, Lodovico 398, 404,
406-408
CasligIione, aIdassar 550
/.0)#" 0") .+*) 758
Caslro, Americo 564
Calone I'Ulicense 358, 500, 508
Callaneo, Inrico 341-359
CavaIcanle de' CavaIcanli 438,
442
CavaIIollo, AnloneIIo 691
Cecchini, Inzo 368, 395
CeIakovsky Iranlisek LadisIav
723, 728
CeIeslino V, aa 529
Cenlauri 466-487
Cerbero 372, 379-384, 410, 416-417
Cerbo, Anna 397-414
CeruIIi, Inrico 412-413, 579-580
Cesare, Gaio GiuIio 373, 514, 548,
577, 645
Chaucer, Geoffrey 543-545, 547-
549, 555
ChiaeIIi, Iredi 494
Chiavacci Leonardi, Anna Maria
621, 625
Chioccioni, Iiero 348
Chirone 467-469, 474, 485-486, 674
Ciacco 432, 495-496, 499, 501, 507-
508, 517-518, 530-531, 539, 541,
663, 674
CiamoIo di Navarra 411
Ciardi, }ohn 754
CicaIa, Maria 457-487
Ciccarese, Maria Iia 434
Cicculo, MarceIIo 462
Cicerone, Marco TuIIio 425-426,
444, 447, 449, 503, 510, 512, 515,
523, 623, 635
Cino da Iisloia 524-525, 530
Cioffari, Vincenzo 752
Ciiko, }eroIim 691
CiriIIo GerosoIomilano 483
CiriIIo, sanlo 716
CIaudeI, IauI 739-741
CIemenle AIessandrino 355
CIemenle IV, aa 704
CIemenle V, aa 442
Cocilo 380, 651
Cogan, Marc 431
Coke, Idvard 545
CoIeridge, SamueI TayIor 555
Comarelli, Domenico 402
ConcoIalo IaIermo, Maria 543-559
Conle, Gian iagio 375, 384
Conlini, Gianfranco 361, 363, 364,
366, 368, 390, 395, 611
Co, Mali|a 711-715, 719, 721, 723-
726, 728, 730
-+&'.+ (iI) 577, 579
Corbin, Henry 576
CorneIio Neole 635
Corli, Maria 412-413, 568, 576,
581, 609-610, 624, 630
Corli, RosseIIa 468
Cosla Lima, Luiz 614
CouIianu, Ioan I. 578
CozzoIi, Villorio 315-339
Creonle 624
Creso, AngeI 562, 567, 570-571,
733
CrisoIogo, Iielro, sanlo 679
Crisliani, Marla 346
Croazia 683-691, 693-694, 697-709,
725
CromveII, OIiver 553
Cronia, Arluro 683, 686
Cunizza da Romano 495, 500
Curlius, Irnsl Roberl 752
D'Amico, Marla 584, 586, 595, 605,
607
D'Ancona, AIessandro 577, 693
D'Onofrio, GiuIio 358
D'Ovidio, Irancesco 638
Da Ionle, Lorenzo 748-749
Da|nko, Ieler 721-723
DaImalin, }uri|
DandoIo, Andrea 684
/.0)#" 0") .+*) 759
Daneri, CarIos Argenlino 734
DanieIe, rofela 320
DanieIIo, ernardino 545, 547
Davide 533, 536, 664
Dazzi, ManIio 393
De Andia, YsabeI 344
De Iranceschi, CamiIIo 411
De Lubac, Henri 331, 354, 356, 359
De Sanclis, Irancesco 637-638,
737-738
De Sua, WiIIiam }. 749
Deanovic, Mirko 683, 686, 690, 696
Debenedelli, Sanlorre 364
Deianira 468-469
Deidamia 620
DeIIa Casa, Giovanni, monsignor
550
DeIIa Terza, Danle 751
Democrilo 373
Desideri, Saverio 374
Diascoride 373
Di enedello, ArnaIdo 553
Di enedello, Vincenzo 621
Di Ionzo, CIaudia 577
Di Gerardo, Vincenzo 669
Didone 628
Dionigi I'Areoagila 342, 344-347,
353, 435
Dionisolli, CarIo 692
Dismore, CharIes 752
Dobrovil, abale 705-706
Domenico, sanlo 343
Donali, GuaIdrada 531
Donne, }ohn 545
Du Ionl, AIexandre 577
Dunbar, HeIen 752
Duncan-}ones, Kalherine 546
DunIa, WiIIiam 748
Durando di San Iorciano 450
Icheverria, AbiIio 566-567
Icuba 386
Idio 391, 623, 626-627, 632
Igillo 357, 576, 668, 753
IIellra 373
IIiol, Thomas Slearns 547, 556-
558, 751
Imerson, RaIh W. 751
Imone 623
ImedocIe 469-470, 483
Imireo 352, 536, 667, 696, 698,
701, 737-738
Inea 385, 401, 408, 416-417, 425,
619, 628, 637, 664, 668
Inrico III d'InghiIlerra 644
Inrico VIII 545
Iicuro 421, 427, 618
IracIilo 740
Irbella, Mario 437
IrcoIe 370-373, 376, 382-383, 395,
410, 416-417, 468-469, 472, 624
Irilone 401-402, 416
Irodiade 495
IschiIo 620-621, 624, 626, 630, 632
Isler 495, 513
IucIide 364, 373
Iuriide 609, 624
Iusebio, vescovo di Cesarea 355
IzzeIino III da Romano 486, 500,
642
IaIIani, Giovanni 347-348, 477-
478, 481, 483, 486
Iaranda ViIIa, Giovanna 468
Iarinala degIi Uberli 367, 370-374,
385, 392, 394-395, 417-422, 427-
428, 432, 438, 443-444, 495, 497,
502-503, 507, 509, 534, 612, 663
673-674, 695
Iazio degIi Uberli 579
Iebrer, Andreu 561-563, 566-571
Iederico I, imeralore 693
Iederico II di Svevia 428, 500, 503,
514, 530, 643-648
/.0)#" 0") .+*) 760
Iederico III, imeralore 715
Iedra 386
IeIdges-Henning, Ula 490
Ienzi, Inrico 494
Iergusson, Irancis 752
Ierrario, Irancesca 457
Ierroni, GiuIio 464
IiesoIe 652
IigureIIi, Iernando 460, 470-475
IiIio III, I'Ardilo 499, 535
IiIio Argenli 503-505, 512
IiIire 468
IiIollele 627
IirenzuoIa, AgnoIo 714
IIaxman, }ohn 556
IIegelonle 465, 474, 476, 651, 653,
665, 674, 678-679
IIegias 433
IIelcher, }efferson 752-753
IoIchello da MarsigIia vd. IoIco
da MarsigIia
IoIco da MarsigIia 341, 498
IoIco Iorlinari 737
IoIena, Gianfranco 385, 393, 400
IoIo, cenlauro 467-469, 472, 485
Iorese Donali 440
Iornari, Vilo 637
Iorlini, Iranco 552
IoscoIo, Ugo 555, 640, 657, 749
Ioxe, }ohn 550
Irancesca da Rimini 352, 511, 556,
612, 622, 659, 739-740, 751
Irancesco da uli 363, 399-400,
406, 410, 467, 478
Irancesco d'Assisi, sanlo 343, 347,
457, 531, 576, 581, 692-693, 697
Irancesco Giusee, imeralore
718
Iranciosi, Giovanni 398
Iranges, Ivo 691
Ireccero, }ohn 621, 626, 629, 632
Iriederich, Werner IauI 545, 547,
552, 554, 555, 749
Irugoni, Chiara 489-490, 527, 533,
536, 541
IuciIIa, }osef G. 748
IuIgenzio, Iabio IIanciade 469
IunaioIi, Gino 364
Iursa di Lagny, monaco e sanlo
434
IuseIi, Henry 556
Gaia, Iio 494
Ga|, L|udevil 725
GaIIina, Annamaria 562, 569
GaroIera, Narcis 564
Gasary, AdoIfo 514
Geremia, rofela 433, 506
Geremia di Monlagnone 393
Gerione 416, 472, 526
Gervais of MeIkIey 392
Gesu 421, 431, 472, 483, 527-528
Gello, Giovanni 403, 431, 471
Ghiberli, Lorenzo 526
GhisaIberli, AIessandro 358
Giacobbe 354, 357, 505-506
Giannini, Crescenlino 399
Giardina, Gian CarIo 393
GiIson, Ilienne 344-347, 524
Giollo di ondone 529-530
Giovanni, aosloIo ed evangeIisla
331, 434
Giovanni allisla, sanlo 347, 495
Giovanni Crisoslomo, sanlo 344
Giovanni Damasceno, sanlo 342
Giovanni Diacono 684
Giovanni deI VirgiIio 366
Giovanni di SaIisbury 374, 544
Giove 466, 536
Giuda Maccabeo 505-506, 508-509
Giunone 466
Giusee, figIio di Giacobbe 524
Giusliniano, imeralore 501, 507
G|uranec, Miho 689
/.0)#" 0") .+*) 761
GIavas, Suzana 683-710
Goez, Werner 688-689
Gover, }ohn 543
Grandgenl, CharIes 752
Grassi, Giacinlo 431
GrazioIo de' ambagIioIi 457-458
Greco, AuIo 398
Greene, Roberl 550
Greenslein, }ack M. 490
Gregorio Magno 342, 529-530
GriIIi, Giusee 561-571
Groi, IeIicina 372
Grossalesla, Roberlo 453
Guazzo, Slefano 550
Guerra, Guido 516, 531
Guicciardini, Lodovico 550
Guido CavaIcanli 417-419, 421,
424, 426
Guido da MonlefeIlro 495-496,
499, 502, 508-509, 516, 539
Guido deI Duca 530
Guido di azoches 392
Guido di Monforl 486
Guidollo di oIogna 510
Guizzardo da oIogna 374, 395
Gulierrez, Iernando 569
HaiIy, WiIIiam 554
HaIIam, Roberl 544
Haringlon, }ohn 550
Harvey, GabrieI 550
HaveIy, NichoIas R. 544-545, 547,
551
Hayvard, }ohn 557
Hayvood, Iric G. 544-545
HazIill, WiIIiam 555
Heaney, Seamus 544, 558
HeIm, RudoIf 469
Herbsl, }ohann 550
Herford, CharIes H. 552
HiII, Geoffrey 558
HirlzeI, Irederich Arlhur 367
Hoby, Thomas 550
Humhrey, duca di GIoucesler
545
Iacoo deI Cassero 499
Ibn Arabi 579
Iodamia 466, 468
IoIilo d'Alene 517
IoIilo Romano, 433
IoIilo (Seneca, 23'"0&') 387, 433
Ireneo, sanlo 355
IsabeIIa di GaIizia 385
Isidoro di SivigIia 342-343, 363,
365
}acomuzzi, AngeIo 494
}acoo da Varazze 434
}acoo deIIa Lana 458, 629, 651
}eveI, }ohn 550
}ohnson, SamueI 553-554
}ones, IIizabelh I. 416
}ones, }uIian Ward 416
}onson, en 544
Karmody, Irancis }. 452
Kazolic, Auguslin, arcivescovo di
Zagabria 697, 710
Keals, }ohn 555
Kemers, ram 490
KIingner, Iridericus 367
Koilar, }erne| 714, 725
Lacoonle 481
Lafaye, Georges 367
Lamb, CharIes 555
Lamb, Mary 555
Landino, Crisloforo 398, 458, 462,
546-547
Lanza, Anlonio 406
Lao Gianni 423
Lalini, runello vd. runello
Lalini
/.0)#" 0") .+*) 762
Lallanzio, Iirmiano 343
Laud, arcivescovo 552
Lenlini, Anlonio 354
Leo, Iriedrich 362, 367, 377-378,
390
Leone Magno 342
Leonardo da Vinci 476
Lerolic, Ivan 695-698, 700
Lia 348, 416
Lo Gallo, Illore 686
Lombardo, Iielro 444, 449-451
LongfeIIov, Henry W. 749-750
Lorenzelli, Ambrogio 525-528,
530-537, 539-540, 661, 680
Lucano, Marco Anneo 382, 401-
402, 408, 416, 466, 619, 741
Lucas, Idvard VeraII 555
Lucchini, Irminia 339
Luciano, marlire 483
Lucifero 413, 470, 483, 548, 660-
661, 665-667, 697
Lulero, Marlin 551, 692,
Lydgale, }ohn 543
Macario iI Grande, sanlo 354
MachiaveIIi, NicoIo 547, 753
MacNeice, Louis 558
Magnaghi, AIberlo 466
MaIalesla, IaoIo 531, 556, 739, 751
MaIalo, Inrico 458, 562-563, 568,
601
MaIosli, Sandra 365
Manfredi di Svevia 439, 499, 510
Marcazzan, Mario 403, 406-407,
460
March, Ausias 564, 568
Mardocheo 495, 524
Maria di rabanle 495, 499-500
Mariolli, ScevoIa 384
Marrou, Henri Irenee 341-342
MarleIIolli, Guido 364, 373-374,
458
Marli, Mario 365, 498, 671
Marlin, Roberl 547
MarlineIIi, orloIo 431-456, 459
Marlinez de MerIo, Luis 562, 567
MarloreIIi, Arluro 553
Marucci, Iranco 552
MasIanka-Soro, Maria 609-633
Malleo, evangeIisla 372, 405, 408,
419, 483
Mazzini, Giusee 555
Mazzoni, Irancesco 365, 368, 400,
406, 431, 537, 691, 751-752
Mazzoni, Guido 475
McKenzie, Kennelh 752
Medea 388-389, 394
Medusa 405-407, 416
Meeserman, GiIIes G. 431
MeIIone, Anlonio 345
Mercuri, Roberlo 415-429, 565,
Mercurio 408, 416-417, 664
MeleIko, Iranc 721
MezzadroIi, Giuseina 365
Micevic, KoI|a 725
MicoI 495
MiIlon, }ohn 545, 547, 550-553, 749
Minerva 404, 416
Minosse 380, 433
Minolauro 469, 472-475, 477-478,
481-482
Mira, }oan I. 567-568
MomigIiano, AlliIio 689, 696, 732-
733
Monlaigne, MicheI de 544
Monlanari, Iauslo 431
Mosca dei Lamberli 497
Mose 357, 418
Mumbru, IuIaIia 564
Murko, Mali|a 718, 722
Mussalo, AIberlino 364, 366, 374,
393, 395
NaIdini, Mario 342
/.0)#" 0") .+*) 763
Nardi, runo 364, 431, 441
Nesso 460, 462, 467-469, 473, 476-
478, 485-487, 510
NiccoIo da Iralo 516, 520
NicoIa di Lira 357
NicoIini, Ugo 343
Nino 495
Noe 418
Norlon, CharIes IIiol 750
Novak, Grga 689
NoveIIo, AIessandro 500
Numa IomiIius (IomiIio) 375
Obizzo d'Isle 478, 486
Odorico 385
Orazio Quinlo, IIacco 361, 364,
367, 373-374, 611, 613, 641, 649,
741
Orfeo 373, 388, 740
Origene 357
Orosio, IaoIo 343
Ollavio degIi UbaIdini, cardinaIe
428
Ovidio Nasone, IubIio 384-386,
403, 411, 468-469, 472, 475, 536,
609, 619-620, 622, 741
Iadoan, Giorgio 382, 393, 406,
457, 459, 469, 619, 653, 669
Iadrin, Luigi 374
IagIiaro, Anlonino 400, 426, 431,
566
IamaIoni, Geno 504
IaoIazzi, CarIo 364
IaoIo di Tarso, sanlo 322, 329,
331, 342, 344, 352, 356, 437, 446,
568, 664
Iaralore, Illore 364, 366, 370, 379,
390, 641-642
Iarks, George . 546
Iarodi, Irneslo Giacomo 364-373,
375-381, 384-386, 388-392, 400
Iarricchi, Umberlo 370
Iarsons, Thomas WiIIiam 750
IascoIi, Giovanni 404
IasquaIi, Giorgio 394
Iasquazi, SiIvio 460
Iasquini, ImiIio 365-366, 381, 386,
388, 390, 626
Iaslore Slocchi, ManIio 364, 374,
479, 481
Ialernu, oris 724
Iavese, Cesare 751
IearI, Mallhev 543
Ieire remon Ricas Novas 508
IeIIegrini, IIaminio 406-407
IeIIegrini, Giovan allisla 412,
IeIoe 363
Iein, }ean 357-358
IeraIdo, GugIieImo 447
Ierrig, AIexander 490
Ierseo 416
Ielerson, Roberl 550
Ielrarca, Irancesco 364, 373-374,
393, 458, 543, 547, 568, 636, 643,
689-691, 693, 701, 725, 748
Ielrocchi, Giorgio 367, 393, 398,
400, 404, 462, 466, 477, 492, 517,
562, 566, 583
Ielrov, MihoviI 685
Iellie, George 550
IhiIIis, Slehen 556
IhiIol, Slehen 556
Iia dei ToIomei 499
Iiccarda Donali 352
Iicchio, Riccardo 565, 703-704
Iicchio SimoneIIi, Maria 565, 703-
704
IiccoIomini, Inea SiIvio (aa Iio
II) 717
Iicone, MicheIangeIo 580, 584
Iier da Ia roccia 499-500
Iier Damiano, sanlo 343
Iier deIIa Vigna 495, 499, 503, 520,
/.0)#" 0") .+*) 764
530, 537, 612, 642, 645-646, 663,
674
Iielro, sanlo 671
Iielro di Danle 403-405, 409
IincherIe, Anlonio 347
Iinlo, RaffaeIe 566
Iiriloo 466, 468-469
Iirovano, Donalo 399
IiseIIi, Irancesco 651-658
IIalone 330, 345, 373, 577, 707
IIularco 374
IoIiziano, AngeIo 384
Iorena, Manfredi 400, 493, 519
Iorzio, Domenico 732-733
Iolesla, Gian Luca 434
Iound, Izra 751
Iraz, Mario 547, 558, 563, 753
Iresren, Irance 719-721, 724-726,
728
IrocaccioIi, IaoIo 398, 458
Iroserina 385, 401, 416
Irolo, Inrico 364, 366-369, 372-
373, 376, 378-379, 381-383, 386,
388-389
Rabboni, Renzo 676
RacheIe 348, 416, 709
Raimondo eringhieri 514, 531
RanaIIi, Irancesco 534-535
Remigio de GiroIami 523
ReynoIds, }oshua 554, 556
Riba, CarIes 563
Richard de IournivaI 392
RikIin, AIois 490
Riquer, Marli de 561, 563,
Rissel, }acqueIine 405-406
Rizzardo di San onifacio 500
Rizzi, Marco 434
Roddevig, MarceIIa 693
RodoIfo d'Asburgo 535
Rogers, CharIes 554
RoIIi, IaoIo 553
Roma 702
RomagnoIi, Sergio 406
Romano, Igidio 523
Romeo di ViIIanova 495, 507, 513,
520, 531, 663-664
RomuaIdo, sanlo 354
Ronconi, AIessandro 365, 372, 386,
390-391
Rosadi, Giovanni 431
Rosselli, GabrieIe 403, 555-556
Rossi, Villorio 406-407
Rola, DanieIe 635-650
Rouse, Richard 393
Rubinslein, NicoIai 490
Regg, Augusl 735-736
Ruskin, }ohn 555
Ruslicucci, Iacoo 497, 502, 516,
674
Saccone, CarIo 579, 581
Sagarra, }ose Maria de 561-570
SaIinari, CarIo 406
SaIomone 443, 516, 523, 526
SaIsano, Iernando 501, 660
San4 Hakim 405, 579
Sandford, }ames 550
Sanesi, Roberlo 556
Sanguineli, Iederico 400, 404
Sansone, Giusee I. 561
Sansone, Mario 371
SanlangeIo, SaIvalore 397
Sanlayana, George 752
SanleIIi, TuIIio 431
Saegno, NalaIino 384, 465-467,
470, 472, 474-479, 481, 507, 570,
621, 640, 733
Saa SaIvani 495, 499, 529, 663
Scazzoso, Iielro 344-345, 353
Scarlazzini, Giovanni Andrea 404,
642, 733
SchIegeI, Augusl WiIheIm von
555, 725,
/.0)#" 0") .+*) 765
SchIess, Hovard H. 549
SchuIze-usacker, IIizabelh 508
Sconocchia, Sergio 361-398
Segre, Cesare 498, 535, 581, 609-
610
Semi, Irancesco 411
Seneca, Lucio Anneo 361-395, 610,
619, 628
Seslo Iomeo 401
Semiramide 343
Servio, Mario Onoralo (commen-
lalore) 382
Sessa, Lucio 731-745
Sforza, GaIeazzo Maria 458
Sforza, IoIila 458
Shakeseare, WiIIiam 546, 550
SheIIey, Iercy ysshe 556
SibiIIa Cumana 401, 416
Sidney, IhiIi 546-547, 550
Simone Marlini 517, 526-529, 540
SingIelon, CharIes S. 753
Skeal, WaIler W. 549
SkeIlon, }ohn 543
Skinner, Quenlin 490
Socrale 373, 375, 577
SordeIIo da Goilo 493-509, 512-
517, 519-520, 530-531, 539, 663
Sano, Iielro 535
Silzer, Leo 752
Slarn, RandoIh 490
Slazio, IubIio Iainio 384-385,
390, 403, 408, 441, 447, 452,
468-469, 475, 516, 546, 609, 619-
620, 630, 674-675
Sleiner, CarIo 406-407, 735, 743
Sliisic, }akov 684-685
Surrey, IarI of 543
Svinburne, AIgernon CharIes 555
TanlaIo 363, 389
Tarquino iI Suerbo 373
Taleo, Irancesco 343
Tavoni, Mirko 583-608
Tennyson, AIfred 555
Teodorico 343
Teresa d'AviIa, sanla 322, 335
TerluIIiano, Quinlo Sellimio 343
Teseo 376, 381-383, 410, 416-417,
466, 469, 472
Thomas, WiIIiam 546, 750
Ticknor, George 749
Tiesle 361, 363, 628
Tiresia 546
Tilo, imeralore 516
Toffanin, Giusee 408
Tomasovic, Mirko 689-691
Tommaseo, NiccoIo 384, 687, 689
Tommaso, sanlo 320, 324, 331,
335, 343, 345, 435-436, 449, 451-
452, 455, 465, 492, 523-524, 576,
668
Torraca, Irancesco 389
Torri, AIessandro 405, 458
Toynbee, Iagel 555
Traiano, imeralore 521
Trevel (Trevelh), NicoIa 363, 374,
392
TrioIo, AIfred A. 431
UgoIino deIIa Gherardesca, conle
361-363, 548, 554
Uguccione da Iisa 361, 363, 395
UIisse 400, 431, 446, 495, 502, 511-
512, 566, 612, 618-625, 659, 663,
674, 735-736, 738, 741
VaIIone, AIdo 401, 410, 412, 457-
458
Vasari, Giorgio 526
VasoIi, Cesare 431
Vazzana, Sleno 431
VeIIuleIIo, AIessandro 399, 408,
458, 462, 547
Venluri, Giovanni Anlonio 406-
/.0)#" 0") .+*) 766
407
Vernon, }ohn WiIIiam Varren 457
469
VeseI Koseski, }ovan 725
ViIIani, Giovanni 499, 577
Vincenzo di eauvais 446-447
VirgiIio Marone, IubIio 323, 326,
328, 358, 366-367, 372, 375-377,
379-384, 394, 397-404, 406, 408-
409, 413, 415-416, 418-420, 425-
426, 428-429, 432-433, 435-436,
438-441, 445-449, 459-461, 463,
466, 468-470, 472-473, 475-478,
480-483, 485-486, 493-494, 497,
500-501, 503-504, 506-612, 516,
526, 546-547, 577-578, 609, 620-
622, 628, 637, 641, 652-653, 656,
662, 666, 669-670, 673, 675, 695-
696, 732, 735, 738, 741, 743-744
Visconli, IiIio Maria 458
VilaIe rovarone, AIessandro 434
VilaIe rovarone, Lucella 434
Vili, IaoIo 458
Villorino, Mario 343, 510
Vivanle, AngeIo 687
VoIlaire, seudonimo di Iranois-
Marie Arouel 553
VuIcano 472, 677
Walkins, Levis 543
Whilman, WaIl 751
Wordsvorlh, WiIIiam 555
Wyall, Thomas 543
Yales, Irances A. 554
ab|ek, AIeksandra 711-729
Zaccheroni, Giusee 458
Zamese, Crislina 363-366
Zannoni, Ugo 402, 411
Zennaro, SiIvio 347-348, 477-478,
483, 486
Zeno, sanlo 375
Zoric, Male 684, 689
Zuan, }akob 723
Prodotto dal
IL TORCOLIERE Ofcine Graco-Editoriali dAteneo
UNIVERSIT DEGLI STUDI DI NAPOLI LOrientale
finito di stampare nel mese di Dicembre 2011
Potrebbero piacerti anche
- Brancalonia Quickstart v. 1.5 PDFDocumento44 pagineBrancalonia Quickstart v. 1.5 PDFriccardo mattioli100% (1)
- Breve Storia Della Letteratura ItalianaDocumento158 pagineBreve Storia Della Letteratura ItalianaAnonymous HyP72Jv100% (1)
- I "Versi Militari" Di Umberto SabaDocumento20 pagineI "Versi Militari" Di Umberto SabaAndrea Arioli0% (1)
- Canto Di Ulisse AnalisiDocumento3 pagineCanto Di Ulisse Analisimarvellous100% (2)
- Vergine Madre Paradiso XXXIII 1 57 in LDocumento42 pagineVergine Madre Paradiso XXXIII 1 57 in LCin HamlinNessuna valutazione finora
- Le Goff - La Nascita Del PurgatorioDocumento2 pagineLe Goff - La Nascita Del Purgatoriolu maNessuna valutazione finora
- Chiarini Espres Con Cit Contini PDFDocumento24 pagineChiarini Espres Con Cit Contini PDFAndrea LombardiNessuna valutazione finora
- Gellio Notti AtticheDocumento2 pagineGellio Notti AtticheAdriano TorricelliNessuna valutazione finora
- Dante Alighieri Nella Biblioteca Reale e Immaginaria Di Ippolito NievoDocumento215 pagineDante Alighieri Nella Biblioteca Reale e Immaginaria Di Ippolito NievoAltoviti2000Nessuna valutazione finora
- Dante AziDocumento31 pagineDante AziirismoNessuna valutazione finora
- La Divina Commedia e I CatariDocumento73 pagineLa Divina Commedia e I CatariValerio BiancoNessuna valutazione finora
- Beatrice e Il Numero AmicoDocumento36 pagineBeatrice e Il Numero AmicoEmanuele SabettaNessuna valutazione finora
- Sui Saggi Danteschi Di ContiniDocumento11 pagineSui Saggi Danteschi Di ContiniPino AlessandriNessuna valutazione finora
- Percorsi Critici DanteschiDocumento21 paginePercorsi Critici DanteschiPino AlessandriNessuna valutazione finora
- Dante Nella Nostra VitaDocumento28 pagineDante Nella Nostra Vitagabri2007Nessuna valutazione finora
- Inferno V in Lectura Dantis Bononiensis PDFDocumento16 pagineInferno V in Lectura Dantis Bononiensis PDFGaetano PreviteraNessuna valutazione finora
- Issue Nr. 18: 04. Da Un Dante All'altro. Pier Paolo Pasolini e La "Divina Mimesis" - Gianluigi Simonetti (Università Dell'aquila)Documento19 pagineIssue Nr. 18: 04. Da Un Dante All'altro. Pier Paolo Pasolini e La "Divina Mimesis" - Gianluigi Simonetti (Università Dell'aquila)Parole rubate. Rivista internazionale di studi sulla citazione / Purloined Letters. An International Journal of Quotation StudiesNessuna valutazione finora
- Dante MalinconiaDocumento24 pagineDante MalinconiaManu PapadakiNessuna valutazione finora
- 2017 Primo Levi, Il Doppio LegameDocumento21 pagine2017 Primo Levi, Il Doppio LegameAndrea CortellessaNessuna valutazione finora
- Il Dante Di Montefiore ConcaDocumento33 pagineIl Dante Di Montefiore ConcaCristinaNessuna valutazione finora
- Gabriele Zanella Itinerari Ereticali Patari e CatariDocumento44 pagineGabriele Zanella Itinerari Ereticali Patari e Catarieles515Nessuna valutazione finora
- Il BorgoDocumento2 pagineIl BorgocatiaNessuna valutazione finora
- Analisi Di Una Riscrittura Dantesca La M PDFDocumento130 pagineAnalisi Di Una Riscrittura Dantesca La M PDFdiradosta_1992Nessuna valutazione finora
- Saba - A Mia MoglieDocumento4 pagineSaba - A Mia MoglieeridaniaseleneNessuna valutazione finora
- Aspetti e Funzioni Della Preghiera Nella Divina Commedia (Renzo Guerci)Documento13 pagineAspetti e Funzioni Della Preghiera Nella Divina Commedia (Renzo Guerci)gdimascio3918Nessuna valutazione finora
- Dante Oltre La SperaDocumento20 pagineDante Oltre La SperaAntonio De Crescenzo100% (3)
- Dal Convivio Alla Commedia (Sei Saggi Danteschi) by Bruno NardiDocumento388 pagineDal Convivio Alla Commedia (Sei Saggi Danteschi) by Bruno NardiAlessandro PaulinNessuna valutazione finora
- 978 88 6969 298 7 - tZHpCiJ PDFDocumento265 pagine978 88 6969 298 7 - tZHpCiJ PDFMichele CarrettaNessuna valutazione finora
- "Il Dono Di Natale", Grazia DeleddaDocumento20 pagine"Il Dono Di Natale", Grazia DeleddaEli MoNessuna valutazione finora
- 05 L'officina Di Dante PDFDocumento144 pagine05 L'officina Di Dante PDFKike RamírezNessuna valutazione finora
- 4° LezioneDocumento14 pagine4° LezionesunshineNessuna valutazione finora
- Teologia e Retorica Dell Ineffabilita NeDocumento40 pagineTeologia e Retorica Dell Ineffabilita NeCin HamlinNessuna valutazione finora
- Divinacommedia 1.1Documento152 pagineDivinacommedia 1.1prisscillalves100% (1)
- Psicosintesi LessonsDocumento160 paginePsicosintesi LessonsSectio Aurea100% (1)
- Dante e L'astronomiaDocumento100 pagineDante e L'astronomiaFilomena MontellaNessuna valutazione finora
- ParadisoDocumento72 pagineParadisoLinda MarconiNessuna valutazione finora
- Teologia CataraDocumento3 pagineTeologia CataraMassimo ClausNessuna valutazione finora
- Boccaccio Editore Della Vita NuovaDocumento26 pagineBoccaccio Editore Della Vita NuovaGaetano PreviteraNessuna valutazione finora
- Commento Dantesco Di Benvenuto Da ImolaDocumento873 pagineCommento Dantesco Di Benvenuto Da ImolaLycophronNessuna valutazione finora
- Commento A La Divina Commedia I - Boccaccio (Opere Volgari 10)Documento380 pagineCommento A La Divina Commedia I - Boccaccio (Opere Volgari 10)Bertran2Nessuna valutazione finora
- VIDEO Vari Alessandro BArberoDocumento18 pagineVIDEO Vari Alessandro BArberoDaniela FioraniNessuna valutazione finora
- Dante Esule in RomagnaDocumento29 pagineDante Esule in RomagnaAntonio MontanariNessuna valutazione finora
- Poesia Dante in BorgesDocumento27 paginePoesia Dante in BorgesAnna BoccutiNessuna valutazione finora
- Suicid IDocumento8 pagineSuicid IIvana BaraćNessuna valutazione finora
- Dante Laico e CattolicoDocumento296 pagineDante Laico e CattolicoEnrico GalavottiNessuna valutazione finora
- La Lirica ItalianaDocumento68 pagineLa Lirica ItalianaSaraiNessuna valutazione finora
- C2 Grazia Deledda Leggende SardeDocumento32 pagineC2 Grazia Deledda Leggende SardeАлександра ОреховаNessuna valutazione finora
- Verdi DanteDocumento24 pagineVerdi DanteValerio SebastianiNessuna valutazione finora
- Petrolio AnalisiDocumento16 paginePetrolio AnalisiAntonio SpainNessuna valutazione finora
- Raffi - Dante e Il Liber de CausisDocumento27 pagineRaffi - Dante e Il Liber de CausisfreigunnarsonNessuna valutazione finora
- Giacomo Leopardi e La Poesia CosmicaDocumento75 pagineGiacomo Leopardi e La Poesia CosmicaSettemontiErma1100% (1)
- Baruch Spinoza, Sossio Giametta - Etica (Traduzione Di Sossio Giametta) - Boringhieri (1959)Documento265 pagineBaruch Spinoza, Sossio Giametta - Etica (Traduzione Di Sossio Giametta) - Boringhieri (1959)Augusto DolfoNessuna valutazione finora
- O03 LinguaggioDocumento19 pagineO03 LinguaggioAndrea VolonninoNessuna valutazione finora
- METRICADocumento21 pagineMETRICAAurora BarbettaNessuna valutazione finora
- San SilvanoDocumento86 pagineSan SilvanoEleonora SassuNessuna valutazione finora
- Da Zoroastro Ai CatariDocumento45 pagineDa Zoroastro Ai CataridonpedrodetoledoNessuna valutazione finora
- Vivere Il Presente La Cosa Piu Bella Che LL Vita Ha-Da OffrireDocumento28 pagineVivere Il Presente La Cosa Piu Bella Che LL Vita Ha-Da OffrireKristijan IvankovicNessuna valutazione finora
- De Te Fabula NarraturDocumento3 pagineDe Te Fabula NarraturEsonet.orgNessuna valutazione finora
- Libri BarberoDocumento2 pagineLibri Barberopeterpan1212Nessuna valutazione finora
- CaproniDocumento3 pagineCaproniLetizia FrancoliNessuna valutazione finora
- I Versi livornesi di Giorgio Caproni (sottotitolo Filologia d'autore e critica della varianti)Da EverandI Versi livornesi di Giorgio Caproni (sottotitolo Filologia d'autore e critica della varianti)Nessuna valutazione finora
- Erbe - Manoscritti - Incisioni Libro PDFDocumento218 pagineErbe - Manoscritti - Incisioni Libro PDFAndrea LombardiNessuna valutazione finora
- Maria Corti Su DVEDocumento2 pagineMaria Corti Su DVEAndrea LombardiNessuna valutazione finora
- ARMELLINI CINQUECENTO P 1 A 241 PDFDocumento127 pagineARMELLINI CINQUECENTO P 1 A 241 PDFAndrea LombardiNessuna valutazione finora
- 3 Vivi e Tre MortiDocumento13 pagine3 Vivi e Tre MortiAndrea LombardiNessuna valutazione finora
- Il Neorealismo e Cesare PaveseDocumento8 pagineIl Neorealismo e Cesare PaveseMariachiara ContiNessuna valutazione finora
- Orgoglio e PregiudizioDocumento1 paginaOrgoglio e PregiudiziosofiaNessuna valutazione finora
- Appunti FilologiaDocumento22 pagineAppunti FilologiaEleonora TondoNessuna valutazione finora
- Verificatori de Proiect Atestati RomaniaDocumento200 pagineVerificatori de Proiect Atestati RomaniaAnamaria GiurgiuNessuna valutazione finora
- Ammaniti, Niccolà - FangoDocumento2 pagineAmmaniti, Niccolà - FangoLaura Volpe100% (1)
- Porfirio Vita Di PitagoraDocumento12 paginePorfirio Vita Di PitagoraPiero Mancuso100% (1)
- Storici Greci D'occidente Ricostruzione Della Vita e Delle Opere Attraverso Le Fonti AnticheDocumento5 pagineStorici Greci D'occidente Ricostruzione Della Vita e Delle Opere Attraverso Le Fonti AnticheUnipaApprofondimentiNessuna valutazione finora
- Bibliografia Arberesca 5Documento258 pagineBibliografia Arberesca 5finestravirtualeNessuna valutazione finora
- Magagnin Storie Cinesi Per Linfanzia Globale PDFDocumento16 pagineMagagnin Storie Cinesi Per Linfanzia Globale PDFPaolo CorneglioNessuna valutazione finora
- Ovidio BiografiaDocumento3 pagineOvidio BiografiaBenedetta BonacciNessuna valutazione finora