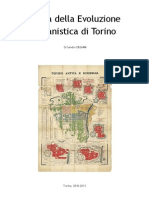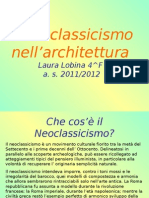Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
248 visualizzazioni3 pagineBarocco Torino
Il documento descrive l'influenza dello stile barocco sull'architettura e l'urbanistica della città di Torino tra il 1500 e il 1700. Vengono menzionati importanti architetti come Guarino Guarini e Filippo Juvarra che realizzarono edifici significativi come il Palazzo Carignano e la Basilica di Superga.
Caricato da
Erica NoTavCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato ODT, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
248 visualizzazioni3 pagineBarocco Torino
Il documento descrive l'influenza dello stile barocco sull'architettura e l'urbanistica della città di Torino tra il 1500 e il 1700. Vengono menzionati importanti architetti come Guarino Guarini e Filippo Juvarra che realizzarono edifici significativi come il Palazzo Carignano e la Basilica di Superga.
Caricato da
Erica NoTavCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato ODT, PDF, TXT o leggi online su Scribd