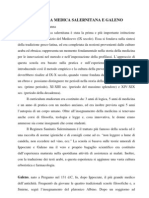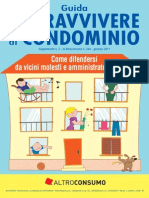Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
GiovanniZanninello Storiadellamedicina
Caricato da
cicleo740 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
790 visualizzazioni179 pagineTitolo originale
GiovanniZanninello-Storiadellamedicina
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
790 visualizzazioni179 pagineGiovanniZanninello Storiadellamedicina
Caricato da
cicleo74Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 179
GIOVANNI ZANNINELLO
STORIA DELLA MEDICINA
. BREVE EPITOME
COL PATROCINIO DELL UNIVERSIT POPOLARE DI CAVARZERE
Edizioni nuova Scintilla Chioggia
PREFAZIONE
E con vero piacere che ci onoriamo di pubblicare questa breve ma intensa epitome, una sintesi
scorrevole e potremmo dire completa, dells storia della medicina, stillata con passione e precisione
dal medico e scrittore cavarzerano Giovanni Zanninello.
Dedito per vari decenni alla professione, in prima linea sul fronte sanitario, sempre apprezzato e
stimato da tutti, Zanninello non ha mai trascurato la sua imtima passione che quella degli studi
classici e filosofici, nonch larte poetica e lamore per la storia.
Tutto questo viene quasi a convergere nellopera che pubblichiamo: lautore, raccogliendo insieme
le numerose lezioni tenute allUniversit Popolare di Cavarzere da oltre un decennio, rivela la sua
propensione per la storia come la sua competenza sanitaria; ma al tempo stesso si dimostra scrittore
attento e scrupoloso, che attinge alle molte conoscenze filosofiche e che non manca di esprimere la
sua costamte attenzione per luomo, indagato non solo nelle sue patologie e nelle differenti terapie,
ma anche nelle sue aspirazioni e nelle sue illusioni.
Lopera che prende le mosse addiritura dalla preistoria e dalla medicina primitiva e si sofferma poi
sulla medicina antica analizzandola per ambiti geografici, da quello greco profondamente segnato
dagli orientamenti della filosofia della natura e poi dal grande Ippocrate a quello romano,
caratterizzato a sua volta dalla grande figura di Galeno. Lautore prosegue poi per epoche temporali
soffermandosi in particolare sulla nedicina medievale, di cui analizza le varie scuole, con speciale
riguardo alla medicina araba ma anche al filosofismo scientifico e agli sviluppi della scienza
universitaria. Lavvincente rassegna spazia quindi sui numerosi personaggi che hanno segnato i
progressi medici nel Rinascimento e poi nel Seicento, caratterizzato dagli sviluppi scientifici che si
approfondiranno ulteriormente nel Settecento secolo che, per converso, prester il fianco anche a
tutta una serie di pratiche pi popolari e discutibili. Della medicina dellOttocento, anche questa
scandita da figure di medici e scienziati di diversa grandezza, vengono messe il rilievo tutte le
nuove conquiste nei vari ambiti, dallanatomia alla chirurgia, dallostetricia alloculistica. Del
Novecento, indfine, si ripercorrono, sempre sinteticamente, le varie tappe di quello che viene
definito ed riconosciuto come un grande progresso della scienza ed arte medica che va sempre
pi specializzandosi e la cui storia dunque richiede trattazioni specifiche per settori, da quello degli
ormoni ed enzimi, a quello della genetica e della procreazione fino alle malattie da stress. Gli ultimi
due capitoli si configurano, per cos dire, come monografie: luna relativa alla lunga e tormentata
storia delle pestilenze nel mondo e in Europa, laltra intorno al complesso arcipelago della medicina
popolare, improntata spesso a pratiche magiche o ad un improprio ricorso al soprannaturale.
Il volume, che si avvale anche di un puntuale indice degli autori (con cognomi e nomi completi) e
di una essenziale nota bibliografica, si conclude con un indice generale un po atipico, che presenta,
quasi in una lunga e dettagliata carellata, tematiche e personaggi con differenti scelte grafiche per
evidenziarne come avviene nel testo, ma superandone la distinzione in paragrafi, - la differente
caratura storica.
Un grazie cordialissimo al dr Zanninello, figura eminente della sanit pubblica cavarzerana, che
-pur gravato egli stesso da precarie condizioni di salute con questopera ha inteso non solo ai suoi
ex alunni e ai suoi estimatori, ma ad una pi vasta cerchia di lettori, il frutto della sua esperienza e
dei suoi studi nellambito professionale, con la passione e la sollecitudine che hanno carattrerizzato
tutta la sua vita di realzione e con il tocco del letterato e del pensatore e talora anche del credente
mai privo di piglio critico e non di rado dedito ad una saggia autoironia.
Il lettore - ci auguriamo potr trovare in questo agile e insieme prezioso volume una sintesi
puntuale e, per quanto possibile, esauriente del percorso seguito dallarte medica nei secoli,
ricavandone - speriamo utili indicazioni per le sue conoscenze e validi orientamenti per una
interpretazione equilibrata del progradire della medicina, peculiare arte scienza al servizio
nelluomo.
Mons. VINCENZO TOSELLO
Direttore di Nuova Scintilla
I
PRESENTAZIONE
Vengo subito - risposi al mio amico Luigi Cavallaro che mi aveva telefonato -: ho pensato di fare
una Universit Popolare. E sono andato a casa sua, nella bella tavernetta.
Dopo due, tre mesi di colloqui ci siamo trovati, una ventina di amici, marted 20 novembre 1990
dalla Notaia per firmare latto di costituzione della societ.
La domenica 27 gennaio 1991 alle ore 10, nella Sala Convegni di Palazzo Piasenti, il Prof.
Giorgio Penzo, ordinario di Storia della Filosofia dellUniversit di Padova, ha tenuto la sua
prolusione sul tema Il pensiero politico di Karl Jaspers: la riunificazione delle due Germanie per
linaugurazione del primo Anno Accademico dellUniversit Popolare di Cavarzere 1990 91.
La prima lezione, quale docente dellUniversit Popolare lho tenuta il venerd pomeriggio del
primo febbraio 91 sul Concetto di salute: alimentazione, stile di vita.
Dal 1991 al 1998 ho tenuto il Corso di Storia della Medicina.
Alla fine mi sono trovato con tutti gli appunti delle lezioni, centinaia di pagine: li ho riletti,
corretti, riordinati, ho aggiornato la bibliografia e ne risultata una breve epitome di storia della
medicina, dalle origini ai nostri giorni. Non un trattato; un semplice compendio di nozioni, distinto
per epoche: dalla medicina primitiva alla medicina delle civilt antiche; dalla filosofia della natura
presocratica alla medicina dei templi. Dalla medicina prerazionale ad Ippocrate, dalla medicina in
Roma a Galeno. La medicina del Medioevo. La scuola Salernitana e le varie scuole. La medicina
degli Arabi, le Universit. La medicina del Rinascimento e il metodo sperimentale di Galileo. Il
concetto microbiologico, la circolazione del sangue, la generazione, la fecondazione. Il pensiero
medico scientifico e la fisiologia sperimentale. La medicina dellOttocento del positivismo e
idealismo: la citologia e listologia, lendocrinologia e la microbiologia, lanestesia, la radiologia e
la chemioterapia. Il grande progresso del Novecento: gli enzimi, le vitamine e gli ormoni, la neuro-
psicologia, la genetica, la medicina psicosomatica e gli antibiotici. E un capitolo sulle Pestilenze:
micro-macroparassitismo. Infine un capitolo sulla Medicina popolare.
Un libro come questo - si pensa - pu interessare pochi lettori, gente di cultura, medici,
farmacisti, biologi, persone di scienza, ma anche - guardandosi intorno - anziani che hanno
conosciuto la malaria, la tubercolosi, la difterite, e le donne che hanno a che fare con lostetricia,
con la ginecologia, la pillola, la menopausa, col tumore della portio e della mammella; e i bambini
con le vitamine e le vaccinazioni. E quelli che combattono col cuore: le valvole,
lelettrocardiogramma, lecografia. E i molti che soffrono dellansia, dello stress e malattie
psichiche; e chi si cura con lomeopatia e con le terapie alternative. Tutti hanno a che fare con la
medicina che ha raggiunto ormai vette eccelse e sempre ne promette di pi alte perch ha dietro di
s la lunga storia del progresso scientifico che ne la base.
Questo libretto, questo breve compendio di storia della medicina, pu essere per pochi, ma la
medicina , certo, per tutti.
LAUTORE
INTRODUZIONE: AGLI ALBORI
1
DALLA PREISTORIA ALLA STORIA
Tentiamo di ripercorrere la storia dellevoluzione della medicina quale una delle molteplici
espressioni del pensiero umano. Seguendo la teoria della evoluzione delluomo, secondo la quale a
partire dai primati (essi stessi anello della evoluzione universale degli esseri viventi) si sono evoluti
gli ominidi, 5.000.000 di anni fa gli Australopiteci, lAfarensis di 4.000.000 di anni fa in Etiopia,
fino allHomo abilis, attorno ai 2.000.000 di anni fa (Paleolitico inferiore), si pu orientativamente
tracciare la cronologia del genere umano nel corso di ere millenarie.
LHomo abilis era capace di fabbricarsi degli utensili scheggiando le pietre e lavorando il
legno. Fu raccoglitore prevalentemente vegetariano, ma anche cacciatore di animali a scopo
alimentare. Circa 1.500.000 di anni fa levoluzione avrebbe prodotto lHomo erectus e lHomo
ergaster. Suoi resti si trovano in Africa, Europa e Asia. Era pi alto e robusto e camminava eretto.
Costruiva utensili per vari usi e con caratteristiche pi sofisticate, aveva scoperto il fuoco che
utilizzava per usi domestici e per difesa (mito di Prometeo). Ad esso appartengono il Pitecantropo
(GiavaCina 700.000 anni fa) e il Sinantropo (Cina 500.000 anni fa), con caratteristiche simili a
quelle dellHomo Sapiens.
Circa 700.000 anni fa sembra che luomo eretto africano, prossimo a diventare Homo sapiens,
per necessit di comunicazione sempre maggiori, abbia sviluppato gli organi anatomici (laringe)
capaci di articolare suoni, era nato il seme del linguaggio. E verosimile che levoluzione degli
organi fonatori, che producono suoni, urli, gridi modulati, parole, sia avvenuto con il progressivo
sviluppo di unarea del cervello di cellule capaci di elaborare lidea, il concetto, (il pensiero)
della cosa che si voleva comunicare, della sensazione che si voleva esprimere.
Nel Paleolitico medio, 90100.000 anni fa, compare lHomo sapiens:contemporaneo allUomo di
Neanderthal, esce dallAfrica, verso lAsia fino in Australia. Grande navigatore, 45.000 anni fa
arriva in Europa. Per le sue migliori capacit intellettuali, in competizione con lotte e rapimenti, in
10.000 anni determina la scomparsa dellUomo di Neanderthal. Coltiva larte, collane, sculture in
avorio per cerimonie e riti che avvengono nelle grotte tra la comunit, conosce la tecnica
dellincastro di vari materiali, pratica la sepoltura dei morti, forse perch crede in un mondo
ultraterreno, in altri Esseri, Entit superiori, buone e cattive, che possono proteggere o nuocere:
nasce il sacro?
Soltanto 35.000 anni fa comparve lHomo sapiens sapiens (luomo di Cro Magnon nella Francia
centro meridionale) diffuso in tutti i continenti, Americhe e Australia. Siamo nel Paleolitico
superiore, ultima tappa dellevoluzione del genere umano verso luomo moderno. Perfezion le
tecniche di caccia, di guerra e del lavoro. Comparvero le prime manifestazioni grafitiche: graffiti,
oggetti scolpiti e pitture (30.000 anni fa) con numerosi esemplari di figure umane e animali (15.000
anni fa), con valore presumibilmente ritualepropiziatorio. Circa 11.000 anni fa compare
lagricoltura e lallevamento degli animali, luomo pratica laratura dei campi, seleziona e coltiva
intenzionalmente certe erbe per la sua alimentazione, usa ceramiche e soggiorna e dorme in
capanne, si riunisce in clan, trib, famiglie prefigurando una primordiale organizzazione sociale,
con una gerarchia con ruoli e gradi. Circa 9000 anni fa (nel Neolitico) sorgono villaggi, le piccole
citt con case di fango e palizzate, luomo fa scorte di cereali. Nell VIIIVII millennio inizia lEra
dei Metalli: delloro, dellargento e del rame. Nel V millennio si pratica la fusione dei metalli ad
alta temperatura. Tra IV e III millennio si realizza la fusione tra rame e stagno ricavandone il
bronzo.
Le grandi citt, Ur, Gerico sorgono nel 3.500 a. C. Presso i Sumeri si trovano i primi documenti
scritti con caratteri cuneiformi incisi sullargilla: nasce la scrittura, prima con testi di carattere
commerciale, elenchi di merci, clienti, poi con testi religiosi, poetici, politici. Le tavolette
sumeriche con caratteri pittografici sono le pi antiche. Siamo nella STORIA.
2
Allinizio del II millennio (18001500 a. C.) i Fenici inventano lalfabeto fonetico che
trasmettono ai greci e a tutti gli altri popoli. Il codice di Hammurabi risale al 19551913 a. C.
Nel 1200 a. C. Mos scrive il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, allepoca dellesodo
degli Ebrei dallEgitto.
Nel VII secolo a C avviene la composizione dei poemi omerici che narrano gli avvenimenti della
guerra di Troia del XVI secolo. Agli inizi del VI secolo a C, circa 500 anni a C, il Regno di Giuda
cade sotto la dominazione del re Nabucodonosor (schiavit di Babilonia per gli Ebrei).
In Italia i primi insediamenti avvengono circa 1.000.000 di anni fa da parte di popolazioni
provenienti dallAfrica settentrionale. Si installarono in Sicilia (Agrigento). Tra il VI e il III
millennio a C comparvero evolute culture neolitiche nelle Puglie e il Val Camonica. Nellet del
bronzo, nella Padania si svilupp la civilt delle palafitte e delle terramare. In Sardegna la cultura
nuragica (IVIII millennio). La civilt etrusca si svilupp tra l XIVIII secolo. Nellarea paludosa
del Tevere, nel VIII secolo, la fondazione di Roma: 753754 (?) a. C.
Verso il 3000 a. C., in Egitto, sorse la civilt del Nilo, lungo 30 dinastie. Fu contemporanea alla
civilt mesopotamica e utilizzava la scrittura geroglifica egiziana. Nel 30002230 circa a. C., (3
4 dinastia) vennero costruite le piramidi. Nel 1300 circa, Ramesse II port guerra agli Ittiti. Nel
1200 a. C. circa avviene lesodo degli Ebrei dallEgitto.
Attorno al II millennio a C inizi un grande flusso migratorio di popoli dalle steppe danubiane e
dal centroRussia di popoli indoeuropei che entrarono in contatto con le civilt semitiche. Giunsero
nella penisola anatolica nel 1819 secolo a. C. Esistono tavolette incise con caratteri cuneiformi
in una lingua non semitica che riferiscono notizie relative al II millennio. Mediante luso di armi in
ferro gli indoeuropei occuparono la Siria tra il 17301300 a. C.
Tra il III e il II millennio a. C. si diffuse la cultura del bronzo indoeuropea nellisola di Creta e
nelle isole dellEgeo dove si espresse con una complessa e articolata architettura (Palazzi di
Cnosso e di Festo). Risale a quellepoca la leggenda di Minosse e del suo mostruoso figlio, il
Minotauro, rinchiuso nel Labirinto. Verso il 1600 a. C. Creta rivolse la sua attenzione alla penisola
della Grecia e del Peloponneso determinando la nascita della civilt Micenea, organizzata in una
miriade di piccoli stati.
Gli Achei e gli Ioni, popolazioni indoeuropee ad economia pastorizia, invasero la penisola greca
quando prevaleva la civilt di Creta: attorno al 16001500 a. C. ebbero grande sviluppo le citt di
Micene, Argo, Pilo, Tirinto, Tebe e Atene con la costruzione di grandi palazzi e tombe
monumentali. Attraverso il fenicio, lebraico aramaico si ha lintroduzione dellalfabeto greco
con i segni indicanti le vocali (740 a. C.). Creta fu sottomessa nel 14001500, e nella stessa epoca
gli Achei si volsero verso lAsia minore (Guerra di Troia). Nel 1200 a. C. cess legemonia
micenea sotto la spinta dei popoli del mare, indoeuropei e dei Dori dai Balcani.
In Grecia, tra il 1200700 si realizz la nascita della religione politeista, e nel corso dellottavo
secolo a. C. i poteri del sovrano miceneo passarono agli aristocratici. Si intensificarono gli
insediamenti urbani e nacque la Cittstato, la Polis. La vita sociale aveva il suo fulcro nella acro-
poli dove risiedeva il tempio della divinit protettrice e lagor, piazza per le riunioni del popolo.
I cittadini partecipavano allamministrazione dello stato.
Nell VIII secolo a. C. inizi il flusso migratorio dalla Grecia alle coste del mediterraneo, Sicilia e
Magna Grecia. Nel VII secolo a C avviene la introduzione della moneta. Dal VII al VI secolo a. C.
si pass dalla aristocrazia al governo dei Tiranni, e quindi alla democrazia.
3
Nelle regioni del basso corso dellIndio si sviluppava nella met del III millennio la civilt
indiana che ebbe contatti con i Sumeri della Mesopotamia. Le informazioni di quella civilt ci
pervengono attraverso i libri sacri Veda scritti in sanscrito che riferiscono fatti relativi al 1500 a.
C. circa. Tra la fine del VI e linizio del V secolo a C posta la nascita di Budda.
Lantica civilt cinese risale al IV millennio a. C. Il primo stato cinese si costitu intorno al 1500
a C. Confucio visse dal 551 al 479 circa a. C. Il Taoismo si svilupp nel III secolo a. C.
Nella valle del Messico circa 7000 anni a. C. si ebbero i primi insediamenti di Nahua (dai quali
deriv la civilt degli Aztechi, Toltechi, Olmechi) che praticavano lagricoltura. Nel 2000 a C tutta
la mesoamerica era popolata. A quellepoca risalgono i pi antichi siti archeologici. Quelle
popolazioni praticavano il cannibalismo rituale e sacrifici umani. La scrittura vi sarebbe comparsa
allinizio del 1000 a. C.
La civilt dei Maya dello Yucatan inizia nel 2000 a. C. e arriva al II secolo d. C. (periodo
preclassico), continua dal 200 al 900 d. C. (periodo classico) e segue nel XVI secolo (nel periodo
postclassico).
Herman Corts giunse in Messico nel 1519 d. C.
I paleoveneti
Gli antichi abitatori del Veneto (Enetoi dellIliade) erano popoli orientali provenienti dalla
Plafagonia (coste del Mar NeroAsia Minore). Si installarono nellentroterra dellalto adriatico
poco dopo la guerra di Troia (tra XIII XII secolo a. C.). Dalloltralpe vi sopraggiunsero i Celti con
i quali in parte si fusero nel VI secolo a. C.
Nel VI secolo a. C. ad Adria, Este e Padova vivevano popolazioni che parlavano una lingua
venetica, attestata da tavolette incise. Tali tavolette avevano carattere votivo, dedicate alle divinit.
La lingua venetica potrebbe essere derivata da una antichissima lingua madre comune,
lindoeuropeo, che diede origine al sanscrito, al greco e al latino.
Adria conobbe la civilt venetica, greca, etrusca, celtica e infine romana.
Nel VI secolo a. C. si ebbe limportazione dellalfabeto dagli etruschi e la nascita dei santuari,
abitualmente costruiti in zone periferiche delle citt, in boschetti, presso fonti. I pi importanti sono
quelli rinvenuti ad Abano, Montegrotto, Padova ed Este. Esistevano anche piccoli santuari, fino a
piccoli capitelli. La divinit pi importante era la dea (?) Reitia (dellAdige?), chiamata anche Pora
perch proteggeva la nascita, la fertilit e il parto, e Sainate (risanatrice) perch preservava e ridava
la salute. Vi si offrivano sacrifici di animali la cui carne era mangiata ritualmente, e libagioni di
vino in recipienti che si rompevano dopo il rito. Alla dea erano offerti ex voto e riti di purificazione.
In un tempio dellepoca romana (50 a. C.) in una stipe votiva si trovarono dei ferri chirurgici a
riprova che i santuari avevano anche carattere medico. Furono trovate anche perle di vetro di chiaro
significato apotropaico (di allontanamento del male). Sempre in epoca romana alla divinit Reitia
subentrarono gli dei greci, Apollo (donatore di salute), Minerva, i Dioscuri e Ercole.
I paleoveneti praticavano lincinerimento dei morti e la successiva inumazione dei resti incombusti;.
ad Adria, nel (IV) III II secolo a. C., il rito dellinumazione con banchetto e libagione funebre.
4
LA MEDICINA PRIMITIVA
Da quando luomo aveva concepito il sacro, lesistenza di Entit del Bene e di Entit del Male,
che a loro arbitrio producevano le avversit naturali, terremoti, eruzioni, tempeste, alluvioni,
fulmini, tuoni, o il piacere del clima, le albe, i tramonti, la benefica sensazione della visione della
natura, era nato anche il desiderio di placare le forze del male e di propiziarsi le forze del bene.
Le forze del male, come producevano a loro arbitrio le avversit naturali, cos dovevano essere loro
stesse a produrre il malessere interno, la malattia, che insorgeva nelluomo senza nessuna forza
esterna: lo agitavano, lo addoloravano, scuotevano e infine lo facevano morire. Era dunque
necessario placarle con sacrifici, con offerte e preghiere. Il pi forte, il pi intelligente, il pi
sapiente della comunit si faceva intermediario tra le entit superiori, le divinit, e gli uomini:
nasceva la figura del Sacerdote e veniva istituzionalizzata la Religione.
Daltra parte luomo primitivo aveva imparato le elementari modalit di lenire il dolore, di
attenuare le sofferenze, con opportuni atteggiamenti del corpo e con utensili, bastoni per
sorreggersi, stecche per immobilizzare le fratture, applicazioni di sostanze calde o fredde. Aveva
anche notato che tutte le cose riproducono se stesse: le piante, le erbe, gli animali, e luomo stesso;
il fuoco genera il fuoco, il suono riproduce se stesso nelleco, la luce nel riflesso. Venne cos
elaborando la Legge di similarit.
E un altro fatto gli era sembrato evidente: una cosa a contatto con unaltra cosa trasmette ad essa
qualcosa di se stessa: una cosa fredda trasmette il freddo allaltra, una cosa calda trasmette il caldo;
cos, forse pensava, il contatto di un maschio con una femmina trasmette la forza di riprodurre il
simile. Luomo primitivo aveva elaborato la Legge del contatto.
Questa conoscenza, luomo primitivo laveva elaborata lui stesso attraverso millenni di
osservazioni, conferme, prove, tentativi: esperienza. Era il primo germoglio dellHomo sapiens, il
frutto dellEmpirismo primitivo.
Luomo primitivo elabora dunque i primordi della conoscenza attraverso due direttrici parallele, la
prima che ritiene che tutte le cose, ed egli stesso, siano a totale dipendenza di Essenze esterne, le
Divinit, buone e cattive, che regolano la natura a loro completo arbitrio. La seconda lo spinge
allosservazione della natura stessa, e a intuire i mutamenti delle cose, il loro evolversi; a stabilire
lesistenza di un prima e un dopo degli eventi, e che il primo genera il secondo, e altri in sequenza:
luomo impara dalla sua esperienza, cerca di dominare la natura. Chiamiamo la prima
linterpretazione religiosa del mondo, la seconda linterpretazione magica del mondo
(protoscientifica). Intendiamo qui per Magia il complesso delle attivit delluomo - di pensiero e di
opere - teso a scoprire, con losservazione, ripetuti tentativi, prove successive, sfruttamento della
casualit, le leggi che governano le cose, cercando di servirsene a proprio vantaggio, senza
chiedere lintervento esterno delle divinit (mago, mag, magusc, magos, magus = grande,
sapiente). In questo senso Magia-Empirismo primitivo possono essere considerati i precursori della
Scienza, contenendone gli elementi essenziali.
Nellinterpretazione religiosa del mondo figura essenziale il Sacerdote, intermediario tra la
Divinit e gli uomini. Nel dualismo antitetico, divinit del bene e divinit del male, compare la
figura del sacerdote delle divinit del male che chiamiamo Stregone (indovino, guaritore). Fin
dallinizio, lesercizio della medicina fu esercitato dalle tre figure, spesso in conflitto tra di loro, ma
talora confluenti nella stessa persona: SacerdoteStregone, Mago.
La Medicina primitiva aveva come oggetto la Malattia, intesa come il male interno di una
persona, che nasceva senza nessuna causa evidente, traumi, ferite, cause atmosferiche. La divinit
5
che per punizione di qualche trasgressione, di qualche peccato, mandava il castigo, mandava il
male, o essa stessa, la deit maligna, prendeva possesso del suo corpo. Bisognava allora riacquistare
la perduta purezza con sacrifici, con offerte, e cos scacciare il male dal corpo malato. Di preghiere,
riti di propiziazione, di offerte, riti di purificazione, di cacciata dei demoni, di rituali di scongiuri,
di sacrifici (anche umani), si trova documentazione nei libri antichi: Veda, Bibbia, Avesta, e tracce
si trovano nellarte primitiva.
Quando da queste concezioni, essenzialmente teurgiche, legate al divino, si rese evidente e pi
distinto il ramo della medicina empirico-magica (protoscientifica)? Certamente non si possono
stabilire n date n epoche sicure attraverso le ere preistoriche in cui luomo tent di dominare la
natura, di pretendere di lenire o sopprimere il dolore, di guarire la malattia o favorirne la
guarigione. Forse se ne pu trovare uneco nel Genesi, quando Adamo, lHomo sapiens,
accogliendo il suggerimento del serpente volle conoscere il Bene e il Male e, scacciato dal
Giardino, fu obbligato al lavoro (non solo raccoglitore), e alla fatica per far produrre la terra. Ebbe il
potere di assoggettare la natura: eritis sicut dii.
DOCUMENTI DELLA MEDICINA PRIMITIVA
Graffiti esterni dellepoca delluomo di Cro Magnon (35.000 anni fa). Grotte e grotte templi
affrescate di circa 14.000 anni fa. Vi sono raffigurazioni di gravidanza, scene di parto, di organi
genitali, rappresentazioni prevalentemente falliche (Rodesia). Una pittura con addome aperto
contenente due gemelli (Isole Caroline). Sculture in osso o pietra calcare con probabile significato
propiziatorio. Il pi importante reperto del genere rappresentato dalle sculture di figure femminili
dalle grasse natiche, le cos dette Veneri steatopigie (100.00080.000 a. C.). Oltre alle natiche
hanno grassi glutei e grasso addome, con particolare evidenza dei genitali. Mancano i lineamenti del
volto e i piedi. Venivano infitte davanti alla casa grotta, con probabile significato propiziatorio.
E documentata lesistenza di alcune malattie. Esistono reperti di ossa consolidate dopo riduzione
e probabile contenzione con stecche (100.00080.000 a. C.), reperti di carie nel Neolitico e di
artrosi con osteofiti in varie ossa (9000 a. C.), di piorrea nel Paleolitico medio, reperti di
trapanazione del cranio (a scopo apotropaico, per farne uscire il demone della malattia?).
Riportiamo i documenti scritti:
Libri di Veda, India (1500 500 a. C.), rivelazione di Brahm.
Tavolette sumeriche (IV millennio a. C.)
Codice di Hammurabi (II millennio a. C.).
Bibbia (1200 a. C.)
Poemi omerici (VII sec. a. C.)
Avesta (1000 a. C.) Lingua iranica indoeuropea, sito incerto. Zaratustra.
Papiro di Ebers Tebe 1500 a. C. Papiro di Smith Tebe 1500 a. C. Papiro di Brugsch 1300 a. C.
LA MEDICINA DELLE CIVILTA ANTICHE
Il pensiero medico delle prime antiche civilt si sviluppa su principi analoghi comuni: teurgico
demoniaci, con elementi proto- empirici e contemporanee pratiche di natura chirurgica.
La medicina ebraica
E tipicamente teurgica: Dio lunica fonte della malattia e della sua guarigione, Ego Dominus
sanator tuus. Unico intermediario il sacerdote, scelto egli stesso da Dio. Lui solo pu intercedere
con offerte di sacrifici e riti lustrali di purificazione. Molte sono le malattie conosciute, elencate
nelle maledizioni, ma le principali sono la lebbra e la peste. A poco a poco si affianc al principio
teurgico il principio empirico, con luso di erbe, piante e medicamenti (esse pure creature di Dio)
6
che possono coadiuvare lopera divina di guarigione (Siracide, 38. 1-15) (200180 a. C.). Ci sopra
tutto nelle malattie chirurgiche, traumatiche; venivano usate unzioni, impiastri, fiele di pesce
I precetti igienici contenuti nella Bibbia sono ispirati al concetto di puro impuro e di peccato,
offesa a Dio che andava punita con malattie o pestilenze e riparata con riti sacrificali. Da ricordare
il sacrificio di Melchisedech e di Abramo. Il sacrificio di Abramo si pu interpretare come
reminiscenza dellepoca in cui luomo abbandon la pratica di sacrifici umani con la sostituzione
di sacrifici di animali. Anche il rito della circoncisione, patto con Dio, pu essere interpretato come
sacrificio di una parte di uomo invece del sacrificio umano.
La medicina assiro-babilonese
E prevalentemente demoniaca: come causa prima e unica di malattia la divinit che, irata per
una qualche colpa o peccato delluomo, ritira il suo patrocinio dallindividuo e permette ai demoni
di aggredirlo, invaderlo, possederlo, e procurargli la malattia. La patologia si manifesta con sintomi
diversi a seconda del demone che prende possesso dellindividuo. I demoni sono in numero di sette.
Compito del sacerdote quello di combattere il demone e di scacciarlo con lesorcismo. Per la
diagnosi il sacerdote si avvale dellinterrogatorio (anamnesi) del malato, alla ricerca di quale
peccato si sia macchiato e di quale demone lo abbia posseduto per poterlo scacciare. Il sacerdote
durante gli esorcismi fa uso anche di piante ed erbe, ma solo come simbolo dellopera divina di
guarigione e non con la coscienza di sfruttarne le virt terapeutiche proprie. Oltre allammalato
venivano interrogati anche gli oggetti della stanza, gli astri e lolio versato nellacqua per trarne
aruspci interpretativi. Per trarne previsioni del futuro era praticata laruspicina del fegato.
Accanto alla medicina demoniaco sacerdotale veniva praticata la chirurgia ad opera di artigiani
regolamentata dal Codice di Hammurabi (19551913 a. C.): punizioni per il chirurgo che provoca
danni nellincisione di un ascesso.
La medicina indiana
Le notizie sono derivate dai quattro libri Veda composti circa nel 1500 a. C. e che costituiscono il
fondamento del Bramanesimo, dei tre dei, la Trimurti: Brahm (dio creatore, anche della medicina)
Visn (dio conservatore), Siva (dio della vita e della morte). Il libro che riporta le notizie della
medicina lAyurveda. La medicina creata da Brahm e la patologia teurgicodemoniaca.
Notevole fu la pratica della chirurgia (piccola e grande chirurgia) eseguita con uno strumentario di
alta perfezione tecnica: erano usati 100 strumenti ottusi e 20 taglienti. Era nota la tecnica delle
medicazioni. Si praticava la litotomia (asportazione dei calcoli) e la rinoplastica (correzione delle
deformazioni del naso). Lesame diagnostico comprendeva la ascoltazione. Si eseguivano esami
diagnostici, come lesame delle urine diabetiche con il gusto.
Lesame anatomico era eseguito sul cadavere macerato in acqua, abraso con strofinazioni di erbe
sacre. Erano presenti concezioni umorali della malattia: proporzione tra vento (pneuma), bile e
flegma. I testi antichi sono studiati ancor oggi.
La medicina cinese
La medicina cinese si sviluppata in ambito chiuso, come la medicina indiana, con pochi
collegamenti con il mondo occidentale allepoca del mitico imperatore ShenNung attorno al 2800
a C. I concetti della medicina cinese sono contenuti negli antichissimi testi (NeiKhing) del III
millennio tuttora consultati. E basata sul concetto filosofico dellArmonia tra le essenze
fondamentali Yiang e Ying, maschile e femminile. La proporzione tra di esse genera la salute, la
sproporzione genera la malattia. Per recuperare larmonia, la medicina si avvale di tecniche
7
strumentali e di osservazioni empiriche. Alla base della semeiotica la tecnica del polso, se ne
descrivono 200 variet esaminati in tre tempi. La farmacologia la pi ricca che si conosca: nel
testo principale di 52 volumi composto nel XVI secolo a. C. sono descritti 2000 medicamenti, dei
quali alcuni sono ancora usati nella nostra farmacologia occidentale: ferro antianemico, arsenico
nelle malattie della pelle, oppio come antielmintico, solfato di sodio come purgante.
Nellinsufflazione di polvere di pustole vaiolose essiccate nelle narici si pu individuare la prima
vaccinazione. La visita medica era praticata su statuette sulle quali il paziente indicava la parte
malata. Come praticche chirurgiche erano note la castrazione e la deformazione dei piedi.
Particolare importanza riveste lagopuntura introdotta nel 2700 a. C. circa, e tuttora praticata anche
nel mondo occidentale. Si basa sullinfissione di aghi doro, argento, ferro, acciaio e pietra nella
cute fino ai tessuti profondi in ben determinate regioni del corpo allo scopo di penetrare nei canali,
in numero di 12 che sono in comunicazione con gli organi interni. In tal modo si ottiene il
riequilibrio, larmonia, tra YangYing turbato dalla malattia.
La medicina iranica
Ha carattere essenzialmente religiosodemoniaco. E desunta dallAvesta, complesso della
letteratura della religione di Zaratustra (Mazdeismo), composto in lingua vedica circa nel 1000 a.
C. La malattia opera del dio del male Arymane, opposto al dio del bene AuraMazda. Di qui la
costante preoccupazione di non contrarre impurit e di sfuggire chi impuro. La schieradei servi del
dio del male diffonde impurit e malattie. La sintomatologia molto vaga e la cura consiste in
sacrifici espiatori e riti lustrali. Vi sono tuttavia cenni del medico che guarisce con le piante e di
quello che guarisce col ferro. In epoche pi tarde nasce una medicina professionale con la misura
del compenso al medico.
La medicina egiziana
Sviluppatasi secondo testi documentali (papiri del 1500) fin dal 3000 a. C., pu essere considerata
la precorritrice della medicina della Grecia. La leggenda di Imhotep ricalca quella di Asclepio,
medicoguaritore divinizzato. Rappresenta il punto di passaggio tra la medicina teurgica e quella
proto empirica; era esercitata da medici che ne svelavano i segreti solo agli interessati.
La concezione biologica si basa sul concetto umorale (sanguigno) e su quello pneumatico (aria
soffio). Conoscevano il polso, cio la pulsazione periferica del sangue che circola partendo dal
cuore. Le conoscenze dellanatomia, nonostante limbalsamazione, erano povere e ingenue. Vi si
trovano invece quadri di sintomatologia combinata, utili per la conclusione diagnostica: dolori allo
stomaco, vomito, occhi stanchi; naso chiuso e sporgenza addominale significa putrefazione degli
escrementi, che, nel linguaggio attuale, potrebbe significare occlusione intestinale con peritonite.
Molto precisa si rivela la terapia che dispone di una poli - farmacia che sfrutta luso di molti
semplici e loro combinazioni: per guarire le granulazioni agli occhi prescritto un rimedio con
colliri, cipolle, verderame (solfatocarbonato di Cu), vetriolo di rame (solfato) e polvere di legno:
un miscuglio per applicarlo sugli occhi. Si conoscono pi di 500 medicamenti in varie confezioni:
colliri, unguenti, polveri, tisane, decotti, macerazioni, pastiglie, boli, elettuari (sciroppi di
medicamenti e miele). Nota era pure la tecnica del clistere. Famosa la bevanda nepente
( ), nota anche ai greci dellepoca della guerra di Troia, che faceva calmare gli affanni e
dimenticare il dolore, (Odissea IV 221).
Altra caratteristica di questa medicina era quella di avere molti specialisti: per gli occhi, per gli
orecchi, la pelle, le malattie urinarie. Anche la chirurgia aveva raggiunto una tecnica assai
progredita: era in grado di diagnosticare la paralisi vescicale e intestinale secondaria a lesioni
traumatiche e a ferite della colonna vertebrale. Praticava la sutura delle ferite, medicazioni,
8
fasciature, escissioni, luso del cauterio e del tagliente, immobilizzazione degli arti; conosceva ben
52 tipi di lesioni traumatiche (vedi Papiro di Smith e Papiro di Ebers).
La medicina del mondo preellenico
Le fonti principali sono i racconti dei poemi omerici, composti nel VII sec. a. C. ma che riflettono
le civilt di Creta (III - II millennio) e di Micene (16001500 a. C.). E un tipo di medicina che si
pu definire teurgicochirurgica.
La medicina, in senso stretto, essenzialmente religiosa: Apollo il dio della salute, il dio che
manda le pestilenze per offese ricevute, e che pu rimuoverle a seguito di preghiere e sacrifici. Al
culto di Apollo segu quello di Asclepio (Esculapio) che si diffuse a vari popoli e regioni e perdur
a lungo. Asclepio fu guaritore, divinizzato, avendo conservato le sue virt taumaturgiche anche
dopo morto. Dalla sua lunga discendenza venivano i sacerdotimedici, privilegiati in casta
esclusiva. Essi esercitavano la medicina in santuari e poi in templi. Altri eroi mitici ebbero culti
propiziatori di salute: Ercole, Melampo, Chirone. Il mitico centauro fu maestro di Achille e di
Esculapio stesso.
Accanto a questo concetto religioso di medicina sono tuttavia riportate nozioni di virt
terapeutiche di erbe e piante. E riconosciuta la virt del citato misterioso nepente, filtro egiziano.
Luso di abluzioni e bagni, e luso del fuoco e dello zolfo nelle purificazioni, ha pi valore rituale
propiziatorio che riconoscimento cosciente del valore curativo delle sostanze adoperate. Notevole
la credenza che siano le mosche a generare i vermi dei cadaveri.
Contemporanea alla medicina religiosa si svilupp notevolmente larte della chirurgia. E desunta
principalmente dallIliade e si tratta prevalentemente di una chirurgia bellica: sono riportati
numerosissimi tipi di ferite (ben 141) e gli opportuni bendaggi e metodi emostatici. Vi
documentazione della fasciatura a spina di pesce (coppa di Sosias: Achille medica Patroclo). La
topografia anatomica degli organi toracici e addominali abbastanza precisa. Erano note le
contrazioni cardiache: dalla vibrazione ritmica del dardo infitto nel cuore.
FILOSOFIA DELLA NATURA PRESOCRATICO -PLATONICA
A partire del VIIVI secolo a. C. ebbe inizio il pensiero filosofico, tappa fondamentale
dellevoluzione del pensiero umano: luomo avvert il bisogno di conoscere quale fosse la sostanza
originaria del mondo, gli elementi che costituiscono la materia, il principio delle cose, larch.
Alla scuola di Mileto, ionica, appartengono Talete, Anassimandro, e Anassimene.
Talete (624548 a. C.) individua nellacqua la sostanza originaria di tutte le cose: presente
ovunque come la vita ovunque presente (ilozoismo).
Anassimandro (570 a. C.) individua nellapeiron (lindefinito) la sostanza che genera tutte le cose
mediante un movimento di separazione, in coppie di contrari: caldofreddo, seccoumido
Anassimene (546528 a. C.) ritiene laria, rarefatta o condensata, la sostanza originaria.
Pitagora (580 a. C.) per primo concepisce lastratto come sostanza originaria di tutte le cose: ritiene
che il Numero sia la forza generatrice di ogni cosa. Il rapporto quantitativo genera larmonia. Gli
oggetti sono misurabili. Scopre i rapporti musicali e il ritmo. Propone la meloterapia.
Nel V secolo a. C. Parmenide ed Eraclito pongono il problema se la sostanza fondamentale esista o
meno, e se lessere sia o no soggetto al divenire.
9
Eraclito (500 a. C.) assume il fuoco come simbolo del perenne movimento e cambiamento delle
cose: panta rei ( ), tutto scorre; EssereNon essere.
Parmenide (prima met del V secolo) di Elea, Lucania, contemporaneo di Socrate, ritiene che la
realt sia lEssere, uno, immobile, immutabile. LEssere lo spazio pieno, il Non essere lo spazio
vuoto. LEssere la substantia delle cose apparenti: ci che sta sotto alla mutabilit delle cose. Il
suo pensiero permea di s tutta la filosofia presocratica.
Anassagora (499-428 a. C.) maestro e amico di Pericle, ritiene che la materia sia formata da
piccolissime particelle che chiama spermata (semi), perfettamente simili alle cose da esse
composte, originariamente in mescolanza caotica, e quindi aggregate dalla Nous, Mente divina.
Aristotele le chiam omeomerie. Tutto in tutto, tutto pu derivare da tutto; nulla si crea, nulla si
distrugge.
Democrito (Abdera 460 a. C.) ritiene che tutte le cose siano formate da piccole particelle di materia
omogenea, di differente forma e grandezza, ma uguali per qualit, che si aggregano e disaggregano
per il continuo movimento di esse nel vuoto secondo le leggi del Caso. Tali particelle sono
indivisibili: atomi.
Empedocle (Agrigento 490430) pensa che la radice di tutte le cose risieda nelle particelle di
quattro sostanze: aria, acqua, terra e fuoco che si aggregano e disaggregano per lazione di due
forze contrarie, Odio e Amore. I contrari si respingono i simili si attraggono.
Platone (Atene 427-347 a. C.), allievo di Socrate (469399), rivolge la sua attenzione non tanto
alle cose fisiche, alla materia ma cerca la verit assoluta: lIdea lessere delluniverso, lIdea la
realt, non solo pensiero astratto. (Dialoghi: Fedro, Fedone, Simposio, Repubblica).
Nel Timeo, tratta della filosofia della natura di cui si erano interessati i presocratici. Sono riferite
le sue conoscenze sullanatomia, sulla fisiologia, i sensi e la patologia. Lanatomia vista in senso
teleologico: ogni organo ha la sua precisa finalit: il corpo sostiene la testa, il polmone rinfresca il
cuore, il cuore domina le parti sensibili(attinge a concezioni di Ippocrate (460377).
La vita consiste in fuoco e spirito (alito, respiro). Il fuoco nel sangue e sceglie gli alimenti per la
digestione, portando nutrimento ovunque. La respirazione un movimento dellaria dallesterno
allinterno e viceversa, che serve a purificare il corpo. Il liquido seminale (sperma) deriva dal
midollo ed spinto dallimperiosit di uscirne. Lutero bramoso di fare figli: se non ne fa genera
fastidi e malattie che errano per il corpo, isterismo. Animaletti invisibili, per desiderio reciproco di
unirsi, vengono seminati nellutero dove crescono e assumono forma umana.
La patologia data dalla trasposizione da un luogo allaltro degli elementi, e da un loro abnorme
rapporto distributivo: laria se non equamente distribuita nel corpo genera disturbi. La pituita,
umore, secrezione acida e salsa, produce malattie catarrali. La pituita bianca mescolata con la
pituita nera genera la lebbra e lerpeteNel Simposio riferito che lambiente naturale influisce
sulla salute delluomo. Nel Lachete riferito che la malattia di un organo comporta disordine in
tutto il corpo: se il tuo occhio malato tutto il corpo malato.
..
Mentre nella Magna Grecia e nellEllade nasceva il pensiero filosofico che raggiungeva vette
eccelse con i grandi filosofi e larte (scultura, pittura, architettura, poesia, lirica, teatro)
raggiungeva perfezioni tuttora insuperate, il pensiero medico nelle sue due direttrici teurgico
religiosa ed empirica non progrediva in proporzione. La medicina teurgico-religiosa manteneva
intatto il principio secondo cui la malattia e la salute sono dono o castigo degli dei, e in tal senso si
sviluppava nei santuari e nei templi. La medicina empirica (sperimentale, protoscientifica)
progrediva di poco. Tra i suoi maggiori esponenti numeriamo Empedocle e soprattutto Alcmeone
che pu essere considerato il precursore della medicina razionale di Ippocrate.
10
La medicina nei Templi
Il culto pi diffuso degli eroideiguaritori fu, come abbiano accennato, quello di Asclepio
(Esculapio). Si svolgeva nei santuari e poi nei templi. I templi, edifici pi o meno fastosi che
sorgevano ovunque, erano costruiti generalmente in prossimit di fonti sorgive in luoghi salubri e
ameni, tra la quiete degli alberi. Il tempio era generalmente dotato di portici, di magazzini per gli
oggetti offerti al dio, e di tavolette votive che narravano la malattia sofferta, in definitiva la storia
clinica del paziente. Era inoltre dotato dei locali per lalloggio dei sacerdotimedici e
laccoglienza dei malati per il pernottamento. Di palestre e soggiorni per i malati cronici e, pi
tardi, anche di locali per le partorienti e i moribondi.
La fonte sorgiva, in prossimit del bosco sacro, serviva per le lustrazioni (bagni) e le libagioni.
Non escluso che, oltre al rito sacro, influissero sulle guarigioni la tranquillit dellambiente e le
propriet terapeutiche delle acque.
Il Dio era posto nellbaton, , in luogo inaccessibile al popolo: solo i sacerdoti erano
intermediari tra il Dio e luomo.
La vita del Tempio aveva unorganizzazione nosocomiale: lammissione (ufficio accettazione), il
periodo preparatorio, durante il quale si facevano le abluzioni, il tempo delle purificazioni,
losservazione astanteria durante la quale si faceva una dieta particolare. Lentrata nel Tempio
aveva un rituale predisposto: vestizione di bianco ed esecuzione dei sacrifici. Alfine, durante il
sonno notturno, presso labaton, aveva luogo la incubatio, il sogno profetico nel quale appariva il
dio per indicare la cura e rivelare la malattia. (Qualche anticlericale, come Aristofane, nella
commedia Pluto, sospettava della buona fede dei sacerdoti, e insinuava di trucchi).
E evidente che con tale pratica assistenziale i sacerdotimedici avevano lopportunit di
osservare il malato, i sintomi della malattia, di abbozzare un primo indirizzo diagnostico, e di
intuirne la patologia. E di preparare e predisporre adeguate misure terapeutiche basate su principi
naturalisticisperimentali, uso di erbe, di sostanze terapeutiche, adombrato dallaura misterica
della presenza della divinit, la quale essa stessa dettava le prescrizioni. Ancora una volta avveniva
la commistione tra lesercizio della medicina religiosa con quella empirico -sperimentale.
I templi pi famosi dellantichit greca sono quelli di Epidauro (380 a. C.), di Coo (375 a. C.) e di
Pergamo (IV secolo a. C.).
La medicina protoscientifica, pre-razionale
I prodromi del pensiero medico biologico, anticipatori della medicina razionale, si registrano in
Sicilia con Empedocle di Agrigento e soprattutto nella Magna Grecia con Alcmeone di Crotone.
Durante i secoli della filosofia della natura avviene gradatamente il passaggio dal Mithos al Logos,
mai tuttavia scomparendo la medicina religiosa.
La scuola siciliana
La figura di Empedocle avvolta in unaura di incertezze biografiche: grande mago, santone,
guaritore, indovino, filosofo dellepoca presocratica. La sua concezione della materia postula che le
cose sono sempre diverse e mutevoli, in quanto la materia, costituita da particelle dei quattro
elementi, acqua, terra, aria e fuoco, si aggrega in ammassi che assumono aspetti diversi, perch si
aggrega secondo proporzioni ponderali diverse. Una cosa quindi si pu trasformare in unaltra:
basta variarne in proporzione i pesi delle particelle. Anche le particelle del corpo esanime
delluomo e degli animali non si distruggono, ma si ricompongono secondo nuove e diverse
proporzioni a formare altre cose, animali, uomini. La materia resta uguale, in continua
trasformazione: una catena di nascita, morte, rinascita (metempsicosi). Delle prime forme umane
cos formatesi sono sopravvissute quelle pi adatte a vincere le avversit dellambiente.
11
Secondo Empedocle la sede del pensiero il sangue, il cui centro il cuore. Il sangue nel suo moto
ondoso centripeto riscalda laria la quale esce dalla bocca dalla quale era entrata (rapporto sangue
aria = respirazione). Laria entra nel corpo anche attraverso dei pori che si trovano nella pelle.
Laria entra nel neonato col primo vagito perch dalla sua bocca fuoriescono le mucosit (umidit):
il vuoto cos viene riempito dallaria. E la Legge dei simili: vuoto \ pieno.
Secondo la Legge dei simili avviene la conoscenza, che, secondo Empedocle, si identifica con la
percezione: con la terra scopriamo la terra, col fuoco scopriamo il fuoco
La nutrizione avviene per putrefazione degli alimenti: il simile attira il simile, ne segue la
formazione di sostanze omogenee che si depositano sulle simili sostanze omogenee.
La generazione avviene per lunione del seme maschile col seme femminile, e la prevalenza di
calidit o di frigidit determina il sesso del nascituro. Nellembrione si sviluppa prima il cuore.
La nutrizione dellembrione e del feto avviene per mezzo dei vasi ombelicali che terminano nel
fegato.
Quando le particelle elementari (simili alle omeomerie di Anassagora) si disgregano, avviene la
morte: lelemento igneo, il fuoco, si ritira completamente dal corpo, provocando il raffreddamento
mortale. Un raffreddamento modesto provoca il sonno.
Empedocle citato anche per le opere di bonifica, di igiene del suolo: liber Selinunte dai miasmi
e dalla pestilenza facendo confluire nel fiume inquinato le acque di altri due fiumi.
La scuola di Crotone
Alcmeone di Crotone, nella Magna Grecia, vissuto tra il 550 e 450 a. C., pu essere considerato
liniziatore del metodo sperimentale in medicina e in generale il precursore in anatomia, patologia,
psicologia, liniziatore dello studio della biologia, lanticipatore della Medicina razionale di
Ippocrate. Riporta unamplissima dossografia di svariati argomenti trattati , peri
fiseos, intorno alla natura.
I principi fondamentali costitutivi del corpo sono detti qualit o potenze disposte in coppie di
contrari, dinami, secondo equivalenze di proporzioni: una tale armonia di contrari detta
isonomia.
Alcmeone fu il primo a praticare la dissezione dei cadaveri allo scopo preciso di conoscere
lanatomia delluomo. Afferm per primo che luomo si differenzia dagli animali perch ha
lintelligenza: luomo capisce, gli animali percepiscono. Distingue quindi tra conoscenza e
percezione. Suo principale merito quello di aver intuito che il cervello la sede del sensorio
comune: il cervello legemone di tutto lorganismo del corpo animale. Le percezioni, dagli organi
periferici di senso, giungono al cervello dove saccordano: vi giungono per mezzo di proi
( ), sentieri di nervi si direbbe oggi.
La procreazione avviene ad opera del seme che proviene dal cervello. La sterilit dovuta alla
frigidit del seme (fattore maschile), alla chiusura dei genitali (fattore femminile). Il sesso del
nascituro determinato dalla prevalenza del seme di uno dei genitori. Nellembrione la parte che si
forma per prima la testa perch in essa la sede principale dellanima. Il feto si nutre nellutero
attraverso tutto il suo corpo che assorbe come una spugna il nutrimento.
Importanti sono le nozioni di fisiologia e anatomia degli organi di senso, secondo quanto la
dossografia attribuisce ad Alcmeone, ma forse patrimonio di altri medici filosofi posteriori,
Callistene (scolaro di Aristotele) ed Erofilo (IVIII sec. a. C.). La vista avviene per mezzo di due
sentieri (proi), nervi, che partono dal cervello, sede percettiva dellanima e giungono alle cavit
degli occhi dapprima appaiati, poi, ad un bivio, si dividono verso le orbite. Gli occhi sono formati
da quattro membrane che raccolgono lumidit naturale. La luce passa attraverso i viottoli che
servono anche a regolare il movimento consensuale degli occhi. Ludito avviene per mezzo delle
orecchie perch contengono una cavit che risuona e trasmette cos il suono al cervello. Gli odori
vengono percepiti perch con laspirazione vengono portati al cervello. Cos i sapori, liquefatti dalla
lingua, vengono trasmessi al cervello.
12
Il sonno avviene per il ritirarsi del sangue nei vasi sanguigni, il risveglio per il suo espandersi.
Nella morte vi il ritiro completo del sangue nei vasi sanguigni.
Il concetto di salute e di malattia conseguente alla legge dellisonomia: si ha salute quando esiste
equivalenza, armonia, tra le coppie dei contrari (dinami), mentre invece si genera malattia quando
avviene il sopravvento di una potenza sullaltra o di una coppia sullaltra, creando cos eccesso,
sproporzione, di uno dei dinami. Labbondanza o il difetto di nutrimento genera squilibrio, quindi
malattia.
La scuola di Cnido
Merita un breve cenno. A Cnido, citt nella penisola dellEgeo di fronte a Coo, sorgeva un celebre
tempio di Afrodite con relativo culto, attorno al quale si svilupp una celebre scuola di medicina.
Era particolarmente trattata la anatomia, di cui per non restano che scarse tracce della vera
conoscenza raggiunta. Erano trattate pure la ostetricia e la ginecologia: la patologia tuttavia aveva
carattere essenzialmente sintomatico e le conoscenze erano rudimentali.
Importante larchivio delle tavolette che riportavano le malattie e le relative guarigioni.
In terapia erano usati scarsi medicinali: succhi di poche piante, euforbio, elleboro e coloquintide,
inoltre latte di donna e di asina.
Appartengono a questa scuola Ctesia, medico di Artaserse, ricordato per le Massime di Cnido e
Crisippo che praticava il salasso e luso di purganti. Contemporaneo di Eudosio (400362),
Eurifone, allievo di Alcmeone, conosceva il prolasso uterino e lo curava.
Da Cnido pass a Crotone, dovera nato, Democede (nato 570-565 ?) medico periodeuta: nel suo
peregrinare fu invitato a fermarsi ad Egina per un anno con lo stipendio di un talento. Cur Dario
per una distorsione dellastragalo mediante medicamenti lenitivi e appropriate manovre mentre
avevano fallito i migliori specialisti egiziani. Cur e guar pure Atossa, sua moglie, di una mastite.
Specie nel VI secolo, sia in Grecia che nella Magna Grecia, fu molto praticata la GINNASTICA.
Era intesa e praticata come esercizio per la conservazione dellarmonia costituzionale, fondamento
di salute dellorganismo. Si trattava di esercizi di atletica leggera, quasi danze, al suono del flauto,
nei Ginnasi, di giovinetti e giovinette in casta nudit (gymnos, = nudo).
Nelle palestre, invece, si esercitavano gli atleti. Prima degli esercizi si praticava la frizione del
corpo con oli aromatici, al termine, la strigliatura e il bagno. La vita era regolata dal ginnasiarca,
che praticava anche lattivit di medico sportivo eseguendo piccoli interventi di chirurgia degli
infortuni degli atleti e ginnasti, e regolava la dieta frugale e controllata, assunta senza avidit.
La scuola di Coo
Rivale della scuola di Cnido fu la scuola di Coo, la maggior isola dellEgeo dopo Rodi. Fu antica
sede del culto di Asclepio esercitato nei templi dove si praticava la medicina ad impronta
prevalentemente teurgica da parte di medici asclepiadi, appartenenti cio alla casta famigliare dei
discendenti di Asclepio, chirurgo della guerra di Troia divinizzato.
Questi medici-sacerdoti si tramandavano, secondo la legge del tempio, linsegnamento e
lesercizio della medicina di padre in figlio, mantenendo rigorosamente il segreto della loro arte.
Durante lo sviluppo e lesercizio di questa medicina si andava parallelamente elaborando ed
arricchendo una conoscenza empirica dei medicisacerdoti che avevano la opportunit di osservare
i casi clinici, di catalogarne i sintomi e di operare la guarigione, oltre che per lopera della divinit,
con lausilio di medicamenti la cui efficacia andavano provando con diuturna esperienza.
Ma si introducevano anche pratiche dintervento, specialmente su malattie traumatiche, che
nascevano ed erano praticate fuori dal tempio, e da persone non autorizzate, estranee alla casta degli
asclepiadi.
13
Nellisola di Coo nacque, probabilmente nel 460 a. C., IPPOCRATE. Diretto discendente dalla
casta degli asclepiadi, impar comera suo diritto larte medica da suo padre. Ma fu anche allievo di
Gorgia e di Democrito (460 a. C.) e conoscitore della filosofia della natura. Conobbe certamente le
idee di Eraclito (500 a. C.) e soprattutto di Empedocle (490 a. C.).
Famoso e tuttora riconosciuto come regola etica dei medici il suo GIURAMENTO. Questo testo
fu sempre ritenuto come regola morale del medico, ma, se inquadrato nel contesto storico in cui fu
scritto e nellambiente in cui si esercitava la medicina regolata dalla legge del tempio, pu assumere
un nuovo e diverso significato. Il testo pu essere interpretato come un atto di adozione da parte
dei figli del padre medicosacerdote mediante il quale il neofita laico diventava fratello e quindi
titolare degli stessi diritti dei figli naturali, compreso quello di imparare la medicina e di esercitarla
a patto di osservare certe regole. Prima tra tutte lobbligo di mantenere il segreto dellarte, di trattare
come famigliari i suoi adottanti e di esercitare la medicina col massimo rispetto per la vita, fin dal
suo nascere (proibizione dellaborto), e al suo termine (proibizione delleutanasia), e di non
produrre sterilit (proibizione di operare sulla vescica per non ledere i deferenti).
Il giuramento, quindi, pu essere interpretato come una formula sacrale di iniziazione, il
corrispondente di unordinazione sacerdotale, che con atto scritto, singraf , assumeva
valore di legge. Cos anche il laico, non appartenente alla casta sacerdotale, poteva esercitare la
medicina.
La medicina diventa patrimonio del popolo (demos, ), diventa demotica.
La medicina razionale di Ippocrate
La medicina uscita dai Templi, permeata dalle idee della filosofia della natura che ricercava
lArch, il principio delle cose e la sostanza dellEssere e del suo evolvere, prescindendo
dallazione diretta della Divinit, si orientava anchessa alla ricerca del principio della malattia, allo
studio dellevoluzione dei sintomi, della loro spiegazione. Cercava la causa della malattia, della
vita e della morte stessa. Non si accontentava pi della semplice rilevazione, osservazione e
constatazione dei fatti (empirismo), ma, pur partendo da essi, procedeva con metodo filosofico,
dialettico, razionale, alla loro interpretazione.
Per fare ci, per, partiva da un modello razionale precostituito, secondo principi assiomatici,
indimostrabili. In questo senso chiamiamo razionale la medicina di Ippocrate come lui stesso lha
definita. Gi Alcmeone aveva anticipato questa strada trattando peri fyseos: della natura. Pi tardi
Aristotele offrir il logos come il pi perfezionato strumento di ragionamento.
La medicina razionale di Ippocrate desunta dal CORPUS HIPPOCRATICUM, collezione dello
scibile medico ippocratico effettuata nel III sec. a. C. dalla Biblioteca Alessandrina.
Non tutti i libri che vi appartengono sono da attribuirsi ad Ippocrate che sarebbe lautore certo solo
dei libri Delle fratture, Della riduzione delle lussazioni, Della dieta, Della prognosi, degli Aforismi,
Delle ferite e delle ulcere, Delle emorroidi, Delle fistole, Delle ferite del capo, Delle epidemie,
Delle arie, delle acque e dei luoghi.
Altre opere appartengono genericamente alla Scuola di Coo: Degli umori, DellAnatomia, Del
parto, Del parto in sette mesi, Del parto in otto mesi, Dei giorni critici, Della dentizione. Altri libri
del Corpus, specie quelli di argomento ginecologico, appartengono alla Scuola di Cnido. Il famoso
libro sul morbo sacro (epilessia) sarebbe di tarda compilazione, di scuola sofistica.
I principi della medicina ippocratica
Idea guida del pensiero medico ippocratico che la salute sia la risultante dellequilibrio degli
umori dellorganismo, della loro proporzione armonica Eucrasia. La malattia invece dipende dalla
14
corruzione degli umori che, a sua volta, dipende dal predominio di un umore sugli altri
Discrasia.Per riottenere la salute necessario espellere lumore corrotto: con ci si ottiene la
risoluzione della malattia: la crisi, che avviene allacme di essa. Se la crisi non si manifesta o non
c errore nel tempo di somministrazione dei medicamenti, la malattia diventa cronica.
Gli umori del corpo umano sono quattro: SANGUE caldo-umido proveniente dal CUORE
FLEGMA freddo-umido CERVELLO
. BILE GIALLA caldo-secco FEGATO
BILE NERA freddo-secco MILZA
(atrabile)
Gli umori ippocratici conservano le stesse qualit caratteristiche degli elementi di Empedocle per
cui si ha il seguente passaggio: ARIA (calda -umida = Sangue
FUOCO (caldosecco) = Bile gialla
ACQUA (freddaumida) = Flegma
TERRA (freddasecca) = Atrabile
Oltre alladerenza ai principi filosofici di Empedocle si noti la aderenza al principio di Alcmeone
della isonomia dei dinami di contrari.
Lalterato equilibrio degli umori, la malattia, tende per le stesse forze della Natura alla cozione,
alla cottura, dellumore prevalente che viene espulso in forza della vis medicatrix Naturae. Se tale
forza della natura non sufficiente interviene la morte. Sono considerati umori esorbitanti, e quindi
da espellere, le urine, il pus, lespettorato, le feci diarroiche.
Non sempre sono ben desumibili dalle sue opere le cause dellalterazione degli umori: ora si parla
di intemperie in senso indefinito, ora di dieta, ora di miasmi, ora di cause ambientali, specie per
quanto riguarda le epidemie. E comunque interessante il legame che si pu stabilire tra malattia,
individuale o collettiva, e ambiente (arie, luoghi, acque).
Compare inoltre un nuovo concetto di malattia, non pi considerata episodio isolato, sintomatico,
di un organo, ma come espressione di un disordine che interessa lintero organismo. (Gi abbiamo
visto questo concetto espresso intuitivamente nel Lachete di Platone e nel Filottete di Sofocle).
Altro concetto innovativo quello di costituzione psicofisica individuale, di temperamento. Se in
un determinato individuo uno dei quattro umori prevale sugli altri, il fatto determina una certa
predisposizione a determinati comportamenti con particolari caratteristiche, tali da definirne il
temperamento. I temperamenti sono quattro: il sanguigno, il biliare, il flemmatico e latrabiliare
(melanconico), che ancora resistono nel nostro vocabolario.
Accanto alla teoria degli umori coesisteva il concetto pneumatico della costituzione organica: il
pneuma, aria vitale cotta dal calore centrale del cuore, contribuisce a regolare la costituzione, il
temperamento.
Molte sono le malattie note alla medicina ippocratica: la polmonite, la pleurite, le riniti, le laringiti;
lileo (occlusione intestinale), la diarrea (colera nostrano). Delle malattie nervose era noto il delirio,
le allucinazioni, e lepilessia; inoltre il tetano e la paraplegia (paralisi).
Di fondamentale importanza per lo studio delle malattie il fatto che viene elaborato un preciso
Metodo di ricerca: viene definito uno strumento dindagine concettuale, razionale, collegato a
strumenti dindagine concreti e definiti, empirici. Il malato un libro aperto da leggersi con metodo
e da trattarsi con rispetto e amore. Nasce la clinica medica.
Il malato viene sottoposto a minuzioso interrogatorio circa i suoi disturbi, (lanamnesi); quindi
scrupolosamente visitato per rilevarne i sintomi, mediante lispezione per notare il colore della cute,
le contrazioni muscolari, il sudore, il tipo di escrezioni e secrezioni. Mediante lascoltazione si
scoprono rumori, sfregamenti, borborigmi; con la palpazione si notano deformazioni, si svelano
punti dolorosi. Ed infine la percussione per rilevare particolari suoni dei tessuti (la succussione
ippocratica).
15
I sintomi erano catalogati in lunghi elenchi derivati dalla lunga esperienza dei medici sacerdoti
della Scuola di Cnido e di Coo: Tavole cnidiche e Prenozioni coiche.
Acquisiti tutti gli elementi di conoscenza, mediante gli strumenti dindagine codificati, si doveva
formulare un giudizio sullo stato di salute, (diagnosi), e sullevoluzione della malattia, (prognosi).
La metodologia clinica prevedeva anche lesame delle urine (quantit, colore, sapore, sedimento,
nubecole). Tutto il complesso delle operazioni cliniche, semeiotiche, si compendiava nel
Prognostico, conclusione delliter che permetteva di divinare il futuro dellevolversi della
malattia. Ma ci solo come indicazione di probabilit, non di certezza assoluta: il miglior medico
quello che sa pre-vedere. Importanti e utilmente valutabili ancor oggi sono i segni letali: facies
hippocratica, (agonica premortale), sudore freddo, pallore e raffreddamento delle estremit, cianosi
diffusa e delle unghie, stato di agitazione.
Particolare menzione merita lopera ippocratica degli Aforismi: citiamo il primo che contiene
tutti i germi essenziali della medicina razionale. Esso recita:
Ars longa = Larte lunga, vasta, estesa.
Vita brevis = La vita breve.
Occasio praeceps = Il momento opportuno fuggevole, repentino.
Experimentum fallax = Lesperienza fallace, ingannevole.
Iudicium difficile = Il giudizio difficile.
Altri aforismi celebri: Primum non nocere deinde evacuare = Primo non nuocere, poi purgare.
Le forze naturali sono i veri medici delle malattie
Lopera una sintesi efficace che la medicina deve sempre seguire, nella forma un insieme di
frasi staccate di vari passi.
Riferiamo ora alcune nozioni fisioanatomiche della scuola di Coo e della scuola ippocratica.
Del cuore si conosceva solo approssimativamente la conformazione interna e non lesatto
funzionamento. Era noto il pericardio e il suo liquido. I nervi erano confusi con i tendini e
legamenti. Il cervello , per la maggioranza dei medici ippocratici, la sede dellintelletto, ma il suo
compito quello di attirare lumidit da tutto lorganismo. E considerato la ghiandola pi grande
del corpo, ripiena di liquido freddo. Raccoglie il liquido seminale che poi discende nei testicoli. E
diviso in due emisferi, separato dalla falce interemisferica e coperto dalle meningi. E noto il
midollo spinale con lo stesso nome attuale. Sono conosciuti i seguenti nervi: trigemino, acustico,
intercostali, sciatico, brachiale, ulnare e il vago. Degli organi di senso il meglio conosciuto
locchio (secondo le informazioni di Alcmeone), collegato col nervo ottico fornito di tre tuniche,
con la cornea e la pupilla. Le sensazioni visive vanno al cervello. Dei muscoli sono conosciuti i
muscoli dorsali, intercostali, il deltoide e il pettorale. Del cranio i muscoli temporali e i masseteri.
Le vene sono confuse con le arterie, e derivano dalla cava e dallaorta in modo indistinto.
Le vertebre sono 18 o 22, le costole sono sette. E noto losso sacro ( = os sacrum).
Lapparato digerente di due cavit: stomaco e intestino. Parti dellintestino sono il colon (con lo
stesso nome attuale), il digiuno e il retto. I polmoni sono divisi in cinque lobi: contengono i bronchi
e la trachea (detta arteria). E nota lepiglottide.
Le opere ippocratiche parlano con cura della chirurgia ,della quale riferiscono vasto strumentario e
sicurezza di tecniche. Da Ippocrate stesso fu inventato il banco per la riduzione delle fratture. Era
noto il trapano, si usavano coltelli, bisturi di varie forme: convessi, concavi, ricurvi, acuminati,
smussi. Particolare interesse era dedicato alle fasciature, alcune delle quali inventate e praticate
dallo stesso Ippocrate, come quella del capo. Le lussazioni erano ridotte per mezzo di macchine
complicate, e cos le fratture venivano contenute mediante stecche e fasciature. La trapanazione del
cranio era eseguita quale intervento nelle fratture di quelle ossa. Secondo tecniche descritte in modo
chiaro e preciso.
16
Gli interventi di ginecologia e ostetricia erano limitati: si usava lo speculum vaginale e anale,
sonde e pessari. E dilatatori di vario calibro. Proibito laborto provocato. Si praticavano irrigazioni
vaginali. La sterilit era trattata con fumigazioni vaginali e infusione di latte di donna. La
generazione avviene per la commistione del seme maschile con quello femminile. Lutero diviso
in due parti, destra e sinistra: nella parte destra confluisce il seme del testicolo destro e genera
maschi, nella sinistra confluisce il seme del testicolo sinistro e genera femmine.
La terapia mediante medicamenti veniva usata con oculata parsimonia: primum non nocere. Erano
per usati molti semplici: elleboro nero, coloquintide, veratro bianco, oppio, giusquiamo,
mandragora, belladonna, scilla, ruta, menta e coriandroPochi i minerali: sali di rame, allume,
piomboI medicamenti erano classificati in gruppi: purganti, narcotici, diuretici
Si usavano le ventose, semplici o scarificate, nelle infiammazioni. Inoltre, inalazioni e lavaggi
delle piaghe, delle ferite e delle cavit naturali.
Ingegnoso il metodo per tamponare una ferita toracica profonda sanguinante: si introduceva una
vescica nella cavit e poi la si gonfiava, realizzando cos un utile tamponamento.
La terapia ippocratica si basava sul principio dellevoluzione naturale della malattia e sulle forze
medicatrici della natura. Il suo compito, quindi, era quello di facilitare il buon decorso, favorirlo e
stimolare, se possibile, le forze individuali. Nelluso dei medicamenti si ispirava, di volta in volta,
allassioma similia similibus curantur o allassioma contraria contrariis curantur. Cos, per
esempio, il veratro d vomito, diarrea, raffreddamento; similmente il colera nostrano d vomito,
diarrea e raffreddamento, ergo, il veratro cura il colera. Ugualmente, abbondanza contrario di
sottrazione, pletora contrario di evacuazione, e cos si user il salasso (evacuazione) nella pletora:
suo contrario. Notevole il concetto che la febbre pu essere utile nella guarigione delle malattie: con
il calore accelera la cozione degli umori corrotti.
Trattiamo ora della dieta. Col termine diaita , modo di vivere, tenore di vita, si
intendeva non solo la regolamentazione delluso degli alimenti, ma comprendeva anche il
complessivo comportamento dellindividuo, sia sano che malato. Nel malato, la dieta, la
regolamentazione dellintroduzione del cibo, aveva il compito di favorire i naturali mezzi di difesa
con lutilizzo delle forze naturali, le quali, durante la malattia venivano impegnate a cuocere gli
umori peccanti. Nelle malattie era prescritta una dieta leggera: semplici bibite umettanti e
blandamente nutrienti, come la celebre tisana, decotto di orzo macinato di scarso valore calorico.
Oltre alla tisana un ruolo importante era assegnato allidromele (fermentato di miele in acqua).
La dieta, nellambito della concezione globale dellindividuo, sia malato che sano e in tutte le sue
espressioni, era importante anche nel contenere, mitigare o stimolare i temperamenti individuali.
Una menzione merita lidroterapia da sempre praticata nella medicina del templi e tenuta in
considerazione anche nella medicina ippocratica.
La scuola dogmatica
Il pensiero medico, influenzato dalla filosofia della natura, si era espresso nella medicina pre
razionale, proto scientifica di Almeone e di Empedocle che poneva laccento sulla anatomia e la
biologia, e in quella razionale di Ippocrate che si fondava sullinterpretazione clinica unitaria e
razionale della malattia. Nel periodo successivo, a partire dagli eredi diretti, gli stessi figli di
Ippocrate, si sviluppato il pensiero medico che riteneva quelle nozioni ormai certe, dogmi del
Maestro. Il figlio Tessalo pu essere ritenuto il fondatore di quella scuola detta appunto dogmatica.
In questo periodo si gettarono le basi per il connubio tra medicina e biologia: fu dato nuovo
impulso allo studio della anatomia, furono perfezionate tecniche chirurgiche e anche modificato
qualche elemento di patologia. Allumoralismo si affianc il concetto di pneuma, aria,
evaporazione del fuoco. Il pneuma entra nellorganismo per la bocca, giunge al cuore dal quale si
espande a tutto il corpo: dal cuore presiede a tutte le funzioni, fisiche e psichiche delluomo.
17
Per la prima volta viene dato fondamentale valore semiologico al polso (Prassagora 340 (320) a. C.
. Da ricordare anche Diocle di Caristo (IV sec. a. C.) il quale ritiene che il sangue origini dagli
alimenti trasformati dal fegato. Scrisse inoltre sulla dieta e sulluso delle erbe.
Aristotele e il mondo culturale alessandrino
Aristotele (384322), figlio di medico, allievo di Platone e maestro di Alessandro Magno, segn
una tappa fondamentale nellevoluzione del pensiero umano e quindi anche del pensiero medico
scientifico. Superato il periodo presocratico dellintuizione e della rappresentazione razionale di
modelli interpretativi, nasce il concetto della prova, della dimostrazione inconfutabile della verit
intuita. Per raggiungere la prova si pu seguire il metodo deduttivo, secondo il quale partendo da
concetti generali assiomatici, verit evidenti, il logos (il ragionamento logico), conduce, attraverso
una catena di sillogismi, alla conclusione che d la verit in quanto non contrasta con i principi di
partenza. E chiaro il vizio originale che d per scontata la verit dei principi assiomatici. Ma si pu
anche seguire una strada diversa che porta, secondo Aristotele, ad una conoscenza minore,
relativa alle cose sensibili: il cos detto metodo induttivo.
Partendo dallosservazione dei fatti sensibili, mediante la percezione, si pu risalire alle cause
generali che generano i fatti stessi. E losservazione dei fatti deve essere precisa, scrupolosa,
toccando con mano, catalogando, ordinando le varie conoscenze parziali per poter poi giungere, con
laiuto del logos, alla verit provata. Questo metodo coincide col moderno concetto di scienza.
Aristotele insegna anche che bisogna selezionare, giudicare, criticare le conoscenze del passato
per poterle accettare o confutare.
Come Empedocle anche Aristotele ammette lesistenza di quattro elementi fondamentali, acqua,
aria, terra, fuoco, ma ne riconosce un quinto elemento, una quinta essenza, sottilissima che ha
movimento circolare e forma il cielo: lEtere. Oltre il cielo forma anche lEmpireo, e Dio che lo
abita il Supremo Motore, la causa delle cause di tutte le cose. Luomo composto di materia e di
anima, sostanza e forma, Lanima che compenetra e organizza la materia chiamata entelechia.
Esistono tre specie di anime: la vegetativa, comune anche alle piante, ha sede nel fegato; lanima
sensitiva ha sede nel cuore; lanima razionale ha sede nel cervello ed esclusiva delluomo.
La fonte della conoscenza la sensazione interpretata dal logos secondo i principi, precostituiti,
della divinit.
Secondo Darwin, Aristotele il padre della biologia. Classific gli animali, dalle piante
alluomo, passando per i molluschi, gli artropodi, i crostacei, i rettili e i mammiferi.
Per mezzo di numerose autopsie studi particolarmente i nervi, che, come Alcmeone, chiam
poroi. Riconobbe nel cuore tre cavit e dimostr che le vene partono da esso: laorta e le cave; non
distingue le vene dalle arterie. Laria penetra nel cuore sinistro per la trachea. Il sangue, formato
dagli alimenti, cotti e trasformati dal pneuma e dal calore del sangue, si muove partendo dal cuore
e va in tutti gli organi ai quali porta alimento. Il sangue nero e denso nutre gli organi
sottodiaframmatici, quello leggero e fresco le regioni superiori del corpo.
La generazione avviene per opera dello sperma che congela il sangue mestruale, dal quale nasce
lembrione. Aristotele ammetteva la generazione spontanea delle piante senza fiori, di alcuni pesci e
di alcuni insetti: una forza vitale, psiche, diffusa nellaria e nel calore vitale, agirebbe sulla materia
organica in corruzione, mescolata con acqua di pioggia.
Oltre ai dieci libri di anatomia e fisiologia comparata (Storia degli animali), Aristotele scrisse i
quattro libri Sulle parti degli animali, i cinque sulla Generazione degli animali. Scrisse inoltre
Fisica, Del cielo, Della generazione e corruzione e Metereologia.
Aristotele, ultimo fulgore della genialit della Grecia prima della decadenza, rappresenta il tratto
dunione col mondo culturale alessandrino.
18
Tra gli allievi di Aristotele degno di nota Teofrasto, che per primo tratt in modo organico della
botanica, morto circa nel 285 a. C.
La scuola alessandrina
Le vicende storico politiche fecero spostare il centro culturale dalla Grecia al bacino orientale
del mediterraneo e allEgitto, specie in Alessandria, la cui costruzione, decretata da Alessandro nel
323 a. C., venne completata molto tempo dopo la sua morte, durante il regno di Tolomeo II tra il
285-246 a. C. Rivale di Pergamo, Alessandria fu sede della biblioteca pi grande del mondo ad
opera di Evergete e di Tolomeo Sotero.
Il pensiero medico di questa scuola fu caratterizzato dal cos detto esperimento biologico.
Le idee di Ippocrate erano tenute in sommo onore e le sue opere conservate e studiate nella famosa
biblioteca. Furono soprattutto la anatomia e, conseguentemente, la fisiologia che ebbero maggior
impulso. Gli alessandrini infatti ricorsero, per lo studio anatomico, alle vivisezioni: il condannato a
morte, addormentato, era ucciso nel sonno e il suo corpo sezionato e studiato. Molte delle nozioni
cos acquisite, anche di anatomia patologica, resistettero fino al Rinascimento. Le conoscenze
scientifiche di anatomia e fisiologia furono poste al servizio della clinica. I maggiori esponenti di
questa scuola furono Erasistrato ed Erofilo.
Erasistrato (330 a. C.), allievo di Teofrasto, scoperse, secondo Galeno, i vasa vasorum, descrisse
le valvole degli atri del cuore e dei vasi, e assegn la tricuspide alla vena cava. Descrisse larteria
polmonare come una vena che sembra unarteria e la vena polmonare come unarteria che sembra
una vena. Intravide lazione aspirante e premente del cuore, ipotizz il sistema di passaggio artero-
venoso periferico (anastomosi). Pens che le arterie vuote di sangue dei cadaveri fossero piene di
pneuma e che le vene fossero piene di sangue. Il movimento del sangue avverrebbe in questo modo:
laria attraversa la trachea e giunge al polmone, e poi al cuore sinistro per mezzo della vena
polmonare dove si tramuta in pneuma; il cuore sinistro, per via delle arterie, spande questaria,
divenuta pneuma, per tutto il corpo. Il succo degli alimenti digeriti diviene sangue nel fegato e da
questo arriva al cuore per via della vena cava. Per il gioco delle valvole, il sangue, attraverso
larteria polmonare, arriva nei polmoni. I polmoni si contraggono e si dilatano in sistole e diastole.
Il pneuma urtando contro le arterie produce il polso.
Nel cervello riconobbe i ventricoli laterali e descrisse il cervelletto; distinse la funzione dei nervi
motori dai nervi sensitivi. Nel fegato descrisse il parenchima e la secrezione della bile. Riconobbe
la cirrosi atrofica e la conseguente idropisia (ascite).
Le sue dirette osservazioni di anatomia patologica lo fecero allontanare dalla teoria umorale,
ippocratica, suggerendogli una prima ipotesi meccanicistica della malattia: egli riteneva che la
malattia risiedesse nei tessuti e nei vasi e che fosse causata da eccessiva produzione di sangue
(pletora). Dette molto valore allesame del polso, stabilendo un rapporto tra tachicardia e
sentimenti, come nellosservazione del giovane Antioco alla presenza di Stratonice
Fu molto parco di medicamenti, us la terapia naturale, lidroterapia e lesercizio fisico.
La sua fama e i suoi insegnamenti durarono oltre tre secoli.
Erofilo (340 a. C.). Le sue ricerche riguardano specialmente il sistema nervoso, la splancnologia
(apparato digerente, respiratorio e urogenitale) e gli organi genitali. Del cervello descrisse le
meningi, scoperse il IV ventricolo (che credette sede dellanima), vide il calamo scrittorio,
descrisse il torculare, il plesso corioideo e i seni venosi. Descrisse magistralmente locchio con le
tre membrane: cornea, coroide e aracnoide. Il nervo ottico fu interpretato come canale che porta la
sensazione visiva al cervello. Dette il nome al duodeno e vide i vasi chiliferi. Vide gli epididimi
sopra i testicoli, e le tube uterine. Fu rinomato medico pratico, specie in ostetricia e ginecologia e
scrisse un libro per levatrici. Dett un trattato di anatomia, uno di terapia e un commentario sulle
opere di Ippocrate.
19
Il periodo di splendore della scuola alessadrina dur poco: non oltrepass di molto la vita dei suoi
massimi esponenti.
La scuola empirica
In seno alla scuola alessandrina i seguaci di Erofilo ed Erasistrato si appiattirono sulle idee dei
maestri e trascurarono la medicina pratica; per reazione si risvegli linsegnamento ippocratico che
si basava sullosservazione diretta, autopsia, del malato, sulla storia delle proprie o altrui
osservazioni e sull analogia o confronto dei simili: il tripode alessandrino. Questi medici, per,
non avevano lacume ippocratico e il metodo non dava gli stessi frutti. Prediligevano la pratica e
losservazione, lempirismo, sulla speculazione razionale, per cui fu trascurata lanatomia e la
fisiologia. La chirurgia invece fece notevoli progressi, specialmente nel trattamento delle lussazioni,
delle fratture, delle ferite, dellernia, nelloperazione per la cataratta, nelle ernie ombelicali e
nella rottura dei calcoli vescicali.
Il medico che molto onor la scuola empirica fu Eracleide di Taranto (III sec. a. C.): si
interess di medicina militare e di dietetica. Pu essere considerato il primo farmacologo,
sperimentando molti principi attivi di piante. Fu autore di ricette ragionate e ben finalizzate allo
scopo, contro la tosse e linsonnia: papavero, zafferano, mirra, pepe lungo, cannella, galbano e
castoroFu autosperimentatore di alcuni veleni in dosi terapeutiche: cicuta e giusquiamo.
La scuola empirica alessandrina si interess anche di tossicologia, con esperimenti in vivo che
portavano spesso a morte gli ignari pazienti. Famoso il re Mitridate (13263 a. C.), fra questi
sperimentatori, che studiava il modo per vincere i veleni e scopr appunto il mitridatismo,
lassuefazione ai veleni. Laltra sua scoperta fu un antidoto universale, composto di 90 droghe, che
da lui prese il nome di mitridato, e che, con laggiunta di carne di vipera da parte del medico di
Nerone, Andromaco il Vecchio, divenne la pi celebre triaca.
La medicina preromana, etrusca
Le cognizioni mediche dei popoli italici sono avvolte nella leggenda e nella tradizione; quei popoli
ebbero fama di essere conoscitori di farmaci e rimedi atti a produrre sanit o terribili effetti: grande
era infatti labbondanza di erbe di quelle regioni. I guaritori erano sacerdoti, la loro arte medica
proveniva pi da dono divino che da studio umano.
Gi allepoca del ferro e del bronzo si svilupp nellItalia centrale una civilt autoctona tipica che
pu grosso modo identificarsi con la civilt etrusca. Scarse sono le conoscenze dirette di questa
civilt e in particolare intorno alla medicina. Le particolarit geografiche, per la presenza di
numerose fonti sorgive di acque minerali, determinarono lo sviluppo dellaspetto igienico, teso a
depurare le acque, a renderle potabili, al loro trasporto e al loro uso per bagni lustrali.
Famosa la cloaca massima fatta costruire dal re Tarquinio Prisco, di origine etrusca, che provvide
anche alla bonifica di luoghi paludosi. Gli Etruschi inoltre costruirono gli acquedotti, e cisterne con
filtri di sabbia per la purificazione dellacqua: un pozzo attiguo serviva per lutilizzo.
Sempre nellambito igienico notevole la regolamentazione del seppellimento dei cadaveri.
Molto diffusa e tenuta in grande considerazione era laruspicina, arte divinatoria che si basava
sullo studio particolareggiato e scrupoloso del fegato (radice caldea har). Oltre al fegato venivano
osservati i polmoni, la milza, i reni ed altri organi. Ci comportava una buona conoscenza della
anatomia, della anatomia patologica e della medicina: di qui lantagonismo tra medici e arspici.
Una particolare perizia ebbero gli Etruschi nellarte odontotecnica. Fin dal 1000 a. C. conoscevano
le protesi dette a ponte, la costruzione di corone e nastri doro per collegare denti vacillanti.
Usavano loro puro, non di lega, che dava plasticit alle protesi con saldature perfette, tuttora
ammirate.
20
LA MEDICINA IN ROMA
Roma, allinizio, non ebbe scuole mediche sue proprie, ma tutti i medici delle sue provincie,
dallAsia Minore ad Alessandria, alla Spagna miravano a venire a Roma. La medicina dellepoca di
Roma ebbe tre periodi: uno di origine autoctona, italica, uno di transizione e uno detto delle
scuole. Nellepoca che possiamo grossolanamente determinare tra la fondazione di Roma (753 a.
C.) e limmigrazione di medici greci (200 a. C.), si esercit nei territori latini e in Roma quella
medicina primitiva che tutti i popoli esplicano agli albori della civilt.
Questa medicina autoctona, italica, and progressivamente sviluppandosi in una sorta di medicina
domestica, esercitata dal Paterfamilias che oltre ad essere il sovrano assoluto della sua comunit
aveva anche il compito di badare alla salute dei suoi sudditi e a quella degli animali. Allo scopo la
casa era fornita di un valetudinario, un locale dove venivano ricoverati gli ammalati. Larte della
medicina si trasmetteva ereditariamente di padre in figlio. Si trattava prevalentemente di una
medicina empirica, basata sulluso di erbe, in infusi o decotti in acqua o vino.
Contemporaneamente era anche praticata la medicina ieratica nei templi.
La medicina domestica non si basa su conoscenze scientifiche ma sulla pratica delluso di erbe
infuse o decotte in vino o in acqua. Esponente di questa medicina fu Catone il censore (234149 a.
C.) che non fu propriamente medico, ma scrisse e si occup di medicina, in quellepoca che Plinio
defin senza medici: scrisse De re rustica e De medicina domestica, andato perduto. Fu una
medicina estremamente povera di sostanze terapeutiche: si basava quasi esclusivamente sulluso di
piante del genere brassica, sul cavolo, e sul vino, dei quali ne fece quasi una panacea. Si usavano
tuttavia anche altre erbe, quali il lauro, il veratro, la ruta, la menta, e il melograno. Il vino era
medicato con ginepro e mirto. Le ricette di Catone erano ispirate ad un saggio empirismo
naturalistico. Utile ricordare qualche capitolo del dottrinario medico di Catone: vinum ad alveum
movendum, ad dyspepsiam et stranguriam, medicamenta brassicae, ad intertriginem remedia.
La patologia abbastanza vasta: erano conosciute le ostruzioni del fegato e della milza, le coliche,
le malattie delle articolazioni; il cancro, distinto in atro, purulento e fistoloso. Della teoria umorale,
che Catone apprende dagli studi delle opere greche, sono considerati solo tre elementi: la bile, la
pituita e latrabile. Nella Roma antica fu data molta importanza alligiene in senso lato, di cui sono
tracce evidenti ed esplicite nella legislazione fin dalle XII tavole, tre secoli dalla fondazione di
Roma. Molta importanza aveva ligiene del suolo e delle acque, con lobbligo di ripulimento delle
acque del Tevere. Esistevano norme sulla conservazione degli alimenti allo scopo di preservarne la
salubrit e la qualit. Nello stesso periodo si esercitava in Roma la medicina ieratica, sacerdotale,
una medicina del tempio, analoga a quella dei Greci e di tutti i popoli.
La medicina ieratica
La divinit particolarmente venerata fu la dea Febbre, con la quale si identificava la malaria,
distinta in terzana e quartana. Molto venerata anche la dea Mefite, invocata per liberare Roma dalle
esalazioni delle paludi e da quelle causate dalle deficienze igieniche nella depurazione delle acque
e delligiene del suolo. Anche la dea Salus aveva i suoi devoti, e tanti altri dei e dee minori per ogni
manifestazione della vita, atti e fatti fisiologici: Mutus Tutunnus (Priapo), Cunina, UterinaCon
lintroduzione della civilt ellenica furono introdotti anche il culto ad Apollo e quello ad Esculapio
che ebbe dedicato il famoso tempio Tiberino (292 a C).
21
Periodo di transizione
Intorno allinizio del III secolo, nel periodo di transizione della medicina in Roma, si ebbe una
progressiva infiltrazione della cultura greca in Roma. Vi giunsero cos anche molti medici, tra i
quali molti ciarlatani girovaghi che contribuirono alla cattiva fama di cui godevano i medici in
generale presso le popolazioni.
Intorno al 219 a C, quando Catone scriveva la sua De re rustica, venne a Roma dal Pelopenneso
Arcagato, un periodeuta greco accolto presto col nome di vulnerarius, di chirurgo, per il quale fu
messa a disposizione una bottega, una taberna dove potesse esercitare la sua arte.
Con larrivo dei medici greci che esercitavano in propri locali la loro arte, ebbe origine lesercizio
pubblico della medicina, riconosciuto mestiere come gli altri esercitati nelle varie tabernae. Cos
insieme alla taberna argentaria, alla taberna vinaria, alla taberna tonsitrina si aperse anche la
taberna medicina. Nelle tabernae medicorum, botteghe dei medici, si faceva un po di tutto: si
confezionavano e venivano venduti i medicamenti, si curavano gli ammalati, si salassava, si
aggiustavano ossa e si chiacchierava, come nelle farmacie di qualche tempo fa. Pochi medici in
quel periodo ebbero buona reputazione. Erano spesso schiavi prigionieri di guerra, colti, ai quali
veniva addirittura concessa la cittadinanza romana. Giulio Cesare, nel 46 a. C., la concesse a tutti i
medici. Negli ultimi anni della Repubblica lesercizio della medicina miglior molto e larte medica
si riconoscer in vere scuole.
LA MEDICINA DELLE SCUOLE DELLA ROMA IMPERIALE
I medici greci pervenuti in Roma nellepoca repubblicana diedero deludente prova come gi
notato. Nel periodo successivo, invece, con la venuta di Asclepiade, sotto limpero di Traiano,
inizia un periodo fecondo in cui larte medica greca trova in Roma nuovo impulso per il suo
sviluppo. La medicina della Roma imperiale tuttavia dominata dalla grande figura di Galeno,
tanto da dover porre il grande medico al centro dellintero periodo, e di poter distinguere la
medicina dellimpero romano in tre fasi: pregalenica (fino a circa il 150 d C), galenica (160200 d.
C.) e postgalenica (dopo il 200 d. C.).
La medicina nella fase pregalenica
La fase pre galenica comprende quasi due secoli di vita, tra la venuta in Roma di Asclepiade e la
nascita di Galeno. E caratterizzata dallo sviluppo di varie scuole: la metodica, la pneumatica e la
eclettica, e dal diffondersi dellenciclopedismo.
La scuola metodica
Gli appartenenti a questa scuola delinearono per la prima volta una netta reazione antiippocratica.
Accanto allinterpretazione della costituzione della materia di Ippocrate (teoria degli umori), si
delineava una nuova interpretazione anche della malattia. La malattia non era solo unalterazione
della crasi umorale, ma era determinata dallalterato movimento delle particelle costituenti la
materia nei pori di esse (solidismo). La dottrina diretta emanazione dellatomismo di Democrito.
. Secondo Asclepiade (124 d. C.), la materia formata di atomi di diversa grandezza e da pori entro
i quali essi si muovono. Quando la proporzione tra atomi e pori perfetta, e il loro movimento
regolare, si ha la salute; al contrario si ha la malattia. E la teoria solidistica contrapposta a quella
umoralistica di Ippocrate. Questa concezione di malattia alla base della scuola metodica fondata
22
da Temisone verso il 50 a. C., cosi chiamata perch egli dette il metodo per lapplicazione pratica
delle idee di Asclepiade, suo maestro, che distingueva uno status laxus da uno status strictus, a
seconda della larghezza o strettezza dei pori. Allo status laxus corrispondeva pallore, polso debole,
flaccidit, astenia, affaticamento, rilassamento, mentre allo status strictus corrispondeva rossore,
calore, congestioni, sete intensa, ipertonia, stato agitato.
In terapia, Asclepiade si basava sul principio del contraria contrariis: rilassare lo status strictus e
restringere lo status laxus. Preferiva esercizi fisici e idroterapia ai pochi farmaci. Aborriva tutti quei
beveroni e intrugli talora usati dalla medicina umorale, il suo motto era: tute, cito et iucunde. Us
per primo le sanguisughe. Ogni terapia era preceduta da tre giorni di digiuno.
Tessalo, venuto a Roma ai tempi di Nerone, contribu alla decadenza della scuola pur avendo avuto
numerosi maestri migliori di lui come Sorano dEfeso, che venne a Roma circa lanno 100 d. C.,
noto come valente ostetrico e scrisse unopera intitolata Delle malattie delle donne. Descrive
lutero, le mammelle e le ovaie, che chiama testicoli; avrebbe descritto limene. Ammette le
pratiche antifecondative come la chiusura dellutero con lana e sostanze grasse, ma proibisce
laborto. Consiglia la difesa del perineo durante lespulsione del feto e lo svuotamento della vescica
mediante catetere prima del parto. Descrive la tecnica del rivolgimento del feto in utero e la doppia
legatura del cordone ombelicale. Descrive i segni di maturit fetale, e d indicazioni sui primi
lavaggi, sulla pulizia e sulla fasciatura del neonato. Detta regole per lallattamento, e per lo
svezzamento da attuarsi allinizio della dentizione, d inoltre consigli sulla cura delle diarree del
neonato.
La scuola pneumatica
Contro la riforma della scuola metodica, contraria al pensiero di Ippocrate, sorse
contemporaneamente una controriforma rappresentata dalla scuola pneumatica ad opera di Ateneo
di Attaleia giunto a Roma dal 41 al 54 d. C. Rappresenta la continuazione della scuola dogmatica
che, accanto a quella degli umori, poneva quella del Pneuma (aria, evaporazione del fuoco). Si
occup di igiene delle abitazioni e della depurazione delle acque. Nellinterpretazione fisio
patologica seguiva le idee di Aristotele.
La scuola eclettica
Fu fondata da Agatino, allievo di Ateneo, nel 90 d. C. La Scuola, preceduta dalle tendenze culturali
sorte fin dallepoca di Cesare e di Augusto in campo filosofico (Cicerone fu uno degli eclettici pi
noti), realizz la fusione dellumoralismo ippocratico con il solidismo di Asclepiade, senza
rinunciare alle idee pneumatiche e metodiche che si fusero e armonizzarono tra loro. Per tale
operazione Agatino si merit lappellativo di episintetico.
Tra i migliori medici della scuola, e di tutta la medicina di Roma, fu Archigne, siriano che visse
e oper allepoca di Traiano (48117 d. C.). Si occup per primo del linguaggio medico con
lintroduzione di nuovi termini. Descrisse la difterite (angina necrotica?) e lascesso del fegato,
perfezion la tecnica delle amputazioni. Descrisse e oper il cancro solido della mammella e i
tumori solidi dellutero. Particolare interesse dedic al polso del quale ne descrisse otto specie con
diverse variet; si occup della dottrina delle febbri e della sede delle malattie dedotta dalle varie
modificazioni del dolore. Fautore del salasso, lo praticava fino al deliquio.
Molto stimato fu Areteo di Cappadocia, ippocratico e penumatico (III sec. d C). Come anatomico
descrisse i reni e assai bene lintestino dove possono formarsi varie ulcerazioni.
Scrisse un libro intitolato Le malattie acute e croniche, dove descrive mirabilmente i quadri
morbosi, in particolare la pleurite, la paralisi cerebrale che riconosce crociata, a differenza della
paralisi spinale con sintomatologia omolaterale. Descrive larresto cardiaco e la sincope e il diabete.
Dalleclettismo si pass allEnciclopedismo.
Questa tendenza culturale interess tutte le branche dello scibile, della sapienza greca e romana, e di
ogni branca tendeva a raccoglierne il meglio e ad armonizzarlo insieme.
23
In campo medico i maggiori esponenti furono A. Cornelio Celso e Plinio Secondo. In campo
generale sopra tutti Cicerone, ma anche Lucrezio, Seneca, Varrone, Columella, e Vitruvio riportano
nelle loro opere notizie di carattere medico.
A. CORNELIO CELSO
Celso quasi certamente non esercit la professione di medico, ma fu autore e compilatore di opere
di medicina di estrema chiarezza e completezza. Fu attivo intorno al 25 d. C. Scrisse De medicina in
otto libri. In essa riflette le idee e il metodo di Ippocrate. Pu essere considerato anche come storico
della medicina, la sua opera infatti comincia con una prefazione in cui traccia la storia della
medicina del passato. Tratta delle varie scienze mediche: dietetica, farmaceutica, chirurgia e
anatomia, De humani corporis, che reputa disciplina indispensabile allo studio della medicina.
Riserva molto spazio alla trattazione delle febbri che distingue e analizza nelle loro varie forme. La
patologia esposta per regioni anatomiche e per i vari organi; di ogni malattia ne descrive i sintomi
il cui complesso forma il quadro generale. Tratta la patologia mentale: ricorda le allucinazioni e la
amenza. Molto estesa la parte della trattazione che riguarda la cura. Descrive le confezioni dei vari
medicamenti: cerotti, pastelli, pessari, antidoti, pillolesuddivisi in classi a seconda delle azioni
medicamentose: purganti, diuretici, revulsivi, emeticiMolti capitoli sono dedicati alle ferite e ai
morsi di animali ; tratta anche dei singoli avvelenamenti.
La parte dedicata alla chirurgia tra le pi precise, comincia col tratteggiare il ritratto del perfetto
chirurgo: giovane, forte, di vista acuta, abile nellusare la mano destra e la mano sinistra, coraggioso
espietato. Per le emorragie riporta il consiglio di trattarle con spugne imbevute di acqua fredda.
Se lemorragia violenta consiglia la legatura del vaso isolato. Riporta varie manovre di fasciatura
per le ferite. Riporta la tecnica e gli strumenti adatti per la trapanazione del cranio. Tratta delle
fratture delle singole ossa e della loro specifica cura. Parla delle ferite penetranti in addome, e delle
ernie di vari tipi: inguinale, scrotale e addominale, con i relativi tipi di trattamento. Riferisce anche
la sintomatologia dellincarcerazione dellernia. E descritta minutamente loperazione per
lestrazione dei calcoli vescicali e la tecnica per loperazione delle emorroidi e delle varici. .
Notevole il metodo celsiano per le plastiche facciali. Molte sono le malattie degli occhi trattate,
delle quali riporta la specifica cura: per la cataratta indica la reclinazione del cristallino e, se ritorna
nella posizione primitiva, la sua frammentazione. Tratta del calazio, pterigio, ectropion,
dacriocistiteRiporta il vastissimo strumentario: circa 50 pezzi confermati dai reperti di Pompei e
Ercolano. La paracentesi ritenuta poco utile se lascite dipende da malattia del fegato. Indica il
salasso solo in casi ben ponderati a seconda della malattia.
Riporta e descrive i tre caratteri fondamentali della flogosi, infiammazione, degli ippocratici:
rubor, tumor, dolor, cui aggiunse la laesa functio.
Distingue i tumori in quelli secundum Naturam: utero gravido, mammelle puberi; super Naturam:
obesit, callo osseo; praeter Naturam: tutte le altre tumefazioni, tumori solidi benigni, maligni e
flogosi.
In dermatologia nota, e ancora in uso, la definizione dellarea Celsi.
Oltre che di igiene generale, si interess di igiene alimentare e di dietologia. Il soggetto robusto e
sano non ha bisogno di nessuna regola. Il soggetto debole deve seguire precise regole adatte al suo
stato: deve usare cibi ingrassanti o dimagranti nelle giuste quantit, sempre accompagnati
dallesercizio fisico. Per liberare lo stomaco indica in taluni casi il vomito.
Notevole importanza viene assegnata ai bagni corroboranti. Tratta anche delle malattie degli organi
genitali, scusandosi di dover parlare di cose oscene.
Lopera di Celso rappresenta una vera summa delle conoscenze medico chirurgiche della
seconda met del primo secolo d. C. esposte chiaramente ed organicamente da chi, anche se non
pratic la medicina, certo la conosceva alla perfezione.
La sua opera fornir le cognizioni di base della medicina araba.
24
CAIO PLINIO SECONDO
Plinio il Vecchio, Caio Plinio Secondo, zio di Plinio il Giovane, nato a Como nel 23 d. C. morto a
Stabia nel 79 fuggendo dalleruzione del Vesuvio, fu autore della Storia naturale, una sorta di
enciclopedia della scienza che resistette per circa 15 secoli. Dedicata a Tito, tratta tra laltro di
zoologia, di botanica, di medicamenti tratti dai semplici di origine vegetale, animale e minerale.
Tra i vegetali riconosce le propriet della belladonna sulla pupilla e il beneficio dellefedra contro
lasma. Parla del verbasco e delle betonica.
Onora Ippocrate, non aderisce alla scuola metodica e disprezza Asclepiade. Molte delle notizie sulla
medicina e sui medici dellepoca di Roma sono desunte dalla sua opera.
..
A completamento di quanto riportato nei vari capitoli sulle diverse Scuole e sui loro esponenti, si
integra il Dottrinario della medicina in Roma prima di Galeno.
Per quanto riguarda lanatomia e la fisiologia si pu dire che, non essendo ammessa la vivisezione
e la visione diretta dei visceri, le nozioni derivano esclusivamente dallosservazione dellanatomia
degli animali e da quanto era pervenuto dalle opere della Scuola alessandrina. Si deve tuttavia
riferire che Marino, le cui opere sono andate perdute, enumer, secondo Galeno, le sette paia di
nervi cranici e fu probabilmente lo scopritore dei nervi palatino e glossofaringeo.
Rufo dEfeso, vissuto allepoca di Traiano, descrive il decorso dei nervi ottici e la capsula del
cristallino e osserv che il ventricolo sinistro del cuore ha le pareti pi grosse e cavit pi piccola
del destro.
Per la chirurgia si deve rilevare la sua grande importanza e notevole sviluppo delle varie branche
con luso di numerosi ingegnosi strumenti: forfices e forficulae a molla, litotomi, tonsillotomi,
serrae e serrulae (seghe), forcipi per lestrazione di corpi estranei, coltelli, dissecatori, flebotomi,
lanceolati, perforatori (terebrae), speculi, specilli, spatole, pinze da denti, aghi da sutura (retti e
curvi), ventose
La disinfezione era coscientemente praticata mediante la pulizia e la detersione delle ferite con
lavaggi con aceto e vino diluiti con estratti di varie erbe, e ci per evitare la suppurazione. Tra le
sostanze usate erano la cera, la trementina, l'incenso, la ruggine, il sale ammonico, il mercurio, il
piombo, lallume, loro, il borace e varie terre: famosa la terra sigillata (in pastiglie timbrate, la
terra Lemnia ) =cimolite, terra di Cimolo, terrosa, silicato di alluminio.
Tra le specialit, molto in auge la oculistica: numerosi i medici ocularii. Erano noti 24 tipi di
operazioni per gli occhi, eseguiti con pochi strumenti, simili, ma pi piccoli di quelli chirurgici.
Lodontoiatria non fece molti progressi dallepoca etrusca. Si praticavano le protesi a ponte e si
usavano denti artificiali, in osso, oro e anche in legno. Lestrazione era preceduta dalla dissezione
della gengiva e veniva eseguita con pinze adatte: odontagrae per i denti, rhizagrae per le radici.
Erano usati dentifrici per pulire e imbiancare i denti: Egnatius quod candidos habet dentes renidet
usquequaque: ha denti candidi e sorride sempre(Catullo). Molto richiesta allo scopo era lurina
degli spagnoli.
Roma dette molta importanza a tutto ci che atteneva alla generazione, alla gravidanza, al parto e
al trattamento del civis romanus. Se ne hanno precise tracce nelle leggi. Gi Numa Pompilio
imponeva il taglio cesareo sulla donna appena deceduta per salvare il neonato. La legge Cornelia
determinava i segni di vitalit del feto nei casi di aborto di feto prematuro e comminava la pena di
25
morte per la sostituzione di neonato. Laborto era proibito, tuttavia praticato da medici poco
ossequienti, specie greci girovaghi. Frequente luso di abortivi.
La donna gravida era ritenuta sacra e la legge ingiungeva alla gestante lobbligo di una vita parca,
frugale e astemia: per ci Lucrezio loda i costumi dellepoca repubblicana.
Il parto era conosciuto con sufficiente chiarezza e note le principali cause di distocia: et avanzata
nelle primipare e anomalie del bacino e dei genitali. Si usavano speculi vaginali in bronzo a 3 o 4
valve e strumenti per lembriotomia. Il parto avveniva sulla sedia da parto, con lassistenza di
ostetriche, che erano anche chiamate a certificare lo stato di gravidanza e ci aveva importanza
determinante in controversie legali. Fin dai tempi di Romolo, il padre aveva il diritto di sopprimere
i figli maschi deformi e le femmine secondogenite. La legge consentiva inoltre la esposizione dei
neonati in caso di povert, di illegittimit, e di nascita in tempo di pubbliche calamit e per cattivo
augurio degli aruspici. I neonati erano esposti nei Fori, nelle cloache, sulle rive dei fiumi e del mare.
Se raccolti diventavano schiavi. I neonati destinati alla vita erano oggetto di molte cure: la scelta
della nutrice, losservanza del migliore tenore di vita per il suo futuro sviluppo e per il
potenziamento della sua costituzione. Il neonato era opportunamente fasciato, e gli veniva praticata
la pulizia degli occhi e della bocca con lolio. Era alimentato per i primi due giorni con miele
bollito, lallattamento iniziava al terzo giorno e lo svezzamento con la dentizione. La vitalit dei
prematuri era valutata dopo il settimo mese.
La terapia raggiunse nella Roma imperiale le caratteristiche di completezza nelluso dei semplici
derivati dalla natura, (erbe, animali, minerali) che durer fino ai primi tentativi dellalchimia, e poi
della farmacia che introdurr i preparati chimici. Di qualunque scuola fosse il medico si basava
essenzialmente sul principio del contraria contrariis, come gi riferito. Talora il criterio era il
principio, di origini ancestrali, similia similibus per cui la velenosit lantidoto di se stessa: lolio
di scorpione giova contro la puntura di quegli insetti; il diaspro, rosso sanguigno, utile contro le
emorragie; le lucertole, che con la loro pelle ricordano laspetto dei tumori, sono utili contro i
tumori stessi. E la vipera, emblema di tutti i veleni, lantidoto di tutti i veleni: il fondamentale
componente della famosa teriaca, antidoto universale e cura di tutti i mali. Famosa la teriaca di
Andromaco, medico di Nerone, composta di 54 ingredienti, raccolti e mescolati con rituali
particolari, che non poco giovarono a conferire al medicamento un indubbio effetto magico, di
placebo, come causa del beneficio terapeutico piuttosto che delleffetto specifico dei molteplici
ingredienti. Fra gli animali pi utilizzati sono da ricordare i ricci, la torpedine, le seppie, le
chiocciole, le locuste, le cantaridi, le cimici, i castori, le lepri, le donnole, i lombrichi, i millepiedi,
le lucertole e naturalmente gli scorpioni e le vipere. Ma anche i derivati animali: latte, formaggio,
peli, ossa, pelli ed escrementi. Xenocrate (I sec. d. C.) ricordato come il maggior esponente di
certa terapia coprologica: oltre allurina usava le feci e varie secrezioni, il sangue mestruale e il
cerume dorecchio. Leccipiente principale era il miele nel quale fermentava il semplice,
formandosi cos un elettuario utile a vari usi. Nei lapidari erano elencate varie pietre e gemme,
alcune delle quali erano ritenute medicamentose o semplicemente apotropaiche (Pedacio
Dioscoride, 80 d. C.).
Molta importanza, come ricordato, ebbe lidroterapia mediante acque saline (alcaline), solforose,
albuminose, bituminose, utili per ammorbidire lutero, la vescica e lintestino; e inoltre acque
ferruginose e vetrioliche. Importanti erano le acque anche per i bagni: Antonio Musa (I sec) salv
nel 23 d.C. la vita ad Augusto variando tipo di terapia, con bagni freddi (invece che caldi) e legumi
e insalata. E il Freud dellantica Roma, nel suo lectulus lucubratorius confess Catullo, Lucrezio,
Virgilio e Orazio.
Non esisteva una disciplina che potesse avvicinarsi a quella che oggi chiamiamo farmacologia,
ma certo vi furono medici che dedicarono la loro specifica ricerca allo studio del medicamenti. Di
essi da ricordare Scribonio Largo che scrisse appunto Compositiones medicamentorum, dove
assegna importanza farmaceutica alloppio introducendolo in molte sue ricette (4348 d. C.) e
26
inoltre, da ricordare il gi citato Dioscoride che oltre ad adombrare un metodo di preparazione di
medicinali chimico (preparazione del mercurio vivo dal cinabro, riconoscendo tuttavia le propriet
venefiche del mercurio), introdusse delle prove per verificare le falsificazioni e le adulterazione dei
medicinali.
La medicina nella fase galenica
GALENO nacque a Pergamo nel 129 d. C. nella citt famosa per lesistenza di un tempio ad
Esculapio, centro quindi di medicina ieratica, ma anche empirica. Dimor a lungo ad Alessandria;
venne a Roma sotto Marco Aurelio e Commodo, dove forse vi mor nel 201.
Fu perfetto osservatore e sperimentatore convinto, che tuttavia non disdegna il ragionamento
sillogistico aristotelico quando la via dellesperimento non pu essere percorsa o la conoscenza
diretta risulta impossibile. La sua genialit si esplic maggiormente nellanatomia e fisiologia, ma
soprattutto nella clinica. Seguace di Platone ammira lopera del Creatore, unico Essere superiore
che ha fatto gli organi ciascuno finalizzato alla sua specifica funzione (concetto teleologico), e di
Aristotele del quale segue il metodo logico, talora complicandolo fino a renderlo un limite alla
conoscenza invece di valido strumento.
La sua patologia la risultante di un geniale sincretismo tra le dottrine umoralepneumatica e
solidistica, con predilezione della prima. Possiamo dire che segue un positivismo scientifico, che
lo rende preciso e scrupoloso nelle dissezioni anatomiche degli animali per poterne ottenere le
migliori deduzioni, come ad esempio nella minuziosa descrizione del decorso dei vasi e dei nervi,
nozioni che sono di base al chirurgo per i suoi interventi.
Delle sue opere (400600?), scritte originariamente in greco, rimangono 83 scritti ritenuti originali,
19 dubbi e, inoltre, 15 commentari degli scritti di Ippocrate. Gli arabi lo tradussero e
commentarono, talora travisandolo nella loro interpretazione. Le traduzioni arabe furono tuttavia
utili anche agli occidentali, che cos poterono integrare le opere originali, andate perdute.
Anatomia
La legge romana proibiva le dissezioni di cadaveri umani, le descrizioni anatomiche di Galeno,
quindi, sono il frutto di dissezioni di scimmie antropomorfe del genere macacus. Era convinto che
gli organi di quegli animali che avevano la stessa funzione di quelli corrispondenti delluomo
potessero avere anche la stessa forma. Degne di nota sono la descrizione delle fibre muscolari, la
scoperta dei muscoli della laringe e dei nervi laringei. Distingue il nervo acustico dal nervo facciale,
del quale ne segue il tortuoso decorso. Conferma la distinzione tra nervi sensitivi e nervi motori.
Descrive la branca superiore e inferiore del nervo trigemino e i nervi olfatori. Riconosce la
connessione dei nervi col cervello, del quale descrive il setto pellucido, il corpo calloso, le
eminenze quadrigemine e i ventricoli. Descrive le fibre della struttura cardiaca, ma non ne riconosce
la natura muscolare. Per lanatomia dei vasi si attiene alle scoperte degli alessandrini Erofilo ed
Erasistrato.
Delle tre concezioni, umoralepneumatica di Ippocrate, meccanicistica di Erasistrato (pletora di
sangue che dilata i vasi e i tessuti) e solidistica di Asclepiade, propende pi per la umorale
pneumatica, come gi notato. Secondo Galeno, gli umori derivano dagli elementi (acqua, aria,
fuoco, terra) e sono contenuti nel sangue. La prevalenza di uno degli umori conferisce la
caratteristica allumore stesso: acqua per la pituita, fuoco per la bile gialla, terra per latrabile, aria
per il sangue. Il pneuma, distinto secondo Aristotele in psichico, con sede nel cervello, zoticon
(vitale), con sede nel cuore, fisico (vegetativo) con sede nel fegato, ha valore di forza vitalizzante.
Queste tre forze del pneuma costituiscono le forze fondamentali dellorganismo che generano le
facolt attraente, alterante ed espellente.
27
Distinse le varie lesioni cerebrali dei due emisferi da quelle del cervelletto. Dimostr che la
secrezione delle urine avviene nei reni che secernono lurina dal sangue. Inoltre osserv la paralisi
di moto e di senso conseguente al taglio del midollo spinale e la morte istantanea alla lesione del
bulbo. Per quanto riguarda la circolazione del sangue, Galeno, contraddicendo gli alessandrini,
scopre che negli animali vivi e nei gladiatori le arterie contengono sangue e non pneuma, e che le
arterie sono
in connessione con le vene. Ci dimostr tagliando unarteria di un animale: constat che conteneva
sangue e che incidendo unarteria si poteva rendere lanimale completamente esangue. Scoperse
inoltre che il sangue delle arterie era diverso da sangue contenuto nelle vene. Il sangue contenuto
nelle arterie detto vitale perch contiene anche il pneuma, quello contenuto nelle vene detto
nutritivo. Il movimento del sangue avviene nel seguente modo: dallapparato digerente gli alimenti
giungono al fegato, dove si trasformano in sangue nutritivo; di questo sangue una parte viene
attratta dagli organi per la loro nutrizione, unaltra parte, attraverso la cava inferiore, arriva al cuore
destro. Dal cuore destro, attraverso fori invisibili del setto (che divide i due cuori), passa al cuore
sinistro dove si mescola col pneuma e diventa sangue pneumatico, vitale, spiritoso. Questo sangue
vitale passa attraverso laorta e si diffonde a tutto il corpo e si esaurisce negli organi. Una piccola
parte di sangue dal cuore destro passa per la vena arteriosa (arteria polmonare) nei polmoni per il
loro nutrimento. Attraverso le vene polmonari il sangue viene convogliato ai polmoni, dai quali,
poi, refluisce in piccola parte per espellere, con lespirazione, le fuliggini, le impurit. In
definitiva per Galeno il fegato il centro del sangue venoso (nutritivo), il cuore il centro del
sangue arterioso (vitale). Il cuore destro comunica col sinistro per i fori invisibili del setto. Galeno
non conosce la circolazione polmonare, sebbene ne dia un piccolo abbozzo nel fatto che parte del
sangue venoso del cuore destro passa ai polmoni, per la depurazione delle fuliggini, come
accennato. E inoltre il sangue non circola: parte dal fegato e dal cuore e si esaurisce nei tessuti come
gi notato.
Per quanto riguarda la generazione, Galeno riconosce lo sperma umano derivante dal sangue: esso
si forma nei vasi spermatici, vena e arteria, e nei didimi dove viene elaborato per poter generare.
Lovaia genera il seme femminile. Conosce gli effetti ormonali delle ghiandole sessuali: lo deduce
da quanto accade dopo la castrazione degli animali.
La patologia secondo Galeno non cos originale come la anatomia e la fisiologia. La malattia ,
per Galeno, uno stato del corpo in cui sono lese le funzioni, diatesi: ad ogni malattia corrisponde
una lesione organica. Divide le malattie in malattie delle parti semplici (arterie, vene, nervi, ossa,
cartilagini e muscoli), malattie degli organi (fegato, polmoni), e malattie traumatiche. Nel fondere
le precedenti teorie patogenetiche, parla di ametria (alterazione dei pori tra gli atomi), e di
intemperie (disarmonica mescolanza di umori). Su queste basi costruisce un complicato e
complesso sistema di divisioni, suddivisioni, cause, concause, delletiologia morbosa, appesantito
da astrusi sillogismi nei quali si perde la chiarezza dellosservatore.
Dove Galeno eccelle nella clinica: ricerca i sintomi (epigenemata) fino allo scrupolo e la loro
ragionata interpretazione dopo la puntigliosa valutazione della storia del paziente (anamnesi), il
tutto fondato sulle basi anatomiche e fisiologiche. Notissimo lesempio del sofista persiano colpito
da paralisi sensoria delle due ultime dita di una mano e della met del medio: lanamnesi pot
mettere in rilievo una caduta che provoc una contusione delle spalle con violento dolore, ne
dedusse uninfiammazione del midollo, mise il paziente a riposo, applic emollienti ed ottenne la
guarigione.
Nella chirurgia non emerse come nelle altre discipline, pur essendo stato medico dei gladiatori,
attivit che gli offr forse loccasione di osservare attraverso le loro ferite lanatomia umana e il
flusso del sangue arterioso e venoso.
Nelle sue opere si trovano chiare allusioni alla medicina legale: porta ancora il suo nome la
docimasia idrostatica per constatare, in caso di infanticidio, se il feto aveva o no respirato. Si
occupa delle morti vere o apparenti e delle simulazioni delle malattie.
28
La terapia di Galeno si basa sul principio contraria contrariis. Essendo, come abbiamo visto,
complicata la discrasia degli umori nel concetto di malattia, diventa, di conseguenza, indaginoso
applicare quel concetto a tutte le infinite combinazioni umorali. Usa medicinali prevalentemente
vegetali, di cui se ne contano ben 473, oltre ai semplici animali e minerali. Non disdegna, come
visto, limmancabile teriaca e la hiera, purgante sacro, a base di coloquintide e la picra, purgante
amaro. Usa il salasso sempre col criterio del contraria contrariis.
La medicina nella fase postgalenica
Al declino dellImpero comincia in Roma quello che comunemente si chiama periodo di
decadenza. Costantino nel 330 scelse Bisanzio, Costantinopoli, quale sua capitale che acquist
particolare splendore, costituendo una nuova civilt, con proprie caratteristiche nella cultura,
nellarte, nella vita sociale e nella medicina: la medicina bizantina.
Citiamo brevemente Leonida di Alessandria che descrisse il verme Filaria medinensis, lidrocefalo
e il gozzo. Filagirio, IV secolo, ottimo chirurgo, fratello di Poseidonio che si occup in modo
particolare delle malattie del cervello. Vindiciano Afro, amico di SantAgostino, si occup di
ginecologia. Teodoro Prisciano, IV scolo, tra i pi noti della bassa latinit, piuttosto empirico in
terapia, tiene presente la depurazione degli umori corrotti. Marcello di Bordeaux, visse allepoca di
Teodosio, animato da spirito di carit verso i poveri, us ricette e prescrizioni con vasto influsso di
superstizione e magia, con parole e canti taumaturgici.
Gli ospedali in Roma
Abbiamo fatto cenno che fin dalla medicina domestica del paterfamilias erano in uso dei locali per
gli schiavi malati, valetudinari: specie di infermerie private pi o meno ampie.
Esistevano, naturalmente, i locali di accoglienza per gli ammessi al Tempio di Esculapio e le
medicatrinae di cui si fatto cenno: tabernae, botteghe, specie di ambulatori, farmacie, luoghi di
osservazione, presso labitazione del medico dove egli esercitava la sua arte e dove teneva in cura e
osservazione i suoi pazienti. Col passare degli anni, i valetudinari si ampliarono e moltiplicarono:
Celso parla di ampla valetudinaria, forse talora sovvenzionati dallo stato, ma non se ne ha
documentazione. Il valetudinari, tuttavia, dovevano essere sempre tenuti ben puliti, salubri e ben
ordinati, anche quando non erano occupati da ammalati. Vi prestavano servizio medici e
infermieri, servi a valetudinario.
Lostetricia era affidata alle ostetriche, che avevano lo status di medichesse invece che di
semplici infermiere. Tutta lassistenza ospedaliera era improntata allo stato utilitario di mettere lo
schiavo in condizioni di lavorare, prescindendo completamente dallo scopo umanitario.
Collavvento invece del cristianesimo, si affianc il concetto di carit: il buon samaritano cura il
malcapitato pellegrino, viandante. Nascono, in piena persecuzione, gli Xenodochi: alloggi per i
pellegrini, luoghi di cura e di assistenza caritatevole per i pi umili, diseredati, malati indigenti.
Vuole la tradizione che San Cleto, terzo papa, nell 80 abbia trasformato la sua casa in ospizio. E
ugualmente SantAgnese nel IV secolo. La prima menzione ufficiale degli xenodochi avviene nel
concilio di Nicea, indetto da Costantino nel 325 (Editto di Milano 313), che vide protagonisti
Attanasio e Ario. In esso si stabiliva che ogni citt dovesse essere dotata del suo ospizio per i
pellegrini, infermi e poveri, presieduto e governato da un monaco. Ne sorsero molti a spese sia
pubbliche che private. La nobile Fabiola (della famiglia dei Fabi), tra i privati, costru in Trastevere
un vero e proprio ospedale, incitata dalla predicazione di San Girolamo (347420), tornato a Roma
nel 381 dal deserto della Calcide, (dove tradusse dal greco - aramaico - ebraico in latino la Bibbia,
la famosa vulgata). Nellospedale di Fabiola erano raccolti gli ammalati che giacevano nelle
piazze, consunti dallindigenza e dallinedia, e i malati pi ributtanti per piaghe gangrenose, ferite
29
fetide e verminose. Lospedale di Fabiola fu il primo dellOccidente. Alla sua morte il popolo le
tribut onori come ai conduttori vincitori. Dal punto di vista filologico, San Girolamo, oltre che la
parola xenodochi, introdusse nella lingua latina il termine greco nosocomeion, nosocomio, tuttora
usato per ospedale.
La professione medica in Roma
Per circa 600 anni, secondo lespressione di Plinio, Roma visse, sembra non male, senza medici,
nel senso, come gi notato, che la professione del medico non era regolamentata n riconosciuta
ufficialmente; al massimo, lesercizio della sua arte era paragonata a quella di qualsiasi artigiano.
Dopo il 200 a. C. -come detto- una moltitudine di medici immigrarono dalla Grecia, ma non
diedero buona prova n lasciarono buona fama: molti erano ciarlatani ignoranti, rari i medici colti,
per lo pi schiavi e prigionieri di guerra. A credere alle descrizioni di Plinio e alle satire di Marziale
il loro livello morale era assai basso. Non mancarono tuttavia medici di alto livello, anche tra gli
immigrati: Asclepiade, Archigne, Areteo, Agatino e altri che sicuramente diedero buona prova,
specie dallet imperiale. Larte e la scienza medica riportata da Celso, Plinio e da Galeno era di
ottima qualit e Galeno ha il merito di averla sintetizzata.
Linsegnamento della medicina si svolgeva allinizio da parte del paterfamilias, poi nelle
medicatrinae e nei valetudinari e nelle scholae medicorum, o dai medici al domicilio del loro
paziente, seguiti da una turba di discepoli: cos riferisce Marziale (L. V. 9) Languebam, sed tu
comitatus protinus \ ad me venisti centum, Symmache, discipulis / Centum me tetigere manus
Aquilone gelatae. / Non habui febrem, Symmache, nunc habeo.(Non avevo la febbre, Simmaco,
ora ce lho.)
Plinio insiste sullavidit dei medici: 200 sesterzi per una visita domiciliare fuori Roma; il medico
Crina lascia alla moglie 100.000 sesterzi in eredit: quanti ne occorrevano per rifare le mura di
Marsiglia; 500.000 sesterzi era lo stipendio per il servizio medico a corte.
I poveri dovevano accontentarsi di mestieranti: ciarlatani, stregoni, sacerdoti di Esculapio,
fattucchiere che per pochi solidi davano ricette e intrugli.
Soltanto nel 46 Giulio Cesare concesse la cittadinanza ai medici immigrati: cominci cos
lemancipazione progressiva e il riconoscimento dellarte medica autoctona. Il medico servus
diventava libertus (spesso per manumissio dominica, (liberazione da parte del padrone), in segno di
riconoscenza per i servizi prestati), e infine civis pleno iure. Come tale poteva avanzare nelliter
honorum e nel cursus honorum.
Giuliano lapostata (331363) promulg una legge secondo la quale il medico doveva attestare la
propria idoneit allesercizio della medicina. Ai tempi di Galeno esistevano delle scholae
medicorum, presso le biblioteche, dove veniva insegnata la parte teorica. Pare che Galeno stesso
abbia insegnato nella biblioteca del Tempio della Pace.
Nel basso impero il medico conquist addiritura una condizione privilegiata: primus inter pares
tra i liberi professionisti cui competeva il titolo di praesulis spectabilisperfectissimus,
clarissimus vir,ma la completa e totale personalit giuridica, la conquister ufficialmente con il
Corpus iuris giustinianeo (528534).
30
LA MEDCINA NEL MDIOEVO
Dal tardo Impero alla soglia delle Universit
Il pensiero medico e tutto il dottrinario derivato da Ippocrate, da Aristotele e dagli Alessandrini,
passato in Roma e raccolto da Celso, Plinio e Galeno si estese alla cultura del tardo Impero sia in
Occidente che in Oriente e successivamente influenz in modo determinante la cultura medica
araba. Durante lera imperiale di Roma inizi e si svilupp la Rivoluzione Cristiana. Questo fatto
storico influenz tutta levoluzione del pensiero del Medio Evo. La nuova religione, la nuova
ideologia, domina, pervade e determina lo sviluppo del pensiero in tutte le sue manifestazioni:
filosofia, letteratura, arti figurative, architettura, costume e sicuramente anche il pensiero medico e
la pratica della medicina.
Durante il tardo Impero e la prima fase del Medio Evo levoluzione del pensiero medico
influenzata da tre orientamenti prevalenti: la dottrina cristiana, che via via si va precisando e
codificando, la misteriosofia (di origine alessandrino romana) e il retaggio della cultura medica
classica.
In campo filosofico prevaleva lo scetticismo. La ragione non pu dare certezze: al massimo offre
probabilit. Per il cristianesimo la verit era la Rivelazione del Verbo, incarnato nella persona di
Cristo. E Cristo predicava lamore per i fratelli, i deboli, e assicurava il premio nel regno di Dio a
chi facesse opere di carit. Ges aveva comandato: ama il prossimo tuo come te stesso; il buon
samaritano medica le ferite e assiste il bisognoso, e Ges ancora aveva insegnato docete omnes
(insegnate a tutti). Ne conseguiva linvito allassistenza del prossimo e alla cura dellindividuo, e
anche la necessit di insegnare non solo la salvezza dellanima, ma anche ogni attenzione al
benessere del corpo: vengono istituite scuole, anche di medicina. Nascono gli xenodochi, si
potenziano le scuole imperiali, rette da funzionari civili, dove insegnavano docenti laici nelle
Diocesi, e si trasformano in scuole cattedrali rette del vescovo. Il retaggio del pensiero medico
classico cos integrato nella nuova ideologia e nella pratica assistenziale.
Tuttavia, come accade in tutte le ere, accanto alla medicina scientifico razionale coesistette,
parallela, la pratica della medicina teurgica, che anzi fu, tra le masse, la prevalente. Dio concede
direttamente la salute alluomo per le sue preghiere: ecco i santi cristiani che, come gli di pagani
danno la salute, e talora perfino restituiscono la vita. E si venerano le reliquie, si fanno esorcismi,
si celebrano processioni: nihil novi (niente di nuovo), come nella medicina dei Templi.
Allo scetticismo si contrappose anche quella corrente di pensiero che si chiama Misteriosofia
alessandrina. Questa dottrina, in modo pi deciso che la cristiana, negava alla mente umana ogni
possibilit di conoscenza: solo la rivelazione divina era la fonte di ogni conoscenza, e la rivelazione
non era terminata con lAntico e Nuovo Testamento, come per i cristiani, ma avveniva per taluni
prescelti da Dio, anche attraverso le estasi, i sogni, durante i quali venivano rivelati i meravigliosi
segreti di Dio, e insegnate pratiche esoteriche e taumaturgiche. Su questa base nascono, specie in
Oriente, le sette teosofiche, tra le quali gli Esseni e gli Gnostici.
Una parola, una formula, letta nel libro sigillato, strappato dal sepolcro di un saggio, dietro la
rivelazione avvenuta durante il sogno, aveva poteri invincibili contro ogni malattia e perfino contro
la morte.
Tra i maggiori esponenti di questa corrente ricordiamo Ermete Trismegisto (terzo sec. d. C.) mago,
astrologo egiziano. Questo pensiero deteriore della medicina ebbe culla proprio in quellAlessandria
dove nacquero le maggiori scoperte mediche e chirurgiche e di anatomia, che abbiamo conosciuto
come Scuola Alessandrina (Erasistrato 331-250 a. C. e Erofilo 340 a. C.).
31
Queste idee erano contenute nelle cosiddtte capsule eburnee, testi i cui manoscritti originari
erano ritenuti come ritrovati in cassette davorio custodite nel sepolcro del vecchio saggio che ne
era stato lautore, dietro la rivelazione, avvenuta nel sogno, che aveva guidato il prediletto
fortunato, alla scoperta del nascondiglio della tomba.
Pur in mezzo a questo dilagare di magismo esoterico persisteva il retaggio del pensiero medico
classico. In Roma e in altre citt restarono le Scuole dove era insegnata la letteratura classica anche
da uomini che avevano abbracciato la nuova religione, e con essa passava il pensiero medico dei
classici grecoalessandrini, Ippocrate, Aristotele, Erasistrato, Erofilo e i latini Celso, Plinio e
Galeno.
..
Per ragioni di pratica esposizione dei fatti storici e della evoluzione del pensiero si convenuto di
fare iniziare il MEDIO EVO con la caduta dellImpero Romano dOccidente (476 d. C.), quando
Odoacre re degli Eruli depone lultimo imperatore Romolo Augustolo e assume il potere in
Occidente col titolo di patricius conferitogli da Zenone, Imperatore dOriente. Cerano stati i
Visigoti (395) e gli Unni (452).
Il Medio Evo stato considerato come il periodo dei secoli bui, notte del pensiero, assopimento di
ogni attivit mentale; certamente questa interpretazione non si ritiene pi valida. Il pensiero
medievale dominato dalla nuova religione cristiana: dallansia di trovare la via della conoscenza
di Dio, della verit assoluta. Dei segreti della essenza, della sostanza di Dio e della Natura da lui
creata. E tenta la via della Rivelazione, del Libro. La via del soprannaturale, intrisa di
neoplatonismo, la via preternaturale della magia, la via naturale dellalchimia, dellastrologia e la
via della speculazione filosofica e, infine, la via dellesperimento alle soglie del Rinascimento.
La via del sopranaturale e della speculazione filosofica porta luomo medievale a valorizzare
soprattutto i valori dello spirito, dellanima. Il corpo talora rappresenta un peso allelevazione
mentis in Deum, e va mortificato: con cilici, flagellazioni, penitenze: amo nesciri et pro nihilo
reputaricastigo corpus meum. Ritiene lesperimento con le cose, con le creature, fallace e non
degno di essere tentato: solo Dio, il trascendente, riassume ogni conoscenza.
Alluomo non resta che ubbidire, ubbidire alla suprema autorit di Dio e alle autorit da lui
direttamente dipendenti in precisa gerarchia. Questa cultura del Medio Evo finir con lUmanesimo
e il Rinascimento.
La medicina occidentale nellepoca gota
Il regno di Teodorico (489526) fu un rifiorire culturale romano in contrapposizione della durezza
gota, ed a Boezio, Simmaco e specialmente a Cassiodoro, scelti come consiglieri, che si deve
questo riaccendersi di romanit. Durante il governo di Roma con lassistenza e i consigli di
Cassiodoro, la medicina era tenuta in grande onore arte prima tra le pi utiliallindigenza
dellumana fragilit. Venne rimesso in onore il Conte degli archiatri, giudice delle attivit dei
medici, rimettendo in auge lantica tradizione delle scuole imperiali.
Non altrettanto era nella cultura dei Visigoti, presso i quali il medico era tenuto in poco conto. Il
medico era tenuto, allinizio della cura, a garantire il buon esito di essa: se moriva un nobile dopo
un salasso, il medico veniva consegnato ai parenti che avevano il diritto di disporne secondo la loro
volont. Se moriva uno schiavo il medico doveva pagarlo al padrone.
Le vicissitudini politiche indussero CASSIODORO (490-580 ?) alla vita pubblica nel 540. Fond in
Calabria, a Squillace dovera nato, il famoso monastero detto il Vivariense (da Vivarium, localit
ricca di vivai di pesci). Era una comunit cenobitica, ricca di una biblioteca, dedita agli studi e alla
copiatura e conservazione dei testi antichi. A lui si deve la suddivisione del curriculum di studio in
trivium e quadrivium: al trivium appartenevano la grammatica, la retorica, la dialettica, al
quadrivium appartenevano laritmetica, la geometria, lastronomia e la musica. Pur governando il
32
monastero come un Abbas, non dett regole scritte, indicando solo un saggio indirizzo di vita ai
monaci.
Tra i codici conservati dai monaci di Cassiodoro vi furono testi di medicina classica: lErbario di
Dioscoride, testi di Ippocrate tra cui gli Aforismi, tradotti in lingua latina, e di Galeno. Il corpus di
cultura medica venne trasferito, dopo lincendio della biblioteca, nel monastero di Montecassino.
Negli orti del vivariense si coltivavano i semplici, descritti dagli antichi come fonte di
estrazione di medicamenti usati nella pratica terapeutica. La cura degli ammalati era in massima
considerazione e cos pure la loro assistenza, secondo gli insegnamenti cristiani. Particolare
attenzione era data alla dieta e alle condizioni igieniche.
E linizio e il prototipo della medicina monastica, che continuer con lOrdine benedettino e gli
altri ordini religiosi.
La medicina monastica
SAN BENEDETTO (480547) nato a Norcia, gemello di Scolastica, il fondatore del monachesimo
in Occidente. Fondamento e compendio delle regole scritte era il famoso ora et labora. Orazione a
Dio e meditazione dei divini misteri, ma anche lavoro, cio attivit manuale per il sostentamento
fisico dei monaci e attivit di studio delle discipline teologiche, ma anche di ogni disciplina che
tenda alla promozione delluomo, e tra esse la medicina.
Il primo di dodici monasteri, in Subiaco, lo dedic ai santi Cosma e Damiano, medici e protettori
della medicina. La regola benedettina mette avanti a tutto e sopra a tutto la cura degli infermi:
abbiano una cella particolare (isolamento), un servitore diligente e sollecito (assistenza
infermieristica), sia concesso luso del bagno ogni volta che se ne renda utilit (igiene). Scopo
primario dunque quello di curare le malattie, specie quelle interne, la cui causa non appare ai sensi e
sono pi difficili da capire con lo studio. Lenire i dolori, medicare le piaghe secondo lesempio del
samaritano del vangelo.
Il monastero era provvisto dell armarium pigmentorum, sorta di farmacia dove erano conservati i
decotti, le pozioni, gli empiastri estratti dai semplici coltivati nellorto. Uno dei monaci, il pi
adatto, assumeva i compiti specifici di assistenza nellambito della comunit: nasce cos la figura
del monachus infirmarius che conosce elementi di medicina, di botanica farmaceutica, luso dei
semplici e il metodo per estrarli dalle piante. Ben presto il monachus infirmarius sar chiamato
Medicus. Egli godeva di grande stima e dignit e la sua autorit veniva subito dopo quella dei
superiori. La continuit del sapere acquisito avveniva attraverso la trasmissione delle nozioni ad
altri monaci, configurandosi cos una sorta di scuola interna di medicina.
Come noto oltre allesercizio pratico della medicina e alla trasmissione delle nozioni mediche dei
monaci - medici fu grande merito del monachesimo la conservazione dei codici antichi del sapere
greco e latino: conservare e copiare. Tra i testi di medicina furono salvati testi di Galeno, Plinio,
Dioscoride, Sorano dEfeso, Celio Aureliano. Ben presto il medicus del monastero usc, spinto dalla
carit cristiana, dalle mura di clausura allesterno, tra il popolo a curare e ad assistere i bisognosi, i
pellegrini, i crociati: la medicina monastica diviene la medicina anche del mondo laico.
Col passare del tempo, per, lo slancio della carit dei medicifrati o dei fratimedici,
specialmente durante il periodo dei Vescovi-Conti e dei ricchi Abati e potenti del feudalesimo
monastico, venne scemando. I monaci infirmarii col pretesto della cura del corpo trascuravano la
cura dellanima, della propria e dellaltrui. Si assentavano troppo spesso e per troppo tempo dal
monastero, dediti alla professione medica pi per guadagno che per carit cristiana, laicizzati fino a
perdere loriginario spirito monastico. A partire dal 1100 si hanno i primi documenti di questa
discrepanza.
33
Del problema si occup San Bernardo tra il 1115 e il 1130 e vari concili. I medicifrati venivano
ormai accomunati ai tavernieri, ai droghieri, e le farmacie, le drogherie, i bagni e i luoghi
dellesercizio della medicina erano considerati come luoghi di turpe guadagno e di menzogna. Nel
Concilio Lateranense II del 1139 si proibisce lo studio della medicina ai monaci e al clero regolare:
medicinam non discant. I motivi sono loccasione di peccare del monaco contro la pudicizia e di
diventare preda della cupidigia di guadagno. I divieti conciliari non ebbero per che scarsi risultati:
i medici monaci continuarono la loro attivit, specie quelli degli ordini successivi a quello
benedettino: i cluniacensi, gli agostiniani, i camaldolesi e i cistercensi Anche il clero secolare
continu ad esercitare la medicina e la chirurgia.
Col Concilio lateranense IV (1215) e soprattutto con la Decretale di Onorio III, papa dal 1216 al
1227, la proibizione fu estesa a tutti i sacerdoti i quali non dovevano aver nulla a che fare con
morte e ferite. Restavano fuori dalla proibizione i chierici che non avevano gli ordini maggiori..
Cos a poco a poco finiva la medicina monastica, mentre, dopo le Scuole vescovili, sorgevano
nelle principali citt del mondo occidentale le Universit.
.
Lassistenza pubblica: ospedali e diaconie
Lassistenza pubblica era svolta, abbiamo visto, da strutture come gli xenodochi che, oltre a dare
un tetto, offrivano anche assistenza medica.
Lassistenza, la beneficenza pubblica era anche svolta dalle diaconie di cui si ha il primo accenno
da papa Benedetto III (684). Erano al principio gestite dai laici, poi dagli ecclesiastici. Cessarono la
loro opera nel XVI secolo. Vecchi edifici della Roma imperiale vennero adibiti a luoghi di ospizio e
cura. Lorganizzazione era molto simile a quella degli xenodochi, di tipo quindi ospedaliero. Talora
si trattava di semplici giacigli in stanze disadorne. La stanza, spesso unica, era rettangolare con i
letti lungo le pareti, un altare e qualche altro piccolo locale per i servizi. Presso queste istituzioni
furono molto importanti le diaconesse che vi svolgevano la preziosa attivit infermieristica.
In seguito si arriv allorganizzazione di ospedali ad opera delle corporazioni delle arti e mestieri e
ad opera degli appartenenti alle singole nazioni, che vi ricoveravano i connazionali malati o che
avessero bisogno di un tetto.
Col tempo piccoli ospedali si riunirono in pi grandi istituzioni, per opera dei Vescovi e delle
autorit civili: sorgevano gli ospedali riuniti, che, dopo circa tre secoli erano divenuti mirabili
costruzioni, veri capolavori darte tuttora presenti.
Lassistenza ospedaliera era particolarmente preziosa nel corso delle numerose pestilenze e
carestie che travagliarono il Medio Evo. Da quella che invase larmata dei Goti che assediavano
Roma nel 538, a quella che dalla Francia si diffuse in Italia nel 588, che distrusse la maggior parte
delle persone, specie in Roma. Era una pestilenza che si manifestava con petecchie e bubboni
inguinali. Vi mor il papa Pelagio II. In quellepoca furono istituite le Litanie maggiori: a peste
fame et bello libera nos, Domine. La tradizione e la leggenda riferiscono che molti morivano
starnutendo o sbadigliando (in una contrazione facciale che gli assomigliava), da allora si dice
salute a chi starnutisce. Altra pestilenza fu quella insorta a Pavia nellanno 774 durante lassedio
di Carlo Magno. E ancora in tutta lItalia e specialmente a Roma nell 856 con sintomi che
colpivano la gola e per ci fu chiamata peste anginosa. Nel 989 la peste si diffuse a Venezia. E
cos via via nei secoli fino al 1022 quando lItalia fu dimezzata della sua popolazione. E ancora nel
1093.
Miseria e pestilenze moltiplicarono gli ospedali e le opere di assistenza pubblica.
34
Le scuole vescovili, le cattedrali e le scuole laiche
Alle scuole imperiali di Roma dove, come abbiamo visto, si insegnava anche la medicina si
sostituirono le scuole medioevali di ispirazione cristiana e a gestione ecclesiastica. Il
comandamento di Cristo docete omnes, diffuso da San Paolo, da SantAgostino, dagli apologisti, e
dai padri della Chiesa, si realizzava nellistituzione delle scuole. Il linguaggio della filosofia
neoplatonica e le sue idee fecero da base alla costruzione teorico filosofica della nuova ideologia
e della nuova religione.
Dalla consuetudine che il Vescovo viveva in comunit col suo clero (SantEusebio vescovo di
Vercelli, Lucifero di Cagliari), nacque fin dal IV secolo il primo seme della scuola vescovile o
cattedrale, cattedra appunto di insegnamento, religioso e non solo. Listituzione formale delle
scuole vescovili fu sancita da un Decreto nel 798. Le aule della scuola si aprivano nel cortile della
chiesa cattedrale. Oltre alle scuole cattedrali sorsero in seguito le scuole canonicali e parrocchiali. I
monasteri avevano le loro scuole cenobiali o claustrali. In queste scuole si insegnavano le scienze
sacre e teologali, ma anche altre discipline, sullesempio delle antiche scuole imperiali, dette poi
arti liberali, tra cui la medicina, come nella scuola del Vivariense di Cassiodoro. Tra queste scuole
erano le diaconie, dove i diaconi, apprendevano ed esercitavano la medicina e lassistenza
ospedaliera. La quasi totalit della letteratura medica di quel periodo proveniva da autori della
ecclesia, dalla comunit vescovile: suddiaconi, diaconi e clerici.
Molti sono i nomi di vescovi, prima del 1000, autori di opere di medicina, che non solo ne
scrivevano, ma anche la praticavano: Teodoro di Canterbury, Isidoro di Siviglia, Benedetto Crespo
di Milano e Romualdo di Salerno, archiatra pontificio. A documentazione che nelle scuole
vescovili si insegnava la medicina valga il fatto che nella Scuola palatina di Roma, per volere di
Innocenzo IV (1243 54), oltre agli studi legali, si aggiunsero quelli di medicina, con facolt di
addottorare.
Notevole impulso alle scuole vescovili e monastiche diede Carlo Magno. Si parla appunto di
rinascita carolingia impressa dallimperatore alla cultura e alle arti. Il vero artefice e ispiratore
fu il monaco inglese Alcuino che conobbe Carlo Magno a Roma.
Sullesempio delle scuole vescovili, furono istituite, in Francia e in tutto il Sacro Romano Impero,
scuole pubbliche laiche. Il passaggio dalle scuole ecclesiastiche alla loro laicizzazione fu
progressivo: vennero inizialmente aperte delle sezioni per laici: alle scholae interiores per
ecclesiastici si affiancarono scholae exteriores per laici. Venne disciplinato il curriculum degli
studi: i due classici gruppi del Trivium e del Quadrivium vennero compresi nel Septemplice
studium: comprendente grammatica, retorica, dialettica, geometria, astronomia, aritmetica e
musica. Oltre a queste sette arti liberali, nel curriculum era certamente compreso linsegnamento
della medicina, come documenta un Capitolato dell 805.
Durante questo periodo furono istituite scuole sia in Francia che in Italia: a Pavia, Ivrea, Torino,
Verona,Vicenza, Cividale. Carlo Magno si avvalse dellopera dei Benedettini che fondarono centri
a Fulda, Lione, Tours, San Gallo, che tennero alto lonore della medicina nei primi secoli medievali.
Tra i maggiori esponenti sono San Patrizio in Irlanda, il Venerabile Beda in Inghilterra, Sant
Isidoro a Siviglia, Rabano Mauro a Fulda e San Colombano a Bobbio.
La badessa benedettina Santa Ildegarda (1108 Boeckelheim 1183 Bingem), di cultura
enciclopedica, scrisse anche di medicina: Causae et curae o Liber compositae medicinae e Physica
o Liber simplicis medicinae. Nel primo testo tratta di fisiologia, anatomia, patologia e terapia, nel
secondo di storia naturale con applicazione continua alla medicina e alla terapia, si occupa delle
piante, degli elementi, delle pietre, dei pesci, degli uccelli, dei rettili e dei metalli. Di grande fama
per la sua dottrina era interpellata da illustri personaggi non esclusi i pontefici regnanti.
35
Cos termina la storia della medicina nelle scuole svoltasi in Occidente fino all XI secolo.
Le Scuole in Occidente dopo lanno mille
Dopo il mille le scuole subirono notevole incremento e nuova organizzazione, sia che fossero
ancora legate alla cattedrale sia che fossero del tutto laiche. In esse nacquero fermenti innovativi
spinti fin quasi alleresia. Nascono in questo periodo la Goliardia e i clerici vagantes, spiriti liberi e
anticonformisti, semi del futuro umanesimo e del Rinascimento.
La Scuola era una societas, un insieme di persone, socii, una associazione, una comunit
accomunata dallo scopo di apprendere e di insegnare, un insieme di studenti e docenti, si
istituivano le prime cariche scolastiche: i magischola, i cancellieri, i decani. La disciplina della
medicina comprendeva dapprima i medici poi i magistri, i physici, i professores,fino ai doctores, la
distinzione pi alta, come per i giuristi. I discepoli, gli studenti, erano gli scolari.
Accanto alle Scholae delle societates, coesistevano anche scuole private, di un solo maestro che
raccoglieva attorno a s i suoi scolari. In queste scuole, dove si insegnava il tradizionale trivio e
quadrivio, la medicina talora assumeva la preminenza. Oltre ad essa era insegnata la filosofia, il
notariato, e le humanae litterae.
La pi importante di queste Scuole fu la Scuola salernitana.
LA SCUOLA SALERNITANA.
Le origini della pi famosa scuola di medicina del Medio Evo non sono sicure. Secondo la
tradizione e la leggenda sarebbe stata fondata da quattro maestri: Helinus (ebreo), Pontus (greco),
Adela (arabo) e Salernus (salernitanoitalico). Sono forse nomi simbolici per significare la
complessit delle fonti di cui la scuola si nutr. Alcuni la vogliono fondata da Carlo Magno. Per altri
sarebbe di origine saracena. Paolo Diacono la fa risalire al suo pi illustre maestro, Costantino
lAfricano. Altri ancora da confraternite secrete. Molto pi verosimilmente si svilupp dalla scuola
vescovile della diocesi di Salerno: i suoi primi medici infatti erano suddiaconi, diaconi, presbiteri,
episcopi, clerici: tutti titoli della gerarchia ecclesiastica secolare, ci che escluderebbe la sua
origine monastica. A riprova iconografica esiste una miniatura trecentesca che raffigura la Civitas
Hippocratica in un edificio incorporato nel complesso edilizio della cattedrale.
Si distinguono tre periodi: Primo periodo dalle origini al 1100; dal 1100 al 1300 (Periodo
costantiniano); dal 1300 al 1811 (Periodo della decadenza).
Primo periodo della Scuola salernitana
Gi alla fine del 900 i medici salernitani erano noti nel mondo occidentale, come testimonia
Richerius, dotti ed esperti pi nella pratica della medicina che nellarte delle dispute teoriche.
La letteratura medica segue la tradizione latina di Galeno di cui avevano diretta nozione, e quella
greca pure direttamente appresa dalle opere provenienti da Bisanzio. E ci prima dellintroduzione
della cultura araba in Italia. Le basi della medicina salernitana sono dunque ippocratiche. Tra i
principali maestri Guarimpoto (o Gariopoto) dell XI secolo, ritenuto ecclesiastico infatti
chiamato subdiaconus. Scrisse il Passionarius, opera enciclopedica sunteggiata da vari autori,
specialmente da Galeno. E importante perch introduce le basi del linguaggio medico tuttora in
uso: cicatrizzare, cauterizzare, clisterare. Pietro Clerico o Petrocello, contemporaneo di Guarimpoto
scrisse la Practica, opera simile al Passionario, dove non rivela nessuna influenza araba. Alfano
Primo, vescovo nel 1058, fu attivo durante lassedio di Salerno da parte di Roberto il Guiscardo.
Scrisse De quatuor humoribus di chiara derivazione ippocratica e De pulsibus. Oltre ai maestri
ecclesiastici ci furono maestri laici provenienti dalle famiglie dei Cofoni e dei Plateari. Degna di
36
nota la medichessa (o semplice levatrice?) Trotula, forse moglie di Giovanni Plateario il Vecchio,
scrisse De mulierum passionibus in ante et post partum. Di origine longobarda, bellissima, era
maestra, esaltava il ruolo delle donne in ogni fase della vita; oltre al parto tratt dellepilessia, delle
malattie dei denti e delle gengive, dellalimentazione del bambino; descrisse la tecnica della
perineorrafia e i polipi del canale cervicale.
Da ricordare lAntidotario salernitano di Anonimo, che sar la base di futuri trattati di terapia.
Riporta la spugna anestetica (oppio, mandragora, cicuta), e, per il risveglio, sugerisce succo di
finocchio nelle narici.
Secondo Periodo costantiniano della Scuola salernitana
Questo periodo inizia con la venuta in Salerno di Costantino lAfricano. Egli port in Occidente
la cultura medica di lingua araba, in un periodo in cui la citt di Salerno godeva di un florido
sviluppo politico, sociale e soprattutto commerciale che la rendeva quasi una metropoli sotto la
guida di Roberto il Guiscardo.
Nel secolo XII si ebbe un profondo mutamento nella didattica medica: rispetto allistruzione piana
e semplice e soprattutto pratica delle origini, prese sempre pi vigore laspetto teoretico, dialettico,
tipico di tutte le discipline di quellepoca. Comparve inoltre la didattica in forma aforistica di
imitazione ippocratica. La scuola era, come le altre, organizzata in Societas: soci, studenti e
maestri, accumunati dallo studio della medicina per lapprendimento e la pratica.
Ruggero II (1140) imponeva un esame, in presenza delle autorit civili, a coloro che volevano
esercitare la medicina. E Federico II (il cui segretario era (1224) Pier delle Vigne), con le sue
Decretali emanate a Menfi nel 1231 e 1241, regolamentava molto pi esplicitamente la licenza per
lesercizio della medicina: un esame davanti a una commissione di dottori.
Il corso di medicina durava cinque anni, preceduto dallo studio della logica per un periodo di tre
anni. Ai chirurghi era prescritto di frequentare almeno per un anno la specialit di chirurgia e di
seguire corsi di anatomia. La Scuola di Salerno, quindi, era una scuola riconosciuta e regolamentata
da leggi dello stato.
Costantino lAfricano, di Cartagine, considerato il maggior esponente della Scuola, anche se,
diventato monaco a Montecassino, non insegn mai nella Scuola salernitana. Fu poliglotta di
cultura enciclopedica. Tradusse in latino le opere di medicina in lingua araba, opere pervenute agli
arabi dai testi greci. Con ci ha origine la diffusione dellarabismo nella Scuola medica salernitana e
della cultura medica araba in Italia. Fu segretario di Roberto il Guiscardo. Mor a Montecassino nel
1087. La sua fama fu ambigua: a volte esageratamente esaltato, a volte denigrato fino ad essere
ritenuto dedito alla magia. Pietro dAbano, grande medico dellUniversit di Padova, ne aveva
scarsa stima: lo chiamava lapostata. La sua opera fu vastissima (22 opere), la maggior parte di
traduzione, talora con interpolazioni arbitrarie che ne alteravano loriginariet. La prima delle sue
opere fu Pantegni (Liber regius) in dodici libri, tratta dellintera arte medica allepoca conosciuta.
Tra le altre opere: Practica, Viaticum, Dieta ciborum, De urina, De ginecia.
Altri maestri, di minor fama, ma forse maggiori di lui per professionalit, furono Cofone il
giovane (1120) che scrisse De modo medendi e Giovanni Platerio II (1120) che scrisse Practica
brevis. Pi celebre Giovanni Plateario III che scrisse De semplici medicina, nota col suo incipit
Circa instans, che ritenuta tra le maggiori opere mediche in Occidente, insieme a quelle di
Dioscoride e Plinio per lo studio dei semplici vegetali.
Importante la famiglia di medici Ferrario, tra i quali Giovannaccio (1120), autore di certe pillole
artetiche, assai note al tempo, dalla pianta omonina, artetica (Ajuga chamepitys), il canapicchio,
erbacea ad azione stimolante e deostruente biliare; e inoltre Giovanni Ferrario II (1188) autore di
un trattato di cura delle febbri.
37
Altri maestri furono il Guarana (1170), Giovanni da Procida, pi noto nella storia civile per i celebri
Vespri Siciliani e Gilles de Corbeil (XII sec.) che pare abbia insegnato a Parigi, autore di due
poemi didascalici De pulsibus, ritenuti un testo classico fino al Rinascimento.
IL DOTTRINARIO della Scuola di Salerno si fonda sulla base della patologia e clinica medica
derivante dalla teoria degli umori di Ippocrate e Galeno. Oltre allinsegnamento della Anatomia
furono prevalentemente coltivate due specialit: la uroscopia e la oculistica.
Particolare interesse ebbe la Uroscopia. Gi Ippocrate, Celso, e Galeno, che ne scrisse un trattato:
De urinis, avevano messo in evidenza le diverse particolarit delle urine in relazione alle varie
malattie. Di tale pratica tuttavia si abus fino ad attribuire allesame delle urine non tanto valore di
segni di malattia quanto invece ad attribuire ad esso valore di uromanzia , di chiaro sapore di
magismo. I maggiori esponenti di tale specialit furono Maestro Mauro (1170) e Gilles de Corbeil.
NellOculistica si distinse particolarmente Maestro Zaccaria che scrisse un opera intitolata
Sisilacera, e Benvenuto Grasso (seconda met del XIII secolo) che scrisse Ars probata oculorum.
Una caratteristica che d diritto di vanto alla Scuola fu linsegnamento della anatomia, il cui studio
via via decaduto dallepoca galenica fu ripreso in questo periodo aureo della Scuola. Le lezioni
avvenivano molto probabilmente mediante dimostrazioni di autopsie di animali. Lopera pi
conosciuta la Anathomia porci di Cofone il Giovane che oper nel periodo 1085 1100. Pur non
avendo la Scuola apportato nuove conoscenze in campo anatomico, ebbe lindiscutibile merito di
averne rimesso in auge lo studio e linsegnamento.
La Chirurgia unaltra branca della medicina che trova nel Medio Evo le radici della trattatistica
futura o per lo meno limpulso al suo affermarsi. Sembra tuttavia che la chirurgia salernitana sia da
intendersi pi come attivit manuale del medico che come attivit di chirurgo, con tagli,
spargimento di sangue, suture, legature di vasi, come usualmente sintende. Pi uso di empiastri,
unguenti, unzioni, manipolazioni esterne, che uso di bisturi e scalpelli.
La vera chirurgia, in senso grecoalessandrino e moderno, sarebbe nata, come si vedr, con la
Scuola di Parma.
Della Scuola salernitana era, per altro, Giovanni Casamicciola, chirurgo militare (XIII sec.) che
praticava la legatura dei vasi sanguigni con filo di seta montato su ago, come documenta il suo
discepolo Arnaldo da Napoli.
LIgiene e la Terapia erano tenute in massimo conto: lopera pi conosciuta della Scuola e della
letteratura salernitana il famoso REGIMEN SALERNITANUM detto FLOS MEDICINAE SALERNI di
Autore ignoto e di epoca altrettanto ignota. Probabilmente molti autori vi hanno messo mano in
epoche successive. Ci sono pervenuti esemplari di 362 versi e di 3250 versi. Nellopera si possono
distinguere due sezioni: una prima in esametri latini di buona fattura, laltra in versi leonini settenari
doppi a rima baciata, di sapore popolare, probabilmente interpolati in date successive da vari autori.
Taluni esametri risultano copiati da autori estranei alla scuola. Secondo alcuni il vero Flos
Medicinae originario sarebbe composto dei soli primi otto versi originariamente dedicato a
Riccardo Cuor di Leone (III Crociata 11891192). Contiene buone regole per mantenersi sani, il
che il fondamento delligiene; consigli di comportamento per favorire le varie funzioni del corpo,
luso dei cibi, bevande, vestiario e rapporti sessuali. Il tutto frammisto a inevitabili ingenuit. Ebbe
enorme importanza non solo per tutto il Medio Evo: i suoi versi furono rispettati e citati, in varie
lingue, in tutto il mondo.
Qualche citazione dal Flos Medicinae.
Temperamenti. I sanguinipingui e giovialiprovano diletto da Venere e Bacco nei pranzi e
nel ridereVersatili in ogni cosanon si muovono allirasono allegri, sorridenti e rubicondi
muscolosi I flemmatici hanno forze fiacche, sono tarchiati ma di bassa staturamoderati in
sanguesi danno allozio e al sonnodeboli dingegno, lenti e pigri sputacchiosi faccia
grossa di colore bianco. Se una donna (gravida) ha laddome grosso e le
38
perdite grasse come amido sciolto la vulva arrotondata e le labbra rosee, dimostra che
concepito un maschioSe le labbra sono bianche e appiattite, concepita una femmina.
Igiene e dietetica. Non mangerai se non sei sicuro che lo stomaco libero e vuoto: lo conoscerai
dallappetito, allora avrai saliva sottile in bocca. Desisti dal desiderio del cibo se ti sentirai
aggravato. Prima del cibo fa del moto, dopo del cibo sii calmo: Ante prandium ambulabis, post
prandium stabis.
Fanno male le fritture, i lessati riscaldano, gli stufati restringono, purgano i cibi acri, i crudi
gonfianoI cibi piccanti infiammano gli occhi e scemano lo sperma, generano la scabbia, il prurito
e la febbre.
Il coito giova in primaveraanche nellinverno salutare. Se vuoi essere sano coisci dautunno,
restane fuori destate. Il coito usato con moderazione prolunga la vita a chi lecito, al contrario
assai dannoso. Coitus omnia curat.
Periodo della decadenza della Scuola salernitana
Dopo il 1300 inizia la decadenza della Scuola salernitana. LUniversit di Napoli, gi nel 1225
prevalse sulla Scuola. Col sorgere delle Universit la Scuola perde via via importanza: rimane di
essa pi il lustro del nome che una reale importanza di fatto; i frutti dei suoi maestri, tuttavia,
perdurano per secoli. In occasione del nuovo ordinamento della pubblica istruzione del Regno di
Napoli, con decreto del 1811, Gioacchino Murat sopprime lantica e gloriosa scuola.
Le Scuole
La Scuola di Parma
Fin dal 1200 Parma, retta dal potente governo del VescovoConte divenne uno dei pi
importanti centri culturali italiani e vantava una delle pi fiorenti scuole di arti liberali. San Pier
Damiani vi convenne nel 1025 e con lui altri illustri maestri. Anchessa organizzata in Societas vi
accoglieva fin dal XII secolo la Scuola di Medicina, con propri statuti (1294) e con facolt di
addotorare: la sua fama era seconda solo a quella di Salerno. La cultura medica italiana, anche nella
branca chirurgica, aveva propri mezzi per alimentarsi, ancor prima dellapporto arabistico.
Esistevano nelle biblioteche dellepoca le opere di Celso e degli altri classici greci e latini, e poteva
acquistare le opere greche provenienti da Bisanzio, attraverso la vicina Ravenna. Celso, Paolo
dEgina e Oribasio (del tardo Impero Occidentale) che avevano alimentato la cultura araba, avevano
direttamente influenzato la cultura italiana.
La chirurgia della Scuola di Parma, tuttavia, da considerarsi autoctona perch, pur influenzata
dalla cultura greco - latina, era figlia della pratica quotidiana dei maestri di Parma. Guido dArezzo,
medico, allievo di Ruggero da Parma, redasse lopera Cyrurgia Magistri Rogerii divisa in quattro
parti, a loro volta divise in capitoli, il cui incipit Post Mundi fabricam divenne una specie di
intitolazione dellintera opera. Vi messo in ordine il materiale prezioso dellattivit pratica di
Ruggero e di altri maestri di chirurgia (1180). Dopo pochi anni lopera fu commentata dai doctores
salernitani che vi introdussero elementi arabistici. Il suo allievo Rolando da Parma la aggiorn
apportandovi proprie additiones.
Rolando da Parma, di cui si ignorano i precisi dati anagrafici, pass da Parma a Bologna di cui
acquist la cittadinanza, insegnando in quella Scuola. Fu anchegli autore di unopera di chirurgia,
la Rolandina, nella quale segue fedelmente le tracce del suo maestro. Anche la Rolandina fu
glossata a Salerno: ne deriv un dotto commento di influenza arabistica, meno genuino dellopera
39
originale, frutto della pratica operatoria. Vi si tratta principalmente della chirurgia durgenza: larghe
ferite toraciche, e toracoaddominali, ferite addominali, ernie strozzate, fratture craniche e lesioni
ossee per erosioni tumorali. Rolando praticava la sutura dellintestino introducendo nel lume un
cannello di sambuco. Notevole era il suo armamentario: scalpelli, trapani, aghi. Notevole la tecnica
della posizione inclinata a capo basso nelloperazione di ernia: posizione che oggi si chiama di
Trendelemburg.
La Scuola di Bologna
Della Scuola di Bologna, rinomata sopratutto per gli studi giuridici dispirazione romanico
giustinianea, si ha menzione di un tale Pepo, insegnante in essa nel 1090. Vi si coltivarono tuttavia
anche la medicina e le arti liberali fin dai tempi di Onorio III (1216 1227) che proib, come
abbiamo visto, agli ecclesiastici di frequentare i corsi di medicina. Tra i Maestri, degno di memoria
Jacopo da Bertinoro (1199), che per primo assunse il titolo di Magister. Ugo da Lucca fu
chirurgo insegnante di chirurgia, e medico condotto, la cui figura appare nel 1300 in epoca
comunale: era il medico del Comune, aiutato nel disbrigo delle pratiche chirurgiche da qualche
empirico. La massa dei guaritori era di gran lunga superiore allesiguo numero di medici delle
scuole. Anche la scuola bolognese era organizzata come Societas, nella quale, col tempo, la
corporazione degli studenti ebbe il sopravvento su quella dei maestri, primo seme del sorgere delle
Universit.
La Scuola Palatina di Roma
Era la Scuola della Curia Pontificia istituita da Onorio III per consiglio di San Domenico. Si
occup di materie filosoficoteologiche, ma in seguito sicuramente anche di diritto e di medicina.
(Innocenzo IV, 1243).
La Scuola di Parigi
Nacque nel chiostro di Ntre Dame come scuola cattedrale con Guglielmo di Champeaux (1070-
1121) che si occupava pi di sillogismi in competizione con Abelardo che di medicina. Si pu
tuttavia presumere che vi fosse insegnata anche la medicina se Carlo Magno, nell 805, ne aveva
introdotto lo studio in quella scuola cattedrale. La scuola prese forma corporativa di insegnamento
nel 1170 e gli statuti furono approvati nel 1210 da Innocenzo III. Gi nel XII secolo aveva titolo di
Scuola, con un Decanus e un Cancellarius. Gli studenti vivevano alla meglio, al loro mantenimento
concorsero anche gli ospedali, tra i quali lHtelDieu presso Ntre Dame. Da questa Scuola
nacque nel 1200 lUniversit.
La Scuola di Montpellier
Fu rivale di Salerno, non se ne conoscono in modo preciso le origini. Montpellier divenne vera
citt solo nel 1150: sita sulla via dei pellegrini al santuario di San Giacomo di Compostela, ne
sorsero di conseguenza le strutture ospedaliere. La sua origine rabbinica di provenienza spagnola
non sembra certa. Tuttavia attorno al 1000 un allievo di Rabbi Abbor avrebbe compilato lopera
Guerison de Montpellier. Verso la fine del XII secolo Guido vi fond un ospedale, retto da un
ordine ospedaliero, che si pose in concorrenza con i medici locali. Nel 1180 Guglielmo VIII,
signore di Montpellier, dava facolt agli arabi e agli ebrei di frequentare la Scuola di medicina.
Per la sua particolare attenzione agli studi medici fu considerato lideale fondatore dellUniversit.
40
La Scuola di Oxford
Solo nel IX secolo Oxford assunse fisionomia di citt, divenendo poi importante centro
commerciale lungo la via del Tamigi. Nel 912 fu fortificata. Che vi sia stata una Scuola di medicina
in epoca pre universitaria probabile, ma non esistono documenti. Di certo si sa che nel 1209
erano 3000 tra studenti e insegnanti i componenti dellUniversit, probabilmente inglesi provenienti
da Parigi.
La Scuola di Cambridge
In questa citt non esistevano istituzioni paragonabili alle scuole. Solo con limmigrazione di
studenti e professori da Oxford (1209) nacquero le prime Scuole, che ben presto divennero la
Universit.
La Scuola di York
Fu la pi antica e quotata delle scuole inglesi dellalto Medio Evo. La sua fondazione si fa risalire
al Vescovo Wilfrido, uomo di grande cultura classicoromana (634709).
Era una Scuola cattedrale nella quale insegn anche il monaco benedettino Egberto, anchegli di
formazione romana, amico di Alcuino che pure studi in quella Scuola. Come nelle altre scuole
cattedrali probabile che vi si insegnasse anche la medicina.
41
La medicina in Oriente, dal tardo Impero agli Arabi
Nel 330 Costantino, rimasto unico Imperatore sia dOriente che dOccidente, trasferisce la
capitale a Costantinopoli costruita sulla vecchia Bisanzio. Alla sua morte (337) limpero viene
diviso tra i suoi figli. Giuliano lApostata (361363) tenta di realizzare lutopia di restaurare la
cultura grecolatina contro la nuova religione cristiana. Il suo successore Teodosio (379 395)
riesce a concentrare nelle sue mani il potere sia dellOriente che dellOccidente, favorendo
lunificazione dei cristiani in continua espansione, anche ad opera dei Padri della Chiesa. Nel
Concilio di Efeso (431) fu condannata leresia di Nestorio. La sua eresia continu tuttavia a
diffondersi, specialmente tra i barbari, presso i quali si svilupp il monachesimo nestoriano che
ebbe importanza nellassistenza ospedaliera.
La citt di Alessandria, gi culla della cultura classica (Erofilo, Erasistrato), divenne in questo
periodo il centro della nascita e diffusione della Misteriosofia, della Gnosi e di altre sette, molto pi
attive che in Occidente, dove pure si espansero e influenzarono lesercizio della medicina.
Alla Misteriosofia e alla Gnosi si oppose il cristianesimo ortodosso, specialmente in Oriente ad
opera del Padri della Chiesa. Nelle loro operegli Exameron e le Omeliei Padri della Chiesa
trattarono soprattutto di teologia in senso apologetico, ma si occuparono, di riflesso, anche
delluomo, della sua anima, e della sua fisiologia e anatomia, e dei migliori modi per mantenerlo
sano, integro, e di curarlo.
La medicina patristica
San Basilio, vescovo di Cesarea di Capadocia (329-379), nei suoi Exameron, piccole enciclopedie
(331), tratta oltre che di teologia, di fisica, botanica e di medicina.
San Clemente Alessandrino (morto nel 271) nel suo Pedagogo tratta soprattutto di igiene: sulluso
moderato dei bagni del corpo a scopo di pulizia, sullutilit della ginnastica, sullabuso dei cibi.
Tratta di cosmesi: condanna la tintura delle ciglia, sopracciglia e palpebre, le pomate contro la
calvizie, la biacca e i belletti.
Nemesio (vescovo di Emesa IV sec) fu il pi famoso: sembra addirittura avere intuito la
circolazione del sangue, quando afferma che esso passa dalle arterie alle vene. In effetti ripete le
idee di Galeno e di Aristotele. In fisiologia segue i classici: quattro elementi, quattro umori, tra loro
simili e contrari. Prende in esame gli organi di senso e le sensazioni, e larchitettura del sistema
nervoso, ma non va oltre Galeno. Tratta dellalimentazione e della trasformazione del cibo in
sangue ad opera del fegato; assegna al sudore la funzione di raffreddamento della cute.
Firmiano Lattanzio (Africa, seconda met del II secolo) mor a Treviso nel 325. Fu detto il
Cicerone cristiano. Nel suo De opificio Dei sostiene che il sangue il fondamento della nutrizione
di tutto lorganismo. Esso si forma nello stomaco e in tutto lintestino per trasformazione degli
alimenti. Accenna alle illusioni ottiche, al mutismo e alla sordit. Sinterroga sulla funzione del
peritoneo, della milza e della bile, e sul modo con cui i reni secernono gli umori. E inoltre sulla
natura delle ossa e sulla formazione delle articolazioni, e sulla localizzazione del gusto.
La medicina bizantina
Su queste basi si form quella che fu chiamata la medicina bizantina, non solo per la sua origine in
Bisanzio, ma anche per peculiari particolarit. Fu in auge nella nuova sede imperiale e in genere
nellOriente fino al VII secolo e fu rappresentata dai quattro suoi maggiori esponenti: Oribasio,
Ezio, Alessandro dEfeso e Paolo dEgina che, tuttavia, si alimentarono dei classici greco
alessandrini e dei latini, primo fra tutti di Celso. La letteratura bizantina passer in seguito agli
Arabi i quali pure direttamente attinsero dai classici. Una particolarit stilistica di questa letteratura
il metodo disputatorio, dialettico, appunto bizantino, per cui, dice Gregorio di Nissa, fratello di
42
San Basilio,: Se a Costantinopoli si chiede a qualcuno di barattarvi del danaro, questi comincia a
dissertare sulla differenza che passa tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo che pure da esso
procede.
Oribasio (325403) fu amico e medico personale di Giuliano lApostata. Compil in 70 libri le sue
Sinagoghe, riassunto di tutte le maggiori opere di medicina esistenti; ne rimangono 25 libri. Le sue
idee si fondano sul dottrinario di Galeno, ma attinge ugualmente da Aristotele, Aslclepiade, Sorano,
ecc. Tratta di igiene, sia dellindividuo che dellambiante, di idrologia, di anatomia, fisiologia e
chirurgia. Riassume la sua opera in Synopsis, ben presto tradotta in latino, in nove libri. Vi tratta di
patologia interna e esterna, di semeiotica e di terapia. Di terapia tratta in modo specifico nella sua
Euporista con la quale fa opera di divulgazione dei medicamenti di pi facile reperimento. Fu
coltissimo ed espertissimo medico pratico. Cur bene una ferita da freccia al fegato di Giuliano
lApostata, che per, strappatesi le bende, ne mor. Fu allora mandato in esilio tra le genti pi
rozze, selvagge e pi barbare, i Goti. Poi, per, fu richiamato in patria e colmato di onori e
ricchezze.
Ezio (Aezio) del VVI secolo, visse durante il regno di Giustiniano. Scrisse opere di
compilazione. Come limperatore ordin le leggi dello stato nel Corpus juris, cos Ezio compendi
il sapere medico, di prevalente impronta galenica, nei suoi Sermoni. Si trova anche qualche
intuizione: per primo fa menzione delluso della canfora e dei chiodi di garofano. Riserva tuttavia
molta importanza anche alle formule magiche di ispirazione cristiana.
Alessandro di Tralles (presso Efeso) visse dal 525 al 605, fu compilatore di opere di medicina, ma
anche buon osservatore dei malati e delle medicine. Fu autore dei Dodici libri di medicina, di un
trattato Sulle febbri e di una Lettera sui vermi, opere che, mutile, in parte sono andate perdute come
i tre libri di oculistica e un trattato delle fratture e dei traumatismi della testa. Da ricordare i suoi
studi sul sistema nervoso e nelle patologie dellapparato respiratorio, tra cui la pleurite e lemoftoe.
Tratta inoltre le malattie dellintestino e dello stomaco, le parassitosi e la gotta. La diagnostica
trattata con precisione e pure, per lepoca, la diagnosi differenziale. La sua opera fu tradotta in
latino e in arabo, diventando uno degli autori preferiti dagli arabi. Anchegli fu propenso
allinvocazione ieratico magica, quando falliva la scienza.
PAOLO DEGINA (isola di fronte ad Atene) 620680. Fu il pi noto tra i medici bizantini,
consultato e copiato dagli arabi soprattutto per la chirurgia. Studi non solo la medicina, ma tutte le
scienze; viaggi molto: fu in Italia e soggiorn a Roma. Delle sue opere ci rimane De medicina in
sette libri.
Anche questa opera un riassunto di antiche opere classiche con laggiunta di qualche
osservazione derivatagli dalla pratica personale; la materia esposta in modo netto e preciso. Tratta
dellarte di conservare la salute, delle febbri, delle malattie interne e di patologia esterna, dei morsi
e dei veleni, di chirurgia, di medicinali semplici e composti. La pi interessante delle sue opere il
libro dedicato alla chirurgia, che fu il testo basilare degli arabi, specialmente per Albucasis. In
questopera sono riportate per intero tutte le conoscenze in materia della medicina bizantina. Vi
trattato il carcinoma dellutero e della mammella, lascesso del fegato, che va cauterizzato: ubi pus
ibi evacua. E le malattie della vescica da trattarsi con cateterismo e lavaggi medicati. Tratta
dellintervento per lernia inguinale e scrotale, della castrazione, di fistole anali, di emorroidi e di
varici. Intu inoltre che lulcera gastrica era di origine acida, e per ci proibiva i cibi acidi. Fu
ottimo ostetrico: assisteva personalmente le partorienti invece di delegare lassistenza al parto alle
levatrici.
La sua opera, specie il trattato di chirurgia resistette a lungo. Fabrizio dAcquapendente, nel 1592,
la tiene come fondamento della sua opera chirurgica. E ancora nel 1607, la Facolt di Medicina di
Parigi richiedeva il commento del VI libro della sua opera per linsegnamento della chirurgia.
43
Attuario Giovanni, medico di corte a Costantinopoli nellultima parte del III secolo, fu lautore
del miglior trattato di urinoscopia dellantichit. Nel suo De urinis sostiene che lesame dellurina
un momento di diagnosi, non come gli urinoscopisti posteriori che arrivarono a darne valenza di
uromanzia. Sostenne inoltre che i disturbi mentali possono dipendere direttamente da cause
organiche come laffaticamento fisico, consigliando opportuna dieta, bagni ed esercizi fisici, invece
di esorcismi.
Gli ospedali in Oriente
Anche questa forma di assistenza pubblica sorse in Oriente sotto la spinta della religione
cristiana, per gli stessi motivi del suo nascere in Occidente. Anche in Oriente nasce nei monasteri.
Il primo monastero fu fondato nel 305 da Sant Antonio Abate (251-356) del medio Egitto. Altri ne
furono fondati nel 320 da San Pacomio (292-348). Nei monasteri era esercitata la medicina e
lassistenza infermieristica che era tenuta in grande onore. Gli addetti furono i precursori dei
monachi infirmarii dei Benedettini in Occidente. Anche San Basilio, vescovo di Cesarea, d molta
importanza, nella sua Regola maggiore, allassistenza degli infermi. Costru un grandioso ospedale,
la Basiliade, vera e propria citt ospedaliera. Xenodochi, ospedali, furono costruiti anche da San
Gregorio Nazianzeno e da San Giovanni Crisostomo. E lebbrosari per la raccolta di quei relitti
umani che la religione cristiana imponeva di assistere.
Un cenno meritano gli ospedali costruiti dai Nestoriani, cristiani eretici, diffusi soprattutto tra i
barbari dOriente. Di essi un tale Giorgio diresse lospedale di Bagdad nel 765.
Lorganizzazione della medicina in Bisanzio
Lorganizzazione della medicina nellepoca bizantina ricalcava fedelmente quella della Roma
imperiale. Esistevano gli Archiatri di Palazzo e gli Archiatri popolari. Gli archiatri palatini erano
veri e propri medici di corte, ben pagati, molto onorati, dalle sontuose vesti e vistose insegne.
Avevano il controllo sugli altri medici popolari che esercitavano nel territorio. A questi, eletti dal
municipio, erano affidati i poveri. Esercitavano la medicina anche altri, non investiti di autorit, e
dediti alla cura dei diseredati. Dal Corpus juris di Giustiniano si desume lo stato giuridico dei
medici: un vero privilegio loro concesso. Per la prima volta riconosciuta la personalit giuridica
del medico. Lesercizio dellarte regolato da norme che fissano doveri e diritti nellesercizio della
professione.
Dopo il periodo giustinianeo si delinea la decadenza della medicina bizantina: si affacciano gli
Arabi.
44
LA MEDICINA DEGLI ARABI
Nei primi secoli del Medio Evo, abbiamo visto, il sapere greco e latino, detto classico, pur
permeando di s le successive e diverse civilt, restava confinato nelle biblioteche dei monasteri.
La civilt cristiana si era diffusa in tutto il mondo occidentale e orientale.
Il mondo arabo, unificato in nazione da Maometto (571632) e animato dalla forza espansiva di
quel popolo divenuto islamico, diffuse, fin dalla nascita dellislamismo, la sua potenza, il suo
dominio e influenza dallOriente su tutto il mondo occidentale.
Nelle terre conquistate in Oriente, gli arabi avevano trovato citt con centri di grande importanza
culturale e scientifica: Alessandria in Egitto e Gondisciapr in Persia.
Ad Alessandria, conquistata nel 642, vennero a contatto con lErmetismo, la Gnosi e la
Misteriosofia. Dal contatto della cultura araba mediterranea con lErmetismo (Ermete Trisgemisto)
avrebbe tratto linfa la nascita dellAlchimia. A Gondisciapr i seguaci di Nestorio, col rifugiati, e i
neoplatonici cacciati da Atene (dovera fiorita una scuola) da parte di Giustiniano (529), fondarono
nuove Scuole che recavano in s lantica eco della civilt greca. Da questa gli Arabi appresero la
medicina, la filosofia, le matematiche e lastronomia. La loro indole intelligente e riflessiva ne fece
dei cultori appassionati: sorsero accademie, scuole, ospedali e centri culturali celebri come quelli di
Bagdad e Samarcanda.
Ugualmente in Occidente sorsero scuole a Cordova, Siviglia e Toledo. Il maggior risveglio si ebbe
a partire dal IX secolo, quando si fuse la cultura visigotica con lelemento ellenizzante nella Scuola
di Siviglia, fondata da Sant Isidoro.
Cos imbevuti di cultura classica, o che per lo meno apparteneva al classicismo, gli Arabi
elaborarono quella caratteristica del pensiero medico arabo che doveva dare impronta indelebile.
La cultura medica araba fu, in parte, preesistente allislamismo, di base greco latina, ma con
influenze egizie ed ebraiche. Lespansione islamica ne facilit la diffusione e il potenziamento.
Il Corano contiene numerose norme di igiene e di medicina; sembra che Maometto stesso, erudito
nellarte di guarire, abbia in qualche circostanza esercitato la medicina.
La storia della medicina araba si svolge nei due Califfati: dOriente e dOccidente. Il Califfato
dOriente con citt principale Bagdad, fondata nel 762, svilupp le famose Scuole di Bagdad e di
Gondisciapur. Il Califfato dOccidente con citt principale Cordova, che divenne centro politico e
culturale e, al massimo del suo splendore contava 300.000 abitanti e poteva gloriarsi di 50 ospedali,
900 bagni, 800 scuole, 600 moschee e 70 biblioteche private, oltre alla ricchissima biblioteca
pubblica con 300.000 volumi.
I due califfati, in emulazione tra loro, contribuirono al rigoglioso fiorire della civilt araba.
Per quanto riguarda la Medicina, la produzione della letteratura era prevalentemente medico
scientifica nel Califfato dOriente, mentre nel Califfato dOccidente era piuttosto improntata a
concezioni filosofiche.
45
Dottrinario della Medicina araba
Il dottrinario della medicina araba ha per base fondamentale i concetti della medicina classica
greca e latina. Si fonda sulla concezione umorale, ippocraticogalenica: le affezioni sono calde,
fredde, umide, secche, di primo, secondo e terzo grado. Un nuovo elemento viene introdotto, la
astrologia. La medicina astrologica sar presente in tutto il Medio Evo. Notevole importanza
assume lesame del polso, con prognostici spesso del tutto esorbitanti, e dellesame dellurina che
prese il carattere di vera uromanzia. In genere per i medici arabi, nei loro massimi esponenti,
furono animati da severo spirito scientifico, attenti e intelligenti osservatori, spesso liberi da influssi
di scuole e di autorit, pronti a difendere le loro idee anche contro i classici. Molta importanza fu
data alle malattie dei bambini. In sintesi si pu dire che la medicina araba non fu semplice opera di
compilazione di opere di derivazione classica, ma vi furono anche intuizioni originali, frutto della
pratica e del metodo di ricerca con fondamento empirico, sia pure con tendenza, in generale, al
filosofismo e alla interpretazione meravigliosa dei fenomeni, e ci specialmente da parte della
massa dei medici arabi minori.
Lanatomia fu pochissimo coltivata, forse per le proibizioni di carattere religioso: le nozioni
anatomiche dei medici arabi sono esclusivamente quelle derivate dalla medicina classica e
bizantina. Anche la chirurgia essenzialmente quella appresa dalla traduzione dei classici,
specialmente da Paolo dEgina. Anche Albucasis, il maggior esponente della specialit, poco vi
innov del sapere classico. Di notevole importanza luso del cauterio come tagliente: si potevano
incidere i tessuti senza spargimento di sangue, come imponeva la nuova religione, e le ferite
cicatrizzavano meglio, disinfettate dallalta temperatura. Il suo uso era estesissimo, fino quasi a
sostituire le lame taglienti. Lo strumentario chirurgico si arricch di nuove forme dei tradizionali
ferri chirurgici: seghe a segmento di cerchio, a falce, a taglio retto e curvo, forbici, sonde. Compare
il cranioclasto per lestrazione della testa fetale nella sproporzione cefalo pelvica di feto morto:
precursore del forcipe per il feto vivo. Una branca particolarmente coltivata fu loculistica, forse per
la frequenza delle malattie degli occhi di quel popolo.
La terapia ebbe notevole impulso. Si scopersero propriet medicamentose di nuove piante e si
introdussero nuovi metodi estrattivi. Entrarono nelluso lalcool, lo sciroppo, lelisir, la canfora,
lhascisc, il mirabolano, la nafta, il giulebbe (sciroppo aromatizzato e zuccherato), il bezoar,
misterioso antidoto universale, e nuove sostanze che tuttora portano il nome arabo. Si ottennero gli
ossidi metallici, il sublimato corrosivo (cloruro mercurico Hg Cl), lacido solforico, lacido nitrico,
lacqua regia per sciogliere loro, il nitrato dargento.
Tecniche alchimistiche, passate poi nella chimica, permisero la distillazione, mediante
lalambicco, e la digestione di sostanze; fu usato il bagnomaria. Si sfrutt la sublimazione, la
filtrazione e la concentrazione delle sostanze.
Si inizi luso di elenchi di farmaci, di medicinali, riconosciuti dalle autorit superiori, a garanzia
della proporzione e composizione delle ricette: prototipi delle moderne farmacopee. Aument il
numero di piante medicinali da cui estrarre i semplici: abbiamo gi ricordato la canfora (dal
canforo, albero del genere cinnamomo) e lhascisc dalla Cannabis indica, il mirabolano; ora citiamo
la noce moscata (pianta miristica), la noce vomica (da cui la stricnina), il seme santo (da cui la
santonina). Da citare il bezoar, medicamento di origine animale: concrezioni calcari formatesi nel
tubo digerente, lisciate e lucidate, erano ritenute antidoti universali, ricercatissimi, avevano alti
prezzi. Questa pietra rimase a lungo in uso, assumendo significato magico.
46
Accanto ai medicamenti ricordati, di sicura attivit medicinale, coesisteva limpiego di pietre ad
uso terapeutico alle quali erano attribuiti potere e virt nascoste. I lapidari elencavano gemme,
pietre preziose, gi presenti allepoca romana e alessandrinoromana. Ugualmente accanto alla
medicina empirica (scientifica), prosperava la medicina astrologica con la produzione di talismani,
capaci di
neutralizzare gli influssi malefici degli astri. E ancora altri arcani influssi maligni erano scacciati
da una pratica occultistica, una pseudo scienza degli abracadabra, degli sciabriri, sui pentacoli, sui
sigilli di Salomone, eredi del peggiore alessandrinismo della misteriosofia. .
Principali esponenti della Medicina Araba
Per comodit espositiva si divide in tre periodi la storia della medicina araba. Dall VIII secolo
all 850 il primo periodo; dal X al XIII secolo il periodo doro, dal XIII secolo il periodo della
decadenza.
Primo periodo
I primi medici di lingua araba furono il tramite tra lelemento greco alessandrino e quello arabo
propriamente detto. Si fa menzione di un certo Harn, prete cristiano di Alessandria, visse nel VII
secolo, contemporaneo di Paolo dEgina. Scrisse una silloge in trenta libri, le Pandette che
racchiudeva tutto lo scibile medico, la prima di origine ellenica a venire nelle mani degli Arabi.
Segue per intero la medicina classica e sembra che abbia descritto il vaiolo.
Il principale esponente di questo periodo Johannitius, (Hunain Ibn Ishaq), allievo di Mesue della
scuola nestoriana. E importante per aver dato fonetica araba a vocaboli medici greci e persiani, e
per aver tradotto Ippocrate, Oribasio, Paolo dEgina e Dioscoride. Nel dottrinario segue il pensiero
classico, tra le sue opere originali sono da citare Questioni della medicina e Dissertazioni
sullocchio.
Serapione il vecchio (Jbya Ibn Serafyn) del IX secolo, fu cristiano e scrisse in siriano. Studi la
cefalea, la lebbra, lidrofobia e i fenomeni isterici. Fu autore di numerosi aforismi.
Secondo periodo
Questo periodo costituisce lapogeo della cultura medica araba. Vi appartengono Rasez, Avicenna
e Albucasis.
Rasez, tra i migliori esponenti della medicina araba, nacque nell 850 presso Teheran, mor tra il
903 e il 923. Studi alla scuola di Bagdad dove poi diresse il famoso ospedale. Lopera medica pi
importante venne tradotta con il titolo Continens, grandiosa enciclopedia dedicata alla terapia con la
quale riassume tutto il dottrinario medico arabo, arricchito dalla sua personale esperienza. La sua
opera pi nota il Liber medicinalis ad Almansorem, di dieci libri dove tratta di anatomia, di
temperamenti, di dietetica, di terapia, di igiene, di cosmetica, di chirurgia e di tossicologia. Il nono
libro, Nonus Almansoris, tratta delle malattie in generale. Molto noto e forse il pi originale fu il De
pestilentia dove fornisce la prima trattazione del vaiolo che distingue dalla varicella, ne indica la
terapia e la profilassi nonch la cosmesi delle cicatrici. La sua personalit scientifica rivela
originalit di vedute, libert di indagine espressa in forma aforistica: La verit in medicina meta
che non si pu raggiungerequando Galeno e Aristotele vanno daccordo faciledifficile
quando sono in disaccordo. Chi interrogher molti medici commetter molti errori.
AVICENNA (Bukara 9801037) fu reputato il principe dei medici arabi. Dintelligenza precoce
studi tutte le scienze. Nella sua opera il Canone coordina tutto lo scibile di Ippocrate e Galeno con
quello di Aristotele, aggiungendovi il frutto della personale esperienza. E la summa non solo
delle nozioni della medicina araba, ma anche di quella occidentale. Questa opera ebbe valore
47
dogmatico per tutto il Medio Evo, fino al Rinascimento e oltre. Lopera divisa in cinque libri,
distinti in capitoli e paragrafi. Tratta di patologia generale e di terapia sulla base di Dioscoride.
Nella trattazione le malattie sono divise tra quelle che interessano le varie regioni anatomiche e
quelle che interessano tutto lorganismo simultaneamente, come la febbre, il vaiolo, il morbillo. Vi
si tratta di chirurgia, di fratture e lussazioni. Nel quinto libro, Antidotarium, si tratta della
composizione dei medicinali, un vero trattato di farmacologia. Nel suo Canone offre descrizioni
precise e chiare: Nella pleurite il dolore puntorio, violento sotto le costole che qualche volta
si manifesta solo quando il malato respira forteTerzo segno la difficolt del respiro e la
frequenza, il polso rapido e debole; la tosse al principio secca, poi con sputo, allora significa che
c affezione del polmone. Tratta in modo preciso di molte malattie e stati morbosi la cui
descrizione resiste ancor oggi: del cancro della mammella, delluso del forcipe, cranioclasto, per
lestrazione del feto morto; della nefrite cronica; della paralisi del facciale, centrale e periferica; del
meningismo secondario ad altre malattie; dellittero, tossico ed emolitico; della tubercolosi come
malattia contagiosa.
Scrisse il trattato De anima allinizio dellXI secolo, tradotto alla met del XII. Assieme al trattato
di Aristotele e al commento che ne fece Averro, riapr in Occidente la questione dellimmortalit e
dellessenza dellanima. La sua opera pose problemi ai filosofi, ai teologi e ai medici. Gli
anatomisti della Scuola di Alessandria avevano scoperto che i nervi erano il veicolo della facolt
del tatto, e i nervi facevano capo al cervello, che diventava quindi sede dellanima, non pi il cuore
come per Aristotele. Il Medio Evo occidentale, sollecitato da questo trattato, discuteva di problemi
simili a quelli della psicologia e della neurologia moderna: come si forma la memoria, come si
immagazzinano le informazioni, dove ha luogo la ragione (la ratio, la psiche) umana, come avviene
il processo di astrazione. Non risparmia, tuttavia, nessuno dei fenomeni pi misteriosi e pi
importanti nella visione religiosa del mondo: la profezia, la stregoneria e la terapia magica.
Mor forse di cirrosi epatica, dovuta alla sua passione per lalcool, allora inventato.
Albucasis (Cordova 10131106). Fu il pi abile chirurgo di tutta la storia della medicina araba e
tra i pi sapienti medici. La sua opera di medicina e chirurgia, Al-Tasrif, tradotta col titolo di
Practica, in 30 volumi, contiene nella parte che riguarda la chirurgia, tutto lo scibile che fu la base
di tutta la pratica chirurgica delloccidente. D molta importanza allemostasi, da ottenersi
principalmente col cauterio. Tratta delle fratture vertebrali e della trapanazione del cranio, della
tracheotomia nel gozzo, delle malattie delle arcate dentarie e di otologia (studio dellorecchio), della
sciatica, della lussazione dellanca e perfino del raffreddore. Molto importanti sono le sue
riproduzioni iconografiche degli strumenti chirurgici. Va ricordato e sottolineato che la sua opera
chirurgica tratta dai libri di Paolo dEgina, pur con aggiunte e interpretazioni personali. Utilizz in
terapia tutte le nuove produzioni farmaceutiche di cui si disse nel Dottrinario.
Da ricordare in questo periodo Ibn Wafid (9771074) di Toledo, medico ospedaliero si distinse
soprattutto per la terapia basata sulla dietetica.
Ishaq di Cordova (880940), era ebreo e si interess di dietetica assegnando grande valore
nutritizio alla carne, compresa quella di maiale che ritenne alimento sanissimo. Si occup anche di
febbri e di esame durina.
Terzo periodo
Con la conquista di Cordova da parte di Ferdinando II di Castiglia (1236) e la distruzione di
Bagdad da parte dei Mongoli (1258), inizia la fine della potenza politico militare araba, ma non si
esaurisce la loro cultura. I maggiori maestri di questo periodo furono Avenzoar, Averro e
Maimonide.
Avenzoar (Siviglia 11131162) fu detto il Saggio, libero da pregiudizi, os attaccare lautorit di
Avicenna e perfino di Galeno. La sua medicina ebbe indirizzo prevalentemente pratico: descrisse la
48
pericardite sierosa, lascesso mediastinico, la paralisi faringea, le otiti. Gli fu attribuita anche la
descrizione dellacaro della scabbia che sembra fosse gi stato descritto dal Al Tabari nel X secolo.
Si oppose allastrologia e al misticismo in medicina, e tenne divisa la pratica medica da quella
farmaceutica e chirurgica.
Averro (Ibn Rushd) (Cordova 11261198) fu tra i pi illustri filosofi e medici della cultura
araba in occidente. Scolaro di Avenzoar, fu notissimo come colui che il gran commento feo alle
opere di Aristotele, dove espone la sua teoria filosofica nota col nome di averroismo. La sua opera
fondamentale fu il Colliget, enciclopedia di scienze mediche nella quale tratta di anatomia,
patologia, fisiologia, semeiotica e farmacologia. Nel trattare di terapia si dichiara contrario alla
polifarmacia, alluso cio di introdurre troppi medicamenti e ingredienti in una ricetta.
Maimonide (Cordova 11351204). Ebreo, perseguitato e peregrino per la Spagna e la Palestina,
giunse al Cairo dove pot dedicarsi agli studi. Studioso di filosofia e di religione, fu tra i pi quotati
talmudisti. Fu autore di un libro di Aforismi o meglio di un commento sugli aforismi di Ippocrate.
Scrisse il Regimen sanitatis per cui divenne famoso, tanto da essere invitato da Riccardo Cuor di
Leone alla corte inglese e divenire medico del Gran Visir. Da ricordare unoperetta intitolata Ars
coeundi e un trattato sui veleni e sugli antidoti. Intravide, nelle malattie, i rapporti tra psiche e
soma. Consigli luso delloppio in unguenti sedativi.
Degno di nota Ibn an Nafis, morto nel 1288. Sembra che abbia avuto lintuizione della
circolazione nel piccolo circolo polmonare: il sangue per giungere dal cuore destro al cuore sinistro
doveva percorrere la via dei polmoni e non passare tra i pori del setto interventricolare come
pensava Galeno.
..
La cultura araba caratterizzata dallimportanza data allo stile di vita, al riconoscimento della
superiorit della cultura classica greco alessandrina e cristiano occidentale, oggetto di studi e
traduzioni. Gli Arabi curarono particolarmente la medicina, creando centri culturali, biblioteche,
ospedali, organizzazioni di copiatura e scuole. Il medico e la sua opera furono valorizzati al
massimo. Anche larte dellassistenza infermieristica, specie negli ospedali dove veniva insegnata
la medicina. Presso le Moschee sorgevano ospedali e poliambulatori. I Califfi se ne occupavano
personalmente. Bagdad, lo ricordiamo ancora, gi nel IX secolo fu sede di un grande ospedale in cui
numerosi medici insegnavano la medicina. Scomparve nel 1258 con la distruzione della citt. Con
questo evento e con la conquista di Cordova (1236), scomparve unepoca: lepoca della civilt degli
Arabi. LArabesimo poi sinfiltr nelle aule delle nostre Universit come a Montpellier e da noi a
Padova, e fu importato a Salerno da Costantino lAfricano.
LA MEDICINA MEDIEVALE: il Filosofismo scientifico e il Dogmatismo
Nel secondo periodo del Medio Evo, nel XIII secolo, si verificarono alcuni eventi che pi di altri
delinearono la svolta verso limminente umanesimo. Nel 1236 cade il califfato di Cordova, e nel
1258 quello di Bagdad: viene quindi a cessare linfluenza politica araba. Le Scuole si trasformano
gradatamente in Universit nelle quali, pur persistendo per un certo periodo linfluenza
dellarabismo, muta gradatamente lorganizzazione dellinsegnamento: la medicina sar accolta nel
numero delle arti che formano il corpo dellinsegnamento universitario.
Prima di questo passo fondamentale la medicina medioevale fu determinata dal filosofismo
scientifico, dallabitudine, cio, di regolare il ragionamento medico sulla falsariga di quello
filosofico. I principali orientamenti di questa pratica furono il Platonismo, con SantAgostino e i
Francescani; lAristotelismo cristianizzato di Alberto Magno e soprattutto di San Tommaso
dAquino, seguito dai Domenicani; lAverroismo, aristotelismo interpretato dalla scuola araba, e
una quarta tendenza, quella eclettica di Duns Scoto, il doctor subtilis della scuola di Oxford.
49
Nello studio e nellesercizio della medicina, oltre al tradizionale indirizzo che si basava sul
ragionamento logicofilosofico, sullilluminazione religioso teologica che portava la medicina,
da una parte al razionalismo ippocraticogalenico, dallaltra al magismo, allastrologia e alla
alchimia, inizia a farsi strada la via della sperimentazione: il cercare, nelloggetto, la realt obiettiva
delle cose: credo quia experimentum explicit (Ruggero Bacone, doctor mirabilis 12141292
Oxford).
Tra i quattro orientamenti prevalse di gran lunga laristotelismo di San Tommaso, che divenne
filosofia ufficiale della Chiesa (anche se non subito) ritenuta philosophia quaedam perennis, verit
immutabile, dogma. Il dogmatismo fu appunto la nota dominante di questo periodo: intoccabili i
dogmi filosofico teologici e i dogmi del sapere. Intoccabili Ippocrate e Galeno, Aristotele e Plinio.
Si diffuse e si accentu in epoca universitaria, nellet dei Comuni.
I medici si chiamavano medici-fisici aristotelici. La medicina cercava di conciliare filosofia,
razionalismo supportato dallautorit dei classici, con levidenza empirica della natura del corpo
umano. Chi osava opporsi allautorit filosofico teologica era eretico, e rischiava il rogo. Chi si
opponeva al dogma scientifico dei classici era sbeffeggiato dai dotti e messo al bando dalle
universit. Galeno sopra tutti fu considerato espressione della verit assoluta: se in anatomia si
rilevava differenza tra quello che lui asseriva e la realt obiettiva, non era Galeno che aveva
sbagliato ma la natura che era cambiata: Ipse dixit, causa finita.
Le Universit diventano sempre pi le detentrici del sapere ufficiale e del patrimonio culturale.
Filosofismo, arabismo e dogmatismo sono i fondamenti dellinsegnamento universitario di questo
periodo. Contro questo appiattimento della libera ricerca si erano gi opposti i Clerici vagantes e la
Goliardia, pur con le loro deteriori manifestazioni. Alla fine del XIV secolo sono presenti i segni
che preludono allUmanesimo. Dante (12651321), della corporazione dei medici e farmacisti,
dichiara di essere uno che va significando come amor gli detta dentro, senza remore, senza paura
di condannare principi, papi e imperatori, a rischio dellesilio, per amor di libert alla quale pu
sacrificare la vita.
LE UNIVERSIT
In periodo comunale, le corporazioni, libere associazioni di persone che esercitavano la stessa
arte o mestiere, andarono sempre pi organizzandosi tanto da diventare la base dello stato sociale
dellindividuo e della difesa degli interessi della categoria. Abbiamo gi visto come la Societas sia
stata alla base delle Scuole. Alcune di queste Societas cominciarono a chiamarsi Universitas: cera
la Universitas fullonum (dei lavandai), la Universitas fabrorum (dei fabbri), e cos anche la
Universitas studiorum, associazione di studenti. Queste associazioni erano rette da un Rettore con
potere su tutta la popolazione studentesca. Gli insegnanti erano riuniti in Collegiu.m I due distinti
organismi, degli studenti e degli insegnanti, operavano nello Studium generale, corrispondente a
quello che oggi sintende con la parola Universit. Nello Studium generale venivano impartite le
lezioni, linsegnamento delle arti liberali e delle discipline giuridiche; inizialmente la medicina era
una delle arti liberali. La parola facolt, per designare la suddivisione dei corsi di studio, appare
in una lettera di papa Onorio III agli studenti di Parigi (principio XIII secolo). Luniversit degli
studenti si divise ben presto in Nazioni a seconda della nazionalit di provenienza degli studenti,
che spesso migravano da uno Studio allaltro alla ricerca del miglior Maestro o di maggior fama.
Inizialmente luniversit degli studenti ebbe peso preponderante: essi pagavano i maestri, ai quali
potevano richiedere e imporre lezioni, orario e impegno didattico. In seguito ben presto la scelta
degli insegnanti e il loro stipendio fu demandato al governo della citt. Nelle Universit si
concentr quindi ogni attivit culturale, anche della medicina: universitari furono i maggiori maestri
di medicina, che dettero quindi ufficialit alla disciplina in quanto garantiti dalla cattedra su cui
sedevano e dal loro prestigio. Il curriculum degli studi medici venne meglio codificato e cos pure
50
laccertamento della preparazione degli allievi mediante ripetuti esami. La concessione della
abilitazione alla pratica era subordinata allaccertamento da parte dei maestri.
La classe dei giuristi, unici ai quali competeva il titolo di doctores, abili disputatori secondo le
norme aristoteliche della logica, non vedeva di buon occhio la nuova disciplina, la medicina, che si
affermava sempre pi negli studi generali, ma i cui esponenti poco valevano in disputazioni
filosofiche. Per farsi riconoscere il titolo di doctores anche i medici dovettero adattarsi al metodo
disputatorio imperante; la medicina, invece, per sua natura tendeva a basarsi sullesperimentum.
Tale pedaggio la medicina pag nel XIII secolo per poter varcare a pieno titolo le soglie delle
Universit. Fu Taddeo degli Alberotti, eminente medico dello studio di Bologna che maggiormente
contribu a far accettare dalla Facolt dei giuristi quella dei mediciartisti. Per la medicina fu una
promozione, ma il metodo disputatoriodialettico, imposto e accettato dai medici, inarid
certamente la ricerca e la voglia di experimentum che gi si faceva sentire.
Le Universit, nate sulle varie Scuole precedenti, di origine ecclesiastica per la maggior parte, o
laica, si potenziarono e diffusero ovunque in Italia e in Europa. Comuni, prncipi e regnanti se ne
fecero vanto e ne trassero prestigio. Le incrementarono chiamando ognuno i pi famosi maestri per
attirarvi studenti dalle svariate Nazioni.
LUniversit di Bologna
La prima Universit in Italia fu quella di Bologna, erede della famosa Scuola. La sua istituzione
fu concessa da Onorio III nel 1219, ma si afferm solo nel 1290. La fama dei medici super ben
presto quella dei giuristi: i pi illustri medici Pietro da Vercelli e Pietro da Perugia. Nellambito
dellorganizzazione generale aveva rigide norme che prevedevano addirittura la pena di morte per
chi tentasse di trasferire altrove la sede, ma anche per il docente che insegnasse altrove senza
lautorizzazione. Gli studenti dovevano giurare fedelt al governo e addirittura al partito al potere.
Il corso di laurea in medicina era diviso in tre parti: medicina teorica, medicina pratica e chirurgia,
con lobbligo dello studio dellanatomia sul cadavere. I cadaveri erano procurati dagli stessi studenti
che dovevano osservare le norme prescritte: studio su cadaveri di giustiziati, di numero prefissato
per anno. La scolara, la campana di San Petronio, annunciava linizio delle lezioni ordinarie. Gli
studenti potevano usufruire di un ripetitore a loro scelta e pagamento. Tra i maggiori esponenti,
oltre a Taddeo Alberotti nominato da Dante (Parad. XII 8285), degno di nota soprattutto
Mondino de Liuzzi che esegu la prima dissezione nel gennaio 1315. Fu il primo a verificare di
persona le affermazioni dei classici, di solito citati come infallibili dalla cattedra. Riferisce Nicol
Machiavelli, suo contemporaneo, che dapprima dissecava personalmente e spiegava agli studenti,
poi si fece aiutare da Alessandra Giuliani, giovane di soli 19 anni, espertissima nel trattare vene e
organi per farne dimostrazione: ripuliva in modo eccellente le vene e le arterie senza lacerarle e
ne faceva dei tubi che riempiva di liquidi coloratie indurivanosenza alterarsi e venivano
mostrati agli studenti e illustrati dal maestro. Sulla base delle sue osservazioni compil la sua
Anothomia, primo moderno testo di anatomia che resistette sino al Vesalio.
LUniversit di Padova
Nacque nel 1222 per una trasmigrazione di studenti e professori dallo studio di Bologna a
Padova, che per opera di quel Comune e di quella Diocesi ebbe calorosa accoglienza. Fin dallinizio
vi furono due distinte facolt, quella dei giuristi e quella degli artisti, tra i quali erano i medici che
subito prevalsero. Gi lanno successivo, 1223, vi accorse Alberto di Bollstaedt, il futuro
SantAlberto Magno. Raggiunse il suo massimo splendore quando, nel 1405, pass dal dominio
papale a quello di Venezia.
Massima importanza fu data allo studio della anatomia mediante il metodo dellautopsia.
51
Degno di nota il calabrese Bruno da Longoburgo che scrisse Cyrugia magna, dove descrive la
guarigione per prima e seconda intenzione e le suture con filo di cotone e seta; distinse
lemorragia venosa da quella arteriosa. Molto pi importante e famoso fu Pietro dAbano (1250
1316), le cui lezioni furono seguite anche da Dante. Esperto non solo di medicina, ma in tutto lo
scibile dellepoca, tent di conciliare la medicina araba con quella greca: volle imparare il greco per
poter leggere Ippocrate nella sua lingua. Scrisse il Conciliator dove non disdegna il sillogismo, a
volte prevalente sulle prove concrete. Si rif specialmente ad Avicenna che distingue quattro fasi
della malattia: attacco, aumento, sosta e declino. Interessanti le sue osservazioni sui traumi cranici,
sulla distribuzione dei nervi e sul trattamento della rabbia. Scrisse un trattato di farmacologia: De
venenis. Le sue conoscenze di astrologia e di alchimia lo circondarono di un alone di magia che,
assieme alla fama di arabista, attirarono le attenzioni dellInquisizione. Nel 1303 i domenicani lo
accusarono di eresia; da prima scagionato, non sfugg nel 1315, quando fu emessa condanna al
rogo: ma mor prima di subirla. N la sub il suo cadavere, trafugato da mani pietose: alle fiamme
and solo la sua effigie.
Napoli ebbe la sua Universit nel 1224 per opera di Ferdinando II, essendo ancora fiorente la
Scuola di Salerno.
A Vercelli sorse lUniversit nel 1228 per la crisi momentanea di quella di Padova. Perdur fino
al 1405, allapertura dellUniversit di Torino.
Altre Universit sorsero a Siena nel 1246. A Perugia nel 1266. A Roma nel 1303.
Universit di Parigi
Sorse dalla Scuola di Ntre Dame nel 1231. La facolt di medicina nel 1271 era di sei lettori, retta
da un canonico della Cattedrale, Scuola vescovile. Nel 1257 Roberto di Sorbon, cappellano di San
Luigi, don la sua casa a 15 studenti di teologia in disagiate condizioni; il numero via via si
accrebbe e cos nacque la Sorbonne, sinonimo dellUniversit. Le sue origini furono assai povere: le
lezioni erano tenute in diversi locali, disadorni e miseri, nelle strade, e talora in case malfamate, in
fienili, assai spesso nel celebre Vico degli strami, di dantesca memoria. Il maestro seduto su un
cumulo di fieno e gli studenti per terra. LUniversit trov stabile dimora solo nel 1369.
Le lezioni consistevano nella lettura e commento di un testo, lectio, spesso interrotta da disputa,
disputatio ordinaria. Due volte lanno si tenevano dispute generali, disputationes de quo libet. Un
Conciliator infine traeva le conclusioni dette le concordantiae. Gli insegnanti di medicina erano
considerati tra gli artisti, maestri delle arti liberali. Dovevano aver compiuto sei anni di studio ed
essere approvati in seguito ad un esame. Dopo i primi tre anni potevano insegnare le scienze
preparatorie, ed avere il titolo di bacca - laurei, baccellieri. Dopo altri tre anni avevano il titolo di
Magistri in physica, col permesso di esercitare liberamente. Erano divisi in phyisici teorici e
practici. Linsegnamento della medicina era prevalentemente dialettico, la pratica totalmente
assente. Tra i primi insegnanti da ricordare Gilles de Corbeil, gi allievo della scuola salernitana,
Pietro Ispano, che divenne papa Giovanni XXI, e soprattutto SantAlberto Magno.
Universit di Montpellier
Nacque nel 1220, quando Onorio III ne approv gli statuti per la facolt di medicina. Lo Studio
generale fu per approvato nel 1289. Fu dispirazione averroistica in rivalit con la Scuola di
Salerno di cui peraltro utilizzava i testi. Gli insegnanti erano pagati dagli studenti.
Tra i maggiori esponenti Arnaldo da Villanova e Pietro Ispano. Guy de Chauliac tra i maggiori
chirurghi.
52
Universit di Oxford
Sorse probabilmente da una trasmigrazione di studenti da Parigi. Si sa per certo che lo Studio nel
1209 aveva 3000 studenti. In quellepoca furono istituiti i Collegi per studenti e insegnanti, prima
per ragioni di indigenza, poi divennero i luoghi di insegnamento, dove studenti e insegnanti
abitavano insieme. Gli studenti erano i socii cio i fellows, retti da un master. I vari Collegi
riuniti insieme formarono lUniversit, governata dagli studenti e controllata da un Cancelliere.
Ordini religiosi, francescani, carmelitani, benedettini diedero impulso allUniversit che nel XIV
secolo era seconda solo a Parigi. In quellUniversit Ruggero Bacone (12141292) inizi la strada
definita sperimentale, e vi insegn Duns Scoto.
Universit di Cambridge
Fu riconosciuta come Studio generale da Giovanni XXII nel 1318. Si organizz sul modello di
Oxford e di Parigi, diventando citt prettamente universitaria, nel senso che tutta la sua economia
era orientata in funzione dei Collegi in essa esistenti. Ebbe i suoi cancellieri, i suoi maestri e i suoi
studenti. Gli studi consistevano nel trivio e quadrivio: il primo, di tre anni, portava al titolo di
baccelliere, il secondo di quattro anni portava al titolo di maestro delle arti. Com noto, il trivio, di
arti liberali, comprendeva la grammatica, la dialettica e la retorica, il quadrivio, delle scienze,
comprendeva laritmetica, la geometria, la musica e lastronomia.
53
IL RINASCIMENTO
Preceduto dai fertili semi dellUmanesimo, il Rinascimento rappresenta la rivolta al dogmatismo
imperante nellultima parte del Medio Evo, esteso dal 476 al 1492. Luomo si riappropria del
proprio Io individuale contro lautorit di qualsiasi genere: filosofica, teologico religiosa o
scientifica. In campo scientifico non ci si accontenta pi dellautorit dei classici, ma si vuole
toccare, vedere, sperimentare in proprio: verificare la verit della tradizione. La fisica separata
dalla metafisica, la ragione dallesperimento. E il periodo della rivoluzione copernicana, dei grandi
viaggi intorno alla Terra, delle esplorazioni. Avviene linvenzione della stampa: i primi caratteri
metallici nel 1450. Fiorisce la cultura ellenistica, il neoplatonismo e il rinnovato studio di Platone.
Avviene lapprofondimento degli studi medicofilologici. Si fondano le prime Accademie:
Marsilio Ficino a Firenze, Pomponio Leto a Roma, Pontano a Napoli, Manunzio a Venezia.
Sono i tempi di Lutero, Paracelso, Leonardo e infine di Galilei.
Per quanto riguarda la Medicina il periodo della rinascita della Anatomia: il 500 il secolo
dellanatomia. Il Maestro, come gi Mondino, scende dalla cattedra, non solo legge e commenta i
sacri testi, ma lui stesso fa notomia: taglia, scruta, classifica, descrive, disegna organi, muscoli, vasi,
nervi, cervello Il vero testo il corpo umano, il cadavere, su cui imparare e comparare la vecchia
scienza. Si impone perci il metodo descrittivosistematico, dimostrativo, vivisettorio, alla ricerca
della verit oggettiva, libera da pregiudizi e dalla sudditanza dei classici.
La descrizione esatta e puntuale, postula una nomenclatura precisa: vengono sostituiti vecchi
vocaboli arabolatini, prelevando vocaboli dallopera di Celso: occipite, omero, radio, rotula, tibia,
vertebra, ano, tonsilla, uteroLa rottura del principio di Autorit insinua il dubbio in tutti campi: al
metodo deduttivo della dialettica si preferisce quello induttivo dellesperimento: le cose vanno
dimostrate. Se ne ha percezione palpabile negli Orti botanici, che mostrano la vita delle piante e la
derivazione dei semplici, e nei Teatri Anatomici, primo tra i quali quello di Padova di Fabrizio
dAcquapendente, e poi diffusi in tutta lEuropa.
Leonardo inaugura il metodo anatomo-comparativo, dimostrando cos che Galeno riferiva una
anatomia animale, non quella del corpo umano. In questo periodo vennero dimostrate ben 200
discrepanze anatomiche rispetto alle nozioni di Galeno: lutero uniloculare, lo sterno tripartito, la
mandibola osso unico, la denominazione dei muscoli secondo il punto dinserzione e di origine.
Venne data dimostrazione del piccolo circolo polmonare, si precis la morfologia del fegato, si
scopr la valvola ileocecale. Si precisarono le nozioni sul sistema nervoso, sullapparato genitale
femminile e sullorecchio interno.
LEONARDO DA VINCI
Nacque a Vinci, presso Empoli, nel 1452, mor in Francia nel 1519.
Il nostro massimo artista, sommo in ogni arte, fu il primo ad imporsi nellAnatomia con spirito e
pratica attuazione di vero scienziato: osservatore acuto della forma e analizzatore delle possibili
funzioni degli organi e delle parti dissecate, perfetto disegnatore dellinsieme e dei particolari della
fabbrica del corpo umano. Nellarte di fare notomia non aveva precedenti cui rendere omaggio:
unica maestra lesperienza propria. Fu anatomico, ma anche fisiologo e biologo: Io scopro alli
homini lorigine della prima o forse della seconda ragione del loro essere. Usufruiva dei cadaveri
dei giustiziati: una delle pene era quella di dover subire la vivisezione. Era sua intenzione di
realizzare un vero Atlante anatomico, completo e organico, di tutto il corpo umano, inserito nel
grande universo di cui luomo parte. Ci lasci invece circa 1000 fogli di disegni con annotazioni
fisiologiche esplicative. Descrisse un secolo prima di Higmoro l armatura della mascella
54
conosciuta appunto come antro di Higmoro che se ne assunse la paternit. Scopr il III ventricolo
del cervello dove pose il centro dellanima, il luogo cio dove convergono tutti i sensi nel Senso
comune. Nel IV ventricolo pose la Memoria. Il Senso comune insieme alla Memoria formano il
Giudizio. Indag il meccanismo del movimento delle articolazioni, studiandone separatamente le
facce articolari. Dei muscoli si preoccup di individuare il punto dattacco dei capi, per poterne
studiare le funzioni. Ancor oggi i testi di anatomia chiamano corda di Leonardo il fascio
moderatore del ventricolo destro del cuore; studi le valvole atrioventricolari e semilunari.
Descrisse levenienza della persistenza di un foro interventricolare, che oggi chiamiamo foro di
Botallo. Invent lesame seriale dei preparati anatomici, e lartificio di riempire le cavit
anatomiche con cere, cos da renderle tridimensionali e poterle disegnare con perfetta precisione.
Famoso il suo disegno del feto in utero. Ed emblematico ormai il suo Canone nel quale fiss le
proporzioni del corpo umano.
Anche se non effettivamente realizzata, la Cosmografia del minor mondo vive nei suoi fogli
disegnati del corpo umano, microcosmo, in relazione col Creato, macrocosmo.
Berengario da Carpi (Iacopo Barigazzi 14601530?)
Fu il primo ad accompagnare la trattazione dellAnatomia con elementi illustrativi delle parti
studiate e descritte. Per le sue conoscenze di chirurgia bellica fu lettore di Chirurgia a Bologna.
Giulio II lo chiama a Roma dove, in seguito, lavorer per Leone X. Assiste Lorenzo de Medici per
una ferita al cranio da una pallottola di fucile. Il suo modello di anatomista fu Mondino di Liuzzi
del quale tuttavia sottolinea gli errori. Scrisse Commentariasuper Anatomia MondiniDistinse
per primo i vasi chiliferi dalle vene e descrisse lappendice vermiforme. Nelle Isogogae breves
descrisse in modo particolareggiato il cuore e il cervello, la ghiandola pineale, il plesso corioideo e
il quarto ventricolo. Cur nel 1525 Giovanni dalle Bande nere. E da considerarsi lillustre
precursore del grande Vesalio.
ANDREA VESALIO (15141564)
Van Viesel, fiammingo di origine tedesca, nacque a Bruxelles, ma scelse per la sua attivit lItalia.
Studi a Montpellier e a Parigi, forse allievo di Guido Guidi e sicuramente di Sylvius Du Bois.
Gi convinto galenista fu il primo ad attaccare apertamente lindiscussa autorit del grande maestro.
Da Parigi torn a Lovanio, dove, preso da intensa attivit anatomica, quasi frenetica, e da furore
vivisettorio, arriva a staccare i cadaveri pendenti dalla forca per poterli sezionare di notte.
Laureatosi a Padova nel 1537 fu subito nominato Lettore di Anatomia.
Scrisse la sua famosa De humani corporis fabrica tra il 1540 e il 1542, allet di 2628 anni. Ne
cur personalmente la stampa e lincisione delle xilografie da parte dei vari maestri incisori. Part
molte volte da Padova e altrettante vi ritorn. Archiatra di Carlo V nel 1544 e del suo successore,
Filippo II, nel 1559.
Nel 1564 intraprese un viaggio in Terra Santa, forse per espiare il suo furore dissecatorio, forse per
condanna dellInquisizione. Certo non fu mai esente da acredine, invidia e maligni sospetti. .
Considerato pazzo sfrontato da ardire di opporsi a Galeno, fu chiamato da Sylvius Du Bois
Vesanus quidam: un pazzo. Fu contestato dai fanatici galenisti, ma anche dai suoi allievi e
successori nella Cattedra di Padova, Colombo e Fabrizi dAcquapendente. Era inoltre incline al
protestantesimo. Nella sua opera riscrive tutta lanatomia, facendo via via rilevare gli errori rispetto
a quella classica tradizionale galenica. Sfata definitivamente lipotesi dei pori interventricolari del
cuore: Io non ho mai trovato fori nel setto. Corregge Galeno sulla anatomia del fegato, dei dotti
escretori, dellutero, dellosso mascellare. Descrive i menischi e individua il corpo luteo e le ossa
componenti losso sacro. Mor a Zante.
55
Realdo Colombo
Nacque a Cremona nel 1500, mor nel 1559. Succedette a Vesalio nella cattedra di Padova nel
1544. Fu buon medico e buon chirurgo, ma soprattutto prosegu nelle ricerche anatomiche e
produsse un mirabile trattato De re anatomica, decisamente superiore a quella del maestro per
quanto riguarda la descrizione del mediastino, della pleura, del peritoneo e del cristallino. Ma
soprattutto per la descrizione della circolazione polmonare: il movimento del sangue va dal
ventricolo destro tramite larteria venosa (arteria polmonare) ai polmoni, e da questi, tramite la
vena arteriosa (vena polmonare), allatrio di sinistra e di qui al ventricolo sinistro.
Gabriele Falloppio
Dopo Realdo Colombo sal sulla cattedra di Vesalio, Gabriele Fallopio di Modena (15231563),
suo discepolo, non per averne udite le lezioni, ma per averne studiato lopera e condiviso
limpostazione. Fu a Padova dal 1551, insegnante di anatomia, di chirurgia e di lettura dei semplici,
fino alla morte. La sua opera legata alla scoperta delle tube uterine, che portano il suo nome, ma
scoperse molte strutture del cranio: la corda del timpano, i canali semicircolari, i seni sfenoidali e il
canale del nervo facciale. Si devono a lui termini medici ancora in uso: vagina, placenta, coclea,
labirinto, palato, velo palatino. Pu essere considerato il fondatore dellOculistica e dellOtologia
per essersene ampiamente occupato. Invi la sua opera Observationes anatomicae a Madrid, al
maestro Vesalio che gli rispose: Non posso verificarlequi non mi permesso neppure di
studiare un cranio. Si interess perfino di preservazione delle malattie veneree, (era lepoca della
sifilide), e invent il preservativo, una sorta di guanto di tela finissima umettato di sostanze
medicamentose.
GIROLAMO FABRIZI DACQUAPENDENTE
Nacque ad Acquapendente nel 1533 (1537?), mor novantenne a Padova nel 1619.
Allievo di Fallopio, studi a Padova e ne occup la cattedra di Anatomia e Chirurgia. Si riallaccia
ai concetti leonardeschi di anatomia: la morfologia serve di base per la ricostruzione dellintero
organismo e delle sue funzioni, soprattutto del movimento: scrisse De motu animalium. E poich
deve studiare lo sviluppo dellessere umano, fin dalla sua evoluzione nellutero materno,
dellembrione, scrive De formato foetu. Contribu inoltre alla conoscenza dellocchio, dellorecchio
e della fonazione con le opere: De oculo, De aure et laringe, De locutione et eius instrumentis.
Nelle opere De musculi fabrica e De motu tratta del camminare, del nuotare, dello strisciare
Fece costruire, a sue spese, lAnfiteatro anatomico che, ricostruito dalla Repubblica Veneta,
tuttora esistente.
Fu ottimo chirurgo, amava ripetere che il miglior chirurgo quello che taglia meno e con maggior
cautela: cur Paolo Sarpi pugnalato da cospiratori.
Di carattere difficile e litigioso girava con la scorta di uomini da coltello.
La sua maggiore scoperta fu lesistenza delle valvole delle vene. La loro funzione, secondo il
Fabrizi, quella di ritardare il ritorno del sangue dal cuore verso la periferia, implicitamente
postulando che il cuore il centro motore del sangue, che da esso fluisce verso la periferia e da essa
vi ritorna. Alle lezioni su questo argomento cera il giovane Harvey che in seguito, nel 1628, scopr
definitivamente la circolazione del sangue, senza per altro fare cenno di quanto aveva appreso dal
Fabrizi e da Cesalpino. In medicina interna fu galenista convinto e aristotelico.
Miguel Servedo (Villanova dAragona 15091553) studi medicina a Parigi e fu amico di
Rabelais, anche lui medico. Parla di circolazione del sangue in un libro di teologia Christianismi
restitutio, dove descrive il sangue (vera anima e forza vitale) che dai polmoni ritorna al cuore,
attraverso le vene polmonari dopo essersi mescolato, nei polmoni, col pneuma.
56
Nel suo libro di teologia dimostra poca ortodossia circa il dogma della S.S. Trinit; Calvino, suo
acerrimo nemico, lo denuncia al vescovo cattolico che lo fa condannare al rogo, su cui muore con
due copie della sua opera, nei dintorni di Ginevra.
Andrea Cesalpino (15241603)
Fu allievo di Realdo Colombo e forse del Vesalio, profondo studioso di botanica (conosceva 1500
piante), fu lettore di medicina pratica. Usa per primo il termine circulatio sanguinis e dimostra
anatomicamente che il cuore, e non il fegato, il centro del movimento del sangue: sanguis currit
ad cor; e cos dal cuore nasce il principio delle arterie e delle vene: come i rivi prendono acqua
dalla fonte cos le vene e le arterie fanno dal cuore. Con la descrizione del fenomeno del laccio
dimostra la circolazione del sangue: le vene legate in qualsiasi punto del corpo, si tumefanno al di
sotto del laccio, cio nella parte periferica rispetto al centro, il cuore. E se vengono aperte, come nel
salasso, scorre da prima sangue scuro, venoso, poi invece rosso, arterioso. Riassumendo si pu
concludere che secondo le pratiche osservazioni sul vivente e sul cadavere anatomizzato, il cuore
centro di tutto il movimento sanguigno; da esso si dipartono le vene e le arterie che si sfioccano in
capillari negli organi; il contatto aria sangue che avviene nei polmoni si effettua per contiguit dei
vasi; nellalbero artero venoso si compie una doppia corrente, una centrifuga e una centripeta
(venosa).
Ricordiamo, solo riportandone il nome, alcuni dei grandi anatomici del Cinquecento che hanno
legato il loro nome a specifiche scoperte.
Bartolomeo Eustachio (15001574): Trombe di Eustachio.
Leonardo Botallo (15101580): Forame di Botallo (tra gli atri del cuore).
Ceare Aranzio (15301589): Descrittore del feto; Dotto di Aranzio.
Costanzo Varolio (15431575): Ponte cerebellare di Varolio.
Gaspare Bauhin (15601624): Valvola ileocecale.
..
Girolamo Cardano (Pavia 1501Roma 1576)
Figlio illegittimo merita di essere ricordato per la sua attivit eclettica e per la sua vita anomala
ed errabonda. Studi a Padova, centro dellaristotelismo umanistico, credeva in modo certo solo alla
matematica. Laureato a Bologna divenne rettore di quella universit a 24 anni. Fu a Milano e a
Piove di Sacco, dedito a vari mestieri, e giocatore dazzardo. A Milano dava lezioni di geometria e
di astronomia non riuscendo ad essere accolto nel Collegio dei Medici. Si dedic anche alla
meccanica: invent il giunto che porta il suo nome. Assai poco estimatore della classe medica,
aveva scritto un libello De malo usu medicorum, nel quale descrive ben 72 errori nella pratica
medica del suo tempo. .
Scrisse il suo capolavoro, Ars magna, che gli diede fama universale di grande medico. Fu
chiamato dallarcivescovo di Edimburgo che soffriva di una malattia polmonare creduta tisi, ma
dopo attenta osservazione dei sintomi, concluse che doveva trattarsi di asma, dovuto alla presenza
di piume del letto: aveva scoperto lasma allergico. Larcivescovo guar seguendo il consiglio di
dormire su lenzuola di seta filata.
57
PARACELSO (14931541)
Filippo Aurelio Teofrasto Bombasto von Hoenheim nacque a Einsiedeln in Svizzera, latinizz il
suo nome Hoenheim in Paracelsus: vicino alleccelso. Io sono stato eletto da Dio a questo fine,
di estinguere e cancellare tutte le fantasie e false operee pretestuose parole di Aristotele, Galeno e
Avicenna o i dogmi di qualsivoglia loro seguaci. Questo il suo programma.
Viaggi molto in Italia e form la sua mente alla filosofia di Marsilio Ficino, di cui fu grande
ammiratore per il suo neoplatonismo. Forse si laure a Ferrara. Vagabondo per dieci anni di paese
in paese, fu in Oriente, in Russia, a Mosca. Chirurgo militare con Francesco I e con Carlo V. Fu
ribelle ad ogni forma di aristotelismo scolasticismo: spinto dal furore della sua missione bruci in
pubblico i testi dellantica medicina. In giovent studi alchimia e apprese limmenso magistero
della trasformazione dei metalli sulle opere degli esperti arabi. Si inimic medici, farmacisti e
pubblico quando fu nominato medico a Basilea. Salv dallamputazione la gamba del celebre
editore di Erasmo, Froben, usando la tintura di laudano, mirabile medicamentum.
Trascin molti a contrapporre alla falsit dei sacri testi la verit dellesperienza diretta e della
tecnica della imitazione della Natura: rivalutando il concetto della Vis medicatrix Naturae.
Demolendo i dogmi del passato, volle rimettere tutto in discussione: invitava al ritorno allo studio
del malato per mezzo della ragione, ma non disgiunto dallesperimento, rivelandosi cos
saggiamente ippocratico: lesperimento pu essere fallace, il giudizio difficile. Alla teoria
ippocratica degli umori, per, oppose quella delle sostanze reali: il sale, lo zolfo, il mercurio:
sostanze vere e sperimentabili, componenti di tutti i metalli non solo, ma di tutti gli Esseri, viventi
e nonviventi: materia universale del macrocosmo (mondo), e del microcosmo (uomo).
Luomo ha quindi una doppia essenza: una astrale e una materiale. Sulla essenza astrale si pu
operare con esorcismi e formule magiche, quando la cura sulla essenza materiale coi mezzi
naturali si dimostra vana. Solo conoscendo queste correlazioni si pu conoscere la malattia.
Paracelso esprime un nuovo concetto di malattia che colloca la forza al di sopra della materia.
. Esiste un principio vitale, una forza soprannaturale, esterna rispetto ai solidi e agli umori, che egli
chiama Archeus. LArcheo indispensabile nei diversi meccanismi fisiologici e fisiopatologici:
esso opera nel chimismo corporeo, nel senso che trasforma le varie sostanze, la materia, di cui
composto il microcosmo, luomo. LArcheo separa in modo adeguato le varie componenti della
materia producendo la salute, le separa in modo inadeguato producendo la malattia. Alla malattia,
quindi, riconosciuta una base che possiamo dire biochimica, dominata dalla forza dellArcheo.
Tutta la ricerca farmaceutica di Paracelso fu mirata a trovare il mezzo per poter separare il puro
dall impuro, affinch il puro, la sostanza pura, cos estratta, possa agire meglio. Bisogna
dunque estrarre il principio attivo dalle sostanze complesse, quello puro che veramente attivo.
Questo era in fondo lo scopo dellalchimia, degli arabi in particolare, che cercavano di ottenerlo
con la distillazione e altre tecniche. Trovare la quinta essenza, lessenza celeste di Aristotele, oltre
laria, acqua, fuoco e terra di Empedocle. In definitiva bisognava trovare un unico solvente, che
Paracelso chiama Alkaest, il quale, sciogliendo ogni sostanza composta, ne estragga il puro
principio attivo per la terapia. Una tale arte Paracelso chiama spagirica, , che
corrisponde alla moderna arte farmaceutica chimica.
Le sue opere pi importanti sono Paragranum (1530) e Paramirum (1531).
Fra tante stravaganze di una vita ribelle, vagabonda e irrequieta, Paracelso pu considerarsi il vero
padre della moderna chimica farmaceutica: certamente contribu alla diffusione delluso del
mercurio, zolfo, ferro, piombo, arsenico, antimonio, solfato di rame e degli estratti alcolici. Ebbe il
merito di aver introdotto luso del laudano, che si dice, portasse sempre con s, nel pomo della
inseparabile spada. Us pure letere solforico, rendendo insensibili i pulcini: si potrebbe, volendo,
ritenerlo il padre anche dellanestesia generale.
58
GIROLAMO FRACASTORO (Verona 14781553)
Allievo del Pomponazzi a Padova, dove si laure, fu medico privato di Paolo III e al Concilio
di Trento. Fu latinista, musico, poeta, filosofo. Scrisse De contagione et contagiosis morbis
eorumque curatione. La sua opera pu essere considerata come la divinazione del mondo
microbico, intuto nellera pre microscopica. Ma si pu anche dire che ha definito il concetto di
contagio e iniziato lera della microbiologia. La paura e la sensazione che le malattie potessero
trasmettersi tra individui antica: Tucidide descrisse il terrore della peste di Atene, i Romani
fuggivano gli appestati, gli Ebrei i lebbrosi, come tutti gli altri popoli. Boccaccio descrive la navata
semivuota di Santa Maria Novella per la fuga dei fedeli impauriti, Petrarca afferma che nessuno sa
in che cosa veramente consista la causa della peste: gli storici tacciono, i fisici si stupiscono, i
filosofi consigliano il silenzio.
Democrito, Epicuro, Lucrezio avevano parlato di atomi. Fracastoro ci parla di particelle
invisibili. Particelle invisibili passano da un malato allaltro, queste sono le seminaria morbi, i semi
della malattia. Ma questo meccanismo si d solo per quelle malattie ben definite che si dicono
contagiose. Le particelle viventi escono fuori col respiro, con la perspiratio superficialis, e formano
attorno al malato un alone, unatmosfera, una nebbia, pronta ad aggredire un altro individuo. Queste
particelle per non sono parti evaporanti dal corpo, non semplici detriti, non atomi, ma sono
corpuscoli vivi che si propagano da un ammalato ad un sano per attrazione, per simpatia. E
inoltre questi seminaria ne generano altri di simili, una filiazione che genera altre fonti di contagio.
I seminaria morbi devono essere uccisi, e bisogna evacuarne anche i loro cadaveri, che sono pure
dannosi: concetti attuali, anticipati: disinfezione, antibiosi, tossine. E ancora i seminaria si
trasmettono: per contatto diretto, per mezzo di cose impregnate di essi, fomites, veicoli, che devono
aver superficie porosa e viscosa, si trasmettono a distanza, per chi entra nel raggio dazione
dellalone creato dal portatore. E non basta: hanno vitalit propria, sufficiente anche per vivere a
distanza, nellaria, nellacqua, nel suolo. Dallambiente vengono assorbiti col respiro, o dai pori
della pelle, da dove passano nel sangue attraverso le vene: la catena epidemiologica: infetto
veicoliinfetto. Questo il merito principale di Fracastoro, di aver pensato ad agenti di malattia
vivi e di averne descritto le modalit di trasmissione, in modo talmente preciso che poco si
aggiungerebbe in un moderno trattato di Igiene.
Fracastoro, uomo del cinquecento, non pu prescindere dallastrologia. Una certa qual importanza
gli astri potrebbero avere nella propagazione delle pestilenze, se vero che gli astrologi le possono
prevedere.
E certo che pu a ragione essere considerato lanticipatore della microbiologia: gli mancava la
prova della diretta visione dei seminaria: gli mancava la tecnologia, il microscopio.
Paracelso inizi la chimica. Per il vero progresso decisivo mancava un metodo che desse la
possibilit di osservare i fenomeni, di quantificarli e di verificarli. Galileo detter il Metodo per la
nascita della Scienza sperimentale.
La Chirurgia e i barbieri chirurghi. LOstetricia
I grandi anatomici ricordati furono anche grandi chirurghi: anatomia e chirurgia progredirono
insieme. Accanto alla chirurgia ufficiale fu da sempre prospera una chirurgia empirica, esercitata
da artigiani, illetterati, su indicazione dei medici o pi spesso in proprio.
Nel Medio Evo esistevano tre classi di tali artigiani: i barbieri, i barbieri chirurghi e i medici delle
ferite. Al barbierechirurgo era concesso, oltre che di tagliare barba e capelli, anche di praticare il
salasso. Il salasso aveva svariate indicazioni, dettate dai medici, ed era eseguito quasi sempre come
un rito: vene specifiche dovevano essere incise per ciascuna malattia, in determinate ore e stagioni,
59
e congiunzioni astraliAlcuni barbieri chirurghi acquisirono grande abilit dalla pratica
quotidiana e dallapprendimento nelle botteghe del maestro: ad essi erano affidate le operazioni
pi difficili e pi gravate da mortalit che i medici rifiutavano di eseguire: non erano cose che loro
convenissero.
Un barbiere -chirurgo divenne un grande chirurgo, fu Ambroise Par (15091590). Ebbe la
ventura di poter far pratica nei campi di battaglia. Nel trattare le ferite trov che era meglio usare un
miscuglio di albume duovo, invece che lolio bollente sulle ferite darma da fuoco. Scrisse nel
1545 un Metodo di trattare le ferite darchibugio e da altri bastoni da fuoco, che divenne ben
presto il vademecum dei chirurghi degli eserciti francese, italiano, tedesco e spagnolo. La sua fama
giunse ad Enrico II di Francia, e cos un barbiere chirurgo, che non conosceva n greco n latino
(scrisse i suoi trattati nella lingua francese, lunica conosciuta), fu accolto nella Confraternita di San
Cosma come Maestro di Chirurgia, il che lo equiparava al rango sociale del medico e lo autorizzava
a usare la veste lunga, suscitando le ire dei maestri della Sorbona.
Tra le altre opere scrisse un Trattato di Anatomia e Dieci libri di chirurgia: la sua opera di
chirurgo da paragonare a quella di anatomico di Vesalio. Propugn la legatura dei vasi
nellamputazione degli arti. Descrisse la lue congenita e attribu allaneurisma dellaorta lorigine
luetica. Descrisse dentifrici per ligiene orale, e denti artificiali in osso o avorio, tenuti da filo doro
o dargento. Propugn il trapano a corona. Pur credendo nellastrologia e nel potere dei santi nella
guarigione delle malattie, sfat la credenza nellefficacia del bezoar. Molto importante lopera di
Par nellOstetricia: descrisse con chiarezza il cancro dellutero e della mammella e fa cenno a
diffusioni ghiandolari sottoascellari; prospetta lestirpazione chirurgica in forme non estese.
Descrisse la tecnica del rivolgimento. Scrisse un libro sulla Generazione delluomo.
Abbiamo gi ricordato Leonardo che descrisse lutero con le sue tuniche e la vera posizione del
feto in utero. Falloppio descrisse le tube. Realdo Colombo precisa le tre posizioni fetali: testa in
basso, testa in alto, posizione trasversa; e inoltre limportanza del liquido amniotico. Riconosce per
primo la cervix uteri distinta dalla vagina.
Lallievo di Par, Guillemeau Jacques (15501613), scrisse lHeureux accouchement des
femmes.
Il taglio cesareo, sempre eseguito su donna morta, fu attuato nel 1500 da un castratore, Giacomo
Nufer, sulla propria moglie che sopravvisseMa fu ardito episodio isolato. Solo nel 1581
Francesco Rousset descrisse loperazione nel libro intitolato Isterotomochya, ma fu Cristoforo
Maini il primo chirurgo che lesegu a tecnica darte. Tali interventi per furono rarissimi e gravati
da altissima mortalit: si dovette attendere molto, prima di poterla usare con sufficiente
efficacia. . . ..Degno di memoria Scipione Mercuri per la sua opera in volgare La commare, che
si rivolge prevalentemente alle levatrici, dove per la prima volta indica il bacino stretto come
motivo per lesecuzione del taglio cesareo. Nel suo trattato d consigli di pediatria, atti a mantenere
sani i bambini e a curarli. Anche Girolamo Mercuriale (153016046?) tratt di pediatria (De
morbis puerorum) e di ostetricia (De morbis muliebribus 1582) dove parla di allattamento,
puerperio, disfunzioni mestruali e malattie ginecologiche.
LIgiene personale
Durante il Medio Evo ligiene personale era quasi del tutto trascurata: non si usava il sapone, per
altro gi conosciuto da Plinio. I vestiti non venivano quasi mai lavati anche per la difficolt tecnica,
essendo per lo pi costituiti di lana. Nella loro trama vivevano abitualmente vari parassiti: pidocchi
e pulci erano ospiti abituali. Il bagno era praticato solo dai ricchi in bigoncia di legno: lacqua calda
era versata con piccoli boccali sul bagnante seduto. Gli scarsi bagni pubblici, pi che fonte di
pulizia erano fomiti di infezioni. Il letto era in comune per tutti i membri della famiglia, ma anche
per gli ospiti che vi giacevano nudi, usando per guanciale i vestiti del giorno. Era costituito da un
60
pagliericcio contenuto in un telaio di legno. I ricchi avevano letti di piume e cuscini, i poveri solo
giacigli, coperti da una tela. Non esistevano latrine, n locali appartati per le esigenze corporali.
Solo nel 1533 il Parlamento di Parigi ordin che ogni casa avesse apposite buche per gli escrementi,
onde evitare di gettarli dalle finestre. Non esistevano i piatti: al principio del Medio Evo erano
rappresentati da una fetta di pane rotonda (la mensa degli antichi), sulla quale si versavano gli
alimenti. Poi vennero i piatti di legno e poi quelli di terracotta. Unico il bicchiere per tutti: i ricchi
ne avevano uno per coppia. Unico il piatto di terraglia, posto al centro della tavola, dal quale
ognuno si serviva con le mani. La minestra era versata in buche scavate nello spessore della tavola.
Nel Rinascimento invece ligiene personale abbastanza curata. Si usa il sapone, anche
profumato, per il lavaggio del viso e delle mani, consigliato ogni mattina. Quello dei piedi e dei
capelli era consiglato ogni settimana. I ricchi avevano camere da bagno, con vasca marmorea e
pareti di lusso, con dispositivo per larrivo dellacqua calda (vedi Castel SantAngelo in Roma,
nellappartamento del cardinale). Era conosciuta la doccia, prima in Italia, in Francia nel XVI
secolo. La biancheria personale era cambiata una volta alla settimana. Comparve il fazzoletto per
aiutare le mani nella pulizia del naso. Abbastanza curata anche ligiene sessuale: era vietata la
prostituzione clandestina, regolata quella pubblica. Durante il regno di Carlo IX, nel 1561, vennero
chiusi tutti i postriboli: erano tollerati solo quelli aperti nel 1256: di qui il nome di case di
tolleranza.
Lebbra e Pestilenze
Lebbra e pestilenze funestarono anche il Rinascimento con varie epidemie cicliche, precedute da
avvenimenti tellurici straordinari, ritenuti presagi dalla credenza popolare. Si credevano mandate
dallira divina a causa di peccati individuali o collettivi che bisognava espiare. Era intuto il fatto
che fossero contagiose: Fracastoro laveva teorizzato. Marsilio Ficino consiglia di fuggire dai
luoghi sospetti di starsene sobri e casti, e allegri, di evitare eccessive fatiche, di evitare i
cattivi odori e i venti provenienti dalle paludi.
Sorgono i Lazzaretti, il primo a Venezia nellisola dove sorgeva la chiesa di Santa Maria di
Nazareth (nazaretum ?), nel 1403. Poi a Milano, Genova, Ferrara e FirenzeMa il ricovero fu reso
obbligatorio solo nel 1476 con ordinanza del magistrato di Padova. Le condizioni di alloggio erano
abbastanza buone, salvo nel corso di epidemie, quando i pazienti giacevano dovunque ci fosse
posto.
Nel Cinquecento comparve una malattia nuova la, Sifilide. Sembra ormai certo da studi eseguiti
su ossa di individui dellAmerica Latina, Stati Uniti e Oceania col metodo del Carbonio 14, che la
malattia esistesse tra quelle popolazioni fin dal IX secolo e che, quindi, sia credibile che la Sifilide
fu importata in Europa dalle caravelle di Colombo di ritorno dal Nuovo Mondo. Il nome di sifilide
fu dato da Fracastoro nel suo celebre trattatopoema Syfilis seu de morbo gallico. Lautore
presume che la malattia provenisse dalla Francia, importata in Italia dalle empie guerre galliche.
Il poema consta di 1300 raffinati esametri. I Francesi chiamarono il morbo gallico mal italien o
mal napolitain, e gli Inglesi french disease. I Giapponesi mal dei Turchi e i Turchi mal dei
Cristiani. Il nome deriva da Sifilo, mitico pastorello che, avendo osato protestare contro Apollo
che non laveva protetto contro la carestia, venne punito dal dio con quella malattia che provocava
pustole e ulcere che poi scomparivano, ma non la malattia che ricompariva con rigonfiamento delle
ossa. La Sifilide non era distinta dalla gonorrea, con la quale fu sempre confusa fino al 1879.
Verso il Metodo scientifico in Medicina
Il pensiero dellultimo periodo del Medio Evo e del Rinascimento si evolve nel senso
dellantiautoritarismo: nessuna autorit possiede la verit assoluta, immutabile. Non si cerca pi
61
lorigine prima delle cose, la causa causarum metafisica, ma lo studioso rivolge il suo sforzo
allesame del fenomeno in s, allo studio della materia, della Natura, col rigore del ragionamento
non solo, ma con lesigenza dell experimentum. Queste esigenze hanno origini lontane, e sorgono
proprio dallinterno della Chiesa, dove germogliano fermenti sempre ai limiti delleresia,
linsofferenza dei clerici vagantes, il confronto tra santi ed eretici, con divisioni talora cos sottili
che solo piccole differenze hanno imposto laureola a taluno e il rogo agli altri. Abbiamo ricordato i
francescani della Scuola di Oxford, Duns Scoto e Ruggero Bacone; citiamo ora, come figura
emblematica di questa esigenza di opposizione all' ipse dixit, Sant'Alberto Magno (Colonia 1193
-1282). Per primo ha il coraggio di opporsi allautorit di Plinio in biologia: lipse dixit nella
scienza non ha nessun valore: experimentum solum certificat. Le cose sono vere solo se probatae
per experimentum. E lesperimento deve essere ripetuto alla presenza di moltiEgo et multi
mecum de sociis vidimus: experti sumus ego et socii mei: io, i miei collaboratori, assistenti, abbiamo
visto...
Esperimento fatto personalmente dallo sperimentatore o da esperti: experto crede Ruperto: credi
allesperto Rupertofidati.
Nelle sue opere quindi non riferisce semplicemente le cose asserite dai classici, ma riporta quanto
lui stesso ha provato. Si tratt di precisa osservazione del fenomeno, rigorosa e confermata; non di
vero esperimento in senso moderno: Galilei era ancora lontano. Certo ne fu un anticipatore, un
precursore. Il dubbio metodico era la sua guida: il fenomeno osservato era provato dal fatto
sperimentato.
Solo dopo circa quattro secoli dovette maturare il Metodo scientifico di ricerca: attenta
osservazione di ciascun fenomeno, valutazione di pi fenomeni fino a risalire alla legge naturale
che li regola, riproduzione del fenomeno secondo la legge che lha prodotto. Questo sar il metodo
di Galileo Galilei che sar possibile adottare solo con lavvento della tecnologia che permetter di
quantificare il fenomeno e di ridurlo a formula matematica.
La Medicina solo con lapplicazione di questo metodo potr veramente avanzare come scienza
che indaga sulla materia. Luomo tuttavia non composto di sola materia riducibile in formule, ma
anche di Psiche che dirige ragione e irrazionalit, che sfuggono alle regole della matematica.
62
IL RINASCIMENTO SCIENTIFICO DEL SEICENTO
Della necessit che anche la verit biologica debba essere certificata dallexperimentum e che
la prova debba essere ripetibile aveva gi parlato SantAlberto Magno. Si dovette per arrivare al
600 perch questo postulato divenisse oggetto di pratica attuazione. In questo secolo i due pilastri
della via scientifica alla conoscenza, il razionalismo e lempirismo, furono in dissidio tra loro: da
una parte lo studio di ci che positivamente esiste, la sperimentazione del fatto reale, dallaltra
lattivit pensante di ciascun individuo, il suo raziocinio, il suo giudizio. Ambedue le vie parallele
contribuirono allo sviluppo e al progresso della conoscenza.
Il principale esponente del Razionalismo fu Cartesio (15961650).
Il pensiero, la ragione ha preminenza sulla sensazione (gi lo affermava Campanella). La
sensazione pu essere fallace; di ogni cosa dunque si deve innanzi tutto dubitare. Il dubbio
sistematico, razionale: la preminenza del ragionamento: cogito, ergo sum. La concezione del mondo
secondo Cartesio quella di Democrito: la materia composta da corpuscoli in movimento entro il
vuoto; il movimento reciproco dei corpuscoli produce le diverse realt esistenti della vita. Fonte
prima dei movimenti lanima, con sede nella ghiandola pineale. Le leggi quindi che regolano il
movimento, le leggi della meccanica, mantengono e regolano il mondo. Scrisse Discours de la
mthode. Suo merito principale fu quello di richiamare lattenzione sulla materia accessibile allo
studio diretto delle sensazioni e di porre il dubbio a regola del raziocinio.
Il principale esponente dellEmpirismo fu Francesco Bacone (15611626).
Ebbe il merito di farsi entusiasta banditore della dottrina che basava ogni fondamento di conoscenza
nella esperienza data dagli organi di senso. Il suo metodo si esplica in due fasi: una negativa, basata
sulla critica delle illusioni, laltra positiva basata, sullo studio sperimentale dei fenomeni, di ciascun
fenomeno: dal particolare alluniversale. E il metodo induttivo. Linverso di quanto aveva
insegnato Aristotele: dalluniversale al particolare (metodo deduttivo). Scrisse il Novum organum.
Determinante per la conoscenza scientifica fu lopera di GALILEO GALILEI (15641642). Egli
realizz una vera rivoluzione nel metodo dindagine scientifica: descrisse e pratic il Metodo
sperimentale, tuttora valido per la ricerca scientifica. I capisaldi del metodo sono:
1) Osservazione del fenomeno, fisico o biologico.
2) Valutazione del fenomeno rendendolo quantificabile in termini matematici.
3) Ricerca della legge naturale che produce e regola il fenomeno.
4) Riproduzione del fenomeno applicando la legge scoperta che lo determina.
La ripetizione dellesperimento diventa quindi la controprova dellesattezza della legge trovata.
Loggetto della scienza, in senso galileiano, la Legge che regola il fenomeno, non lEssenza delle
cose, oggetto della filosofia. E la scienza misura. Lintera Natura e i fenomeni fisiologici e
patologici vengono cos ricondotti alla vera oggettivit, espressa con numeri. Il Metodo galileiano,
matematico sperimentale, applicato a tutte le scienze, mut profondamente la forma mentis di fronte
al problema della conoscenza. Nelle scienze esatte la legge esprime il rapporto costante e
necessario tra due fenomeni: ammesso il primo (causa), ne consegue di necessit il secondo
(effetto). E il procedimento induttivo.
Effetto diretto del metodo fu il progresso dello strumentario clinico. Principale e fondamentale
invenzione di strumenti dindagine fu il Microscopio. La paternit dellinvenzione non certa. La
prima menzione di uno strumento per vedere cose invisibili si ricollega a Galileo che denomina
occhialino lo strumento da lui realizzato nel 1610 sullidea del cannocchiale. Il nome
microscopio appare nel 1625 in una lettera di Giovanni Faber, medico di Urbano VIII. Grande
costruttore e perfezionatore di microscopi fu Leeuwenhoek che costruiva personalmente lenti
biconvesse capaci di 270 diametri.
63
Le Accademie scientifiche
La prima di esse fu lAccademia dei Lincei, fondata dal principe Federico Cesi nel 1603. Aveva
come stemma una lince, dagli occhi indagatori, che atterra lIdra, con il motto Sagacius ista.
LAccademia del Cimento, col motto Provando e riprovando, fu fondata dal Card. Leopoldo de
Medici nel 1657. Da essa presero spunto le accademie scientifiche straniere.
Sorse la Royal Society, di Londra ad opera di Carlo II nel 1662, e lAcadmie Franaise ad opera
del Card. Richelieu nel 1635.
LAccademia dei Lincei, dopo varie vicissitudini, fu chiusa nel 1840 da Gregorio XVI, riaperta da
Pio IX col titolo di Pontificia Accademia dei nuovi Lincei, poi definitivamente costituita nella
attuale Pontificia Accademia delle Scienze da Pio XI. Fusa nel 1939 con lAccademia dItalia.
Ricostituita nel 1944 come Accademia dei Lincei.
Le Scuole Jatromeccanica e Jatrochimica
Il 1500 fu il secolo dei grandi anatomici. Il 1600 vide soprattutto rinascere linteresse per
linterpretazione delle funzioni che gli organi biologici, per la loro struttura e conformazione,
dovevano esercitare. Lo studio appunto della Fisiologia.
Due orientamenti contrapposti tentarono di interpretare e spiegare i fenomeni biologici, normali o
patologici. Uno, di ispirazione galileiana, li interpretava sulle basi della meccanica, laltro sulle basi
della chimica. Furono le due scuole: jatromeccanica e jatrochimica.
Scuola jatromeccanica
Secondo questa Scuola le funzioni del corpo umano sono effetti meccanici della macchina umana.
Conservano tuttora una certa validit le interpretazioni delle funzioni relative allazione muscolare e
alcuni fenomeni della meccanica respiratoria. Caposcuola fu Santorio Santorio (15611636),
inventore di vari strumenti scientifici: us per misurare la febbre lo scherzino, termometro ad
alcool inventato da Galileo. Invent il pulsilogio per misurare le pulsazioni delle arterie
(frequenza e ritmo) e l igroscopio per misurare la umidit dellambiente. Fu soprattutto famoso
per luso sistematico della bilancia. Invent la statera a seggiola, pesando i malati prima e dopo i
pasti, prima e dopo le escrezioni, prima e dopo ogni attivit fisica, e scopr che gli escreti, con le
urine e le feci, pesavano meno della quantit di cibo ingerita: qualcosa quindi doveva sfuggire alle
vie fecale e urinaria, qualcosa doveva essere eliminato per altre vie: la via cutanea e polmonare.
Chiam questo fenomeno perspiratio superficialis.
In terapia prescriveva ricette molto semplici e consigliava attenzione per lambiente, lo stato
danimo, lo stile di vita e lattivit sessuale, che influenzano positivamente o negativamente
lattivit delle escrezioni. Affermava che lallegrezza rende pi facili la sistole e la diastole; il
timore e la mestizia le rende pi difficili.
Tornato a Venezia carico degli escrementi dei nobili di mezza Europa, fu docente allUniversit di
Padova finch gli studenti ne ottennero le dimissioni per assenteismo: era troppo occupato con la
professione privata.
64
Altro grande esponente di questa Scuola fu Alfonso Borelli (16061679). Fu matematico allievo
di Galilei. Condusse studi sul movimento degli animali: lattivit muscolare dovuta ad una
sostanza attiva, mentre i tendini e le fibre erano interpretati come semplici strutture di supporto.
Attribu la forza meccanica della sistole cardiaca alla disposizione a spirale delle fibre muscolari
del ventricolo, e il flusso ematico alla elasticit delle arterie, e, inoltre, la inspirazioneespirazione
allattivit dei muscoli toracici. Sostenne che nello stomaco esiste un succo corrosivo che
trasforma il cibo da solido in liquido. Le febbri maligne erano da lui interpretate come dovute ad
evaporazione di particelle velenose che, ricadendo al suolo, lo inquinavano, provocando cos le
febbri: non quindi per contagio, come sostenevano altri, specialmente Fracastoro.
Da ricordare Giorgio Baglivi (16681707), strenuo sostenitore dello sperimentalismo per spiegare
i fenomeni biologici alla luce delle scienze, ma ippocratico sul piano della attivit clinica. Studi al
microscopio le fibre muscolari e distinse i muscoli in lisci e striati. Studi gli aspetti fisiologici della
saliva, della bile e del sangue. Il medico doveva essere il ministro della natura, che ne ascolta i
principi e li classifica e raggruppa: precedenti morbosi, sintomi in atto, complicazioni: il tutto
digerito forma la Storia naturale della malattia. Come le lettere dellalfabeto che da sole non
dicono nulla, ordinate e collegate, invece, formano un chiaro linguaggio.
Scuola jatrochimica
Accanto alla Scuola jatromeccanica e in contrapposizione ad essa si sviluppava nello stesso
periodo, la Scuola jatrochimica che basava ogni interpretazione dei fenomeni biologici su concetti
chimici. Ispiratore e precursore di questa scuola fu G.B. von Helmont (15771644), seguace delle
idee di Paracelso ebbe felici intuizioni frammiste a idee misticooccultistiche che ne fecero uno
strano medico alchimista, sempre sotto i rigori e il controllo dellInquisizione. Riteneva che
esistessero diverse forze attive, archei, accompagnate da materia aeriforme, da lui stesso chiamata
gas, e da movimento, chiamato blas, energia che trasforma la materia.
Alla base di ogni processo fisiologico e patologico sta la fermentazione, concetto che trov
favorevole eco tra i medici jatrochimici. Us per primo il termine saturazione per indicare il
completo stato di soluzione e intu che la materia disciolta nel solvente non veniva in esso distrutta.
In terapia seguiva gli insegnamenti di Paracelso e ne usava le sostanze: guar dalla scabbia con i
medicamenti del maestro svizzero, mentre quasi soccombeva ai salassi della medicina galenica.
Il vero fondatore della Scuola jatrochimica fu Francesco Dubois (16141672), De la Bo di
Hanau che latinizz il suo nome in Sylvius. Sostenne che le fermentazioni sono alla base di ogni
processo vitale. Dalla fermentazione scaturiscono tre umori fondamentali: saliva, bile e succo
pancreatico, elementi fondamentali nel processo della digestione. Oltre alla fermentazione si svolge
nel sangue anche il processo di effervescenza, ebollizione: lurina si formerebbe dal sangue per
effetto delleffervescenza che stacca dalla massa ematica delle particelle piccolissime che,
ammassandosi, costituiscono lurina. Scopr che i sali sono la risultante della combinazione di
acidi con alcali. AllUniversit di Leida, dove insegnava, introdusse un corso di Laboratorio
quale complemento allo studio della Clinica medica. Come anatomico descrisse larteria,
lacquedotto e la scissura che portano il suo nome.
Alcune nozioni introdotte dalla scuola jatrochimica restano tuttora valide. Nel 600, tuttavia, la
scuola incontr strenui avversari per la difficolt di scalzare la indiscussa autorit di Galeno.
65
Tra i pi accaniti fu Gui Patin (16011672), violento polemista contro i medici jatrochimici e
contro i medicinali chimici, primo fra tutti lantimonio attivo contro la sifilide e dichiarato efficace
dalla Facolt di Parigi. Strenuo galenista, non tralasci nulla contro gli jatrochimici: scrisse
Martyrologium Antinomii, dove elenca le vittime di quel medicinale.
Altro oppositore fu Roberto Boyle (16261691), che considerato invece il padre della chimica
moderna. Nellintento di demolire la teoria empedocleoaristotelica dei quattro elementi - aria,
acqua, terra, fuoco -, introdusse il moderno concetto di elemento, sostanza, composto: Io
intendo per elementi certe sostanze semplici e primarienon costituite da altredette corpi
composti in cui in ultima analisi possono risolversi. Scoperse la legge che porta il suo nome: il
volume di un gas a temperatura costante inversamente proporzionale alla pressione.
..
Alcuni medici tentarono di conciliare le teorie jatrochimiche con le idee di Galeno. Tra i pi
rinomati B. Ramazzini (16331714), seguace per la clinica della sempre valida scuola ippocratica,
e, alle soglie dellilluminismo, autore della prima opera di medicina del lavoro, De morbis
artificum (1700). Fu professore a Modena e Padova.
Anche Alessandro Pascoli (16691757), professore a Perugia realizz un sano eclettismo tra il
tradizionale galenismo e le nuove teorie derivate dalle scienze. Scrisse Il corpo umano, o breve
storia dove con nuovo metodo si descrivono in compendio tutti gli organi suoi e i loro principali
uffizi. Venezia MDCCL.
..
Il merito delle Scuole jatromeccaniche e jatrochimiche fu soprattutto quello di far avvicinare gli
ingegni pi dotati tra i medici al fascino delle nuove scoperte della Fisica e della Chimica, scienze
che, grazie al metodo galileiano, divennero esatte, sotto il controllo del rigore matematico. A
regolare i fenomeni biologici sono forze fisiche, mutamenti chimici: azioni di acidi, alcali, sali:
sostanze misurabili, quantit numeriche: fenomeni sottoposti al vaglio dellesperimento, ripetibile
secondo leggi fisse, scoperte dallesperimento stesso.
La medicina sincammina sulla giusta strada per arrivare alla Scienza.
Concetto microbiologico: il contagio animato
Accanto allinterpretazione fisica e chimica dei fenomeni patologici continuava a mantenersi
viva lidea che talune malattie fossero causate dal contagio di animaletti nati per generazione
spontanea dalla putrefazione: le idee di Fracastoro continuavano ad aver seguaci. I suoi seminaria,
semi, diventano i vermi di Kircher (Mundus subterraneus 1678), che a miliardi popolano la
putredo animata e che per contagio si diffondono provocando le malattie: la peste, la malaria, la
sifilide. Il piccolo essere vivente, microbio, spontaneamente si sviluppa in innumeri esemplari, dalla
putredo, putrefazione, causa di malattia. Putrefazione che corrompe gli umori. E seppure
Leeuwenhoeck (16321723) e Redi abbiano visto al microscopio gli infusori nel 1675, grossi
protozoi cigliati, e altri microrganismi, nel tartaro, negli intestini di rane e cavalli, non hanno potuto
per stabilire il nesso di causaeffetto tra microrganismi e malattia. Neppure la scoperta dellacaro
della scabbia, il pellicello di Cestoni (1687), sugger lidea dei microbi come causa di malattia.
Anche per Malpighi (1665) i microrganismi sono solo parassiti non causa di malattia.
Bisogner aspettare Bassi, Pasteur, Koch.
66
Le malattie psichiche , indemoniati e streghe
Furono studiate da Paolo Zacchia (15841659), il quale tratta delle varie malattie mentali
aggredendo la spinosa questione degli indemoniati: sulla possessione diabolica trova un
compromesso tra fede religiosa e scienza. Luca Tozzi (16301717) nellopera Medicina pratica
distingueva le vesanie in frenesia, furore e delirio melanconico. Da ricordare le epidemie psichiche
di indemoniati, tra le pi gravi quella, memorabile, del monastero delle Orsoline di Loudun che
cost la vita sul rogo a U. Grandier, il curato accusato di averla provocata (1654).
Si deve registrare uninnovazione nel metodo di cura degli indemoniati: prima dellesorcismo,
vera cura per scacciare il demonio, ospite infernale che corrompeva gli umori, gli ammalati
venivano opportunamente preparati, mediante depurazione a base di salassi, emetici, purghe,
clisteri, allo scopo di far evacuare gli umori peccanti e facilitare la cura con lesorcismo.
Come accade in tutte le epoche, accanto al progresso del pensiero medico convive parallela una
medicina ieraticodemoniacostregonesca. Anche nel 600 le streghe esercitavano la loro
professione di guaritrici e credevano veramente, in buona fede, di essere depositarie di poteri loro
conferiti dal demonio, col quale avevano commercio nel sabba dove si radunavano. La strega
prima di volare al sabba si chiudeva nella sua stanza o laboratorio, dove completamente nuda
si spalmava con la pomata magica, mentre lambiente era completamente invaso da fumi di
sostanze atte a favorire le evocazioni: oppio, giusquiamo, mandragora, belladonna, tutte dotate di
potere stupefacente e allucinogeno. Avevano visioni infernali, apparizioni di demoni con i quali, in
preda ad esaltazione sessuale, credevano di avere rapporti carnali. Dopo il viaggio la strega si
ritrovava stremata nel suo letto, spesso polluta, quasi a riprova del commercio demoniaco.
Questa spiegazione dei viaggi e della attivit delle streghe sembra essere suffragata da resoconti
storici quali quelli del Nider (13801438). Il quadro della stregoneria pu essere riassunto con una
diagnosi moderna: delirio cronico sistematizzato su base allucinatoria tossica.
Per quanto riguarda il trattamento della pazzia, in definitiva degli indemoniati, si deve notare, nel
XVIXVII secolo, un accenno di cambiamento: mentre prima venivano trattati come dei colpevoli,
e spesso meritevoli del rogo, con la Bolla di Gregorio XIV veniva abolito tale supplizio.
Nel 1616 si erigeva, in Bologna, un Serraglio per le streghe, come previsto nelle Case della
Piet: il contatto continuo con queste psicopatiche, il loro ricovero in appositi ospizi, fece allora
sorgere il dubbio sulla loro malattia mentale, e non invece un giudizio di colpa, loro sino ad allora
riservato.
LA CIRCOLAZIONE DEL SANGUE
Galeno, come noto, riteneva che il sangue, spinto alla periferia dal cuore si esaurisse nelle
estremit per la nutrizione dei tessuti senza ritornare al cuore. Questa teoria dominava in via
assoluta anche nel 600, pure se Miguel Serveto e soprattutto Andrea Cesalpino avevano intuito e
prefigurato lidea di una circolazione del sangue. In particolare il Cesalpino aveva introdotto
lespressione circulatio sanguinis e ben interpretato il fenomeno del laccio concludendo che
dovevano esistere due correnti sanguigne: una dal cuore alla periferia e una dalla periferia al cuore,
come avveniva esemplificava - nel fiume Eurito. Neppure il grande Fabrizi dAcquapendente
quando, nel 1574, scopr lesistenza delle valvole delle vene pot interpretarne la funzione di aiuto
al ritorno del sangue al cuore: segu il grande Galeno e pens che rallentassero il flusso verso la
periferia per meglio nutrire i tessuti.
Nel 1595 giunse a Padova dal Kent la giovane matricola di medicina GUGLIELMO HARVEY
(15781657), alla scuola del Fabrizi quando in quellUniversit insegnava anche Galilei. Fu proprio
67
il metodo matematico a suggerire ad Harvey lidea che la teoria di Galeno doveva essere errata: se
si moltiplica la mezza oncia di sangue che ad ogni contrazione il cuore spinge nellaorta per 1000
pulsazioni, occorrerebbero 500 once di cibo per nutrire il corpo:una quantit enorme, impossibile
se calcolata nelle 24 ore.
Ne dedusse che la quantit di sangue presente nel corpo deve essere costante, e ci era possibile
solo se il sangue circolava nellorganismo, come appunto aveva sostenuto il Cesalpino per la
circolazione polmonare. Seguendo il metodo della scuola patavina, Harvey approfond l
anatomia, la fisiologia e lanatomia comparata. Studi la meccanica dei movimenti del cuore: gli
atri si contraevano dopo i ventricoli; i ventricoli si contraevano contemporaneamente; le valvole
cardiache (scoperte da Leonardo) si chiudevano durante la sistole e si aprivano nella diastole. Estese
lo studio a vari e numerosi animali, determinando la fisiologia sulle comparazioni anatomiche. Mise
in relazione il polso periferico delle arterie con la sistole cardiaca. Nel 1628 Harvey pubblica la sua
famosa Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, dedicata a Carlo I.
Partendo dalla conoscenza dellesistenza delle valvole delle vene ne determina la corretta
interpretazione: la loro disposizione anatomica si oppone al corso centrifugo del sangue venoso, ma
permette il flusso centripeto, verso il cuore. E riprendendo la figura del braccio teso con laccio
dellopera dellAcquapendente, De venarum ostiolis, la completava con una additio: un indice
interrompe il turgore delle vene tra valvola e valvola, strisciando dalla periferia verso il centro. Cos
dalla scoperta del maestro, Harvey giungeva, dopo 44 anni, alla grande scoperta della circolazione
del sangue, seguendo il metodo matematico sperimentale di Galileo e anatomico-comparato
dellAquapendente: ambedue della Scuola patavina. Non riusc tuttavia a stabilire il punto di unione
tra sistema arterioso e sistema venoso: alla periferia il sangue si sparge in carnis porositates, in
lacune sanguigne, per essere ripreso dalle piccolissime vene: non sono riuscito a trovare alcuna
connessione tra arterie e vene per mezzo di una diretta anastomosi dei loro orifizi.
Per la scoperta dei capillari bisogner attendere Malpighi.
La grande scoperta non ebbe subito riconoscimento, che anzi fu molto avversata. Guido Patin la
giudic paradossale, falsa e nociva, e Jacopo Primerose ne confutava linterpretazione sia anatomica
che funzionale. Ma sopra tutti Riolano fu strenuo oppositore: Galeno non poteva sbagliare: certo la
Natura era cambiata. La nuova teoria fu difesa da Cartesio e confermata da Nicola Stensen,
Stenone, e finalmente universalmente accettata con la pubblica ritrattazione di Fortunato Plemp,
Plempio, nel 1652.
La composizione del sangue
La composizione del sangue venne scoperta in seguito. Malpighi nel 1665 scopr i globuli rossi:
di forma piatta e ovale. Leeuwenhoeck nel 1674 ne determin la grandezza. Riccardo Lower stabil
che il colore rosso del sangue arterioso era dovuto alla sua mescolanza con lo spirito nitroaereo,
evidentemente con lossigeno, e che tale mescolanza avveniva nei polmoni.
Il XVII secolo fu ricco di scoperte fondamentali nel campo anatomicofunzionale che
rappresentarono la base di partenza per successivi studi che costruirono la moderna medicina.
Diamo un succinto elenco degli Autori e delle scoperte che portano il loro nome.
Warton (16141675): la ghiandola sottomascellare.
Spigelio (15781625): struttura del fegato: Lobo di Spigelio.
Glisson (15971677): struttura del fegato: la capsula.
R. De Graaf (16411693): pancreas e follicolo ovarico.
Bartolini (16161680): ghiandole vulvari e vasi linfatici e chiliferi.
Pecquet (16221674): congiungimento dei vasi linfatici (cisterna).
F, Ruysch (16381731): valvole dei vasi linfatici (scoperti da Aselli nel 1622). Famoso per la sua
bella collezione di cadaveri che ispir a Leopardi il Dialogo di F. Ruysch e delle sue mummie.
68
MARCELLO MALPIGHI
Merita particolare menzione Marcello Malpighi (16281694), figura di vero scienziato che nelle
sue successive scoperte perseguiva un piano preciso di indagine: scoprire la intima struttura
biologica della vita, sia vegetale che animale, nella loro unicit.
La sua prima e fondamentale scoperta fu quella dei capillari (1660), che chiude cos il circolo del
sangue, dal cuore al cuore, attraverso dei piccolissimi vasi, di struttura particolare, nei quali il
sangue passa dalle arterie alle vene, trasformandosi da arterioso in venoso.
Nel 1661 scopre la struttura dei polmoni: come un favo dapi, nelle cui celle confluiscono i
bronchi, sempre di minor calibro, che trasportano laria.
Altra fondamentale scoperta fu quella della cellula, unit fondamentale di tutta la struttura
anatomomicroscopica di tutta la natura vivente: degli animali e delle piante. Cos studiando la
gemma dei vegetali, comparativamente allo studio dellovulo e dellembrione di pollo, fu portato
a concludere che omne vivum ex ovo, apporto fondamentale contro la imperante teoria della
generazione spontanea.
Scopr inoltre le papille linguali, lo strato corneo della pelle, i corpuscoli della milza e la struttura
ghiandolare del fegato. Importante scoperta fu quella dei glomeruli renali e del meccanismo della
formazione dellurina: i diuretici agiscono sui vasellini dei glomeruli in via diretta e non solo per
filtrazione meccanica.
Nemico del facile uso dei farmaci e della loro somministrazione senza lesatta indicazione, comp
studi accurati sui loro meccanismi dazione tanto da poter essere considerato liniziatore della
farmacologia sperimentale: provava tossici e farmaci sugli animali per scoprirne lazione mediante
lesperimento.
Nella stessa direzione si muoveva in Italia il Redi e il Vallisneri e il padre della moderna chimica,
Boyle.
La generazione e la fecondazione
Ancora in questo secolo dominava il concetto della generazione spontanea, secondo le teorie di
Aristotele. Il moderno impulso scientifico, per, e la scoperta del microscopio contribuirono ad
orientare la ricerca sulla giusta strada. Omne vivum ex ovo, aveva concluso Malpighi. Nel periodo
tra il 1664 e il 1677 Leeuwenhoek e Hartsoeker, videro e descrissero al microscopio gli spermatozoi
scoperti da J. Ham nel 1677, mentre R. De Graaf (16411693) nel 1672 aveva scoperto i follicoli
ovarici, che lui credeva veri ovuli (scoperti poi nel 1827 da von Baer). Ma come avveniva la
fecondazione delluovo? Due erano le teorie. La epigenesi e il preformismo.
I preformisti, con Leeuwenhoek, ritenevano che dagli spermatozoi, ritenuti uomini in miniatura,
homunculi, elemento germinale primitivo, si sviluppasse successivamente ogni nuovo essere
umano, o animale. Secondo lepigenesi, invece, ogni essere vivente si sviluppava dalla materia
omogenea e indifferenziata per virt di una forza vitale creatrice. Altri pensavano che l omuncolo
non fosse rappresentato dallo spermatozoo ma dallovulo: ovisti invece di animalculisti.
Il Malpighi dalla cattedra di Bologna e il Vallisneri dalla cattedra di Padova furono preformisti.
Preceduto da altri studiosi, diede fondamentale contributo alla demolizione della teoria della
generazione spontanea Francesco Redi (16261698), medico, naturalista, letterato, poeta. Egli
esegu le sue esperienze di biologonaturalista con perfetta regola darte, secondo il metodo
sperimentale. Autore del famoso ditirambo Bacco in Toscana, fu figura singolare: Al volto
69
macilento e al collo torto, \ ognun mi crederebbe un San Francesco, \ ma se col fiasco mi vedesse al
desco \ si accorgerebbe aver creduto il torto.
La sua opera Intorno alla generazione degli insetti, 1668, fu la prima dimostrazione
dellinfondatezza della generazione spontanea. E la sua opera Osservazione intorno agli animali
viventi che si trovano sugli animali viventi, 1684, da considerasi la prima pietra della
Parassitologia di cui pu ritenersi il fondatore.
L ostetricia
Abili chirurghi si dedicarono nel XVII secolo allarte dellostetricia e allo studio della gravidanza,
del parto e delle malattie dei neonati. Da ricordare per primo Francesco Mauriceau (16371709) la
cui manovra per lestrazione del feto pour la tte dernire, nella presentazione podalica, tuttora
praticata. Descrisse inoltre il rivolgimento podalico, i movimenti fetali e le diverse posizioni del
feto in utero. Fu nemico delloperazione cesarea su madre vivente per i troppi casi di esito letale per
la madre e per il feto. Non laureato in medicina, scrisse il trattato Des maladies des femmes grosses
et de celles qui sont accouches. 1668.
Altrettanto nemico del taglio cesareo fu il prevosto Filippo Peu, morto nel 1707. Fu contrario alla
tecnica della esplorazione vaginale ripetuta troppo spesso e alla forzata apertura del collo uterino.
Invece del tiratesta di Mauriceau us uno strumento smusso per poter estrarre il feto ancora vivo, e
poterlo battezzare.
Da ricordare le celebri levatrici, quali la Boursier, Luisa Bourgeois (15631636), allieva del Par;
salv la vita al futuro Luigi XIII nato asfittico(1601). In Germania Giustina Siegmundin assegnava
alle forze della natura la preminenza nellassistenza al parto: la natura massimo fattore nel parto.
In questo secolo fu inventato e si diffuse uno strumento che divenne fondamentale nellassistenza
al parto distocico: il forcipe. Lorigine di questo strumento non molto chiara, e attorno alle
vicissitudini della sua diffusione e del suo inventore sono molto intricate la storia e le leggende.
Sembra assodato che lo strumento sia nato nella famiglia inglese Chamberlen (originariamente
Chamberlein?), e probabilmente il figlio Pietro ne fu linventore prima del 1670. Fu tenuto segreto
dalla famiglia che poi lo vendette in Francia da dove si diffuse: molti furono gli oppositori, tra i
quali Mauriceau, Guillemeau e Peu.
Farmacodinamica e Terapia . Medicina alternativa
Abbiamo gi accennato alla farmacologia sperimentale ad opera di Malpighi, Vallisneri, Redi
Willis e soprattutto Boyle. I precursori delle nuove indagini furono Paracelso alla ricerca del
principio attivo, depurato dalla sostanza vegetale che lo contiene, mediante il solvente universale, e
von Helmont che aveva intuito come i farmaci dovevano agire non solo localmente, ma diffondere
la loro azione allintero organismo. Dalla teoria spagirica (di riunire le sostanze) si tenta di fissare i
principi della farmacodinamica, e ci mediante il metodo sperimentale. Lemery, usando come
mezzo estrattivo lalcool si era incamminato sulla giusta strada.
Tra i fisiologi di Oxford deve essere ricordato Thomas Sydenham (16241689), chiamato anche
lIppocrate di Oxford, per la sua abilit professionale, per lammirazione del grande medico antico e
per la sua fiducia nelle forze medicatrici della natura: tutto ci che utile buono. Intravide i ritmi
di certe malattie: stagionali ed epidemici, dovuti a fenomeni meteorologici e tellurici. Superando la
jatromeccanica e la jatrochimica cercava di portare la chimica al contatto diretto dellammalato, la
cui storia e sintomatologia doveva guidare la cura. Il suo nome legato agli studi sulla gotta e alla
proposta di usare contro di essa la nuova sostanza degli alberi di kina kina proveniente dal Per.
Visse e descrisse la peste (o influenza?) di Londra, 167576.
70
Le nuove droghe introdotte nel 600 nella Terapia furono il caff, il cacao, lipecacuana, e
soprattutto la china, oltre alloppio e alla valeriana. Tra gli alimenti fu introdotta la patata. Del caff
avevano parlato gli arabi, Rasez e Avicenna. In Europa, dal 1615, sorsero le botteghe del caff,
famose quelle di Venezia. Gli effetti della nuova droga non erano ben chiariti. Redi la riteneva
narcotica mentre Willis eccitante: probabilmente ci era dovuto alle dosi e alla costituzione dei
pazienti. Nel 1520 Cortes importava dal Sudamerica il cacao che, si dice, abbia guarito il Card.
Richelieu dallipocondria. Anche il the comparve in quellepoca: se ne occuparono il Malpighi e il
Redi (1672). Ma il medicamento pi importante e che fece anche pi scalpore fu la corteccia
dellalbero della china. Narra la leggenda che un soldato spagnolo, febbricitante, fosse caduto nelle
acque di un lago nel Per, molto amaro per le foglie dellalbero di china macerate nella sua acqua,
della quale ne bevve: il giorno dopo la febbre era scomparsaLa contessa Chincon, moglie del
vicer del Per, diffuse luso terapeutico della droga in Europa. (O furono invece i Gesuiti
attraverso lopera del loro cardinale De Lugo?). Linneo, comunque, la chiam cinchona in onore
della contessa.
Il suo uso diede modo di studiare le febbri perniciose. Francesco Torti (16581741) le classific
meglio e stabil la dose sufficiente di chinina per ogni tipo di malattia, secondo la fase evolutiva di
esse. La droga era indicata non solo per le febbri, ma anche per i loro postumi. Il tutto sulla base
dellesperimento clinico e nel recupero di un sano ippocratismo, metodo proprio della scuola
patavina dellepoca.
Loppio fu in auge grazie a Sydenham che lo us sotto forma di tintura, il laudano, che porta il suo
nome. Lantimonio e il mercurio, come abbiamo accennato, movimentarono la storia della
farmacologia del 600.
..
Come sempre, accanto a una terapia su basi scientifiche, prosperarono il magismo, lastrologismo,
la segnatura, la stregoneria e luso di pietre preziose: la medicina alternativa, si direbbe oggi.
La triaca fu ampiamente in uso, specialmente a Venezia. E lorvietano (da Lupi di Orvieto?), la cui
formula rimase sconosciuta, efficace anchesso per quasi tutte le malattie, fu fonte di grandi
guadagni. Da segnalare luso di tazze terapeutiche, impastate soprattutto di antimonio con effetto
emeticopurgativo. Nelle tazze si versava vino che doveva soggiornarvi 12 o 24 ore, a seconda
della stagione. Lantimonio era anche somministrato in pillole, in modo circolatorio: prima
venivano ingoiate, poi, emesse per sotto e lavate, venivano re-ingoiate: erano le pillole perpetue.
Per qualsiasi malattia, ma soprattutto per la scrofola.
Per chi si trovasse sul posto giusto e avesse pazienza, cera la possibilit di sfilare davanti a un Re
(specialmente in Francia e in Inghilterra), che, toccata la parte lesa, lavrebbe guarito.
La pratica dellimposizione delle mani per la guarigione, oltre che per infondere potere, grazia e
coraggio, antica. Persino San Tommaso dAquino racconta che re Clodoveo guar un suo paggio
toccandolo opportunamente. Tra i pi famosi guaritori furono San Luigi IX, re di Francia e Edoardo
il Confessore, re dInghilterra.
Ma anche nel 1824, Carlo X di Francia tocc 121 malati, presentati dai famosi medici Albert e
Dupuytren.
Emotrasfusione
Il Seicento vide inoltre le prime applicazioni della trasfusione di sangue. Da sempre il sangue fu
ritenuto fonte di energia, forza vitale: antica quindi lidea che la sua immissione nel corpo debole o
malato potesse rinvigorire. Tra i precursori della pratica attuazione della trasfusione fu Giovanni
Colle (Belluno 15581631) e sopra tutti Francesco Folli (16231685) che concep lidea nel
71
1654, prima di Denys e di Lower in Inghilterra. Ne descrisse la tecnica particolareggiata e
lapparecchiatura: nella vena del ricevente veniva infitta una cannula doro, o di penna di corvo,
collegata ad un tubicino fatto di budellino di animale, collegato ad una piccola imboccatura dosso
tornito, da infiggersi e legarsi sulla ferita da salasso del donatore. Le braccia erano poste in croce,
quella del donatore sopra quella del ricevente. Invi la descrizione della sua scoperta al Granduca
di Toscana Ferdinando II che, malgrado ripetuti solleciti, non rispose mai.
Intanto nel 1666, Riccardo Lower realizz lemotrasfusione da animale ad animale e Giovanni
Battista Denys, morto a Parigi nel 1704, trasfuse il 15 giugno del 1667 nove once di sangue di
pecora ad un ragazzino di 15 anni, gravemente prostrato dopo ben venti salassi consecutivi. Le
successive trasfusioni non andarono sempre bene: molti ne morivano. Venivano usate per le pi
svariate situazioni morbose. Poi invece riservate a compensare le emorragie e a prevenire lo shock
conseguente. I numerosi insuccessi la fecero bandire dalla Facolt di Parigi e proibire con bolla
papale. Contemporaneamente e con gli stessi strumenti nasceva la pratica delle iniezioni
endovenose: Vahrendorff, 1642, su cani, con vino per rinvigorirli nella caccia. In Italia fu G.
Fracassati ad interessarsi dellargomento dandone notizia, nel 1665, a Malpighi. Come la
trasfusione, la pratica delle iniezioni and in disuso.
Per quanto riguarda lalimentazione, lintroduzione della patata dal nuovo mondo subito si diffuse e
divenne fonte basilare energetica per le popolazioni pi povere, che quasi non conoscevano luso
della carne; solo i provvidenziali fagioli avevano salvato le nostre popolazioni. Il grande
Ramazzini, professore a Padova, per altro li sconsigliava alle monache, perch le flatulenze che ne
derivavano risvegliavano immagini erotiche a quelle vergini consacrate...
72
LA SCIENZA E LA MEDICINA NEL SETTECENTO
Il Settecento non solo il secolo della frivolezza, delle parrucche incipriate e dei minuetti. E il
secolo del pensiero, del rinnovamento sociale, delle scoperte. E il secolo di Volta, Galvani, Linneo,
Laplace, Franklin, Goethe, Leibnitz. Di Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot e DAlambert.
E il secolo dei Lumi e della Ragione. E il secolo dominato dalla filosofia di Kant della ragion
pura, suprema facolt delluomo. Lo spirito del soggetto osservatore acquisisce la sensazione
dell oggetto, materia osservata, e gli conferisce forma. Linsieme costituisce lesperienza, che
non registrazione passiva dei fatti, ma prodotto dellattivit formatrice della coscienza. Viene cos
riconosciuta validit oggettiva alla scienza della Natura: alla Biologia, alle Scienze mediche. Il
mondo della realt esiste in s, ed conoscibile dallesperienza empirica, ma pu anche
trascendere una tale conoscenza oggettiva. Il Settecento il secolo dellIlluminismo che pretende
di poter giungere alla conoscenza senza la guida di dogmi precostituiti, seguendo unicamente la
Ragione.
Orientamenti del pensiero medico scientifico
Orientamento vitalistico, romantico
Gli albori del Settecento sono ancora pervasi dalla concezione di Galileo: un sano connubio tra
speculazione della Ragione e sperimentazione empirica. Prevalse tuttavia uno sterile
sperimentalismo senza un preventivo progetto di ricerca. Questo fatto induceva a valorizzare e a
sopravvalutare il razionalismo e a negare ogni valore allesperienza sensibile, dando
maggiormente credito a quel che dettava dentro la propria ragione individuale. Si ritornava ai
preconcetti filosofici pregalileiani. Informatore di questo orientamento fu G. E. Stahl (16601734),
secondo il quale unica causa universale lanima, che viene identificata con la Natura degli antichi,
forza universale che presiede a tutti i fenomeni vitali. E lorientamento vitalistico, detto anche
romantico, che precede e anticipa il movimento artisticoletterario omonimo.
Rappresenta la continuit di quella medicina filosofica prescientifica che si sviluppa da sempre
parallelamente alla medicina scientifica basata su riscontri sperimentali.
Orientamento animisticomeccanicista
Anche Federico Hoffmann (16601742), medico e chimico, parte dal concetto animistico. Il
fondamento vitale lanima, una specie di etere diffuso su tutta la Natura (G. Bruno, Leibnitz,
Glisson). Essa risiede nel sangue e nel cervello. Dal cervello si propaga a tutto il corpo mediante i
nervi (cavi), confluendo tutti nel Midollo allungato: i nervi, da esso dipartendosi, propagano il
movimento, vera espressione della forza vitale inerente alla materia vivente. La morte cessazione
di movimento. Il corpo simile ad una macchina in movimento che sottost alle leggi della
meccanica sublime della vita, ma sconosciuta. Il cervello mantiene il giusto tono alle fibre del
corpo, mosse dallanima universale.
73
La salute, secondo W. Cullen (17121790), consiste appunto nel giusto tono: n troppo teso n
troppo flaccido. Il tono prodotto dallimpulso nervoso del cervello, ma influenzato dagli stimoli
esterni, che provocano o meno la eccitabilit della materia (Glisson), producendo contrazioni o
atonie.
I concetti di Cullen vengono ripresi dal suo scolaro J. Browm (1731788). La vita una continua
risposta a stimoli, in equilibrio instabile, provenienti dallesterno. Agli stimoli risponde la
eccitabilit degli organi. Secondo questa dottrina (brownianismo), la salute determinata dalla
esatta dosatura degli stimoli e dalla adeguata risposta delleccitabilit degli organi. La malattia,
invece, dal difetto o dalleccesso dello stimolorisposta. Una risposta eccessiva allo stimolo
provoca uno stato stenico, una risposta troppo debole provoca uno stato astenico. Ne consegue che
la terapia deve essere stimolante negli stati astenici e sedativa negli stati stenici.
Una variante a questa teoria fu quella di G. Rasori (17661837). Egli pose laccento sulla qualit
degli stimoli, che distinse in stimoli stimolanti, stenici, e stimoli controstimolanti, astenici: stimolo
controstimolo. Gli stimoli sono di natura animale, i controstimoli di natura vegetale. La conferma
della diagnosi data dagli effetti terapeutici: se la terapia efficace la diagnosi giusta: criterio ex
juvantibus. Oltre che di scienze, si interess di politica: fu cospiratore e redattore del Conciliatore.
Orientamento positivistico
La radice di questo orientamento risiede nellidea, sorta fin dai primordi della medicina, che la
vera conoscenza solo quella che deriva dai fatti verificati e sperimentatati e non dai personali
convincimenti o da dogmi codificati da qualsiasi autorit. Questo atteggiamento fu ben vivo nel
Seicento, come abbiamo visto. NellOttocento prender il nome di positivismo (A. Comte: Corso di
filosofia positivista). Il metodo sperimentale sar adottato nel Settecento da G. B. Morgagni, A.
Vallisneri, L. Spallanzani, A. Haller e da tanti altri che, partendo dal dato positivo
dellosservazione, ricercano la verit mediante linsopprimibile contributo dellinterpretazione
personale. Questo orientamento nellindagine scientifica nella medicina, intravisto fin dalle origini
della medicina empirica, sar quello che, codificato da Galileo, permetter il progressivo sviluppo
scientifico attraverso il Settecento fino al Positivismo dellOttocento e ai contemporanei traguardi
della scienza e della tecnologia medica.
Lesplicarsi durante il XVIII secolo della Medicina filosofica, in particolare dello spiritualismo
animismo di Sthal, ha rappresentato un ostacolo e un rallentamento allo sviluppo della medicina
sperimentale. Rappresenta inoltre un esempio di come da una concezione filosoficoscientifica si
possa passare, per gradi insensibili, ad una concezione contraria: dallanimismo al materialismo
dellOttocento. Lanima, elemento vitale, si identifica via via nel sangue, nel cervello, negli organi,
nella materia; materia che diviene essa stessa viva, vita essenziale: dallo spirito alla materia, da
Kant ed Hegel a Marx: lanima, fatta materia, potr cadere sotto lo scalpello anatomico.
Orientamento eclettico
Il sottofondo culturale di tutti gli esponenti dei vari orientamenti della medicina del XVIII secolo
restava sempre la teoria ippocratica degli umori con le teorie delle scuole jatromeccanica e
jatrochimica. Famosissimo esponente di questo indirizzo fu Hermann Boerhaave (16681738),
professore a Leida. Rimise in auge il metodo della lezione al letto dellammalato e istitu il corso
di studi di medicina con le materie, anatomia, fisiologia, patologia e clinica. Scopo principale della
medicina curare lammalato, lindividuo ammalato, e prima cosa il suo esame clinico: le teorie
vengono dopo.
Egli ritiene che la vita sia il risultato dei movimenti dei solidi e dei liquidi del corpo. La malattia
consiste nellalterazione di questi movimenti, dei solidi o dei liquidi. Se sono alterati i movimenti
dei solidi si tratta di cattivo sviluppo organico o di modificazione della grandezza e della posizione
74
dei tessuti. Se sono modificati i liquidi la malattia dovuta alla pletora, ingorgo, o allacrimonia:
imperfette mescolazioni, che possono essere acide, salate, piccanti, aromatiche, grasse, alcaline o
viscose. Ritiene che ogni globulo rosso possa dividersi, nel sangue, in sei globuli gialli, che si
trasformano in piccolissime sferule pellucide, invisibili al microscopio. I vasi sanguigni sono
distinti in arterie sanguifere, che nel lume delle pi piccole lasciano passare un solo globulo rosso,
e in capillari sierosi, che lasciano passare un solo globulo giallo, e in altri vasellini, di calibro
sempre minore, attraverso i quali passano specifiche particelle.
Nei fenomeni vitali sono importanti la velocit del sangue, il diametro dei vasi, il volume e la
forma delle particelle e la viscosit. Se il sangue si addensa per la contrazione delle piccole arterie ,
si ha infiammazione, mentre si ha la febbre per la resistenza dei vasi capillari e laumento
dellattivit cardiaca. Usa il termometro di Fahrenheit per misurare la temperatura.
A lui si deve lisolamento dellurea e il suo riconoscimento come diuretico. Inventa un suo metodo
per la produzione dellaceto. Lesame clinico del malato completato dallesame autoptico del
cadavere per verificare la diagnosi e stabilire la causa della morte. Ebbe fama grandissima in tutta
lEuropa, lo Zar fu suo paziente e Goldoni si ispir al maestro di Leida per il suo Medico
olandese.
Esponenti dellorientamento positivisticosperimentale
Il Seicento aveva conseguito mediante il metodo scientificosperimentale grandi progressi
nellanatomia con Harvey e con Malpighi e nella parassitologia con Redi e Leeuwenhoek, e la
chimica e la fisica imboccarono con decisione il metodo scientificosperimentale. La giusta strada
della ricerca scientifica prosegu anche nel Settecento nel campo dellanatomia, della fisiologia,
della patologia e delle scienze naturali.
Il massimo esponente dello studio dellanatomia, intesa come comparazione tra la morfologia
dellorgano normale e la morfologia dellorgano malato in relazione ai sintomi clinici del paziente,
fu G. B. MORGAGNI (16821771). La sua opera maggiore il De sedibus et causis morborum per
anatomen indagatis. Ma il suo pensiero risulta completamente espresso nella Opera postuma,
scoperta dal Pazzini nel 1952 nella Biblioteca Laurenziana di Venezia. Si tratta del manoscritto di
203 lezioni di medicina teorica tenute a Padova dal 1711 al 1714: un vero e proprio trattato di
patologia generale e di patologia speciale medica con riferimenti alla anatomia e alla fisiologia.
Il linguaggio adoperato rimane quello umoralista, ma il fondamento posa sulla realt dei fatti
anatomici. Esistono gli umori ma sono prodotti dalle ghiandole, organi che cadono sotto
losservazione e lo scalpello dellanatomico, che sperimenta e tocca con mano. Morgagni pu
essere considerato la figura pi rappresentativa del secolo e tra i primissimi assertori del
positivismo. E stato il fondatore dellAnatomia patologica come tuttora si pratica. Lesame
autoptico preceduto dallo studio della storia clinica dei sintomi e della terapia secondaria alla
ipotesi diagnostica. Segue lattento e minuzioso esame degli organi e la comparazione della forma
riscontrata con quella dellanatomia normale. La diagnosi anatomopatologica della malattia causa
di morte si conclude con lepicrisi. Un siffatto procedimento presuppone una perfetta conoscenza
della clinica, della terapia, dellanatomia normale degli organi e una grande capacit di sintesi
comparazione con i reperti del riscontro autoptico.
Con tale metodo descrisse laneurisma aortico luetico, la polmonite lobare, la meningite
secondaria ad otite, il cancro e lulcera gastrica, i calcoli biliari, lendocardite, la stenosi mitralica,
linsufficienza aortica, la stenosi polmonare, la sclerosi coronarica, lileite terminale e la iperostosi
frontale interna, che il mio Maestro di Anatomia patologica, Mario Raso, citava dalla stessa
cattedra patavina con le parole latine del grande innovatore Morgagni.
Riconobbe la relazione tra cirrosi epatica (fegato duro), e ascite (liquido in addome). Afferm che
lapoplessia non deriva da malattia primitiva del cervello, ma da lesioni dei vasi cerebrali, e che la
emiplegia conseguente controlaterale rispetto alla lesione.
75
Descrisse anche i ventricoli laringei, il legamento sospensore del pene, i canali parauretrali, le
colonne rettali e limene. Sorprende inoltre la descrizione chiara e lapidaria di sindromi che tuttora
conservano la loro validit: la sindrome dellepilessia con polso raro, ora chiamata di (Morgagni)
-Adams-Stokes, e la sintomatologia dellangina pectoris e della sindrome delladdome destro,
tuttora da tener presente, soprattutto per individuare specificatamente gli organi interessati nella
sintomatologia.
Da convinto credente nel contagio si rifiutava di eseguire lautopsia su cadaveri deceduti per
vaiolo e tubercolosi.
Anatomici e chirurghi
Tra i discepoli di Morgagni fu Antonio Scarpa, Motta di Livenza (17521832), celebre chirurgo
anatomico. Portano il suo nome il triangolo muscolare del lato anteriore della coscia, la fascia
cremasterica e il ganglio vestibolare: intumescentia gangliformis Scarpae. Sinteress dellorgano
delludito e dellolfatto e soprattutto della vista.
Da ricordare G. D. Sartorini, Venezia (16811737), che sinteress del sistema nervoso centrale,
descrisse i vasi emissari che portano il suo nome. M. V. Malacarne (17441816), fu il fondatore
dellanatomia topografica, con cattedra a Padova nel 1794. G. F. Meckel (17241774) descrisse il
ganglio sfenopalatino e il diverticolo ileale.
Albert von Haller (17081777), allievo di Boerhaave, indipendente dalle scuole di jatrofisica e
jatrochimica, fond e attu un metodo basato sullosservazione anatomica e sugli esperimenti
fisiologici. Scrisse opere enciclopediche di anatomia, Icones anatomicae, e di fisiologia, Elementa
physiologiae c. h., con importanti osservazioni sul sistema nervoso e sul tessuto muscolare
(eccitabilit). Fu coltissimo, letterato e poeta. Descrisse il tripode celiaco, le ghiandole salivari e la
rete del testicolo. Xavier Bichat (17711802), allievo di Dessault (17441795), fu propugnatore del
metodo sperimentale in fisiologia e anatomia patologica. I suoi studi furono continuati da Schwann
e Virchow. Winslow (16691760) danese, leg il suo nome al processo uncinato del pancreas e al
foro epiploico della borsa omentale.
J. Douglas (16751742) scozzese, studi specialmente il peritoneo, di cui la piega e lescavazione
retrouterina portano il suo nome. G. L. Petit (16951769) ha legato il suo nome al triangolo
lombare. Percival Pott (17141788) scrisse un trattato sulle fratture, A treatise on fractures, mentre
guariva da una frattura esposta della tibia. Descrisse la carie vertebrale che prese il suo nome:
Morbo di Pott, attribuendone la causa ad una osteomielite tubercolare. Descrisse il cancro degli
spazzacamini, cancro dello scroto che li colpiva dopo circa 20 anni di mestiere, a causa della
fuliggine (gli idrocarburi in essa presenti), che si insinuava tra le pieghe della cute scrotale. Luigi
Rolando ( 17731831) descrisse il solco del cervello che porta il suo nome.
La fisiologia sperimentale: generazione e fecondazione
Tra i massimi assertori del metodo sperimentale fu Lazzaro Sapallanzani (Scandiano 1729, Pavia
1799), abate dei Sacerdoti di Maria: ingegno poliedrico, insegn matematica, metafisica, greco,
filosofia, e materie religiose, oltre ad aver polarizzato i suoi studi sulla zoologia e sulla biologia.
Insegn a Modena e Pavia. I suoi principali studi sperimentali furono sulla generazione, sulla
digestione e sulla fecondazione artificiale. Gi il Redi (1626-98), abbiamo visto, aveva contestato il
concetto aristotelico della generazione spontanea, pure Vallisneri e Morgagni. Ma il gesuita J. T.
Needhan aveva sostenuto sperimentalmente nel 1745 la vecchia teoria aristotelica. Frammenti di
carni e vegetali, rinchiusi in fiaschi pieni di acqua, che veniva riscaldata ad alte temperature,
generavano dopo alcuni giorni degli infusori, osservabili al microscopio. Spallanzani modifica la
tecnica dellesperimento: fa bollire lacqua, usa recipienti a collo lungo dai quali espelle laria e
76
chiude alla fiamma. Nel liquido sterile non nasce nessun infusorio n microbio: la generazione
spontanea non esiste. La polemica col gesuita e famoso naturalista Buffon fu vinta.
Anche nel campo della fecondazione port il suo contributo sperimentale. Dimostr che non
possibile la nascita di un nuovo essere senza che luovo sia fecondato in precedenza dal seme
maschile. Delle due teorie del 600, epigenesi e preformismo, era seguace come Vallisneri e
Malpighi della seconda: nelluovo, animaletto maschile, spermatozoo, contenuto lomuncolo, che
sviluppandosi diventa un nuovo essere. La sua prima esperienza lesegu sui rospi dagli occhi rossi.
Preleva il liquido seminale dalle vescichette dei maschi. Prende un pezzo di cordone gelatinoso
delle femmine, fatto di ovuli in fila, e lo divide in due parti: una per controllo, sullaltra spalma con
pennello il liquido seminale maschile. Immerge in bacinelle separate, contenenti acqua, i due
frammenti. Al quinto giorno nella bacinella contenente frammento di cordone gelatinoso spalmato
di liquido seminale, si sviluppano i girini, il frammento di controllo, invece, marcisce. Ripete
lesperimento sui mammiferi: una cagna barbona tenuta segregata fino al tempo del calore. . .
. Preleva lo sperma da un cane della stessa razza, e, con una siringa a cannula sottile, lo inietta
nellutero. Dopo 62 giorni partorisce 3 cuccioli. E il primo esperimento di inseminazione artificiale
nei mammiferi. Nei suoi innumerevoli esperimenti us tutti gli animali che poteva: rospi, rane,
salamandre, pesci, uccelli, cani, montoni, cavalli, conigliSenza risparmiare se stesso, come
vedremo per la digestione del cibo da parte dello stomaco, che fu un altro suo campo fondamentale
dindagine.
Prevaleva allora la teoria che gli alimenti venissero triturati dalle contrazioni dello stomaco, o che
fermentassero in esso. Si sapeva inoltre della teoria di Galeno che sosteneva che i cibi erano
trasformati da sughi gastrici segregati dalle sue pareti, e della teoria di Borrelli che sosteneva
lesistenza di un succo corrosivo che trasforma lalimento solido in liquido.
Spallanzani dimostra sperimentalmente lesistenza di succhi gastrici capaci, essi soli, di operare la
digestione degli alimenti. Nelle sua Dissertazioni di fisica animale e vegetabile riporta ben 264
esperimenti. Ne riportiamo alcuni per evidenziarne il rigore e la genialit. Fa ingoiare a gallinacei
grani di cereali, alcuni liberi, altri protetti da tubicini aperti ai lati: i grani protetti risultano
inalterati, i liberi sempre macerati. Esiste quindi lazione di triturazione dello stomaco, ma sono
indispensabili i succhi gastrici. Unulteriore conferma da altri esperimenti: riempie di succo gastrico
due provette di vetro contenenti rispettivamente dei pezzetti di carne di cappone e chicchi di grani
schiacciati. Cova per tre giorni le provette sotto le ascelle (il calore del ventriglio facilita lazione
dei succhi), al terzo quarto giorno la digestione completa. Come ha fatto a procurarsi il succo
gastrico? Si caccia in gola due dita al mattino a digiuno; oppure, meglio, forza nella gola di
cornacchie delle spugnette legate ad un filo, che gli uccelli vomitano dopo un po. Ripet
lesperimento con ogni sorta di animali: bisce, vipere, civette, falchi, barbagianni, e perfino aquile.
E nelluomo? Ingoia egli stesso un tubicino di legno forato contenete carne di vitello, dopo 19 ore
lo evacua per via rettale, lo esamina attentamente: la carne interamente digerita. E che sapore
avr? Ingoia un sacchetto contenente quella carne legato ad un filo che sporge dalla bocca. Ritira il
filo dopo 17 ore (!) : la carne digerita e ha un bel sapore dolce. Esiste lo stomacal dissolvente e
lesperienza dimostra che ha la capacit di digerire gli alimenti.
Geniale, coltissimo, onorato e stimato per i suoi successi, suscita linvidia e vero odio, tanto da
essere accusato dai suoi colleghi dellUniversit di Pavia addirittura di furto. Una commissione
inquirente svolge linchiesta ufficiale. Alla fine la Corte imperiale di Vienna riconosce la sua
innocenza. Intanto per subisce lumiliazione e il discredito di tutta l Europa, e medita,
cristianamente!, la sua vendetta. Preleva lesofago di un pulcino e lo prepara sotto alcool in provetta
in modo che appaia un lombrico. Lo invia ad un suo amico medico che provveda ad inviarlo, per le
dovute analisi, ai professori dellUniversit di Pavia. Il Prof. Scopoli lo studia in ogni aspetto e
conclude con soddisfazione di aver scoperto una nuova specie di verme intestinale e lo battezza
come Physis intestinalis. Raggiante per la scoperta lo invia alla Royal Society di Londra. Labate
77
Spallanzani non se la sente di far rischiare una brutta figura ai professori della societ londinese e li
avvisa della beffa. Intanto quello scherzo da prete fa il giro dItalia e accentua lodio tra i
professori. Tra i quali lo Scarpa, che poi, riappacificatosi, lo assister durante la malattia, cancro
della vescica, che lo porter a morte alla soglia del nuovo secolo, 1799.
Anatomia microscopica
Allo studio dellAnatomia patologica contribu in questo secolo luso del microscopio, strumento
indispensabile per il progresso della disciplina. Ne nacque una nuova branca specifica: lanatomia
microscopica. Fu iniziata dallanatomico G. N. Lieberkhn (17111756), che scoperse le ghiandole
che portano il suo nome e descrisse i villi intestinali e la valvola del colon.
Da ricordare il nostro F. Fontana (17201805) che invent il procedimento di colorare i preparati
microscopici, riuscendo in tal modo a evidenziare i nuclei delle cellule e la struttura striata dei
muscoli. Comp studi sulla struttura delle fibre nervose, sulla retina, sulle ossa e sullepidermide.
La respirazione e la circolazione del sangue
Lo studio di questa fondamentale funzione dellorganismo animale avvenne, nel Settecento,
nellambito della scoperta della chimica. Ma fu ritardato dalla teoria del flogisto di Stahl, che
sosteneva che tale sostanza, contenuta nei corpi combustibili, si sprigionava durante il fenomeno
della combustione; il flogisto, contenuto nellorganismo animale, nella respirazione passa dal corpo
allaria ambiente. Priestley (1774) facendo reagire nitrato di potassio con ossido di mercurio
ottenne un gas che chiam aria deflogisticata e un anno dopo dimostr che laria deflogisticata era
capace di trasformare il sangue rosso scuro (venoso) in rosso chiaro (arterioso). A. L. Lavoisier
(17431794) chiam laria deflogisticata ossigeno, e stabil che lacido carbonico era costituito da
ossigeno e carbonio ( HCO3 = H2 O + CO2). Afferm che nella respirazione si aveva consumo di
ossigeno, indicato necessario alla vita, e formazione di acido carbonico, composto di acqua e
anidride carbonica, gassosa. Lagrange (17361783) intu che nei polmoni avveniva un semplice
scambio di gas, senza vera combustione che avrebbe dovuto produrre calore: la vera combustione
doveva avvenire allinterno dellintero organismo. Spallanzani ne diede prova sperimentale: alcune
chiocciole in ambiente di azoto puro emettevano ancora anidride carbonica, poich nellambiente
non cera ossigeno dedusse che questo doveva trovarsi nellorganismo dei molluschi,
precedentemente assorbito. Liebig conferm la presenza di ossigeno nellorganismo con
esperimenti nel tessuto muscolare: respirazione muscolare, respirazione interna. Nel corso del
secolo non si risolse il problema circa il modo in cui laria veniva a contatto con il sangue. La
soluzione, intravista da A. Cesalpino ( 1524 1603), non venne allora tenuta in considerazione.
Nellambito della circolazione del sangue e della sua composizione, si deve ricordare la scoperta
dellautomatismo dei movimenti del cuore e del suo autogoverno (Tebesio, 1708), e del potere di
irritabilit delle fibre cardiache in alto grado spiegata da Haller. Anche Spallanzani concluse per
lautomatismo del muscolo cardiaco. Mascagni (1787) e Cohnheim misero in evidenza la capacit
dei globuli rossi di attraversare le pareti dei capillari (diapedesi). Spallanzani scopr i capillari
sanguigni negli animali a sangue caldo. Halle e Spallanzani videro i leucociti, emazie scolorite.
Menghini nel 1745 dimostr la presenza del ferro nel sangue: la terra insipida delle ceneri di
sangue conteneva dei corpiccioli soggetti all attrazione della calamita.
Tra le altre scoperte, Cavendish (1783) dimostr che lacqua era composta da ossigeno e idrogeno:
H2 O. Foucroy trova lazoto nel corpo degli animali
78
Il contagio animato: concetto ancora irrisolto
Lorientamento microbiologico non fece, nel Settecento, grandi passi in avanti rispetto alle
conoscenze precedenti. Il concetto di contagio animato diffuso anche a livello popolare. Se ne
impossessano anche i ciarlatani per vendere i loro specifici mediante ingannevoli trucchi.
Non mancano intuizioni e affermazioni di studiosi: scambio di lettere tra Vallisneri e Bono: si
vedono al microscopio verminetti piccolissimi ma spiritosi. Lancisi (1717) ritiene che la malaria
sia data da miasmi animali, zanzare, che iniettano i loro malefici succhi, ma non osa dire, senza
lappoggio sperimentale, che animaletti penetrino nel sangue umano. Il Muratori non riferisce di
animaletti causa delle pestilenze, ma di certi spiriti velenosi e maligni che, corrompendo il
sangue o, in altra maniera, offendendo gli umori, levano la vita alle persone. Si ancora in attesa
di una chiara e indiscutibile dimostrazione che i microbi siano la causa diretta di malattia.
La semeiotica
In questo secolo fu molto in auge lo studio del polso e della pressione sanguigna, la sfigmia.
Trov applicazione e diffusione il metodo della percussione, e, nellambito della tradizione
ippocratica, fu praticato lo scrupoloso esame clinico del malato. La sfigmia, larte del polso,
dilag, dalla scuola di Montpellier, in tutta lEuropa, dilatandosi in tecniche e teorie
complicatissime e bizzarre. Si tent di rappresentare graficamente il polso (Fouquet).
Un tentativo di misurare la pressione del sangue fu esperito dal reverendo S. Halles nel 1773:
introdusse un tubicino di vetro di 30 centimetri nellarteria femorale di una giumenta e osservava
laltezza alla quale saliva il sangue, e i movimenti in coincidenza delle pulsazioni cardiache.
Nel 1774 R. Pagnini ide uno strumento per la misurazione della pressione sanguigna da usarsi
solo su unarteria messa a nudo. J. M. Poiseuille, circa 50 anni dopo Halles, us un tubicino a U
parzialmente ripieno di mercurio, ne misurava lo spostamento in millimetri: era l
emodinamometro, il precursore del moderno sfigmomanometro (vedi Riva-Rocci 1896).
Oltre allinterrogatorio, lesame dei sintomi soggettivi e oggettivi (polso, respirazione, moto,
sensibilit, sonno, secrezioni, escrezioni: specie delle urine, lesame delle funzioni organiche e in
particolare la ispezione, secondo gli insegnamenti di Ippocrate e di Galeno), prese gradatamente
piede la percussione, forse conosciuta da Galeno, e praticata da Ippocrate come succussione.
Leopold Auenbrugger (17221809), figlio di un vinaio di Vienna, aveva notato che il torace di un
uomo sano risuona come un tamburo ricoperto di panno: il suono da percussione del torace e
delladdome variava da paziente a paziente come quello delle botti piene e vuote. Nel suo libretto
Inventum novum (1761), descrive un sonus alterior, timpanico, un sonus obscurior, indistinto, e un
sonus carnis percussae, ottuso, praticamente di vuoto e di pieno: presenza o assenza di
aria. . ..Diagnostica cos lenfisema polmonare, la pericardite, e la dilatazione del cuore, e,
nelladdome o nel torace, una massa solida o liquida. Per le sue invenzioni lImperatrice Maria
Teresa lo creer nobile (Edle) e diverr Leopold von Auenbrugger.
Tra apprezzamenti, Von Aller, e avversioni, R. A. Vogel, il suo metodo di percussione dovr
aspettare una cinquantina danni prima di essere universalmente accettato e insegnato nelle
Universit. Sar quando, nel 1809, J.N. Corvisart, medico di Napoleone, che invent il termometro
a gradi centigradi, tradurr lInventum novum in francese e lo diffonder nel mondo.
La terapia
Lidea di estrarre il principio attivo da sostanze complesse, iniziata dalla spagirica, continua
anche in questo secolo collaiuto della chimica. E il secolo di Lavoisier, Cavendish, Scheele,
Priestley e soprattutto di F. Fourcroy (17551809), il chimico che maggiormente avvicin la
scienza alla medicina: Trait de lart de connatre et de employer les medicaments. Nella pratica
79
dellestrazione egli usa gli acidi, gli alcali, lalcool, letere, lolio e anche lacqua. Gli esperimenti di
Scheele (1741 1786) molto contribuirono alla separazione dei principi attivi della china, oppio e
tabacco, e gettarono le basi per i primi chiari risultati dellinizio dell800.
A segnare linizio della revisione della farraginosa farmacopea in uso allinizio del secolo fu
Linneo, Carl von Linn (17071778), per incarico di Boerhaave professore anche di botanica a
Leida: fondamentale lopera del grande naturalista autore della classificazione binomia degli
animali e delle piante che tuttora resiste. Inizia cos la censura simplicium che permise di
abbandonare i vecchi medicamenti e di inserirne di nuovi. Fu ripreso luso della ipecacuana. Fu
introdotto luso dellacqua di lauro ceraso (Baylies, 1773) e della digitale (E. Darwin, 1780) quale
rimedio contro lidropisia (ascite da scompenso cardiaco), con la diuresi. Il catrame e la felce
maschio come antielmintico. Fu introdotto luso dellarsenico sotto forma di liquore arsenicale di
Fowler (17361801), droghiere inglese, e di liquore di Pearson (17511828), in uso fino a qualche
anno fa.
Della stessa epoca luso dellAcqua vegetominerale, Acqua di Goulard 1760: acetato basico di
piombo in acqua. Vengono introdotti nuovi veleni: la cicuta, il colchico, laconito, il giusquiamo, il
tabacco e la belladonna (Firk 1710). Furono eseguiti esperimenti sulloppio che risultava eccitante
cardiaco. Ugualmente furono sperimentati il the, lo zucchero e la segala cornuta.
Accanto alluso di farmaci chimici era in auge la scuola (Boerhaave, Stahl, Pinel) che sfruttava
maggiormente la Vis medicatrix Naturae, secondo i consigli ippocraticogalenici.
Accanto ai tentativi della scienza di migliorare la terapia, persistevano vecchie usanze che
sfruttavano le ipotetiche propriet terapeutiche dei derivati organici: feci, urine, fiele dorso, grasso
di gatto selvatico e pietre preziose.
Erano in uso, inoltre, i tradizionali soccorsi terapeutici: il salasso, i revulsivi, i vescicatori, i
cauteri. E i setoni, cordoncini di seta o cotone che, infilati con ago nella cute, ne determinavano
linfiammazione e la suppurazione, che espelleva il marcio. E, inoltre, il serviziale, il clistere, che
divenne una propria moda, al quale si attribuivano mirabili propriet terapeutiche e igieniche e
persino la capacit di conservare la bellezza e la giovent. Ricordiamo Molire.
Guaritori
Il Settecento fu lepoca dei grandi ciarlatani, detentori di secreti, di portentose propriet
terapeutiche dei loro specifici.
Giusepe Balsamo (17431795), si faceva chiamare conte di Cagliostro. Con le sue essenze, acque,
tinture, elisir, divenne lidolo delle folle, soprattutto per le sue indubbie capacit di introspezione
psicologica che, mista ad una infarinatura di medicina e di chimica, lo facevano capace di guarire le
malattie psicosomatiche, che, come sempre, rappresentano la maggior parte della sintomatologia
corrente
Da ricordare anche lavventuriero, ma pur colto e letterato Giacomo Casanova (Venezia 1725
1798), arrestato per magia legata a pratiche di guarigioni. Lo pseudoconte di SaintGermain ebbe
molta fama allestero. Il suo Elisir di lunga vita era talmente efficace che, sosteneva, grazie ad esso,
egli pot essere presente tra gli invitati alle nozze diCana!
Elettroterapia
Nel Settecento nasce la Elettroterapia e prendono piede le basi per lo studio della energia elettrica.
Volta e Galvani in Italia, Boyle, Newton, Winkler e labate Nollet arricchirono le conoscenze
sullelettricit. Si costruirono macchine a sfregamento, e il primitivo condensatore: la bottiglia di
Leida, capace di fornire forti scariche elettriche. Furono usate scariche elettriche nella cura delle
paresi facciali (fino a poco tempo fa si facevano le scosse) e nelle malattie febbrili: il positivo
durante il brivido e il negativo nellipotermia. Un seguace della terapia elettrica fu G. Marat,
medico avventuriero e capo rivoluzionario. A. Volta (17451827), pur non essendo medico, tent la
guarigione, per mezzo dellelettricit, delle affezioni delludito.
80
Magnetismo animale
Tra le tendenze mistico occultistiche diffuse in tutta lEuropa, specie in Germania, e la diffusa
credenza di malattie demoniache e di guarigioni miracolose, di streghe, messe nere, in unaura di
fanatismo del soprannaturale e del meraviglioso, si inserisce la rapida diffusione del magnetismo
animale ad opera di Mesmer. Francesco Mesmer (17341815), fu un misto di genialit e di
ciarlataneria, credeva nellinfluenza astrale sullorganismo umano e nellesistenza di un fluido
universale vitale che permea gli animali e luomo: onde e fenomeni magnetici che possono agire
anche a distanza. Ne fu maggiormente convinto quando, applicando una calamita, guar un
professore di Vienna da una molesta oftalmia e un altro da una paralisi.
Ebbe fama in tutta Europa. Si stabil a Parigi in Place Vendme. La sua casa divenne meta di nobili
e ricchi di ogni parte. Eseguiva la terapia di gruppo ante litteram. Attorno ad una tinozza, baquet,
di 150 centimetri per 30, piena dacqua magnetizzata con acido solforico e limatura di ferro,
erano i pazienti; anelli di ferro, collegati con lacqua della tinozza erano fissati al corpo dei pazienti
in contatto con i pollici dei vicini: il fluido passava dallacqua ai loro corpi, e onde magnetiche
erano emesse da un pianoforte. Appariva Mesmer avvolto di seta lilla e con la bacchetta in mano.
Con essa toccava un paziente e gli trasmetteva il suo fluido. Il toccato si contorceva e contraeva
nella crisi che precedeva la guarigione. Una Commissione, sollecitata al Re Luigi XVI dai medici
toccati dalla concorrenza del taumaturgo, esperiti i dovuti esami sulla tinozza, non trov nessuna
attivit elettrica. Con la Rivoluzione arriv al potere Robespierre, e Mesmer part precipitosamente
verso il Lago di Costanza, dove si ritir sfiduciato e vinto.
Delle teorie di Mesmer si appropriarono veri ciarlatani, come abbiamo visto a proposito di
Cagliostro e di una miriade di minori che mescolavano forze naturali a magia, stregoneria e
demonismo. Il Mesmer ebbe, per altro, il merito di credere che forze animali, magnetismo, simile
al fluido elettrico, poteri della sua personalit, potessero operare prodigi senza invocare lazione di
diavoli o forze soprannaturali. Apriva in qualche modo la strada a Charcot e anche a Freud.
Omeopatia
Sempre nellambito del clima di facile credulit, che sempre esiste in ogni tempo e luogo, nel
Settecento nacque e prosper quel metodo di terapia che il suo autore, S. Hahnemann (1775
1843), chiam Omeopatia ( ) moios = simile. Aveva creduto di osservare che la corteccia
di china, noto febbrifugo, producesse invece febbre in un organismo sano. Prov su se stesso anche
altre sostanze e si convinse che il vecchio aforisma di Ippocrate, contraria contrariis curantur,
doveva essere mutato in similia similibus curantur: le ustioni si curano con gli impacchi caldi, la
sonnolenza con loppioAltro concetto fondamentale della sua terapia era quello della diluizione
delle sostanze attive: poich le sostanze usate producevano gli stessi sintomi che si doveva
combattere, era necessario usarle con parsimonia. Della soluzione madre del medicamento si
prendono 2 gocce e si mescolano con 98 gocce di spirito. Della soluzione ottenuta una goccia si
mescola con 99 gocce di spirito, e cos via per 30 volte. Inutile dire che il metodo fu contestato dalla
chimica nascente. Avogadro dimostr che alla fine delle diluizioni resta il solo solvente senza
tracce di sostanza. Il metodo trov resistenza nella scienza. Tuttavia si diffuse, specie allestero, ed
tuttora utilizzato.
Assieme al mesmerismo, allanimismospiritualismo, lomeopatia si situa negli orientamenti
riconosciuti nella mentalit romantica delle correnti di pensiero del Settecento.
81
La chirurgia e le branche chirurgiche
Nel 1700 larte chirurgica si avvia allemancipazione rispetto allesercizio della Medicina. Un
editto di Luigi XIV autorizza i chirurghi a professare linsegnamento della loro arte. Nel 1723 viene
definitivamente separata larte del chirurgo dallarte del barbiere: nessun chirurgo potr esercitare
larte senza aver conseguito il grado di maestro in arti in qualcuna delle Universit I chirurghi
non confonderanno la loro professione con arte non liberaleLesercizio della barbieria
appartenga alla comunit dei maestri barbieriparrucchieribagninistufisti. Il regio editto
viene ribadito nel 1730 con effetto in tutte le provincie del regno, e le lettere patenti del 1756
consacrano definitivamente la separazione dei barbieri dai chirurghi. Solo nel 1803, per, il
chirurgo sar considerato un medico specialista in chirurgia.
Abbiamo gi menzionato tra gli anatomici i chirurghi Scarpa, Pott, Petit, Desault e altri. Tra gli
italiani ricordiamo Flaiani (17411808), medico di Pio VI che tra i primi osserv il gozzo
esoftalmico, contemporaneamente a Basedow: il Morbo di FlaianiBasedow.
Alessandro Brambilla (17281800), chirurgo dellesercito austriaco, riorganizz la Scuola cesarea
di applicazione di sanit militare. Questa Accademia, insieme alle altre francesi, poteva conferire
diplomi di laurea in chirurgia. Ricordiamo inoltre il chirurgo J. I. Guillotin (17381814), assai abile
e celebre che, per alleviare le sofferenze nelle esecuzioni capitali e per renderle pi spedite, dato il
grande numero di esse durante il periodo del terrore rivoluzionario, invent la macchina che porta il
suo nome, la famigerata ghigliottina.
Lostetricia
In questo secolo lostetricia compie importanti progressi. Specialmente il forcipe, con le decisive
modifiche, entra nelluso comune con migliori possibilit di riuscita positiva. Viene modificato
specialmente da Guglielmo Smeille (16971763) con lincrociamento e la curvatura pelvica delle
branche. Egli fece anche studi sulle misure del cranio fetale, sul meccanismo del parto e sulla
placenta previa. Ancor oggi usata la sua manovra per lestrazione della testa seguente nella
presentazione podalica.
Sulle varie presentazioni fetali e sullaltezza dellutero nello sviluppo della gravidanza fece
importanti osservazioni lostetrico J. I. Baudeloque (17461810). Per la prima volta, nel 1777,
R. G. Sigault esegu la sinfisiotomia a feto vivente nei casi di bacino rachitico. Nel 1759 G. Bard
oper, probabilmente, un caso di gravidanza extrauterina con laparotomia.
Il taglio cesareo ancora gravato da alta mortalit; da segnalare il consiglio di Giovanni Lebas
(17171797) che suggeriva di eseguire il taglio trasversale invece che longitudinale sullutero.
Da ricordare litaliano Francesco Asdrubali (17561832) che insegn nella cattedra di Roma
istituita da Pio VI. Scrisse pregevoli trattati di ostetricia tra i quali il Trattato generale
dellostetricia, 1812, in cinque volumi.
La salute mentale
Con Filippo Pinel (17551826) inizia a farsi strada lidea che il pazzo un uomo sofferente e
infelice, malato a causa di alterazioni del cervello, e non un indemoniato da relegare e torturare.
Il suo metodo era improntato ad un trattamento umanitario dei malati, degni di piet e adeguata
assistenza. Il Regolamento Bonifacio, del 1789, che doveva disciplinare lattivit dellomonimo
ospedale, fatto erigere dal Granduca di Toscana Leopoldo I, prescriveva che i malati ricoverati vi
fossero trattati secondo principi umanitari, e venissero curati come gi il Valsalva, maestro di
Morgagni e allievo di Malpighi, (16661723), aveva indicato. Non si dovevano ingiuriare n
percuotere n far loro burle. Dovevano esserci un medico e un chirurgo di guardia. Potevano
82
lavorare nel terreno circostante, protetto da recinti per sottrarli ai motteggi e alla curiosit dei
passanti. Ad ispirare questi principi fu V. Chiarugi (17591820). Erano abolite la tortura, la
contenzione per mezzo di catene e limmersione sotto acqua per lo spazio di un Miserere.
La psichiatria si evolveva in senso scientifico, con la ricerca di lesioni cerebrali, anche con la
conferma autoptica, come causa di malattia mentale, e si evolveva anche in senso culturale nel
trattamento umanitario imposto per quegli ammalati.
LIgiene, la vaccinazione
Nel secolo XVIII era sempre pi evidente la convinzione che sotto la putredine degli umori, da
doversi in ogni caso depurare, ci fosse lesistenza di animaletti, microbi, causa di malattia.
Per eliminare la putredine si usavano dei disinfettanti, gli antisettici secondo la denominazione di
Cullen. Si impiegavano i vapori di cloro per gli ambienti infetti, e per le mani e gli oggetti si usava
lacqua di calce, il cloruro di sodio, il cloruro di calcio, lacido acetico, eccetera. Per la
sterilizzazione da ricordare C. G. Scheele (17421786) che usava lebollizione, oltre a conservare
laceto. Per lespurgo degli oggetti erano in uso tre metodi: venivano sciorinati allaria e al sole per
venti giorni; si sbattevano con bacchette; si bollivano ed esponevano ad essenze profumate.
Il medico nellesercizio della sua professione in tempo di pestilenza munito della tradizionale
maschera con proboscide contenente essenze antimiasmi. Diventa pi intransigente la legislazione
sulle quarantene, lisolamento, e il regolamento dei lazzaretti, divisi per malati, sospetti e
convalescenti. Dovevano essere sorvegliati anche i cani e i gatti, isolati, ma non uccisi: sarebbero
aumentati i topi.
Anche ligiene mortuaria venne regolamentata: con la legge austriaca 1787 furono proibite le
sepolture nelle chiese; e disciplinati i cimiteri, da costruirsi fuori delle citt, con lEditto di Saint
Cloud 1804 (Napoleone). A Londra si costruirono i primi marciapiedi nel 1782 e si coprirono le
fogne. Si istituirono i bagni pubblici. Anche ligiene nelle prigioni fu migliorata, per suggerimento
di Domenico Cirillo 1739 1799) medico e patriota, seguace del movimento di Cesare Beccaria
(17351795), secondo quanto afferma nel suo celebre trattato Dei delitti e delle pene.
Nel 1798 Edward Jenner (17481823) diffonde nel mondo il principio della vaccinazione
antivaiolosa introducendo concetti scientifici come norma direttiva di tale pratica. Nel 1796
vaccin il bambino James Philipps con pus tolto dalla pustola di una contadina. Inoculato in
seguito con pus vaioloso, il bambino non ammal: era la prova cruciale. In Italia fu propugnata la
vaccinazione da Angelo Gatti (17301798) e soprattutto da Gianmaria Bicetti che nel 1765 si
merit unode del Parini: O genovese ove ne vai pi delloro Bicetti alluom cara
linoculazione antivaiolosa.
La pellagra
Entit di vero flagello pubblico ebbe, in talune zone (Veneto, Romagna, Asturie), la pellagra
nel 1700. Gi nota in modo indistinto nel 1600 e anche prima, venne sommariamente descritta dal
Maffei e dal Ramazzini. Con maggior precisione fu descritta dal Pujatti nel 1743 44, che la
denomin scorbuto alpino. Francesco Frappoli (m.1773) diede il nome di pellagra ad una
specifica malattia distinta dallo scorbuto. Gaetano Strambio (1752-1831) scrisse il De pellagra
nel 1787 e indic la causa della malattia nella dieta maidica, di una specie di mais guasto. Ne
descrisse i sintomi: alterazioni cutanee, eruzioni erpetiche, febbre, alterazioni neurolgiche e
psichiche, con psicosi talora maniacali. Prescrisse i modi di panificazione e le modalit di cottura
della polenta. La Repubblica Veneta, per mezzo dei suoi Provveditori alla Sanit, dett un decreto
che proibiva luso del cereale alterato, e ingiungeva ai medici lobbligo della denuncia.
Ora conosciamo la vera causa della pellagra: il mancato utilizzo della vitamina PP, acido
nicotinico, che si trova nella carne, nel pesce, nel grano e anche nel mais. Le popolazioni povere si
83
cibavano quasi esclusivamente di polenta, anche di mais alterato, guasto, e quindi non contenente
vitamina assorbibile. Anche nel Messico lalimentazione era quasi esclusivamente di mais, ma
quelle popolazioni trattavano il mais con acqua e calce, lacido nicotinico diventava, evidentemente,
assorbibile e quindi la pellagra non si manifestava.
LA MEDICINA NELL OTTOCENTO: POSITIVISMO E IDEALISMO
Nellesame del pensiero medicoscientifico del Settecento, abbiamo fatto cenno come il sistema
kantiano, basato sul binomio ragione-esperienza, abbia nella sostanza riconosciuto validit
oggettiva alla ricerca scientifica, e come l' Illuminismo, negatore di ogni dogma trascendentale,
con la sua credenza nella fede della Ragione abbia affidato ad essa il potere della conoscenza della
Natura attraverso la valutazione, razionale appunto, dellindagine sperimentale.
Abbiamo anche rilevato come il pensiero medicoscientifico, sviluppatosi lungo la direttiva del
Metodo sperimentale galileiano fu quello che attraverso Morgagni, Spallanzani, Haller eccetera,
tracci la strada sicura e definitiva dellorientamento che proprio nellOttocento venne denominato
Positivismo. Come corrente filosofica fu sistemizzato da Comte (17921857), e fu la linfa che
vitalizz il metodo sperimentale: verum ipsum factum. La verit il fatto stesso: lesistente, visibile,
misurabile, verificabile dallesperimento. Ma anche razionalmente interpretato.
Laccento sul primato della Ragione fu posto soprattutto da Hegel (17701852), dal cui pensiero
complesso nascer, per certe vie, il Materialismo di K. Marx (18181883) e di F. Engels (1820
1895), la sinistra hegeliana. Sopra tutto Engels estese il concetto di materialismo a tutto il mondo
della Natura: Naturamateria, soggettooggetto della ricerca scientifica.
Il fondamentale dissidio tra idealismospiritualismo da una parte, e materialismo positivismo
dallaltra, si compose nella pratica della ricerca scientifica dei maggiori scienziati dellOttocento.
Tra i maggiori esponenti, non solo nellattivit di ricerca medicoscientifica , ma anche della
speculazione filosofica, Claude Bernard (1813-1878) cos scriveva : Come sperimentatore io evito
i sistemi filosofici, ma non potrei respingere quello spirito filosoficoche deve regnare non solo
su tutta la scienza, ma su tutte le conoscenze umane Io non voglio sopprimere la metafisica e i
grandi problemi che tormentano lo spirito umano, ma voglio separarli dalla scienza per distinguerli,
perch il loro studio segue Metodi del tutto diversi. In questi concetti sta lo spirito scientifico che
anima la ricerca scientifica dellOttocento, e anche della nostra epoca.
Cos componendosi e compenetrandosi i vari orientamenti, si arriva a quel sano positivismo
anatomoclinico, microbiologico, fisiopatologico, che, pur legato alle precise regole della
sperimentazione, non disdegna lattenzione alle idee, alle intuizioni della ragione, sempre bisognose
della verifica e del vaglio sperimentale.
Ma non tutto pu cadere sotto il controllo dellexperimentum: lanima, che non si identifica con la
materia, non cade sotto lo scalpello dellesperimento. Esistono dei limiti anche per la Scienza: la
Storia che lo dimostra. La scienza progredisce per successivi errori. Il valore della scienza legato
al momento della teoria, che vera finch non sar dimostrata falsa: non esiste il sapere certo,
lepisteme. E necessario riflettere, studiare, indagare sui limiti della Scienza: nasce una nuova
disciplina: l Epistemologia (Piaget 18961980), K. Popper (19021949).
Il positivismo e la scienza, con le grandi scoperte favorite dalla nuova tecnologia, contribuirono
ad indebolire ancor pi la religione e la fede nel trascendente di quanto non avessero fatto
lilluminismo e la rivoluzione francese. I filosofi decretavano la morte di Dio: Gott ist tot (F.
Nietzsche, 18551900). Lanticlericalismo tocc le massime punte investendo direttamente la
figura, le persone dei papi: Pio VI e Pio VII furono vittime dirette della rivoluzione francese e di
Napoleone. Gli scienziati e i medici avevano fama di miscredenti positivisti. Pio VII prigioniero in
Francia, avendo visto Laenec tra coloro che erano andati a fargli omaggio, esclam: Medicus pius,
res mirabilis!
84
La storia della Medicina dellOttocento tra le pi complesse. Nellarco che va dalla fine della
Rivoluzione allinizio del secolo XX, si sono accumulate tutte le fondamentali scoperte e nozioni
basilari in ogni settore, che hanno dato inizio al grande progresso teorico e alle pratiche
realizzazioni terapeutiche dei nostri giorni e alle prospettive future nel campo della biologia in
generale.
Prospettive talora sconvolgenti e inquietanti, da far sorgere problemi tali da far nascere una nuova
scienza, la Bioetica, che cerchi di individuare le sempre nuove problematiche e ne studi la eticit
delle soluzioni bioterapeutiche e le possibili implicazioni turbative dello stesso equilibrio
evolutivo biologico.
Nella trattazione cercheremo di enucleare, tra le scoperte, le acquisizioni pi significative e
importanti, quali base dellinarrestabile progresso.
Anatomia
NellOttocento lo studio dellanatomia non si limita pi allo studio descrittivo, macroscopico,
dei vari organi ed apparati, ma con lausilio del microscopio, ormai perfezionato e reso adatto ad
una vera ricerca scientifica (G.B. Amici 17861863), inizia una nuova branca dindagine, la
Istologia ed estende la ricerca ad un nuovo campo, la Citologia (Guglielmo Roux 18501924) e la
Anatomia comparata (G. Cuvier 17691832).
Citologia
In questo secolo viene formulata la teoria cellulare: ogni organismo, vegetale, animale e quindi
anche umano, formato da un insieme di cellule, differenziate per i diversi organi e per le diverse
funzioni: T. Schwann (1810 1882). Nel 1836 Purkinje (17871869) chiam protoplasma la
sostanza gelatinosa che circonda la massa centrale pi densa; il nucleo allinizio ebbe meno
attenzione di quanta ne ebbe in seguito. Lo si credeva non necessario alla formazione della cellula
dal momento che esistevano, come i globuli rossi, cellule senza nucleo. Fu il nostro Bizzozero che
dimostr che anche i globuli rossi, allinizio della loro vita, ne erano dotati.
Nel 1887 Boveri e Beneden scoprirono il centrosoma. Schneider osserv la divisione indiretta del
nucleo e Flemming (18431905) osserv (1880) la figura cromatica e quella acromatica: la
sostanza cromatica fu detta cromatina; descrisse inoltre la cariocinesi. Boveri nel 1887 distinse la
divisione del nucleo in diretta e indiretta: amitosi e cariocinesi. Lanno successivo fu meglio
osservata la divisione cromosomica: latto di riproduzione della cellula con la trasmissione dei
caratteri ereditari. Il primitivo assioma di Virchow (1855) omnis cellula e cellula divenne, secondo
il citato Flemming, omnis nucleus e nucleo.
Istologia
La prima rete cellulare, il primo tessuto indagato dal microscopio in modo sistematico, fu il
tessuto che regola tutto lorganismo, il tessuto nervoso. Fondamentale importanza nello studio delle
cellule nervose e del tessuto nervoso ebbe Camillo Golgi (18431926), che con la sua scoperta
della reazione nera, un particolare metodo di colorazione delle cellule e del tessuto nervoso, la
impregnazione cromoargentofila (impregnazione dei tessuti in soluzione di nitrato dargento),
pot cos evidenziare la struttura delle cellule nervose e soprattutto i loro sottili filamenti e i delicati
e intricati intrecci tra i rami delle varie cellule, dendriti, appunto come rami dalbero. Con lo
stesso metodo descrisse la sostanza connettiva del cervello, la sostanza fondamentale, detta
nevroglia. Per queste ed altre scoperte Golgi ricevette il premio Nobel (1905) ex aequo con Ramon
y Cajal (1852-1934) che ugualmente aveva studiato la sostanza connettivale del cervello. Nel 1895
descrisse la sostanza reticolare nel citolplasma delle cellule che porta il nome di Corpo del
Golgi. Individu le cellule sensitive e motorie del cordone anteriore e posteriore del midollo
85
spinale. Ebbe come assistente il Padre Agostino Gemelli (18781959), medico e ricercatore,
fondatore della Universit Cattolica di Milano.
Nellambito della composizione del sangue, Bizzozero (1846-1901) scoperse il terzo elemento
corpuscolato, le piastrine (1882). P. Erlich (18521905) mediante un suo nuovo metodo di
colorazione distinse i leucociti a seconda delle affinit per i colori basici, acidi o neutri e li distinse
in basofili, acidofili (eosinofili) e neutrofili, prefigurando cos la formula leucocitaria, ancora
utilissima nella diagnosi.
Metchnikoff scoperse il potere fagocitario dei leucociti.
Tra le altre scoperte in campo istologico ricordiamo i corpuscoli tattili di Pacini (18121883), e di
quelli descritti dal Meissner. E nel campo delludito lorgano del Corti, la degenerazione
rigenerazione delle fibre nervose di Waller, la stria muscolare di Amici, le anse dei tubuli renali di
Henle, le fibre perforanti del periostio di Shapey. E la capsula renale di Bowman (18161892)
Per quanto riguarda la tecnica istologica dobbiamo ricordare il nostro Fontana che 1776 inizi la
tecnica di attaccare i tessuti con alcali ed acidi prima di proseguire con la colorazione. E i primi
tentativi di coltivazione in vitro (A. Bonone 1885) dei tessuti, poi continuati con buoni risultati da
A. Carrel. Nel 1866 G. His invent il microtomo e Todaro, nel 1875, il metodo dei tagli
microscopici in serie.
Nel campo della Anatomia microscopica ricordiamo la scoperta del centro del linguaggio di Broca
nel 1860, e dei centri motori della corteccia parietale (Hirzig e Fritsch nel 1870). E tra le altre, nel
sistema nervoso, la scoperta della circolazione del liquido cefalorachidiano (Cushing) e i fasci del
midollo spinale: lanteriore di Gowers, 1886, il posteriore di F. Goll (18251903), e il gracile di E.
Burdach (18011876).
Per losteologia da ricordare Civinini con la scoperta della corda del timpano, e Zoia con la
scoperta della bulla etmoidalis. E inotre la scoperta del nodo atrioventricolare del cuore di Keith, e
del cosiddetto anello del Waldeyer delle ghiandole paratiroidee (Sandstrm).
Fisiologia
Il fondatore della moderna fisiologia fu Claude Bernard (18131878) che fu anche esperto
della farmacologia e filosofo della scienza. Garzone di farmacia e autore di opere di teatro, arriv
ventenne a Parigi dove, abbandonato il teatro, incominci la sua collaborazione con il grande
Magendie lavorando nei bui e tetri scantinati del suo laboratorio.
Il suo metodo di studio fu quello della autopsia fisiologica, che consisteva nellisolare, mediante
sostanze chimiche, le propriet dei tessuti e degli organi. Studi le funzioni dello stomaco del
fegato, del pancreas, dei nervi vasomotori; linnervazione delle corde vocali e la termoregolazione
nervosa. Con la sua puntura del IV ventricolo del cervello prov che la produzione di glucosio da
parte del fegato era regolata dal sistema nervoso. Nel 1857 isol il glicogeno. Studiando lazione
del curaro scopr che esso paralizza le terminazioni nervose di tutti i muscoli, compresi quelli
respiratori. Nel 1843 prov che i globuli rossi esplicano la loro funzione respiratoria in quanto
lossigeno nel sangue non libero, ma legato ad una qualche sostanza presente nel globulo rosso
stesso. Quella sostanza si rivel, alla scoperta di Khne (1865), come la emoglobina, in seguito
studiata da Hoppe-Seyler.
La figura di Claude Bernard fondamentale per seguire quel filo rosso conduttore che andiamo
cercando nel corso dei secoli allo scopo di seguirlo, individuarlo, come la strada della vera ricerca
scientifica percorsa dal pensiero medico. Il metodo sperimentale, nellambito del positivismo,
rappresenta una tappa importante, quella segnata dal grande fisiologo, filosofo, epistemologo. Il suo
metodo dichiarato nella Introdution la medicine exprimentale. Le esperienze devono partire da
una ipotesi da verificare ed eventualmente da dimostrare, appunto dallesperimento, e dalla
86
deduzione razionale, e dalla verifica pratica. La ricerca rivolta a studiare i fenomeni della
Natura, che poggiano tuttavia sui fatti che interessano la Natura nel suo complesso biologico.
I complessi fatti biofisiologici sono regolati da un inesorabile determinismo, pari a quello che
regola i processi chimici e fisici, determinati dalle loro leggi infrangibili. Non sostenibile un
vitalismo indeterminato che non possa cadere sotto le leggi della Natura che regolano il suo
sviluppo. Conferm, in via definitiva, il metodo sperimentale di ricerca medicoscientifica tuttora
riconosciuto e praticato.
E lo studio della fisiologia non pu prescindere da quello dellanatomia, ma dallanatomia in vivo,
dalla vivisezione. A questo metodo si opponeva fieramente la moglie, della Lega contro la crudelt
sugli animali: Claude si separ legalmente da Fanny Martin nel 1870.
Tra i grandi studiosi della fisiologia da ricordare J Mller (1801-1858) che spieg la visione dei
colori da parte della retina e comp fondamentali ricerche nel campo dellembriologia (Canali di
Mller). Il suo allievo E. H. Helmholtz (18211894) riconobbe la connessione tra le cellule nervose
e i nervi. Nel suo saggio Uber die Erhaltung der Kraft dimostr che tutte le fonti di energia (calore,
luce, elettricit, fenomeni chimici) possono trasformarsi le une nelle altre, ma sono indissolubili.
Interessanti i suoi studi sulla funzione uditiva e visiva. E ricordato per la sua invenzione
delloftalmoscopio. T. Young (17731828) fond la dottrina della sensazione dei colori, stabilendo
i tre elementi della retina sensibili ad essi. Di oftalmologia si interess anche J Dalton (1766
1844), dal quale deriva il nome daltonismo, del difetto della visione del colore rosso. Kries
descrisse i coni e i bastoncelli.
Tra i maggiori maestri di fisiologia dell800 figura C. Ludwig (1816--1895): insegn a Vienna e
a Lipsia dove accorrevano allievi di tutto il mondo che, assieme a lui, influenzarono lintero
pensiero medico del secolo. Tra le sue scoperte lesistenza delle cellule gangliari nel setto
interventricolare del cuore, del ramo linguale del trigemino, i nervi secretori delle ghiandole
sottomascellari, il nervo depressore del cuore e il centro vasomotore del bulbo. Invent il metodo
per mantenere vitali gli organi isolati, mediante la perfusione. Formul una teoria per spiegare la
formazione della urina: la prima causa della sua formazione la pressione idrostatica nei vasi
glomerulari, e le proteine sono trattenute nella membrana semipermeabile del glomerulo. I restanti
costituenti del plasma si concentrano nei tubuli, dove avviene un riassorbimento differenziale.
Anche la linfa si forma, secondo la sua teoria, per la pressione idrostatica dei capillari sanguigni.
Nel 1847 aggiunse un galleggiante scrivente alla colonna di mercurio del tubo a U di Poiseulle,
ponendo le basi quindi della chimografia. Fu anche un passo avanti nel perfezionamento della
misurazione della pressione del sangue, culminata nel 1896, con lapparecchio di RivaRocci.
Nel campo della ematologia sar di fondamentale importanza la scoperta di K. Landsteiner (1868
1943) secondo il quale, oltre alla eteroemoagglutinazione tra sangui di specie diverse, esisteva
anche la isoemoagglutinazione (descritta nel 1901) delle emazie di sangue umano se veniva a
contatto con siero di altro individuo: dovevano esistere nel sangue di diversi individui delle
sostanze, agglutinine nel siero e agglutinogeni nei globuli rossi, che provocavano il fenomeno. Si
scoperse in quellanno lesistenza di diversi Gruppi sanguigni.
Nel 1837 T. L. Bischoff (18171882) dimostr la presenza di anidride carbonica e di ossigeno
nel sangue, e G. Stokes (18041878), nel 1864, che era la emoglobina lagente dello scambio tra
ossigeno (O2), e anidride carbonica (CO2), attivit fondamentale della respirazione sanguigna.
E Ludwig miglior lapparecchio per lestrazione dei gas dal sangue. Hutchinson invent nel 1844
lo spirometro. Nel 1837 Flourens scopr il centro respiratorio bulbare, il nodo vitale
La fisiologia della digestione fece progressi ad opera di Ludwig, Bayliss, Starling, Deaumont
(17851853). Studi sulla saliva furono fatti da Cohnhneim (1863). La tripsina fu scoperta da Khne
nel 1876. Nel 1868 Jaffe scopr la urobilina. Ehrlich (1883) perfezion gli esami di laboratorio
sulla bile. W. Khne (18371900) fond la dottrina sugli enzimi.
87
Alimentazione. Ricambio
Lavoisier aveva stabilito la funzione calorimetrica, mentre Magendie divise le sostanze alimentari
in azotate e non azotate. J Liebig (18031873) stabil che le sostanze azotate servono per la
ricostituzione dei tessuti mentre le altre, grassi, amido e zuccheri, bruciando servono per la
produzione di calore; scopr inoltre le proteine vegetali (1855). Green, nel 1809, scopr il glutine di
cui fece la prima analisi chimica, ricercandone il contenuto in calcio, azoto, idrogeno e carbonio:
Ca, N, H, C. Con questi studi inizia la chimica biologica che, tra laltro, dimostra come lenergia
chimica si pu trasformare in energia calorica, termochimica (Berthelot 186468). Bunge (1803
1897) mise in evidenza limportanza delle sostanze minerali, sali. Altri studiosi furono Pettenkofer
e Voit, MagnusLevi e Minkovski, che posero le basi per le ricerche sul bilancio nutritivo (von
Voit) e sul ricambio in stato di lavoro o di quiete.
Sono i primordi della dietetica.
Prodromi dellendocrinologia
La scoperta e il concetto di vitamina non appartengono all800, anche se gi alla fine del secolo si
era capito che nel pericarpio del riso era contenuta una sostanza che impedisce il Beriberi. Solo
nel 1911 Funk conier la parola vitamina applicata a quella antiberiberica.
Anche lEndocrinologia nascer nel XX secolo. Tuttavia lo studio delle ghiandole e della propriet
dei loro secreti faceva gi intuire a Claude Bernard lattivit di secrezione interna di certe
ghiandole: funzione glicogenica del fegato e relazione con letiologia del diabete. Minkowski
provoc il diabete arsportando il pancreas in animali da esperimento (1889). Solo allalba del XX
secolo si porrano le prime ipotesi sulle alterazioni delle Isole di Langerhans quali causa del diabete
(MaCollum, Opis)
Ugualmente erano noti gli effetti della privazione della tiroide e delle paratiroidi (Flaiani,
Basedow, Gull). Fraenkel prepar estratti surrenali che contenevano adrenalina, e Abel, nel 1898,
chiam il suo estratto epinefrina. Le relazioni tra ipofisi e gigantismo e acromegalia furono messe in
rilievo da Pierre Marie nel 1886. Minkowski provoc il diabete asportando il pancreas in animali
da esperimento (1889). Solo allalba del XX secolo si porranno le prime ipotesi sulle alterazioni
delle Isole di Langerhans quali causa di diabete (McCallum, Opis). Ugualmente erano noti gli effetti
della privazione della tiroide e delle paratiroidi (Flaiani, Bsedow, Gull). Fraenkel prepar estratti
surrenali che contenevano adrenalina,e Abel, nel 1898, chiam il suo estratto epinefrina. Le
relazioni tra ipofisi e gigantismo e acromegalia furono messe in rilievo da Pierre Marie nel 1886,
Una vera dottrina ormoni sar elaborata pi tardi da Starling e Bayliss, e da Pende in Italia.
Non minor spicco nella fisiologia fu quello di Brown Squard (18171894) nato nelle isole
Mauritius, di padre americano e madre francese, il primo grande studioso di scienza medica degli
Stati Uniti. Giovanissimo, descrisse la Sindrome che porta il suo nome: gli effetti della sezione
trasversa del midollo spinale. Dimostr inoltre gli effetti della emisezione del midollo spinale e gli
effetti della stimolazione del simpatico cervicale sui vasi. E, nel 1856, che gli animali non potevano
vivere senza le surrenali. Assieme ad altri, gi ricordati, apr la strada alla Endocrinologia.
IL DIABETE
Diabete (diabetes ), come citato da Lucio Giunio Campanella, scrittore del I sec d.C.,
significa condotto adatto a far attraversare un liquido dallalto in basso, sifone. Definizione antica
del passagio dellurina attraverso la persona ammalata. Areteo di Capadocia , fine II sec d.C. della
ascuola eclettica d una pregevole descrizione del diabete.T. Willis, nel 1674 rilev il sapore
dolciastro delle urine. Claude Bernard (1813 1878) afferma che i diabetici hanno troppo
glucosio nel sangue. Langerhans (1847-1888) scopr nel 1869 le insule del pancreas. Nel 1874
88
Kussmaul descrisse i sintomi del coma diabetico. Best Charles (1899-1978) isol nel 1921
linsulina insieme a Banting (1891 1941) che la iniett nel 1922 in una cagnolina. Nel 1923
unazienda tedesca mette a disposizione degli ammalati un tipo di insulina derivata dal pancreas.
Nel 1955 F. Sanger ne chiarisce la struttura e nel 1958 realiza la insulina sintetica. Nel 1981 si
produsse linsulina umana mediante lEscherichia coli ad opera di Goodman. Poco dopo appare sul
mercato la prima insulina biosintetica titolata in U.I. per via sottocutanea o intramuscolare.
Attualmente sono in vendita confezioni di insulina umana con siringa allegata e strumento per
determinare le unit da iniettare. Ci sono due tipi di diabete: Tipo I = insulino - dipendente,
giovanile e Tipo 2 non insulino dipendente, degli anziani. Il diabete caratterizzato da
ipergicemia: sopra 120 mg% e glicosuria. Si usa la prova da carico glucosico per determiare un
diabete latente (Staub Traugott). Si pu arrivare al coma quando il fegato perfuso da aminoacidi
chetoplastici. Il diabete di Tipo due il pi comune e si trasmette ereditariamente (famigliarit).
Nel 1942 46 si studiarono gli antidiabetici orali. I principali sono le solfoniluree, di prima e di
seconda generazione (gliburide e glipizide. Dal 1996 in uso la glimepiride, di terza generqzione
(Solosa). Stimolano la secrezione di insulina endogena. Si deve usare dieta appropriata, esercizio
fisico e controllo del peso. Alla fine degli anni 50 viene introdotta la metformina (Metforal) che
riduce il glucosio epatico. Per il monitoraggio si usa la glicemia (75 120) una o due volte la
settimana. Per valutare i valori medi della glicemia si usa la Hb-glicosilata HBA1C (valori normali
4,3 5,9) 4 volte lanno. Si usano anche i sartani : candesartan (Blopress Ratacand).
ANATOMIA PATOLOGICA
Sulla scia e seguendo linsegnamento di Morgagni, lAnatomia patologica si svilupp come
necessaria base dellinterpretazione clinica della patologia. Delle varie scuole, quella di Vienna fu
tra le pi importanti. Suo fondatore fu il medico boemo K. Rokitansky (18041878). Suoi
principali contributi scientifici furono la distinzione della polmonite lobare dalla broncopolmonite,
la dettagliata descrizione dellatrofia gialloacuta del fegato e della degenerazione amiloide. Da
ricordare lagenesia vaginale con difetti dei genitali, sindrome che porta il suo nome. In opposizione
alla scuola viennese, la scuola tedesca (Goethe 1749-1832), influenzata dalla Naturphilosophie di
Schelling, il filosofo idealista della intuizione lirica della Natura, espressione pi caratteristica dello
spirito romantico, espresse il suo massimo esponente in Rodolfo Virchow (18211902). Lautore
della Die cellular patologie (185861), pur dichiarando nella prima edizione, citando Bichat, di
non voler rivoluzionare, ma solo riformare le precedenti concezioni (sostanzialmente umoralistiche)
della patologia, ha in effetti rivoluzionato e definitivamente sepolto le vecchie teorie. La sua opera
venne percepita, giustamente, come la prosecuzione della morgagnana De sedibus, ricercando il
celebre studioso, con laiuto del microscopio, la sede delle malattie nella cellula e negli aggregati
cellulari, come il maestro padovano laveva cercata nella forma degli organi. Questo fu il merito
principale di Virchow che rimane un punto fermo, anche se nella sua descrizione risente ancora
dellumoralismo. Non fa alcun cenno allazione microbica e ritiene i tumori eterotipie dovute ad
alterazione di succhi parenchimatosi pi o meno cospicui a seconda della malignit. Distinse la
pioemia dalla setticemia, lartrite deformante dalla artrite gottosa. Descrisse la leucemia, sangue
bianco. Individu la tirosina e la leucina nel pancreas. Spieg linfiammazione, tumor, con
lemigrazione attiva dei leucociti dal torrente circolatorio attraverso la membrana vasale integra,
vedi G. Cohnheim (18391884).
Contemporaneamente alla sua attivit di grande anatomopatologo, svolse anche intensa attivit
politica, fu membro per i liberali del parlamento prussiano, os sfidare Bismarck a duello! Mise la
sua autorit scientifica al servizio della Germania unificata, alla ricerca della identit razziale. Cos
organizz in tutto lo Stato una indagine statistica sul colore degli occhi, dei capelli e della pelle dei
bambini nelle scuole, alla ricerca della razza germanica: occhi azzurri, capelli biondi, pelle chiara.
Dalla sua ricerca risult che nel 54,1 % i bambini dimostravano un miscuglio di caratteri. Ma i
89
bambini ebrei erano scuri per il 42 %. Nonostante che Virchow si opponesse alla utilizzazione
politica dei suoi dati, questi furono strumentalizzati dagli antisemiti, in definitiva favorendo
lantisemitismo pi tardi esploso ad opera del nazismo che si richiam, spesso impropriamente, a
illustri paternit come Nietzsche, Wagner e Gobineau che pubblic il suo saggio Sulla
ineguaglianza delle razze nel 1853.
Fisiologia della digestione
Nellambito della fisiologia della digestione ebbero un particolare significato gli studi e le
scoperte di Pawlow. Prima di quelli ricordiamo gli esperimenti eseguiti da W. Beaumont (1785
1853), lavventuroso medico dellesercito americano che ebbe la ventura di poter utilizzare una
fistola gastrica prodotta da una ferita da arma da fuoco su un cacciatore. Per otto anni pot
guardare direttamente le pareti gastriche con laiuto di una lente, usando per il resto i propri sensi
e un termometro Fahrenheit. Studi ogni modificazione in coincidenza degli eventi fisiologici e in
particolari situazioni emotive, ansia, paura, delusione, iraE cos pot stabilire che gli alimenti
animali e farinacei sono pi digeribili dei vegetali; la digestione facilitata dalla piccolezza delle
parti di cibo; i principi finali degli alimenti sono gli stessi indipendentemente dal cibo di
provenienza; lazione dello stomaco e dei suoi succhi la stessa per qualsiasi dieta. Mand
campioni di succo gastrico a vari chimici, Duglison, dellUniversit della Virginia, riconobbe in
esso lacido cloridrico. La fistola di Beaumont servir poi alla costruzione di fistole artificiali, di
Witzel, per la nutrizione con sonda dei pazienti di cancro gastrico.
Una breve trattazione a parte merita lo studio dei riflessi condizionati. J. P. Pawlow (18491936)
li scoperse nel corso di esperimenti sulla secrezione gastrica e pancreatica allazione di stimoli
esterni con lattivazione di funzioni cerebrali superiori. Condusse i suoi studi nellanimale sano e
vivente, mediante lesecuzione di fistole artificiali nelle ghiandole salivari, nellesofago e nel
pancreas, e in particolare con la creazione di una piccola sacca nello stomaco, ventricolo di
Pawlow. Le ghiandole salivari reagiscono, oltre che agli stimoli chimici del tipo di cibo ingerito,
anche agli stimoli psichici: odore, aspetto, richiamo del pasto emozioni.
E diventato storico il suo esperimento: presentava il cibo ad un cane e, contemporaneamente,
metteva in azione un metronomo e accendeva una lampadina. Ci ripeteva per alcuni giorni.
Accendendo poi la lampadina e azionando il metronomo, senza lofferta di cibo, le ghiandole
salivari rispondevano ugualmente con la loro secrezione. A livello della corteccia cerebrale, quindi,
si fissavano gli effetti del complesso di stimoli somministrati. Le cellule nervose conservavano per
qualche tempo la capacit di rispondere anche a stimoli separati dal complesso stimolante
originario, rispondendo anche a quelli inadeguati ad ottenere la risposta naturale. Avveniva un
condizionamento delle cellule nervose: della capacit psicosensoriale (1903).
Pot anche indurre delle nevrosi, mediante la somministrazione al soggetto di stimoli
contraddittori. Nel campo della fisiologia isol lenzima entrochinasi con Shepovolnikov. Ottenne il
Premio Nobel nel 1904. Il Governo Sovietico assicur al compagno Pawlow le condizioni pi
favorevoli alle sue ricerche e inaugur nel 1923 la Citt del riflesso condizionato a Leningrado.
La microbiologia
Abbiamo visto che il concetto microbiologico, secondo cui le malattie prodotte dai miasmi in
realt fossero dovute a degli animaletti presenti nel materiale inquinato, presente anche nel 700,
e gi ipotizzato da Fracastoro. Ma ancora nei primi decenni dell800 cerano studiosi che asserivano
la loro presenza ed altri che la negavano. Altri asserivano che il contagio dipendesse dalle sostanze
materiali contenenti sostanze venefiche, saline o metalliche.
Per sciovinismo, ma certo con fondate ragioni, potremmo dire che la conferma dellorientamento
microbiologico sorta nel Veneto. Era accaduto nel 1819 (ma chiss quante altre volte), che un
90
villaggio del Veneto fosse preda del panico stregonesco perch alcune fette di polenta aveva
no assunto un colore rosso sanguigno. Chiamato ad indagare V. Sette (17851827) pervenne alle
sue conclusioni nel 1824 quando pubblic unoperetta intitolata Memoria storico naturale
sullarrossamento di alcune sostanze alimentose osservato nella provincia di Padova nel 1819. In
quello scritto sosteneva che larrossamento era dovuto allazione di un essere microscopico che
denomin zoogalactina inetrofa, che poi fu chiamato col suo nome attuale da Flgge bacillus
prodigiosus. Bizio nello stesso periodo riproduceva sperimentalmente, a Venezia, lo stesso
fenomeno. Del contagio microbico era convinto anche Enrico Acerbi (17851827), medico lodato
dal Manzoni, che sostenne che la causa del tifo petecchiale era una sostanza specifica organizzata
in grado di riprodursi e di svilupparsi allinterno di un altro essere vivente.
Ma il vero padre della microbiologia, almeno per noi italiani, da considerarsi Agostino Bassi
(17731857), laureato in legge, ma frequentatore delle lezioni di Spallanzani e di Rasori, il quale
diede dimostrazione incontrastabile di causaeffetto tra agente microbico e malattia. Studiando la
malattia dei bachi da seta (mal del calcino moscardino) che si credeva sorgesse spontaneamente
per condizioni atmosferiche o per alimentazione del baco, fece questo ragionamento: se la malattia
non si sviluppa spontaneamente nel baco, pu darsi che essa debba aver bisogno di un germe
estraneo che, entrato in esso per di fuori, abbia a generarla. E allora vide che, conficcando un ago
dacciaio in un filugello (baco da seta), ucciso dal mal del segno e ferendo quindi con questo un
altro filugello, egli vide che si comunicava a questo il terribile morbo moscardino; questessere
omicida organico, vivente e vegetabile: un fungo parassita delle crittogame (1837).
Il nostro avvocato-agricoltore si occup per 26 anni di esperimenti; la sua opera non interessa solo
la bachicoltura, ma investe tutto il campo della microbiologia, delle malattie epidemiche quando
soprattutto afferma che il contagio pu essere dovuto anche a vettori di microbi: le mosche diceva
possono essere apportatrici di molte specie di contagio, per non dire di tutti. Non solo, ma
dimostr che lagente del malcalcino poteva anche essere distrutto da sostanze disinfettanti.
PASTEUR
Un altro scienziato non medico, mancato pittore, chimico, diede fondamentale impulso alla
sistemazione della Microbiologia patogena, Louis Pasteur (18221895). Fu il primo ad amalgamare
in un tutto organico quello che era stato, in campo di contagio animato, felice intuizione, geniale
scoperta, severit sperimentale sulletiologia delle malattie infettive. Costru e utilizz la grande
macchina investigativa tesa a scoprire la causa delle malattie e la cura di esse basata
sullattenuazione degli agenti patogeni. Ancora una volta, grandi e fondamentali scoperte nel campo
della medicina presero lavvio da altre discipline.
Lalcool di barbabietola, usato per la fabbricazione della birra, era spesso contaminato da sostanze
estranee: scoperse che si trattava dei globuli del lievito e che nei liquidi che non erano fermentati
erano presenti moltissimi bastoncelli isolati o a catena. Vide che il secondo liquido non era alcool,
ma acido lattico: si trattava della fermentazione alcolica e della fermentazione lattica: in ambedue
tuttavia agiva un essere vivente, un bacillo, come causa del fenomeno.
Un episodio di ictus cerebrale non imped di riprendere gli studi dopo soli tre mesi. Era alle prese,
anche lui, con una malattia del baco da seta, questa volta la pebrina, che minacciava lindustria
della seta di tutta la Francia (1864).
Dimostr, nel 1870 a Villa Vicentina, che la causa della malattia era la presenza di certi
corpuscoli ovali, lucenti. Si poteva evitare la malattia usando per lallevamento dei bachi, delle
uova prive, al microscopio, di tali corpuscoli. Esisteva un rapporto di causaeffetto tra corpuscoli e
malattia.
Pasteur scopr numerosi microrganismi: il cocco piogeno (stafilococco), il pneumococco, lo
streptococco (a rosario), il microbo della febbre puerperale (microbe en chapelet de grain), 1789.
Nel 1875 Pasteur riusc ad ottenere delle culture pure di bacillo del carbonchio, confermando la
causa della malattia, ma vide anche che, nei successivi passaggi delle colture, circa 40, il bacillo
91
assumeva delle forme diverse che si allungavano e si intrecciavano. Anche Koch faceva analoghe
esperienze. Il bacillo si attenuava, e le colture di esso, cos ottenute, potevano essere iniettate nelle
pecore, e realizzare cos la vaccinazione contro la malattia (1881).
La maggior fama di Pasteur gli deriva, per, dai suoi studi sulla rabbia. Prima delle sue scoperte
lunica terapia era il ferro rovente sulla morsicatura del cane idrofobo. E ugualmente la quasi
totalit dei pazienti idrofobi morivano. Il randagismo era pi diffuso di oggi, e la paura, il terrore
popolare dellidrofobo era tale che era usanza avvelenare, strangolare o abbattere a fucilate
chiunque fosse morso da un cane sospetto; e ci fino al 700, quando una legge fu emanata per
reprimere la barbara usanza.
Pasteur aveva osservato che non tutti i morsicati da cani sicuramente idrofobi si ammalavano:
forse il virus si disperdeva, allora, nellorganismo e cos diluito non era pi patogeno: la sua
virulenza si attenuava. Forse si poteva ottenere lattenuazione con successivi passaggi del virus in
organismi viventi. Ma occorreva prima disporre di un virus ad incubazione fissa, che cio
producesse la malattia dopo un esatto periodo dallinoculazione. Allo scopo iniett a dei conigli in
serie il virus da strada (naturale), per via sottodurale. Dopo circa 50100 passaggi otteneva un virus
ad incubazione fissa, di sette giorni: era il virus fisso. Ora bisognava attenuarlo. Per fare ci
escogit il seguente metodo: essiccava il midollo spinale di coniglio, preventivamente infettato con
virus fisso, e lo metteva in pezzetti in un vaso di vetro, a 2223 gradi, sul fondo del quale erano
posti pezzi di potassa caustica. Il vaso viene tappato con cotone, in modo che vi passi aria con
ossigeno. Dopo 23 giorni il materiale contiene virus innocuo per via sottocutanea. E il virus
fisso attenuato utile per la vaccinazione dei morsicati da cane idrofobo. Tanto pi utile quanto pi
precocemente iniettato. Iniziati gli esperimenti nel 1881 ebbe loccasione di sperimentare la sua
scoperta il 6 luglio 1885. Dopo angosciosi indugi iniett il suo virus fisso attenuato a Joesph
Meister di 9 anni, figlio di una povera alsaziana, con pieno successo. Ebbe subito fama in tutta
Europa. Ma qualche insuccesso e, forse, le inevitabili invidie gli valsero laccusa nientemeno che di
omicidio. Laccusa fu sostenuta da un giovane medico, tale Georges Clemenceau, che divenne poi
presidente del Consiglio francese e fu detto il Tigre. La classe medica, come sempre, si divise. Lo
stesso Roux (1850-1924) abbandon le sue ricerche sulla rabbia. Gradatamente le polemiche
cessarono e la validit del metodo prese definitivamente piede. Quando dalla Russia arrivarono a
Parigi 19 mugiki morsi da un lupo 20 giorni prima, nonostante il lungo periodo dal morso 16 di
essi si salvarono. Fu un trionfo. Lo Zar lo insign della Croce di SantAnna, e invi 100.000 franchi
per linizio di quello che sarebbe divenuto il famoso Istituto Pasteur di Parigi. In questo istituto
lavora il Prof. Montagner, che individu lHIV, il virus dell AIDS, o alla francese, del SIDA.
LAIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) stato segnalato la prima volta nel 1981. Dopo
25 anni ha fatto 20 milioni di morti!
ROBERT KOCH
Robert Koch (18431910) cominci i suoi esperimenti da medico condotto, usando un
microscopio che gli aveva regalato la moglie nel suo trentesimo compleanno. Cercava la causa del
carbonchio che colpiva inesorabilmente animali e contadini. Usava i topolini: una mucca o una
pecora sarebbero state troppo care. Nel sangue degli animali infetti aveva scorto dei corpuscoli neri
mobili, li ritenne responsabili della malattia. Present la sua scoperta allUniversit di Breslavia
dove insegnavano Cohn ed Ehrlich. Aveva anche dimostrato che la trasmissione della malattia
avveniva attraverso le spore in cui si trasformavano i bacilli di carbonchio. Spore resistentissime in
qualsiasi ambiente: per distruggerle non restava che incenerire le carcasse degli animali morti da
carbonchio. I bacilli del carbonchio erano gi stati visti da Duvaine nel 1850, ma la prova definitiva
di causa ed effetto fu data da Pasteur.
Divenuto professore a Berlino Koch si accinse nel suo laboratorio ben attrezzato alla ricerca della
tubercolosi. Procedeva con regole sicure, i cosiddetti postulati di Koch: il microrganismo presente
e dimostrabile in ogni caso della malattia infettiva in esame; deve essere coltivato in coltura pura;
92
linoculazione della coltura deve produrre la malattia negli animali recettivi; il microrganismo deve
poter essere isolato nuovamente da quelli animali e coltivato in coltura pura.
Per il suo lavoro di ricerca invent molti terreni di coltura, preferendo quelli solidi, tra cui la
patata, svilupp tecniche di colorazione con lanilina, taluno gli attribuisce anche la priorit della
microfotografia.
La scoperta del bacillo della tubercolosi, un bacillo che resiste agli alcoli e agli acidi, e appare al
microscopio come un bastoncino rosso in campo blu, venne annunciata il 24 marzo 1882 alla
Societ Tedesca di Fisiologia, presente il grande Virchow, che, alla fine della relazione si alza e se
ne va, in silenzio: non aveva nulla da eccepire a quanto Koch aveva detto. Grande fu lemozione di
quella scoperta in tutto il mondo: si sperava di poter trovare la terapia. Bisogner aspettare che
lagronomo russo, naturalizzato americano, Waksman la scopra, col suo gruppo, nel 1943. E per noi
ben dopo la fine della guerra.
Nel 1884 scoperse il vibrione del colera, il nostro miglior alleato lo defin per le quattro
pandemie in Europa dopo il 1830: lo studi in Egitto, lo isol e ne riprodusse la malattia. Il nostro
Pacini lo aveva gi identificato nel 1854. Nel 1890 annunci la tubercolina, estratto batterico del
bacillo da lui scoperto.
Era vissuto nellera dei microbi. Di carattere mite e schivo, attribuiva le sue scoperte
principalmente alla fortuna di essersi imbattuto in una regione dove loro era ancora sparso per le
strade. Nel 1905 ebbe il Premio Nobel.
La malaria
Nella seconda met dell800, quando la malaria mieteva vittime in tutto il mondo, A. Laveran
(18451922) nel 1880 osserv nel sangue dei malarici dei corpiccioli di quattro forme: sferica, a
rosetta, a semiluna e flagellata: le ritenne forme di un unico parassita che denomin Plasmodium
malariae. Il parassita di Laveran si riveler essere, come dimostr Grassi nel 1889, il Plasmodium
falciparum. Nel periodo dal 1886 al 1893 si occup di malaria anche Camillo Golgi (18841926)
che stabil la legge che va sotto il suo nome: ciascun accesso febbrile corrisponde alla
moltiplicazione del parassita maturo e allinvasione delle forme giovanili nel sangue.
Bignami, Koch e Manson, nel 1894, sostennero che la malaria dovesse essere trasmessa da insetti
ematofagi. E Manson incaric Ronald Ross (18571932) di scoprire quali insetti fossero in causa,
essendo medico militare in India. Studiando lo stomaco dei mosquitos vide in esso dei
corpi flagellati, e nelle ghiandole salivari gli sporozoiti. Ma ci per quanto riguarda la malaria dei
passeri e non per la malaria umana. Del genere mosquitos molte sono le specie, ma quali insetti
sono i veri vettori del plasmodio? G. G. Grassi (18541925), zoologo dellUniversit di Roma,
cattura e studia le zanzare nellagro pontino molto ben fornito. Intanto stabilisce che la malaria
esiste solo dove esistono le zanzare. Ma non c sempre malaria dove ci sono le zanzare: non tutte
le zanzare, quindi, ma solo alcune specie possono produrre la malaria. Alla fine conclude che solo
uno strano tipo di zanzare dalle ali grigiochiare, lo zanzarone che gira solo di sera e che gli zoologi
chiamano Anopheles claviger, quello che produce la malattia. Non solo, ma solo la femmina
che succhia il sangue delluomo infetto e lo trasmette ad altri individui infettandoli. Era il 29
settembre 1898. Mentre Ross descrive il ciclo riproduttivo del plasmodio nel globulo rosso, Grassi
descrive la parte del ciclo che avviene nello stomaco della zanzara. Tra Grassi e Ross intercorre una
lunga e spietata guerra per la paternit e la precedenza delle scoperte. Grassi diventa senatore del
Regno dItalia e laureato honoris causa a Lipsia, ma il Premio Nobel sar assegnato a Ross nel
1902.
93
La difterite
Lo studio di questa patologia ebbe particolare impulso quando Napoleone indisse un concorso per
lo studio della malattia. Nel 1826 Bretoneau identific il croup con la angina pseudomembranosa.
La parola croup, coniata da F. Home nel 1765, significa strozzamento, con il suono dellabbaiare.
E. Klebs (18341913) scoperse il bacillo, il corynebacterium difteria, nel 1883, ma G. F. Loefler
(18521915) lo isol e coltiv su terreno speciale nel 1884 e ne diede il nome.
Bouchot introdusse la pratica dellintubazione nel croup che salv la vita a tanti piccoli ammalati e
Trousseau effettu la tracheotomia. Ma la malattia fu vinta solo con la vaccinazione e la
sieroterapia. E. Behring (18541917) individu lattivit determinante degli anticorpi, delle
antitossine, nel 1890.
La disinfezione
I P. Semmelweis (1818 1865) fu il grande pioniere incompreso dellantisepsi. Gi Bassi
aveva visto che lalcool iodato giovava nei processi suppurativi (1854). Quando Semmelweis,
giovane medico ungherese, arriv allOspedale generale di Vienna trov una assai strana
situazione nelle due cliniche ostetriche. Nella I quasi tutte le puerpere morivano a seguito di
violenti febbri, mentre nella II le morti puerperali erano assai minori. Nessuno sapeva darsi
ragione del fatto. Il giovane assistente fa spostare gli studenti e le ostetriche delle due cliniche: il
personale di una clinica passa nellaltra e viceversa. Sembra che le febbri seguano gli studenti! Nel
frattempo accade che un suo collega carissimo muore in poche ore per una infezione ad una mano
nel corso di unautopsia, con lo stesso quadro clinico e tanatologico delle puerpere. Nasce il
dubbio: sono le dita degli studenti, contagiatesi nel corso delle recenti dissezioni, che portavano le
fatali particelle cadaveriche negli organi genitali delle puerpere, allaltezza dellutero?: non si
erano ancora visti i microbi. Unico segno sensibile, lodore delle mani dopo le autopsie. Ne
deriva chiara la conseguenza: dora in poi chiunque abbia eseguito autopsia o semplicemente sia
entrato in una sala anatomica deve lavarsi accuratamente le mani con soluzione di cloruro di calce,
finch non sia scomparso il lezzo cadaverico. Dopo tale semplice misura lindice di mortalit
puerperale era sceso rapidamente al 3, 4 %. Le mani per devono essere disinfettate dopo ogni
visita alla paziente, e non solo prima del turno di visite. Con questo secondo accorgimento il tasso
scese ulteriormente (1847). Nello stesso anno, per, muoiono altre puerpere, esplorate dopo il
ricovero di una paziente affetta da cancro icoroso: con i tessuti in avanzata decomposizione. E
altre muoiono dopolesplorazione genitale da parte di un medico che aveva medicato unartrite
purulenta. Sammelweis ne dedusse, giustamente, che ogni sostanza decomposta ha la capacit di
indurre la febbre puerperale. Ne segue la logica contromisura: obbligo di disinfezione prima di
ogni esplorazione per chiunque, obbldisinfezione dei ferri chirurgici, della biancheria, padelle,
speculum. La mortalit delle puerpere scende allo 0,5%. E la vittoria delle intuizioni del
medico ungherese. Nel 1858 stampa a Budapest Il concetto, la patogenesi e la prevenzione della
febbre puererale.
. Per le sue intuizioni dovette combattere con illustri scienziati, tra i quali con il grande Virchow.
Pochi, tra cui Rokitansky, furono dalla sua parte. Si cre troppi nemici: dovette tornare a Budapest.
Malato di morbo di Alzheimer, poco bene controllando i movimenti, si ferisce ad una mano durante
unautopsia, sinfetta e muore. Allo Josephinum di Vienna sono religiosamente custoditi i suoi
strumenti e la famosa bacinella della disinfezione.
Lord Giuseppe Lister (18271912) operava nellOspedale di Glasgow dove per lo stato
antigienico moriva il 45% dei pazienti. Come tutti i chirurghi del mondo era alla ricerca di opporsi
alle complicazioni suppurative delle ferite, sia chirurgiche che traumatiche. Nel 1861 era convinto
che la suppurazione fosse determinata dalla decomposizione dei tessuti. Aveva osservato che le
94
fratture associate a lacerazioni dei tessuti superficiali suppuravano quasi sempre e andavano spesso
in gangrena con morte conseguente. E che le ferite chirurgiche suppuravano quasi regolarmente, e
pi delle altre le ferite esposte allaria. Nellaria, aveva imparato dalle opere di Pasteur, esistevano i
germi della putrefazione e della fermentazione: bisognava quindi distruggere questi germi sia
nellaria sia sulle mani e sul materiale di medicazione dove si depositavano, sulla cute e sulle stesse
ferite chirurgiche. Nellaria spruzzava lacido fenico con uno speciale nebulizzatore, nelle ferite
applicava garze imbevute di acido fenico, sulla cute poneva un telino imbevuto di acido fenico
coperto con una sottile lamina di stagno per impedirne levaporazione. Sembra che la sua prima
utilizzazione dellacido fenico sia stata nellagosto del 1865. Gi Lemaire e Declat per ne avevano
vantate le doti disinfettanti nel 1861. Anche Vanzetti a Padova aveva praticato il concetto di opporsi
alla sepsi, lantisepsi; egli pungeva gli ascessi freddi sotto acqua per proteggere la ferita dai germi
dellaria. A Lister tuttavia riconosciuto il merito non solo di aver praticato il suo metodo, ma
anche di averlo diffuso in tutto il mondo. Adott anche la preparazione del campo operatorio,
eseguiva infatti le sue incisioni chirurgiche attraverso un pannolino imbevuto di olio fenicato.
Lacido fenico si dimostrava irritante e tossico, volatile e di sgradevole odore. Vennero usati molti
altri disinfettanti, lacido salicilico, il timolo, lacido benzoico e la tintura di jodio.
Lister fu sempre riconoscente a Pasteur che aveva visto quei germi, nemici dei chirurghi, che con
i suoi disinfettanti aveva sempre combattuto, e con efficacia. Il felice connubio del microbiologo
con linventore della antisepsi, fu suggellato nel 1892 con labbraccio tra i due grandi nella sala
maggiore della Sorbona.
La semeiotica
La percussione raggiunse un importante traguardo con linvenzione della percussione mediata,
percuotendo cio torace e addome con linterposizione del dito con funzione di plessimetro: il
metodo attuale. Con tale accorgimento si pot determinare il confine degli organi e quindi dedurne
il loro volume. Questo metodo fu ideato da A. Piorry ( 17941879). Anche il metodo auscultatorio
fu modificato, non pi diretto ma anche questo mediato: allinizio con un tubo di carta!. Toccare
direttamente la cute di una donna, specie se giovane, con lorecchio del medico non era
conveniente daltra parte cera di mezzo ligiene: ricordo alcuni medici che ascoltavano il
torace di una donna attraverso un pudico fazzoletto steso sulla cute. Lannec (1781-1829) ebbe
unidea: di fronte ad una donna piuttosto grassa pens di frapporre qualcosa tra la sua orecchia e lo
spesso adipe: arrotol il suo quaderno e ne fece un cilindro e appoggi una estremit sulla pelle da
auscultare e laltra sul suo orecchio: si sentiva ugualmente bene, anzi meglio. Scriveva: rimasi
sorpreso e lieto nelludire i battiti del cuore molto pi chiaramente. Con le sue mani costru il
primo stetoscopio: un cilindro di legno 23 X 3,10 , scanalato per lungo. Fu chiamato cilindretto,
sonometro, cornetto medico, da noi trombetta Con successivi perfezionamenti pot udire il soffio
anemico, il soffio di raspa, di rigurgito, di trottolacon i quali si poterono porre diagnosi pi
precise sulle malattie cardiocircolatorie, toraciche e anche addominali. Laennec lo chiam steto
scopio, che vede dentro, come appunto unautopsia sul vivente. Il suo celebre libro De
lauscultation mdiate fu pubblicato nel 1819.
Anche la termometria, la misurazione della febbre, progred nell800. Gi Van Swieten (1700
1772) ne aveva diffuso la metodica con il termometro a mercurio di Fahrenheit posto in bocca del
paziente. A. R. Martin stabil nel 1763 che la temperatura normale era 3637 gradi. Ma il vero
fondatore della moderna termometria fu C.A. Wunderlich (18151877), quando la febbre venne
considerata un sintomo non una malattia.
95
Lanestesia
Oltre alluso della disinfezione e al concetto dellantisepsi, fu fondamentale la scoperta
dellanestesia per lincremento della chirurgia in tutte le sue specialit. Prima delluso degli
anestetici, il paziente in attesa dintervento scriveva W. Simpson nel 1884 era pervaso dalle
stesse ansie e paure che tormentavano chi dovesse essere sottoposto a tortura o in procinto di essere
giustiziato. Si erano tentati vari metodi per alleviare il dolore: luso dellalcool, delloppio, e
perfino dellipnosi. Un giorno del 1789 scrive H. Davy, linventore della lampada per i minatori
mi spuntavano i dentes sapientiae, e linfiammazione era particolarmente dolorosa, aspiravo tre
dosi abbondanti di protossido dazoto: il dolore scemava e subentrava un senso di euforia.
Bisognava per aspettare il 1844 per verificare sulluomo leffetto anestetico del gas esilarante.
Orazio Welles (18151848), un dentista americano, lo speriment su se stesso e sui pazienti
durante lestrazione dentaria. La pubblica dimostrazione allUniversit di Harvard, fu per una vera
catastrofe. Abbandon la professione, si diede alla droga, al cloroformio, e fin suicida. Un altro
dentista J. H. Smith riusc nel 1868 ad eseguire in modo indolore una vera operazione chirurgica
con lo stesso gas esilarante che si dimostr anche anestetico. Nel 1846 il farmacista C. Jackson
(18051880), precisamente il 30 settembre, mise a conoscenza il dentista W. Morton (18191868)
delle propriet anestetiche del vetriolo dolce, cio delletere solforico. Il dentista non perse
tempo: il giorno dopo esegu la prima estrazione indolore con quel gas. Pochi giorni dopo, Morton
esegu per Warren, chirurgo di Boston, la narcosi eterea su un giovane paziente affetto da tumore:
loperazione si svolse indolore. Levento fu comunicato da Bigelow allAccademia delle scienze e
delle arti. Il dott. Guld us, in quelloccasione, il termine gi usato di anestesia che significava
allora, genericamente, soluzione di nervi accompagnata da privazioni di tutto il sentimento, cio
di lipotimia. Etimologicamente, privazione di sensazioni.
Lanestesia si diffuse tra tutti i chirurghi, che cos poterono eseguire con maggior tranquillit
operazioni pi lunghe e indaginose. Tra Morton e Jackson insorsero rivalit e litigi circa la priorit
della scoperta. Ne ebbe la peggio Morton, che ridotto in miseria dalla lunga vertenza, colpito da
apoplessia, si diede allwhisky e mor pazzo.
Un anno dopo la scoperta della narcosi eterea, Bell e Flurens comunicarono allAccademia di
Medicina di Parigi che il cloroformio, scoperto nel 1831-32 simultaneamente e separatamente
dallamericano Guthrie (17821848), dal francese E. Soubeiran (17931858) e dai tedeschi I. v.
Liebig (18031873) e Fr. Woehler (18001882), aveva le stesse propriet delletere.
Lo stesso anno, 1847, lostetrico di Edimburgo J.Young Simpson (18111870), insoddisfatto
delluso anestetico delletere, dopo aver provato il cloroformio lui stesso e i suoi assistenti, lo
sommistr con buon esito ad una partoriente. Il parto indolore ebbe grande diffusione ma anche
tante dispute, critiche e accuse. La Chiesa ricord il castigo biblico che la donna doveva partorie
con dolore. Simpson vi oppose che Dio, per operare Adamo di asportazione di una costola da
trapiantare su Eva, prima lo fece sprofondare in un sonno profondo: lo sottopose ad anestesiaAlla
fine la Regina Vittoria pens che era meglio partorire senza dolore e mise alla luce il suo ottavo
figlio, Leopoldo, in anestesia cloroformica, e anche lultima figlia Beatrice nel 1857. Lanestesia
la Reine divenne di moda, per chi poteva permetterselo. (A Cavarzere arriv nel 1946, con
protossido dazoto). Il cloroformio veniva somministrato goccia a goccia versandolo su una
maschera, di F. von Esmark (18231908, coperta da un telino: il paziente si addormentava a poco
a poco, con vari gradi di approfondimento; il terzo grado era ladatto per lintervento. Ma attenzione
a non arrivare al quarto: ne seguiva midriasi e morte.
Per un certo periodo si pratic con relativo successo lipnosi, come metodo anestetico. Liebeault
pubblic nel 1884 un trattato sulla suggestione. Charcot e Babinsky lusarono in psichiatria. Dopo
i primi entusiasmi and in disuso.
96
Dopo la scoperta della morfina (1806) e della cocaina (1855) e della siringa (1866), venne praticata
la cosiddetta anestesia locale. Gi consigliata da C. Bernard nel 1869, venne usata per prima la
morfina a Calcutta nel 1881 da Crombil. La cocaina fu usata nel 1884, sostituita nel 1905 dalla
novocaina (Einhorn, Braum). Molti tipi di anestesia locale vennero proposti e ancora in uso:
anestesia di blocco (Holsted 1885), la tronculare (Reclus 1885), e la splancnica. Lanestesia
lombare fu introdotta da Bier nel 1899.
La radiologia
G. C Roentgen (18451923) nel 1895 comunic in una seduta della Societ fisicomedica di
Wuerzburg la sua osservazione: i raggi, invisibili, emanati da unampolla vuota daria attraversata
da corrente ad alta tensione, potevano attraversare corpi opachi, riprodurre limmagine su uno
schermo fluorescente e sensibilizzare una lastra fotografica. Quei raggi non potevano essere raggi
catodici, ma unaltra specie di raggi prodotti da quelli catodici contro la parete dellampolla: li
chiam raggi X, appunto perch non ne conosceva la natura. Continu a studiarli: quanto erano
penetranti? Cosa poteva fermarli? Solo il piombo li arrestava. In una scatoletta di legno mise dei
pezzi di metallo: i raggi attraversavano la scatola, ma non i metalli, e la loro ombra appariva su uno
schermo fluorescente. Interpose la sua mano tra il tubo radiante e lo schermo: cosa incredibile:
appariva lo scheletro della mano, ma non le parti molli. Confida la scoperta alla moglie. Frau Bertha
acconsente a farsi radiografare la mano: limmagine dello scheletro della mano sinistra con lanello
fece il giro del mondo. Era nata la Radiologia. Il 28 dicembre dello stesso 1895 present alla
Societ la sua opera Eine neue Art von Strahlen. Invi la copia delle radiografie ai maggiori circoli
scientifici. Per caso una ne arriv al redattore della Die Presse che il giorno dopo ne dava notizia
come di una scoperta sensazionale. La notizia fu ripresa da tutti i giornali.. Anche il Corriere della
Sera (dopo una settimana) scriveva: Una meravigliosa scoperta nella fotografia fatta dal Prof.
Roentzer (sic!).
Nel mondo medico la scoperta fatic alquanto a trovare la sua giusta applicazione. Se ne
impadronirono subito gli operatori in campo fotografico. Ne seguirono dicerie e paure: addiritura
di poter essere spiati con occhi misteriosi nella propria intimit. La scoperta per fu giustamente
messa a profitto della medicina e divenne una delle maggiori armi diagnostiche. Da essa derivarono
tutte le innovazioni metodiche e le ultime scoperte in campo di diagnosi per immagini.
Guglielmo II confer al grande fisico il nobiliare von, e nel 1901 Roentgen ottenne il Premio
Nobel. Uomo semplice e riservato come sempre, nel ricevere il premio sussurr semplicemente:
Dankeshn (Grazie mille). Non brevett la scoperta mettendola al servizio dellumanit e don
met delle 10.000 corone allUniversit di Wrzburg.
Nel 1898 i coniugi Curie (Pierre 18691909 Marie 18671934) isolarono il radio e 15 anni p
tardi scoprirono la radioattivit artificiale, premessa per luso degli isotopi radioattivi in terapia.
La chemioterapia
Il nuovo secolo segna la data della nascita di nuovi indirizzi terapeutici. Si abbandona lantico
contraria contrariis della medicina umorale e si afferma la chemioterapia e la immunizzazione. Ci
fu il frutto della scoperta degli agenti microbici come causa di malattia. Si vuole da una parte
disinfettare il sangue, il mezzo biologico, dallaltra creare una difesa naturale contro lazione dei
microbi e delle loro tossine: immunizzazione attiva = vaccinazione; immunizzazione passiva =
sieroterapia.
97
E. Behring (18541917) osserv lazione patogena dei filtrati batterici, in realt delle tossine
antibatteriche, cio degli anticorpi, antitossine: lazione battericida del siero che le contiene. Con
lesperimento dimostr lefficacia contro la difterite da parte del siero proveniente da animali
preventivamente immunizzati da tossine antidifteriche. Nasceva il siero antidifterico con il quale
furono curati i primi bambini il 28 dicembre 1890. Era il siero di Behring, limmunit passiva. .
. Ugualmente attiva la immunizzazione antipestosa, pasteurella pestis (A. Yersin 1863-1939
Calmette 1895) e quella antitetanica (Tizzoni).
Nasce la Farmacologia sperimentale e il concetto del lavoro di gruppo e ci per il contributo da
parte di C. Bernard. Vengono scoperte nuove sostanze: la curarina, la fenacetina, il cloralio, il
piramidone, il veronal, il digalen, littiolo, lefedrina, la pilocarpina, la vaselina, lantipirina, gli
estratti opoterapici: la epinefrina.
La chemioterapia ebbe impulso specialmente da P. Ehrlich (18541915). Si era scoperto che
alcune sostanze chimiche avevano una specificit elettiva verso taluni microbi. E il concetto dei
proiettili magici capaci di colpire i microbi direttamente nel sangue, allinterno delle cellule
dellorganismo. Dopo vari esperimenti fu pronto nel 1907 il famoso preparato 606, il Salvarsan, a
base di arsenico per il trattamento della sifilide. Dimostratosi troppo tossico fu modificato in Neo
Salvarsan, pi attivo e meno tossico. La chemioterapia produsse poi altri preparati a base di
mercurio, bismuto, antimonio, iodio e di coloranti: tripanblu, tripanrosso.
Lapplicazione del principio chemioterapico condusse nel 1935 alla scoperta dei sulfamidici da
parte di G. Domagk (1895-1964). Era la prima vittoria contro le malattie infettive.
Il pneumotorace
Carlo Forlanini (18471918), dopo numerosi e seri studi teorici sulla base delle recenti scoperte
(Koch aveva isolato il bacillo solo quattro mesi prima), comunic lesito delle sue ricerche nel
1882, ma fu solo nel 1888 che, ingegnoso meccanico oltre che perfetto conoscitore dei fenomeni
fisiopatologici della tisi cavernosa, pratic la prima volta il suo pneumotorace artificiale
monolaterale. Si trattava di iniettare aria, in seguito anidride carbonica, nel cavo pleurico in modo
da collassare il polmone che cos veniva messo a riposo, e facilitava la guarigione delle caverne,
dove restavano tuttavia sepolti i bacilli. Il metodo ebbe universale successo e venne riconosciuto
come lunico sussidio terapeutico solo nel 1918 al Congresso di Roma.
Rimase lunico presidio cui affidarsi fino allavvento della streptomicina. Io stesso ho pi volte
eseguito loperazione con lapparecchio appunto di Forlanini.
La paleoanatomia
Ch. Darwin (18091882) dal 1831 al1836 visit le Isole del Capo verde, il Sud America, le
Galapagos, Tahiti, la Nuova Zelanda, lAustralia, le Isole Mauritius e il Sud Africa. Raccolse le sue
osservazioni nel Giornale delle ricerche sulla geologia e sulla Storia Naturale in varie Regioni,
pubblicato nel 1839. Sinteress specialmente sulle relazioni esistenti tra le attuali specie viventi e i
fossili ritrovati nei paesi visitati, specialmente nelle Galapagos e in Sud America. Pens che le
differenze riscontrate fossero dipese dalla differenza di ambiente e dalle condizioni di vita nel loro
sviluppo. La sua teoria della selezione naturale la pubblic nel 1837. Contro lipotesi di Malthus
che poneva laccento sulla disponibilit delle risorse per lo sviluppo delle singole specie, Darwin
sostenne che doveva essere la selettivit delle singole specie a determinare la loro possibilit di
perpetuarsi. In altre parole, sopravvivono solo quelle forme di vita che sono meglio in grado di
adattarsi, con mutamenti, alle condizioni dellambiente. Ci avviene attraverso mutazioni
genetiche che permangono nel patrimonio della specie stessa e si trasmettono in generazioni
98
successive. Questa la teoria che Darwin espose nel suo famoso libro del 1859 Sulle origini della
specie. Il libro fu una bomba: and esaurito il primo giorno della pubblicazione.
LInghilterra vittoriana e tutta lEuropa cristiana non potevano sostenere lipotesi che quello che il
Creatore aveva compiuto in sei giorni la Natura lavesse compiuto in milioni di anni. E se ne trasse
loccasione per sostenere che luomo allora deriva dalla scimmia. Lo scandalo non poteva essere
sopportato. Per altro Darwin stesso confermava nel 1871 lipotesi con il suo libro Le origini
delluomo. La Chiesa insorse decisamente: erano teorie in netto contrasto con la Bibbia e la
tradizione: degradanti per la dignit delluomo. - Aberrazioni ripugnanti alla storia, alle scienze -,
aveva scritto Pio IX. Il pensiero di Darwin fu un altro colpo inferto alla credenza letterale della
Bibbia. In seguito prevarr il concetto di reinterpretare le parole bibliche alla luce delle scoperte
scientifiche.
Teilhard de Chardin (1881-1955) ader alla teoria dellevoluzione prevedendo come suo punto
massimo il punto Omega, Dio, oltre luomo. Ora levoluzionismo cristiano accettato dalla Chiesa,
senza tuttavia rinunciare alla certezza dellesistenza di una entit metafisica, trascendente e
salvifica.
Con Darwin e la sua teoria prendeva maggior impulso la Paleoanatomia, scienza fondamentale
per la conoscenza dello sviluppo dellevoluzione del processo vitale dei vertebrati.
La chirurgia e le specialit chirurgiche
La branca chirurgica che maggiormente ebbe impulso sia nella teoria che nella pratica fu quella
addominale. Nel 1881 si ebbe la prima gastrectomia per cancro dello stomaco eseguita da
Th. Billroth (18291894) che esegu inoltre la laringectomia totale (1873), la resezione
dellesofago (1872) e la resezione del piloro (1881). Mikulicz tent la cura della perforazione
dellulcera, completata da Eiselsberg (18091847). Di fondamentale importanza fu la soluzione
pratica della peritiflite stercorale, linfiammazione dellintestino cieco con sua rottura e morte
conseguente, come descritta da Rokitanski. Lindividuazione del quadro morboso si ebbe con le
due monografie, rispettivamente del 1886 e 1888, del chirurgo americano Reginald Fitz. A
Sonnemburg e a Kummel si ebbe la constatazione che la peritiflite stercorale era in realt la
conseguenza di una appendicite acuta perforata con peritonite conseguente.
Locclusione intestinale, dovuta a strozzamento o invaginazione, fu curata con la laparotomia e lo
scioglimento dei nodi delle anse. A.Nelaton (1807-1873 sostenne invece la tecnica della
enterostomia. Fu medico di Napoleone III, inventore delle classiche sonde uretrali che portano il
suo nome. Applic una sonda di gomma flessibile ad una sonda rigida per ferite per la ricerca della
pallottola che fer Garibaldi ad Aspromonte.
Maisonneuve (18091887) ebbe la prima idea della entro-enteroanastomosi. La resezione
segmentaria dellintestino per cancro del colon pelvico fu eseguita da Reybard (17901863).
Unimportante novit nel trattamento dellernia inguinale e crurale fu quella apportata dal nostro
E. Bassini (18471924) col metodo che ancor oggi porta il suo nome e universalmente eseguito fino
a pochi anni fa, quando si iniziarono nuovi metodi pi semplici per tecnica e meno soggetti a
recidive. Un altro italiano ide un metodo originale per il trattamento dellernia crurarle, il Ruggi.
Nel fegato fu eseguito lintervento per lasportazione delle cisti da echinococco e inciso lascesso
epatico da P. F. Segond. Bobs e Kning (1882) eseguirono la colecistostomia. Langenbuch esegu
la prima colecistectomia (1882). La prima splenectomia fu eseguita da E. Pan (18301898) nel
1867 e da Cred nel 1881. La prima sutura sul cuore fu eseguita nel 1896 da L. Rehn e nello stesso
anno da Farina ed altri italiani. Da ricordare il celebre intervento di F.Trendelemburg (18441924)
di embolectomia sullarteria polmonare (1908).
99
Da ricordare F. Guyon fondatore della moderna urologia. Paget (18141899) che leg il suo
nome allartrite deformante. Koeberle (18281913) che nel 1863 esegu la prima isterectomia per
fibroma. Tito Vanzetti (1809 1888), professore a Padova, esegu la prima ovariectomia (1848).
Tommaso Rima (17751843), come Trendelemburg, studi la fisiopatologia delle varici e la
tecnica operatoria.
Nel campo dellOrtopedia sono da menzionare linvenzione della fasciatura rigida mediante colla
(Vanzetti 1846), e mediante bende gessate, nel 1852, da Mathijssen (18051878). E linvenzione
della tecnica chirurgica dellamputazione cinematica nel 1898, del medico condotto Giuliano
Vanghetti, e resa nota nel 1915 dal Sauerbruch: i tendini dei muscoli estensori e flessori vengono
rinchiusi in due sezioni del moncone allo scopo di servire poi per lazionamento della protesi.
Da ricordare i nostri V. Putti e Alessandro Codevilla (18611912) e Agostino Paci (18461902).
Ostetricia e ginecologia
Lostetricia nell800 fece un vero balzo in avanti e conquist vera dignit di materia a s stante in
campo universitario: nascono nuove cattedre, dopo la prima di Bologna fondata da Galli nel 1757.
Nel 1821 fu applicata anche allostetricia la pratica dellauscultazione: il battito fetale si poteva
ascoltare attraverso laddome materno e lo si poteva studiare: ritmo, frequenza, intensit e da esso
arguire la salute e il benessere fetale. Lo sviluppo delluovo fecondato, la respirazione, e la
circolazione fetale furono studiati da Zweifel (18481927). Vennero presi in considerazione i
rapporti biologici tra madre e feto e la genesi dei cosiddetti fenomeni simpatici, nausea, vomito
delle prime settimane, e gli effetti della intossicazione gravidica. Si eseguirono le prime reazioni di
gravidanza (Aschheim Zondek): iniettando urine di gravida nelle rane si provocano reazioni sulle
loro ovaie, segno che nelle urine delle donne gravide esistono delle sostanze specifiche dello stato
gravidico. Lindagine diagnostica di laboratorio facilita la diagnosi di gravidanza. La radiologia
aiut a studiare lapparato scheletrico del bacino e la posizione del feto. Fu perfino proposta la
isterosalpingografia (Beclre 1925) e dal Gauss, nel 1928, la isteroscopia.
Pasteur scoperse gli agenti della febbre puerperale, stafilococco, streptococco, e escherichia coli.
Fervono gli studi sulla sifilide maternofetale: un bambino nato con manifestazioni sifilitiche non
contagia mai la madre; una madre con manifestazioni sifilitiche non contagia il proprio bambino
(Leggi di Colles e di Profeta). Cred attua la profilassi della blenorragia fetale con la classica
goccia di nitrato dargento nella congiuntiva dei neonati (1884), tuttora praticata. F. Hitschmann
(18701926) studia il ciclo della mucosa uterina e rinnova il concetto delle endometriti. Da
ricordare gli studi sul bacino viziato, ristretto, cui contribu tra i primi G. Michaelis (17981848) e
tra gli altri Kilian, Breisky e Naegele (17781851). E gli studi sul rivolgimento esterno di Wiegand
(1807).
Importante lapporto sullanatomia patologica e la clinica di F.von Shauta (18491919), del quale
porta il nome lintervento di isterectomia vaginale totale per cancro della portio.
Continua luso della sinfisiotomia. Nel 1902 fu proposta da L. Gigli (18631909) la pubiotomia,
mediante la sua celebre sega a filo, invece della sinfisiotomia. Anche gli interventi per gravidanza
tubarica furono perfezionati (Rob. Lawson Tait 18451899). Nel 1850 Cred propose la sua
spremitura della placenta, tuttora eseguita, e la restaurazione delle lesioni da parto: fistole vescico
vaginali. O. Pankow (18761934) studi la placenta previa. Nacque lo speculum di G. M. Sims
(18131883) e di C. A. Rcamier (17741856). E il forcipe di Stefano Tarnier (18281897) traente
sullasse, tra ben 144 variet.
Lovariectomia vide ridurre drasticamente la sua mortalit operatoria specialmente ad opera del
gi citato Lawson Tait di Birminghan. Ugualmente si distinse G. Pan (18301898), e P. C.
Huguier (18041873) port il suo contributo nelloperazione delle cisti ovariche, nellisterometria
100
e nellamputazione del collo uterino. Lasportazione della vagina e la sua ricostruzione fu eseguita
nel 1895 da A. C. Mackenrodt. E listerectomia addominale nellultimo quarto del secolo XIX da
A. Hegar (18301914).
Furono descritte nuove affezioni: ladenomioma da Th Cullen nel 1908 e il cistoma papillare nel
1891 da W. Williams. E. Pestalozza (18601935) descrisse il corionepitelioma. Ottimo operatore fu
L. Doyen (1851916).
Loperazione cesarea, alquanto in disuso per la frequenza delle sinfisiotomie, embriotomie e
applicazione di forcipe, non decadde mai del tutto. Fu ripresa nel 1876 ad opera di E. Porro (1842
1902) con la tecnica dellamputazione uteroovarica, taglio cesareo demolitore. Nel 1882, Kehrer e
M. Saenger indicarono la sutura dellutero e proposero il taglio cesareo conservatore.
Il taglio cesareo vaginale fu eseguito da L. Acconci nel 1895 in un caso di gravidanza complicato
da metrocarcinoma.
La ginecologia e la ostetricia si avviano a mete sempre pi alte e di grande rilievo tecnico
scientifico. Il balzo di 150 anni fu enorme se si pensa che la febbre puerperale, prima di
Semmelweis, poteva essere imputata anche al profumo di alcuni fiori.
Nel campo della Urologia l 800 vide realizzata la possibilit di vedere direttamente allinterno
della vescica: venne inventato il cistocopio. Dopo gli studi di F. Bozzini (17731809), fu
presentato nel 1806 un primo tipo di strumento, lanterna magica, per rifiutato. A. G. Desormeaux
(18441894) nel 1865 pubblic un trattato e coni i termini di endoscopia e endoscopio.
Finalmente Maz Nitze (1848-1907), dopo linvenzione di Edison delle lampade elettriche, pot
costruire uno strumento efficiente (1886), adatto a studiare dallinterno la cavit vescicale.
Il secondo passo in avanti fu la possibilit di esaminare separatamente le urine dei due reni, per
poter determinare quale dei due fosse il responsabile della insufficienza renale. Ci si ottenne con
il cateterismo separato degli ureteri e il prelievo delle rispettive urine da esaminare. Nel 1902 si
inizi (Strauss) a calcolare la azotemia, lazoto residuo nel sangue, utile alla determinazione della
funzionalit renale. Nel 1906 Vlker indic il metodo della cromocistoscopia. E Volhard (1910)
introdusse le prove di concentrazione e diluizione delle urine utili a determinare la funzionalit
renale. Altri fondamentali esami furono offerti dalla Radiologia con o senza contrasto.
Negli ultimi anni dell800 fu possibile lestirpazione della prostata, per via perineale o
transvescicale, nei casi di ipertrofia. A. Mercier (18111882) fu linventore dei famosi cateteri
(1836) a piccola curva. Tra gli inventori di cateteri vanno menzionati Nlaton (1807-1873) dei
cateteri di gomma (1860) e Charrire per i calibri differenziali in serie. Nel 1870 Gustavo Simon
(18241876) pratic la prima nefrectomia. Nel 1881 Hann esegu la nefropessia, e ugualmente il
nostro Bassini, nel 1882, con un suo metodo originale. Il maggior impulso allurologia si svolse in
Francia ad opera soprattutto di C. F. Guyon (18311920).
Nel campo della Otorinolaringologia importante ricordare la teoria di E. Helmholtz (1821
1895) che, ricordando quella di Mller, considera lorgano di Corti come un sistema di risuonatori,
ciascuno dei quali vibra in maniera propria. Da ricordare lintubazione laringotracheale e
lintervento di tracheostomia di Trousseau. Da segnalare P. Menire (17991862) e la sua sindrome
vertiginosa, e tra gli italiani G. Gradenigo (18591926). Linsegnamento universitario fu istituito in
Italia nel 1880.
Nel campo dellOculistica, F. C. Donders (18181889) perfezion loftalmoscopio, a specchio
con foro centrale, e studi i vizi di rifrazione e di accomodazione, sinteress di ipermetropia,
miopia, e di presbiopia. A. von Graefe (18281870) studi la papilla da stasi quale segno di
tumore cerebrale, e utilizz liridectomia quale trattamento del glaucoma (1857). Il distacco della
retina fu studiato da G. Gonin (1870 1935). Nellambito del concetto che le malattie dellocchio
sono spesso espressione di malattie sistemiche o di altri organi, fu studiata la cataratta diabetica
(Leber) e la retinite diabetica (E. Drury Noyes). Entra nelluso il nitrato dargento per la
congiuntivite purulenta. La congiuntivite acuta fu ritenuta causata dallagente microbico scoperto
da Koch (1883).
101
MEDICINA MILITARE. LA CROCE ROSSA E LA CONFERENZA DI GINEVRA
Gi nel secolo precedente si era venuta costituendo una rudimentale organizzazione sanitaria
bellica. Fu merito specialmente di Domenico Larrey (17661842) e di P.Francesco Percy (1754
1825) laver cooperato allorganizzazione della medicina militare. Vennero istituiti gli ospedali
ambulanti atti a seguire le truppe in movimento e le unit sanitarie mobili per portare soccorso ai
feriti. Nuovi veicoli vennero costruiti per il trasporto di materiali di soccorso sul fronte di battaglia.
Percy presenta a Napoleone il progetto Chirurgia delle battaglie, con la costituzione di un corpo
permanente di chirurghi. A Larrey si deve la costituzione degli Hpitaux roulants, ambulanze
volanti. Importante la costituzione delle infermiere volontarie da parte di Florance Nightingale
(18231910).
Ferdinando Palasciano (18151891), in un discorso allAccademia Pontaniana di Napoli il 24
aprile 1861, aveva sostenuto il principio della inviolabilit dei feriti di guerra, e il 10 giugno
1861 veniva pubblicata a Parigi una lettera aperta al Ministro della Guerra dove veniva sostenuto il
suo principio. Allindomani della sanguinosa battaglia di Solferino (giugno 1859, tra Napoleone III
e Francesco Giuseppe), Henry Durant (18281910), cittadino svizzero, soccorse i feriti delle
armate avversarie con la stessa compassione fraterna, nelle tristissime condizioni rimasti sul
campo. Lanno seguente raccont la sua esperienza nel celebre libro Souvenir di Solferino, dove
ricorda che le donne, vedendo chio non ho nessuna distinzione di nazionalit, seguono il mio
esempio e testimoniano la stessa benevolenza.
Nellottobre 1863 una Conferenza internazionale di undici Stati convocata a Ginevra, dichiara
allunanimit neutrali le ambulanze, gli ospedali e il personale sanitario.
Allo scoppio della guerra di Crimea (1854) la gi citata infermiera tedesca Florence Nightingale si
rec con un corpo di volontarie: 38 infermiere, 14 professioniste, 10 suore, allospedale militare di
Scutari, un agglomerato di sporche e antigieniche baracche. Lopera innovatrice delle infemiere fu
subito malvista e ostacolata dai militari, che la giudicavano nociva alla disciplina dei sodati e alla
guarigione dei malati. Ma dopo la battaglia di Balaclava, per laltissimo numero di feriti, la loro
opera divenne indispensabile e altamente meritoria, e finalmente riconosciuta. La Signora della
lampada e le sue coraggiose compagne ridussero la mortalit dal 42% al 2%. Divenuta eroina
nazionale si ritir nella sua campagna, dove, con la sovvenzione raccolta da una pubblica
sottoscrizione, fond la prima scuola per infermiere (1859).
Nel 1864 si ebbe la Prima Convenzione di Ginevra per il miglioramento della condizione del
ferito degli eserciti sul campo di battaglia; fu assunto come emblema la Croce Rossa in campo
bianco: inter arma caritas. E a Milano nello stesso anno fu costituita la Croce Rossa Italiana. Il
corpo delle Crocerossine fu fondato nel 1904. La Croce Rossa Internazionale fu costituita allAia
nel 1928 .
Nellambito del Diritto Internazionale Umanitario, fu convocata nel 1949 la Quarta Convenzione
di Ginevra sul trattamento in guerra dei feriti, sotto la tutela della Croce Rossa Internazionale. Nel
1965 vennero proclamati i Sette Principi: umanit, imparzialit, neutralit, indipendenza, servizio
volontario, unit, universalit. E nel 1977 i Protocolli aggiuntivi per la protezione di tutte le vittime
di guerra e anche della popolazione civile, disastri e calamit naturali.
IL MEDICO CONDOTTO
Si pu farlo risalire XII sec. In Firenze vi furono medici stipendiati dal Comune, generici o
chirurghi delle ossa, ferite---A Bologna si ricorda tale Borgognoni, 1214. Anche a Reggio ce ne
furono. Il Medico era condotto, reclutato da altri paesi.
Nel 1923 venne assicurata la presenza del medico, detto condotto, per curare i poveri
gratutitamente, compresi nell elenco dei poveri. Listituzione fu soppressa nel 1978 con la nascita
delle ASL (Aziende Sanitarie Locali).
102
IL GRANDE PROGRESSO DELLA MEDICINA NEL NOVECENTO
La Medicina nelle due guerre mondiali
Dopo il Secolo dei Lumi, dopo il periodo della Ragione e dei fatti come unica fonte di verit,
si arriva nel XX secolo alla valorizzazione dellAzione: alla valutazione delle attivit umane in
relazione alla loro utilit, al pragmatismo. Della realt si studia solo il fenomeno, unico aspetto della
realt globale che sia suscettibile di studio e di conoscenza: il fenomenismo. Scienza e tecnica
iniziano un rapido sviluppo lungo una linea ascendente mai vista. Ci sono tutte le premesse: lo
scambio dinformazioni diventa sempre pi rapido e intenso, si inizia il lavoro di gruppo, in quipe.
La lingua inglese diventa lesperanto scientifico. La ricerca programmata e finalizzata. Anche le
guerre ebbero il loro merito. Gli eserciti devono essere sani e i mezzi di offesa sempre pi sofisticati
e letali. Le difese proporzionate: si incrementa la chimica, la fisica, la biologia e quindi la medicina.
Mentre si gareggia nel trovare larma pi micidiale, per paradosso si cercano anche le armi pi
efficaci per guarire, per rimediare alle ferite, per rimettere il soldato in linea, o per renderlo pi
resistente, pi aggressivo. Aumentano le fonti di energia, il motore a scoppio, lelettricit, ma anche
lenergia nucleare verr ipotizzata, studiata, realizzata e impiegata.
La filosofia entra in crisi: sposta gradualmente il fine della sua ricerca fino a confondersi con la
scienza: lo scientismo. E comunque sviluppa la critica di se stessa, della stessa scienza. Nasce
lepistemologia. La societ si laicizza sempre pi: sono in crisi i valori assoluti. Il valore
immediatamente percettibile lutile, hic et nunc. Lutile relativo allindividuo, al gruppo, al clan,
alla razza, alla religione, alla nazione, al gruppo di nazioni. Non in nome di valori, assoluti, eterni,
ma in vista dellutilit individuale o di appartenenza. Si invoca il Villaggio globale (Mac Luan), ma
lO.N.U si rivela incapace di prefigurare un Governo universale. La ricerca dellutile individuale ha
spinto la scienza, la medicina, verso frontiere oltre le quali non si intravede la certezza di utilit
generale. Il futuribile ipotizza realt talora inaccettabili o quantomeno problematiche. Si rende
necessaria unEtica della scienza: della medicina, della biologia: la Bioetica.
Il pragmatismo di W. James, che come Protagora ritiene luomo misura di tutte le cose, sostiene
il concetto dellutilit, perfino della religione se produce questo frutto. La filosofia della crisi
iniziata di Kierkegaard riceve nuovo impulso con lesistenzialismo, con lanalisi dellangoscia.
Heidegger (18891976) postula langoscia come stato liberatore della paura della morte che rende
luomo capace di costruire il proprio futuro. K Jaspers (18831969) riscopre il trascendente come
meta dellesistenza. Riconosce i limiti e limpossibilit di raggiungerlo, ma ne soffre la mancanza.
Per J. P. Sartre, tra lEssere \ NonEssere, il Nulla, esiste solo la propria individualit: il suo
nichilismo esaspera quello di Nietzshe. Abbagnano (19011990) cerca di conciliare
lesistenzialismo con il pragmatismo: esistenzialismo positivo, superando il nichilismo sartriano.
La Ragione e la Scienza rendono possibile lesistenza.
La Economia assume dignit di scienza con le sue leggi che determinano in buona parte i destini
dello sviluppo socioeconomico. Da A. Smith (17231790) che teorizza leconomia di mercato,
attraverso il liberismo di Ricardo (17721823) a Stuart Mill (18061873) con la teoria del valore, le
leggi della produzione e della distribuzione del reddito, si arriva a Carlo Marx (18181883) che
dallo studio del Capitale e delle leggi che lo regolano, e dallo studio della realt operaia nellera
della industrializzazione, arriva alla lotta di classe che alla fine si dovr risolvere nella vittoria della
classe operaia, lunit di tutti i proletari, che conquister il potere. Il Potere esercitato dalla dittatura
del proletariato assumer nello Stato tutti i mezzi di produzione realizzando la giusta distribuzione
dei profitti in una societ senza classi. A ci contribuir la crisi del capitale che, per le sue stesse
contraddizioni interne, croller con laiuto della rivoluzione proletaria.
Con J. M. Keynes (18831946) si fissa lattenzione sui livelli di reddito nazionale,
sulloccupazione nellindustria, sulle cause delle fluttuazioni economiche e soprattutto
103
sullimportanza degli investimenti con moltiplicazione del reddito: sulla ricchezza quindi. Si crea il
circolo virtuoso: redditiinvestimentiricchezzainvestimenti. Per regolare il processo
economico necessario, per, un prudente e illuminato intervento dello Stato per la
programmazione e lequilibrio della distribuzione dei redditi \ ricchezza, tale da evitare scontri
sociali, fonti di recessione con scarso reddito: scarso investimentoscarso reddito=minor ricchezza.
Nel campo della Scienza dominano le grandi teorie rivoluzionarie: la teoria della relativit di
Einstein (E = m c
2
- 1907) e la formulazione della Meccanica quantistica di Plank. La teoria di
Einstein mette in discussione il concetto della simultaneit di due eventi. La teoria dei quanta
indusse Heisenberg a postulare il suo principio di indeterminazione: non possibile la
contemporanea conoscenza esatta della posizione e della velocit delle particelle che compongono
la materia. Le leggi che regolano la Natura sono di ordine probabilistico, statistico (casuale?).
La ricerca scientifica tuttavia si sviluppa secondo il percorso della ipotesi di lavoro: rilievo del
fatto, sperimentazione rigorosa, controprova in doppio cieco, con lausilio della statistica che,
integrata dalla matematica e dallaiuto del computer, diventa componente essenziale nella ricerca
scientifica, medica e biologica.
Accanto alla scienza che progredisce col suo rigore allo studio delle leggi che regolano i fenomeni
della realt, affioreranno gli insopprimibili, atavici istinti che cercano lirrazionale, il
soprannaturale, il miracolistico. Accanto alla medicina ufficiale, convivranno, anzi prospereranno le
cosiddette medicine alternative. Lomeopatia, lerboristeria, la pranoterapia, lagopuntura e altre
pratiche terapeutiche basate su ipotesi filosofiche, di visione simbolistica del mondo reale.
Gli enzimi e le vitamine
Nel grande campo della fisiologia, dallinizio del secolo XX si afferma sempre pi la Biochimica,
oltre che lapplicazione delle scoperte in tutte le scienze, prima tra le quali la Fisica, quella
dellatomo e delle radiazioni in particolare. Otto Warburg (18831970) medico, soldato allinizio
delle ostilit della Prima guerra mondiale, nota che i sali di ferro aumentano lassorbimento di
ossigeno da parte di una poltiglia di uova di riccio di mare. Devono esistere delle sostanze che
facilitano la ossigenazione. Esiste una ossigenazione per sottrazione di idrogeno, per
deidrogenazione. Le reazioni ossigenazione \ riduzione didrogeno = ossi-riduzione sono alla base
della respirazione respirazione cellulare. Lossidazione per deidrogenazione non pu avvenire se
mancano delle proteine che la inducono: queste proteine sono dei fermenti cio degli enzimi, le
deidrogenasi, che, a loro volta possiedono delle co-deidrogenasi. Il primo fermento, enzima, che
facilita la respirazione cellulare, il fermento - appunto - respiratorio, fu scoperto nel 1926 da
Warburg e chiamato ferrossigenasi: Fermento respiratorio, Atmungsferment, Fermento giallo.
Esistono legami tra gli enzimi e le vitamine, come vedremo. Nel co-enzima del fermento giallo
entra la riboflavina, che altro non che la Vitamina B 2 (1935). Gli enzimi gialli sono detti
flavoproteine. Il fermento respiratorio, citocromossidasi, ha una struttura complessa, simile a
quella dellemoglobina, contenente ferro nella molecola.
A Warburg , Premio Nobel per questi studi nel 1921, verr concesso un secondo Nobel nel 1944
per le sue ricerche sul cancro.
Hans Adolf Krebs (19001981), allievo di Warburg, studia gli stadi intermedi dellossidazione
dei carboidrati nel tessuto muscolare. Nel 1937 scopre il famoso ciclo dellacido citrico che porta
il suo nome: il meccanismo della fonte di energia nella biologia dei mammiferi. Nel 1957 scopre il
ciclo dellacido gliossilico. Nei reni e nel fegato evidenzia la D-Amino-acidossidasi, la glutamina,
la ipoxantina, e la fissazione del CO2 nei tessuti animali, attraverso la sintesi dellacido
ossalacetico.
104
Principali scoperte di Biochimica
-Equazione tampone, Acido-base di HendersonHasselbach (1908)
-Dissociazione dell Hb, Emoglobina (1914) - Concetto di riserva alcalina (1916)
-Elettroforesi (Tiselius, 1930)
Nel 1924 T. Svedberg (1884-1971) assieme a Rinde d il nome al nuovo strumento,
lUltracentrifuga, con il quale si riesce a produrre dei campi centrifughi che arrivano ad un milione
di volte la forza di gravit (g). Col nuovo strumento si riesce a dividere le lipoproteine in tre
classi: a bassissima densit VLDL, a bassa densit LDL, e ad alta densit, HDL; utili per la
valutazione patogenetica dellaterosclerosi: alte le proteine LDL.
Vitamine
Allinizio del secolo si era persuasi che i componenti essenziali della dieta fossero le proteine, gli
zuccheri, i grassi, lacqua e i sali minerali. Abbiamo visto, per, che si sapeva che il succo di
limone, pi di quello del limoncello, era capace di prevenire lo scorbuto, sia di mare che di terra, e
che il beri beri insorgeva nelle popolazioni che si nutrivano di riso brillato, privo della pula. Si
poteva dedurre che negli alimenti esistevano delle sostanze, capaci di prevenire delle malattie, che
dovevano esserci nella dieta, altrimenti si produceva la malattia: sostanze essenziali alla salute.
Le prime esperienze sono state eseguite da F. G. Hopkins (18611947) tra il 1906 e il 1912. Egli
vide che i ratti alimentati con latte artificiale non crescevano normalmente; la crescita invece
diventava normale con la semplice aggiunta di latte, anche in minime quantit. Hopkins ne dedusse
che nessun animale poteva vivere se, oltre agli alimenti gi citati, non fosse presente nella dieta un
quid, una sostanza aggiuntiva, accessoria la chiam. Gli studiosi, allora, andarono alla ricerca
delle sostanze accessorie capaci di assicurare vita normale agli organismi animali.
Nel 1913 E. V. McCollum (1879-1967), un chimico americano, vide che i ratti alimentati con dieta
artificiale si ammalavano di cheratomalacia, e che questo si poteva evitare aggiungendo alla dieta
del burro. Ci doveva, quindi, essere una sostanza solubile nei grassi, liposolubile, capace di
prevenire quella malattia. Nel 1915 scopre la prima delle sostanze ricercate, il fattore A.
Nel 1920 Rosenhein e Drummond identificarono il fattore A con il carotene, sostanza presente
nei vegetali, specie nelle carote. C Funk (1884 - ) nel 1911, credendo che le sostanze essenziali
alla vita, fossero chimicamente delle amine, coni il nome di Vitamina, amina capace di
assicurare la vita ad ogni sostanza essenziale. Il nome fu fortunato, resiste tuttora, anche se si
seppe presto che le varie sostanze essenziali via via scoperte, non erano chimicamente delle amine.
Sempre McCollum chiam il fattore che impediva linsorgenza della polinevrite, Vitamina B.
Nel 1926 la vitamina B viene identificata come Complesso B, e se ne distinse la Vitamina B1,
termolabile e la Vitamina B2, termostabile. Nel 1922 si vide che anche la vitamina A era in realt di
due principi essenziali: quello antixeroftalmico, cui venne conservato il nome di Vitamina A, e un
altro, che aveva attivit antirachitica, al quale, progredendo nellalfabeto, venne dato il nome di
Vitamina D.
Un passo in dietro per la Vitamina C. Dopo gli studi e i suggerimenti del chirurgo militare Lind
(1746) e le successive osservazioni di Capitan Cook, il Parlamento inglese (1795) aveva varato una
legge che imponeva ai comandanti di navi di assicurare debita scorta di limoni o limoncelli (Lime),
dimostratisi capaci di impedire lo scorbuto. Intanto si era visto che anche lo scorbuto di terra poteva
essere evitato dal succo di limone: varie epidemie della malattia avevano mietuto vittime fino alla
Prima guerra mondiale: la maggiore epidemia nel 1854 56, nella guerra di Crimea.
Nel fermento degli studi sui principi essenziali, Holst e Frhlich (18711953) erano riusciti nel
1907 a riprodurre lo scorbuto sottoponendo le cavie a dieta senza succo di limone. Ma dovettero
105
attendere il 1920 per scoprire che il fattore antiscorbutico era presente negli agrumi e nei vegetali
freschi. Quel fattore era la Vitamina C. Nel 1928 A. Szent-Gyrgyi (1893 - ), estraendo la
sostanza dalle surreni, la isol come acido esuronico. Nel 1939 venne adottato definitivamente il
nome di Acido ascorbico per la Vitamina C. E dal 1939, inizio della Seconda guerra mondiale, luso
della Vitamina C venne adottato su scala mondiale. Nel 1920, H McLean (1913 - ) not che alcuni
ratti diventavano sterili se alimentati esclusivamente con latte. K Bishop, nel 1922, dimostr che il
fattore mancante, responsabile della sterilit, era abbondantemente presente nella verdura fresca e
nei germi di grano: era la Vitamina E.
M. L. Goldberger (1922 - ) dimostra che una frazione della vitamina B contiene una sostanza
capace di impedire linsorgenza della pellagra: fattore Pellagra Protettivo, chiamato poi Vitamina
PP, dimostratosi come Acido nicotinico, o Nicotinamide (1937).
Molto importanti nel 1929 le osservazioni di C. P. Dam (18951976, secondo le quali diete povere
di grassi potevano indurre emorragie cutanee ai polli e una diminuzione della coagulabilit del
sangue. Dam chiam questo fattore che diminuiva la coagulazione ( Koagulation) vitamina K, che
Dam stesso, Almquist e Doisy (18931986) dieci anni dopo isolarono in forma pura e distinsero
poi in vitamina K1 e Vitamnia K2 (1942)
Nel 1936 Kgel e Tmis isolarono dal tuorlo duovo la biotina, alla quale diedero il nome di
Vitamina H. Nello stesso anno Szent-Gyrgyi ipotizza lesistenza della Vitamina P (citrina), negli
agrumi, contro la fragilit capillare. Dal 1930 al 1935 avviene la definizione chimica di molte
vitamine: A D C B1 B2. E il riconoscimento dellattivit antianemica dellacido folico (1935),
sintetizzato nel 1940. Nel 1948 il riconoscimento della Vitamina B 12 , sintetizzata nel 1955 come
cianocobalamina (A R Todd, 1907). Nel 1953 H. A.Krebs (19001981) e F. A. Lipman (1889
1986) ottennero il Nobel per le loro ricerche sul Co-Enzima A, legato allacido pantotenico,
Vitamina B 5 .
Dai vari passaggi dallacido pantotenico al Co-Enzima A appare chiaramente lintima unione tra
Enzimi Vitamine e il loro rapporto quali fattori energetici nei processi ossidoriduttivi cellulari.
Acido pantotenico + cisteina + ATP
Fosfopantotenil cisteina CO2
Fosfopanteina + ATP
Defosfo Co Enzima A + ATP
Co Enzima A.
Cervello, psiche e neurotrasmettitori
Seguendo il nostro itinerario lungo lo sviluppo del pensiero medico, dalle origini fino alle
straordinarie scoperte nelle varie branche della scienza medica, abbiamo accennato, in un paragrafo
sullo sviluppo della medicina nel 700, come F. Pinel (17751826) nel suo Trattato medico
filosofico della pazzia (1801) avesse (per altro preceduto dal nostro Ghiarugi (17591820) di otto
anni), intuito e sostenuto che il pazzo, il folle, era tale perch era malato il suo cervello. La causa
della malattia si situa nella struttura anatomica, nella sostanza, nella materia, nelle cellule del suo
cervello. Il folle non un posseduto da forze esterne, un ossesso, un indemoniato. La causa della
sua malattia mentale da ricercarsi nellorganismo, che regola e coordina ogni attivit: dal
movimento degli arti per lazione dei muscoli, dal linguaggio articolato, dalle emozioni al pensiero.
Questa idea che le malattie mentali sono leffetto di alterazioni patologiche della materia
costitutiva del cervello il passo fondamentale lungo quel filo rosso ideale, seguito dal vero
progresso della scienza medica: la struttura anatomica del cervello si deve studiare con il metodo
sperimentale, misurare, indagare al microscopio, verificare la corrispondenza tra malattia e
106
alterazioni della materia cerebrale. Seguendo questo metodo Luigi Rolando (17731831) scopriva
nel lobo frontale larea motrice, che porta il suo nome. Si stabilito che stimolando questarea si
provocano movimenti coordinati nella met opposta del corpo e, al contrario, se viene lesa i
movimenti vengono turbati o aboliti. La zona si estende dal basso verso lalto e governa i muscoli
di vari organi : laringe, lingua, mandibola, bocca, naso, orecchie, palpebre, collo, pollice, mano,
polso
gomito, torace, addome, anca, ginocchio, caviglia, piede, perineo. Ecco spiegato leffetto di una
emorragia cerebrale che distrugga questarea: la paralisi della met opposta del corpo, la
deviazione della lingua, limpossibilit di chiudere locchio e la perdita di feci.
Paul Broca (18291880) scopriva nel 1860 larea del linguaggio articolato che porta il suo nome,
subito sotto larea di Rolando, nel piede della III circonvoluzione frontale sinistra.
Karl Wernicke (18481905) descriveva nella circonvoluzione temporale il centro che porta il suo
nome e che presiede alla memoria acustica delle parole. Dopo di lui, Kussmaul (18221902)
individu il centro della memoria delle parole scritte. La lesione di questi centri, delle loro cellule,
provoca le afasie, le agrafiedisgrafie. Notevoli gli studi di Pierre Marie sulle afasie (1906).
I vari studi sul sistema nervoso: midollo spinale, midollo allungato, cervelletto, mesencefalo,
diencefalo, encefalo, nei quali si sono via via individuati nuclei, centri, aree, con funzione ben
definita, hanno potuto stabilire con precisione quasi matematica, che alla lesionestimolazione di
ogni zona corrisponde un sintomo o una sindrome bene individuata.
Ricordiamo come esempio la Sindrome di BrownSquard (18181894). Essa consiste nella
paralisi motoria e nella perdita della sensibilit termica, dolorifica, (tattile) del lato opposto
dellemisezione del midollo spinale. Tra i vari studiosi della anatomiafisiologia del cervello
impegnati a individuare una precisa area cerebrale competente per ciascuna ben determinata
funzione, da menzionare C.von Economo (Trieste 1876Vienna 1931) che tracci una vera e
propria mappa delle aree cerebrali e delle corrispondenti funzioni. Di fondamentale importanza
sono gli studi di W. G. Penfield. (1891-1976). Egli elabora una sua mappa delle aree funzionali
della corteccia cerebrale precisando e definendo le aree precedentemente descritte e descrivendone
di nuove: larea del controllo della vocalizzazione, aree supplementari della parola, del gusto ecc.
Ma soprattutto dimostra che, stimolando la circonvoluzione temporale superiore destra, il
soggetto pu rivivere, come in playback, esperienze passate come se scorresse un film: immagini,
suoni, sensazioni (1930). Cessando lo stimolo elettrico, il ricordo cessa bruscamente. Ipotizza un
sistema integrativo, capace di unire le funzioni dei due emisferi. Le sue teorie sono esposte nel testo
The citology and cellular Pathology of the nervous System (1932).
Abbiamo gi visto come sia complicata la struttura di un neurone, di una cellula nervosa, come
venne descritta da Golgi e Cajal, con il suo nucleo, i suoi dendriti e le sue fibre. Ricordiamo che si
chiamano sinapsi i punti di raccordo tra una fibra nervosa con il corpo cellulare, tra una fibra e i
dendriti, tra una fibra e unaltra fibra, e di una fibra nervosa con altri elementi cellulari. Si chiama
placca motrice lunione di una fibra nervosa con elementi cellulari muscolari. Si definisce
giunzione neurocellulare la giunzione di cellule nervose con i propri organi recettori: tattile,
dolorifico, termico, del piacere, eccetera.
Non basta per la semplice connessione anatomica tra fibre, dendriti, cellule nervose e altre cellule
per spiegare le delicatissime funzioni cerebrali: sono stati scoperti i trasmettitori chimici, che
trasmettono gli impulsi dalla cellula nervosa, dalle fibre, dalle placche nelle giunzioni e nelle
sinapsi. I primi neurotrasmettitori scoperti furono ladrenalina e lacetilcolina. Dale (18751968)
dimostra nel 1936 che la stimolazione dei nervi cardioacceleratori produce adrenalina e, nel 1937,
sempre Dale dimostra che la sostanza neurotrasmettitore vagale lacetilcolina. Ladrenalina il
mediatore simpatico delle fibre postgangliari, lacetilcolina il mediatore parasimpatico delle
fibre pregangliari; fibre che si dicono rispettivamente adrenergiche o colinergiche.
Era facile prevedere lesistenza di altri mediatori chimici delle funzioni cerebrali.
107
Nel 1933 fu identificata chimicamente una sostanza, isolata nel 1921 dal faseolus vulgaris, il
preziosissimo fagiolo delle nostre mense: si trattava della 3, 4, DiidrOssiPhenilAlanina,
isomero levogiro, L. DOPA. Nel 1960 si scopr che quella sostanza era deficiente nei gangli della
base del cervello nei malati di Parkinson. Era evidente che la sostanza avrebbe potuto funzionare
da trasmettitore chimico degli impulsi delle cellule gangliari della base ai muscoli periferici, come
fu poi dimostrato. Si era riconosciuto un nuovo trasmettitore chimico; le fibre attraverso le quali
mediante il trasmettitore si trasmettono gli impulsi furono da allora dette dopaminergiche
(Carlsson, Ehringer). Oltre ai descritti sistemi di neurotrasmettitori, adrenergico, colinergico,
dopaminergico, ne esistono altri: il sistema della serotonina (5 Idrossitriptamina), il sistema della
istamina, fibre istaminergiche e il sistema del GABA (alfa gamma butirrico acido) gabaergico.
Ma quali e quanti se ne possono ipotizzare nella determinazione delle pi alte funzioni del nostro
cervello che nascono nelle cellule delle circonvoluzioni cerebrali, nelle diverse aree, sempre meglio
definite? Quali reazioni chimicofisiche (e sub-nucleari?) si svolgono tra le cellule, le fibre, nelle
sinapsi, nelle giunzioni, nelle congiunzioni tra diencefalo ed encefalo, nella costruzione dei processi
cognitivi, affettivi, volitivi? Come in definitiva si forma il Pensiero dalle cellule del nostro cervello?
Moderne tecnologie (PET, SPECT) hanno permesso di determinare nuove aree, sede della
memoria, della predisposizione alle arti Si pu vedere in diretta quali aree sono coinvolte in
diverse sensazioni, sentimenti, affetti: se ne parler pi avanti.
E quali altre sostanze, oltre ai trasmettitori chimici, sono necessari alla creazione delle funzioni
cerebrali? Certamente gli ORMONI E GLI ENZIMI
Il termine ormone fu coniato da Starling (18661927) nel 1905. Tutto il nostro cervello, sostanza
grigia, sostanza bianca, singole cellule, tutto immerso, bagnato da infinite sostanze chimiche in
continuo mutamento chimicofisico, dal Sistema neuroormonaleenzimatico. Il tutto permeato dal
Sistema immunitario della difesa dellorganismo da agenti nocivi, provenienti dallesterno e
dallinterno stesso dellorganismo e perfino nati nel sistema neuroendocrino encefalico: sistema che
pu essere oggetto di depressione, negli stati che predispongono alla malattia.
A modulare, coordinare, determinare le complicatissime attivit neurocerebrali sembra preposto il
Nervous Growth Factor (NGF), scoperto e studiato dalla nostra Nobel Rita Levi Montalcini (1909- )
nel 1952. La sua prima capacit evidenziata quella, utilissima, di indurre la crescita di fibre
nervose lese nei gangli: anche il tessuto nervoso, quindi, pu rigenerarsi. Ulteriori studi hanno
messo in evidenza la possibilit di influire sul sistema immunitario con unazione trofica sulle
cellule della linea mastocitaria: sui linfociti B e T. Stimola inoltre la produzione di glicocorticoidi
da parte del surrene. Inoltre, ipotizzando una molteplicit di azioni da parte del NGF sui sistemi
neuro-ormonaleenzimatico e immunitario, si pu ritenere di poter meglio conoscere la genesi
neuro-chimica delle malattie mentali e forse di meglio curarle.
I principali ormoni che agiscono e interagiscono, assieme agli enzimi che li modificano, col
sistema nervoso, determinando effetti somatici, neurologici e anche mentali, sono, tra i pi noti, il
cortisone, lACTH, il testosterone e i suoi derivati, gli estrogeni: estrone, 17 estradiolo, estriolo,
progesterone, tiroxinaLa maggior parte sono chimicamente degli steroidi, tutti hanno in comune
un anello composto di 4 anelli (sterano) corrispondente al ciclopentanoperidrofenantrene.
La sostanza base degli steroidi il colesterolo. Caratteristica degli ormoni steroidei sono i gruppi
CH3 e OH. A seconda della loro localizzazione nelle varie posizioni dellanello, e della loro
disposizione spaziale, variano le attivit e gli effetti di essi, che possono addiritura essere contrari.
Vedi la somiglianza della formula del testosterone e dellestradiolo: luno mascolinizzante laltro
femminilizzante. Si conoscono bene le azioni del testosterone e derivati, anche da parte del grande
pubblico: stimolazione della sessualit maschile, azione trofica sui muscoli (anabolizzante),
stimolazione della libido nei due sessi, crescita dei peli.
108
Ma abbiamo visto che gli ormoni sono soggetti alla degradazione, modificazione da parte degli
enzimi. Non solo, ma ogni ormone viene prodotto dalle cellule competenti in quanto stimolato da
altre sostanze, prodotte in specifiche sedi: Ipofisi, Diencefalo, Epifisi. Queste sostanze sono
chiamate Releasing Factors (Gn Rh). Ma anche aree cerebrali possono stimolare gli stimolatori a
produrre ormoni o altre sostanze. Daltra parte, sensazioni, percezioni, stati danimo, stimolano la
produzione da parte dei neuroni encefalici di sostanze capaci di contrastare gli stimoli stressanti o
di modulare la sensibilit.
Tutti sappiamo per esperienza che basta la carezza della madre per calmare il bambino dolorante
o impaurito. Tutti ricordiamo come il suono della cetra di David avesse il potere di sedare lira di
Saul. E tutti ancora abbiamo sperimentato leffetto della musica, calmante o eccitante a seconda del
tipo. Sensazioni, percezioni esterne, hanno la capacit di modificare la cenestesi, il comportamento
dellindividuo; possono influire sulla percezione del dolore, della gioia; addiritura possono
influenzare la volont e il giudizio (suggestione, plagio).
E logico e legittimo supporre che le azioni, gli stress esterni, possano indurre la produzione da
parte dei neuroni encefalici di determinare sostanze capaci di far fronte alle varie circostanze.
Sostanze capaci di modulare, di ridurre la percezione del dolore, sono state isolate nel cervello: si
chiamano endorfine, per lazione e forse la struttura simile alla morfina.
Abbiano descritto il cervello come un immenso, complicatissimo laboratorio chimico, come una
intricatissima struttura fisica, di cellule interagenti in sensibilissimi microcircuiti molto pi
sofisticato di qualsiasi modello cibernetico. Una macchina in continuo equilibrio dinamico,
flessibile, duttile, adattabile a tutte le circostanze, avverse o propizie. Questo sistema inoltre
utilizza tutti i fenomeni legati allelettricit, al magnetismo, alla fisica nucleare e, probabilmente,
subnucleare. Le pi grossolane di queste attivit si sono potute evidenziare e utilizzare a scopo
diagnostico. Nel 1929 Hans Berger (1873-1941) dopo studi iniziati circa 30 anni prima,
dimostrava lesistenza di attivit elettrica nel cervello umano: esegu il primo Encefalogramma su
un uomo sottoposto a trapanazione del cranio. Continu poi i suoi esperimenti con galvanometri
eseguendo le sue indagini sul cuoio capelluto dei suoi assistenti, famigliari e addetti allospedale.
Berger osserv che il malato a letto a occhi chiusi emetteva onde nel tracciato con ritmo regolare di
10 cicli \ secondo e le chiam onde alfa ( ); se, invece, il malato veniva in qualche modo stimolato
o apriva gli occhi, aumentava la frequenza e diminuiva lampiezza delle onde che chiam onde beta
( ). Il fenomeno si avverava anche se il paziente eseguiva un semplice calcolo aritmetico: il
normale ritmo di riposo si arrestava: reazione darresto. Le onde cambiano anche nel sonno e in
situazioni di eccitazione, immaginazione, richiamo alla memoria, eccetera.
Nel 1935 E. D. Adrian (18891977) stabiliva che il ritmo alfa era prodotto dallattivit della
regione occipitale. Nel 1938 W.C. Walter rivel lesistenza delle onde delta ( ) circostanti un
tumore cerebrale e, successivamente, rivel un altro tipo di onde chiamate theta ( ).
Successivamente Kennedy dimostr le onde kappa (k). Si poteva cos confermare e rettificare
precedenti mappe di aree di attivit cerebrale.
E stato assunto come prova di morte cerebrale il cosiddetto EEG piatto, cio tracciato lineare,
come prova di assoluta mancanza di attivit delle cellule cerebrali. Dichiarando cos che, se sono
morte le cellule dellencefalo, tutto lorganismo da considerarsi irreversibilmente privo di vita,
morto. Molto importante lesecuzione dellEEG nella diagnosi di epilessia, e, indirettamente, di
tumori cerebrali.
Abbiamo visto come azioni esterne possano interferire con lattivit cerebrale: stimoli esterni
possono scatenare convulsioni, dosi elevate di insulina possono indurre il coma (M. Sakel, 1935).
U. Cerletti (18771963) aveva notato che durante luccisione di maiali con lenergia elettrica, questi
cadevano preda di violente convulsioni. Il fatto che le convulsioni potevano risolvere alcuni
sintomi psichici e che il coma elettrico poteva in breve essere superato, indusse Cerletti, dopo molti
esperimenti sugli animali, a trasferire il metodo di stimolo elettrico sulluomo. Ma ne ottenne aspre
critiche al Congresso di Neurochirurgia del 1937. Cerletti e Bini comunicano, nel 1938, i risultati
109
della loro nuova tecnica di Elettroshock nelluomo, riferendo i buoni risultati della cura. Nel primo
esperimento su uno schizofrenico, Cerletti riferisce: fu lanciata una scarica di 110 volt per 510
secondi si ebbe brevissimo spasmo, poi un tipico accesso epiletticocon apnea, cianosi, pallore
cadaverico, lapnea sembrava interminabile finch apparve respirazione stertorosa, alla fine un
risveglio gradualesi guard intorno: Forse ho dormito, disse. Il metodo ebbe una grande
fortuna fino a una decina di anni fa, poi, aspramente condannato, fu abbandonato. Ora sembra
ritornato in uso, con maggior cautela e miglior tecnologia.
La moderna tecnologia, sempre in evoluzione migliorativa, mette oggi a disposizione dello studio
del sistema nervoso e dellencefalo nuove tecniche e apparecchiature, tra le quali la Risonanza
magnetica, oltre alla TAC (Tomografia Assiale Computerizzata), soprattutto per quanto riguarda le
attivit cerebrali pi elevate. Lelaborazione del pensiero pu essere visualizzata con le recenti
apparecchiature che la tecnologia ci offre, la PET (Positrone Emissione Tomografia) e la
SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomographie).
La PET una scintigrafia basata sul rilevamento di positroni (+) emessi da sostanze marcate, C11,
N12, O15, introdotte nellorganismo. Produce immagini tridimensionali che possono riflettere
lattivit metabolica e chimica del tessuto studiato. I positroni liberano fotoni visualizzabili
dallapparecchio. Applicata al cervello, questa macchina pu svelare tumori, focolai di epilessia, e
evidenziare le funzioni cerebrali nelle malattie mentali. Gli isotopi sono prodotti dal Ciclotrone.
Un altro tipo di scintigrafia la SPECT che utilizza i fotoni singoli. Con analoghi procedimenti si
inventato un apparecchio capace di guidare il bisturi nellatto dellescissione di tumori cerebrali,
permettendo di resecare la neoplasia senza ledere i tessuti circostanti.
Da ricordare la possibilit di scatenare accessi epilettici, in soggetti predisposti, qualora siano
esposti a rapide variazioni dimmagine e a suoni intensi e ritmati, con variazione di colori come pu
verificarsi nelle Discoteche o nei Viedogames. Lintensa concentrazione e la estrema rapidit di
variazioni di suoni, colori, ritmi, impone continui momenti decisionali, causa dello scatenarsi
dellaccesso. Basta un EEG con stimolazione per svelare i soggetti a rischio.
La complessit del cervello ora descritta sufficiente a spiegare i meandri entro i quali si
contorce il pensiero umano, lanima, la PSICHE; a spiegare la fisiologia delle facolt cognitive,
sensitive, volitive, creative, e le relative patologie? Il metodo da perseguire resta sicuramente quello
scientifico, sperimentale, statistico, e il fine da raggiungere quello di trovare la base organica delle
malattie mentali. Si fatto ricorso a modelli concettuali, a spiegazioni simboliche dei fenomeni
psichici: nata la Psicologia, la Psicoanalisi, la Psicosomatica.
G. M. Charcot (18251893), grande clinico delle malattie nervose presso il rinomato ospedale
della Salptire e insigne anatomopatologo, fu il capostipite che apr lo studio delle malattie
mentali su base anatomica. Notevoli i suoi studi sullisteria, descritta come psicosi indotta da errore
della ideazione, che egli trattava con lipnosi.
Presso il grande ospedale e dal famoso clinico, accorse anche Siegmund Freud (18561939), ma
torn a Vienna insoddisfatto dei metodi di trattamento delle malattie mentali, e delle psicosi in
particolare. J. Breuer (18421925) aveva notato nel 1890 che, trattando una paziente con lipnosi,
riusciva a fare retrocedere la sua memoria fino ad un episodio traumatico della sua vita. Raggiunto
questo ricordo (che da cosciente non affiorava alla sua mente), i disturbi scomparivano. Ne concluse
che dovevano esserci, sepolte nella mente, rifiutate dalla coscienza, delle idee affettive che in certi
particolari stati, per esempio nellipnosi, affioravano con effetto liberatorio, catartico: Trattamento
psico-catartico. Freud scopr che per svelare i potenti processi mentali che rimangono celati nella
coscienza, non era necessaria la ipnosi, bastava un semplice rilassamento in un comodo divano,
dove il paziente si lasci scivolare in un tranquillo dormiveglia tale da dare libero sfogo ad ogni
pensiero che gli passasse per la mente. Ogni idea che affiora, in quello stato, ne trascina altre
andando a ritroso nella memoria fino alle pi remote esperienze sepolte in un ambito sconosciuto
della mente, inconscio, non presente alla memoria, dimenticato: come non fosse accettato dal
110
paziente. Freud chiam Es (pronome soggetto impersonale tedesco) linconscio, depositario di quei
ricordi nascosti alla coscienza, e Id (pronome soggetto impersonale neutro latino) = ci, la cosa.
Freud ipotizz che molte sensazioni, immagini, sgradite e riprovevoli al soggetto, vengono
rifiutate, censurate dalla coscienza del soggetto: solo quelle permesse dalla sua morale e dalla
societ secondo la cultura prevalente, vengono accettate e memorizzate. Le idee represse,
conservano tuttavia la loro potenziale energia, Libido, che si sprigiona in sintomi di turbe mentali, o
in sintomi somatici, interessanti il soma, il corpo. Secondo Freud due sono i livelli dellattivit
mentale, il Livello primario, espresso dal pensiero simbolico come i sogni, i miti, il piacere, e il
Livello secondario contrassegnato dal pensiero logico, il principio dellautocoscienza, il principio
di realt. Il principio simbolico non mai manifestato, pur essendo permanente: si rivela solo nei
sogni, nelle fantasie, nellimmaginazione artistica, e nei sintomi delle nevrosi e delle psicosi. LEs,
(lIncoscio) l Id la fonte delle motivazioni di base, della Libido (forzaenergia, impulso
costruttivo), e della Destructio (impulso distruttivo). LEs si trova spesso in conflitto con le
esigenze morali del soggetto, dellEgo (Iocoscienza morale individuale), plasmato secondo la
morale della societ, dalle regole accettateimposte dalla cultura, dalla religione, da un Super
Ego (Dio, legge divina). I conflitti tra Es \ SuperEgo generano i disturbi nevrotici. Il SuperEgo,
secondo la cultura prevalente giudaicocristiana, impone rigide regole morali soprattutto nel campo
della sessualit, da cui il maggior numero di conflitti con questa genesi, e, di conseguenza, il
grande numero di nevrosi e di devianze del normale comportamento sessuale.
Freud fond lAssociazione Internazionale di Psicanalisi nel 1910. La sua dottrina si diffuse
rapidamente, specialmente negli Stati Uniti.
Leccessiva importanza che Freud riferiva agli impulsi sessuali (Libido), specie della prima
infanzia, nella genesi delle neuropsicosi fu la causa della discrepanza con i suoi due pi brillanti
allievi. Adler (18701937 nel 1929 introdusse il concetto della impulsivit aggressiva: la forza
trainante della personalit non era la libido, ma il potere e il senso di superiorit. Per superare i
propri complessi di inferiorit lindividuo imbocca strade tortuose e fittizie che lo psicanalista deve
correggere, facendogli prima di tutto prendere coscienza del complesso, per poi superarlo.
C. G. Jung (18751961) nel 1912 pubblicava il suo Wandlungen und Symbole der Libido
(Mutamenti e simboli della Libido), dove applicava la dottrina psicoanalitica ai miti, e spiegava la
personalit e il comportamento umano secondo un punto di vista misticoreligioso. La Libido
intesa come energia indifferenziata. Lequilibrio psichico dato dalla stabilit tra conservazione e
distruzione dellenergia. La teoria junghiana si basa su tre principi: l Io conscio, l Inconscio
personale e lInconscio collettivo. L Io comprende le percezioni, i pensieri, i sentimenti, la
memoria. L Inconscio personale comprende i desideri e gli impulsi, prima coscienti poi
dimenticati. LInconscio collettivo comprende linfluenza delle esperienze collettive delle
generazioni passate (gli archetipi), la cultura in definitiva. Il Selbst (=se stesso, autocoscienza)
governa, modula, interpreta le opposte energie e individua il comportamento. Nel 1914 fond la
sua scuola di Psicologia analitica. Adler aveva fondato nel 1911 la Societ di Psicologia
individuale.
Freud nel 1938 fugg dallAustria a Londra, dove moriva nel 1939, dopo penosissima malattia, un
cancro del cavo orale (fu accanito fumatore di sigari), stoicamente sopportata fino a quando, per sua
preghiera, il suo amico Schur non gli indusse una gnadentod (eutanasia, morte per piet) con una
overdose di morfina. Iniziatore tra i divulgatori, porta in Italia la psicanalisi Cesare Musatti ( 1897
1989).
Ritornando al concetto gi accennato, sostenuto dai positivisti organicisti, secondo cui la struttura
anatomo-fisiologica del cervello condiziona le attivit psichiche, doveroso citare il Lombroso
111
(18361909) che, profondo conoscitore della anatomia e della fisiologia, applic il concetto
delluomo delinquente, con la tendenza a delinquere, a deviare dalla norma. Il crimine era da
considerarsi una anomalia individuale desumibile dalla storia di ciascun soggetto e rintracciabile in
stimmate somatiche di ciascun individuo. Si poteva dai tratti anatomici e somatici costruire dei
prototipi di potenziale delinquente: evidentemente perch la sua struttura anatomofunzionale lo
determinava e predisponeva. Era il concetto, ora perseguito, della ricerca: il DNA
(DeoxyriboNucleicAcid) di ciascuno, i suoi geni, determinano le espressioni somatiche e gli
atteggiamenti comportamentali di ciascuno.
Il Lombroso, quindi, ammetteva che lo stesso comportamento umano potesse essere determinato
dallanatomia, dalla conformazione fisica della materia cerebrale, dai suoi neuroni, collegati con
altri centri nervosi, il tutto bagnato, secondo le moderne teorie, dal sistema ormonaleenzimatico
immunitario. Daltra parte, lintuizione lombrosiana ha trovato conferma nella scoperta del gene
Philadelfia che sarebbe responsabile nel determinare la tendenza a delinquere.
Unulteriore conferma che la struttura materiale dellencefalo la responsabile del complesso
della personalit individuale, si ebbe allinizio dellanno 1995, con la scoperta della diversit
dellarea del linguaggio nel maschio, nelluomo, rispetto alla donna: larea femminile,
naturalmente, meglio conformata di quella maschile.
E recente la scoperta del Prof. Dick Swaab, olandese, secondo la quale il nucleo BSTc
dellIpotalamo, nella stria terminale c, presenta delle differenze nei due sessi, non solo, ma quello
dei maschi transessuali, almeno in quelli fortemente motivati a subire lintervento chirurgico
correttivo, risulta diverso da quello dei maschi normali: pi simile a quello della donna. .
Individuato il Centro si possono studiare al microscopio elettronico i suoi neuroni e sottoporre a
procedimenti istochimici i tessuti fino a studiarne il chimismo, la trasformazione biochimica della
materia che determina il desiderio sessuale: il coltello anatomico riuscito a incidere l dove solo
gli psicologi potevano offrire i loro modelli simbolici interpretativi.
Abbiamo accennato come il benessere psichico sia corrispondente a un clima di equilibrio
biologico dinamico psico-neuro-endocrino, e come la rottura, il turbamento di questo equilibrio sia
la causa delle malattie psicosomatiche. Ci impone una visione unitaria del Sistema nervoso e di
tutte le altre funzioni dellintero organismo. Il concetto della psicosomatica pervade tutte le
anomalie di tutti gli individui dei due sessi, tanto che si potrebbe dire che tutte le malattie siano di
natura psicosomatica. Quali inizialmente somatiche e poi psicosomatiche, quali inizialmente psico
ormonali e poi somatiche. Il campo dove ci pi visibile il campo delle malattie psico
endocrinologiche femminili, dove il rapporto ormoni e trasmettitoriipofiso\diencefalo\encefalico
pi stretto. Risulta chiaro che, cos stando le cose, sostanze che modifichino lequilibrio ormonale,
neurotrasmettitore ed enzimatico fanno sentire i loro effetti necessariamente in campo
psicosomatico e psichico. E equivalente a dire che esistono sostanze che possono modificare lo
stato psichico, il comportamento, la ideazione, la volont, in definitiva il Pensiero.
Neuro-psicologia. Psicofarmaci
La Storia della medicina ricca di numerosi esempi, fin dallanalisi dei primi documenti. Il
Genesi (3,6) riporta come la donna avesse notato che lalbero era buono a mangiarsie che era
prezioso per accrescere lintelligenza; e pi avanti, (30, 14 16) Ruben trov delle mandragore,
e le port a Lia sua madre, piante di valore usate come merce di scambio; forse se ne conoscevano
le propriet narcotiche e afrodisiache. Dioscoride utilizz la mandragora in decotto nel vino, in
pervigiliis et doloribus, nelle veglie e nei dolori: nellinsonnia per lenire il dolore. Anche lelleboro
noto fin dai primordi. Nel XVI secolo Gacia da Orta scoperse le propriet della Rauvolfia, che
lolandese Rumpf nell Herbarium (17411755) indic che valet contra anxietatem. E ben noto
leffetto delle foglie di coca, masticate dagli indigeni dellAmerica del Sud. E da ricordare che lo
stesso Freud fu entusiasta sostenitore delluso della cocaina, che inizi a sperimentare su se stesso
112
trovandolae farmaco meraviglioso: cambiava lumor nero, era euforizzante, agiva contro la fatica.
La prescriveva a pazienti depressi e dispeptici. Nel 1884 ne scrisse un famoso lavoro scientifico,
ber coca, dove ne descriveva le meravigliose propriet. Koller intanto sperimentava la soluzione
di cocaina come anestetico locale, definendone le sicure propriet nellocchio. Ancora oggi i
derivati di cocaina (xilocaina, carbocaina) sono impiegati come anestetici locali.
Leffetto delloppio, noto fin dall VIII secolo come stupefacente in Oriente, e nel XVI secolo in
Europa sotto forma di laudano, fu usato da Teofrasto di Hohenhein, meglio conosciuto come
Paracelso. Ne abbiamo gi parlato. Altrettanto noto luso e labuso fatto da Baudelaire e dai poeti
maledetti delloppio e dellassenzio (vermut con tanacetone). Da citare Baudelaire per il suo saggio
(1851), I paradisi artificiali delloppio e dellalcool. N da dimenticare che lhascisc (Cannabis
indiana) nota gi dallera precristiana (115205 a. C.), come i suoi effetti dannosi sulla volont.
Anche letere era noto a Sauvet per la sua liberazione emozionale (abreazione), riscoperta nel
1917 dagli psichiatri dellesercito americano (Starkey) come possibilit di esplorare il sub
cosciente (1944 Kelley). Con la sintesi dei barbiturici (E. Fisher 1903), la pratica delle sostanze
attive sulla psiche, usate solo da stregoni e poeti, passer in uso ai medici con scopi di indagine e di
terapia. Nasce il cloralio e si scopre la propriet dei bromuri.
Si inizia la pratica della Narcoanalisi per esplorare la personalit.
Soltanto alla vigilia della seconda guerra mondiale si scoprir la prima vera sostanza psicotropa, la
anfetamina (benzedrina), studiata negli USA nel 1931. Hauschild, nel 1938, sintetizz il Pervitin
(metilanfetamina) tre volte pi attivo come stimolante psicotropo. Poteva vincere il sonno, la
stanchezza e stimolare la vigilanza: tutte propriet sfruttate dagli eserciti: dalla Wehrmacht,
dallareonautica, e in vari commandos. Le propriet terapeutiche furono studiate dopo la guerra e
risultarono molto limitate. Come droga, le anfetamine sono usate in vari cocktail.
Tra il 1940 e il 1950 si svilupparono gli studi sulla mescalina e sulla Dietildi-amide dellacido
lisergico, LDS 25, dopo che, secondo lespressione di Huxley, artisti e scrittori avevano varcato
le soglie della percezione. Soltanto per nel 1950, in occasione del I Congresso mondiale di
psichiatria, J. Delay poteva affermare che la medicina psichiatrica poteva mirare a curare i malati.
Dal 1944 furono studiate le amine della fenotiazina. Nel 1947 fu scoperta la prometazina, sedativo
potenziante i barbiturici. Nel 1950 Charpentier realizzava una nuova fenotiazina (in sigla 4560
RP). Nel 1952 H. Laborit (1914 - ) ne rivelava le propriet di stabilizzatore vegetativo in
anestesia. Ma solo il 26 maggio 1952, J. Delay, J. Deniker (18521918) e Harl poterono
annunziare che una sostanza chimica, la cloropromazina, usata da sola in modo continuativo e
prolungato, era in grado di guarire una malattia mentale. Lesperienza dimostrava che era
sedativa, ipnotica, antiemetica e poteva attenuare i sintomi della schizofrenia: capace insomma di
abbassare la reattivit agli stress. Aveva una larga applicazione nei maniaci, nei malinconici e nei
depressi: fu quindi battezzata Largactil. Io stesso lho spesso prescritta: era sempre nel Pronto
Soccorso dellospedale per i casi di emergenza maniacale e rendeva meno frequente luso della
camicia di forza che, qualche volta, anchio ho ordinato di imporre.
Nel 1954 fu la volta del meprobamato (Quanil), altamente efficace negli ansiosi. E cos, con
lavvento degli psicofarmaci, nasceva una nuova scienza: la Psiconeuro-farmacologia.
Tra le sostanze meglio attive contro lansia si sono dimostrate le benzodiazepine, subito dette
ansiolitiche insieme ad altre sostanze di simile formula. Nel 1955 L. Sternbach speriment una
vecchia formula, il clorodiazepossido (Librium), che dimostrava subito di possedere notevole
capacit di indurre rilassamento muscolare e sedazione, con molto minori effetti collaterali della
cloropromazina. Altre benzodiazepine sono il Diazepan, il Valium e altri innumerevoli derivati, con
buoni effetti. Tra le malattie pi difficili da penetrare la schizofrenia che sembra in aumento.
Sembra tuttavia che un nuovo farmaco (1995), la clozapina, Leponex, abbia maggior efficacia di
altri, anche se gravato da notevoli effetti collaterali.
113
Abbiamo visto, toccato, misurato che nella materia encefalica nasce, tra laltro, quello che si
manifesta come psiche. Stimoli esterni, sostanze chimiche, atomi, elettroni, cariche, energia,
permeano la materia encefalica, con effetti inspiegabili; ne nascono emozioni, sentimenti, modi di
essere, di sentire. Organo di sostanza materiale, il cervello produce idee, produce trasformazioni
nella materia stessa, nella funzionalit delle cellule e dei tessuti: cose mirabili. Il metodo scientifico,
statisticosperimentale non sufficiente a spiegare tutto: si deve ricorrere a modelli concettuali.
La fecondazione
Le modificazioni cicliche della mucosa endometriale, con la comparsa del flusso mestruale,
furono studiate particolarmente da Federico Hitschmann (18701926). Inoltre Parker, nel 1932, e
Cless, nel 1951, dimostrarono che la parte ampollare della tuba ha corrente ciliare diretta verso
lutero, mentre, al centro del lume, la direzione opposta. Una tappa fondamentale nello studio
della ovulazione stata la scoperta del ginecologo giapponese Ogino e la quasi contemporanea del
Dr Hermann Knaus (1892-1970) di Gratz. Nel 1842 F. R. Pouchet (18001872) aveva tentato di
fissare il giorno dellovulazione durante il ciclo mestruale senza risultato. Pi tardi il tedesco
Cappellman nel 1883 ha tentato di fissare i giorni fecondi ed infecondi della donna: la donna
doveva essere feconda durante i primi 1718 giorni del ciclo; quindi sterile per circa 7 giorni, e
ancora feconda nei 34 giorni premestruali. La soluzione del problema fu data esattamente da
Ogino nel 1923. In Europa, in Germania apparve nel 1930. Quasi contemporaneamente lipotesi di
K. Ogino (1882 1975) fu confermata da Knaus che la rese nota con la pubblicazione del 1935,
La fecondabilit e la infecondabilit della donna. La massima fecondabilit della donna compare il
14 giorno contando dal primo giorno della prossima mestruazione.
Riporta un manoscritto arabo del 1322 che un allevatore di cavalli lasci per una notte in vagina
di una giovane cavalla un batuffolo di lana. Lo fece annusare ad uno stallone, che eccitato
dallodore, eiacul il suo seme sulla lana. Lallevatore la rimise nella vagina della giumenta :
sembra che la pratica abbia avuto buon effetto perch si diffuse rapidamente
Qualche tempo dopo, un medico introdusse nella vagina di una donna un batuffolo di lana
bagnato di sperma umano: non ebbe nessun esito: solo le ire dellInquisizione. Sappiamo che
labate Spallanzani ebbe successo con la sua cagna nel 1769, iniettandovi in vagina seme canino.
Il primo a rendere gravida una donna con seme del marito iniettato in vagina fu J, Hunter (1728
1793), tra il 1776 e il 1790. Nel 1777 si speriment la pratica della conservazione del seme
mediante congelamento. Altri tentativi seguirono finch Elia Ivanov (18701932), allinizio del
1900, studi scientificamente il metodo e Girard sostitu il metodo endovaginale con quello
endouterino. Anche in America fervevano gli esperimenti. Tanto che la Chiesa, con decreto del
SantUffizio del 25 marzo del 1897 stabil che non licebat sostituirsi alla Natura. Nel 1928 i casi di
inseminazione artificiale umana erano in tutto il mondo 185, col 35% di successi. Salirono a 9.642
nel 1941 i casi di successo di inseminazione artificale umana. E nel 1950 ammontavano ormai a
250.000 nel mondo.
Nel 1954 Bunge, Keetel e Sherman ottennero 4 casi di gravidanza con seme congelato di
donatore. Si costituivano le prime Banche del seme. In Italia, tra diatribe eticoreligiose, il metodo
era stato applicato, tra il 1936 e il 1942, in sole 16 coppie sterili, con tre gravidanze, presso il
Centro della clinica ginecologica di Bari. Le opposizioni furono violente ancora fino al 1961,
quando sorsero apertamente Centri a Bari, Firenze e Pisa. Per il caso di seme donato si parlava di
adulterio. Fino al 1970 il metodo di fecondazione artificiale consisteva nellintroduzione del seme
donato in vagina o nel canale cervicale. Presto la tecnica evolveva : linseminazione avveniva entro
lutero (IUI, Intra Uterine Insemination) o nella tuba dello zigote (ZIFT Zigote Intra Fallopian
114
Transfer). Un salto di qualit si ebbe con la tecnica detta GIFT (Gametes Intra Fallopian Transfer)
perch consiste nellintrodurre, per via laparoscopica, gameti, cio spermatozoi di donatore pi
ovulo prelevato alla donna. Ma soprattutto con la FIV\ET (Fecondazione In Vitro + Embrione
Trasferimento). Cio la fecondazione dellembrione avviene in vitro, e quindi lembrione viene
trasferito in utero. La fecondazione in vitro comporta prima linduzione alla crescita dei follicoli
(CFM Crescita Follicoli Multipla) con farmaci (Clomifene, hCG, E2), quindi maturazione dei
follicoli, segue il prelievo di ovociti. Fecondazione in vitro (in provetta) e coltura degli embrioni
fino ai primi stadi di segmentazione, e, infine, trasferimento degli embrioni nella cavit uterina:
Fecondazione in vivo.
Ci comporta dei problemi: la stessa fecondazione in vitro, la conservazione degli embrioni, il
loro soprannumero, la fine degli embrioni che sopravvanzano all inseminazione. Occorrono 60.000
100.000 spermatozoi per fecondare un ovocita. Dopo 48 ore di incubazione si ottengono 4-6
cellule da trasferire in utero per via trans-cervicale. Occorrono circa 7-8 cicli di trattamento per
ottenere una gravidanza. Possono insorgere gravidanze multiple e gravidanze ectopiche. La prima
fecondazione in provetta avvenne nel 1944. Solo 15 anni dopo, nel 1961, il biologo bolognese
Petrucci riusc a realizzare numerose fecondazioni umane in provetta con successivo trasferimento
in utero, ma la gravidanza venne interrotta. Ne seguirono accese polemiche eticoreligiose e una
denuncia per aborto. Nel 1965 linglese J. H. Edwards (19281979) perfezion la tecnica di
fecondazione in vitro e Steptoe perfezion la tecnica di rimozione degli oociti e della reintroduzione
degli oociti fecondati.
Gli stessi ricercatori, nel 1976, riuscirono a impiantare un ovulo fecondato a Silvya Allen che
rimase gravida. Ma anche questa gravidanza si interruppe tra le polemiche. Edwards e Steptoe non
si arresero: ci riprovarono con la moglie di un camionista il 10 novembre 1977. Il 25 luglio 1978, il
Daily Mail annunciava che era nata la prima bambina concepita in provetta, Louise.
In Italia lANSA annunciava che alle 9 dell 11 gennaio 1982 nasceva a Napoli Alessandra,
portata dalla cicogna di vetro.
Le moderne tecniche rendono possibile indurre una gravidanza in una donna in postmenopausa,
rendono possibile la donazione, da figlia a madre, di uova che poi, fecondate con seme del marito
morto, possono realizzare una gravidanza in utero a prestito. Non solo, ma si possono selezionare
gli embrioni in coltura, eliminando i malati e tenendo i sani da trapiantare, e, forse, si possono
curare gli embrioni geneticamente malati e, risanati, reinserirli nellincubatrice pi idonea. Si
possono ordinare figli a terze madri, di semi di terzi padri a pagamento. Un problema ancora
maggiore nascerebbe in caso di manipolazione genetica, alterando il patrimonio individuale di una
persona.
Si pu indurre la fecondazione assistita, facilitando la perforazione della zona pellucida da parte di
spermatozoi pigri o incapaci.
Tecniche che indurranno sempre discussioni; e le varie legislazioni, nelle diverse Nazioni,
tenteranno di regolamentare.
La pillola
G. G. Pincus (19031967), gi famoso endocrinologo della riproduzione, sollecitato da
Margareth Sanger nel 1951 a scoprire in fretta una pillola per regolamentare le nascite, incominci
a sperimentare con laiuto del suo collaboratore Chang, il progesterone ad alte dosi come
anticoncezionale nelle coniglie. Leffetto era buono: nessuna coniglia cos trattata restava incinta,
seppure assalita da focosi partner. Consultandosi con Rock che studiava il metodo per vincere la
sterilit, convenne che il miglior progestinico da studiare a scopo anticoncezionale era il Nor
etinodrel. Lo somministr ad alcune donne per 30 giorni, iniziando dal 5 giorno di flusso. Il
risultato fu incoraggiante. Il Noretinodrel era un progestinico impuro: conteneva piccole dosi di
estrogeno. Nel corso delle ricerche i due studiosi si resero conto che la pillola era pi efficace se al
115
progestinico si aggiungevano piccole dosi di estrogeno. Si arriv alla seguente formula: Nor
etinodrel mg. 9,85, Mestranolo mg. 0,15. La pillola venne chiamata Enovid.
La pillola fu sperimentata sulle donne di Portorico nellambito del programma Birth control
program per 18 mesi su 265 donne sposate tra i 16 e 44 anni: nessuna rimase gravida. La verifica
avvenne ad Haiti con pillola a dosaggio molto pi basso (5 e poi 2,5 mg di progestinico).
Gi nel 1957 la FDA (Food and Drug Administration, la messa in commercio dei medicinmali)
aveva autorizzato luso del Noretinodrel, Noretindrone e Mestranol per il trattamento dei disturbi
mestruali. Solo nel 1960 fu data lautorizzazione dalla FDA alluso della pillola, come
contraccettivo. Dopo 30 anni le dosi si sono ridotte di 1000 volte. Leffetto contraccettivo ottimo
e gli effetti collaterali minimi.
GENETICA E PROCREAZIONE
Abbiamo gi visto come Spallanzani alla fine del 1700 aveva dimostrato con ingegnosi
esperimenti che si poteva avere generazione solo se il seme del maschio, cio i suoi spermatozoi
venivano a contatto con lovulo della femmina. Spermatozoi gi visti al microscopio circa un secolo
prima, da J. Ham, 1677, Leeuwenhoek (16321723), Hartsoecker (16561725) , e ovuli scoperti da
K. E. von Baer (1792 1876) nel 1827. Graaf aveva descritto i follicoli dove gli ovuli sono
contenuti. Nella cellula si era dimostrata la presenza del nucleo, al centro del citoplasma. Il nucleo
era composto da una sostanza, scoperta col nome di nucleina, nel 1869 da F. Miescher (1844
1895), isolandola dalla testa degli spermatozoi di salmone. Essendosi rivelata questa sostanza come
acido, fu ribattezzata acido nucleinico. In questo acido A. Kossel (18531927), Nobel nel 1910,
aveva trovato la presenza di due purine, adenina e guanidina, e di due pirimidine, citosina e timina.
Le purine e le pirimidine sono le basi azotate. Nel 1910 Levene scoperse che esistevano due tipi di
acido nucleico, uno che conteneva oltre alle basi azotate uno zucchero detto ribosio e un altro
contenente le stesse basi azotate e uno zucchero che risultava lo stesso ribosio, ma con un atomo di
ossigeno in meno: desossiribosio. Il primo fu denominato Ribo-NucleicAcid: R N A Il secondo fu
denominato DesossiriboNucleicAcid: D N A.
Ancora Levene ipotizz che oltre alle basi azotate e agli zuccheri fosse presente nella nucleina il
fosforo, e chiam Nucleotide il composto fosfato + zucchero + basi azotate, e ipotizz inoltre che
gli acidi nucleici fossero costituiti da migliaia di nucleotidi.
Osservando la divisione di una cellula nellatto di generarne unaltra, mitosi, si era visto che il
nucleo si segmentava in diversi bastoncelli, che, in una certa fase del processo, si appaiavano. Di
ciascuna coppia di bastoncelli, uno finiva in una cellula e uno nellaltra. Questi bastoncelli furono
chiamati, nel 1901, cromosomi da McClung (18701946).
Correns (18641933) e T. Boveri (18621915) nel 1902 e Sutton nel 1903 trovarono un
parallelismo tra la trasmissione dei caratteri con i processi di maturazione dei gameti e le leggi
mendeliane che regolano la ereditariet dei caratteri.
Le cellule somatiche, tutte le cellule cio che compongono un certo organismo - uomo,
mammifero, uccello di ogni specie -, contengono un numero ben definito di cromosomi. La razza
umana caratterizzata dal fatto che ogni individuo normale contiene 46 cromosomi in ogni sua
cellula. Un tempo si era creduto che fossero 48. Nelle cellule germinali invece, dette gameti
(spermatozoi e ovuli), il numero dei cromosomi si dimezza. Si dice mitosi il processo con il quale le
cellule si dividono in due perfettamente uguali. Si dice meiosi il procedimento per cui una cellula
somatica (di 46 cromosomi) si trasforma in unaltra di 23 cromosomi. Questa trasformazione
avviene nelle gonadi, organi specifici essenziali, per la trasmissione della vita che sono il testicolo
per il maschio e ovaio per la femmina. Durante la spermatogenesi e l' ovogenesi, nel processo di
maturazione (moltiplicazioneaccrescimentomaturazione), da una cellula somatica di 46
cromosomi ne nascono due con numero di cromosomi dimezzato. Queste cellule, nella seconda
divisione, si moltiplicano fornendo cos molte cellule mature con numero di cromosomi dimezzato.
116
Da una cellula diploide (doppia) ne nasce una aploide (semplice). Se una cellula maschile si
unisce con una cellula femminile ne risulta una nuova cellula, zigote, formata da met cromosomi
di origine maschile e met di origine femminile. Lo zigote quindi risulta dallunione di nuclei
aploidi (Oscar Hertwig 1875). Nel 1891 Henking aveva notato che durante la maturazione dei
gameti, met di essi contenevano un cromosoma in pi rispetto allaltra met. McClung chiam
questo cromosoma accessorio, e E. B.Wilson (18561939) la denomin cromosoma X. Si visto
dopo, che il cromosoma X era decisivo nella determinazione del sesso dello zigote, formato da
due gameti che lo possedessero oppure ne fossero privi (McClung 1901). Ne risultava in definitiva
che cerano due tipi di spermatozoi, quelli che possedevano il cromosoma X e quelli che ne erano
privi. Mentre tutti gli ovuli possedevano il cromosoma X. Successivamente si scoperse che durante
la maturazione dei gameti maschili, accanto al cromosoma X ne compariva un altro di diversa
forma che venne chiamato cromosoma Y. Per cui, in definitiva, risultava che gli spermatozoi
maturi sono di due tipi: quelli col cromosoma X e quelli col cromosoma Y. Tutti gli ovuli invece
hanno il cromosoma X.
Posto A = numero dimezzato di cromosomi presente nel gamete, ne risulta la seguente formula.
Spermio Ovulo Zigote Sesso
A+X + A+X = 2A +XX Femmina
A+Y + A+X = 2A +XY Maschio
Si vede chiaramente che il sesso femminile risulta determinato da due cromosomi uguali XX,
mentre il maschile risulta determinato da due cromosomi diseguali XY. La cellula con cromosomi
sessuali uguali si dice omozigote, quella con cromosomi differenti si dice eterozigote
Labate agostiniano Bruno Gregorio Mendel (18221884), preceduto dagli studi di F. Galton
(18221911) e W. L. Iohannsen (18571927), aveva annunciato nel 1865 le sue Leggi
sullereditariet dopo numerosi studi sugli ibridi di piselli e polli. Constat che certi caratteri
specifici dei singoli individui si trasmettono nella prima e nelle altre generazioni con leggi ben
precise. Alcuni caratteri comparivano nella prima generazione, altri invece solo nelle successive.
Ipotizz che dovessero esserci fattori pi influenti di altri nella trasmissione. Chiam i primi fattori
dominanti, i secondi recessivi.
Si era osservato che la trasmissione dei sessi da una generazione allaltra, seguiva in definitiva le
leggi di Mendel sulla ereditariet: laccoppiamento di due individui di sesso diverso, uno omozigote
maschio, laltro eterozigote femmina, danno gli stessi risultati dellaccoppiamento di due individui
che siano uno eterozigote laltro omozigote, per un qualsiasi carattere studiato secondo le leggi di
Mendel. Era lintuizione della teoria cromosomica dellereditariet. I cromosomi quindi dovevano
essere portatori dei caratteri trasmissibili di generazione in generazione (Correns e Boveri, 1902, e
Sutton, 1903); e quindi in essi doveva trovarsi un fattore che Johannsen chiam gene.
Nel 1909 nasce ad opera di W. Bateson (1861-1926) la scienza chiamata Genetica.
T. O. Morgan (18861945) nel 1926 pone le basi citocromosomiche delleredit in armonia con
le Leggi di Mendel. Riconosce lallineamento dei geni nei cromosomi, la prima volta nella
Drosophila, e li individua e classifica, relativamente alle varie parti del corpo. Individua e indica
come gene letale un gene nel cromosoma X. E la teoria del gene: allineamento dei geni nel
cromosoma. Si pu costruire una vera e propria Mappa dei geni.
Esistono dei geni legati al cromosoma sessuale X, per cui si trasmettono solo attraverso il sesso
(femminile = trasmissione diaginica). E quello che avviene per la emofilia, che si trasmette solo ai
maschi attraverso la madre. Di questa malattia sofferse lo zarevich Alexej figlio di Nicola II
Romanoff, ultimo Zar di Russia.
117
Le Leggi Mendeliane sono: Legge I = della dominanza. Legge II = della disgiunzione. Legge III
= della indipendenza.
Un altro esempio di malattia ereditaria la Talassemia, dovuta a geni sbagliati portati dai
genitori. Se ambedue i genitori sono portatori del gene allora succede, secondo le leggi mendeliane,
che, posto che la coppia avesse cento figli, il 25% sarebbe sano, il 50% portatori sani
(microcitemici), il 25 % malati di forma grave, Morbo di Cooley. La microcitemia la forma pi
leggera della talassemia; Morbo di Cooly si dice la Talassemia Maior, i cui affetti muoiono
generalmente entro i venti anni se non si curano, difficilmente, col trapianto di midollo osseo.
Lo stato di microcitemia consente una vita normale. Ma se si uniscono un maschio e una
femmina entrambi portatori del gene microcitemico pu succedere che nascano sia dei
microcitemici come, secondo le leggi mendeliane, un malato di M. di Cooley.
Un altro esempio di trasmissione ereditaria quello relativo al Gruppo sanguigno. Tale esame
ammesso in tribunale per escludere la paternit di un individuo confrontando il suo Gruppo
sanguigno con quello dei suoi genitori, o per escluderne la possibilit.
Esistono esempi di eredit anche di caratteri psichici. E classico lesempio dellereditariet del
talento musicale di Giovanni Sebastiano Bach: ben 40 persone in cinque generazioni ne hanno
ereditato il talento. Ugualmente noti gli esempi di Scarlatti e degli Strauss. Anche il talento pittorico
fu tramandato a successive generazioni nella famiglia di Tiziano Vecellio. E per il genio
matematico noto lesempio dei matematici svizzeri Bernouilli. In questi casi tuttavia forse
meglio parlare di familiarit, piuttosto che, scientificamente, di ereditariet genetica.
Sicura invece la possibilit di trasmissione di malattie genetiche, legate ai geni, ereditarie:
Sindrome di Down (trisomia 21, Sindrome di Turner (XO), acondroplasia, osteogenesi imperfetta,
glicogenosi, mucopolisaccaridosi, spina bifida, fibrosi cistica, mucoviscidosi).
Nei nuclei delle cellule compresa, circondata dalla capsula, la sostanza costitutiva di essi, la
cromatina, nel cui contesto ci sono, invisibili nellinterfase di riposo riproduttivo, i cromosomi
contenenti i geni del patrimonio trasmissibile, costituiti da DNA (che conferisce la colorazione blu
con lematotossilina basica). Il nucleo contiene uno o due nucleoli che si colorano con i colori acidi,
eosina, e costituiscono la eucromatina che contiene RNA. Il nucleolo circondato da uno strato
blu, basofilo, di eterocromatina (Sandritter 1973). LRNA diffonde attraverso la membrana nucleare
nel citoplasma cellulare in cui, per suo messaggio, avviene la costruzione delle singole proteine,
secondo il progetto contenuto nel DNA. Nellinterfase la cromatina, come abbiamo detto,
uniforme e finemente granulosa. Suoi aspetti modificati sono indici di displasia o di tumori (Patten
(18661969). In definitiva il DNA si trova solo nella cromatina del nucleo. LRNA si trova nel
nucleolo del nucleo e nel citoplasma cellulare.
Abbiamo visto come lungo il cromosoma sono allineati i geni, i quali contengono tutte le
informazioni, esatte o talvolta errate, da trasmettere alle cellule figlie. Ne risulta che anomalie o
malattie genetiche possono insorgere sia per geni anomali, sia per combinazioni casuali anomale
di geni normali. Tra i geni dei gameti si possono avere associazioni di caratteri, Linkage
(collegamento), oppure scambi di caratteri (Crossing over), attraversamento, oppure mancata
separazione dei cromosomi (Th. Morgan 18661945).
Di estrema importanza il fenomeno della Mutazione.
Fu osservato nel 1910, nel corso dei numerosi esperimenti di ibridazione di quegli anni, che
improvvisamente comparivano, in una generazione, dei caratteri mai comparsi prima e del tutto
imprevisti dalle leggi mendeliane. H. J. Mller (18901967) nel 1928 scopre che mutazioni possono
essere provocate anche artificialmente per mezzo dellesposizione dei gameti ai ragg X, alle
radiazioni (beta) (alfa), ai raggi ultravioletti, catodici, e ai neutroni. Anche le alte temperature
possono indurre mutazioni, e anche alcuni agenti chimici. Le mutazioni si possono produrre per
cambiamenti che intervengono nella struttura materiale stessa del gene, per scambio di posizione
nello stesso cromosoma, Trasposizione, o per passaggio da un cromosoma allaltro, Traslocazione,
118
per raddoppiamento o perdita di un cromosoma. Le mutazioni, quindi, possono interessare i soli
geni, i singoli cromosomi o lintero Genoma. Si dice Genoma il complesso dei geni portati dai
cromosomi di un individuo. Con varie tecniche si sono potute costruire delle Mappe dei cromosom
Abbiamo visto che il sesso di ciascun individuo determinato dallassociazione dei cromosomi
sessuali: XX = femmina XY = maschio. Questo certamente vero, ma solo a livello genetico
iniziale. Hartmann (18761962) ha ipotizzato che inizialmente le prime cellule somatiche,
sviluppate dallo zigote, sia maschili o femminili, hanno uguale capacit di produrre sostanze
mascolinizzanti o femminilizzanti in misura uguale. Precocemente compare nelle cellule maschili
la prevalenza a produrre ormoni mascolinizzanti, e in quelle femminili ormoni femminilizzanti,
rispettivamente testosterone e estrogeni. A ci sono deputati i cromosomi X e Y e anche il
citoplasma. La prevalenza delluno o dellaltro ormone induce la formazione delle gonadi e dei
genitali, in senso maschile o femminile. Quindi si dice che la differenziazione sessuale genotipica,
in quanto determinata dai geni, e fenotipica perch orientata dagli ormoni.
Se non si sviluppa chiara prevalenza di ormoni maschili o femminili, si pu sviluppare,
fenotipicamente, cio a sviluppo esterno, un sesso intermedio: individui intersessuali, transessuali
Limportanza degli ormoni nella determinazione del sesso fenotipico evidenziata
dallosservazione di Murisier e Crew: galline si possono trasformare in galli per distruzione
patologica (tubercolosi o tumori) della gonade femminile, mentre sotto linfluenza del testosterone
si pu sviluppare una gonade maschile. Anche nelluomo si possono sviluppare fenomeni di
virilizzazione di femmine o di femminilizzazione di maschi.
Nel 1928 F. Griffith (1894- ) osserv che il pneumococco si trasforma da nonpatogeno in
patogeno con laggiunta di ceppi patogeni morti: il germe quindi riceve, utilizza sostanze del
germe patogeno ucciso. Nel 1944, O. T. Avery (18771955) insieme con J. J. McLeod (1876
1935) e M. McCarty (1911 - ) scoprono che la sostanza che modifica le propriet genetiche dei
germi il DNA.
Una prova sperimentale della possibilit di trasferire DNA, e contemporaneamente caratteri nuovi
in altre cellule, venne da Elena Ottolenghi-Nichtingale. Estrasse DNA da topini neri e lo mescol
con embrioni di topini albini, bianchi. Iniett le cellule di questi embrioni nel collo di topini albini:
dopo 15 giorni le cellule dei topini albini, che non producevano sostanza nera, melanina, potevano
invece produrre melanina, come le cellule dei topini neri. Il DNA dei topini neri, trasportato nelle
cellule dei topini albini, faceva s che questi potevano produrre melanina: un carattere veniva
trasferito da una cellula (dai suoi cromosomi) ad unaltra (ai suoi cromosomi). Il gene del color nero
era trasferito ad altra cellula che lo riceveva: riceveva il nuovo DNA. Ma lo studio della Ottolenghi
pass inosservato: non aveva mai parlato di trasformazione genetica.
Qual la vera costituzione biochimica del DNA, dellAcido DesossiriboNucleico: la sua
struttura chimica?.
L. Pauling (1901 1994) nel 1950 aveva ipotizzato che il DNA avesse una struttura elicoidale,
con i gruppi di acido fosforico in catena, e le basi puriniche irradiate allesterno.
J. D. Watson (1928- ) nellUniversit di Chicago sincontr, con laiuto di Luria e di una borsa
di studio, a Cambridge, con F. Crick (1916 - ). In quellUniversit lavorarono insieme sulla
struttura del DNA. Sulla base dei precedenti studi pensarono, da prima, che la struttura del DNA
fosse uno scheletro di zucchero e fosfato alternativamente collegati con le purine e pirimidine
aggettanti allesterno ad angolo retto, in tre catene. Questa ipotesi non resse alle prove sperimentali,
a controlli cristallografici, rifrattografici. Allora seguirono la strada del come il DNA potesse
trasferire linformazione da cellula a cellula: in che modo il DNA veicola linformazione da cellula
a cellula.
Linformazione del DNA, della sua molecola, potrebbe essere riposta nelle basi puriniche:
potrebbe essere la sequenza delle basi lungo la molecola del DNA lelemento che controlla lordine
in cui gli aminoacidi si allineano per formare le specifiche proteine. Bisognava stabilire la
sequenza e la disposizione delle basi lungo il DNA.
119
Dopo infinite prove, discussioni, modelli, speranze, delusioni, costruzioni di modelli di cartoncini
colorati, finalmente, il 31 gennaio 1953 Watson, mentre viaggiava in treno, ebbe lidea che il
modello fosse di due filamenti di DNA disposti allesterno, con le basi allinterno, come i pioli di
una scala a chiocciola. Ne discusse febbrilmente con Crick. La conclusione fu che due scheletri
laterali di DNA fanno da impalcatura alle basi puriniche e sono avvolti ad elica. Ciascuna base di
una catena opposta ad una base sullaltra catena, unite tra loro da un ponte di H (idrogeno).
Con questa forma di disposizione spaziale simmetrica, avrebbe potuto autoriprodursi. Watson poi
osserv che una coppia adeninatimina, unita da due H, aveva la stessa forma e dimensioni
molecolari di una coppia citosinaguanidina, tenuta insieme anchessa da due o pi legami di H.
E cos una base adenina di una catena si lega sempre con un ponte di H ad unaltra base di timina
sullaltra catena, e ugualmente la guanidina si appaia sempre con la citosina.
Per cui gli accoppiamenti risultano: Adenina --- H ---Timina
Guanidina -- H -- Citosina
Le due catene sono complementari: una positiva e una negativa, - cos si possono spiegare i
rapporti 1\1 appaiando le basi -. Ciascuna catena fa da stampo di una nuova catena complementare,
perfettamente uguale alla prima. Viene anche spiegata lautoreplicazione del DNA a partire da ogni
spirale, che diventa stampo per la spirale complementare.
Watson e Crick spedirono la loro comunicazione, di sole novecento parole, alla rivista Nature,
dove Crick spiegava: le due catene di DNA si sposano luna allaltra come un guanto alla mano, si
separano, e la mano si comporta da stampo per un nuovo guanto, mentre il guanto fa da stampo ad
una nuova mano.
Un passo fondamentale lungo il filo rosso del progresso medicobiologico.
Nello stesso anno, 1953, F. Sanger (1918 - ) stabilisce la sequenza di aminoacidi codificata nel
DNA. Nel 1970 Khobrans e collaboratori sintetizzano il primo gene che programma la sintesi della
somatostatina.
Nel 1977 si eseguono le prime ricerche sullinclusione di geni umani nei batteri.
Nel 1982 viene approvato in USA e in Gran Bretagna luso di insulina prodotta da batteri per
mezzo dellingegneria genetica.
Nel 1988 viene brevettato il topo transgenetico, creato in laboratorio.
Nel 1990 avviene la realizzazione del primo prodotto alimentare genetico, la rennina.
Nel 1991 si realizzano le prime sonde genetiche per la diagnosi dei tumori.
Nel 1993 vengono sperimentate nuove tecniche di immunizzazione per la cura dellabortivit
ripetuta.
Abbiamo gi visto come nel 1956 il patrimonio genetico fu precisato in numero di 46 cromosomi,
in 23 coppie di cromosomi.
Negli anni successivi furono identificati 68 geni; nel 1990 il numero dei geni era salito a 1884
con 2000 segmenti di di DNA.
Nel 1986 R. Dulbecco (1914 - ), Nobel nel 1975, assieme a Baltimore e Temin concepirono
lormai famoso PROGETTO GENOMA allo scopo di identificare tutti i 100.000 geni
presumibilmente costitutivi di tutto il patrimonio genetico umano. A tuttoggi (1995,) ne stato
identificato circa lo 0,1% . Sono stati catalogati circa 5000 geni. Il 13 dicembre 1995 il Gruppo
Genetisti di Padova comunicava che altri 400 geni erano da loro stati catalogati.
Limpresa Genoma immane: si tratta di determinare lordine di sequenza dei tre miliardi di
basi del DNA che rappresentano lalfabeto dellinformazione genetica. Se si volesse stampare il
Genoma delluomo, calcolando una media di 10.000 caratteri per pagina, si riempirebbero 300
volumi di 1000 pagine ciascuno, dice Dulbecco.
120
Sappiamo infatti che il DNA contenuto nel nucleo della cellula in forma di filamento che, al
microscopio, appare la sostanza che abbiamo conosciuto come cromatina; il filamento srotolato
misurerebbe circa 12 metri, ma le informazioni codificate in esso sono tali che lelenco completo
occuperebbe 13 copie della Enciclopedia Britannica: sequenziamento delle funzioni di 34 miliardi
di nucleotidi.
La mappatura presuppone la manipolazione dei geni, e lo scopo quello di individuare i geni
portatori delle malattie ereditarie: fino ad oggi ne sono stati determinati circa 5000. Anche le
malattie infettive e il cancro sono collegate al patrimonio genetico, almeno per quanto riguarda la
capacit genetica di opporre la resistenza immunitaria.
Ma sono gi stati identificati degli oncogni, capaci di indurre disordine nella moltiplicazione e
nella struttura cellulare: di indurre insomma il cancro, facilitati dallambiente, da fattori esterni
cancerogeni (vedi il fumo).
Unaltra possibilit rivoluzionaria prevedibile: la possibilit di individuare nel Genoma, la futura
storia clinica patologica di ciascuno: una Carta didentit da utilizzarsi anche a fini sfavorevoli:
non assunzione al lavoro, discriminazione sociale, nel campo assicurativo, eccetera.
Gli oncogni sono geni originariamente del tutto normali, col compito di controllare la
moltiplicazione delle cellule e le loro differenziazioni. Se questi oncogni sono incorporati nel
genoma di un virus, originariamente non oncgeno, assume capacit oncgena: capacit di indurre
disordine nelle cellule in moltiplicazione.
Esistono anche i proto-oncogni, la matrice degli oncogni, detti geni regolatori, ed anche gli
anti-oncogni che si oppongono allazione degli oncogni. Il cancro insorge quando lazione degli
oncogni non contrastata dagli anti-oncogni Si conosce gi il gene soppressore del tumore del
rene, del reticoloblastoma; sappiamo che esiste il gene soppressore del cancro della mammella e
forse anche quello del cancro del colon. Esistono infine i geni modulatori che regolano la coesione
delle cellule: se si sregolano facilitano le metastasi.
121
122
STRESS E MALATTIE
Sindrome di adattamento
Il termine stress significa stimolo, impulso, tensione. La prima volta che incontrai questa parola
fu nei primi anni del Liceo, 194647, quando vidi esposto in una libreria il titolo Stress and strain:
imparai il significato nel mio vocabolarietto e in una grammatica del 1831, trovata sotto le macerie
dei bombardamenti. Poi non ne sentii pi parlare. Solo allUniversit nel corso di Fisiologia
comparve quel termine quando mi spiegarono la Reazione dallarme.
Hans Selye (19071982) scriveva nella sua pubblicazione Adaptation Syndrome. J. Endocr. 6
117 1946 : In base alle esperienze sugli animali risult che caldo, freddo, infezioni, traumi,
emorragie, irritazione nervosa e molti altri stress provocano lo stesso tipo di alterazioni
patologiche causate dagli estratti della corteccia surrenale. Si ottiene cos, in sede sperimentale, la
replica della Sindrome dellinfermit, un modello misurabile quantitativamente.
La Sindrome dellinfermit era un complesso di sintomi che Selye aveva osservato ancora
giovane studente di medicina. Aveva osservato che molte e diverse malattie avevano in comune gli
stessi sintomi: perdita di peso, diminuzione di forze, diminuzione dellappetito, svogliatezza,
tensione nervosa. Approfondendo le sue osservazioni aveva concluso che diverse cause, diversi
stimoli, diversi stress, provocavano una serie di turbamenti di varia natura, in vari organi
dellorganismo. Una sorta di adattamento dellorganismo allo stimolo, allo stress. Chiama questo
complesso di sintomi Sindrome di adattamento. Lo stesso concetto della sindrome dinfermit.
Per Selye dunque la Sindrome generale di adattamento la somma delle reazioni generali e
aspecifiche generate dallazione protratta nel tempo, da fattori di diversa natura: chimica, fisica,
batterica o psichica. Questi fattori, di diversa natura, non sono altro che stimoli, stress , che danno
reazioni simili, spesso diverse, come risposta.
Lo scopo delle reazioni allo stress quello di consentire allorganismo di adattarsi alle diverse
noxae, ai diversi insulti, per superarli e vincerli. Si distinguono tre fasi della Reazione di
adattamento: Reazione di allarme, Fase di Adattamento, Fase di Esaurimento.
Reazione di allarme. Di fronte allo stress lorganismo in un primo momento reagisce con una
specie di stordimentosorpresa, e subisce passivamente linsulto: stato di shock = urto, ma
rapidamente interviene il controshock, nel quale lorganismo allarmato mette in atto meccanismi
di difesaoffesa.
Sotto una cascata di comandi trasmessi dal sistema nervoso (nervi spinali, mediatori chimici =
acetilcolina), la Surrenale midollare produce delle sostanze dette catecolamine (Adrenalina, Nor
adrenalina) simpaticomimetiche, con vasocostrizione delle arteriole cutanee, dilatazione delle
coronarie, delle arterie cerebrali, tachicardia, contrazione dellano, retrazione del pene, degli sfinteri
ileocolici, del piloro, dellutero, erezione dei peli, iperossigenazione. La Surrenale corticale
anchessa mobilitata e produce gli ormoni, tra i quali importante, in questa fase, il Cortisolo,
Idrocortisone: 17 idrossi-11 deidrocorticosterone, glicorticoide ipertensivo. Sotto stress
diminuisce il colesterolo. La corticale regola inoltre la funzionalit renale (clearance dellacqua, del
sodio e del potassio) e il metabolismo dei carboidrati, sotto lo stimolo della Corticotropina, ACTH
(Adreno Cortico Trophic Hormone).
Gli stress che inducono la produzione delle catecolamine sono la tensione fisica (sforzo) e
psichica (emozioni), lesposizione al freddo, la caduta della pressione arteriosa, lasfissia,
lipoglicemia, lipossia: tutte situazioni di pericolo contro il quale bisogna allarmarsi. Situazioni
demergenza cui fare immediatamente fronte.
Lorganismo per effetto delle catecolamine assume lo stato di difesa \ attacco contro il pericolo:
aumenta la pressione arteriosa, la gittata cardiaca, il glucosio nel sangue mobilizzato dal fegato,
aumenta la disponibilit di sangue ai muscoli per dilatazione delle arterie, e quindi aumenta la
123
disponibilit di ossigeno, aumentano le piastrine con diminuzione del tempo di coagulazione. In una
parola si mettono in moto tutti i meccanismi per aumentare il grado di attivit dei tessuti.
Fase di Adattamento: in questa fase, di durata varia in rapporto alla natura e allintensit degli
stimoli, lorganismo si adatta a far fronte e a superare lo stato di stress.
Fase di Esaurimento: questa naturalmente manca se lo stress viene superato e vinto. Se invece
persiste, di grande intensit, superiore alle misure poste in essere per il suo superamento, lenergia
reattiva dellorganismo si esaurisce: i danni persistono e si aggravano fino alla morte, o
allinstaurarsi di uno stato cronico a carico dei vari organi ed apparati.
SaluteMalattia. Medicina psicosomatica
La concezione di Sindrome di Adattamento ha influenzato nel tempo linquadramento
nosologico di varie malattie, per la sintesi interpretativa che suggeriva tra stress \ affezioni fisiche e
psichiche e il concetto che ne nasceva di medicina psicosomatica: varie malattie vennero studiate
anche sotto laspetto reattivo psicosomatico, come lartrite reumatoide, lasma bronchiale,
lipertensione arteriosa, lulcera gastrica, la colite ulcerosa, eccetera.
Dalle prime osservazioni di Selye il concetto originario di stress ha subito, nei decenni successivi,
varie rielaborazioni da parte dei medici clinici, degli psicologi \ psichiatri e neurologi. Lo stress
entrato nel parlare comune: qualsiasi alterazione del benessere viene riportato allo stress. E il
momento di definire il concetto di Malattia, Salute, Benessere psicofisico.
Per Benessre psicofisico possiamo intendere lEquilibrio, relativamente instabile, entro un
tollerabile range individuale, tra il complesso dei Bisogni individuali e il loro Soddisfacimento.
B(isogno)
E(quilibrio) = -------------
S(oddisfacimento)
E intuitiva la necessit di soddisfare i bisogni primari: mangiare, bere, respirare, eliminare le
scorie, procreareIl progresso della civilt e la cultura ha per creato nuovi e sempre diversi
bisogni indotti, di per s non necessari ma divenuti indispensabili per taluni stili di vita, talune
culture, che, se non soddisfatti, creano disagio psicofisico e squilibrio che si configura con
generico malessere e alla fine con vera malattia.
Persistendo lo stato di insoddisfazione per uno o pi bisogni indotti, persistendo la spinta al
soddisfacimento, si crea un perpetuo stato di difesa \ adattamento, che gradatamente pu indebolirsi,
attenuarsi e infine esaurirsi, generando un malessere, un cronicizzarsi di un complesso
sintomatologico, di malattia cronica, o talvolta, per indebolimento delle difese immunitarie, di vera
malattia acuta: pi spesso manifestazione psicosomatica iniziale, che pu trasformarsi in vero
danno organico, in una vera Malattia con lesioni fisio-anatomiche reali.
Nellunit biopsicocomportamentale dellindividuo, nel caso di grave o persistente stress
possono insorgere degli stati precursori di malattia, sia somatica che psichica, oppure quella
sindrome dellinfermit aspecifica che, se non indica vera malattia, significa disagio, malessere,
comunque non perfetta salute.
Dalla originaria concezione di Selye di stress (stimolo che provoca allarme, difesa
nellemergenza, e adattamento), si arrivati a considerare lo stress come effetto stressante, ansioso,
stato di malessere cronico, che pu essere considerato malattia psicosomatica e diventare poi vera
malattia somatica.
Attualmente si ritiene che lo stress pu essere indotto da tre categorie di stimoli, rispettivamente
connessi I) alla sopravvivenza dellindividuo 2) alla sopravvivenza della specie 3) alla
124
sopravvivenza del gruppo sociale. Si parla quindi di stress Individuale, stress Produttivo, stress da
Attaccamento, stress da Perdita.
Al centro della Reazione di adattamento, come gi detto, posto il sistema Psiconeuro
endocrino, modulato dalle cellule specifiche della corteccia cerebrale, dellipofisi, dellipotalamo,
della midollare e corticale del surrene, delle gonadi, che in definitiva governa il funzionamento di
tutti gli organi, dal cuore, allintestino, ai genitali, alla muscolatura, allespressione emozionale, alla
creazione del pensiero.
Difesa contro le malattie
E nozione ormai acquisita che la Natura difende gli organismi viventi contro le malattie
mediante il complesso sistema detto Immunitario.
E stata dimostrata unImmunit Innata e una Immunit Acquisita. LImmunit acquisita attiva
(naturale, artificiale), passiva (naturale, artificiale) e inoltre immunit adottiva.
Il sistema immunitario si gioca sullazione \ reazione, corpi \ anticorpi: sostanze nocive (noxae) \
sostanze ad esse contrastanti.
Gli anticorpi sono delle glicoproteine con caratteristiche comuni alle Immunoglobuline (Ig) che
si distinguono in cinque classi: Ig G (pi numerose, circolanti)
Ig M (stadi iniziali)
Ig A (nelle secrezioni)
Ig D
Ig E (allergizzanti)
I valori di Ig G fino a 30 UI\ml sono considerati negativi: assenza di anticorpi. Oltre i 30 UI\ml
significa che forse c uninfezione in atto. Quindi devono essere controllate le Ig M che
confermano linfezione in atto o noxa in atto.
Che da certe malattie pregresse si diventasse immuni lo aveva descritto Tucidide durante la peste
di Atene (430 429 a. C.).
Nel 1890 E. Behring (18541917) e S. Kitasato (18561931) dimostrarono che, in seguito ad
iniezione di tossina tetanica, si sviluppavano delle antitossine che neutralizzavano la tossina
proteggendo cos dalla morte tetanica. Denominarono queste antitossine anticorpi che si
opponevano ai corpi nocivi.
Nella prima decade del 1900 C. von Pirquet (18741929) dimostr che certi anticorpi potevano
diventare nocivi: si scopr il fenomeno dellallergi a . Gli anticorpi sono prodotti principalmente dai
linfociti e si accumulano nelle immunoglobuline: gammaglobuline.
Vari sistemi immunitari producono la immunit acquisita: da fattori umorali e da fattori cellulari
(midollo osseo, milza, linfonodi, timo). Due tipi di linfociti sono i maggiori produttori di anticorpi: i
linfociti T (immunit cellulare dal Timo) e i linfociti B (immunit umorale: B, organo non
identificato dei mammiferi, analogo alla Borsa di Fabrizi degli uccelli).
Soppressione anticorpale
Gli anticorpi sopprimono gli anticorpi: lapporto esterno di anticorpi ne inibisce la produzione
endogena. Molte malattie, o sindromi, si associano a immunodeficienza (o ne sono conseguenza?)
come nellAIDS, nel cancro, nelle infezioni, nella leucemia eccetera.
I corticosteroidi (cortisolo) modificano la chemiotassi anticorpale e la risposta linfocitaria alle
noxae. Provocano lisi del tessuto linfoide e quindi ridotta sintesi dimmunoglobuline. Anche
linvecchiamento causa di minore risposta immunitaria.
E opinione ormai diffusa che lo stato immunitario di un organismo condizioni linsorgenza o
meno di malattia, a seguito di qualsiasi stress, noxa, sia chimica, fisica o psichica. Se le difese
immunitarie (psicoimmunitarie?) sono adeguate, la noxastress non provoca effetti negativi
125
apprezzabili, oppure solo minimi. Se viceversa le difese immunitarie sono nulle o inadeguate, la
malattia prende il sopravvento fino a provocare la soppressione dellorganismo.
Il modello immunitario di difesa ampiamente noto, ma soddisfa soltanto il meccanismo
difensivo contro le malattie infettive: noxae, corpiantigeni \ anticorpiimmunoglobuline. Pi
difficile spiegare come lorganismo vivente si difenda dagli altri agenti patogeni: chimici, fisici,
ambientali, psicoemotivi. Il modello di Selye: stress-turbamentoallarmeadattamento \
equilibrioesaurimentoshock, pu essere la scarna rappresentazione di un groviglio di reazioni
chimicofisiche di cui poche tappe si riconoscono, e che dimostrano tuttavia limpegno di tutto
lorganismo nel suo insieme, e di ciascuna delle sue cellule e componenti cellulari, in complesse
reazioni che coinvolgono lintera unit funzionale che, impropriamente, distinguiamo in soma e
psiche.
La salute lequilibrio dinamico dinfinite costellazioni, corpistimoli, forze, chimicofisiche,
subnucleari, elettromagnetiche che producono quei fenomeni, apprezzabili dai nostri sensi, che
distinguiamo arbitrariamente in somatici e psichici: sensazioni, emozioni, pensiero; in una unit
vivente indistinta e indistinguibile, in una cascata di cause-effetti-cause in circolare equilibrio.
Quanto lo stress sia nel senso originario di Selye di stimolo \ noxa che nel senso attuale di
effettoturbamento psicogeno, pu influire nel determinare lo stato di malattia, il suo superamento,
o il cedimento totale?
E comune esperienza che possono verificarsi situazioni psicofisiche che definiamo
comunemente di debolezza fisica, di malattia occulta o incipiente come si verifica negli stati di
caduta delle difese immunitarie. Spiegare con rigore scientifico le relazioni tra cause (stress) e
turbamenti di benessere (stato morboso), impresa assai difficile.
Cerchiamo di riassumere quanto finora detto sullo stress come causa di malattia.
Lo stress agisce sullunit psicosomatica dellindividuo. Sono implicate in primo luogo le aree
cerebrali, lipotalamo, la sostanza reticolare e lipofisi. Lipofisi influisce direttamente sulle surreni,
la tiroide e le gonadi con gli ormoni. Delle surreni sono interessate la midollare e la corticale. La
midollare produce le catecolamine che, con i neurotrasmettitori e gli enzimi, regolano la Reazione
di allarme e ladattamento. Fino alleventuale Esaurimento e quindi alla Malattia. La corticale
produce il cortisolo da cui i linfociti che attivano il sistema immunitario che in fase di adattamento
in grado di opporsi allinsorgere della malattia.
Lansia
Nellelenco degli stress abbiamo compreso lansia. Lo stato ansioso pu essere considerato come
una condizione di allarme cui lorganismo sottoposto per un evento: una reazione di allarme, una
sindrome di adattamento come quella descritta da Selye; lutile e necessaria difesa dellorganismo
di fronte allemergenza. Quando lemergenza viene superata con successo lorganismo gode della
vittoria, compensato delle fatiche e delle energie utilmente spese: ne trae Benessere, soddisfazione
e fiducia in se stesso, compiacimento. Al contrario, quando nonostante tutte le energie evocate si
esauriscono, insorge lo sconforto, il senso di inadeguatezza, la paura, la frustrazione: Malessere.
.Sono i disturbi dellansia.
Oltre ai disturbi psicologici si possono manifestare sintomi fisici: lunit psicoorganica parla
attraverso lintero organismo e manda i suoi segnali. Pu comparire affanno, senso di cuore in gola,
strette allo stomaco, vampate di calore, sensazione di freddo, formicolii, pruriti, localizzati o diffusi,
eruzioni cutanee, dolori addominali, cefalee, dolori alle ovaie, alla colonna, diminuzione della
libido, impotenzaSintomi psicosomatici, dietro i quali non c nessuna malattia organica. Ma non
facile stabilirlo: inizia la via crucis del medico: esami, ricerche, medicinaliLa sindrome
126
dallarme diventa di esaurimento, e il malessere psicosomatico pu diventare vera malattia
organica.
Il bambino soggetto pi degli adulti agli stress: i suoi organi sono immaturi e lambiente esterno
ancora poco noto. Per ambiente esterno sintende il grembo materno, la madre, il padre, la famiglia,
lasilo, la scuola, la chiesa, latmosfera. Lintero ambiente fonte di stimoli, di stress, di conflitti tra
i suoi istintivi bisogni e la necessit di soddisfarli. Soprattutto nel bambino, molti sintomi, molte
sindromi non sono che Reazioni di allarme \ adattamento a vari stress provenienti dallambiente che
lo circonda: gli manca la sicurezza che pu dare la madre, la rassicurazione del padre, la complicit
del nonno.
Il bambino manda i suoi messaggi attraverso il suo corpo: somatizza i suoi conflitti, i suoi disagi
affettivi, le sue paure, il bisogno di affetto e sicurezza. Le cefalee, i disturbi gastrici, il vomito,
lasma, la balbuzie, linappetenza, lenuresi, la suzione del pollice, il mangiarsi le unghie, il pavor
nocturnus, non sono altro che domanda di attenzione, richiesta di soccorso. Il non decifrare questo
linguaggio e non provvedere a sedare la sua ansia pu favorire linsorgenza di vera malattia.
Ansia stressante
Lansia cronica, il continuo stato di allarme, di tensione psicoemozionale, linsoddisfazione di
bisogni spesso indotti dalla cultura dominante, pu determinare quello stato di esaurimento, di
caduta delle difese immunitarie e facilitare linsorgenza di disagio psicosomatico e infine di vera
malattia. Quando la cultura dominante crea nellindividuo lintima convinzione che qualsiasi
bisogno indotto debba sempre essere soddisfatto, che la sua soddisfazione sia un diritto, e
linsoddisfazione menomi la sua personalit, o solo il suo prestigio, si crea, allora, un grave
dissidio: turbato lequilibrio tra bisogno e soddisfacimento. Allora lindividuo si sente legittimo
debitore di diritti, di soddisfazione di bisogni, e soffre la frustrazione: il disagio psicoemotivo
stressante.
La cultura e i media che tutto pervadono, determinano le regole, gli imperativi, danno i canoni di
benessere, ricchezza, bellezza, status symbol: di bisogni da soddisfare. E nascono continue
insoddisfazioni, in circolo vizioso fino a cercarne di artificiali, nelle droghe; che addormentano
transitoriamente il bisogno; ma poi segue depressione e nuovo bisogno.
Luomo, unit psicosomatica di cellule, apparati, organi, programmati ad ununica funzione, cio
il mantenimento della vita, immerso nellambiente, atmosferico, ionosferico, ma anche culturale e
sociale. La vita pervasa dallo stato ambientale e lorganismo umano vive in sintonia. E immerso
nel tempo e nello spazio, sente le stagioni, la gioia della primavera fiorita e la tristezza dellinverno
uggioso, la calma dellautunno ferace; la luce del mattino e lombra della sera; laria fresca e
carezzevole e la tempesta minacciosa; sente la pressione atmosferica, laltimetria e lo stato
igrometrico; avverte il rimorso e il compiacimento della virt; il clima e le meteoropatie.
Tutto lorganismo delluomo pervaso dallambiente, determinato dalla sua struttura anatomo
fisiologica, guidato dal pensiero nato dai neuroni e dalle sinapsi. Lequilibrio salute \ malattia
dipende dai molteplici fattori esaminati e deve essere mantenuto meglio possibile, con lausilio
della medicina, attuata secondo il metodo scientifico sperimentale e la tecnologia sempre pi
necessaria.
127
GLI ANTIBIOTICI
Nel capitolo sulla chemioterapia abbiamo parlato dellimpulso dato a quella scienza da parte di
Ehrlich, e dei proiettili magici capaci di colpire i microbi direttamente nel sangue, e inoltre dei
sulfamidici.
Trattiamo ora degli antibiotici.
Nel 1889 il botanico inglese Ward parlava di antibiosi, del fenomeno, cio, dellantagonismo
microbico tra le diverse specie per lequilibrio biologico in un medesimo ambiente. Gi Pasteur
aveva descritto quel fenomeno.
Il concetto di farmaco antibiotico si stacca dalla chemioterapia: il farmaco chemioterapico infatti
viene preparato dalla consapevole e paziente sintesi chimica, lantibiotico, invece, prodotto da
muffe e da altri germi ed attivo contro i microbi dellorganismo: da ci nascono i farmaci
antibiotici.
Nel 1928 Alexander Fleming (18811955) nel suo Laboratorio di Londra aveva messo in
evidenza un fenomeno strano: allintorno di una coltura su piastra di stafilococchi, contaminata da
una coltura di ifomiceti, i cocchi morivano. Coltiva allora il fungo, il Penicillum notatum, ed ottiene
una vigorosa azione batteriostatica. Pubblica la sua scoperta nel 1929, ma non ritenendo che ci
fossero possibilit terapeutiche, abbandona la ricerca. Nel 1940, H. W. Florey (1898-1968)
patologo di Oxford, assieme ad un gruppo di ricerca, si indirizza allestrazione della sostanza attiva
dal substrato nutritivo degli ifomiceti di Fleming e alla sua purificazione. E. B. Chain (1906-
1979), dello stesso gruppo, contribuisce ad isolare la penicillina. Nel 1941, per, si accorgono che la
muffa di Fleming instabile e non riescono a produrla in grandi quantit. Finalmente quattro grandi
ditte americane riescono a mettere a punto un metodo di produzione industriale e nel 1942 riescono
a produrne in grande quantit. Da noi la penicillina arriv alla fine del 1945 e i tre scienziati ebbero
il Premio Nobel. Era il primo antibiotico della storia, attivo sulla maggior parte dei germi Gram
positivi.
Nel 1946, S. A. Waksman (1888-1973) dopo un lustro di ricerche, stimolato dallosservazione
della distruzione cui andavano incontro i micobatteri a contatto col terreno di actinomiceti,
Streptomyces griseus, mette a disposizione degli ammalati la streptomicina, attiva contro i germi
Gramnegativi, larma pi attiva contro la tubercolosi. Ugualmente attiva, ma meno tossica la di-
idro-streptomicina. Scoperse inoltre lactinomicina e la neomicina.
Il Gruppo Parke e Davis comunic nel Congresso di Chimica di San Francisco, nella primavera
del 1949, la struttura e la sintesi del cloranfenicolo (cloromicetina) prodotto dallo Streptomyces
venezuelae. Con questo fatto si getta un ponte tra la produzione degli antibiotici e la produzione
dei chemioterapici: attivit del filtrato di actinomicete e attivit di sintesi chimica. Agli studi per la
realizzazione del cloranfenicolo parteciparono J. Ehrlich e Q. Bartz oltre a D. Gottlieb, W.
Anderson e H. Carter.
Beniamin M. Duggar, ormai settantenne, volle nel 1943 intraprendere ricerche per un nuovo
antibiotico. Nellestate del 45 prepar una coltura e sulla sua piastra si svilupparono delle colonie
di una tinta dorata: chiam lactinomicete Streptomyces aureofaciens. Dopo infinite prove riusc ad
isolare una sostanza che denomin aureomicina. E un antibiotico polivalente, attivo per via orale,
meno tossico del cloranfenicolo, inattivo per contro la tubercolosi.
Chimicamente laureomicina risulta molto simile alla terramicina, isolata nel 1949 da un ceppo
dello streptomyces rimosus: nella formula della terramicina un atomo di cloro sostituito da un
gruppo OH. E unossitetraciclina. Fu chiamata terramicina perch il campione da cui fu isolata
proveniva non da remote terre, ma da Terre Haute, nelle vicinanze del luogo di ricerca.
Nel 1952 L. Conover scopr che, in definitiva, la struttura di base dellaureomicina, della
terramicina e di un altro antibiotico, l acromicina (cio la tetraciclina), era la stessa. E cos
laureomicina, la terramicina e lacromicina formarono il gruppo delle tetracicline, che insieme al
128
cloranfenicolo hanno rappresentato gli antibiotici a largo spettro: sensibili ad un grande numero di
germi.
Antibiotico naturale prodotto dallo streptomyces erythreus leritromicina con indicazioni simili
alla penicillina, alternativo al suo uso in caso di allergie.
Tutti questi antibiotici sono prodotti da muffe.
Antibiotici possono essere prodotti anche da bacilli.
B. A. Johnson esamin nel suo laboratorio un piccolo frammento osseo commisto a pus prelevato
da un focolaio di osteomielite di una bella ragazza, Margareth Tracy, trattata inutilmente con
penicillina. Dalle varie colture di pus isol un piccolo microrganismo producente spore, il Bacillus
subtilis. Con grande sorpresa si accorse che uno degli estratti possedeva una insospettabile attivit
contro numerosi germi Grampositivi. Era evidentemente una sostanza antibiotica. La chiam
bacitracina: baci da bacillus, tracina da Tracy. E molto attiva contro i germi Grampositivi.
Da altri ceppi di Bacillus subtilis sono stati isolati la polimixina e laerosporina, e dal bacillus
brevis la tirotricina. Vennero inoltre isolati una serie infinita di altri antibiotici: la metaciclina,
lazitromicinaE dalle muffe del penicillum griseofulvum la griseofulvina identificata da J. Grove
e McGowan.
Vennero prodotte inoltre la vancomicina, la kanamicina, la gentamicina e l amikacina.
A Milano, nel 1959, C. C. Sensi isol dai brodi di fermentazione dello Streptomyces mediterranei
una nuova classe di antibiotici che chiam rifamicina (da rififi nel titolo francese di un film), con
risultati deludenti sulluomo. Dopo una serie di ricerche per modificarne la struttura, nel 1966
Sensi dimostr che il pi promettente derivato semisintetico dalla rifamicina era la rifampicina,
dimostratasi assai valida nella cura della tubercolosi assieme alla streptomicina e allisoniazide.
Un altro gruppo interessante di antibiotici furono le cefamicine: esse si rivelarono finalmente
invulnerabili alle betalattamasi, furono isolate da E. O Stapley nel 1972, indicate con le lettere A
B C. Sono antibiotici betalattamici a struttura molto simile alle cefalosporine. Le cefamicine sono
derivati semisintetici della cefamicina C, prodotta dallo Streptomyces lactamdurans. Appartengono
a questo gruppo la cefoxitina e il cefmetazolo.
Dal nucleo cefemico della cefalosporina C prodotta dal Cephalosporium acremonium derivano le
cefalosporine, tra le quali quelle Long-acting, ad emivita pi lunga che consentono un ridotto
numero di somministrazioni giornaliere, a volte una sola. Tra di esse il ceftriaxone (Rocefin)
sintetizzato da Roland Reiner a Basilea.
LA RESISTENZA
Da tempo noto che svariati germi patogeni possono diventare pi o meno rapidamente resistenti,
completamente e stabilmente, a taluni chemioterapici e antibiotici. Diverse le possibili spiegazioni:
una particolare impermeabilit al farmaco da parte del germe, oppure altre caratteristiche speciali
del germe o, pi spesso, attraverso una sopravvenuta mutazione nei batteri stessi che acquisiscono il
carattere di resistente allazione antibiotica o chemioterapica. Si pu arrivare ben presto alla
scomparsa di miliardi di germi sensibili al farmaco e alla comparsa di miliardi di germi resistenti.
Anche i germi resistenti tuttavia possono trovare dei limiti al loro sviluppo. E noto inoltre che
molto pi facile determinare lo sviluppo di germi resistenti adoperando basse dosi di farmaco
invece che subito alte dosi appropriate. E appare anche conveniente adoperare due diversi
antibiotici insieme, perch difficilmente tutti e due, usati contemporaneamente, possono diventare
resistenti. Un altro modo quello di usare insieme un antibiotico e un sulfamidico. E inoltre
opportuno somministrare antibiotici dopo il tempo necessario per una diagnosi certa, o almeno
probabile, di infezione e, inoltre, di scegliere lantibiotico pi sensibile al probabile germe
responsabile. Meglio dopo lesecuzione dellantibiogramma, che ricerca il germe e ne saggia la
sensibilit alla terapia. Altro suggerimento quello del trattamento breve, in dose unica e
giustamente elevata. Meglio evitare lunghe degenze in ospedali, specialmente in reparti infetti,
come sale operatorie e stanze di Pronto Soccorso per evitare la disseminazione di germi resitenti.
129
CARDIOLOGIA
Willen Einthoven (1860-1927) riesce a registrare, tra il 190203, con il galvanometro a corda le
cosiddette correnti dazione di Waller e inoltre dimostra che le cardiopatie si possono registratrare
sul tracciato elettrocardiografico con le derivazioni standard, onde P- QRS -T, tuttora adottate.
Nel 1920, Pardee pubblica la sua osservazione secondo cui nellinfarto del miocardio compare un
onda a cupola nellelettrocardiogramma, londa elettrica di irritazione di Pardee, causata dalla
variazione di potenziale che si origina nel focolaio ischemico. Dal 1930 lelettrocardiografia
diventa ausilio essenziale e insostituibile nella diagnostica cardiologica.
Nel 1929, Werner Forssmann (1904- ) Nobel nel 1956, inventa il cateterismo cardiaco,
introducendo su se stesso un catetere ureterale in una vena del braccio fino allatrio del cuore
destro: una nuova strada nella diagnostica cardiaca. Dopo 12 anni, A. Cournand e D. W. Richards
propongono il cateterismo cardiaco su larga scala. In seguito si praticher la rivascolarizzazione
coronarica con o senza il posizionamento di stent di leghe metalliche a livello della placca. Negli
anni 60 si dimostr, con langiografia coronarica, che il Bypass tra la rete coronarica e laorta
mediante un tratto di safena impiantato distalmente al segmento occluso era effettivamente efficace
(Effer e Favoloro Johnson e Lepley).
Il 6 giugno 1960 Chardack e Gage effettuarono il primo impianto del nuovo modello di
Pacemaker, il dispositivo elettronico di piccole dimensioni che consente linserzione sottocute,
destinato a mantenere costante e regolare il ritmo cardiaco compromesso, originato dal nodo del
seno atriale. Pu essere mono o bicamerale o defibrillatore nel caso di fibrillazione ventricolare.
Christian Barnard (1923 - ) Sud Africa, Citt del Capo, il 13 dicembre1967 attu con successo
il primo trapianto cardiaco: il paziente mor dopo 19 giorni per complicazioni immunitarie. Il
secondo trapiantato soppravvisse quasi due anni. Ormai la pratica diffusa nel mondo con buoni
risultati. Il 16 giugno 1960 Chardack e Gage efettuarono il primo impianto di un nuovo modello di
Pacemaker, dispositivo elettronico di piccole dimensioni che consente la sua inserzione sottocute,
destinato a mantenere regolare e costante il ritmo cardiaco, originato nel nodo del seno atriale
compromesso. Tutti questi apparecchi possono essere mono o bicamerali e svolgere la funzione di
defibrillatori, nelle fibrllazioni ventricolari.
Nel 1960 A. Starr e L. Edwards ebbero i primi sucessi nellimpianto di valvole cardiache
artificiali. I materiali usati furono vari: teflon, dacron e bioprotesi dal cuore di maiale. In Italia, nel
1978 fu realizzata la protesi di Sorin che riduce i vortici e le turbolenze del sangue.
Grntzing il 16 settembre 1977 pratic langioplastica coronarica con laiuto di un palloncino
gonfiabile allestremit del catetere. Ora si pu eseguire lablazione per conversione della giunzione
atrio-ventricolare, nelle fibrillazioni atrialie ventricolari.
Dopo poco pi di ventanni dagli studi di Edler e Hertz (1954), si giunse all Ecografia
bidimensionale con tecnica Doppler ella Eco-color-doppler del cuore.
Ormai da diversi anni si usa la tecnica della registrazione dellelettrocardiogramma per 24 ore con
lapparecchio di Holter.
CITOLOGIA VAGINALE
Hans Hinselmann propose nel 1925 la Colposcopia, lesame endoscopico della Portio. La tecnica
and sempre pi perfezionandosi e luso diffondendosi.
G. N. Papanicolaou (18831962) inizi, nel 1923, le ricerche di citodiagnostica e le concluse nel
1943 in un lavoro scientifico sulla diagnosi del cancro della Portio con luso dello striscio vaginale
che veniva colorato col suo metodo e studiato al microscopio, il Paptest.
Ultimamente (2007) stata realizzata la vaccinazione contro il virus responsabile del cancro della
Portio, lHPV, Human Papilloma Virus.
130
LE PESTILENZE
Il microparassitismo e lo sviluppo del genere umano
A peste, fame et bello libera, nos Domine. Da sempre luomo, da quando ebbe coscienza della
divinit ha pregato: liberaci dalle epidemie, dalla carestia, dalla guerra.
Da sempre questi tre eventi hanno accompagnato, regolato, controllato, determinato lo sviluppo
del genere umano, la sua evoluzione, la sua storia.
Incominciamo con la pestilenza.
Con questo termine sintende qualsiasi malattia infettiva ad insorgenza acuta, a sviluppo
repentino, in una zona geografica, da cui si estenda a popolazioni vicine o lontane, per contatto
diretto o indiretto e che si spenga con rapido epilogo.
Qualsiasi specie, per potersi sviluppare ed evolvere deve poter trovare una sua nicchia ecologica,
un posto, un luogo in un ambiente adatto, per situazione del territorio, del clima e delle relazioni di
lotta \ convivenza con le altre specie, il tutto in equilibrio biologico completato e determinato da
una idonea catena alimentare. Questa catena costituita da anelli precedenti e conseguenti la
specie: ogni individuo di una data specie preda e predatore di altri individui di altre specie in un
complesso sistema in equilibrio che regola il numero degli individui compatibile col complessivo
sviluppo del sistema bioecologico.
Varie cause, accadimenti, eventi, situazioni possono rompere lequilibrio bioecologico. Un
elemento perturbatore o creatore di equilibri il cosiddetto microparassitismo. Lazione cio di
esseri viventi invisibili, ospiti delle varie specie, capaci di indurre turbativa nel benessere o nella
salute degli individui e delle comunit, fino a poterne causare la morte e la distruzione.
Il genere umano si sviluppato ed evoluto passando per vari e diversi equilibri bio -ecologici.
DallAustralopiteco allHomo sapiens sapiens, fino al neolitico e allinizio della storia il genere
umano stato funestato, regolato, determinato, dallazione del microparassitismo, e dalle guerre e
dalla fame che lo accompagnarono quali cause e conseguenze.
Iniziamo la nostra storia dal Paleolitico inferiore, quando gli australopiteci conducevano vita
arboricola nelle foreste fluviali subtropicali dellAfrica equatoriale e delle zone subtropicali
dellAsia. Gli ominidi erano onnivori, vivevano della preda di animali di grande mole e, a loro
volta, erano vittime dellaggressione di altri predatori. Minuti parassiti vivevano nel loro corpo e
sulla loro pelle pelosa, a loro spese. E verosimile che ospitassero acari, pulci, zecche, vermi,
mosche, oltre che protozoi, funghi, batteri e virus. Tra i protozoi, circa una ventina, cera
certamente il protozoo della malaria. E verosimile che i batteri abbiano colonizzato luomo
primitivo quando il numero di individui era relativamente basso nellequilibrio ecoclimatico di
quelle foreste, habitat ideale per lo sviluppo del maggior numero di specie viventi, dai mammiferi ai
batteri.
E anche probabile che, per la grande variet ed abbondanza di cibo, lo stato di reciproca
convivenza, di equilibrio, sia rimasto stabile per milioni di anni. Determinante del lungo equilibrio,
fu anche la grande variet di parassiti ospiti degli ominidi; parassiti in competizione \ equilibrio tra
di loro e, nel loro complesso, tra i mammiferi e ominidi e loro stessi.
Il lungo periodo di equilibrio ecobiologico fu turbato, presumibilmente, quando lHomo erectus,
sceso dallambiente arboreo, divenne capace di uccidere gran numero di specie erbivore di grossa
taglia. Quando dovette competere con leoni, iene, avvoltoi nella caccia allantilope. Allora luomo
primitivo divenne predatorecacciatore. Cos nellevoluzione umana si adattarono i muscoli, i denti,
le unghie e, soprattutto, luomo dovette progredire nellorganizzazione della caccia.
131
Fondamentale per una migliore organizzazione fu certamente lelaborazione dei mezzi di
comunicazione: tra di essi dovette svilupparsi un linguaggio primitivo: gesti, urli, sibili,
modulazioni, suoni, vocalizzi, che indussero la lenta e progressiva evoluzione degli organi fonatori:
laringe, faringe, lingua, conformazione cranicafacciale, e corrispondente modificazione
dellencefalo, con la formazione dei centri del linguaggio. Luso di un vero linguaggio articolato
sembra essere insorto circa 200.000 anni fa, dopo lunghissimi periodi evolutivi. Con il linguaggio,
oltre a migliorare lorganizzazione della caccia, si pot sviluppare lorganizzazione sociale e
soprattutto la trasmissione delle cognizioni. Luomo acquist la possibilit di sovvertire tutti i
precedenti equilibri naturali, modificando le diverse forme di vita soggette alla sua predominante
predazione.
Con la discesa dagli alberi e labitazione nella savana diminu la quantit dei suoi parassiti e vari
la qualit di essi. Acquis i germi degli animali erbivori, specie alcuni vermi. A questo stadio
evolutivo forse acquis dalle antilopi il tripanosoma e ne fu preda: prima malattia infettiva letale per
gli ominidi. Il tripanosoma, ospite abituale innocuo delle antilopi, era trasmesso dalla mosca tze
tze. Questo fatto rappresent una protezione per gli animali erbivori. Alcune zone tropicali,
infestate dalla mosca tzetze, divennero impenetrabili per luomo, il pi temibile devastatore,
mentre erano accessibili ad altri predatori, immuni dal tripanosoma.
Il lungo periodo, durante il quale gli ominidi da predatori si trasformarono in cacciatori, fu tale da
consentire levoluzione delle altre specie concorrenti di grossa taglia e dei parassiti, cos da
contrastare laggressivit perturbante degli umanoidi, costituendo in tal modo un equilibrio
dinamico.
Le malattie infettive, causa di epidemie durante le lunghe ere evolutive, devono essere state il
morbillo, la varicella, il vaiolo, la peste, il colera, il tifo esantematico, la malaria, la schistosomiasi,
il tifo addominale, la difterite e linfluenza, oltre alla tripanosomiasi, prima insorta, e alla
framboesia (Treponema pertenue, simile al treponema pallidum della sifilide).
Durante i lunghi periodi (milioni di anni), fino allHomo erectus, luomo fu sempre pi dotato dei
mezzi utili alla predazione e quindi alla caccia. Nella caccia divenne, in modo incontrastato e
assoluto, nettamente superiore a tutti gli altri animali, lHomo sapiens (200.000 anni fa) che, come
abbiamo visto, conquist lapice della catena alimentare. Con tale conquista, la specie umana, la
meno numerosa tra le viventi, increment rapidamente la propria popolazione. Luomo di
Neanderthal (100.000 anni fa) era certamente in grado di praticare la caccia grossa. Lo straordinario
sviluppo dellHomo sapiens nella caccia avrebbe certamente potuto distruggere quasi tutte le specie
utili alla sua alimentazione. Laumento della sua popolazione per, provoc contemporaneamente
un complesso parassitismo proporzionale al numero degli individui, che fu sopportato finch
popolazione\parassitismo furono in equilibrio. Rotto lequilibrio si svilupparono violente epidemie
che riportarono, con numerose vittime, il numero degli individui umani a livello di equilibrio.
Gli equilibri subentranti, - numero di individui \ cibo disponibile parassitismo, - vennero
sicuramente influenzati da variazioni bioclimatiche e telluriche: siccit, incendi, inondazioni,
escursioni termiche, terremoti, eruzioni vulcaniche.
Con lo straordinario progressivo incremento della abilit nella caccia si svilupp
contemporaneamente la rivalit tra orde di cacciatori umani: ne conseguirono stragi tra bande rivali,
con il conseguente controllo demografico; ottenuto anche, presumibilmente, con labbandono dei
neonati deboli o ritenuti inadatti alla caccia.
Le conseguenze della comparsa dellHomo sapiens furono diverse nelle zone subtropicali africane
e asiatiche rispetto alle zone temperate dove si era andato insediando.
Nelle zone settentrionali invent il modo di difendersi dal freddo con luso di pelli e pellicce, e
adoper il fuoco; fu cos in grado di permettere alle sue orde di cacciatori di attaccare gli animali
delle praterie e delle foreste, e pot sfruttare nuove risorse alimentari, occupando quindi nuove
132
nicchie ecologiche. Ci avvenne tra 40.000 e 10.000 anni fa, quando lHomo sapiens sapiens
abitava tutta la terra ad eccezione dellAntartide. Comparve in Australia tra 40.000 \ 30.000 anni fa,
nelle Americhe, attraverso lo stretto di Bering, 15.000 \ 5.000 anni fa. Nella Terra del fuoco circa
8.000 anni fa. Nessuna specie dominante di grossa taglia si era sparsa su tutta la Terra.
La cosa pi notevole consiste nel fatto che una specie di origine tropicale stata capace di
adattarsi alla vita di qualsiasi clima e ambiente ecologico, e, ancor pi sorprendente, che
ladattamento avvenne senza dover provvedere a modificare di molto il patrimonio biogenetico
della specie, operando quasi esclusivamente degli adattamenti culturali: invent vestimenti adatti
ai diversi climi, costru abitazioni adatte ad ogni luogo, clima e ambiente ecologico.
Questo fatto rappresent un fattore disgregatore e costantemente mutevole su tutti gli equilibri
bio - ecologici del Globo.
Con labbandono dei tropici, quelle popolazioni umane si liberarono anche dei parassiti tipici
delle zone torridofluviali. La salute conseguentemente miglior e quindi anche il vigore degli
individui. La capacit riproduttiva fu tale che raggiunse dimensioni numeriche mai conosciute.
Ben presto si svilupp un parassitismo proprio delle zone temperate e un nuovo equilibrio uomo \
parassiti.
Gli uomini, invece, che restarono nelle zone tropicali dellAfrica dovettero continuare a
combattere con i parassiti pi numerosi in quelle zone e a contrastare altre forme di vita anchesse
pi numerose: ambiente, quindi, potenzialmente meno salubre e pi avverso di quello delle zone
settentrionali.
Le zone equatoriali, nelle quali si svilupp maggiore parassitismo, risultarono pertanto pi
inquinate da agenti patogeni, e quindi a maggior rischio di epidemie. Questo fatto costitu anche una
barriera alla loro penetrazione da parte delluomo. Le zone nordiche, con minor carica parassitaria,
rappresentarono un ambiente pi favorevole allo sviluppo biologico e allinsediamento e sviluppo
di animali di grossa taglia (Mammuth), oggetto di caccia da parte delluomo; e anche allo sviluppo
di piante che gradatamente furono addomesticate, dando cos inizio allagricoltura.
Abbiamo notato come luomo si sia progressivamente adattato ai vari ambienti, variando
adeguatamente la sua cultura: si difese dalle fiere, dal freddo, dalle ostilit dellambiente, ma nulla
poteva la sola cultura contro il parassitismo.
Lunica arma contro il parassitismo, contro le malattie infettive, doveva essere apportata solo da
mutamenti bio-genetici: cos levoluzione cre il meccanismo dellimmunit contro gli agenti
patogeni del microparassitismo.
Limmunit
Schematicamente limmunit consiste nel seguente meccanismo, come ampiamente trattato.
Lagente patogeno, parassita, microbico o virale, quando penetra nellorganismo produce infezione
e malattia infettiva, ma contemporaneamente stimola le cellule alla difesa (levoluzione ha
specializzato i linfociti), le quali producono delle sostanze, gli anticorpi, che tendono a neutralizzare
o a uccidere lagente patogeno parassitario, impedendo linsorgenza della malattia o provocando la
guarigione. Se lorganismo guarisce conserva le sostanze attive contro i parassiti di quella malattia:
diventa immune: non si ammaler pi di quella malattia. Questo meccanismo, luomo lha
sviluppato lungo le ere evolutive, quale adattamento alla convivenza con i parassiti: un
meccanismo che interessa il patrimonio biogenetico, unico capace di opporsi allazione del
microparassitismo e di permettere allorganismo di convivere in successivi equilibri.
Nel lungo periodo in cui si evolveva ladattamento biologico antiparassitario, dellimmunit,
luomo della pietra aveva anche decimato la selvaggina migliore, con conseguenti crisi successive
di sopravvivenza nelle varie zone abitate.
La scarsit di selvaggina costrinse luomo a cercare altre forme di alimentazione. Si spost quindi
verso le coste per sfruttare la pesca. Invent e perfezion le imbarcazioni.
133
E dovette anche cercare nel regno vegetale fonti di alimentazione. Torn (laveva gi fatto quando
era arboricolo) a cogliere i semi per cibarsene, a selezionare piante per cibarsi delle loro radici,
frutti o foglie.
Estinte le grosse prede si adatt alla caccia di animali di piccola taglia. E in questo periodo che
dovette imparare a preparare i cibi. Immergeva, prima di mangiarli, i semi e le radici nellacqua, li
triturava per renderli pi adatti alla masticazione (macinazione). Incominci ad esporli al calore
(cottura) e a lasciarli fermentare prima di cibarsene. Ci avvenne probabilmente circa 50.000
20.000 11.000 anni fa, nel Paleolitico superiore-Neolitico.
In tale periodo, parassiti come i pidocchi e le spirochete della framboesia erano in grado di
sopravvivere anche nei climi temperati, tra le piccole comunit di cacciatori nomadi. Cos i parassiti
poterono perpetuarsi, ma provocando nelle popolazioni sintomi di malattia attenuati, tali da non
impedire una caccia fruttuosa. Piccole comunit erano pi sane di grandi agglomerati di individui.
Si instaurava un equilibrio tra parassitismo \ popolazione \ contagio.
Un ulteriore passo verso la civilizzazione venne compiuto con laddomesticamento degli animali
e delle piante. Ci avvenne per gradi: le specie, quella umana e quelle degli animali, che
convivevano nello stesso territorio, dovettero reciprocamente adattarsi alle caratteristiche del clima
e del terreno sul quale luomo iniziava ad operare le sue trasformazioni. Le varie acquisizioni,
dovute per lo pi a scoperte casuali, venivano trasmesse alle trib e alle comunit contigue.
Siamo allavvento della agricoltura e della pastorizia. Un passo fondamentale nella storia del
genere umano, che ebbe il suo prezzo.
I cacciatori e i raccoglitori dovettero sottoporsi alla fatica del lavoro agricolo. Dovettero imparare
a dosare le provviste per larco annuale e soprattutto dovettero imparare a conservare le sementi e
provvedere alla loro difesa. Dovettero procurarsi i pascoli per il bestiame e approntare mezzi per
proteggersi dalle ruberie. Luomo dovette guadagnarsi il pane col sudore della fronte (Gen. 3
19). Laddomesticamento delle piante, la selezione, cio, di quelle utili al sostentamento delluomo,
produsse un impoverimento delle variet biologiche dei vegetali, dovendo distruggere le piante
nocive alla coltura e proteggere quelle utili alla produzione di cibo.
Luomo divenne il maggior consumatore di cibo di tutte le specie esistenti, mentre le catene
alimentari si assottigliavano.
Non tutte le trib e non tutte contemporaneamente passarono dalla caccia allagricoltura e alla
pastorizia. Le trib rimaste cacciatrici si trasformarono in trib di predatori. Predatori umani su altri
uomini dei quali distruggevano i campi, i pascoli, e rubavano il cibo e le provviste conservate. Da
una parte trib lavoratrici e produttrici di beni, dallaltra trib predatrici, ladre di beni.
Da una parte le trib lavoratrici fiaccate dalla fatica e meno sane perch raccolte in agglomerati
pi numerosi (e quindi pi soggetti a contagio), e pi pacifiche, dallaltra le trib nomadi, meno
numerose, violente, rapinatrici, pi gagliarde e guerriere.
Queste trib guerriere, che in pratica vivevano alle spalle delle trib agricole, divennero
dominatrici su quelle stanziali, agricole. Sterminavano il nemico dopo averne razziato il cibo. Ma
cos facendo danneggiavano anche loro stesse: distruggevano il nemico e con esso il loro fornitore
di risorse. Gli agricoltori, i pastori si vedevano privati sia del cibo sia delle sementi: al limite della
sopravvivenza.
Le due parti dovettero trovare un modus vivendi, utile per entrambe. Forse gli agricoltoripastori
concessero una specie di diritto alla predazione limitato. Le trib guerriere potevano prelevare
solo un data quantit di cibo, lasciandone il sufficiente per la sopravvivenza e per la seminagione. In
cambio, le trib guerriere offrivano la loro protezione contro trib predatrici rivali. Una sorta di
patto sociale tra le due classi.
La classe guerrierapredatrice imponeva i suoi tributi, li riscuoteva e dettava le condizioni, le
regole. Forse trasmetteva alle varie comunit le esperienze di altre comunit con le quali erano a
contatto, contribuendo a migliorare la produzione dei campi e dei pascoli. In pratica dirigevano la
134
produzione, stabilivano le norme, riscuotevano i tributi e offrivano i loro servigi. Nasceva la
mafia, lembrione dello Statopadrone.
Per ridurre la proliferazione di erbacce e per preservare la coltura di piante domestiche si us
originariamente lallagamento, linondamento, cos si otteneva leliminazione delle piante che non
resistevano al trattamento, e la conservazione, invece, di quelle che potevano sopravvivere in acque
basse. Fu cos che probabilmente si selezion luso del riso e lutilizzo delle radici di alcune piante.
Oltre allallagamento per leliminazione delle erbacce si us la smovitura del terreno superficiale,
la sminuzzatura delle zolle: la sarchiatura. Successivamente si invent la vangatura, e poi laratura
(3000 a. C.) con lutilizzo di animali domestici; forse per la prima volta in Medio Oriente.
La necessit di ampliare la superficie coltivabile produsse la pratica del disboscamento mediante
incendio. E il bisogno di aumentare la fertilit della terra indusse a inventare la tecnica della coltura
a maggese. Ci fu probabilmente suggerito alluomo dal primordiale concetto animistico della
Natura: la grande Madre Terra, che produceva piante e semi, ne avrebbe prodotto in maggior
abbondanza se, di tanto in tanto, la si lasciava riposare.
Con la necessit di accumulare provviste, nacque il bisogno di difendersi dallopera devastante di
piccoli predatori dei raccolti: roditori, ratti e topi.
Il notevole aumento delle fonti di alimentazione produsse un forte aumento numerico della
popolazione umana e corrispondentemente una potenziale fonte di alimento per i parassiti, ignota
causa di malattie infettive, contro le quali, per lunghe ere evolutive, nacque a difesa limmunit: il
genere umano pass allora attraverso esplosioni e spegnimenti di cicliche epidemie.
Il microparassitismo miet vittime non solo nel genere umano, ma anche tra gli animali, domestici
e selvaggi, e tra le piante.
LE EPIDEMIE
Linsorgenza di una epidemia determinata, come sappiamo, dalla rottura dellequilibrio
biologico ospite \ parassita. E ci si verifica sia per squilibrio numerico, ma anche per lazione
favorente di eventi negativi climaticotellurici; per carestie, scarsa alimentazione e conseguente
indebolimento fisico. E inoltre, per i tempi di latenza tra infezione e reazione immunitaria
dellospite. Ma con la civilizzazione si aggiunsero altre cause. La vita sociale in agglomerati di
contadini pastori favoriva il contatto interumano, causa di contagio e di trasferimento di parassiti
da individuo a individuo. Inoltre le deiezioni umane e degli animali costituivano una importante
fonte di propagazione di agenti infettivi. E ancora, gli iniziali 'scambi commerciali' portavano
frequentemente a contatto diverse comunit umane tra le quali mescolavano i loro parassiti.
Stavano nascendo le citt (8000 a. C.), che rappresentavano luoghi molto pi inquinati dei
precedenti siti di stazionamento di piccole comunit.
Sembra che lo schistosoma abbia fondato la sua attuale stabilizzazione biologica circa 5000 anni
a. C. a causa della pratica dellallagamentoirrigazione dei terreni, che, in pratica, ricostruiva
lambiente delle foreste fluviali. Il sistema di adattamento biologico cronico consentiva la
sopravvivenza sia del verme che dellospite, mediante la seguente catena. Le femmine adulte
depongono le uova nelle venule della vescica umana. Le uova, eliminate con lurina nelle acque
dolci, si schiudono, in miracidii, che parassitano un mollusco (Bulinus) dentro il quale si
trasformano in forma cistica, sporocisti; dalle cisti nascono le cercarie che, libere nelle acque,
aggrediscono la cute e le mucose delluomo infettandolo. Cos il parassita, partito originariamente
dalle foreste equatoriali africane, si riproduceva e stabilizzava nella forma attuale nella
Mesopotamia e nellEgitto (1200 a.C.).
135
Abbiamo visto che nel corso del tempo si crearono equilibri diversi tra microparassitismo e ospiti
umani a seconda delle condizioni ecobiologiche e del rapporto numerico tra parassiti e
popolazioni umane. Cos, le popolazioni che convivevano con malattie infettive ad andamento
cronico, erano frequentemente affette da astenia, scarsa energia, malessere e limitata volont
combattiva, che, pur consentendo lesercizio dellagricoltura e della pastorizia, le rendevano facile
preda di altre popolazioni pi sane e robuste, meno numerose ma forti e guerriere. Queste trib
guerriere vivevano a spese delle altre pi numerose ma pi deboli e pacifiche: vivevano del loro
lavoro depredandone i frutti: una sorta di macroparassiti, forti sui deboli; minoranze guerriere
dominatrici su masse lavoratrici.
Si parla di macroparassitismo dal quale luomo dovette difendersi in analogia al
microparassitismo. Anche in questo sistema si dovettero creare degli equilibri. Quando il
macroparassitismo diveniva insopportabile perch metteva a repentaglio la stessa sopravvivenza,
lunico rimedio era la guerra: non restava altro che difendersi, combattendo.
Le piccole comunit predatrici finirono con limporre la loro violenza, le loro leggi. Queste
comunit dominanti vivevano separate dalle comunit di lavoratori, con le quali avevano sporadici
contatti, in occasione delle predazioni e delle imposizioni delle condizioni alle quali era permesso
di lavorare e della riscossione dei tributi che dovevano pagare. Ne nacque una sorta di classe
dominante, che dirigeva, preordinava il lavoro, dava ordini sulle modalit delle colture irrigue,
senza per altro adattarsi mai al lavoro nei campi e tra le acque, e senza avere con le popolazioni
lavoratrici frequenti contatti fisici. Daltra parte, neppure le popolazioni lavoratrici dovettero aver
desiderio di incontrare quelle violente trib: convinte del reciproco interesse di quella separatezza.
Quella separatezza impediva il reciproco diffondersi dei propri parassiti.
Sembra che in India un simile meccanismo abbia creato il principio di casta e i relativi tab.
Questi sarebbero stati i meccanismi con i quali si formarono i susseguenti equilibri ecobiologici
del parassitismo tra le specie viventi, fino alla nascita delle Citt (70005000 a C).
La ricostruzione di questi presumibili eventi si basa sulle conoscenze delle attuali malattie infettive
e sullo studio delle popolazioni attuali rimaste culturalmente e socialmente allet della pietra.
Difese contro le pestilenze
A parte la difesa naturale dellImmunit, elaborata dalla evoluzione, luomo adott contro il
microparassitismo strategie in definitiva sempre insufficienti fino ai nostri giorni. Non mancarono
certo tentativi di proteggersi: a peste, fame et bello libera nos, Domine, si pregava per chiedere alla
Divinit protezione contro le pestilenze, la carestia e la guerra. Le pestilenze erano causate dai
peccati delluomo contro la Divinit: bisognava espiare e pregare. Ne nacquero norme empiriche:
non mangiare la carne di animali immondi, i porci, che si cibano di immondizie, feci, rifiuti;
relegare in posti isolati i lebbrosi, coperti di piaghe immonde, maleolenti; praticare abluzioni
lustrali, purificatrici di impurit; bagni rituali, purificazioni di massa, battesimi di acqua
purificatrice.
I microparassiti che infestarono fin dallinizio animali, primati e uomini, furono vermi, protozoi,
batteri e virus, simili a quelli attuali, anche se molto diversi, a causa dei progressivi adattamenti
genetici.
Circa 20 furono probabilmente i plasmodi capaci di dare la malaria. Nelle zone disboscate delle
foreste equatoriali dellAfrica, le radure, adatte allagricoltura, si formarono ambienti ecologici
favorevoli allo sviluppo delle zanzare anofeli gambiae, che si nutrono di sangue umano e bovino.
Questo tipo di zanzare soppiant altri tipi di zanzare che si nutrivano del sangue di altri animali. La
presenza delle anofeli portatrici del plasmodio della malaria e voraci di sangue umano fece s che la
malaria si svilupp enormemente, e colp praticamente ogni individuo umano presente in quelle
zone disboscate.
136
Un tentativo di contrastare la mortalit della malaria fu messo in atto dallevoluzione: un
adattamento genetico fece s che alcuni individui producessero globuli rossi falciformi, meno
ospitali dei globuli rossi normali per il plasmodio della malaria. Gli individui portatori di globuli
rossi falciformi subirono danni meno debilitanti di quelli portatori di globuli rossi normali.
Contemporaneamente allevoluzione dellequilibrio plasmodi \ ospiti umani, si sviluppava il
fenomeno dellimmunit, e quindi si creavano individui portatori sani, immunologicamente
resistenti al batterio che potevano ospitarlo e trasmetterlo. Si crearono dei serbatoi di germi che, in
occasione di eventi climatici propizi o crisi nutrizionali, avrebbero potuto sviluppare delle epidemie.
Originariamente le malattie infettive furono trasmesse alluomo da branchi di animali domestici: il
morbillo dal cimurro dei cani, il vaiolo dai bovini, linfluenza dai suini. Anche animali selvatici
trasferirono il loro parassitismo alluomo: la peste attraverso i roditori, la febbre gialla attraverso le
scimmie, lidrofobia dai pipistrelli.
Dopo i primi eventi catastrofici sulle popolazioni vergini, si and instaurando, attraverso i
millenni, un progressivo adattamento, per cui i parassiti provocarono solo malattie ai bambini, i
quali o soccombevano o, guariti, diventavano immuni, ma portatori sani per nuove malattie. Fu cos
che il morbillo, il vaiolo, e molte altre malattie diventarono malattie infantili.
Macroparassitismo e organizzazione civile
Abbiamo gi visto come con lagricoltura e la pastorizia si crearono due classi: lavoratori agricoli
pastori, e predatoriconquistatori. La classe dominante fin con limporre il suo governo
delleconomia e del commercio, le classi conquistatrici avranno espresso un loro capo con dei
dipendenti guerrieri. Un piccolo esercito di violenti gabellieri, che avr contribuito
allorganizzazione del lavoro, alla trasmissione di nuove nozioni, al mantenimento dellordine
imposto. Era lorganizzazione civile dellera della primitiva agricolturapastorizia. Liniziale
nuovo equilibrio tra genere umano e il suo macroparassitismo.
Nel Medio Oriente antico
Verso il 500 a. C, quando lagricoltura irrigua aveva almeno 3000 anni, si erano stabiliti equilibri
micromacroparassitari in ogni regione civile della Euroasia, con notevoli adattamenti tra ospiti
umani e le nuove malattie della civilt.
Testimonianze scritte attestano chiaramente la comparsa di malattie epidemiche nel Medio
Oriente. La Epica di Gilgamesch, scritto babilonese del 2000, e un Papiro egizio pure del 2000 a.
C. attestano di pestilenze, come Scritti cinesi del XIII secolo a. C. I Testi biblici, scritti tra il 1000 e
il 500 a C, riferiscono tradizioni orali di accadimenti, di epidemie, risalenti alla stessa epoca 2000
1500 a C. Non possibile individuare quali malattie si celassero dietro la descrizione delle Piaghe
dEgitto: ulcere e pustole sugli uomini e animali, la moria dei primogeniti degli Egiziani; o quale
fosse la malattia nascosta dietro la epidemia dei Filistei o dietro la epidemia di David; o quella che
decim improvvisamente il campo degli Assiri, che dovettero abbandonare loccupazione di
Gerusalemme. Potevano essere epidemie di vaiolo, di morbillo, influenza, febbre tifoidea o
dissenteria E certo che tali malattie erano note in Medio Oriente prima del 500 a. C. e che
sicuramente ebbero un ruolo determinante sulla densit della popolazione e sugli eventi militari.
Tali epidemie, tuttavia, non dovettero essere cos gravi e frequenti da minacciare il tessuto
fondamentale delle societ civili del tempo.
Si era creato un equilibrio compatibile con il loro sviluppo e progresso. I parassiti, ospiti degli
animali, costituirono i serbatoi microbici, che, tra unepidemia e laltra, ne permisero la
sopravvivenza. Le malattie infettive si stabilizzarono in forma endemica, fluttuante: riserve
microbiche per le endemie subentranti. Alcune malattie si avviarono, come abbiamo visto, a
diventare malattie infantili. Questo equilibrio microparassiti \ ospiti umani e animali, relativamente
poco morbigeno, consent laumento progressivo della popolazione, lespansione territoriale e
lelaborazione di strutture politicoculturali secondo lo schema del macroparassitismo e il
137
miglioramento tecnico dellagricoltura, che conferirono a ciascuna civilt del Medio Oriente la
fisionomia duratura e caratteristica nel corso della Storia.
La civilt mediterranea classica. La Grecia
Durante il periodo classico della civilt mediterranea, lorganizzazione politico civile era
fondata sulle Citt. Citt-Stato con governi autonomi, sedi quindi di centri di potere in concorrenza
e quindi in conflittualit reciproca. Quel periodo pertanto fu caratterizzato da frequenti guerre, come
nel pi vasto ambito europeo. In questo equilibrio geopolitico, il microparassitismo era stato tale
che le zone litoranee mediterranee erano relativamente poco aggredite da malattie infettive ed
epidemie, e quelle popolazioni poterono espandersi. Le coltivazioni dellolivo e della vite
(proveniente dalla Tracia), del grano e dellorzo, non comportavano che modeste alterazioni del
territorio e degli equilibri biologici precedenti.
Naturalmente con laumentare della popolazione, alcune malattie infettive divennero pi frequenti
e comuni. Tra di esse sicuramente la Malaria. Ippocrate (430377 a. C.) parla di febbri di tre,
quattro giorni, che certamente ricordano la malaria, e descrive inoltre altri tipi di infezione simili
alle nostre attuali: l'epidemia di parotite nell'isola di Taso, e altre forme epidemiche nelle quali si
potrebbe riconoscere la difterite, la tubercolosi, o forse certe forme di influenza. Non compaiono
malattie infettive riferibili al vaiolo e al morbillo. In effetti sembra plausibile che nellepoca
ippocratica della Grecia classica tali malattie non fossero presenti, come appare verosimile che non
fosse presente la peste bubbonica.
Intorno al 700 a. C., allinizio del processo di civilizzazione delle zone costiere del Mediterraneo,
le condizioni ambientali geoclimatiche del versante occidentale erano diverse da quelle del
versante orientale, ambedue in attesa dello sfruttamento agricolo intensivo: pi aride (nellAfrica
settentrionale) e pi fredde (nel litorale del Mar Nero e della Penisola italica), che nelle zone
dellEgeo e del mediterraneo orientale (Palestina e Siria).
Queste due circostanze arrestarono lintensificarsi delle malattie che accompagnano laumento
della densit demografica.
Per questa ragione pot svilupparsi lImpero Ateniese (480404 a. C.) che strapp le terre a
popolazioni pi deboli doltremare e pot colonizzarle, inviandovi i propri cittadini pi poveri. .
Almeno nove colonie erano state cos costituite prima che scoppiasse la Guerra del Peloponneso
(431 a. C.). In analoghe circostanze di equilibrio bio-parassitario e di condizioni geoambientali si
poterono espandere nei secoli successivi gli Imperi della Macedonia, di Roma e di Cartagine.
Secondo quanto si pu arguire dallo sviluppo biozoologico durante levoluzione, si pu
affermare che levento di una costante espansione demografica rappresenta uneccezione, che trova
il suo limite nellaumento del micro e macroparassitismo.
Secondo il seguente schema:
Temperatura e umidit media = Basso microparassitismo = Salubrit = Salute =
Incremento demografico = Incremento microparassitismo = Infezioni Epidemie.
Macroparassitismo = guerre = microparassitismo.
Sulla base di questa regola, nel corso del primo millennio avanti Cristo si stabilizzarono equilibri
che consentirono una costante crescita demografica in tre centri di insediamento umano: Cina ,
India e Bacino mediterraneo.
LImpero romano alla morte di Augusto (14 d. C.), contava 54.000.000 di abitanti. LImpero
cinese, durante un censimento della dinastia Han (II sec. d. C.) contava 59.000.000 di abitanti.
Popolazioni in apparente equilibrio demografico, in costante aumento, diventano improvvisamente
preda dinfezioni per fattori imprevedibili, ma determinati da condizioni preesistenti. Come
paradigma pu essere ritenuto quanto accadde ad Atene nel 430429 a. C.
138
La peste di Atene
Secondo il racconto di Tucidide linfezione era partita dallEtiopia, pass poi in Egitto e in Libia e
quindi si manifest improvvisamente al Pireo. Infine giunse alla citt alta e le vittime furono
molto pi numerose. Il contagio si manifest ad Atene e fra le pi popolose delle altre citt. Si
spense in una sola stagione. Evidentemente gli ateniesi svilupparono subito un alto numero di
anticorpi che interruppe la catena epidemiologica. Il danno tuttavia fu gravissimo: la potenza di
Atene non si riebbe mai pi, e, secondo Tucidide, scompigli i piani di Atene contro Sparta e la
Lega del Peloponneso. Limpero ateniese non dur che tre generazioni.
Il resoconto di Tucidide conferma lipotesi che qualche epidemia pot superare dun balzo il
Medio Oriente e giungere fino alle coste del Mediterraneo.
Cos sembra lecito supporre che si possa essere verificato lo scavalcamento dello spazio che
divide lIndia dal Medio Oriente. Tuttavia il superamento delle barriere epidemiologiche, che
separavano lEuroasia, rimase eccezionale fino allEra cristiana.
Inizio dellEra cristiana. Impero romano. Cina.
Almeno quattro serbatoi diversi di microparassiti si erano venuti a costituire in quel periodo: in
Africa, nellEuroasia, nella Cina e nel Bacino del Mediterraneo. La possibilit di effettuare lunghi
viaggi, sia per terra ma sopratutto per mare, offr loccasione per la mescolanza dei diversi
microparassiti dei diversi serbatoi nelle diverse zone geografiche. Premessa, questa, per lo sviluppo
di epidemie qualora lincremento della popolazione, ed altri occasionali eventi, si fossero verificati.
Traffici carovanieri divennero regolari e frequenti tra la Cina e la Siria, lungo il tragitto che i
Romani chiamarono la Via della seta, che iniziava dalla Siria, ultima provincia romana verso
lOriente. I commerci raggiunsero il massimo intorno allanno 100 d. C. quando le signore romane
iniziarono a vestirsi con abiti di seta semitrasparente. Questi tessuti venivano fabbricati ad
Antiochia disfacendo robusti tessuti cinesi.
Lintensificarsi dei traffici tra Occidente e Oriente, lungo la via della seta, fece sorgere, svilupp e
intensific quel fenomeno che abbiamo chiamato macroparassitismo: lotta di uomini su altri uomini
con formazione di classi sfruttate e di classi sfruttatrici. Individui forti e coraggiosi della steppa con
spiccate doti guerriere, militari riuniti in bande, in trib, con capi e guardie mercenarie, offrivano,
imponevano i loro servigi, la loro protezione ai carovanieri contro il pagamento di pedaggi, tasse: in
definitiva in soggezione. Le trib fondarono villaggi, stazioni lungo litinerario e infine citt stato;
e veri Stati.
Queste popolazioni entrarono in comunicazione con i capi e le popolazioni delle Oasi dellAsia,
con conseguente mescolanza del microparassitismo.
E certo che nei primi due secoli dellEra cristiana si svilupp e fu attivo uno scambio
commerciale, sia per via di terra che per via di mare, mai esistito prima, tra il Bacino mediterraneo
dellImpero romano e lImpero della Cina.
Ci documentato da fonti cinesi: notizie di mercanti romani (ambasciatori di MarcAurelio) che
giunsero in Cina nel 166 d. C., e da fonti romane: Strabone (63 a. C.-24 d. C.) che era a Roma
intorno al 45 d. C.
I dati storici sono stati confermati dai reperti archeologici trovati durante gli scavi sulla costa
meridionale dellIndia (194548).
Con lo scambio delle merci e con il contatto interumano avvenne anche lo scambio dinfezioni, per
cui lecito supporre che episodi epidemici abbiano funestato, prima della fine del II secolo d. C.,
sia le popolazioni del Mediterraneo che quelle cinesi. Le epidemie tuttavia non provocarono
sensibile squilibrio demografico tra le citt medioorientali, cinesi e indiane. Nessun disastro
epidemico con gravi conseguenze turb i paesi orientali nei primi due secoli dellEra cristiana in
conseguenza della fusione dei serbatoi microparassitari delle varie zone.
Un grave disastro epidemiologico, invece, funest il mondo romano tra il II e il VI scolo d. C.
139
Area mediterranea durante la Repubblica e lImpero romano
Tito Livio ci ha lasciato la testimonianza di almeno undici casi di pestilenza verificatisi durante la
Repubblica: il pi antico fu nel 387 a. C.
Nel 471 scoppi unepidemia che, secondo Luigi dAlicarnasso, colpiva particolarmente le donne
gravide e partorienti, che morivano insieme ai loro figli. Ne fu data colpa ad una sacerdotessa che
per punizione fu sepolta viva.
Unaltra epidemia impervers dal 435 al 398 a. C., molto grave. In quel periodo, per ordine dei
libri sibillini, fu rinnovata la cerimonia del lectisternium: uno o pi di invitati al banchetto
sacrificale occupavano i letti conviviali per loro approntati.
Durante la peste del 292 a. C. fu costruito il tempio ad Esculapio nellIsola Tiberina, divinit
portata a Roma da Epidauro. Nel 205 a. C. scoppi unepidemia in Calabria che decim le truppe
romane e cartaginesi. Nel 23 a. C., sotto Augusto, Roma fu quasi spopolata.
Nellera cristiana seguirono le pestilenze di Nerone, Tito, e, nel 170 d. C., la peste di
MarcAurelio.
Il fatto veramente sconvolgente, per, inizi nel 165 d. C., quando una pestilenza in forma
epidemica, la Peste Antonina, incominci a diffondersi per tutto lImpero e dur per almeno
quindici anni, fino al 180 d. C. Linfezione fu portata nellarea del Mediterraneo dalle truppe reduci
dalla campagna in Mesopotamia. La violenza, lestensione e il numero di vittime furono tali che
dovette trattarsi di una infezione di parassiti del tutto sconosciuti a quelle popolazioni, prive quindi
di anticorpi immunitari. Fu particolarmente violenta a Roma, dove pare che morissero circa 5000
abitanti al giorno. Galeno (129 199 d. C.) visse questa epidemia: parla di vittime colpite da
ascesso ai polmoni con sangue espettorato; tuttavia in diversi passi nomina febbri accompagnate
da pustole che possono far pensare al vaiolo.
Questa epidemia inaugur un periodo lungo 500 anni, in cui si registr una costante diminuzione
della popolazione dei paesi mediterranei.
Nel 263 e nel 295 d. C. le pestilenze devastarono lImpero sotto Diocleziano (243-313).
Nessuna difesa efficace venne opposta naturalmente contro le pestilenze fino allepoca della
microbiologia. Le cause erano attribuite o a maledizioni divine o a miasmi maleolenti che
ammorbavano laria, e quindi le armi erano le preghiere e, per la legge dei contrari, luso di fuochi
che, alimentati da essenze profumate, purificavano laria. Anche Ippocrate non aveva altro da
consigliare.
Le pestilenze e la crisi dellImpero romano.
Il duro colpo inferto dalle epidemie che si manifestarono nel periodo dal 165 al 266 d. C. provoc
linesorabile diminuzione della popolazione, e come conseguenza la crisi del sistema politico
economico imperiale. La repentina mora delle popolazioni urbane dei pi attivi centri mercantili
fece diminuire il gettito fiscale di denaro contante, necessario alle casse dellerario imperiale. Di
conseguenza non si pot pagare, nella misura consueta, il soldo alle truppe a protezione delle
popolazioni di frontiera. Bande armate ribelli attaccarono la societ civile, estorcendo con la
violenza quanto pi potevano dalle popolazioni indifese annesse allimpero: ci aggiunse danno
economico e ulteriore spopolamento.
Le sollevazioni militari e le guerre eliminarono rapidamente i curiales, classe di proprietari
terrieri che, con le tasse, sostenevano i funzionari delle Provincie dellImpero. Furono sostituiti da
una nuova classe di proprietari, di origine rustica quasi esente da tasse imperiali (del governo
centrale), ma tributari delle Autorit locali, spesso pi esose. Si indebol, quindi, lAutorit centrale
140
dellImpero, sia per le minori risorse erariali sia per la diminuita forza militare. Limpero divenne
sempre pi vulnerabile, specie in Occidente, e alla fine cadde.
In un circolo vizioso tra macro e microparassitismo: guerre, carestie, epidemie, tutto concorse alla
diminuzione della popolazione e allindebolimento generale delle strutture socio economiche
dellorganizzazione statale dellImpero.
Il Medio Evo e lEra cristiana
Il micromacroparassitismo and intensificandosi durante il Medio Evo a causa delle ripetute
invasioni barbariche, la decadenza delle citt, lemigrazione degli artigiani verso le campagne,
laumento dellanalfabetismo con il conseguente disfacimento dellapparato amministrativo
dellImpero a favore della potenza organizzativa del Cristianesimo, apportatore di una nuova
concezione del mondo e della vita.
Il cristiano, in virt del comandamento evangelico, aveva lobbligo di assistere il fratello
ammalato, anche e soprattutto in corso di pestilenze. Lassistenza, per, non modificava le
conseguenze catastrofiche delle epidemie, ma il fatto di provvedere cibo e acqua, e di assicurare la
pulizia dei malati e degli ambienti di raccolta (xenodochi, diaconie, nosocomi, ospedali), facilitava
la guarigione ai pi forti e rafforzava il senso di solidariet e fratellanza tra le varie comunit
cristiane, e anche tra i pagani con i quali venivano a contatto. Ne conseguiva un rafforzamento del
cristianesimo e della sua organizzazione. La nuova fede, inoltre, con la previsione della ricompensa
celeste, dava un senso alla vita anche in mezzo allimperare della morte.
Ne derivava lumiliazione dellorgoglio dei pagani e delle loro istituzioni, e lesaltazione della
superiorit, morale e organizzativa, della nuova fede e della sua pratica.
Il Cristianesimo bene si adattava ai bisogni dei tempi disgraziati di peste, fame e guerra.
Cipriano, vescovo di Cartagine, scriveva nel 251 d. C.:la pestilenza un flagello per i giudei, per
i gentili, per i nemici di Cristo, ma per i servi di Dio una cosa vantaggiosa. Se la peste colpisce sia
i buoni che i cattivi, non la stessa cosa per gli uni e per gli altriI buoni sono chiamati al
riposo, i cattivi trascinati al supplizio. La pestilenza, spaventosa e funesta, mette alla prova la
nostra virt.
Lo Stoicismo non poteva dare una tale consolazione n una tale forza per sopportare la malattia e
favorire unutile ripresa. Sembra abbastanza verosimile che la pratica della nuova religione abbia
influenzato positivamente le conseguenze del microparassitismo e relative epidemie tra le
popolazioni a partire dal 165 d. C.
Dal 542 al 750. Lespansione degli Arabi.
Un lungo periodo di pestilenze funest le zone costiere del Mediterraneo, dalla Peste di
Giustiniano (542543), fino al 750.
La precisa ed estesa descrizione di Procopio permette di indicare la Peste di Giustiniano, con
relativa precisione, come peste bubbonica. La pestilenza, genericamente pestis, viene per la prima
volta identificata come la malattia peste come la conosciamo oggi. La Peste era probabilmente
comparsa per la prima volta in Egitto e in Libia nel III sec. a. C., secondo quanto riferisce Rufo di
Efeso (200 a. C.). La malattia deve essere penetrata nel Mediterraneo da un focolaio originario
dallIndia, o dallAfrica centrale, trasportata per nave.
La scoperta dellagente patogeno della peste avvenuta nel 1894 da parte di Alexander Yersin
(18631939). Dellagente, ora chiamato in suo onore Yersina pestis (gi Pasteurella pestis),
conosciamo la catena epidemiologica e la malattia.
Il ratto (rattus rattus) il serbatoio del germe che viene veicolato dalle pulci che pungono luomo.
Il contagio pu avvenire anche per contatto diretto, mediante goccioline infette di espettorato da
uomo a uomo. I ratti pestiferi, originari dallIndia, viaggiano facilmente sulle navi, ed molto
141
probabile che siano arrivati sulle coste del Mediterraneo, quando iniziarono gli scambi commerciali
tra lEgitto e lIndia.
Allepoca di Giustiniano i ratti non avevano ancora colonizzato lEuropa settentrionale, per cui la
peste rimase circoscritta alle coste del Mediterraneo.
E certa linfluenza che le pestilenze succedutesi dal 542 al 750 esercitarono sugli avvenimenti
politico - militari in Europa.
E logico supporre che i disastri demografici che esse provocarono abbiano contribuito alla
diminuzione dei mezzi a disposizione di Giustiniano per la realizzazione del suo progetto di
ripristinare lunit imperiale nel Mediterraneo e conseguentemente al fallimento dei suoi tentativi.
E che gli stessi disastri demografici - diminuzione del numero e infiacchimento delle popolazioni -
siano state le cause favorenti la irresistibile avanzata degli Arabi, che dal 634 iniziarono a sciamare
in Europa, scarsamente contrastati dagli eserciti occidentali.
NellEuropa settentrionale
Oltre allarea del Mediterraneo, le epidemie imperversarono anche nellEuropa settentrionale. Tra
le pi importanti quella che si svilupp nel 664 in occasione del Sinodo di Whit, nelle Isole
britanniche. Circa 49 epidemie registrate si susseguirono nellEuropa settentrionale. La loro
virulenza and col tempo progressivamente decrescendo, finch quelle popolazioni si adattarono
alle malattie in un regime di stabile cronicit relativamente compatibile con lo sviluppo civile.
Presso i popoli germanici e slavi.
Dal V all VIII secolo si ebbe la colonizzazione della Penisola balcanica da parte degli Slavi, e
delle Isole britanniche, delle zone del Reno e del Danubio, da parte delle popolazioni germaniche.
Le massicce incursioni dei Vichinghi che avvennero tra l800 e il 1000, fanno presumere che la
Scandinavia fosse abbondantemente abitata da quelle forti popolazioni che divennero il popolo
normanno.
Il clima dellEuropa settentrionale e la pratica dinsediamenti rurali a villaggi separati, influ sul
controllo del microparassitismo. E le popolazioni del Nord Europa non subirono una spoliazione da
parte del macroparassitismo paragonabile a quella subita dalle popolazioni del Mediterraneo. Ci
rende ragione della documentata concentrazione demografica in quelle zone dellEuropa in questo
periodo. A questo fatto contribu non poco laumento della produzione alimentare dal V all XI
secolo, dovuto allintroduzione di nuove tecniche agricole determinate dalla diffusione dellaratro
munito di versoio.
Tra le popolazioni nordeuropee si svilupp un unico, comune serbatoio microparassitario, che,
fin dallinizio, provoc forme endemiche con progressivo adattamento di convivenza tollerabile.
Quando una malattia compare ad intervalli di una decina di anni, solo i sopravvissuti, diventati
immuni, possono aver figli. E solo i bambini, non immuni, possono ammalarsi: la malattia dunque
diventa una malattia infantile. Poich relativamente facile sostituire i bambini, persi con le
epidemie, con laumento della natalit, limpatto negativo sulla demografia da parte delle malattie
infettive fu ampiamente colmato durante il Medio Evo in tutta lEuropa.
Analogamente a quanto avvenne nelle zone mediterranee dellImpero romano cos avvenne
anche nellImpero cinese nello stesso periodo.
Crescita della popolazione e comunicazione marittima dopo il 900
Entro il 900 d. C. tutte le popolazioni del Globo, avevano sperimentato gli effetti del
microparassitismo con epidemie pi o meno disastrose e frequenti nelle varie regioni.
Perduravano intanto due fattori di instabilit sistemica per gli equilibri stabilitisi: una crescita
continua e consistente della popolazione fra il 900 e il 1200, e una modificazione ulteriore dei
142
modelli di comunicazione marittima e terrestre. Principale, tra questi, il movimento carovaniero
attraverso lAsia: Gengis Khan (11621227), Marco Polo (12541324 ?).
Attorno a queste epoche avvenne il contatto dei roditori selvatici, serbatoi della peste, con le navi
e il loro trasporto nelle varie terre, dove colonizzarono il territorio.
La peste bubbonica (Yersina pestis) fu tra le malattie pi gravi e distruttive che in forma epidemica
squass lEuropa dal XII secolo fino allultima epidemia dEuropa, scoppiata in Italia nel 1815.
LE GRANDI EPIDEMIE DEUROPA (XII XVII secolo)
Nel 1167 e 1193 scoppiarono epidemie negli eserciti rispettivamente del Barbarossa e di Enrico
VI a Roma e Napoli.
Nel 124243 una pestilenza miet la maggioranza delle sue vittime tra lesercito di San Luigi di
Francia.
Nel 1301 scoppi una pestilenza in Lombardia, durante la quale si prodig in cure caritatevoli San
Rocco di Montpellier che contrasse il male e ne mor. Divenne poi il protettore contro la peste.
Nel 1348 la violenza dellepidemia di peste raggiunse il suo apice. La peste nera, partita del centro
dellAsia, 1333, pass in India, in Crimea, a Costantinopoli, Mesopotamia, Arabia, Egitto. Nel 1347
era in Sicilia, da dove raggiunse tutte le regioni dItalia. Invase poi tutta lEuropa fino alla Russia
(135152) fino ad estinguersi nel 1353 sulle rive del Mar Nero, nel punto dorigine. I superstiti
intanto si erano immunizzati. LItalia perdette circa met della sua popolazione. Venezia perdette
100.000 abitanti. LEuropa in tre anni cont 43.000.000 di vittime.
Firenze ne perdette 96.000. Lacme dellepidemia, nel 1348, fu descritta dal Boccaccio: la peste di
Firenze:a chiunque usciva sangue dal naso era manifesto segno di inevitabile morteNascevano
o nellinguinaia o sotto le ditella certe enfiature e a permutare in macchie nere o livide nelle
braccia e per le cosce.
In quello stesso anno, 1348, Venezia si dava la prima organizzazione sanitaria per opporsi al
flagello con listituzione dei Provveditori alla Sanit e poi dei Lazzaretti (1403).
Seguirono altre pestilenze in varie citt italiane, tra le quali a Roma in occasione del giubileo del
1400. E nel 1450 in Germania, Spagna e Francia.
Ricordiamo la peste del 1503 che colp, tra le altre citt del Sud, anche Chioggia. Nel 1555
devast Padova, e lanno seguente Venezia. Ancora a Venezia nel 1575 una gravissima epidemia
impervers tra la popolazione, la quale, per voto o per supplica, costru la chiesa del Redentore su
progetto del Palladio. E inoltre la peste di Firenze, descritta da Machiavelli, dellanno 1527.
Nel 1576-77 esplose la peste a Milano durante la quale si prodig la carit di San Carlo
Borromeo. Durante questa epidemia si verificarono episodi di perturbazione psichica collettiva
maggiori che in altre occasioni: le donne, per il timore di essere internate nel lazzaretto e di essere
spogliate, si uccidevano, colte da una sorta di mania collettiva. La maggior parte delle giovani,
quasi per opporsi alla morte con un aumentato appetito sessuale, rimasero gravide, e, alla fine,
furono pi i nati che i morti.
Oltre alla vera peste, furono, in questo periodo, causa di pestilenze il catarro endemico, detto in
Italia influenza (1510; 1557; 1580) e il tifo esantematico o petecchiale nel 1477, e poi nel 149293,
detto peste marranica, e pi tardi, quando fu descritto da Fracastoro, nel 1456.
Si diffusero in questepoca in Occidente anche il vaiolo e la varicella, molto pi noti in Oriente.
Nel 1600 continuarono le pestilenze, una cinquantina in totale, soprattutto di peste bubbonica, ma
anche di difterite, malaria e tifo petecchiale.
Da ricordare nel 1629 la peste di Montpellier dove, partita da Lione, scoppi e sincrement con
larrivo del Cardinale Richelieu, del Re e della Corte e di numerosi armati, in guerra contro i
Calvinisti. Tutti fuggirono; delle 10.000 persone rimaste, met furono vittime dellepidemia.
143
La pi celebre e la pi violenta e disastrosa fu lepidemia che colp lItalia settentrionale,
specialmente il milanese e la citt di Milano nel 1629. Fu la peste bubbonica narrata dal Ripamonti
e descritta dal Manzoni. Preceduta da una grave carestia e dalla guerra tra Austria e Francia, fu
portata in Italia dai soldati tedeschi, i lanzichenecchi (lands knecht = servi, fanti di campagna).
Milano vi perdette circa 160.000 abitanti; lItalia settentrionale circa un milione.
Famosa e interessante, sotto il profilo della psicologia di massa in tempi di calamit, la credenza
che la peste fosse diffusa dagli untori, istigati e protetti dal demonio, ai quali sembra credesse
anche il Cardinal Borromeo, che tanto si prodig nellaiuto agli appestati.
Non credeva al contagio Don Ferrante (Promessi sposi fine cap. 37): Vibici, esantemi,
antracibubbonichi nega che non ce ne sia?ma il contagio esiste in rerum naturae i
medici, che faccia tosta: non toccate qui non toccate l, e sarete sicuri! Come se questo schivare il
contatto materiale de corpi terreni potesse impedir leffetto virtuale de corpi celesti! E tanto
affannarsi a bruciar de cencibrucerete Giove e Saturno?. His fretus, non prese nessuna
precauzione contro la peste; gli sattacc, and a letto, a morireprendendosela con le stelle.
La peste di Verona e Venezia
Nel 1630 scoppi unepidemia di peste a Verona e poi a Venezia, dove acquist particolare
violenza: uccise in undici mesi 94.000 persone. Interess tutta la Repubblica, e quindi anche
Chioggia e poi Cavarzere e Adria, dove si videro nellAdige e nel Po i cadaveri che scendevano a
valle. I Veneziani fecero voto di innalzare la chiesa della Madonna della Salute per ringraziarla
della cessazione del flagello. Chioggia, liberata il 22 novembre, scelse S. Cecilia, venerata in quel
giorno, come compatrona insieme ai Santi Felice e Fortunato. Ancora oggi, da noi, si celebra la
festa, il 21 novembre.
Tra le pi violente della storia fu lepidemia di influenza che scoppi a Londra nel 1675 76. Fu
descritta da Sydenham (16241689) che ne fu testimone. Una precedente, 1656- 57, fu descritta da
D. Defoe.
La difterite, di cui si trovano cenni nellantichit (Ippocrate, Galeno), comparve in Europa nel
Medio Evo, soprattutto in Spagna (mal del garrotillo). E poi ancora nel 1600 Francesco Perez la
descrisse nel 1611. Pass poi nel napoletano nel 1620.
In questo secolo, stato gi notato, la malaria, che provoc alcune epidemie, fu descritta dal
Lancisi e dal Torti.
Di tifo petecchiale comparvero epidemie nel 1606, 1628, 1646, 1670.
Le epidemie del 1700 e lultima epidemia dEuropa nel 1815
Le principali epidemie del 1700 furono simili a quelle che avevano funestato gli altri secoli: la
peste bubbonica, che fu particolarmente grave a Marsiglia (1720-21) a Vienna (1712 14) a Mosca
(1789 1811). Da ricordare le epidemie influenzali che infierirono in Europa e in America (Mal del
castrone). Il tifo esantematico provoc unepidemia a Praga e in Italia rispettivamente nel 1741 e
nel 1783. Il tifo addominale (febbre mucosa), descritto da Roederer nel 1762, miet vittime tra
1726 e il 1778.
Oltre ad esacerbazioni periodiche di febbri malariche e di vaiolo.
Il concetto di epidemiologia non muta di molto in questo secolo, anche se prende maggior piede
quello microbiologico dellinterpretazione delle malattie infettive, gi iniziato del 1600.
Lultima epidemia di peste in Italia fu nel 1815, la peste di Noiacataro nel Reame borbonico, da
cui fu colpito lo stesso Gioacchino Murat. Fu descritta da Pietro Colletta, testimone, con toni che
riportavano ai tempi delle grandi epidemie. Fu lultima epidemia dEuropa.
NellOttocento scomparve anche dallImpero ottomano, lultimo stato ad adottare le misure
igieniche in vigore ovunque in Europa.
144
Il colera
Bench il colera possa considerarsi una malattia antichissima dellAsia, la sua identificazione in
India relativamente recente (1325). Il primo cronista europeo la segnal nel 1543 durante
lepidemia di Goa. Il centro endemico lestuario del Gange: nel Bangladesh, Bengala e Calcutta.
Lungo i fiumi in zone a densissima popolazione.
Fino al 1700 non ebbe tendenza a sconfinare dallAsia. Ma con laumento dei mezzi e della
celerit delle comunicazioni, fu possibile la diffusione negli altri continenti. La prima pandemia
europea si ebbe nel 181723, attraverso lAsia minore, il Mar Caspio con linvasione della sola
Russia. Comparve in Italia la prima volta nel 1835. Nel 1841-56 invase lEuropa e anche lAmerica.
Nel 1854 Pacini osserv il vibrione colerico.
Dal 186574 lepidemia origin dai pellegrinaggi alla Mecca.
Nel 188486, dal Tonchino a Tolone per mezzo di una nave da guerra, invase lItalia e lEgitto,
dove R. Koch isol il vibrione (1884). E ancora nel 189293 invase tutta lEuropa, compresa
lItalia.
La prima pandemia del Novecento, 190226, arriv in Europa via terra dalla Russia, e per mare
in relazione ai pellegrinaggi alla Mecca. Arriv in Italia nel 1911 e nel 1915, durante la guerra
mondiale per contatto delle nostre truppe sullIsonzo con soldati nemici infetti.
Ricomparve in Italia nel 1973, in focolai epidemici a Napoli, Bari e in Sardegna con centinaia di
casi e decine di morti. La malattia era probabilmente dovuta al biotipo El Tor del vibrione,
resistente alla Polimixina B. E ancora comparve a Cagliari, nel 1979, con 6 casi.
Il colera ricomparve nella met di ottobre del 1994 a Bari. Allinizio fu ritenuto importato dagli
emigrati dallAlbania dove era endemico. Fu poi trovato nelle acque luride delle fognature: fu
proibito luso del pesce crudo, prima solo a Bari, poi, essendo comparso il colera anche a Torino, e i
casi saliti a 10, anche nel territorio nazionale.
La malattia si trasmette per via orofecale avendo come veicoli acque infette, molluschi bivalvi,
cibi contaminati e, in periodi di epidemia, anche col contatto interumano. Si producono portatori
sani e malati plurisintomatici, possibili trasmettitori dellinfezione. E molto sensibile alla
tetraciclina ed anche al Bactrin e al cloranfenicolo. La tetraciclina 500 mg ogni 6 ore per os, riduce
la mortalit a meno dell 1%.
Pandemie dinfluenza
Le pandemie dinfluenza, ab occulta coeli influentia, si sviluppano ogni una o due generazioni.
Sembra che la prima pandemia europea, riportabile quasi con sicurezza allinfluenza, si sia
verificata nel 1510, cui fecero seguito, nel XVI secolo, altre due pandemie nel 1557 e nel 1580. Nel
secolo XVII si sarebbe avuta la pandemia del 1675, come abbiamo visto, descritta dal Sydenham.
Nel secolo XVIII sarebbero avvenute non meno di quattro pandemie, negli anni 1709, 1730, 1743 e
178082. Nel XIX si sono registrate le pandemie degli anni 1805, 183233, 1847 e quella del 1889
90 che dette inizio allo studio batteriologico della malattia. Nel XX secolo si avuta la pandemia
del 191819 la cui violenza e gravit stata la maggiore che la storia ricordi: ha provocato oltre 50
milioni di morti. Creduta importata dalla Spagna fu chiamata spagnola. Nel 1957, partita dalla Cina
si diffuse in tutti i continenti, lasiatica, e poi, nel 1969 la spaziale, dovuta al virus B Hongkong. I
grandi focolai dorigine sono russi ed asiatici: per lEuropa soprattutto russi. Causa della malattia
un virus di diversi sottotipi, ABC, con grande facilit di mutazioni. Nelle forme pi gravi sono
145
frequenti le complicazioni dovute al bacillo di Pfeifer, streptococchi, pneumococchi. Si realizzato
un vaccino di discreta efficacia.
LE REAZIONI PSICOLOGICHE E CULTURALI
Sul piano psicologico e culturale, le reazioni degli Europei alle gravi pestilenze dei secoli basso
medievali e successivi, furono inizialmente quelle istintive che suscita il terrore della morte: la fuga
e il rifugio nella fede che assicura la continuazione della vita: Fuge longe, cito, tarde redi. Libera
nos, Domine, a peste Parce nobis. Chi poteva, fuggiva i luoghi malsani al pi presto e vi tornava
il pi tardi possibile; quando lira di Dio, per i peccati, era calmata dalle preghiere e dalle
espiazioni.
Col tempo le reazioni allangoscia generale si configurarono in liturgie collettive: riti espiatori e
penitenziali, preghiere, processioni.
Sorsero congregazioni di penitenti, di flagellanti. Specie in Germania, dove queste confraternite
rifiutavano ogni autorit, sia della Chiesa che dello Stato, con rituali talmente violenti che, stando
alle cronache, rappresentavano poco meno che suicidi dei partecipanti. La Scuola della S.S. Trinit
di Loreo, tuttora esistente, ne potrebbe essere un esempio e un ricordo.
Talora aggredivano gli Ebrei, ai quali imputavano la diffusione della peste.
Alcuni danno molta importanza alle pestilenze quali concausa dellaffermarsi delle lingue
nazionali, vernacolari, sulla lingua latina, propria degli uomini colti dellEuropa occidentale: la
mora dei chierici e dei maestri che soli conoscevano quella lingua e che ne consentivano luso
universale. Anche la pittura ne fu influenzata: la Danza della Morte divenne un tema frequente,
assieme a scene macabre.
La constatazione della precariet della vita e della catastrofe arbitraria, casuale, scosse la fiducia
nella filosofia tomistica di un ordine razionale e provvidente. Spinse verso il ritorno a qualche
forma di filosofia pagana, alledonismo, carpe diem, al fatalismo. Cos reagirono i rifugiati nelle
colline di Fiesole del Decamerone.
Molto pi diffuso e popolare fu un nuovo empito di misticismo: intima e personale unione con
Dio al quale elevarsi, sublimarsi in contemplazione, estraniandosi dalle brutture del mondo; totale
rifugio nella divinit, unica salvezza e sicurezza. Tutte le religioni istituzionali, cattolica, ortodossa,
protestante, aderirono a questa forma di espressione religiosa, pur controllandone gli eccessi.
Linadeguatezza dei riti propiziatori e liberatori, come delle misure igienicheamministrative
verso il dilagare delle pestilenze, ebbe effetti sconvolgenti. Nel XIV secolo morirono molti
sacerdoti e monaci, e i loro successori erano meno preparati a far fronte a un gregge pi critico di
fronte agli interrogativi pressanti della morte e della giustizia divina. Ne consegu una diminuzione
della fede nelle credenze predicate dal clero e, in definitiva, anche unavversione verso di esso.
Lanticlericalismo si fece pi aperto e diffuso dopo il 1348, inizio della grande peste nera che
squass lEuropa. Lavversione al clero sar la base del successo che, in seguito, avr Lutero.
I riti, le cerimonie, i simboli si mantennero uguali per secoli. Ma con la Controriforma,
nellambito della generale riscossa del cattolicesimo, si potenziarono i simboli di lotta contro le
pestilenze. Uno dei principali rituali fu conservato: quello dellinvocazione a San Sebastiano, come
allinizio del Cristianesimo. Le frecce che trafissero il santo ricordano le frecce di Apollo con le
quali poteva colpire gli umani (vedi le divine quadrella dellIliade). La figurazione di San
Sebastiano cominci a comparire nellarte sacra.
Unaltra figura ebbe molto rilievo quale protettore contro la peste, fu quella di San Rocco che,
come accennato, si distinse per la carit nellassistenza durante la peste di Lombardia (1301).
Anchegli entr nelliconografia sacra: non poche chiese hanno altari o statue del santo, ormai quasi
ignoto alla devozione dei fedeli.
Il protestantesimo non svilupp rituali contro le pestilenze, sia per la minor frequenza di episodi
epidemici, sia per le caratteristiche dottrinali della Riforma.
146
Contrariamente allorientamento della Chiesa, che cristallizz i rituali sulla fede nel concetto di
peccato e conseguente castigo - pestilenze e quindi perdono e penitenza -, i governi delle Cittstato
europee, specie italiane (Venezia) e germaniche, opposero alle pestilenze misure igieniche, come
quarantene, lazzaretti, distruzione di masserizie, lotta al contagio, seppellimenti, controlli doganali,
anche se scarsamente efficaci. Contribuirono per al cambiamento del costume e dello stile di vita
in senso laico. Un vigore civile, che dal 1350 al 1550 fece nascere e prosperare il Rinascimento.
In questo periodo inizi uneconomia di mercato interregionale, integrata tra le varie Cittstato
europee.
NellIslam
La reazione alla peste e alle malattie infettive, note in Arabia fin dai tempi di Maometto, fu (o
divent) quasi passiva. Queste sono le parole del Profeta: Quando vieni a sapere che un paese
colpito da una malattia epidemica, non andarci; ma se ci seinon lasciarlo. Colui che muore per
una malattia epidemica un martire: una punizione che Dio infligge secondo il suo volere.
Le misure igieniche dei cristiani erano viste con ironica sufficienza, e come tentativo di sfuggire
al volere di Allah.
Le pestilenze e la scoperta dellAmerica
Dal punto di vista del microprarassitismo le civilt amerindie, nel periodo precolombiano,
possono essere paragonate a quelle degli antichi Sumeri ed Egizi. Le malattie di cui parlano i codici
aztechi potrebbero essere interpretate come correlate a perdita di raccolti e a carestie, e non dovute
alla catena epidemiologica delle infezioni del Vecchio mondo. I vecchi amerindi raccontavano che
non ricordavano malattie prima dellinvasione dei bianchi.
Pi di mille anni prima la popolazione divenne abbastanza densa, in Messico e in Per, da poter
mantenere catene dinfezioni trasmissibili da individuo a individuo. Sembra per che non vi si siano
potute stabilire; forse perch gli animali addomesticabili non erano portatori dinfezioni
trasmissibili alluomo.
Sembra che le popolazioni amerindie dellepoca precolombiana assommassero a circa 100 milioni
dindividui, di cui 2530 milioni in Messico. Meno di cinquantanni dopo dalla conquista di Cortes,
nel 1568, nel Messico si potevano contare, tra Indii ed Europei, solo tre milioni di abitanti. Nel
1620 erano scesi a 1.600.000.
Del drastico calo delle popolazioni amerindie dopo il contatto con gli Europei, fu maggior causa il
microparassitismo importato, con le conseguenti malattie infettive, in forma di gravi epidemie.
Il primo incontro con le malattie infettive degli Europei fu nel 1518, quando il vaiolo raggiunse
Hispaniola, da cui poi si spost verso il Messico, dove arriv Cortes nel 1520. Una esplosione di
vaiolo piomb sugli Aztechi vincitori; la loro apatia glimped di sfruttare la iniziale vittoria
sullesigua banda di Spagnoli.
Similmente accadde nella spedizione degli avventurieri di Pizzarro contro gli Incas del Per, che
praticamente non opposero resistenza allavanzata del conquistatore (1525 26).
Di fronte a tali eventi, Spagnoli e Indiani, furono daccordo nel giudicare che la malattia
epidemica era una punizione divina. Anche tra gli Indiani cera la credenza che le divinit erano
spesso irate contro gli uomini.
Gli Spagnoli, cattolici, credevano naturalmente alla punizione divina delle malattie. Prevalse lidea
tra i due popoli, che, se le divinit preferivano gli Spagnoli, questi godevano della protezione di un
Dio superiore. Il Dio di maggior potenza, infatti, proteggeva gli Spagnoli contro il vaiolo, verso il
quale erano pi resistenti degli Indiani, vergini a tale malattia.
147
In effetti gli Indiani divennero del tutto succubi dei bianchi, che finirono per aver la meglio
nonostante il loro esiguo numero e le brutalit del comportamento. Anche per questo, forse, si
convertivano in massa, docili agli ordini dei sacerdoti, vicer, proprietari terrieri, imprenditori
minerari, esattori: di chiunque alzasse la voce e avesse la pelle bianca.
Ai disastri del vaiolo seguirono quelli del morbillo, nel Messico e nel Per (153031) e nel 1546
del tifo. Gli amerindi avevano assimilato le malattie del Vecchio mondo. Ci fu confermato con
lepidemia dinfluenza, scoppiata in Europa nel 1556 che colp lAmerica nel 1558 59.
Anche nelle terre scarsamente popolate sia del Sud che del Nord dellAmerica, le epidemie
probabilmente preesistettero allarrivo degli Europei. Cos si ha notizia di una epidemia non ben
definita che colp la Nuova Scozia nel 161617 e spazz via larea della baia di Massachusetts.
La divinit, si pu dire, aveva spianato il cammino dei Padri Pellegrini che, tre anni dopo,
iniziarono la colonizzazione del Nord (1620). E nel 1633 unepidemia di vaiolo apparve
confermare, con la differente mortalit, che la Divina Provvidenza stava con gli Inglesi contro gli
Indiani.
Nelle zone tropicali del Nuovo mondo, si stabilirono almeno alcune delle malattie africane: la
malaria e la febbre gialla. Ci avvenne mediante ladattamento di alcune specie di zanzare al
plasmodio, o col trasferimento delle zanzare del vecchio mondo al nuovo (anofeli).
La febbre gialla si manifest la prima volta nel 1648 contemporaneamente nello Yucatan e
nellAvana. Il relativo ritardo dellarrivo in America della febbre gialla, probabilmente, fu dovuto al
tempo necessario, per l Aedes Aegypti, per trasferirsi a bordo di recipienti dacqua delle navi,
dallEuropa allAmerica. La febbre gialla mieteva vittime ugualmente tra gli amerindi e tra i
bianchi; anzi da questi era ancor pi temuta della malaria. Yellow Jack, comera chiamata,
terrorizzava i marinai durante i lunghi viaggi, specie nei Caraibi, dove poteva manifestarsi pi
facilmente per il clima molto adatto allo sviluppo della zanzara nei barili dacqua dolce delle navi.
Con landar del tempo le malattie infettive dei due continenti si omogeneizzarono e assunsero
carattere endemico.
Le nuove malattie in Europa
Nellesercito, che alla guida di Carlo VIII invadeva lItalia verso Napoli, scoppi nel 1494 una
epidemia di Sifilide. I soldati, congedati dopo la campagna dItalia, diffusero la malattia in ogni
parte. Venne considerata una malattia nuova, arrivata in Europa con i marinai di Colombo di ritorno
dalla spedizione: una specie di saldo rispetto alle malattie che gli Europei avevano trasferito nel
Nuovo Mondo.
Come malattia distinta e ben riconoscibile fece la sua comparsa nel 1490 il Tifo esantematico,
anchesso malattia nuova per lEuropa. Portato in Spagna dai soldati che avevano combattuto a
Cipro: dalla Spagna allItalia e in tutta lEuropa; colpiva soprattutto le popolazioni misere,
pidocchiose: eserciti, prigioni, ospizi. Durante la Prima guerra mondiale (191518) fece circa 23
milioni di vittime (Zinsser).
Unaltra malattia nuova apparve in Europa nel 1485 e scomparve, misteriosamente, dopo il 1551.
Fu il cos detto Sudore anglico, con sintomatologia simile alla scarlattina, che portava spesso a
morte. I sopravvissuti, nella fase terminale, cadevano in un profuso sudore. Si manifest soprattutto
in Inghilterra. Non ebbe conseguenze sulla popolazione dellEuropa continentale.
Singolare lepisodio dellinterruzione precipitosa del colloquio tra Lutero e Zwingli
sullEucaristia che sanc la frattura della Riforma luterana da quella calvinista, a Marburgo nel
1529. Il colloquio fu interrotto dal timore dellinfezione che provocava terribili sudori.
Unepidemia, forse, influenz il corso della Storia.
148
La trasformazione degli effetti del microparassitismo
Abbiamo visto che con landar del tempo il microparassitismo tese ad omogeneizzarsi in Europa e
nel mondo, America e Asia. Non solo, ma le malattie che producevano epidemie, a breve scadenza
si andavano trasformando in malattie infantili, e la mortalit infantile era facilmente riparabile.
E le stesse infezioni, che generavano epidemie, diventavano endemiche in varie zone, con
manifestazioni pi attenuate e di minor numero: pi tollerabili dalla popolazione, che quindi non
subiva gravi perdite numeriche. Ci si manifest tra il 1500 e il 1700.
Queste trasformazioni dellespressione del microparassitismo, assieme alle misure igieniche
adottate dalle nazioni Europee, prima tra le quali dalla Repubblica di Venezia, furono, tra le altre, la
causa del costante aumento della popolazione in Europa e nel resto del mondo.
Aumento della popolazione
Unaltra causa importante dellaumento della popolazione, fu la diffusione in tutto il mondo della
coltura delle piante trasportate dallAmerica: patate, mais, pomodori, peperoncini rossi, arachidi e
manioca, che rendevano molte pi calorie, per unit coltivata, rispetto alle abituali colture. Erano
inoltre ricche di vitamine essenziali, quali la Vitamina C, la cui mancanza era responsabile dello
scorbuto, malattia che mieteva numerose vittime specie tra i marinai.
Una terza causa contribu, paradossalmente, allaumento della popolazione: linvenzione, e luso
in guerra del cannone. Arma nuova, solo delle grandi potenze che disponevano del potere
economico per procurarsela e poterla usare. Ci contribu alla concentrazione del potere in pochi
Stati: imperi della polvere da sparo: i Ming, i Manci, i Mogol, Tokugawa, i Moscoviti, gli
Spagnoli e i Portoghesi.
Diminuirono le guerre locali e le conseguenti razzie e depredazioni da parte degli eserciti sulla
popolazione, sia dei vinti che dei vincitori. Ad iniziare dalla seconda met del secolo XVII (1650)
aument il livello di pace pubblica.
Nellattuale era nucleare, con il concentramento del potere in poche Grandi Nazioni, o alleanze
di Nazioni super-armate, le grandi guerre sembrano impossibili per il rischio insito di una totale
distruzione della Terra; persistono tuttavia numerosi focolai di guerre locali.
149
CONCLUSIONI
Il nostro excursus arriva alle soglie del 1700, quando sotto limpulso della nuova cultura
rinascimentale e lapporto fondamentale del 1600, soprattutto per lopera e il pensiero di Galileo,
lUmanit entra in una nuova era: lEra della Scienza.
Lintuizione del contagio e lipotesi di animaletti che potevano trasmettere le malattie infettive,
come aveva insegnato nel 1546 Fracastoro (1479?1553), e la rottura degli schemi galenici da parte
di Paracelso (14931541) con lintroduzione delluso e sperimentazione di nuovi farmaci, furono
preceduti dalla cultura che aveva superato i tradizionali schemi filosofici della pura speculazione, a
favore della cultura dellesperienza e dellesperimento.
Anche i precetti religiosi e i tab tradizionali, pur talvolta cnsoni con i consigli delligiene, si
erano dimostrati talora inutili e anche dannosi (pellegrinaggi dei mussulmani, e degli Ind con i
bagni in comune nel Gange).
Lesperienza aveva dimostrato lefficacia dei lazzaretti, delle quarantene, della distruzione col
fuoco degli effetti personali, della pulizia della persona e degli ambienti, nel diminuire la frequenza
e lintensit delle epidemie di peste.
Pi tardi si comprese limportanza dellinoculazione del vaiolo per lattenuazione della malattia
stessa. Se ne fecero propagatori i monarchi: Caterina la Grande di Russia (1768), Federico II di
Prussia nel 1775, dopo la morte per vaiolo di Luigi XV, Giorgio Washington nel 1776. E, dopo
lintroduzione della tecnica di Jenner (1798), Napoleone nel 1805.
I monarchi delle grandi nazioni erano ben consapevoli che, oltre a possedere i cannoni, avevano
assoluto bisogno di eserciti sani.
Linteressamento di Lady Mary Wortley, deturpata dallinoculazione vaiolosa nel suo bel viso, e le
vittime di vaiolo nelle case regnanti, indussero la Royal Society a indirizzare la medicina in senso
rigorosamente scientifico: nacque la Medicina organizzata e la promozione di Congressi
Internazionali per lo scambio di informazioni.
Le misure igieniche e la vaccinazione jenneriana (oltre agli, ignorati, adattamenti ecologici),
trasformarono il regime delle malattie infettive. Le espressioni epidemiche si trasformarono in
forme endemiche di malattia, con esacerbazioni di casi sporadici. Divenne sempre pi raro che una
persona in pieno vigore soccombesse rapidamente allattacco di una malattia inesorabile.
La coscienza che tutto ci era avvenuto per lintervento delluomo, della ragione, dellintelligenza
umana, prospettava lidea che luomo pu modificare la Natura prescindendo dallopera della
Divinit
Un importante cofattore dellaumento della popolazione nel 1700 fu la cosiddetta Rivoluzione
industriale, iniziata in Inghilterra e poi diffusa in Europa e in America. Si ebbe un incremento della
mano dopera operaia, e quindi la necessit di nuove braccia e, conseguentemente, laumento dei
mezzi di sostentamento alimentare.
Nasceva contemporaneamente la Nuova Agricoltura, con luso di macchine agricole ad energia
meccanica, limpiego dei fertilizzanti, la selezione delle sementi, e limpiego di nuovi mezzi di
immagazzinamento e di conservazione del cibo.
Il cambiamento di maggior rilievo fu labbandono della coltura a maggese, e la conseguente
maggior estirpazione di erbacce e linizio della coltura dellerba medica (Medicago sativa). La sua
coltivazione aument di molto la produzione di foraggio per il bestiame: bovini, ovini soprattutto. E
con questo aumento di animali domestici si ebbe maggior quantit di carne per lalimentazione.
Laumento dei bovini ebbe come conseguenza indiretta la diminuzione della malaria: i bovini,
infatti, non recettivi della malaria, offrivano animali da pungere e da succhiare alle anofeli infestate
dal plasmodio della malaria.
150
Anche luso dei recinti delle mandrie e gli ovili contribu alla diminuzione del microprassitismo,
impedendo la mescolanza e la trasmissione di microparassiti tra i capi di bestiame che divenne
quindi pi sano e di conseguenza meno infettante per luomo.
La malaria tuttavia dovette aspettare lavvento del D. D. T. (Dicloro Difenil Tricloroetano) che
distrusse praticamente tutte le zanzare portatrici di plasmodio. Per altro creando squilibri ecologici e
inquinamento chimico, e soprattutto selezionando zanzare DDT- resistenti.
Nel 1854, un medico londinese, John Snow, dimostr inequivocabilmente come i casi di colera
erano dovuti allinquinamento di ununica fonte idrica di approvvigionamento. E fu confermato ad
Amburgo nel 1892, quando il colera colp un unico lato di una strada le cui abitazioni erano
collegate ad una fonte diversa da quella dellaltra strada collaterale, collegata ad altra fonte.
Era posto il problema dellapprovvigionamento idrico.
Nel 1840 Edwin Chadwick concep lidea del sistema fognario dinamico, in senso moderno:
linstallazione generalizzata di tali fognature, per, dovette attendere il XX secolo per la sua
integrale e non sempre totale realizzazione.
Nel XX secolo si sono scoperti i disinfettanti chimici, indispensabili alla disinfezione e alla
disinfestazione.
Come conseguenza di queste scoperte e provvedimenti si ebbe un costante aumento della
popolazione mondiale.
Nel 1850 era di 1 miliardo
1950 2, 5 miliardi
1970 3, 6 miliardi
1976 4 miliardi
1994 5, 66 miliardi
1998 6 miliardi
2005 6,5 miliardi.
Il costante aumento della popolazione mondiale pone gravissimi problemi allintero pianeta:
in relazione alla possibilit di reperire le risorse alimentari ottimali per tutti, e in relazione alla
possibilit di rottura di equilibri microparassitari consolidati. Ma soprattutto per il fatto che
laumento si verifica in continenti e subcontinenti meno sviluppati economicamente, mentre le
nazioni pi ricche tendono a ridurre la loro popolazione. Ci creer inarrestabili correnti migratorie,
con tensioni sociali e mescolanza di microparassitismo, e possibile sviluppo di malattie infettive.
Non solo, ma sar la premessa per possibili conflitti tra nazioni ricche e nazioni povere: quando lo
sfruttamento del macroparassitismo sar spinto al limite della sopportazione dei paesi poveri, che ad
un certo punto si ribelleranno, quali che possano essere le conseguenze per loro.
I possibili conflitti saranno di potenziale distruzione quasi totale del pianeta: guerre nucleari,
guerre microbiologiche.
Si sta tentando il controllo delle nascite, con scarso risultato: la popolazione della Cina in
continuo aumento.
Saltuari squilibri microparassitari fanno temere possibili insorgenze di malattie infettive
generalizzate, nonostante lattento isolamento del germe e il rigoroso controllo igienico.
Microparassitismo e macroparassitismo saranno ancora le forze che regoleranno il progresso
dellumanit.
151
LA MEDICINA POPOLARE
Con questo capitolo la nostra Storia torna alle origini.
Alla medicina teurgica (sacerdotalestregonesca) e alla medicina magica, intesa come scienza
empirica, protoscientifica.
Dallistintiva concezione dellesistenza di forze del Bene e di forze del Male, nacque nelluomo
primitivo lidea di propiziarsi le forze del Bene e di combattere le forze del Male.
Sacerdoti e Stregoni a propiziare la salute (forze del Bene), e a scacciare la malattia (forze del
Male), e Magi, a influire con i mezzi della Natura sulle malattie, come intermediari, dotati di
particolari virt.
Proponiamo il seguente Schema.
Sacerdotale - Religiosa
MAGIA BIANCA
(Pranoterapia)
TEURGICA
Stregonesca
MAGIA NERA
MEDICINA POPOLARE
EMPIRICA Erboristeria
(Agopuntura)
(Omeopatia)
Volendo tentare di ridurre a comun denominatore, per quanto possibile, il pensiero primitivo che
sottost a tutta la medicina popolare, demoiatrica, si pu ricondurre la razionalit primitiva che la
informa, ai seguenti principi, presenti fin dallinizio della Storia della medicina.
La legge di simpatia per cui il simile attira il simile. Principio accettato anche da Empedocle e
dalla medicina antica, oltre che essere alla base dellOmeopatia: similia similibus curantur.
Il Principio del contatto secondo il quale una cosa che sia stata a contatto con una persona, rimane
in relazione con essa cos intima e vitale, che qualsiasi azione si compia sulla cosa, si ripercuote
sulla persona. Oppure una sostanza che viene a contatto con unaltra vi lascia il segno: vi lascia la
sua potenza. E il principio della segnatura, invocato, anche questo, per spiegare lattivit, nell
Omeopatia, di certe soluzioni seriali, dove ormai non resta neppure una molecola di sostanza.
La legge dei contrari, analoga al principio di similarit: contraria contrariis curantur: i contrari si
curano con i contrari.
Il Principio di impurit: nelle civilt primitive - ma il principio si ritrova codificato anche dalla
Bibbia -, la malattia vista e vissuta come punizione del peccato che rende il malato impuro: il
suo corpo piagato, corrotto dal male. Allora deve essere lavato, purificato: riti di battesimo, di
lustrazione.
Il Principio dellEroeSemidio. Esistono uomini, prescelti dalla divinit, di cui sono figli
particolarmente amati, che hanno in se stessi dei poteri superiori agli altri uomini, il potere di fare il
Bene e di fare il Male: sono i ministri, gli intermediari della Divinit. Secondo la Bibbia Satana
ministro di JHVE. Il potere fluisce dallimposizione delle loro mani.
Il Principio dellArmonia. Questo principio ci perviene dalle culture orientali (cinesi), basato sul
concetto filosofico dellarmonia tra le essenze fondamentali: Yang eYing (maschile e femminile).
152
La proporzione tra di esse la Salute, la sproporzione, in vari gradi e modi, genera la Malattia.
Ricostruendo la proporzione mediante opportune tecniche (ritrovate nel tempo in modo empirico)
si riproduce la Salute.
LA MAGIA DEL MALE
La magia del Male consiste nellattivit di alcune persone capaci di produrre malattia: lattivit
patogenetica di alcune persone che hanno questa capacit, con laiuto delle forze del Male, del
Demonio, con cui sono in commercio, in stretta collaborazione e dipendenza.
Sono le streghe , strigae, veneficae mulieres, donne venefiche; da strix, uccello notturno,
barbagianni, vampiro, quod horrendo stridere nocte solet (Ovidio, Fasti VI VII 131).
Di esse pieno il Medio Evo: i loro riti misteriosi e diabolici, con convegni nei Sabba notturni,
viaggi sopra le scope dopo lunzione rituale di sostanze deffetto allucinogeno, le loro fatture
malefiche; e i roghi su cui salirono tante innocenti.
Oltre alle streghe possono operare stregoni con le stesse caratteristiche generali, salvo la
partecipazione ai Sabba, prerogativa femminile, dove il Demonio, talora si accoppia con le streghe.
Attorno alla loro figura fiorirono leggende e tradizioni che si perpetuarono fino (quasi) ai nostri
giorni.
La fattura
Per fattura sintende qualunque procedimento basato su concetti di simpatia, similarit e di
contatto, rivolto a scopo di male contro una determinata persona, compiuto da soggetto adatto, con
particolare materiale e particolari cerimonie. La controfattura un processo opposto, basato sugli
stessi principi, diretto allo scopo di disfare lazione maligna della fattura. La fattura, come indica la
parola stessa, implica il concetto di fare qualche cosa, di operare materialmente con oggetti o
materiale appositamente preparato: il grado maggiore di azione maligna. Lelemento profano
sintreccia con quello sacroreligioso con riti di sacrilega profanazione. La fattura pu essere diretta
e indiretta.
La pi frequente fattura indiretta quella per infissione, che consiste nellinfiggere spilli su
fantocci rappresentanti la persona da colpire, anche a morte: si cerca di infiggere gli spilli nelle parti
vitali, il cuore, il petto, il collo. I fantocci sono costruiti con materiale che stato a contatto con la
persona da colpire: capelli, unghie, indumenti, fotografie. Obbedisce alla legge del contatto.
Persiste, specie in certe regioni del meridione; forse scomparsa nelle nostre zone. Si hanno cenni
storici lontanissimi. Platone nella Repubblica vietava luso agli Ateniesi di figurine per fare
malefci, e Orazio descrive, in una satira (Contro Canidia), una cerimonia di stregoneria in cui si
usano due figurine, una di cera, una di lana (658 a. C.).
Con lavvento del Cristianesimo che aveva attribuito tutto il potere spirituale a di Dio
onnipotente, a Ges suo figlio, alla Madonna e ai Santi, si svilupp il sacrilegio, o loltraggio alla
divinit, come mezzostrumento di fattura: fattura sacrilega. Si esalta il potere di Satana,
opponendolo al suo nemico: nascono le Messe nere, con profanazione delle ostie, bestemmie
durante lelevazione. Specie in certe regioni, Piemonte, Romagna sembra in auge il cos detto
satanismo, dietro il quale talora si scoprono veri delitti.
Meritano di essere citate le fatture dei nodi: il nodo costituisce un elemento di primo piano nella
mentalit primitiva: impedisce, lega, danneggia, nuoce. Piume fittamente intrecciate si trovano nei
cuscini, nei piumini di persone oggetto di fattura. Sono stato testimone, da giovane, della visita del
vescovo ad una famiglia che si riteneva stregata: si trovarono nei cuscini nodi di piume intrecciate.
E il vescovo diede la benedizione alla casa et omnibus abitantibus in ea, e a tutti i suoi abitanti
colpiti dalla fattura.
Oltre alle fatture indirette, con materiale di contatto, esistono le fatture dirette, con
somministrazione alle persone di materiali vari: si tenta, secondo il principio di similarit, di
riprodurre nella vittima il carattere nefasto del materiale usato. Come il sangue mestruale, di uso
153
assai antico, nominato fin dal XIII secolo da Pietro dAbano (12501316); serve anche per
confezionare filtri damore. Per le fatture sono usati anche lo sperma e lurina; e le ossa di gatto,
creduto di natura diabolica: far male ai gatti porta male: chi copa i gati, va male i so fati.
Diverso dalla fattura il Malocchio, lazione malefica da un presupposto fluido che emana
dallocchio di particolari persone: pu essere spontaneo e contrario alla volont dellindividuo. E
antico e diffuso. Fin dallepoca egiziana, e poi dai greci e romani si usava come amuleto contro il
malocchio, leffigie di un occhio umano dipinto sul fondo delle tazze, su vasi, sulla prua delle navi,
oppure di terra cotta, oro o argento da portare con s.
La diagnosi di fattura non opera da tutti: necessario che loperatore sia esperto: spesso uno
stregone, capace anche di disfare la fattura. Il sistema pi diffuso lolio e lacqua. Si osserva quali
forme e figure prendano le gocce dolio facendole cadere su una scodella dacqua: se si disperdono
o mantengono la loro figura, allora c o non c fattura o malocchio. Si possono anche far cadere
nellacqua alcuni acini di grano: si osserva se il grano va a fondo o resta a galla.
LA MAGIA DEL BENE
Le persone che hanno il potere di fare il male (streghe, stregoni) hanno anche il potere di fare il
bene, nel senso che sono le sole capaci di fare la controfattura. Streghe e stregoni sono impegnati
nellambigua attivit di fare fatture e controfatture.
Sono quindi attori del bene quelli che disfano le fatture e quelli che guariscono dalle malattie.
Quelli che guariscono dalle malattie hanno ricevuto dalla natura, fin dalla nascita, una virt
particolare, adatta a guarire col tocco o con semplici preghiere, tenute segrete, alcune determinate
malattie, quasi sempre le stesse: eczemi, sciatiche, foruncoli, scrofole, porri. Riconoscono e liberano
dal malocchio, dallinvidia, dallodio. Le persone guaritrici possono esserlo per qualit
individuali: i settimini maschi nati dopo sei maschi, le settimine, femmine nate dopo sei femmine,
le madri di gemelli, le persone nate con la camicia, nate, cio, con il rivestimento del sacco
amniotico, e anche i primogeniti: i primi de mare. Ciascun individuo di queste categorie capace di
guarire col toccamento.
Altri avevano il potere in quanto investiti da particolari dignit o cariche: i sacerdoti, i vescovi, i
re.
I sacerdoti hanno anche la capacit di riconoscere le streghe: mentre pronunciano, alla Messa,
lOrate fratres: le possono scorgere in chiesa, tra i fedeli. I sacerdoti possono fare esorcismi e
liberare gli indemoniati (spesso malati epilettici).
La credenza dei Re guaritori antica, come il concetto SacerdoteRe. Nella Roma imperiale
limperatore era adorato. Romolo e Numa Pompilio avevano poteri di guaritori. Vespasiano guariva
i ciechi, Adriano gli idropici. E nei secoli successivi molti re avevano simili poteri: da Clodoveo a
Luigi IX di Francia; e Macbeth stesso dichiarava di avere tale potere (Macbeth Atto IV scena III).
Abbiamo gi accennato a Carlo X, ultimo re guaritore che nel 1828 procedette al rito del
toccamento di 121 malati.
La Magia del Bene si svolge secondo due modalit: profilattica, cio, difesa dalle streghe agenti
del male, e curativa, atta ad annullare le fatture.
Per difendersi dalle fatture e dal malocchio si usano gli amuleti e i talismani .
Sintende per amuleto qualsiasi oggetto che la credulit popolare, in un dato contesto sociale,
riconosce come apotropaico, capace di allontanare il male ( - . Lat. amoliri =
allontanare)
Come amuleti possono essere considerate le medaglie, un tempo raffiguranti simboli cristiani: la
Madonna, la Croce; ora i segni zodiacali.
Il talismano pi grande dellamuleto, pi evoluto nella storia, quasi oggetto scientifico secondo
le conoscenze della magia. Contiene sempre un elemento grafico: scritti, figure, segni magici su
carta, pergamena o altre sostanze: etimologia (telesma = oggetto consacrato), tilasm,
(arabo), tselem (ebraico).
Gli amuleti, i talismani hanno delle forme particolari, forse conseguenti alla logica elementare
che nei vari popoli e nei vari tempi si creata. Ci sono esempi nelle civilt assira, egizia, romana.
154
Molta importanza nel determinare la forza apotropaica sembra avere la forma degli oggetti.
Molti amuleti e talismani hanno forma a punta, o di superficie forata. Anche la mano e il braccio,
in diverse forme, sono usati come apotropaici
E anche animali, particolari animali o gli organi di animali: locchio, il cuore e soprattutto i
genitali. Agli albori della presa di coscienza del proprio corpo, luomo stato certamente
impressionato dal comportamento dei propri genitali: la forza potente del genitale maschile che si
erige, come unarma, e trafigge, penetra. Lidea del fallo come forza documentata nelle civilt in
tutti i luoghi: le statue della Grecia, le rappresentazioni nelle case di Pompei, il culto di Dioniso e di
Priapo. La rappresentazione dellorgano stesso, la sua forma, oggetto appuntito, corno, evoca la
magia delle punte: chiodi, frecce, forbici, pinzette, cornetti, manine a corna, indici tesi.
Anche il genitale femminile, ha sbito avuto la sua importanza presso luomo primitivo e poi
nelle culture popolari. La vulva, protetta e coperta dalla folta peluria nera, la sua apertura verso un
interno misterioso, occulta forza dattrazione per il maschio, pertugio nascosto da cui pu uscire un
nuovo individuo, assume sicuramente il potere di evocare la figura di simbolo, evidente o nascosto.
Tale pu essere la simbologia delle pietre forate, dellalbero spaccato, del passaggio stretto, delle
valve delle conchiglie.
Degli animali, usati in raffigurazione come amuleti o talismani, utilizzato il serpente, per la sua
forma insinuante e per la sua velenosit; e anche il pesce, gi in era precristiana, anchesso forse per
la sua forma fallica (a Napoli pesce significa pene).
Anche gli organi di animali sono usati, il pi diffuso locchio: lorgano che trasmette e riceve il
fluido attraverso la luce: entit immateriale, divina. Locchio malo (malocchio) pu fare il
male, locchio buono pu fare il bene. Di questi amuleti con locchio ci sono esempi, come gi
accennato, presso gli Egiziani, i Greci e i Romani: vedi le tazze dipinte sul fondo e allesterno, nel
museo degli scavi di Ercolano. Si dipingeva sulle prue delle navi: ancora oggi si possono vedere
cerchi rossi, occhi protettori, dipinti sulle prue dei bragozzi chioggiotti. Diffuse le pietre docchio,
cristalli in cui, per gioco di luce, sintravede nellinterno un punto scuro: locchio.
Anche la mano in vari atteggiamenti ha significato apotropaico. Con la mano si pu riprodurre
lidea del fallo penetrante, sodomizzante: il medio teso; oppure evocare la magia delle punte
facendo le corna.
Con le mani si pu rappresentare la vulva o latto stesso del coito: io ti sottometto, ti domino.
Si pu fare le fiche: digitis medio cum pollice iunctis, a dita unite il pollice tra indice e medio
(Ovidio, Fasti V 433 - 34). E Dante: le mani alz con ambedue le fiche (Inf. XXV, 2). La copula
appunto si pu rappresentare introducendo il pollice tra lindice e il medio di una mano chiusa.
Ugualmente significato di sodomizzazione, riduzione in assoluto potere, ha il gesto
dellavambraccio teso con pugno serrato, piegato ad angolo sul braccio, mentre la mano opposta
preme sul braccio.
Ex voto suscepto, per il voto fatto alla divinit, se mi concede la grazia richiesta, prometto di
portare alla sua immagine un oggetto che abbia legame di significato con la grazia ricevuta. Anche
questa pratica, tuttora in uso nella cultura cattolica, preesisteva al cristianesimo. Si portavano alla
divinit oggetti raffiguranti parti anatomiche guarite, per intervento del dio o della dea pregati.
Ho visto, da giovane, in una cattedrale spagnola molti ex voto, tra i quali, bene scolpito in una
placca dargento un pene, guarito per grazia ricevuta.
Anche lurina, e latto di urinare, sembra che abbiano capacit magiche. Certamente lurina fu
usata come medicamento, vedi Dioscoride, Galeno, gli Arabi e tutto il Medio Evo. E da bambino
minsegnavano che una ferita si poteva disinfettare urinandoci sopra; e faceva guarire le perlches,
le boccarole.
Anche i metalli loro, largento, il rame - furono usati come dotati di virt guaritrici: forse per la
loro preziosit o per la forma degli oggetti. Ho visto, per altro anche ora, gente con un braccialetto
di rame contro i dolori reumatici
155
Anche il ferro ebbe importanza contro le stregonerie, specie se forgiato in forme particolari: a ferro
di cavallo, a forma di chiave, di chiodo. Anche oggi, in alcune case, allentrata c il ferro di
cavallo; e dallaltro lato, magari, limmagine di SantAntonio. Tra i colori il rosso ebbe valore
magico, e forse lo conserva tuttora. I trionfatori romani si dipingevano il volto di rosso, e tuttora
fanno cos i popoli di cultura primitiva. Si mettono fiocchi rossi ai buoi; oggetti portafortuna sono
rossi. Molti santi sono vestiti di rosso: il rosso ha relazione col sangue, con la vita: rosse sono le
bandiere rosse. Mentre il viola sembra avere un significato triste, di penitenza: vedi i paramenti
sacri in quaresima e nelle funzioni funebri.
Anche i gradini hanno avuto un significato apotropaico: le streghe non sono capaci di salire i
gradini. Basta interporre dei gradini per impedire il loro passaggio. E tutte le case avevano il
gradino alla porta: il meale, il meato.
Anche il pane ha rivestito significato di protezione: dopo il Cristianesimo per il sacramento del
pane eucaristico. A Tolentino ho comperato, nei negozi di souvenir, un sacchetto di pane che aveva
toccato la statua del Santo protettore: pane vecchissimo, che assicuravano, come portafortuna.
A scopo di protezione contro le malattie e contro le stregonerie si usavano i brevi, piccoli
sacchetti di tela contenenti santini, immagini religiose, pezzi di stola: si portavano al collo; ne ho
visti indosso a donne.
La magia delle erbe
Da sempre lantico arsenale medicamentoso fu composto da erbe. Non sempre chiaro quanto,
nelluso di esse, sia stato o sia dovuto al loro effetto magico o al loro effetto terapeutico.
Sicuramente significato magico avevano le piante coltivate in epoca romana, sulle finestre o lasciate
crescere spontaneamente sui tetti: avevano la capacit di tenere lontani gli spiriti del male dalla
casa. Anche fascetti di rami posti alle porte delle case, delle stalle. Ora si adopera il vischio di
Natale e capodanno e lulivo di Pasqua. La ruta, presso i Romani, aveva capacit antistregonesche.
Chiss se la ruta posta in certi liquori non rifletta lantica credenza, e se i vasi ai davanzali non
ricordino le antiche credenze. Tra le piante, lincenso ha sempre avuto significato protettivo: in
epoca precristiana bruciato agli angoli delle case, e in epoca cristiana, fino ai nostri giorni,
cristallizzato, nella liturgia cattolica e ortodossa. Da ricordare la mandragora, erba velenosa delle
solanacee, con fiori bianchi, foglie seghettate e grosse radici dalle quali si estrae un complesso
alcaloideo ad azione atropinica, conosciuta e impiegata fin dallantichit: ricordata dal Genesi
(30, 1420). Attorno alle sue propriet, forse legate alle forme antropomorfe delle sue radici,
fiorirono leggende, e rituali nella raccolta; e fu materia di letteratura (Boccaccio, Machiavelli).
La magia del nodo
E un concetto ambiguo: nodo significa legare, impedire, sia il male che il bene. Forse il concetto
fu rafforzato dalla cultura cristiana sul potere di Cristo dato agli apostoli (e quindi al Papa ai
vescovi e sacerdoti) di sciogliere e legare. Da noi, una volta, si legavano le febbri. Mia madre mi
raccontava che, da bambina, lavevano accompagnata, allalba, camminando allindietro, fino in
aperta campagna, sotto il tronco dun albero dove lavevano legata con le strope, ritortole di salice.
La persona dotata di potere diceva la formula: freve terzane / freve quartane / brute putane / ve
ligar chi. Dopo bisognava ritornare camminando sempre allindietro. Le febbri spesso sparivano:
la malaria, si sa, ha andamento ciclico.
Alla magia dellacqua possiamo in qualche modo riportare le benedizioni con lacqua santa:
purificatrice, lustrale, precedente alla civilt cristiana. Per guarire dalla magagna, un fortissimo
dolore alla regione frontale sopraorbitaria (nevralgia del trigemino superiore), bisognava bagnarsi
con lacqua corrente dellAdige, aspergendosi pi volte, per due o tre giorni: aqua corra / la
magagna porta via. Spesso gli accessi sparivano: accessi, appunto, saltuari.
La magia dellolio
Oltre al significato magico (unzione del Re e dei Sacerdoti), ha rivestito anche un significato
terapeutico: fu il cardine di una particolare medicina. Il Buon samaritano unge le ferite con olio e
vino. L'unzione con olio agli infermi affermata negli Atti degli Apostoli, e nella la tradizione
156
cattolica rimane un Sacramento: un tempo chiamato Estrema unzione, oggi Unzione degli
infermi. Nella tradizione popolare lolio si perpetua come mezzo guaritore di ogni male, dalla
fattura e dal malocchio.
Lolio era usato anche nelle pratiche di Segnatura. Si segnavano i malati di talune malattie: la
persona che ne aveva la facolt, procedeva a segnare con lolio (o anche talvolta col carbone) la
parte malata, biascicando delle preghiere in latino storpiato, pezzi di Pater noster con Ave Maria, in
modo incomprensibile. Si segnavano la risipilia, leresipela, el molton, gli orecchioni (la parotite
epidemica), el simioto, probabilmente stato anemico con pallore e magrezza da carenze vitaminico
alimentari in soggetti microcitemici: tutti bambini.
La magia della morte
Questo concetto sinquadra nellimpurit della morte, rappresentata dal cadavere, materiale in
decomposizione, usato per le fatture.
Per la legge dei contrari si pu spiegare il teschio e lo scheletro come portafortuna, tuttora in uso.
Scheletri erano anche raffigurati nelle coppe di libagione dei Romani.
Con tale significato, inconscio, erano forse usati i teschi e gli scheletri nei labari delle Brigate Nere
della Repubblica Sociale: portafortuna o sfida alla morte.
157
SANTI TAUMATURGHI
Nellevoluzione storica i Santi, per cos dire, hanno sostituito gli dei e le dee del paganesimo nella
protezione degli uomini e dei loro beni. Il Santo lintermediario tra Dio e luomo, per mezzo di
Ges, uomo Dio: nella cultura popolare, ma anche secondo linsegnamento della Chiesa. Il fatto
di possedere il potere di guarire gli infermi un tratto distintivo degli inviati di Cristo : caccerete
i demoni, guarirete gli infermi: in ci vi riconosceranno miei discepoli.
Al Santo si chiede sempre di fare il Bene e di vincere il Male: fare grazie e togliere malattie.
Molto spesso, nel corso della storia, il culto dei Santi cristiani ha preso il posto, anche
logisticamente, di quello dei corrispondenti protettori dei pagani. Il celebre tempio di Epidauro,
dedicato ad Esculapio, continu ad essere frequentato luogo di cura, dedicato allArcangelo S.
Michele dopo lEditto di Teodosio (392), e pi tardi ai Santi Cosma e Damiano. A Menuthis
esisteva un antro dove profetava un oracolo molto frequentato, ad esso andavano sia pagani che
cristiani. S. Cirillo (Concilio di Efeso, 430) fece trasportare con gran pompa, in quel luogo, i corpi
di due martiri, San Ciro e San Giovanni.
Anche sorgenti e fonti dacque avevano capacit curative, da sempre, nei tempi precristiani e con
il Cristianesimo: prima in forza degli dei poi in forza di Cristo e per intercessione di Maria e dei
santi. Sono famose le fonti di Lourdes.
La fantasia astrologica conserv il suo valore magico, legato al principio della similarit,
nellattribuire importanza al momento della nascita sul futuro carattere dellindividuo: il nato sotto
il segno del Toro aveva carattere forte, potente; e cos le altre Costellazioni influenzavano (e,
secondo molti, influenzano!) il destino dei nati sotto il loro influsso. Vedi gli amuleti astrologici
portati al collo, invece dei Santi e della Madonna. Sappiamo, invece, che il destino del neonato
dipende dal suo DNA e dallambiente in cui vivr.
Lentamente, negli anni, a mano a mano che la muova religione pervadeva le masse, agli Dei
subentravano i martiri, Santi cristiani, anchessi protettori contro le malattie; e anche, inizialmente,
con lo stesso frasario sibillino oracolare, e lincubazione: il sogno profetico che rivelava la natura e
la cura del male, come nella medicina dei Templi.
Ogni Santo, guaritore di una malattia, aveva una relazione biografica, di martirio subto, con la
malattia che doveva guarire, secondo il concetto di simpatia.
SantEustorgio guarisce il mal di testa: fu decapitato. Santa Apollonia guarisce dal mal di denti: fu
martirizzata con lo strappamento dei denti. E anche protettrice dellOrdine degli odontoiatri.
SantAgata era protettrice delle mammelle e della lattazione: fu martirizzata con il taglio delle
mammelle.
Santa Lucia, non centra, come si crede, con lo strappamento degli occhi: raffigurata anche oggi
nei reparti oculistici con gli occhi sul piatto. E pi probabile la rassomiglianza del nome Lucia con
luce degli occhi. San Sebastiano il protettore degli appestati: ucciso a colpi di frecce, come
frecce erano gli influssi celesti che mandavano le pestilenze. E Apollo, nella civilt greca, era il dio
che mandava le frecce della peste: nellIliade Apollo manda le divine quadrella nel campo acheo
perch il suo sacerdote aveva ricevuto offesa. Spesso liconografia che opera le trasformazioni
paganocristiane. Contro le pestilenze era efficace anche San Rocco che in vita assistette gli
appestati. Inoltre, sembra che dalla prigione dove giaceva, vittima di uningiustizia, vide cadere
dallalto un foglio che, a caratteri doro, diceva: a coloro che soffrono la peste sarai patrono.
Guarisce anche dalle ulcere: le brose de San Roco. San Biagio era invocato (e forse ancora) per il
mal di gola: aveva infatti guarito un bambino da una lisca di pesce conficcatasi in gola. E il 3
febbraio si riceveva e in alcune comunit ancora si riceve - la benedizione per intercessionem
Beati Blasii confessoris liberet te a malo gutture. Contro le ustioni non cera di meglio che San
Lorenzo, morto sulla graticola. Per le malattie della pelle, specialmente le eruzioni erpetiche
particolarmente dolorose dette Fuoco di SantAntonio specialista SantAntonio Abate. E anche
158
protettore degli animali: lo si vede spesso raffigurato contornato da vari animali domestici, e un
fuoco accanto.
SantAntonio da Padova dispensa tredici grazie al giorno: gli si recita la Tredicina per chiedere
i miracoli, e il ritrovamento delle cose perdute: Si quaeris miraculares perditasCerano donne
che sapevano il Siqueri, e lo dicevano, a richiesta, per trovare le cose perdute.
Santa Rita da Cascia la santa degli impossibili: quando non si poteva far pi niente, nei casi
disperati, si ricorreva alla sua protezione e intervento.
Per il cuore andava bene SantEleuterio: sembra che abbia guarito da extrasistoli Papa S. Giorgio.
La specialit di alcuni santi legata al loro nome. SantAureliano, infatti, cura il mal dorecchi:
Aureliano deriva da aures, orecchi. SantAgostino, in terra di lingua tedesca guarisce il male degli
occhi: Auge. Per non dire di SantEspedito che favoriva speditamente, sollecitamente, ogni affare, e
in virt della rima, faceva trovare marito.
Nulla di irriverente in questa storia di medicina popolare, sempre esistita, prima e dopo il
Cristianesimo.
Di recente San Luigi Gonzaga stato proclamato da Giovanni Paolo II protettore dei malati di
AIDS: San Luigi era vergine; conferma il principio contraria contrariis.
Con questo ultimo capitolo siamo tornati allinizio della nostra Storia della Medicina: alle origini,
alla preistoria, alla Medicina primitiva, Teurgica (sacerdotale-stregonesca), alla medicina Magica,
intesa come conoscenza empirica, protoscientifica.
Di seguito abbiamo esposto la Storia della medicina, dalla filosofia della natura presocratica alla
medicina pre-razionale fino ad Ippocrate. La Medicina di Roma, con Galeno, la Medicina del
Medio Evo, la Scuola salernitana, gli Arabi, le Universit fino al Rinascimento, al Metodo
scientifico di Galileo, e via via alla scoperta dellAnatomia e della Fisiologia, fino alla Medicina
scientificosperimentale; il concetto microbiologico. Il Positivismo, lAnatomia patologica fino alla
Biochimica, alla Neuropsicologia, alla Genetica.
A parte abbiamo trattato delle Pestilenze, del microparassitismo e del macroparassitismo quale
presupposto dello sviluppo ed evoluzione del genere umano.
Sempre abbiamo cercato di seguire, nelle varie tappe delle scoperte, il filo rosso del vero progresso
delle conoscenze scientifiche, tra false nozioni ed errate teorie, col confronto del metodo scientifico
sperimentale statistico che segna il vero progresso fino agli attuali traguardi.
Le teorie scientifiche sono vere fino alla dimostrazione della loro falsit: la Scienza progredisce
per successivi errori. Socrate sapeva di non sapere, ora la Scienza sa che, tra infiniti casi, la
probabilit prevede i miracoli: meraviglia inspiegabile. Lirrazionale, tuttavia, non pu sostituire
la Ragione che illumina la Scienza e la Tecnologia verso la promozione dellUomo in continua
evoluzione.
159
INDICE
DALLA PREISTORIA ALLA STORIA..1
LA MEDICINA PRIMITIVA..4
DOCUMENTI DELLA MEDICINA PRIMITIVA.5
LA MEDICINA DELLE CIVILTA ANTICHE 5
La medicina ebraica ..5
La medicina assiro-babilonese .6
La medicina indiana 6
La medicina cinese ..6
La medicina iranica .7
La medicina egiziana ..7
La medicina del mondo preellenico 7
FILOSOFIA DELLA NATURA PRESOSCRATICOPLATONICA ..8
Platone ...9
La medicina nei Templi ..9
La medicina protoscientifica, prerazionale..10
La scuola siciliana 10
Empedocle.. 10
La scuola di Crotone.11
Alcmeone.11
La scuola di Cnido11
La scuola di Coo...12
IPPOCRATE...12
La medicina razionale di Ippocrate..13
I principi della medicina ippocratica13
Gli Aforismi 15
La scuola dogmatica..16
Aristotele e il mondo culturale alessandrino.17
Aristotele.17
La scuola alessandrina 18
Erasistrato...18
Erofilo..18
La scuola empirica19
Eracleide di Taranto..19
La medicina preromana, etrusca..19
LA MEDICINA IN ROMA.20
La medicina autoctona italica ..20
La medicina domestica.20
Catone.20
La medicina ieratica.20
Periodo di transizione..21
160
Arcagato..21
LA MEDICINA DELLE SCUOLE DELLA ROMA IMPERIALE..21
La medicina nella fase pregalenica.21
La scuola metodica.21
Asclepiade.21
Sorano dEfeso.22
La scuola pneumatica.22
La scuola eclettica .22
Archigne.22
Lenciclopedismo.22
A. CORNELIO CELSO23
CAIO PLINIO SECONDO24
Dottrinario della medicina in Roma prima di Galeno24
La medicina nella fase galenica.26
GALENO.26
La medicina nella fase postgalenica..28
Gli ospedali in Roma..28
La professione medica in Roma29
LA MEDICINA NEL MEDIOEVO.30.
Dal tardo Impero alla soglia delle Universit .30
La medicina occidentale nellepoca gota..31
CASSIODORO31
La medicina monastica..32
SAN BENEDETTO 32
Lassistenza pubblica: ospedali e diaconie33
Le scuole vescovili, le cattedrali e le scuole laiche.. 34
Le Scuole in Occidente dopo lanno mille35
LA SCUOLA SALERNITANA..35
Primo periodo della Scuola salernitana.35
Secondo periodo costantiniano della Scuola salernitana36
Costantino lAfricano.36
Giovanni Plateario III.36
IL DOTTRINARIO..37
Flos medicinae.37
Periodo della decadenza della Scuola salernitana.38
Le Scuole.38
La Scuola di Parma ..38
La Scuola di Bologna39
La Scuola di Roma39
La Scuola di Parigi39
La Scuola di Montpellier..39
La Scuola di Oxford..39
La Scuola di Cambridge.. 40
La Scuola di York.40
161
La medicina in Oriente, dal tardo Impero agli Arabi41
La medicina patristica.41
La medicina bizantina .41
Oribasio.42
PAOLO DEGINA42
Gli ospedali in Oriente43
Lorganizzazione della medicina in Bisanzio.43
LA MEDICINA DEGLI ARABI 44
Dottrinario della Medicina araba ..45
Principali esponenti della Medicina araba..46
Primo periodo.46
Secondo periodo.46
AVICENNA 46
Terzo periodo ..47
Averro..48
La cultura araba..48
LA MEDICINA MEDIEVALE: il Filosofismo scientifico e il Dogmatismo48
LE UNIVERSITA49
LUniversit di Bologna.50
LUniversit di Padova...50
LUniversit di Parigi.51
LUniversit di Montpellier .51
LUniversit di Oxford 51
LUniversit di Cambridge52
IL RINASCIMENTO..53
LEONARDO DA VINCI 53
Berengario da Capri 54
ANDREA VESALIO .54
Realdo Colombo .55
Gabriele Falloppio ..55
GIROLAMO FABRIZI DACQUAPENDENTE 55
Miguel Servedo .. 56
Andrea Cesalpino .56
Girolamo Cardano 56
PARACELSO 56
GIROLAMO FRACASTORO 57
La Chirurgia e i barbieri-chirurghi. LOstetricia .58
Ambroise Par ..58
LIgiene personale59
Lebbra e pestilenze .60
Verso il Metodo scientifico in Medicina .60
162
IL RINASCIMENTO SCIENTIFICO DEL SEICENTO.62
Cartesio62
Francesco Bacone62
GALILEO GALILEI62
Le Accademie scientifiche 63
Le scuole jatromeccanica e jatrofisica 63
La scuola jatromeccanica 63
Santorio Santorio63
La scuola jatrochimica..64
Francesco Dubois . 64
Roberto Boyle 65
Concetto microbiologico: il contagio animato.65
Le malattie psichiche, indemoniati e streghe ...66
LA CIRCOLAZIONE DEL SANGUE 66
GUGLIELMO HARVEY ..66
La composizione del sangue .67
MARCELLO MALPIGHI 68
La generazione e la fecondazione 68
Francesco Redi 68
LOstetricia ..69
Francesco Mauriceau 69
Farmacodinamica e Terapia. Medicina alternativa.69
Thomas Sydenham 69
Emotrasfusione 70
LA SCIENZA E LA MEDICINA NEL SETTECENTO 72
Orientamenti del pensiero medico scientifico .72
Orientamento vitalistico, romantico .72
Orientamento animisticomeccanicista .72
Orientamento positivistico ..73
Orientamento eclettico 73
Hermann Boerhaave 73
Esponenti dellorientamento positivisticosperimentale ..74
G. B. MORGAGNI 74
Anatomici e chirurghi 75
La fisiologia sperimentale, generazione e fecondazione75
Lazzaro Spallanzani.75
Anatomia microscopica .77
La respirazione e la circolazione del sangue 77
Il contagio animato: concetto ancora irrisolto ..77
La semeiotica ..78
La terapia 78
Linneo, Carl von Linn 78
163
Guaritori.79
Elettroterapia..79
Magnetismo animale. 79
Omeopatia..80
La chirurgia e le branche chirurgiche.80
Lostetricia..81
Guglielmo Smeille 81
La salute mentale81
Ligiene, la vaccinazione82
La pellagra..82
LA MEDICINA NELLOTTOCENTO: POSITIVISMO E IDEALISMO.. 83
Anatomia... 84
Citologia 84
Istologia. 84
Camillo Golgi.. 84
Fisiologia...85
Claude Bernard.. 85
C. Ludwig 86
Alimentazione. Ricambio. 86
Prodromi dellendocrinologia...87
IL DIABETE.
Brown Squard...87
Anatomia patologica. 87
Rodolfo Virchow 87
Fisiologia della digestione.. 88
J. P. Pawlow 88
La microbiologia.. 89
Agostino Bassi 89
LOUIS PASTEUR.. 89
ROBERT KOCH 91
La malaria 91
Ronald Ross91
G. G. Grassi92
La difterite92
La disinfezione.92
I. P. Semmelweis92
Giuseppe Lister..93
La semeiotica...93
Lanestesia...94
La radiologia 95
G. C. Roentgen..95
La chemioterapia 95
E. Behering96
P. Ehrlich.. 96
G. Domagk.. 96
Il pneumotorace.. 96
La paleoanatomia96
164
La chirurgia e le specialit chirurgiche97
Th. Billroth..97
Ostetricia e ginecologia.98
E. von Shauta..98
Urologia99
Otorinolaringoiatria..99
Oculistica. 99
A. von Graefe. 99
MEDICINA MILITARE. LA CROCE ROSSA E LA CONFERENZA DI GINEVRA.100
Il medico condotto
IL GRANDE PROGRESSO DELLA MEDICINA NEL NOVECENTO101
La medicina nelle due guerre mondiali101
Gli enzimi e le vitamine.102
Otto Warburg 102
Hans Adolf Krebs.. 102
Vitamine.. 103
Cervello, psiche e neurotrasmettitori.. 104
Dale 105
ORMONI ED ENZIMI106
Starling...106
Hans Berger ..107
Encefalogramma 107
PSICHE108
Siegmund Freud .108
Neuro-psicologia, Psicofarmaci 110
La fecondazione112
Hermann Knaus 112
K. Ogino .112
La pillola ..113
G. G. Pincus ..113
GENETICA E PROCREAZIONE . 114
A. G. Mendel 115
T. O. Morgan 115
J. D. Watson ..117
F. Crick . 117
R. Dulbecco 118
PROGETTO GENOMA . 118
STRESS E MALATTIE .. 121
Sindrome di adattamento 121
Hans Selye . 121
SaluteMalattia. Medicina psicosomatica 122
Difesa contro le malattie ..123
Soppressione anticorpale 123
Lansia ..124
Ansia stressante 125
GLI ANTIBIOTICI .126
A. Fleming ...126
165
LA RESISTENZA 127
CARDIOLOGIA. CITOLOGIA VAGINALE 128
LE PESTILENZE.129
Il microparassitismo e lo sviluppo del genere umano 129
Limmunit... 131
Le epidemie..133
Difese contro le pestilenze134
Macroparassitismo e organizzazione civile...135
Nel Medio Oriente antico..135
La civilt mediterranea classica. La Grecia...136
Inizio dellEra cristiana. Impero romano. Cina.137
Area mediterranea durante la Repubblica e lImpero romano...138
Le pestilenze e la crisi dellImpero romano...138
Il Medio Evo e lEra cristiana139
Dal 542 al 750. Lespansione degli Arabi..139
NellEuropa settentrionale.140
Presso i popoli germanici e slavi140
Crescita della popolazione e comunicazione marittima dopo il 900140
LE GRANDI EPIDEMIE DEUROPA (XII XVII secolo) 141
La peste di Verona e Venezia142
Le epidemie del 1700 e lultima epidemia dEuropa 1815 ..142
Il colera .143
Pandemie dinfluenza143
LE REAZIONI PSICOLOGICHE E CULTURALI.144
NellIslam..145
Le pestilenze e la scoperta dellAmerica..145
Le nuove malattie in Europa ..146
La trasformazione degli effetti del microparassitismo ..147
Aumento della popolazione .. 147
CONCLUSIONI ... 148
LA MEDICINA POPOLARE..150
LA MAGIA DEL MALE151
Le streghe151
La fattura.151
LA MAGIA DEL BENE..152
Le persone guaritrici..152
Gli amuleti e i talismani.152
La forma degli oggetti152
La magia delle erbe...154
La magia del nodo.154
La magia dellacqua..154
La magia dellolio.154
La magia della morte155
SANTI TAUMATURGHI.156
166
INDICE DEGLI AUTORI
Adler 116
Adrian E. D. 114
Alcmeone 15
Alessandro di Tralles 47
Alfano Primo 40
Aranzio Cesare 61
Arcagato 26
Archigene 27
Aristotele 21
Asclepiade 26
Asdrubali Francesco 87
Attuario Giovanni 48
Auenbrugger L. 83
Avenzoar 52
Averro 53
Avery O. T. 125
Avicenna 51
Bacone Francesco 67
Baglivi Giorgio 69
Balsamo Giuseppe 84
Barnard Christian 135
Bartolini 72
Bassi Agostino 95
Bassini E. 104
Bateson B. 123
Baudeloque J. I. 87
Bauhin Gaspare 61
Beaumont W. 94
Behring E. 98 102 130
Berengario da Capri 59
Berger Hans 114
Bernard Claude 89 91
Best Charles
Bichat Xavier 80
Billroth Th. 104
Bizzozero 91
Boerhaave H. 78
Borelli Alfonso 69
Botallo Leonardo 61
Bourgeois Luisa 74
Boyle Roberto 70
Breuer J. 116
Broca P. 112
Browm J. 77
BrownSquard 93 112
Bruno de Longoburgo 56
Cardano Girolamo 61
Cartesio 67
Casanova Giacomo 85
Cassiodoro 36
Catone 25
Celso A. Cornelio 28
Cerletti U. 115
Cesalpino Andrea 61 71
Chain E. B. 133
Charcot G. M . 115
Charpentier 118
Chiarugi V. 87
Codevilla A. 105
Cofone il Giovane 42
Colombo Realdo 60 64
Correns 122 123
Corvisart J. N. 84
Costantino lAfricano 41
Crich F. 125
Cullen W. 77
Curie P. 102
Curie M. 102
Dale 113
Dalton J. 92
Dam C. P. 111
Darwin Ch. 103
Delay J. 119
Deniker J. 119
Denys Battista 76
Domagk G. 103
Douglas J. 80
Dubois Francesco 69
Dulbecco R. 126
Economo von C. 112
Edwards J. H. 120
Ehrlich P. 103
Einthoven Willen 135
Empedocle 14 15
Eracleide di Taranto 24
Erasistrato 23 46
Erlich P. 91
Erofilo 23 46
Eustachio Bartolomeo 61
Fabrizi dAcquapendente 60 71
Falloppio Gabriele 60 64
Firmiano Lattanzio 46
Flaiani 86
Fleming A. 133
Flemming 90
Florey H. W. 133
Folli Francesco 76
Fontana F. 82
Forlanini C. 103
Fracastoro Girolamo 63 65 156
Freud S. 116 118
Galeno 31 81 146
Galilei Galileo 67
Gilles de Corbeil 42
Giovanni Plateario III 41
Glisson 72
Golderberger M. L. 111
Golgi Camillo 90 98
Graaf de R. 72 73 121
Graefe von A. 106
Grassi G. G. 98
Griffith F. 125
Guarimpoto 40
Guyon F. 104 106
Hahnemann 86
Haller von Albert 80
Hartman 124
Harvey Guglielmo 71
Hegar A. 105
Helmholtz E. H. 92
Helmont G. B. 69
Hoffmann Federico 77
Hunter J. 120
Ippocrate 17 143
Ishaq 52
Ivanov E. 120
Jenner Eduard 87 156
Johannitius 51
Jung C. G. 116
Kitasato S. 130
Knaus H. 119
Koch Robert 97
Kossel A. 121
Krebs H. A. 105
167
Khne W. 93
Kussmaul 112
Laborit H. 119
Lannec 100
Lagrange 82
Landsteiner K. 92
Lavoisier A. L. 82
Leeuwenhoeck 70 73 121
Leonardo da Vinci 58
Levi Montalcini R. 113
Liebig J. 93
Lierberkhn G. N. 82
Linneo 84
Lister Lord J. 99
Loefler G. F. 98
Lombroso 117
Ludwig C. 92
Maimonide 53
Malpighi Marcello 73
Mauriceau Francesco 74
McCarty M. 125
McClung 122
McLeod J. J. 125
Meckel G. F. 80
Mendel B. G. 123
Menire P. 106
Mercuri Scipione 64
Mercuriale Girolamo 64
Mesmer Francesco 85
Mitridate 24
Mondino de Liuzzi 55
Morgagni G. B. 79
Morgan T. O. 124
Morton W. 101
Mller H. G. 124
Nelaton A. 104
Nemesio 46
Ogino K. 119
Oribasio 47
Paget 104
Paolo dEgina 47
Papanicolaou G.N 136
Paracelso 61 118 156
Par Ambroise 64
Pascoli Alessandro 70
Pasteur Louis 96
Pauling L. 125
Pawlow J. P. 95
Pan E. 104
Pecquet 72
Penfield W. C. 112
Petit G. L. 80
Pietro dAbano 56
Pincus G. G. 121
Pinel Filippo 87 111
Piorry A. 100
Pirquet von C. 130
Platone 13
Plinio il Vecchio 29
Porro E. 106
Pott Percival 80
Purkinje 90
Ramazzini B. 70
Rasez 51
Rasori G, 78
Redi Francesco 73
Reiner R. 134
Roentgen G. C. 102
Rokitansky von C. 94
Rolando da Parma 44
Rolando Luigi 80 103 112
Ross Ronald 98
Rousset Francesco 64
Rufo dEfeso 29
San Benedetto 37
Sanger F. 126
SantAlberto Magno 66
Santa Ildegarda 39
Santorini G. D. 80
Santorio Santorio 68
Scarpa Antonio 80
Scheele C. G. 87
Schwann T. 90
Selye H. 128
Semmelweis L. P. 99
Sensi C. C. 134
Serapione 51
Sette V. 95
Shauta von F. 105
Siegmundin Giustina 74
Simpson J. Y. 101
Smeille Guglielmo 86
Sorano dEfeso 27
Spallanzani L. 80 82
Spigelio 72
168
Stahl G. E. 77
Stapley E. O. 134
Starling 113
Sternbach L. 119
Strambio Gaetano 88
Swaab D. 117
Switen van 100
Sydenham Thomas 74 150
SzentGyrgyi A. 111
Taddeo degli Alberotti 55
Tarnier S. 105
Todd A. R. 111
Torti Francesco 75 150
Tozzi Luca 71
Trendelemburg 104
Trotula 41
Ugo da Lucca 44
Varolio Costanzo 61
Velles O. 101
Vesalio Andrea 59
Virchow Rodolfo 94
Waksman S. A. 133
Warburg Otto 109
Watson J. D. 125
Wernicke K. 112
Wilson E. B. 122
Winlsow 80
Yersin A. 102 147
Zacchia..Paolo.70
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Adalberto Pazzini LA MEDICINA NELLA STORIA NELLARTE NEL COSTUME
Bramante Editrice Milano 1968
Luciano Sterpellone Dagli DEI al DNA
Antonio Delfino Editore Roma 1988 1995 (10 vol.)
Loris Premuda METODO E CONOSCENZA DA IPPOCRATE AI NOSTRI GIORNI
CEDAM Padova 1971
J. Le Goff J. Ch. Sournia PER UNA STORIA DELLE MALATTIE
Edizioni Dedalo Bari 1986
Frank Bridel I FARMACI CHE HANNO CAMBIATO LA VITA
LAriete Edizioni Milano 1988
Michel Morange STORIA DELLA BIOLOGIA MOLECOLARE
Edizioni Tema 1966 (Fuori commercio Merck Sharp & Dohme)
William H. McNeill LA PESTE NELLA STORIA
Arnaldo Mondadori Editore Milano 1991
Adalberto Pazzini STORIA DELLE TRADIZIONI E LEGGENDE
NELLA MEDICINA POPOLARE
Recordati Milano 1980 (Riprodotto dallOriginale 1940)
IN RISVOLTO DI COPERTINA
FOTOGRAFIA
Giovanni Zanninello nato a Cavarzere (Venezia) il 27 02 1928. Studi ginnasiali in Seminario. Liceo
classico in Istituto pubblico. Laurea in Medicina. Carriera ospedaliera fino a primario.
Ha sempre coltivato linteresse per la cultura classica e levolversi della civilt occidentale ebraico
cristiana, attento ai progressi della scienza e della tecnica e al contemporaneo sviluppo del
pensiero filosofico moderno.
Ha pubblicato una raccolta di poesie DAI PROFONDI - Racconti e pensieri in versi come poesia -
nel 1996 (Lalli Editore). LORATORIO DEL MOLINAZZO nel 1999 (edito in proprio). MARN
ATH BALLATA AL TEMPO - Poemetto con poscritto - nel 2000 (Ed. Nuova Scintilla). LA TERRA
LA VITA STORIE DI CIVILT CONTADINA nel 2002 (Ed. Promomedia communications) e CANTI
DI VERSI - CARMI, FOLE, POMES - nel 2006 (Ed Nuova Scintilla).
Potrebbero piacerti anche
- Origine Evoluzione Dell'UomoDocumento219 pagineOrigine Evoluzione Dell'Uomopaolachit0% (1)
- Speciale Gioacchino Web1Documento164 pagineSpeciale Gioacchino Web1Júlio César Barbosa100% (1)
- (Ebook - Ita) Giovanni Papini - Chiudiamo Le ScuoleDocumento7 pagine(Ebook - Ita) Giovanni Papini - Chiudiamo Le ScuoleGiuseppe MarescaNessuna valutazione finora
- UntitledDocumento158 pagineUntitledMatheusNessuna valutazione finora
- Breve storia della medicina: Dalla Preistoria al MedioevoDa EverandBreve storia della medicina: Dalla Preistoria al MedioevoNessuna valutazione finora
- Wiki Rudolf SteinerDocumento21 pagineWiki Rudolf SteinerScarbNessuna valutazione finora
- AMORTHDocumento4 pagineAMORTHAtrafinRuNessuna valutazione finora
- L'Errore e La Conquista Della ConoscenzaDocumento7 pagineL'Errore e La Conquista Della ConoscenzaAnnamaria Mazzacuva100% (1)
- Alchimia Ed Ermetismo, Paolo Lucarelli - Il MetodoDocumento11 pagineAlchimia Ed Ermetismo, Paolo Lucarelli - Il Metodopeshqit1981Nessuna valutazione finora
- Alla ricerca delle ultime cose: vie spirituali e spunti escatologiciDa EverandAlla ricerca delle ultime cose: vie spirituali e spunti escatologiciNessuna valutazione finora
- Rudolf Steiner - Sommario O.O. Dic. 2010 - 2 EdizioneDocumento54 pagineRudolf Steiner - Sommario O.O. Dic. 2010 - 2 EdizioneEugenio SorrentinoNessuna valutazione finora
- 123 - CAL - Agopuntura CineseDocumento94 pagine123 - CAL - Agopuntura Cineseiperico68Nessuna valutazione finora
- Apuleio (A Cura Di Bianca Maria Portogalli Cagli) - Il Demone Di Socrate-Marsilio (1992)Documento85 pagineApuleio (A Cura Di Bianca Maria Portogalli Cagli) - Il Demone Di Socrate-Marsilio (1992)Llubisa Nesovic100% (1)
- Massimo L. Bianchi - Signatura Rerum. Segni, Magia e Conoscenza Da Paracelso A LeibnizDocumento102 pagineMassimo L. Bianchi - Signatura Rerum. Segni, Magia e Conoscenza Da Paracelso A LeibnizDrBenway84100% (1)
- Ossido NitricoDocumento39 pagineOssido NitricowpedrNessuna valutazione finora
- Alchimia - Wikipedia PDFDocumento105 pagineAlchimia - Wikipedia PDFAntimo Di DonatoNessuna valutazione finora
- La Sezione AureaDocumento130 pagineLa Sezione AureaRotas AloscNessuna valutazione finora
- Etica Nicomachea - Aristotele - Libro Da 6 A 10Documento7 pagineEtica Nicomachea - Aristotele - Libro Da 6 A 10Mared'inverno AnimebluNessuna valutazione finora
- Medicina LegaleDocumento37 pagineMedicina Legalecicleo74100% (1)
- Lafilosofiagreca 02 DeruuoftDocumento312 pagineLafilosofiagreca 02 Deruuoftparsifal11Nessuna valutazione finora
- Incidenti Stradali PDFDocumento104 pagineIncidenti Stradali PDFcicleo74100% (1)
- Incidenti Stradali PDFDocumento104 pagineIncidenti Stradali PDFcicleo74100% (1)
- Sidgwick - Prime Linee Di Una Storia Della MoraleDocumento461 pagineSidgwick - Prime Linee Di Una Storia Della MoraleludwittgNessuna valutazione finora
- Disumanizzazione Dell UomoDocumento255 pagineDisumanizzazione Dell UomoAndrea ColtroNessuna valutazione finora
- Scismi e Crisi Nella Torre Di GuardiaDocumento12 pagineScismi e Crisi Nella Torre Di Guardiaobag100% (1)
- La vita lucida: Un dialogo su potere, pandemia e liberazioneDa EverandLa vita lucida: Un dialogo su potere, pandemia e liberazioneNessuna valutazione finora
- La FotosintesiDocumento59 pagineLa Fotosintesig.ciancio7Nessuna valutazione finora
- Cartesio RiepilogoDocumento75 pagineCartesio RiepilogoFabioDeMartinNessuna valutazione finora
- Prefazione A Cura Del Prof. Ernesto MilanoDocumento82 paginePrefazione A Cura Del Prof. Ernesto MilanoV.F.Nessuna valutazione finora
- (Ebook - ITA - MEDICINA) IPNOSI, Una Introduzione Psicofisiologica PDFDocumento112 pagine(Ebook - ITA - MEDICINA) IPNOSI, Una Introduzione Psicofisiologica PDFAdriano PiantellaNessuna valutazione finora
- Linee Guida Per Pazienti Con IperomocisteinemiaDocumento32 pagineLinee Guida Per Pazienti Con Iperomocisteinemiametal76Nessuna valutazione finora
- 16 La Grande TriadeDocumento137 pagine16 La Grande TriadeAugusto PrioreNessuna valutazione finora
- La Civiltà Nuragica PDFDocumento28 pagineLa Civiltà Nuragica PDFRoberto SiriguNessuna valutazione finora
- Giordano Bruno e Il Vincolo Di CupidoDocumento6 pagineGiordano Bruno e Il Vincolo Di CupidoGuido del GiudiceNessuna valutazione finora
- Thomas Szasz - La Teologia Della Medicina (Ed. 3)Documento31 pagineThomas Szasz - La Teologia Della Medicina (Ed. 3)Tristano AjmoneNessuna valutazione finora
- Galeno e Scuola SalernitanaDocumento5 pagineGaleno e Scuola SalernitanaDanilo ViriNessuna valutazione finora
- L'arte Della Persuasione - PpsDocumento66 pagineL'arte Della Persuasione - PpslanaNessuna valutazione finora
- WP I 20120301Documento32 pagineWP I 20120301Alessio Fasano100% (1)
- Paracelso Metafisica Del SaleDocumento2 pagineParacelso Metafisica Del Salebruno_mor33Nessuna valutazione finora
- Alchimia 3Documento26 pagineAlchimia 3Uilli UauNessuna valutazione finora
- Il Laboratorio AlchemicoDocumento7 pagineIl Laboratorio AlchemicosoloiosochisonoNessuna valutazione finora
- Storia Della Metafisica - Da Parmenide A Hegel - Appunti 2013Documento44 pagineStoria Della Metafisica - Da Parmenide A Hegel - Appunti 2013Enrico TonioloNessuna valutazione finora
- Divinità Dell'Antico EgittoDocumento12 pagineDivinità Dell'Antico EgittoPersiusalNessuna valutazione finora
- Contro Matematici BVS PDFDocumento4 pagineContro Matematici BVS PDFSofíaFundoraNessuna valutazione finora
- (Med ITA) Anatomia Patologica CompletoDocumento489 pagine(Med ITA) Anatomia Patologica CompletoKranNessuna valutazione finora
- Gli Apostoli TraditoriDocumento280 pagineGli Apostoli TraditoriEnrico Galavotti100% (1)
- ARTEMISIA ANNUA Studi e Posologia PDFDocumento5 pagineARTEMISIA ANNUA Studi e Posologia PDFAnonymous 8Ur5UKNessuna valutazione finora
- Manuale Per La Comunicazione in OncologiaDocumento142 pagineManuale Per La Comunicazione in OncologiashaezzanNessuna valutazione finora
- Rocco Carbone in Natura Felicitas 21 Drenaggio e GemmoterapiaDocumento23 pagineRocco Carbone in Natura Felicitas 21 Drenaggio e GemmoterapiaFrancis ParthenicumNessuna valutazione finora
- Aby Warburg by Alice BaraleDocumento18 pagineAby Warburg by Alice Baraleon77eir2Nessuna valutazione finora
- Jung La SolitudineDocumento17 pagineJung La SolitudineMarcelaNessuna valutazione finora
- La casa che vorrei: Feng Shui, campane tibetane, oli essenziali e armonia interioreDa EverandLa casa che vorrei: Feng Shui, campane tibetane, oli essenziali e armonia interioreNessuna valutazione finora
- IppocrateDocumento74 pagineIppocrateSturm brightblade100% (1)
- Cause Ambient Ali Delle Malattie NeurodegenerativeDocumento220 pagineCause Ambient Ali Delle Malattie NeurodegenerativebubuababaiabaNessuna valutazione finora
- B. Mondin, Etica e Politica PDFDocumento74 pagineB. Mondin, Etica e Politica PDFMichele MattaNessuna valutazione finora
- Seyyed Hossein Nasr - Scienza e Civilta Nell'Islam (Sufismo Storia - Byfanatico 2009)Documento312 pagineSeyyed Hossein Nasr - Scienza e Civilta Nell'Islam (Sufismo Storia - Byfanatico 2009)massimote2866Nessuna valutazione finora
- Diagnosi e Terapia Della Sincope - Manuale GIMSI (Ungar)Documento220 pagineDiagnosi e Terapia Della Sincope - Manuale GIMSI (Ungar)marcosivieroNessuna valutazione finora
- Architettura Di Vitruvio3Documento230 pagineArchitettura Di Vitruvio3cannizzo45091Nessuna valutazione finora
- Prodigiorum Liber - Libro Dei Prodigi - OssequenteDocumento182 pagineProdigiorum Liber - Libro Dei Prodigi - OssequenteFrancesco LopianoNessuna valutazione finora
- Roberto Melisi Divinizzazione DellumanoDocumento8 pagineRoberto Melisi Divinizzazione DellumanoluxfidesNessuna valutazione finora
- Tesi DR Pieraldo Pelizza PDFDocumento307 pagineTesi DR Pieraldo Pelizza PDFcicleo74Nessuna valutazione finora
- Tesi DR Pieraldo Pelizza PDFDocumento307 pagineTesi DR Pieraldo Pelizza PDFcicleo74Nessuna valutazione finora
- RLS, Ovvero Vivere Con La Sindrome Delle Gambe Senza RiposoDocumento15 pagineRLS, Ovvero Vivere Con La Sindrome Delle Gambe Senza Riposocicleo74Nessuna valutazione finora
- Manualidiulisse LaringeDocumento17 pagineManualidiulisse Laringecicleo74Nessuna valutazione finora
- Al - Troc.onsumo Gu - Ida Co - NdominioDocumento17 pagineAl - Troc.onsumo Gu - Ida Co - Ndominiocicleo74Nessuna valutazione finora
- FeriteDocumento64 pagineFeritecicleo74Nessuna valutazione finora
- Medlegbs 3Documento84 pagineMedlegbs 3cicleo74Nessuna valutazione finora