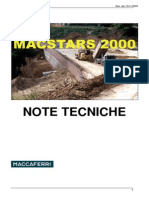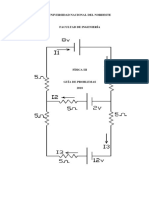1.
IL CONCETTO DELL'EQUILIBRIO LIMITE
La soluzione di un problema ingegneristico, solitamente, richiede il rispetto simultaneo della
condizione di equilibrio, del principio di conservazione di massa (equazioni di campo) e della
congruenza del sistema globale coinvolto (equazioni di legame costitutivo).
Come noto, le equazioni di campo sono già sufficientemente complesse quando si deve trattare
un materiale costituito da una sola fase: i terreni costituiscono un sistema multifase che può
essere ricondotto al caso monofase solo quando si tratti di terreno secco o di analisi in condizioni
drenate, cioè in assenza di sovrappressioni interstiziali.
Nella maggior parte dei casi (condizioni non drenate o di drenaggio parziale) però, si deve
analizzare il comportamento di un materiale che, se saturo, è per lo meno bifase e ciò rende la
trattazione delle equazioni di campo notevolmente più complessa (come ad esempio visto, anche
se sommariamente, nel caso dei moti di filtrazione).
Inoltre, le definizione di un legame costitutivo di validità generale è praticamente impossibile, in
quanto i terreni:
hanno un comportamento non lineare già a piccole deformazioni,
sono materiali dotati di attrito il cui comportamento dipende non solo dallo sforzo deviatorico
ma anche da quello normale,
in condizioni drenate esibiscono variazioni di volume ed in condizioni non drenate insorgono
sovrappressioni nell'acqua interstiziale,
presentano spesso un comportamento instabile (curve sforzi-deformazioni di tipo rammollente)
che víolano il postulato di Drücker [1959],
hanno un comportamento dipendente dalla variabile tempo.
A causa delle suddette difficoltà, è prassi generale l'introduzione delle seguenti semplificazioni, al
fine di ottenere soluzioni sia pure approssimate ma di pratica utilità:
a) i problemi vengono suddivisi in verifiche di stabilità e di deformazione: i primi riguardano la
condizione di equilibrio limite (cioè il cosiddetto stato limite ultimo), mentre i secondi fanno
riferimento alla situazione di esercizio;
pagina 1 di 9
�b) si utilizzano leggi costitutive semplificate quali, ad esempio, il modello elastico-lineare-isotropo
per il calcolo delle deformazioni o il modello rigido-perfettamente plastico nelle analisi di stabilità;
c) molto spesso le equazioni di campo vengono soddisfatte solo in parte.
Tali semplificazioni vanno tenute ben presenti affinché siano chiarissimi:
la portata ed i limiti delle soluzioni a cui ci si affida nella progettazione corrente,
l'importante ruolo che gioca l'esperienza nel valutare l'applicabilità delle soluzioni disponibili ai
casi reali.
Alla luce delle precedenti osservazioni, nel seguito approfondiamo il metodo di verifica di Stabilità
Equilibrio Limite e, successivamente, alcune delle applicazioni
più pertinenti sviluppate su di esso.
1.1 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
Quando il piano di campagna non è orizzontale (pendii naturali o scarpate artificiali), la gravità,
unitamente ad altre eventuali azioni esterne, tende a mobilizzare una parte della massa di terreno
potenziali superfici di scorrimento.
istenza al taglio mobilitata nel terreno)
supera le tensioni tangenziali indotte dalle azioni spingenti. Complice, per le forze instabilizzanti, è
per distruzione di coesione, maggiormente al progressivo fenomeno di riduzione della resistenza
La rottura si manifesta generalmente come fenomeno progressivo, mobilizzando la resistenza di
picco a cui segue un valore ridotto, detto residuo
frana per poi propagarsi al resto della massa, sino a produrre il collasso globale.
Altre forze instabilizzanti sono introdotte da eventuali azioni sismiche; le forze di filtrazione
giocano inoltre un ruolo più importante di quello normalmente loro attribuito.
rigonfiamento ed essicamento stagionali (soil slips), e lenti movimenti nel tempo possono prodursi
a causa del comportamento viscoso del terreno (creep).
pagina 2 di 9
�Ovviamente, molte di queste cause possono essere concomitanti; ma, anche quando non lo siano,
lema complesso, quasi sempre di difficile schematizzazione,
soprattutto per quanto concerne la determinazione dei parametri di resistenza al taglio del
terreno.
oè
lineazioni, contatti tra formazioni diverse, discontinuità di origine microtettonica e, soprattutto,
per il riconoscimento di situazioni relitte (paleofrane).
tensionale, la determinazione delle caratteristiche meccaniche e delle proprietà fisiche dei
materiali dei vari strati, la definizione delle variazioni dello stato tensionale prodotte da eventuali
interventi (scavi, riporti, drenaggi).
2. ANALISI DI STABILITÁ DI PENDII IN TERRA CON IL CONCETTO, O METODO,
GLE)
Benché il grado di stabilità di un pendio sia evidenziato dalle deformazioni che esso manifesta, le
analisi di stabilità sono di solito basate su metodi che considerano solo l'equilibrio delle forze in
gioco. I motivi di tale scelta obbligata sono già stati discussi nel primo paragrafo, e sono legati a
schematizzazioni mediante le quali, in pratica, si disgiungono le analisi di resistenza effettuate con
il concetto dell'equilibrio limite dalle analisi di tipo deformativo.
Tutti i metodi basati appunto sull'equilibrio limite hanno in comune le assunzioni di seguito
elencate:
poiché spesso la superficie di rottura al contorno è ben definita, l'analisi di stabilità viene
effettuata considerando l'equilibrio della massa di terreno individuata da tale superficie,
sottoposta alle forze al contorno;
la resistenza al taglio necessaria all'equilibrio e agente lungo la superficie di scorrimento (sia
essa ipotizzata che reale) è calcolata solo attraverso le equazioni della statica: il coefficiente di
sicurezza è inteso come il fattore per il quale possono essere divisi i parametri di resistenza per
portare il pendio in condizione di equilibrio limite (rottura); è inoltre implicitamente assunto
pagina 3 di 9
� costante lungo tutta la superficie di scivolamento (cioè si trascurano i fenomeni di rottura
progressiva);
l'analisi viene effettuata, nella quasi totalità dei casi, in condizioni di deformazioni piane;
poiché il pendio può non essere omogeneo, è usuale il ricorso a metodi (detti "slices methods
Y
Livello della falda
Piano di campagna
Massa scivolante
Ipotetica superficie di
rottura
Figura 2.1
che suddividono la massa di terreno interessata dallo scivolamento in un numero conveniente
di elementi discreti, tipicamente detti conci.
È necessario, in questo tipo di analisi, individuare a priori una superficie di potenziale scorrimento
erno del pendio. Un esempio di tale curva è indicato nella seguente sezione trasversale.
A questo punto è individuata la massa di terreno che si deve analizzare, delimitata superiormente
dal piano di campagna ed inferiormente dalla (ipotetica) superficie di rottura; si assume
implicitamente che sia raggiunta, lungo essa, la condizione di equilibrio limite. Tra tutte le possibili
superfici di scivolamento andrà poi ricercata quella avente fattore di sicurezza minore.
Come già anticipato, il problema tridimensionale viene trattato come piano (avente lunghezza di
fuga unitaria): ne segue che, ovviamente, la superficie diventa una curva e così facendo è
trascurato ogni effetto di costrizione trasversale.
ettabile soltanto quando si studiano pendii
aventi caratteristiche morfologiche e meccaniche sufficientemente regolari nella direzione
trasversale, altrimenti il problema piano diventa rappresentativo di una zona alquanto ristretta (e
ciò sempre prescindendo dalla costrizione trasversale);se così fosse sorgerebbe la necessità di
esaminare un problema piano per ogni zona in cui le caratteristiche geometriche e meccaniche
variano sostanzialmente.
pagina 4 di 9
�Suddivisa la massa di terreno in conci (che possono anche avere facce inclinate a seconda del
dalle interazioni che i singoli conci vicendevolmente si scambiano.
Per valutare la stabilità nei confronti di un meccanismo di collasso, è necessario conoscere le forze
effettive che agiscono su ciascun concio; prendendo in esame la figura 2.3,
G
Hm
P Vm
Vv
Hv
T
Ytm
Ytv N=N +U
Y= 0 X
Figura 2.3
ove:
P è il vettore peso del concio;
N è la forza normale totale alla base del concio;
T è la forza di taglio, mobilitata alla base del concio;
Hv m
Vv m cia;
Ytv m Hv m .
v m
fa riferimento.
assemblaggio degli n conci, si hanno quindi le
seguenti incognite:
pagina 5 di 9
� numero Incognite
1 Fattore di sicurezza globale: F
n Forza normale alla base di ciascun concio: N
n Posizioni delle forze normali
n Forza di taglio alla base del concio: T
n-1 Componenti orizzontali delle forze di interfaccia: H
n-1 Componenti verticali delle forze di interfaccia: V
n-1 Posizioni delle forze di interfaccia: Yt
(linea delle spinte)
6n-2 Numero totale di incognite
mentre, per ogni concio, si possono scrivere le seguenti equazioni:
numero Equazioni disponibili, per ogni concio
n 1 di equilibrio alla ROTAZIONE
2n 2 di equilibrio alla TRASLAZIONE (vert. e orizz.)
n 1 CRITERIO DI ROTTURA secondo Mohr-Coulomb
4n Numero totale di eq. disponibili
Una assunzione largamente adottata consiste nel supporre, tracciando conci di spessore
relativamente sottile, che la forza normale N sia applicata nel punto medio della base; ne
consegue che il numero delle incognite si riduce a (5n-2). A questo punto è necessario introdurre
altre (n-2) ipotesi restrittive per rendere staticamente determinato il problema, ossia per avere un
numero di equazioni indipendenti uguale al numero delle incognite.
Le alternative più ragionevoli
interfaccia o sul loro punto di applicazione (linea delle spinte).
Quindi, i vari metodi che sono stati proposti in letteratura differiscono largamente tra loro, a causa
delle differenti assunzioni adottate per rendere il problema staticamente determinato; alcuni dei
metodi, addirittura, non utilizzano neppure tutte le equazioni di equilibrio disponibili.
Ad esempio, i cosiddetti Metodi Ordinari
interfaccia, mentre le analisi del pendio di lunghezza infinita (Fredlund e Krahn) e di Janbu
semplificato non soddisfano la condizione di equilibrio alla rotazione.
I metodi più sofisticati cercano di soddisfare tutte le condizioni di equilibrio, introducendo ipotesi
sulle forze di interfaccia (Spencer, Morgenstern e Price, Janbu esatto).
pagina 6 di 9
�Tali difetti impliciti nei metodi sono inevitabili e, conseguentemente, in
ciascuno di essi le varie ipotesi adottate influenzano il calcolo del fattore di sicurezza, a volte
producendo differenze assai notevoli.
Il trasferimento delle forze di interazione tra la massa considerata instabile ed il resto, deve essere
coerente con gli aspetti meccanici e fisici del problema.
linea di spinta è stata presa in considerazione in passato (per esempio da
Spencer nel 1973), ma alle forze di interfaccia è stata data poca attenzione: normalmente infatti è
trascurato, ad esempio, come esse vengono mobilitate, così come è la loro influenza sulla
superficie di scorrimento.
Solo più recentemente il metodo di Sarma (1973, 1979) si è occupato proprio di ciò.
Le varie tecniche di analisi possono considerare complesse geometrie, terreni con differenti
caratteristiche e diverse condi oza
et al., 1992; Donald and Zhao,1995).
Volendo elencare solo i più noti, tra i numerosi metodi proposti per eseguire analisi di stabilità
secondo il concetto GLE (Global Limit Equilibrium), in sequenza cronolgica si ricordano:
Collin [1846]
Fellenius [1927]
Fellenius (modificato da Terzaghi [1936])
Taylor [1939]
Bishop [1955]
Janbu [1957]
Morgenstern e Price [1965]
Spencer [1967]
Bell [1968]
Madej [1971]
Sarma [1973]
Analogie o differenze tra i metodi sono spesso oscure, in parte a causa della scarsità di una
formulazione uniforme nella esplicitazione delle relazioni che definiscono il fattore di sicurezza, in
pagina 7 di 9
� -circolare non risultano così
evidenti.
Alcuni studi sono stati fatti per valutare le differenze qualitative ottenute dal confronto tra vari
metodi (Bishop, 1955; Wright, 1969; Duncan e Wright, 1980).
In generale, le differenze nel valore del coefficiente di sicurezza ottenuto non sono sostanziali, ad
eccezione dei Metodi Ordinari che possono differire per più del 60 rispetto agli altri.
Altri studi sono stati fatti per mostrare la relazione tra i vari metodi da un comune punto di
partenza teorico (Wright,1969; Fredlund e Kranhn, 1977; Popescu, 1978; Janbu, 1980).
Secondo Espinoza et al. (1992), le varie ipotesi adottate nelle ana
possono essere raggruppate come segue:
viene assunta la direzione della risultante delle forze interne (ad esempio Spencer, 1967 -
Morgenstern e Price, 1965)
viene assunta la linea delle spinte delle forze di interfaccia (Janbu, 1957)
viene assunta la forma della distribuzione delle forze di taglio interne.
Tutte queste differenti assunzioni citate portano generalmente a differenti espressioni per le forze
di interfaccia e per il calcolo del fattore di sicurezza.
Come conseguenze di ciò si possono presentare alcuni problemi.
tto della pressione
neutra, vengono trascurate le forze di interazione tra i conci. Il coefficiente di sicurezza in tal caso
è approssimato per difetto in misura anche sensibile.
Bishop, mantenendo la condizione di equilibrio globale alla rotazione già adottato da Fellenius,
trascura solo le componenti verticali delle forze di interazione, che sono supposte nulle. Il limite di
tale metodo è nella forma della superficie di scorrimento che è ancora ipotizzata circolare.
Janbu assume una superficie di scorrimento di forma qualsiasi, adotta quale criterio di stabilità la
derano nulle le
componenti verticali delle forze di interazione e si perviene ad un coefficiente di sicurezza
così per successive iterazioni ad un coefficiente di
pagina 8 di 9
�in letteratura.
Tale arbitrarietà è superata dal metodo di Morgensern & Price, i quali assumono quale variabile
variazione di tale inclinazione, assumono come corretta quella per cui è contemporaneamente
sodd
Pertanto, allo scopo di ottenere una valutazione attendibile del fattore di sicurezza per il singolo
caso in esame, utilizzando un certo metodo piuttosto che un altro, è chiaramente opportuna la
comprensione delle ipotesi alla base di ciascuno.
Attualmente, molti programmi di calcolo sono implementati su computer, largamente accessibili e
forniscono grande aiuto nelle valutazioni numeriche; se però non è chiaramente definito
pagina 9 di 9