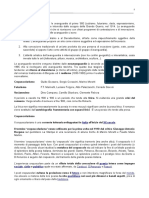GUIDO GOZZANO
- Nasce a Torino nel 1883 da una famiglia dell’alta borghesia piemontese;
- Nome intero: Guido Gustavo Riccardo Gozzano (gli altri nomi appaiono ironicamente
nelle sue poesie)
- Si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza all’ UniTo ma abbandona gli studi nonostante
ciò nelle sue poesie spesso e volentieri si autoproclama “l’Avvocato”
- Inizia a frequentare le lezioni di Arturo Graf presso Lettere, al contemplo collabora con
giornali e riviste
- 1907 esce La via del rifugio e intrattiene un rapporto sentimentale con Amalia
Guglielminetti
- 1908 va a Ronco Canavese per curarsi dalla tubercolosi (diagnosticatagli quattro anni
prima)
- 1911 escono I colloqui
- 1912 parte per l’India nel tentativo di alleviare i sintomi (da febbraio ad aprile)
- Muore a Torino nell’agosto del 1916
Letteratura:
- Si avvicina al dannunzianesimo, poi manipola in senso manieristico il linguaggio,
riportandolo a un patetismo borghese, ingenuo e provinciale, criticamente realistico, e
soprattutto capace di uno straniamento ironico rispetto al "sublime" poetico proclamato dal
'canto' dannunziano = dannunzianesimo rientrato
- Recuperando la lezione pascoliana, distanziandosi dal liberty e dal simbolismo, rinnova lo
status stesso della poesia evidenziando la collocazione equivoca del poeta nella cultura e
nella società contemporanea
- Ritenuto il maggior esponente del crepuscolarismo:
abbassamento dei contenuti e dello stile della lirica alta tramite la componente
ironica
poesia con funzione consolatoria ed espressione di un ripiegamento interiore
immersione nella dimensione privata del ricordo (rispetto agli atteggiamenti
superomistici dell’estetismo)
demistificazione dell’amore e della figura femminile = l’amore si trasforma in
disinganno, nell’illusione di relazioni impossibili e la fascinazione per donne umili (al
posto della femme fatale appaiono ragazze di paese, vecchie ballerine ecc.) (Le due
strade, La signorina Felicita, L’amica di nonna speranza, Cocotte, Ketty
le ambientazioni sono umili e familiari (non più dimore rinascimentali); gli oggetti
descritti sono cose di tutti i giorni = «buone cose di pessimo gusto», ovvero oggetti
kitsch e tuttavia cari all’autore perché rappresentano il legame con il passato (L’amica di
nonna speranza)
figura dell’inetto
tematiche della malattia (spirituale ma anche fisica) e la morte
Stile:
- dettato che tende ad avvicinarsi alla prosa
�- onomatopee, interiezioni, reticenze, vocaboli nuovi (legati alla scienza e alle lingue
straniere Alle soglie)
- rime paradossali (La signorina Felicita – rima camicie Nietzsche
- diffusi diminuitivi e vezzeggiativi
- rispetto agli altri esponenti crepuscolari si attiene alle forme metriche della tradizione (anche
a quelle più rare: versi martelliani nel Le due strade)
- “plagio” = continua ripresa della letteratura tradizionale italiana (Dante, Petrarca) e
contemporanea (Pascoli, D’Annunzio) Gozzano è l’autore più letterato del Novecento:
guardare la realtà attraverso la letteratura (non sempre del tutto digerita) è l’unica
modalità di approccio al reale che Gozzano conosca e il suo modo di fare letteratura non
può che adeguarsi alla sua generale attitudine
l’assimilazione della tradizione avviene anche tramite l’ironia (talvolta critica) nei
confronti del mondo, di sé stesso e delle sue letture