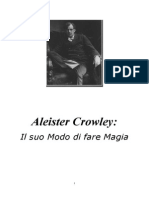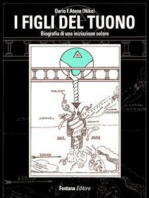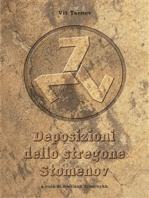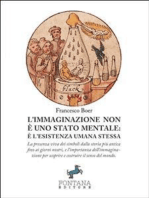Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Eros e Cabala
Eros e Cabala
Caricato da
solmiCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Eros e Cabala
Eros e Cabala
Caricato da
solmiCopyright:
Formati disponibili
1
Eros e Kabbalah
(Il Foglio, 5 gennaio 2008)
Le-Shem Yichud Qudesha Berikh Hu u-Shekinateh. Questa
formula cabbalistica in aramaico, che significa In nome dellunione del
Santo, sia Egli benedetto, con la Sua Divina Presenza, entrata a far
parte di certi rituali ebraici a partire dalla met del Cinquecento. Essa il
leitmotiv del nuovo libro di Moshe Idel dal titolo intrigante Eros e
Qabbalah (Milano, Adelphi). Difatti, secondo lautore, essa esprime in
forma emblematica lintento di alcuni importanti adempimenti religiosi di
indurre lunione, nel senso di unione sessuale, tra un attributo divino
maschile [] e una manifestazione divina femminile. Secondo Idel,
alcune correnti importanti della Qabbalah medioevale che avevano
precedenti nella tradizione rabbinica hanno attribuito ai riti religiosi la
virt di indurre una riunificazione di diverse polarit del mondo divino,
attraverso un incontro interpretato in termini audacemente erotici. Molti
sono gli aspetti assai originali di queste concezioni. In primo luogo,
lidentificazione di differenti polarit nella vita divina che rappresenta la
massima forma di articolazione dellessenza divina compatibile con il
rigido monoteismo della tradizione rabbinica. Non a caso la tradizione
cabbalistica stata pi volte sospettata di eresia di tipo cristiano. In
secondo luogo, lidentificazione di queste polarit con un dualismo di
tipo maschile-femminile e lidea che la ricomposizione di tale dualismo
sessuale possa avvenire attraverso un atto erotico. Di qui deriva una
santificazione dellatto sessuale come rappresentativo di uno stato di
unit ed armonia del regno divino. Ma e questo uno degli aspetti pi
originali il rapporto tra divino e umano non visto in modo
unidirezionale, come se soltanto la vita divina fosse capace di influenzare
il mondo degli uomini. Il processo va anche dalluomo verso Dio: il
sistema dei canali dellemanazione divina consente una risalita verso
lalto, e quindi le azioni umane possono influenzare la vita divina e
armonizzarla. La preghiera, i riti ma anche gli atti sessuali ed erotici
possono facilitare una ricomposizione delle polarit maschile e femminile
presenti nellessenza divina.
Soltanto la lettura diretta del libro pu restituire la ricchezza del
tema e la complessit degli intrecci che lautore ricostruisce con
straordinaria sapienza filologica. Oltretutto, ledizione italiana riveste un
valore particolare sia perch studia molte opere scritte sul suolo italiano
da Menachem Recanati a Leone Ebreo fino a un racconto di Primo Levi
ma anche perch la lettura critica delloriginale inglese e dei testi ebraici
condotta con eccezionale cura da Elisabetta Zevi ha prodotto a detta
2
dello stesso Idel una versione del libro non soltanto precisa, ma in
alcuni casi pi corretta delloriginale. La traduzione italiana pu quindi
essere considerata come la fonte pi attendibile di questo testo.
impressionante constatare a qual punto gli studi storici recenti
sulla Qabbalah e sulla mistica ebraica abbiano rivoluzionato limmagine
della cultura europea: si tratta di un mutamento di prospettiva molto pi
profondo di quanto si possa immaginare e che era stato previsto da alcuni
studiosi. Quasi trentanni fa, Frances Yates, nel suo Cabala e occultismo
nellet elisabettiana, scusandosi di affrontare un argomento su cui non
riteneva di aver titoli, indicava che lopera di Gershom Scholem avrebbe
dovuto essere conosciuta oltre il contesto degli studi ebraistici ed
integrata nella storia generale. Yates richiamava anche il fondamentale
volume di Chaim Wirszubski sullincontro tra Pico della Mirandola e il
misticismo ebraico. Un recente convegno su Pico tenutosi a Mirandola ha
testimoniato come questi studi siano usciti dal chiuso di una filologia
strettamente ebraistica. Ad esso, oltre a Idel, ha partecipato uno studioso
come Brian Copenhaver che in un saggio del 1980 sulle Teologie dello
spazio nella rivoluzione scientifica critic lo scarso interesse di taluni
studiosi, pur di ampie vedute come A. Koyr e I. B. Cohen, per gli
influssi teologici nella formazione della scienza moderna. Copenhaver
sosteneva che lo studio di queste tradizioni mostra come le storie della
teologia, della filosofia e anche delloccultismo possono contribuire a una
visione sintetica del passato che illumina, o forse pi precisamente,
include la storia della scienza. Occorre anche ricordare gli studi di Tony
Levy sulle concezioni dellinfinito che hanno mostrato limportanza del
contributo del filosofo medioevale ebreo Hasday Crescas, fortemente
influenzato dal pensiero cabbalistico, alla formazione del concetto di
spazio vuoto che ebbe un ruolo fondamentale nella scienza newtoniana.
Gli studi dellultimo trentennio, e in particolare quelli di Moshe
Idel, hanno messo sempre pi a fuoco gli intrecci infinitamente variegati
e complessi tra cultura ellenica ed ellenistica, ebraica e cristiana che si
dice tanto spesso, ma genericamente, essere il fondamento della civilt
europea. Lo studio di questi intrecci permette di scardinare certe rigide
schematizzazioni che ci portiamo dietro da tempo e che sono allorigine
di pregiudizi liquidatori. Tale il caso della visione semplificatrice di A.
Nygren (Eros e agape) secondo cui la Grecia rappresenta leros (ovvero
linsieme dei comportamenti che determinano la spinta a stabilire contatti
sessuali o emozionali, fisici o spirituali tra due entit attratte luna
dallaltra), lebraismo il nomos (la legge) e il cristianesimo lagape
(ovvero unattrazione spirituale verso Dio priva di spinta libidica). In tal
modo, le tre tradizioni vengono impoverite e cristallizzate in una
separatezza irriducibile. Il Cristianesimo viene privato di ogni dimensione
mistica. Lebraismo viene ridotto a mero nomos, a legge estranea ad
3
ogni forma di amore, quando non v neppure bisogno di invocare
limponente tradizione della mistica ebraica per mostrare linconsistenza
di questo schema. Senza dire che lidentificazione dellidea greca di
nomos con lidea ebraica di legge azzardata e trascura il fatto che sotto
il termine di legge si raccoglie la storia di unidea immensamente
complessa. Lebraismo, come osserva Idel, sempre stata una religione
complessa e polimorfa. Ancor prima che emergesse il movimento
cabbalistico, possibile cogliere atteggiamenti positivi nei confronti
delleros nella tradizione rabbinica, il che smentisce il carattere
puramente legalistico della religione ebraica. Daltra parte, la distanza tra
il concetto di legge come norma etica e comportamentale da quello di
legge come ordine naturale allontana, almeno in quella fase, lebraismo
dalla metafisica e persino dalla teologia. Di qui limportanza attribuita ai
comportamenti fisici e, in particolare, agli atti sessuali ed erotici che
vengono considerati come parte essenziale di una vita ordinata dal punto
di vista morale e religioso. Compiere latto sessuale per la procreazione e
per la soddisfazione erotica un vero e proprio precetto di vita per
luomo pio.
Idel ricorda le riflessioni di Jung, secondo cui nello gnosticismo il
fisiologico subordinato al metafisico e leros ideale cerca di
sottomettere il comportamento sessuale terreno a una certa forma di
spiritualit erotica asessuale o transessuale. Di qui limportanza
dellandrogino che Jung vede come simbolo dellunione creatrice degli
opposti, e Mircea Eliade, come simbolo della totalit, della
coincidentia oppositorum, che trascende la polarit maschio-femmina.
Il fatto che una simile visione unidirezionale non sia presente in ambito
ebraico rappresenta forse unulteriore prova della debolezza della tesi
scholemiana contestata da Idel secondo cui la Qabbalah una forma
di gnosticismo in ambito ebraico. Lassenza di una simile visione
nellambito del pensiero precabbalistico probabilmente dovuta alla
relativa autonomia della religione ebraica dalla metafisica e dalla teologia
in quella fase. Ma degno di nota che anche quando, nel periodo
medioevale, la teologia ebbe sempre pi peso nel pensiero ebraico e le
correnti mistiche presero corpo in modo esplicito nel movimento
cabbalistico, la visione del rapporto tra Dio e luomo assunse un carattere
sempre pi marcatamente bidirezionale. In particolare, la Qabbalah
teosofico-teurgica (cui appartiene lopera cabbalistica pi nota, lo Zohar)
si bas sullidea di una corrispondenza completa tra atti di culto e vita
divina: competeva ai primi favorire la riconciliazione degli aspetti
dualistici della seconda.
Si noti, al riguardo, che la stessa nozione di androginia, sia nel
senso di Jung che in quello di Eliade, non coerente con le concezioni
ebraiche. noto che una rappresentazione bisessuale emerge in Genesi
4
1.24 quando si dice che Dio cre gli uomini secondo la sua immagine;
[] maschio e femmina li cre. Ma la tradizione della mistica ebraica
non fa tanto riferimento allimmagine di una figura androgina che
corrisponde piuttosto a quella dellermafrodita quanto a quella del
cosiddetto du-partzufin, essere bifronte, letteralmente due facce. Il
du-partzufin rappresenta una condizione primordiale schiena a schiena
che ricorda il mito platonico la quale tuttavia insoddisfacente in
quanto non consente la procreazione e quindi trova la sua risoluzione
nella modalit di azione faccia a faccia, elogiata dallo Zohar. La
modalit faccia a faccia evoca anche la condizione in cui si trovato
Mos di fronte a Dio al momento della rivelazione. Un altro passaggio
biblico fondamentale, al riguardo, quello di Numeri 7. 89, in cui Mos
udiva la voce di Dio (la presenza divina o Shekinah) tra due cherubini nel
Tabernacolo. Essi si rivolgevano luno verso laltro quando Israele
adempiva ai voleri di Dio, mentre si ponevano schiena a schiena quando
peccava. Il Talmud commenta cos: Quando Israele saliva in
pellegrinaggio, i sacerdoti [] mostravano loro i cherubini abbracciati
luno allaltro, e dicevano loro: Vedete, il vostro amore di fronte a Dio
come lamore del maschio e della femmina. Qui limmagine della
ricomposizione amorosa dellessere bifronte rappresenta larmonia tra
Dio e uomo. Pertanto, il rapporto uomo-Dio attraversa i canali
dellemanazione per via discendente e ascendente. Come dice Idel il
mistico aspira a una radicale riorganizzazione dellessere, trascendendo
lesistenza ordinaria. Egli separa ci che unito, vale a dire lanima, o
lintelletto, e il corpo, ma unisce ci che separato, lo sposo e la sposa,
vale a dire lo spirituale nelluomo e lo spirituale nella realt esterna.
Tra le tante citazioni che si potrebbero fare di questa tensione
erotica verso la ricomposizione armoniosa, e di cui il libro di Idel pieno,
appare molto significativo questo brano del cabbalista spagnolo
medioevale Abraham Abulafia: Esso basato sulla ghematria (o
equazione numerologica) che stabilisce che il Tetragramma, avendo
valore numerico 26, equivalente alla somma di amore e uno,
entrambi aventi valore 13, ed anche equivalente a due volte amore o
due volte uno: Il nome divino composto di due parti, poich vi sono
due parti damore fra due amanti, e diventano una sola quando lamore
realizzato. Lamore intellettuale divino e lamore intellettuale umano si
congiungono diventando una cosa sola. Proprio cos il nome di Dio
include le parole uno uno, poich lesistenza umana connessa con
lesistenza divina durante lintellezione []. Questo il grande potere
delluomo: egli pu collegare la parte inferiore con quella superiore, e la
inferiore si innalzer e si unir alla superiore, e la parte superiore
discender e bacer lentit che sale verso di essa, come uno sposo bacia
5
la sposa per via del suo desiderio grande e reale, caratteristico della
delizia di entrambi, per il potere del nome di Dio.
In un autore rinascimentale come Leone Ebreo Rebb Yehuda
Abravanel, di cui il libro analizza le riflessioni sullandrogino questa
visione assurge a toni universali che Idel definisce un cosmoerotismo.
Nei suoi Dialoghi damore Leone Ebreo osserva che dunque
lamoroso matrimonio de luomo e de la donna simulacro del sacro e
divino matrimonio del sommo bello e de la somma bellezza, di che tutto
luniverso proviene.
Insistiamo sul fatto che queste speculazioni sul rapporto tra eros e
vita divina mettono in luce come nella storia del pensiero religioso
ebraico siano emerse visioni della divinit assai pi dinamiche e
complesse di quella che riduce Dio a puro intelletto. Questa articolazione
raggiunge livelli molto spinti nel pensiero cabbalistico. Secondo Idel,
possiamo parlare da un lato della creazione di una personalit divina pi
complessa di quella propria dellebraismo anteriore, e che talora si evolve
in una biografia divina, da un lato dellinclusione, nello schema teosofico,
di una struttura familiare, sicch spesso le relazioni tra manifestazioni
divine sono descritte mediante le nozioni di padre, madre, figlio e figlia.
in questa seconda corrente che fu stabilito un rapporto di affinit fra la
struttura divina complessa e dinamica da una parte, e i rituali dallaltra,
nesso che ha dato origine a concetti teologici che hanno informato la
Qabbalah teosofico-teurgica. In questa complessit della vita divina
possiamo identificare gli influssi pi profondi che sono intercorsi tra
ebraismo e cristianesimo. Non c dubbio che la nozione di Keneset
Israel, unentit ipostatica che rappresenta la comunit o assemblea
dIsraele e che spesso posta in relazione damore con Dio ha come
corrispettivo lEcclesia cristiana. viceversa sorprendente cogliere gli
influssi del culto mariano in un brano cabbalistico composto in Spagna
attorno al 1470: Il Santo, sia Egli benedetto, si era riconciliato con
Israele, e questi sono i giorni di assoluzione e di perdono, e questo il
mistero della vergine, che nessun uomo aveva ancora conosciuto. []
C una vergine vera e propria fatta di fuoco, ed sessualmente ricettiva,
e questa sembianza stata creata per Israele, in quanto sposa e vergine
[]. Nel tempo della redenzione, il mistero del Messia si manifester a
Israele. Fino a quel tempo essa rester una vergine, e allora lo spirito
celeste entrer nella sua bocca []. Per questo la costellazione di
Israele e questo il significato del versetto: Sorgi, vergine di Israele.
Concludiamo osservando che non sarebbe stato possibile offrire
una simile ricchezza di temi e di spunti se lautore si fosse attenuto a un
approccio rigido, improntato ad una metodologia codificata, anzich
aderire con una molteplicit di strumenti analitici alla specificit storica
dei testi. Divento sospettoso osserva Idel ogniqualvolta la variegata
6
letteratura cabbalistica viene presentata come consonante con un
qualunque particolare sistema psicologico o filosofico moderno. Ritengo
che un approccio del genere riduca gli universi culturali medioevali a
teorie moderne o postmoderne, e rischi di trasformare lo studio scientifico
in un esercizio di proiezione del moderno sul medioevale: in breve in un
gioco anacronistico. In fondo, per quale ragione tutti i cabbalisti, o anche
solo la maggior parte di loro, avrebbero dovuto aderire a un modello
culturalmente condizionato, scoperto da Freud, modificato da Jacques
Lacan e adattato al femminismo contemporaneo da Luce Irigaray, e in un
modo cos totalizzante da non consentire alcuna eccezione
significativa?.
A noi la risposta sembra ovvia: per nessun motivo al mondo. Ci
stupisce piuttosto che si debba essere costretti a difendere idee cos
sensate ed evidenti, e che costituiscono la base stessa di unanalisi
scientifica degna di questo nome. il sintomo di quanto siano opprimenti
il bigottismo della cultura postmoderna e i suoi schemini preformati, che
prescrivono di verificare se la Qabbalah sia una dottrina fallocentrica
oppure no, come precondizione per considerarla degna di attenzione.
Tanto pi apprezzabile il coraggio di Idel che, dovendo confrontarsi con
tali approcci, ne prende le distanze con nettezza: Poich credo che le
moderne metodologie di studio nelle discipline umanistiche (freudiana,
junghiana, femminista, strutturalista, antropologica, studi culturali, ecc.),
pur avendo contribuito a interpretazioni nuove e pi sfumate di testi o di
tradizioni antiche, riflettano tutte, essenzialmente, programmi sociali
specifici, bench diversi, basati sulla sensibilit del XX secolo, penso
anche che siano poco adatte a illuminarci sulle complessit caratteristiche
del contesto medioevale. Sono strumenti precari e spesso deboli, che
vanno usati con attenzione, buon senso e selettivit, non verit da
proiettare indiscriminatamente su qualunque testo. Nessun approccio
specifico, nessuna metodologia pu da sola aiutarci a comprendere
pienamente la complessit della letteratura cabbalistica, un corpus
vastissimo prodotto in un lungo arco di tempo in contesti religiosi e
sociali diversi.
Giorgio Israel
Potrebbero piacerti anche
- Angeologia PlanetariaDocumento7 pagineAngeologia PlanetariastefanoNessuna valutazione finora
- Abramelin Il Mago - Magia Sacra e Grimoires Segreti - Stefano MayorcaDocumento8 pagineAbramelin Il Mago - Magia Sacra e Grimoires Segreti - Stefano Mayorcatomaso.spagnoloNessuna valutazione finora
- Invocazione Di Samael PDFDocumento5 pagineInvocazione Di Samael PDFVITTORIONessuna valutazione finora
- La Divinazione Tramite Le RuneDocumento5 pagineLa Divinazione Tramite Le Runealfredo81itNessuna valutazione finora
- Kabbalah La Mistica Dei NumeriDocumento13 pagineKabbalah La Mistica Dei NumeriTenebrarum est100% (1)
- Alchimia SessualeDocumento3 pagineAlchimia SessualeChiara Elisabetta ScarfòNessuna valutazione finora
- Adamo, Uomo Tra Due RegniDocumento26 pagineAdamo, Uomo Tra Due Regniblueyes247Nessuna valutazione finora
- Consigli Dello Sceicco El-Khodja Sulla MagiaDocumento22 pagineConsigli Dello Sceicco El-Khodja Sulla MagiagetulionettoNessuna valutazione finora
- Lettere Ebraiche Come Simboli. IdeologiaDocumento53 pagineLettere Ebraiche Come Simboli. IdeologiaLuca BaroniNessuna valutazione finora
- 1970 Il Parsifal Svelato - Samael Aun WeorDocumento267 pagine1970 Il Parsifal Svelato - Samael Aun WeorGnosi Pratiche e LibriNessuna valutazione finora
- Ebook Magia Con Le CARTE 1 PDFDocumento75 pagineEbook Magia Con Le CARTE 1 PDFMax TremontiNessuna valutazione finora
- Cabala e Albero Della VitaDocumento11 pagineCabala e Albero Della VitaparisipromoNessuna valutazione finora
- La Bibbia - Libro Di Magia Ebraica Serie Di Articoli Raccolta Di Sermoni Del Ministero Di Joy of Satan Sull Argomento Della Magia e Della NumerologiaDocumento68 pagineLa Bibbia - Libro Di Magia Ebraica Serie Di Articoli Raccolta Di Sermoni Del Ministero Di Joy of Satan Sull Argomento Della Magia e Della NumerologiaMauro FerialdiNessuna valutazione finora
- I Guerrieri AlchemiciDocumento13 pagineI Guerrieri AlchemiciEmanuele NicolosiNessuna valutazione finora
- La Chiave Di IsideDocumento19 pagineLa Chiave Di IsideSon Nessuno100% (1)
- Significato Lettere EbraicheDocumento31 pagineSignificato Lettere EbraichedadokaidoNessuna valutazione finora
- La Magia Della Parola e Le Piante Magiche, MiracoloseDocumento11 pagineLa Magia Della Parola e Le Piante Magiche, MiracoloseSettemontiErma1Nessuna valutazione finora
- Alfabeto EbraicoDocumento13 pagineAlfabeto EbraicoJoePansaNessuna valutazione finora
- Magia Dei Nodi - Gli Spiriti Di MorganaDocumento9 pagineMagia Dei Nodi - Gli Spiriti Di MorganaFrancoNosedaNessuna valutazione finora
- Padre Nostro e CabalaDocumento5 paginePadre Nostro e CabalafrancescopunzoNessuna valutazione finora
- Magia - Dion Fortune - Levi - SabellicusDocumento10 pagineMagia - Dion Fortune - Levi - SabellicusMax VetranoNessuna valutazione finora
- Il Segreto Delle Sfingi e Il Segreto Dei Segreti Di Re SalomoneDocumento6 pagineIl Segreto Delle Sfingi e Il Segreto Dei Segreti Di Re SalomonezapremNessuna valutazione finora
- Accenni Di Cabala PraticaDocumento21 pagineAccenni Di Cabala PraticaAnonymous FaJ8Z8fNessuna valutazione finora
- Spiriti ElementariDocumento7 pagineSpiriti ElementariSilvia VialeNessuna valutazione finora
- Angeli e Diavoli Custodi - DefDocumento70 pagineAngeli e Diavoli Custodi - Deftomaso1957100% (1)
- Alchimia SpiritualeDocumento59 pagineAlchimia SpiritualeMorgana_Var_r_5872Nessuna valutazione finora
- Il Potere Dei SalmiDocumento2 pagineIl Potere Dei SalmiClaudia PerilloNessuna valutazione finora
- Il Suo Modo Di Fare Magia - Aleister CrowleyDocumento11 pagineIl Suo Modo Di Fare Magia - Aleister Crowleygfer80100% (1)
- Purificare Con Le ErbeDocumento2 paginePurificare Con Le Erbecarlo47Nessuna valutazione finora
- Come Fare Il Cerchio MagicoDocumento6 pagineCome Fare Il Cerchio Magicopaolo_ukNessuna valutazione finora
- A.O.Spare IntroDocumento5 pagineA.O.Spare IntroChris PanoNessuna valutazione finora
- RochelDocumento92 pagineRochelOja AriaNessuna valutazione finora
- Preghiera RussaDocumento3 paginePreghiera RussamassimopupilloNessuna valutazione finora
- Sotto Il Segno Di CagliostroDocumento18 pagineSotto Il Segno Di CagliostroSerena GasperiniNessuna valutazione finora
- Astrologia CabalisticaDocumento7 pagineAstrologia Cabalisticagino attaNessuna valutazione finora
- La Bibbia CensurataDocumento3 pagineLa Bibbia Censuratababonzo100% (2)
- Medicina EgiziaDocumento6 pagineMedicina Egiziatormael_56Nessuna valutazione finora
- Gli Angeli Nella CabalaDocumento32 pagineGli Angeli Nella CabalaDavide LoddoNessuna valutazione finora
- Il Mondo Magico Della SanteriaDocumento10 pagineIl Mondo Magico Della SanteriaGiacomo LiveraniNessuna valutazione finora
- Le Candele PiromanziaDocumento3 pagineLe Candele PiromanziaaerdnaNessuna valutazione finora
- SLdC1 6x9 PreviewDocumento20 pagineSLdC1 6x9 PreviewWietoNessuna valutazione finora
- Estratto Da Essere Reale, Essere Reali - Il Rituale Del MaithunaDocumento22 pagineEstratto Da Essere Reale, Essere Reali - Il Rituale Del MaithunalucaNessuna valutazione finora
- Oli Essenziali Erbe e IncensiDocumento8 pagineOli Essenziali Erbe e IncensiValentina F. Neliel100% (1)
- Horus Il Giovane (Arpocrate) e Il Silenzio IniziaticoDocumento6 pagineHorus Il Giovane (Arpocrate) e Il Silenzio IniziaticoEsonet.orgNessuna valutazione finora
- Appunti Studio Tarocchi KierDocumento1 paginaAppunti Studio Tarocchi KierqwertyuiNessuna valutazione finora
- Scaligero, Massimo - Dallo Yoga Alla Rosacroce PDFDocumento120 pagineScaligero, Massimo - Dallo Yoga Alla Rosacroce PDFabenati68100% (1)
- Cabala Dion FortunaeDocumento10 pagineCabala Dion FortunaePierre-Alexandre NicolasNessuna valutazione finora
- I Figli del Tuono: Biografia di una iniziazione solareDa EverandI Figli del Tuono: Biografia di una iniziazione solareNessuna valutazione finora
- Stregapedia della Prosperità: Rituali di prosperità e abbondanza per la ricchezzaDa EverandStregapedia della Prosperità: Rituali di prosperità e abbondanza per la ricchezzaNessuna valutazione finora
- L’Immaginazione non è uno stato mentale: è l’esistenza umana stessa: La presenza viva dei simboli dalla storia più antica fino ai giorni nostri, e l’importanza dell’immaginazione per scoprire e costruire il senso del mondo.Da EverandL’Immaginazione non è uno stato mentale: è l’esistenza umana stessa: La presenza viva dei simboli dalla storia più antica fino ai giorni nostri, e l’importanza dell’immaginazione per scoprire e costruire il senso del mondo.Nessuna valutazione finora
- Geometria del male: Una misteriosa pergamena templare, una setta sopravvissuta nel corso dei millenni, una cospirazione ordita nei confronti dell'umanitàDa EverandGeometria del male: Una misteriosa pergamena templare, una setta sopravvissuta nel corso dei millenni, una cospirazione ordita nei confronti dell'umanitàNessuna valutazione finora
- Apr 2009Documento48 pagineApr 2009solmiNessuna valutazione finora
- Capitol Ox VDocumento31 pagineCapitol Ox VsolmiNessuna valutazione finora
- Mar 2009Documento44 pagineMar 2009solmiNessuna valutazione finora
- La Kabbala LurianicaDocumento23 pagineLa Kabbala LurianicasolmiNessuna valutazione finora
- RitualiDeiGradiMassonici Massoneria Apprendista Compagno MaestroDocumento85 pagineRitualiDeiGradiMassonici Massoneria Apprendista Compagno MaestroafugooahNessuna valutazione finora
- Il GR or Di Napoli Nel Periodo NapoleonicoDocumento5 pagineIl GR or Di Napoli Nel Periodo NapoleonicosolmiNessuna valutazione finora
- Preghiere Di LiberazioneDocumento8 paginePreghiere Di Liberazionediv100% (1)
- Tra Re - Kerygma e MetanoiaDocumento101 pagineTra Re - Kerygma e MetanoiaMichał SzczurowskiNessuna valutazione finora
- Issue Nr. 9: 02. Il Filo Di Aracne. Variazioni e Riscritture Italiane - Daniela Codeluppi (Università Di Parma)Documento28 pagineIssue Nr. 9: 02. Il Filo Di Aracne. Variazioni e Riscritture Italiane - Daniela Codeluppi (Università Di Parma)Parole rubate. Rivista internazionale di studi sulla citazione / Purloined Letters. An International Journal of Quotation StudiesNessuna valutazione finora
- Verifica Storia LongobardiDocumento1 paginaVerifica Storia LongobardiFrancesco LaganàNessuna valutazione finora
- 013 B V AddolorataDocumento29 pagine013 B V AddolorataLuca BriatoneNessuna valutazione finora
- Riassunto Storia Politica Della Repubblica 1943 2006 - Appunti Di Storia ContemporaneaDocumento50 pagineRiassunto Storia Politica Della Repubblica 1943 2006 - Appunti Di Storia ContemporaneaAle AleNessuna valutazione finora
- La Svolta Di GiottoDocumento128 pagineLa Svolta Di GiottosaraNessuna valutazione finora
- Arnaldo MomiglianoDocumento13 pagineArnaldo Momiglianolsilva29Nessuna valutazione finora
- Materiale Visite Guidate Ciro PDFDocumento59 pagineMateriale Visite Guidate Ciro PDFBenedettaNessuna valutazione finora
- Gottfried SeumeDocumento4 pagineGottfried Seumebibliotecaminio7817Nessuna valutazione finora
- Guida 311207Documento100 pagineGuida 311207ilexNessuna valutazione finora
- Il Rotolo Di RutDocumento6 pagineIl Rotolo Di RutDaveNessuna valutazione finora
- Il Beato Pietro Bonilli - Stampa 4,1 - 2,3Documento4 pagineIl Beato Pietro Bonilli - Stampa 4,1 - 2,3TreSacriCuori di Gesù, Maria e GiuseppeNessuna valutazione finora
- Concilio Vaticano SecondoDocumento1 paginaConcilio Vaticano Secondoado'sNessuna valutazione finora
- Catálogo Bose 2017Documento23 pagineCatálogo Bose 2017agnesosaNessuna valutazione finora
- 2013 DEL NEGRO Montecuccoli e La Guerra Contro Il Turco in UngheriaDocumento15 pagine2013 DEL NEGRO Montecuccoli e La Guerra Contro Il Turco in UngheriaVirgilio_Ilari100% (1)
- Euripide - BaccantiDocumento27 pagineEuripide - BaccantiDeborah ヅ CiculiNessuna valutazione finora
- Disposizione Del Coro - Choraliter-40-2013 - InnominatoDocumento10 pagineDisposizione Del Coro - Choraliter-40-2013 - Innominatorzzt1078256Nessuna valutazione finora
- Canti Di NataleDocumento7 pagineCanti Di NataleLuNessuna valutazione finora