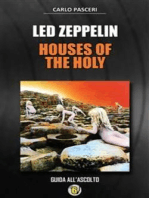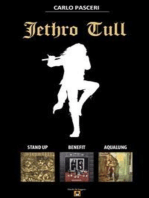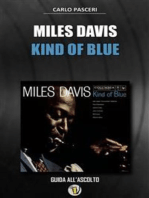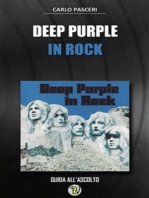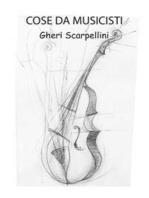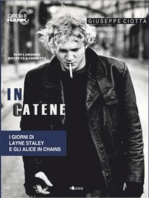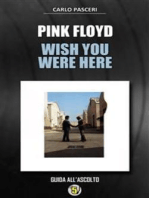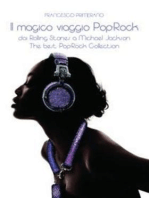Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
NUCLEUS - We'll Talk About It Later
Caricato da
robertogarino0201Titolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
NUCLEUS - We'll Talk About It Later
Caricato da
robertogarino0201Copyright:
Formati disponibili
NUCLEUS – WE’LL TALK ABOUT IT LATER (Marzo 1971)
Certa musica solletica il cervello, lo punta verso una direzione che non possiamo
nemmeno identificare, lo tuffa in una vertigine che, ben lungi dall'essere caotica, è in realtà
una costruzione architettata al millimetro. Qualcosa che ci arricchisce.
"We'll Talk About It Later" è un esempio di quella certa musica. Musica per i neuroni. Un
album che l'ensemble riunito intorno a Carr registra in una manciata di giorni sotto
l'influsso della vittoria al Festival Jazz di Montreaux. In quell'occasione i Nucleus
avevano suonato un set di venti minuti trascinato da vari temi tutti diversi e concatenati,
qualcosa che già era nelle loro corde già dal disco di esordio. E infatti nel loro secondo
lavoro (presentato da un'altra bellissima cover, stavolta targata Roger Dean) le
composizioni si dilatano, assumono una dinamicità e una spinta nuova e del tutto
inaspettata, molto più colorata rispetto alla sobrietà e ai toni dimessi di "Elastic Rock".
Cosa più importante, i nostri qui sono una vera band, un gruppo solido (e purtroppo
effimero) che ruota soprattutto intorno al pirotecnico asse Jenkins - Spedding. Prendiamo
"Song For The Bearded Lady": un inizio che già mette le sinapsi sull'attenti, un pezzo
unico, partorito dall'oboista ma partecipato da tutti con un'energia quasi estatica. E'
trascinante, riflessivo, metodico, vivo in tutto e per tutto.
La caratteristica di "We'll Talk" è proprio questa sua vitalità cangiante, cerebrale eppure
diretta, complessa eppure perfettamente equilibrata: in questo senso i solismi non
sono mai fine a sé stessi, ma sono cullati, motivati, come nella solidissima "Sun Child",
guidata dall'oboe, che tra l'altro fa emergere la polipesca e raffinata abilità di John
Marshall, uno che dietro alle pelli fa quello che vuole. A conferma del fatto che nella
categoria del jazz-rock i Nucleus ci stanno proprio stretti c'è il tocco esotico e delicato di
"Lullaby For a Lonely Child": retto dai fiati di Carr e Brian Smith, ciò che lo caratterizza
maggiormente è però il sorprendente bouzouki (una specie di banjo alla greca) suonato da
Spedding, che ci accarezza la coscienza con ficcante gentilezza. E poi ancora energia
pulsante nelle title track, dove in prima linea è ancora Spedding, che non ha l'esplosività
tecnica di Allan Holdsworth ma ha un gusto per le cesellature e le finezza ritmiche che ci
fa crollare in ginocchio inebriati. I poderosi botta e risposta tra lui e Jenkins cementati da
Marshall sono vera manna per le orecchie e per ciò che ci sta in mezzo, e manna sono gli
sperimentalismi ritmici e atmosferici di "Oasis", quasi dieci minuti di racconto mentale,
ipnosi in cui il suono rotondo della tromba si incrocia con lo strillo dell'oboe. Ma abbiamo
anche la freschezza, l'agilità e l'apparente cialtroneria di "Ballad Of Joe Pimp", uno dei
pochissimi brani cantati della band, sbalorditivo omaggio e "giù il cappello" per il baffo
Frank e il suo pappone di "Hot Rats". Credo che la voce sia di Spedding (già cantante su
"Mantle Piece" del progetto Battered Ornaments) che si esibisce anche in "controcanti"
con chitarre sovraincise e wah-wah.
Il finale è corale, figlio maggiore di "Battle of Boogaloo", rutilante e poderoso. "Easter
1916", ispirata ai moti irlandesi di quell'anno, è una vera e propria maratona, e come tale
ha la sua vita e la sua progressione: tutti in pista al via, lanciati in un'improvvisazione
all'inizio guidata, poi sciolta e fiammante,c'è anche una voce roca e particolare che
diviene strumento essa stessa. Poi pian piano si delineano le posizioni, e gli strumenti
scivolano lontano; prima lascia la voce, poi la chitarra, il basso, alla fine i duellanti
rimangono in due, sax e batteria, a rincorrersi, cercarsi, sfidarsi ed evitarsi. La spunta
Marshall, suo il proscenio, quaranta secondi di lucida foga batteristica, rullata e stop.
Questo liquido sonoro è linfa per i cervelli attenti; un disco unico che si riscopre, e vi
riscopre, ogni volta.
Potrebbero piacerti anche
- Genesis 1970-1976: Viaggio musicale da Trespass a Wind & WutheringDa EverandGenesis 1970-1976: Viaggio musicale da Trespass a Wind & WutheringValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Led Zeppelin - Houses of the Holy (Dischi da leggere)Da EverandLed Zeppelin - Houses of the Holy (Dischi da leggere)Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Il sussurro del serpente: messaggi satanici nella musica rockDa EverandIl sussurro del serpente: messaggi satanici nella musica rockNessuna valutazione finora
- Miles Davis - Kind of Blue (Dischi da leggere)Da EverandMiles Davis - Kind of Blue (Dischi da leggere)Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (2)
- Return to Forever - Hymn of the Seventh Galaxy (Dischi da leggere)Da EverandReturn to Forever - Hymn of the Seventh Galaxy (Dischi da leggere)Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- John Coltrane - A Love Supreme (Dischi da leggere)Da EverandJohn Coltrane - A Love Supreme (Dischi da leggere)Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Fiori Al Quadrato EnsembleDocumento1 paginaFiori Al Quadrato EnsembleAUGUSTA DALL'ARCHENessuna valutazione finora
- T.2-1 Jazz in Bianco e Nero, Gli Anni '50 (Tr. 2 - CD 1)Documento23 pagineT.2-1 Jazz in Bianco e Nero, Gli Anni '50 (Tr. 2 - CD 1)Luca Luke Cupido PortnoyNessuna valutazione finora
- Light My FireDocumento5 pagineLight My FireJacopo FerrazzaNessuna valutazione finora
- Fanno Rock Come Se Non Ci FosseDocumento75 pagineFanno Rock Come Se Non Ci Fossejordan_beljuliNessuna valutazione finora
- Television - TelevisionDocumento1 paginaTelevision - TelevisionJackNessuna valutazione finora
- Dieci dischi sul mondo Red Hot Chili Peppers che (forse) non conosci beneDa EverandDieci dischi sul mondo Red Hot Chili Peppers che (forse) non conosci beneNessuna valutazione finora
- Be-Bop e Cool JazzDocumento2 pagineBe-Bop e Cool JazzAnonymous ndDdTbAfNessuna valutazione finora
- Dark Wave Musica Dello SpiritoDocumento2 pagineDark Wave Musica Dello SpiritolullabyNessuna valutazione finora
- CacciniDocumento2 pagineCacciniAlessio PizNessuna valutazione finora
- Pink Floyd 1967-1972 - Gli anni sperimentaliDa EverandPink Floyd 1967-1972 - Gli anni sperimentaliValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- CHICAGODocumento1 paginaCHICAGOrobertogarino0201Nessuna valutazione finora
- In catene. I giorni di Layne Staley e gli Alice In ChainsDa EverandIn catene. I giorni di Layne Staley e gli Alice In ChainsNessuna valutazione finora
- Ti sparo i Deep?: Vita, cover e miracoli di convintissime rock band di paeseDa EverandTi sparo i Deep?: Vita, cover e miracoli di convintissime rock band di paeseNessuna valutazione finora
- Tesi ConfalonieriDocumento49 pagineTesi ConfalonieriMarco ConfalonieriNessuna valutazione finora
- Pink Floyd - Wish You Were Here (Dischi da leggere)Da EverandPink Floyd - Wish You Were Here (Dischi da leggere)Valutazione: 3 su 5 stelle3/5 (2)
- Rock Progressivo Italiano Vol. 1Documento16 pagineRock Progressivo Italiano Vol. 1mirco1988Nessuna valutazione finora
- Musica '70. L'età aurea: progressioni rock per il futuroDa EverandMusica '70. L'età aurea: progressioni rock per il futuroValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1)
- David Sylvian MusicografiaDocumento7 pagineDavid Sylvian MusicografiastefanoNessuna valutazione finora
- 20 dopo Kurt: 20 anni e 20 dischi dalla morte di CobainDa Everand20 dopo Kurt: 20 anni e 20 dischi dalla morte di CobainNessuna valutazione finora
- Analisi Degli Standards ST Thomas - A Night in Tunisia - Godchild-1 PDFDocumento10 pagineAnalisi Degli Standards ST Thomas - A Night in Tunisia - Godchild-1 PDFAlessa ChiappinelliNessuna valutazione finora
- Soft Machine 4Documento5 pagineSoft Machine 4PieraRaiaNessuna valutazione finora
- Commenti Dischi Milton NascimentoDocumento4 pagineCommenti Dischi Milton NascimentoGiuliaNessuna valutazione finora
- Sun Ra2Documento4 pagineSun Ra2Gennarino ParsifalloNessuna valutazione finora
- Cage Il Precursore, Salvatore Caruselli 1975Documento2 pagineCage Il Precursore, Salvatore Caruselli 1975Gianluca SalcuniNessuna valutazione finora
- Miles Davis - Bitches Brew (Dischi da leggere)Da EverandMiles Davis - Bitches Brew (Dischi da leggere)Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Sex Pistols: Dio salvi la regina (e il punk rock)Da EverandSex Pistols: Dio salvi la regina (e il punk rock)Nessuna valutazione finora
- Shostakovic 24 Preludi e Fughe Op.87Documento7 pagineShostakovic 24 Preludi e Fughe Op.87Giorgio PlanesioNessuna valutazione finora
- Niccolò CastiglioniDocumento7 pagineNiccolò CastiglioniGiorgio PlanesioNessuna valutazione finora
- Supreme Kind of Brew. Tre capolavori Jazz: riscoperta e nuove prospettiveDa EverandSupreme Kind of Brew. Tre capolavori Jazz: riscoperta e nuove prospettiveValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Il magico viaggio Pop - Rock...dai Rolling Stones a Michael JacksonDa EverandIl magico viaggio Pop - Rock...dai Rolling Stones a Michael JacksonNessuna valutazione finora
- Il Sassofono e Il Linguaggio Del JazzDocumento5 pagineIl Sassofono e Il Linguaggio Del JazzEthan BoniniNessuna valutazione finora
- Paolo RicucciDocumento17 paginePaolo RicuccialiceadslNessuna valutazione finora
- 50 years of Rock: Beatles, Pink Floyd, Queen, Vasco Rossi & LigabueDa Everand50 years of Rock: Beatles, Pink Floyd, Queen, Vasco Rossi & LigabueNessuna valutazione finora
- Vermi Sonori e Usignoli MeccaniciDocumento11 pagineVermi Sonori e Usignoli MeccaniciDomenico Lo VetroNessuna valutazione finora
- LA STORIA DEL POP ROCK 2.0: Dai primordi della Musica al Rock'n'Roll, da John Lennon a Freddie Mercury, dal Pop.Rock anni 80' e 90' al Rap'n'Roll, da David Bowie a Kurt Cobain, da Vasco Rossi a Renato ZeroDa EverandLA STORIA DEL POP ROCK 2.0: Dai primordi della Musica al Rock'n'Roll, da John Lennon a Freddie Mercury, dal Pop.Rock anni 80' e 90' al Rap'n'Roll, da David Bowie a Kurt Cobain, da Vasco Rossi a Renato ZeroNessuna valutazione finora
- Hard Rock Emotions: Un viaggio attraverso la musica più elettrica degli ultimi cinquant’anniDa EverandHard Rock Emotions: Un viaggio attraverso la musica più elettrica degli ultimi cinquant’anniValutazione: 1.5 su 5 stelle1.5/5 (2)
- Le Melodie Del NataleDocumento17 pagineLe Melodie Del NataleFoundation for Africa20% (5)
- James Brown. Live at The Apollo.Documento3 pagineJames Brown. Live at The Apollo.spammagazineNessuna valutazione finora
- Spanish Flea TrumpetDocumento9 pagineSpanish Flea Trumpetsassyfrasman100% (1)
- Analisi OleoDocumento2 pagineAnalisi OleoPhil BassNessuna valutazione finora
- Storia e Evoluzione Batteria JazzDocumento4 pagineStoria e Evoluzione Batteria JazzDanielePavignanoNessuna valutazione finora
- Finale 2005a - (Il Rosso e Il Nero Partitura PDFDocumento4 pagineFinale 2005a - (Il Rosso e Il Nero Partitura PDFpastycciottoNessuna valutazione finora
- Rock Medley PDFDocumento9 pagineRock Medley PDFPapageorgiou GeorgeNessuna valutazione finora
- Veronique (Sammy Nestico)Documento10 pagineVeronique (Sammy Nestico)Dude Man100% (2)
- Chi Tarra RockabillyDocumento8 pagineChi Tarra RockabillyAndrea PiovesanaNessuna valutazione finora
- Piano en Salsa Brava Vol. 2 - Gio Miranda DEMODocumento10 paginePiano en Salsa Brava Vol. 2 - Gio Miranda DEMOGio MirandaNessuna valutazione finora
- Jazz GazzetteDocumento16 pagineJazz GazzettejazzasconaNessuna valutazione finora
- Storia Dell'hip HopDocumento9 pagineStoria Dell'hip HopDamiano PuleoNessuna valutazione finora
- Max Roach Ed AltroDocumento9 pagineMax Roach Ed AltroNicola ToroNessuna valutazione finora
- DCPL-67 Pop-Rock Basso ElettricoDocumento4 pagineDCPL-67 Pop-Rock Basso ElettricoSimon UkaNessuna valutazione finora
- JazzDocumento2 pagineJazzLorenzo CeciNessuna valutazione finora
- Abba Gold - FlautoDocumento2 pagineAbba Gold - FlautoMauro VergimigliNessuna valutazione finora
- Caricamento 1Documento5 pagineCaricamento 1maddafakeNessuna valutazione finora
- ROCKERDocumento2 pagineROCKERGiulio JesiNessuna valutazione finora
- Le Caratteristiche Della Popular MusicDocumento2 pagineLe Caratteristiche Della Popular MusicSimona RiccoNessuna valutazione finora
- Ferrara Buskers Festival - WikipediaDocumento32 pagineFerrara Buskers Festival - WikipediaRoberto RolfoNessuna valutazione finora
- Jazzitalia - Lezioni - Chitarra - Pensare Velocemente Alle Scale. Accordo Di Dominante (7a)Documento7 pagineJazzitalia - Lezioni - Chitarra - Pensare Velocemente Alle Scale. Accordo Di Dominante (7a)Enrico De PaolaNessuna valutazione finora
- Jazz Libri LogoDocumento22 pagineJazz Libri LogoValentina MadonnaNessuna valutazione finora