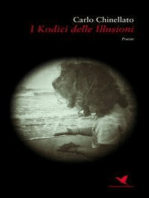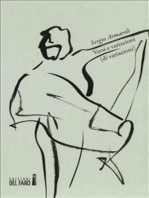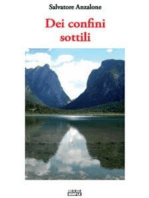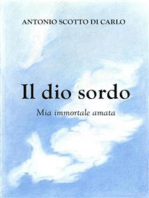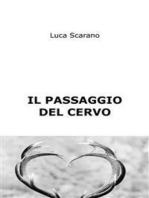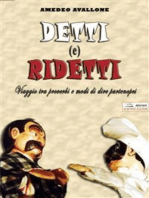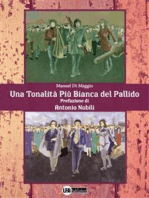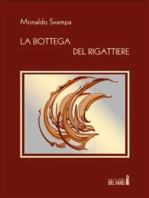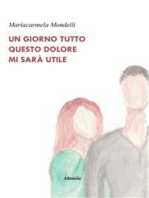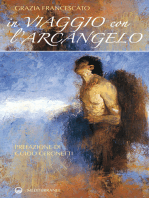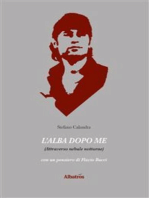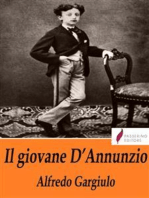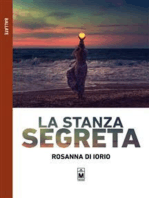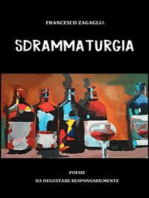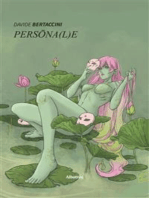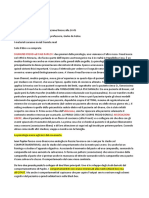Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Edoardo Sanguineti - Su Dino Campana
Caricato da
anna maria spingola0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
119 visualizzazioni9 pagineCopyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
119 visualizzazioni9 pagineEdoardo Sanguineti - Su Dino Campana
Caricato da
anna maria spingolaCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 9
Edoardo Sanguineti
TESTIMONIANZA DI UN LETTORE
in A.R.Gentilini (a c. di),
Dino Campana alla fine del secolo,
Bologna, Il Mulino, 1999 (pp.51-62)
E d o a r d o S a n g u in e ti
TESTIMONIANZA DI UN LETTORE
[...] se la mia testimonianza come si addice
ai processi - anche se questa non è una sede processuale -
consiste in testimonianza a favore o contro, io propongo
la mia come a favore, toccando due soli punti che però
mi sembrano quelli nodali e anche quelli forse meno vo
lentieri, per certi riguardi, affrontati, ma in qualche
modo imprescindibili. Il primo è proprio la questione del
rapporto biografia-opera: questione estremamente spinosa
che si tende volentieri, ed è comprensibile, in qualche
modo ad accantonare; poesia e follia è un binomio sul
quale è molto facile perdersi davvero, o per eccessi di en
tusiasmo di fronte a una sorte di sacralità delirante o per
un imbarazzo che ripiega nettamente sul versante lettera
rio (dell'uomo non vogliamo sapere nulla, stiamo ai testi,
il resto è pura confusione e caos).
Nel ’69 io parlavo dell’opportunità di ridimensionare
il mito di un Rimbaud italiano che circondava Campana,
ma dicevo anche che lo preferivo in ogni caso ad un ec
cesso di riduzione letteraria sul quale poi si è molto, e a
mio parere troppo, insistito. Non voglio affrontare una
questione, diciamo così, diagnostica nei confronti di
Campana, che non solo non sarebbe nelle mie competen
ze, ma poi non sarebbe di grande interesse, voglio però
fare un paio di osservazioni minime al riguardo. Ci sono
due sintomi, ,che, per quello che noi sappiamo, sono
quelli con* cui Campana paga la propria sofferenza esi
stenziale, sono la caffeinomania e la pulsione al vagabon
daggio. Questi sono, come dire, gli argomenti accusatori
da un punto di vista di rigore medico, confessati da
Campana stesso, anzi è lui la fonte poi di queste indica
zioni, e intorno ai quali argomenti si è avuto vario com
mento. Voglio prestare un minimo di attenzione alla caf-
feinomania, che naturalmente oggi farà sorridere, nella
cultura della droga in cui ci troviamo, ma credo siajnolto
opportuno leggere con cautela e con senso storico certe
categorie che noi possiamo, oso dire dobbiamo, non più
condividere - credo che si possa leggere tranquillamente
Freud con un certo distacco di fronte a certe considera
zioni intorno all’isteria, anche perché quell’isteria di cui
parlava Freud non si trova più, e probabilmente non si
trova più nemmeno la caffeinomania di cui fu indiziato
Campana, ma non per questo mi pare ci sia molto da
sorridere Il mate di Pampa, nei Canpi, appàrtiene un
poco a questo ambito. Ma in sostanza c’è un tipo di dia
gnosi che Campana interiorizza e subisce, diciamo pure
subisce, ma l’interiorizza, perché fa parte di una cultura
d’epoca alla quale non si sottrae né ha la possibilità di
sottrarsi. Allora io credo che valga la pena di accogliere,
non su un piano di analisi psicocritica, legata così ad at
tenzioni biografiche o appunto psicologica o psichica o
psichiatrica, quella sorta di autodiagnosi che Campana
formula quando si presenta come un nevrastenico. Anche
questa parola evidentemente noi non useremmo più clini
camente, e ce ne potremmo avvalere, al più, con qualche
rischio metaforico. Ma se optiamo per la scrittura di un
nevrastenico, assumendola come una sorta di chiave di
uno statuto psichico che si riflette nella pagina, anzi che
è nella pagina, allora il divorzio o la delicata relazione tra
biografia e testo può ricomporsi proprio perché mette
l’accento su una modalità dello stile, una modalità dicia
mo, se volete, di percezione e non sopra un accidente
eventualmente accantonabile della figura dello scrivente.
Se dovessi indicare un archetipo, che non è una fonte
ma potrebbe benissimo esserlo, penserei a qualcosa di si
mile all’uomo del sottosuolo, per capirci, all’uomo malato
e maligno che soffre di fegato e che da questa sorta di
condizione deduce poi una modalità di comportamento
molto più, perché questo poi ci interessa, molto più scrit
torio, ripeto, che esistenziale. Vorrei, - il fatto di parlare
da testimone mi esime da argomentazioni documentarie
ma qualche minima citazione ci vuole - vorrei leggere
due passi appena della Giornata di un nevrastenico pro
prio come esempi di modalità scrittoria:
* (Caffè) È passata la Russa. La piaga delle sue labbra ardeva
nel suo viso pallido. È venuta ed è passata portando il fiore e
la piaga delle sue labbra. Con un passo elegante, troppo sem
plice troppo conscio è passata. La neve seguita a cadere e si
scioglie indifferente nel fango della via. La sartina e l’avvocato
ridono e chiaccherano. I cocchieri imbacuccati tirano fuori la
testa dal bavero come bestie stupite. Tutto mi è indifferente.
Oggi risalta tutto il grigio monotono e sporco della città. Tutto
fonde come la neve in questo pantano: e in fondo sento che è
dolce questo dileguarsi di tutto quello che ci ha fatto soffrire.
Tanto più dolce che presto la neve si stenderà ineluttabilmente
in un lenzuolo bianco e allora potremo riposare in sogni bian
chi ancora. C’è uno specchio avanti a me e l’orologio batte: la
luce mi giunge dai portici a traverso le cortine della vetrata.
Prendo la penna: scrivo: cosa, non so: ho il sangue alle dita:
scrivo: «l’amante nella penombra si aggraffia al viso dell’amante
per scarnificare il suo sogno... ecc.».
Vi leggerò ancora le ultime righe di questa Giornata
di un nevrastenico:
Passeggio sotto l’incubo dei portici. Una goccia di luce
sanguina, poi l’ombra, poi una goccia di luce sanguigna, la dol
cezza dei seppelliti. Scompaio in un vicolo ma dall’ombra sotto
un lampione s’imbianca un’ombra che ha le labbra tinte. O Sa
tana, tu che le troie notturne metti in fondo ai quadrivii, o tu
che dall’ombra mostri l’infame cadavere di Ofelia, o Satana
abbi pietà della mia lunga miseria!
Ecco, questa nevrosi da sottosuolo la proporrei come
una chiave di lettura per Campana e il finale, con la deri
vazione da Les litanies de Satan baudeleriane, può jcon-
giungere, diciamo così, in quello strano rimescolarsi che
certamente è la tanto problematica cultura di Campana,
ripeto, non tanto come fonti ma come archetipi, Baudelai
re e Dostoevskij. Mi pare un bell’impasto in ogni caso; e
aggiungo che nel Fascicolo marradese, in prima stesura,
questa Giornata di un nevrastenico si chiudeva con l’ap
parizione della «troia notturna», in questo modo però:
«[...] (Cazzottaste voi mai una troia notturna in fondo ad
un vico gridando: perché perché vuoi tu dall’ombra pa
rermi) (mostrarmi) (il cadavere di Ofelia? E la cazzotto)».
Questo finale va tenuto presente perché, qui espunto, è
però rivelatore di un elemento grottesco e teppistico che
è fortissimo in Campana, una sorta, così mi piacerebbe
Allora dire, se non vi pare abusiva l’espressione, di orfh_
smo teppistico: questa è una formula che mi pare pratica-
b ilen ch e permette di contenere ogni spinta verso tenta
zioni di sublimazione.
Ma quello su cui volevo mettere l’accento è l’altro
sintomo evidentemente: per usare espressioni che Cam
pana impiega parlando al Pariani, «smania di instabilità»,
«mania di vagabondaggio». Ora, basta scorrere, prima
che le pagine, l’indice dei Canti, per trovarsi ossessiva
mente dinanzi a viaggio, ritorno, promenade o petit^pro-
menade, viaggio in montagna, Viaggio a Montevideo, Pas
seggiata in tram in America e ritorno, e poi Ritorno nella
sezione de La Verna: «[...] Riposo ora per l’ultima volta
nella solitudine della foresta. Dante la sua poesia di mo
vimento, [...] O pellegrino, o pellegrini che pensosi anda
te! [...]».
I Canti sono in qualche modo un rendiconto di anni
di pellegrinaggio e, per usare l’espressione che troviamo
ancora in Pampa, si fondano sopra il mito dell’errante,
anzi come dice Campana a poche righe di distanza del-
l’«eternoj errante» (Wanderjahre):
[...] Che cosa fuggiva sulla mia testa? Fuggivano le nuvole
e le stelle, fuggivano: mentre che dalla Pampa nera scossa che
sfuggiva a tratti nella selvaggia nera corsa del vento ora più
forte ora più fievole ora come un lontano fragore ferreo: a trat
ti alla malinconia più profonda dell’errante un richiamo:... dalle
criniere delTerbe scosse come alla malinconia più profonda del
l’eterno errante per la Pampa riscossa come un richiamo che
fuggiva lugubre. [...].
Ora, la poesia del movimento, per usare proprio
l'espressione «la poesia di movimento» di Campana, non
è soltanto del soggetto, è delle cose perché solita in vaga
bondaggio, le nuvole, il vento, la pampa, le stelle: n<p è
soltanto l’errante, sono tutte le realtà che, evocate, sono
colte in una sorta di infrenabile dinamismo. Ma più im
portante anche qui è, direi, cercare di individuare, una
volta assunta la centralità di questo sintomo, quello che
può essere il modulo giacente in una sorta di archetipo.
Allora utilizzerei il titolo di un libro uscito l’anno scorso,
il saggio di Patrizio Collini Wanderung: il viaggio dei ro
mantici, per fornire questa formula: e in particolare, pos
sono servire le pagine che sono dedicate al Lenz di Bùch-
ner. Non discuto anche qui di fonti, tomo a dire si tratta
di modelli. Nella cultura romantica muore il viaggio, si li
quida l’idea di un itinerario, di una organizzazione razio
nale per cui ci si muove per andare da un luogo verso
una meta. U viaggio dei romantici non è più viaggio, c’è
una frattura in qualche modo storica, comincia un errare
che può essere un euforico immergersi nel mondo, nella
natura, una continua scoperta, esplorazione, ma che porta
in sé immediatamente (e il Lenz in questo senso è al soli
to estremamente profetico) i tratti nevrotici che sempre
più diventeranno forti. Allora, questa che per l’ultimo
germano di cui stiamo discorrendo va bene che abbia eti
chetta gotica, è poi quella che in termini appunto alla
Rimbaud potremmo chiamare la storia di un «bateau
ivre», questo è il modello: ubriaca magari di caffè o di
mate al massimo, un’ebrezza un po’ all’italiana quella di
cui soffre Campana, ma in ogni caso con questa pulsione
errabonda, la sua scrittura assume, e assume sempre più
evidentemente, un andamento errabondo. Non è questio
ne solo di una tematica contefiuSstica, di viaggi, di ritor
ni, di promenade ecc. di cui è piena la scrittura campania-
na e con addensamento nella costruzione dell’opera: è
che la scrittura assume questo andamento, si fa errabon
da la sintassi, è la forma delTerranza, dell’instabilità che
organizza il discorso. Allora non è più il voyageur o pro-
meneur, e nemmeno il flàneur quello che è in causa: è
una nevrosi jimbulatoriì-gratpita che proprio passa sulla
pagina, che architetta il discorso (anche Whitman, se vo
lete, può entrare in giuoco e giustificare in maniera meno
romantica forse di quanto il sangue terminale del co
lophon possa suggerire una cosa di questo genere) per’ar
rivare poi ai giorni nostri, senza nessun abuso, ad un’idea
di esperienza della scrittura on thè road. che finalmente è
l’ultimo anello di questo grande mito romantico e dei
suoi eccessi, fino a modellizzare veramente comportamen
ti alternativi, socialmente deplorati o deplorevoli, e pro
prio significativi per questo.
In questo itinerario prendono significato allora, come
percorse da questa erranza, tutte le infinite figure femmi
nili di cui sono pieni i Canti, alte e basse, e propriamente
chimeriche, che spuntano da ogni angolo dell’erranza, le
matrone, le femmine, le troie, le regine, le ancelle, le pas
seggiatrici, le ruffiane, le sacerdotesse, le cariatidi, le zin
gare, le fanciulle, le sartine, le ostesse, le prostitute.^
L'anima di questo Faust «giovane e bello» credo trovi
il suo emblema più significativo in un passo molto breve,
quando ci sono le ragazze della «leggera» che, mi pare,
potrebbero essere indicate come una sorta di forma me
dia di quella costellazione campanìana Chimera-Ofelia-
troia, e che naturalmente è logico trovare là dove si va in
America, e si torna, in tram:
[...] il battello è una casa scossa dal terremoto che pencola
terribilmente [...],
[...] C’erano due povere ragazze sulla poppa: «Leggera, sia
mo della leggera: te non la rivedi più la lanterna di Genova!»
Eh! che importava in fondo! Ballasse ^il bastimento, ballasse
fino a Buenos-Aires: questo dava allegria: e il mare se la rideva
con noi del suo riso così buffo e sornione! Non so se fosse la
bestialità irritante del mare, il disgusto che quel grosso bestione
col suo riso mi dava... basta: i giorni passavano. [...].
Dall’altro lato di questa erranza, gli altri punti capitali
sono i sosia di Campana e qui basta citare due figure
che, calcolatamente certo, appaiono l’una subito prima
del viaggio in tram e l’altra subito dopo: il Russo e Rego
lo. Il Russo, a proposito dell’erranza della penna: «[...]
Febbrile, curva sull’orlo della stufa la testa barbuta, scri
veva. La penna scorreva strideva spasmodica: [...]»; e an
cora poche righe, le ultime, di Regolo:
Voleva partire. Mai ci eravamo piegati a sacrificare alla mo
struosa assurda ragione e ci lasciammo stringendoci semplice-
mente la mano: in quel breve gesto noi ci lasciammo, senza ac
corgercene ci lasciammo: così puri come due iddii noi liberi li
beramente ci abbandonammo all’irreparabile.
Ecco, quest’errare vagabondo, se ha una meta, è l’ir
reparabile, esiste per^un naufragio.
Il secondo punto che tratterò molto più brevemente,
è un punto che per sé è non meno sgradevole ormai di
quello del rapporto follia e scrittura ed è la querelle, pro
prio cui alludevo prima, impostata da Contini tra il visivo
e il veggente. Dirò subito che, a mio parere, l’errore,
come si dice volgarmente, è nel manico e vi spiegò per
ché: Contini cercava di estrarre criticamente da questo
anarchico - parola di Contini - da questo bohémien -
sempre di Contini - quell’uomo d’ordine che era in lui:
questa era la preoccupazione continiana e che Contini
non è riuscito a risolvere. Contini muoye da Rimbaud,
anzi, dal Rimbaud di Soffici, più particolarmente, per
dire la celebre proposizione che vi sentirete rileggere per
la millesima volta: «Campana non è un veggente o un vi
sionario: è un visivo, che è quasi la cosa inversa». Quan
do sistema in volume definitivamente i propri scritti,
Contini addita in nota l’opinione di Montale del 1942 per
cui le corna di questo dilemma non sarebbero affatto in
conciliabili e questa soluzione, per cui le due cose vengo
no conciliate, tende a diventare quella prevalente, e serve
se non alti;o ad accantonare un poco la questione, che
rappresenta una sorta di impasse. Le corna di questo di
lemma, in realtà, si possono accantonare perché non è un
dilemma, ma non nel senso di una composizione, ma per
ché, io suggerirei, e spero non vogliate prendere questa
come una questione di vana logomachia, sono possibili
tre soluzioni e non due, perché non è la stessa cosa il
veggente e il visionario. E allora direi così: Campana non
è un visivo, Campana non è nemmeno un veggente, ma
Campana è visionario, che è un’altra cosa. Non avrà
delle illuminazioni, diciamo così, ma ha delle allucinazio
ni, è un nevrotico, non ha vedute né rivelazioni, ma ha
delle apparizioni; la scrittura di Campana è una scrittura
per apparizioni.
Quando dico Campana non dico tutto Campana, na
turalmente, parlo di quel Campana che ci importa, che ci
sta a cuore, che egli viene costruendo nell’opera secondo
una progressione non meccanica né inerte, e piuttosto
complessa. Allora, cosa faceva Contini? Contini prendeva,
se ricordate, proprio l’inizio de La Notte, la prima pagi
na, per dimostrare che Campana era un visivo - e già
questo è una campionatura da prendersi con molta caute
la - sceglieva cioè il momento proprio d’avvio di Campa
na, quando Campana comincia - parlo dell’architettura
non della cronologia - la sua erranza, e dunque bisogna
procedere cauti, e non di meno questa pagina che do
vrebbe dimostrare quella che Contini chiama «la fe^e» di
Campana - crede nel veduto, nella cosa vista per pòi ca
ricarla indebitamente, come dice Contini, questo sarebbe
il suo sbaglio «d’oscurità indecifrabile» per estrarre «figu
razioni» - e questo mi piace invece, «figurazioni» perché
parola di Campana, precisamente visionaria - ha già un
andamento comunque di tipo allucinatorio, fin dall’inizio,
con quel ricordo che ha già una strategia tutt’altro che
mimetico-registratoria, ma al contrario proprio di stacco
immediato verso una apparizione:
*
Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, arsa su
la pianura sterminata nell’Agosto torrido, con il lontano refri
gerio di colline verdi e molli sullo sfondo. Archi enormemente
vuoti di ponti sul fiume impaludato in magre stagnazioni plum
bee: sagome nere di zingari mobili e silenziose sulla riva: tra il
barbaglio lontano di un canneto lontane forme ignude di ado
lescenti e il profilo e la barba giudaica di un vecchio: e a un
tratto dal mezzo dell’acqua morta le zingare e un canto, da la
palude afona una nenia primordiale monotona e irritante: e del
tempo fu sospeso il corso.
Ecco: «[...] e a un tratto dal mezzo dell’acqua morta
lp zingare e un canto, da la palude afona una nenia,| pri
mordiale monotona e irritante: [...]». Qui attacca Campa
na, nel momento in cui il visivo cessa e, scusate l’elemen
tarità della cosa, è all’ascolto, è per un suono che si ha
uno stacco netto: «[...] e del tempo fu sospeso il corso»
non depone affatto verso una visività che poi Contini in
qualche modo corregge quando dice: «Non siamo di
fronte a un quadro [...]» ma per quello sgangheramento,
se volete diciamo pure dérèglement, del tempo e dello
spazio che qui si manifesta per accidente in questa forma,
ma che altrove comincerà sempre più a sabotare la strut
tura dei Canti nell’erranza in tempi e spazi che non sono
più piegati a quell’«orrore della ragione» di cui parlava
Campana nel passo che vi ho citato a proposito di Rego
lo. La nevrosi errante di Campana scardina spazio e tem
po e la «mostruosa assurda ragione» è quella che invece
viene respinta. Parlare di un visionarismo espressionista
per Campana mi parrebbe la soluzione cEe finalmente
scioglie quell ingombrante ostacolo e quel falso problema
e - questo lo accenno appena - aiuta anche di fronte al
l’abitudine ormai troppo convalidata, secondo me, di
concepire l’espressionismo secondo categorie di stile, se
condo modalità pluristilistiche, plurilinguistiche che ci è
stata solennemente trasmessa, puntare su quello che
l’espressionismo significa secondo me molto più corretta-
mente cioè verso un’ottica di deformazione, di visionarie
tà e finalmente, al limite, di astrazione.
Allora, ancora in omaggio, abusivo questa volta, alle
modalità gotiche che si addicono a un germano, io utiliz
zerei con grande spregiudicatezza una espressione con
nessa alla poetica di Webern, quella della «Klangfarben-
melodie» (della melodia timbrica, ma che in tedesco dice
sempre qualcosa di più, felicemente) per quell’idea dei
colori del suono. E i colori di Campana sono precisamen
te dei colori che hanno una loro dimensione visiva, da ot
tica visionaria perché sono davvero «Klangfarben», sono
veramente colori.di suono e allora, l’ultima citazione - lo
so che è banale^quello che vi cito, ma se vogliamo pren
dere un campione di Campana è inevitabile leggere un
tratto di Genova - là dove Campana per così dire è più
Campana, e non si potrebbe confonderlo in nessun modo
- come potrebbe accadere per l’inizio de La Notte con
qualche prosa frammentistica d’epoca - questo passo in
vece che solo Campana avrebbe potuto scrivere:
Per i vichi marini nell’ambigua/ Sera cacciava il vento tra i
fanali/ Preludii dal groviglio delie navi:/ I palazzi marini avevan
bianchi/ Arabeschi nell’ombra illanguidita/ Ed andavamo io e
la sera ambigua:/ Ed io gli occhi alzavo su ai mille/ E mille e
«mille occhi benevoli/ Delle Chimere nei cieli: .../ Quando,/
Melodiosamente/ D alto sale, il vento come bianca fìnse una vi
sione di Grazia/ Come dalla vicenda infaticabile/ De le nuvole
e de le stelle dentro del cielo serale/ Dentro il vico marino in
alto sale, .../ Dentro il vico ché rosse in alto sale/ Marino l’ali
rosse dei fanali/ Rabescavano l’ombra illanguidita, .../ Che nel
vico marino, in alto sale/ Che bianca e lieve e querula salì!/
«Come nellali rosse dei fanali/ Bianca e rossa nellombra del fa
nale/ Che bianca e lieve e tremula salì:...»/ Ora di già nel rosso
del fanale/ Era già l’ombra faticosamente/ Bianca .../ Bianca
quando nel rosso del fanale/ Bianca lontana faticosamente/
L’eco attonita rise un irreale/ Riso: e che l’eco faticosamente/
E bianca e lieve e attonita salì...
Potrebbero piacerti anche
- Antonio Fogazzaro DiscorsiDocumento154 pagineAntonio Fogazzaro DiscorsiDaniel AranaNessuna valutazione finora
- Come Gettare Un Sasso In Uno Stagno (e anche qualche altro sasso...)Da EverandCome Gettare Un Sasso In Uno Stagno (e anche qualche altro sasso...)Nessuna valutazione finora
- Un giorno tutto questo dolore mi sarà utileDa EverandUn giorno tutto questo dolore mi sarà utileNessuna valutazione finora
- Consigli Sulla Composizione Dell'inquadratura RidottoDocumento10 pagineConsigli Sulla Composizione Dell'inquadratura Ridottoanna maria spingolaNessuna valutazione finora
- Il DoppiaggeseDocumento41 pagineIl Doppiaggeseanna maria spingolaNessuna valutazione finora
- EavesdroppingDocumento2 pagineEavesdroppinganna maria spingolaNessuna valutazione finora
- UniCal OralitàScrittura SileoDocumento19 pagineUniCal OralitàScrittura Sileoanna maria spingolaNessuna valutazione finora
- ObiettiviDocumento26 pagineObiettivianna maria spingolaNessuna valutazione finora
- Il Simil Sinc o Semi SincDocumento10 pagineIl Simil Sinc o Semi Sincanna maria spingolaNessuna valutazione finora
- L'Amante - Harold PinterDocumento27 pagineL'Amante - Harold PinterCarlo Original CongiaNessuna valutazione finora
- La Profondità Di CampoDocumento20 pagineLa Profondità Di Campoanna maria spingolaNessuna valutazione finora
- La Nascita Della Fotografia 58158Documento18 pagineLa Nascita Della Fotografia 58158anna maria spingolaNessuna valutazione finora
- Interrail - Massimiliano BrunoDocumento20 pagineInterrail - Massimiliano Brunoanna maria spingolaNessuna valutazione finora
- Campi e Piani FotograficiDocumento30 pagineCampi e Piani Fotograficianna maria spingolaNessuna valutazione finora
- Schema Riassuntivo Tonalità MaggioreDocumento1 paginaSchema Riassuntivo Tonalità Maggioreanna maria spingolaNessuna valutazione finora
- Esposizione e ComposizioneDocumento45 pagineEsposizione e Composizioneanna maria spingolaNessuna valutazione finora
- OthelloDocumento53 pagineOthelloanna maria spingolaNessuna valutazione finora
- La Sgualdrina TimorataDocumento29 pagineLa Sgualdrina Timorataanna maria spingolaNessuna valutazione finora
- Assasinio in Casa MiaDocumento40 pagineAssasinio in Casa Miaanna maria spingolaNessuna valutazione finora
- PINTER Harold Ceneri Alle Ceneri Null U (1) - D (1) Commedia 1aDocumento17 paginePINTER Harold Ceneri Alle Ceneri Null U (1) - D (1) Commedia 1aFrancescaCNessuna valutazione finora
- Ivonne e Sandy - La CottaDocumento6 pagineIvonne e Sandy - La Cottaanna maria spingolaNessuna valutazione finora
- Terapia Di Gruppo A Chicago Che Non Ci Piace AbbastanzaDocumento17 pagineTerapia Di Gruppo A Chicago Che Non Ci Piace Abbastanzaanna maria spingolaNessuna valutazione finora
- Tradimenti PinterDocumento43 pagineTradimenti Pinteranna maria spingolaNessuna valutazione finora
- Allen Woody MonologhiDocumento17 pagineAllen Woody Monologhilomonesa100% (1)
- Avviso Di Pagamento 001700033369443Documento1 paginaAvviso Di Pagamento 001700033369443anna maria spingolaNessuna valutazione finora
- Monologo A TreDocumento4 pagineMonologo A Treanna maria spingolaNessuna valutazione finora
- La CollezioneDocumento26 pagineLa CollezioneAlfredo KemNessuna valutazione finora
- L'Amante - Harold PinterDocumento27 pagineL'Amante - Harold PinterCarlo Original CongiaNessuna valutazione finora
- PsicologiaDocumento15 paginePsicologiaanna maria spingolaNessuna valutazione finora
- Sintesi Libro Psicologia Generale Anolli Gerrig Zimbardo 1Documento56 pagineSintesi Libro Psicologia Generale Anolli Gerrig Zimbardo 1anna maria spingolaNessuna valutazione finora
- Freud Ric Rip RieDocumento5 pagineFreud Ric Rip Rieanna maria spingolaNessuna valutazione finora
- Lezioni Comportamentismo (Fondamenti)Documento4 pagineLezioni Comportamentismo (Fondamenti)anna maria spingolaNessuna valutazione finora
- Programma Scienze NaturaliDocumento7 pagineProgramma Scienze Naturalianna maria spingolaNessuna valutazione finora
- Cristo Si È Fermato Ad Eboli Di Carlo Levi (Giovanni Falaschi)Documento28 pagineCristo Si È Fermato Ad Eboli Di Carlo Levi (Giovanni Falaschi)Grodi100% (1)
- Autofiction, Confessioni Di Un Genere. Da Roland Barthes A Paul Auster, Di EMANUELE TREVI - Corriere Della Sera 12.02.2013Documento1 paginaAutofiction, Confessioni Di Un Genere. Da Roland Barthes A Paul Auster, Di EMANUELE TREVI - Corriere Della Sera 12.02.2013glisfogliatiNessuna valutazione finora
- Letterature ComparateDocumento71 pagineLetterature Comparate469cwvnb5sNessuna valutazione finora
- Tesi Su Capo VerdeDocumento158 pagineTesi Su Capo VerdeANY1NEXT100% (1)
- Il Mediatore Regale Della Salvezza (Testi Cristologia)Documento4 pagineIl Mediatore Regale Della Salvezza (Testi Cristologia)Riccardo CerianiNessuna valutazione finora
- Pirandello Vita 1Documento1 paginaPirandello Vita 1Francesco LicataNessuna valutazione finora
- Curruculum Edoardo Sala 1Documento14 pagineCurruculum Edoardo Sala 1Silvia ArosioNessuna valutazione finora
- Henrik IbsenDocumento3 pagineHenrik IbsenIlaria GhirardelloNessuna valutazione finora
- Altri LibertiniDocumento2 pagineAltri LibertiniFaruk BecirovicNessuna valutazione finora
- Rosso MalpeloDocumento2 pagineRosso MalpeloGiorgia RambaldiNessuna valutazione finora
- Decadentismo - Simbolismo Ed EstetismoDocumento1 paginaDecadentismo - Simbolismo Ed EstetismoMarta SansoneNessuna valutazione finora
- Il Tragico in ShakespeareDocumento38 pagineIl Tragico in ShakespeareMarco MassafraNessuna valutazione finora
- Giudizi Critici Sullopera Di Pirandello - A.A. 20212022Documento3 pagineGiudizi Critici Sullopera Di Pirandello - A.A. 20212022MMNessuna valutazione finora
- Lingua Sarda Falsi ArboreaDocumento18 pagineLingua Sarda Falsi ArboreaBetelgeuseNessuna valutazione finora
- Filol. Romanza Libro Profilo Delle LetteratureDocumento21 pagineFilol. Romanza Libro Profilo Delle LetteratureMartina PorcelliNessuna valutazione finora
- PetronioDocumento3 paginePetronioValentina Uale MengoniNessuna valutazione finora
- Powerpoint MusicaDocumento7 paginePowerpoint Musicadaniela sannaNessuna valutazione finora
- Licei "G.A. Pujati" Di Sacile Corso Di Scienze Umane: Programma Svolto Di Lingua E Letteratura ItalianaDocumento6 pagineLicei "G.A. Pujati" Di Sacile Corso Di Scienze Umane: Programma Svolto Di Lingua E Letteratura Italianagiuliaottobre2005Nessuna valutazione finora
- D'Annunzio e Lo SportDocumento17 pagineD'Annunzio e Lo SportAssunta CarusoNessuna valutazione finora