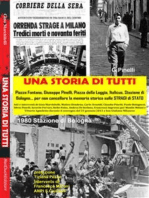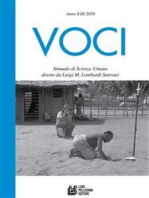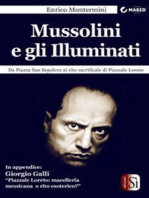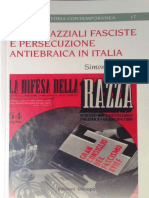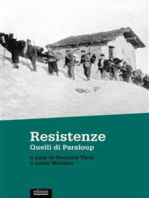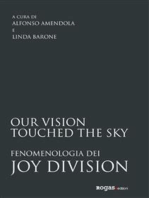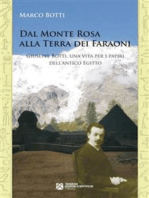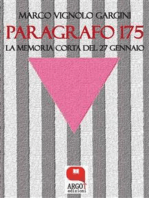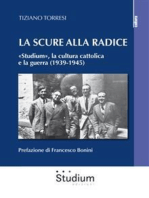Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Testimoni Luoghi Memorie. Viaggi Di Studio Nei Lager Nazisti 1998-2006
Caricato da
CorsaroGialloTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Testimoni Luoghi Memorie. Viaggi Di Studio Nei Lager Nazisti 1998-2006
Caricato da
CorsaroGialloCopyright:
Formati disponibili
Citt di Moncalieri Assessorato alla Cultura
Testimoni luoghi memorie
Viaggi di studio nei Lager nazisti 1998 - 2006
a cura di Lucio Monaco, Marcella Pepe, Gabriella Pernechele
Scuole Superiori Statali della Citt di Moncalieri Istituto di Istruzione Superiore Statale Majorana Istituto Tecnico Industriale Statale Pininfarina
II
Citt di Moncalieri Assessorato alla Cultura Testimoni luoghi memorie. Viaggi di studio nei Lager nazisti 1998 - 2006 Il Progetto Memoria, il presente volume e le iniziative collegate alla ricorrenza del Giorno della Memoria, 27 gennaio 2007, sono posti sotto lAlto Patronato del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano Il volume pubblicato con il patrocinio e il contributo della Regione Piemonte e della Provincia di Torino
Comitato Promotore Lorenzo Bonardi - Sindaco di Moncalieri Mariagiuseppina Puglisi - Assessore alla Cultura Coordinamento generale e curatela del volume Lucio Monaco, Marcella Pepe, Gabriella Pernechele Produzione audiovisiva Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina Francesco Martino, Carla Piana Fotografie Studenti e docenti del Progetto Memoria e Mario Pettinati Segreteria organizzativa Elena Ughetto - Dirigente Settore Cultura e Istruzione Bruna Bonaldo - Direttore Ufficio Cultura Alba Ginestrella - Ufficio Cultura Grafica e stampa Comunecazione, Bra (CN) - Gennaio 2007 Si ringraziano Giuliana Tedeschi, Eleonora Vincenti, Massimo Lajolo, Paolo Valentino
La Citt di Moncalieri si rende disponibile a regolare eventuali diritti sulle immagini riprodotte nel volume per le quali non sia stato possibile identificare la provenienza. Per i casi in cui non stato possibile ottenere il permesso di riproduzione, a causa della difficolt di rintracciare chi potesse darlo, si notificato allUfficio della propriet letteraria, artistica e scientifica che limporto del compenso a disposizione degli aventi diritto.
III
IV
Indice
PRESENTAZIONE (Mariagiuseppina Puglisi, Lorenzo Bonardi, Gianni Oliva, Umberto DOttavio, Ferruccio Maruffi) INTRODUZIONE Incontrare i luoghi (Lucio Monaco) I. II. I VIAGGI DEL PROGETTO LE GUIDE DELLA MEMORIA 1. Il contesto storico (Marcella Pepe) Il sistema concentrazionario nazista Lo sfruttamento economico dei prigionieri Cronologia della Shoah (Adriana Mogna) La Conferenza di Wannsee I campi fascisti Le leggi razziali 2. I luoghi della deportazione (Lucio Monaco) Cenni sulla storia del Lager di Auschwitz Le deportazioni dallItalia ad Auschwitz Bolzano: il Durchgangslager di Gries Il KL Buchenwald (Lucio Monaco, Marcella Pepe) Il campo di concentramento di Dachau Ebensee, Kommando di Mauthausen (Italo Tibaldi) Il Durchgangslager di Fossoli di Carpi. Cronologia Gusen I, Gusen II, Gusen III: sottocampi di Mauthausen Hartheim e il Programma di Eutanasia Linz I, II, III: sottocampi di Mauthausen Le marce della morte Il Lager di Mauthausen e lo sterminio mediante il lavoro Melk: il sottocampo di Mauthausen e il lavoro in galleria Il KZ di Mittelbau-Dora fra produzione missilistica e sterminio Il KL di Ravensbrck Il KZ di Sachsenhausen e la sua storia PERCORSI DI MEMORIA Scienza, razza, biologia: un percorso possibile (Rosella Cocciolo) Memoria ufficiale, memorie vive. Usi della monumentalit (Alessandra Matta) Il Lager come museo (Piero Cresto-Dina)
3 11
19 37 37 38 40 42 48 57 63 67 69 70 77 79 83 85 87 88 89 90 94 95 102 108 111 111 121 145
III.
IV.
TESTIMONI E MEMORIE Immagini e parole di Anna Cherchi Il racconto di Natalia Tedeschi (Studentesse dellITCS Marro) Un viaggio (Maria Clara Avalle) Pio Bigo, Memorie e testimonianze di una vita da schiavo Intervista a Giorgio Ferrero (Marcella Pepe) Marcello Martini, Fossoli 13-21 giugno 1944 Frammenti di riflessione da un viaggio a Fossoli (Studenti dellI.I.S. Majorana) Albino Moret, Dalla cattura alla liberazione Il racconto di Natalino Pia (Studentesse dellITCS Marro) Primarosa Pia, Viaggio della memoria Benito Puiatti, Ricordi di Dachau Sono stato prigioniero e bon. Ricordo di Antonio Temporini (Luisa Bonelli) Da Moncalieri ai Lager nazisti: i deportati moncalieresi (Lucio Monaco) Un ragazzo di Borgo San Pietro (Elisa Armentaro, Alessandra Gardino) I GIORNI DELLA MEMORIA. LA COMMEMORAZIONE DEL 27 GENNAIO NELLA CITT DI MONCALIERI (Mariagiuseppina Puglisi) INTITOLAZIONE DELLA SALA DEI CENTO A PRIMO LEVI (Moncalieri, 28 maggio 1999) Primo Levi tra memoria e profezia (Carlo Ossola) Primo Levi testimone del nostro tempo (Alberto Cavaglion)
165 166 168 172 174 178 184 191 195 205 208 209 217 218 221 225
V.
VI.
231 231 235 239 239 241 248 251 251 255 256 258 259 260 260 262 262 263 266 266 268 269 270
VII. APPENDICI A. ARCHIVI DELLA MEMORIA Guida allArchivio Multimediale (Pier Luigi Cavanna, Marcella Pepe) Indici Filmografia testimoni (Pier Luigi Cavanna) B. IMMAGINI DELLA MEMORIA Lavorare sulle testimonianze con le immagini e linformatica Esperienze di un Laboratorio Multimediale (Carla Piana) Compagni di un viaggio (Emanuele Cassaro e Matteo Gai) Compagni di un viaggio: fra emozioni, conoscenza e ragione (Lucio Monaco) Frammenti di memorie (Emanuele Cassaro) Le forme della memoria (Carla Piana) 44145 Anna (Michela Cane) Anna e Natalia a Ravensbrck (Carla Piana) La necessit di sopravvivere (Carla Piana) Leco della memoria. Un testimone fra i giovani (Carla Piana) Parole e Segni oltre il Tempo. Mauthausen e Gusen (Carla Piana) Ricordo di Albino Moret (Carla Piana) Matricola 0155. Un deportato inesistente (Michela Cane) Memorie di pietra (Paolo Bommino) Tracce. Unesperienza didattica di uso del Kalendarium di Danuta Czech (Lucio Monaco) Tracce (Lorenzo Anania e Mario Mancuso)
Presentazione
Il 27 gennaio 2002, nella Sala Conferenze del Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri, fu presentato il volume Percorsi di memoria. Viaggi di studio nei Lager nazisti 19982001, nel corso di una cerimonia ancora vivo il ricordo in cui al rilevante significato implicito si univano la valenza emotiva e una intensa commozione: quel giorno fu conferita la cittadinanza onoraria a Pio Bigo, Anna Cherchi, Albino Moret, Natalino Pia, Benito Puiatti e Natalia Tedeschi, i testimoni che avevano accompagnato il Progetto Memoria nei suoi primi quattro anni di svolgimento, di cui il libro era il racconto. Va a queste sei persone Albino, Anna e Natalia sono poi mancati il nostro pensiero e il ringraziamento pi sentito. Pur con storie personali diverse, hanno vissuto la comune orrenda esperienza della deportazione e avvertito lurgenza e la responsabilit di testimoniare e di accompagnare gli studenti nei Lager, tornando con enorme dolore e con grande determinazione nei luoghi delloffesa. Conferendo loro la cittadinanza onoraria, la Citt ha voluto segnalare fortemente non solo la profonda riconoscenza e il grande affetto nei loro confronti, ma anche ladesione convinta ai valori della libert, della democrazia, dei diritti delluomo. La continuit amministrativa e la coerenza programmatica sono stati elementi importanti per lo sviluppo successivo del Progetto Memoria che, per i contenuti, le finalit e i risultati raggiunti, devessere a buon diritto considerato uno dei punti pi importanti del nostro programma politico-amministrativo. La presentazione di quel volume, scritta nel 2001 da Carlo Novarino, allora Sindaco di Moncalieri e da Mariagiuseppina Puglisi, Assessore alla Cultura, contiene considerazioni che vogliamo anche oggi ribadire e per questo, in parte, ripubblichiamo. Il Progetto Memoria che ha interessato le Scuole Superiori di Moncalieri stato voluto e costruito per mantenere vivo il ricordo e per avere memoria del pi tragico evento che ha sconvolto il secolo trascorso, un male assoluto che ha attraversato lEuropa distruggendo ogni barriera di civile convivenza. Un male che ha prodotto abissi di dolore e devastato la dignit di tante popolazioni: la discriminazione, la persecuzione, la deportazione, la spoliazione, la sofferenza, la distruzione dei cittadini ebrei di ogni Paese dominato dal nazismo e da governi di ispirazione razzista e fascista. Un male che ha anche difficolt a trovare una voce che lo possa definire: la Shoah, lOlocausto, il genocidio, la soluzione finale. necessario riflettere su un evento di tale delittuosa portata e sulla sua inconcepibile e assurda ferocia, un evento che cresciuto e si radicato allinterno di Paesi civili, evoluti, sviluppati. Le radici di questa tragedia si trovano non solo nel disegno criminoso di alcune oligarchie, ma investono strati ampi e diffusi di societ, in un ambiente culturale conformista che per tanti motivi, anche banali e piccoli, ha reso possibile prima, tollerato poi e infine accettato lorganizzazione meticolosa e scientifica della Shoah. Pensiamo alle leggi razziali, allantisemitismo sempre pi diffuso e progressivo, con le
sue fonti anche colte e religiose. un viaggio nel cuore della cultura di una societ i cui rapporti sociali hanno permesso, se non addirittura favorito, tale delitto: un viaggio che ha solo due mete. Una la dimenticanza, bench questa possa non essere meramente il frutto di un colpevole intento di negare o di cancellare. La dimenticanza e loblio servono a stendere un velo grigio che consente di allontanare, di assolvere senza giudicare, di archiviare senza capire. una scelta riprovevole che non vogliamo percorrere perch si accantona in tal modo un male assoluto senza averne prodotto gli anticorpi, cosicch il male pu riprodursi. Laltra meta, lunica moralmente accettabile, ricordare, mantenere viva la memoria per quanto sia dolorosa, per quanto sia atroce. Questo ci che abbiamo cercato di fare con il Progetto Memoria. Mantenere la memoria di una tragedia assoluta, consci che questa non stata il frutto di un gruppo di criminali di guerra, di fanatici nazisti di un solo Paese, di un particolare e irripetibile momento. una tragedia che ha coinvolto limpegno di un grande numero di donne e di uomini con gradi e livelli diversi di consapevolezza. Si stima che oltre un milione di persone abbia dedicato alla sua attuazione la propria attivit consapevole: fra queste cera anche molta gente comune. Il piano di sterminio di un popolo a cui tanti hanno prestato la propria opera o dato il proprio consenso aveva la sua base nelle aberranti teorie razzistiche che miravano a uno Stato nuovo fondato sulla omogeneit appunto razziale: era un obiettivo rassicurante per tanti nei confronti del nuovo, del diverso, nei confronti delle insicurezze che levoluzione della modernit si portava dietro, allora come ora. Un nuovo Stato forte, autoritario, omogeneo, razzialmente capace di rassicurare gli individui fragili, intimoriti dalle forme della competizione sociale ed economica e pervasi dal timore di perdere privilegi anche piccoli, anche marginali. Quanto di questo superato e quanto invece ancora vivo e attuale? Se ci guardiamo attorno vediamo che lEuropa ancora interessata da forti inquietudini e da forme di xenofobia che serpeggiano, da manifestazioni di intolleranza religiosa: progetti politici esecrabili, tuttavia prosperi e reali. Noi sappiamo che questi progetti continueranno a sollecitare le fantasie dei pi deboli: sono risposte semplici e semplificate alle paure quotidiane di ciascuno di noi; un capro espiatorio (il diverso, lestraneo) la proposta pi facile per esorcizzare i problemi. La violenza non viene cancellata dal progresso e dalle modernizzazioni, e neppure appartiene a un passato irripetibile allontanato una volta per tutte. La violenza sempre presente nei recessi dei nostri comportamenti: una via di fuga da cui ci separano soltanto la nostra responsabilit, la nostra maturit civile e la capacit di opporci. Dobbiamo quindi conservare la memoria per imprimere nella coscienza collettiva il senso della responsabilit come valore civico e la consapevolezza della tragedia che si ripropone ove vincano complicit, silenzio, indifferenza. Dobbiamo conservare la memoria per radicare la consapevolezza del nostro passato nelle atrocit e nel qualunquismo indifferente che ha segnato la nostra storia con le leggi razziali, con i propositi collaborativi di una parte del nostro Paese, con un pesante contributo politico, istituzionale e morale allo sterminio. Non c un male assoluto che pu essere isolato una volta per sempre: c un male profondo che pu essere molto diffuso; dunque dobbiamo conservare la memoria per riaffermare il valore fondante e fondamentale dei rapporti sociali costituito dalla democrazia come sistema che si regge sul pluralismo e sul confronto fra le differenze. Alcuni anni sono trascorsi dalla scrittura di quella presentazione: ora entriamo nel decimo del Progetto Memoria, che si nel tempo consolidato ed evoluto mantenendo tuttavia ben saldo il suo impianto originario di progetto territoriale in cui istituzioni, scuole, testimoni hanno realizzato una rete virtuosa che grazie ai viaggi, ai luoghi e allo studio ha consentito ai giovani unesperienza altamente formativa e agli adulti unopportunit fondamentale nellelaborazione di una coscienza civile matura e consapevole.
Presentazione
Un programma politico che voglia includere contenuti e alti obiettivi di crescita per i singoli e per la collettivit deve sostenere progetti di studio e di laboratorio che rinforzino i giovani, ne nutrano la mente, ne arricchiscano la personalit e ne consolidino la coscienza. Questo stato il significato del Progetto Memoria, ed emblematico suggellarlo con la pubblicazione del secondo libro, cui affidiamo la documentazione di quanto stato fatto nella consapevolezza che i testi possono conservare la memoria e che la memoria il filo che deve legare le generazioni tracciando un percorso nella coscienza collettiva, perch ognuno impari a combattere lindifferenza e a ripudiare ogni forma di estremismo. Le Scuole Superiori di Moncalieri hanno in questo periodo effettuato un percorso pluriennale di studio e di analisi di testi producendo documentazione cartacea, artistica e multimediale sullesperienza vissuta a scuola e nei viaggi. Abbiamo visto centinaia di giovani lavorare con seriet e impegno sotto la guida dei loro insegnanti; lincontro con i testimoni nei luoghi della memoria stato un elemento formativo essenziale, a maggior ragione in quanto il viaggio non mai stato momento conclusivo ma passaggio intermedio per i gradi successivi della loro riflessione. I materiali di studio e le ricerche dellI.I.S. Majorana e lArchivio Multimediale dellITIS Pininfarina costituiscono un patrimonio documentale che potrebbe diventare centro di documentazione disponibile alla consultazione. Per questo esprimiamo il nostro ringraziamento pi sentito a quanti si sono impegnati in un complesso lavoro pluriennale: le istituzioni, i docenti, i testimoni, gli studenti hanno contribuito a delineare un itinerario di studio in cui lezioni, testimonianze, viaggi, documentazione sono mescolati insieme in un unico percorso della memoria che insieme storia e formazione civile. In tale contesto, le istituzioni devono sempre essere presenti a rafforzare il senso morale e civico dei giovani che devono sentire una certezza, quella di non essere soli, e devono coltivare una speranza, quella di una societ fondata sul rispetto della dignit di ogni essere umano, una societ di donne e di uomini liberi votati alla costruzione di un mondo di fratellanza tra i popoli, nel rispetto delle culture diverse e attraverso il riconoscimento della propria identit. La nostra Citt orgogliosa di avere partecipato al Progetto Memoria.
Il Sindaco Lorenzo Bonardi
LAssessore alla Cultura Mariagiuseppina Puglisi
avvenuto, quindi pu accadere di nuovo: cos scriveva Primo Levi ne I sommersi e i salvati, il suo ultimo lavoro pubblicato poco prima della tragica morte. E in quella frase egli condensava il senso di una vita trascorsa nella testimonianza di ci che era avvenuto dietro i fili spinati di Auschwitz, di Dachau, di Mauthausen e degli altri luoghi di deportazione. Ci che oggi appare come unaberrazione vergognosa realmente accaduto; accaduto nella civile Europa del XX secolo; accaduto in una nazione, la Germania, che era allavanguardia scientifica e culturale del continente; accaduto che un intero popolo di decine di milioni di abitanti credesse nella superiorit della propria razza, riempisse di sangue lEuropa intera, seguisse nel suo delirio un personaggio come il caporale Adolf Hitler, che a distanza di pi di mezzo secolo a noi sembra tragicamente ridicolo. In quelle stesse pagine de I sommersi e i salvati Primo Levi aggiungeva una considerazione inquietante: i nazisti egli scriveva non erano dei mostri, non erano uomini geneticamente tarati. Erano uomini come noi, ma erano stati educati male. E una cattiva educazione di Stato, che aveva monopolizzato ogni strumento di comunicazione e di formazione, aveva insegnato a milioni di tedeschi che fosse giusto sterminare gli ebrei, i diversi, gli oppositori politici; che fossero leciti i Lager, le camere a gas, i forni crematori; che le coscienze dovessero tacere di fronte alla missione di dominio della razza ariana. Milioni di tedeschi avevano creduto a quel messaggio; oppure avevano taciuto per vilt, per interesse, per complicit; oppure ancora, non si erano opposti per debolezza. In ogni modo, essi avevano seguto sino in fondo Hitler nellavventura della guerra e nella vergogna dei Lager. In tale premessa si trova anche il senso dei percorsi didattici e dei viaggi della memoria organizzati dalla Citt e dalle Scuole di Moncalieri. Prima insegnare ai pi giovani che cosa accaduto, come accaduto, perch accaduto; poi far conoscere loro i luoghi, accompagnati dalle testimonianze dei pochi sopravvissuti; poi ancora riprendere il discorso didattico in classe. Lezioni, testimonianze, viaggi di studio mescolati insieme in un unico percorso della memoria, che insieme storia e formazione civile. Presentando il volume, che raccoglie le esperienze maturate in questi anni, non si pu non esprimere stima e riconoscenza a chi (amministratori, docenti, studenti) ha saputo sostenere uno sforzo cos qualificato e intenso. Mai pi si legge in una grande lapide di granito posta allingresso del Lager di Dachau: perch sia davvero mai pi occorre che le nuove generazioni sappiano e non dimentichino. Grazie dunque alla Comunit di Moncalieri per aver saputo lavorare in tale direzione con tanto impegno. LAssessore alla Cultura della Regione Piemonte Gianni Oliva
Presentazione
Non si scriver n si parler mai abbastanza della Shoah. In tal senso lapprezzamento per questa pubblicazione non pu che essere massimo, perch, pi del revisionismo o, peggio, del negazionismo, la riduzione della memoria, la sua perdita, a rappresentare il pi grave pericolo rispetto al periodo storico che ha visto il determinarsi di quelloscuramento umano noto come nazifascismo e che invece necessita di costante attualizzazione. Non solo per un fatto fine a se stesso, un ricordo, che gi di per s sarebbe sufficiente e necessario, ma ci che pi ci pare importante sottolineare per i valori e i riferimenti che ne derivano, linsegnamento che ne scaturisce in fatto di civilt, di valorizzazione dellintegrazione delle diverse culture, di apertura agli altri, di rispettiva contaminazione e accettazione senza cui si corre il rischio di imboccare strade che, partendo dallindividualismo e dallautoreferenzialit mali sempre pi evidenti della nostra societ contemporanea , possono portare, con il contributo di fattori sociali, politici e culturali sfavorevoli, a paurosi ritorni a tempi bui gi vissuti. Il libro Testimoni luoghi memorie, segno di un impegno che dura dal 1998, con il suo articolarsi fra ricostruzioni storiche e percorsi di viaggi, testimonianze, archivi e immagini, ci aiuta a ricordare ci che scritto in quelle tragiche pagine della Storia e ci incoraggia nel continuare a operare affinch nessuno sforzo sia risparmiato e gli orrori di cui lumanit si resa colpevole non abbiano a ripetersi. LAssessore alla Formazione professionale e allIstruzione della Provincia di Torino Umberto DOttavio
Esce a cura dellAssessorato alla Cultura della Citt di Moncalieri questa importante opera sulla memoria dei campi di sterminio nazisti. Un percorso dettagliato che si avvale di testimonianze significative. E dire che il dopo Lager era stato abbastanza mortificante allinizio. Invece con il trascorrere di questi sessantanni per il consapevole impegno delle istituzioni, specialmente in Piemonte, dove Regione, Province e Comuni si sono attivati (e fra questi proprio la Citt di Moncalieri) molto si fatto affinch dimenticanza non fosse. Quella che segue un po la storia del dopo Lager. A suo tempo avevamo testimoniato e scritto che i Lager di sterminio nazisti furono luoghi terrificanti, resi ancora pi cupi e sinistri dal fumo nero che fuoriusciva ininterrottamente dai forni crematori. I reticolati di fili spinati percorsi dallalta tensione che li circondavano erano diventati, con il trascorrere del tempo, una sorta di attrazione fatale e un ossessionante invito a farla finita. I deportati tuttavia si erano guardati bene dal toccarli, quei fili, perch il meccanismo perfetto della soppressione, invece di spegnerlo, aveva impresso a ciascuno di loro il desiderio di vivere il pi a lungo possibile. Cosicch ucciderli, e tanti ne erano stati uccisi, era servito soltanto a testimoniare lefferatezza di quel sistema e a suggellare la sua inevitabile sconfitta morale. Negli anni che seguirono superstiti e famigliari tornarono spesso a visitare i campi. I primi, per ricercare se stessi, quello che erano stati capaci di essere, per risentire quella stupefacente voglia di vivere che li aveva animati, che aveva accompagnato gli ultimi istanti dei loro compagni morti. I famigliari, per vedere i luoghi dove il loro caro era scomparso, camminare adagio sulla terra che lui, sospinto e vilipeso, aveva calpestato, sperando che nellazzurro del cielo, sul verde dei prati, sulle pareti delle baracche fosse rimasta miracolosamente impressa limmagine di un sorriso, il cenno di un possibile arrivederci. Tuttavia gli uni e gli altri non si voltarono soltanto indietro, ma restando uniti nella loro Associazione parteciparono alla vita politica, sociale e culturale del Paese. Piero Caleffi, che aveva scritto come si facesse presto a dire fame, e Francesco Albertini da Verbania si resero promotori in Parlamento della legge contro il genocidio. E lo stesso Albertini, vincendo la causa con il Governo federale tedesco per il simbolico indennizzo a favore dei reclusi nei Lager di sterminio, ottenne il riconoscimento della figura giuridica dei deportati italiani politici e antifascisti ovviando a quella dimenticanza. Italo Tibaldi si batt da par suo affinch lAssociazione Nazionale Ex Deportati fosse eretta a Ente morale. E fu eretta. Poi simpegn a ricostruire la cronologia dei trasporti, evidenziando cifre alla mano uno degli aspetti pi diabolici del sistema nazista: quello di mandare a morire uomini, donne e bambini a migliaia di chilometri di distanza dalla loro patria. Giovanni Melodia e Giorgina Bellak fin dal 60 parlarono delle donne e dei bambini nei Lager, e ancora tante volte dopo ne parl Giovanni.
Presentazione
Perch uomini, donne e bambini deportati nei Lager diventassero memoria perenne Gemma e Giacinto Guareschi, genitori di Marco, morto a Mauthausen, promossero il Monumento ai caduti italiani. Albe Steiner e Barbiano di Belgiojoso progettarono un Museo della Deportazione a Carpi e lANED allest i Memoriali ad Auschwitz e Ravensbrck. Bepi Calore, medico e partigiano Marangoni , colse un premio importante che accomunava professionalit, abnegazione e coraggio di deportato. Vincenzo Pappalettera fece uscire dal camino le memorie e le nozioni del sacrificio. Lidia Beccaria Rolfi, una donna partigiana in Mondov, fece uscire quelle delle donne di Ravensbrck, e Giuliana Tedeschi, una donna ebrea, quelle di AuschwitzBirkenau. Gino Valenzano, che aveva gi descritto linferno, raccont delluomo in quel fuoco. Quinto Osano pens ai morti e ai vivi, ai morti soprattutto, affinch emozioni e lacrime, fumo e aria restassero tracce indelebili di partecipazione e gratitudine. Teo Ducci progett e present mostre dappertutto, coniugando da par suo arte e dolore, e Primo Levi per tutta la vita fu e, anche adesso che non c pi, continua a esserlo, il Testimone Principe. Alberto Todros chi se non un architetto che era stato prigioniero a Mauthausen? diede alla Sezione Piemontese dellANED solide basi e robusti architravi di programmi e iniziative testimoniali. Molti ex riempirono pagine di storia sui campi. Bruno Vasari, che aveva preso carta e penna fin da subito, invent convegni internazionali e diede impulso alla pubblicazione del libro fondamentale curato da Anna Bravo e Daniele Jalla, La vita offesa, raccolta di testi dincontestabile valore-verit. Ci fu il processo sui crimini compiuti alla Risiera di San Sabba affinch la giustizia anzich dimentica fosse giusta, e la citt di Prato si gemell per iniziativa degli ex con la citt di Ebensee affinch la pace anzich transitoria fosse imperitura. E la Citt di Moncalieri? In questi ultimi anni, collegandosi a gruppi via via pi numerosi di insegnanti, si impegnata tantissimo nelle scuole e ha organizzato viaggi di studio nei Lager nazifascisti. Importanti restano le cittadinanze onorarie date ad alcuni sopravvissuti. Fra costoro Anna Cherchi, Natalia Tedeschi, Albino Moret non ci sono pi, ma rester il ricordo prezioso della loro presenza nelle scuole della citt. In fondo, a pensarci bene, la prima delle date storiche che hanno contrassegnato il dopo Lager fu il 9 giugno del 45 quando, appena scesi dal treno, allingresso di un bar di Via Sacchi a Torino, al nostro apparire la gente spar in fondo alla sala. Il 5 maggio di qualche anno dopo, anniversario della liberazione di Mauthausen, alcuni di noi in una sala da ballo di Corso Vittorio si chiamava Castellino ricordando quella data chiesero allorchestra di suonare Ci sposeremo a maggio con tante rose ... Prima che le danze cominciassero i ballerini si rivolsero al nostro gruppo, battendo tutti a lungo le mani. A fine ottobre del 48, al Cimitero generale, fu accolta ufficialmente la Salma del Deportato Ignoto. Per venire ai giorni nostri, quando le esequie di Natalia prima, di Albino poi e infine di Anna furono accompagnate dal Gonfalone della Citt di Moncalieri. Torino, 20 ottobre 2006 Il Presidente dellANED Regione Piemonte Ferruccio Maruffi
10
11
Introduzione
Incontrare i luoghi
Lucio Monaco Dieci anni dopo Nellarco di dieci anni 1 in Italia (ma non solo) i viaggi di studio nei Lager nazifascisti sono diventati unesperienza diffusa, caratterizzata da percorsi didattici di maggiore o minore complessit e ampiezza, non limitati allambito dellinsegnamento della storia e finalizzati alla formazione della coscienza civile. La situazione, rispetto al momento in cui abbiamo iniziato lesperienza moncalierese, quindi ben diversa: fare un bilancio significa anzitutto fare i conti con questo scarto, cos come con le trasformazioni che sono avvenute nei luoghi stessi della memoria. Non occorre per esempio riproporre linterrogativo sullutilit della educazione a partire dai luoghi2 come si proponeva, sia pure rapidamente, nel nostro volume del 2002.3 Una simile strategia conoscitiva oggi largamente consolidata, sia sul piano della riflessione teorica e metodologica sia su quello del terreno concreto e operativo: da parte di chi soggetto attivo del viaggio insomma chi lo progetta e lo organizza e da parte di chi tutela i luoghi stessi. Pu essere invece utile ribadire, in primo luogo, le caratteristiche che, attraverso inevitabili correzioni di rotta dovute al mutare dei tempi, il Progetto delle Scuole di Moncalieri possiede rispetto a iniziative apparentemente simili (e in qualche caso condotte effettivamente con gli stessi criteri); e in secondo luogo vedere come questi tratti specifici rispondono alle nuove condizioni dinsieme, che possiamo velocemente indicare nella popolarit raggiunta dallargomento con tutti i vantaggi di una conoscenza diffusa, ma anche con i problemi legati a un possibile eccesso di esposizione mediatica e nelle trasformazioni dei luoghi, spesso passati dalla forma abbandono4 a una configurazione completamente diversa, attraverso ricostruzioni o monumentalizzazioni. Il viaggio ai luoghi In prima istanza c lidea forte perch formulata sin dai primi anni, e poi sempre pi esplicitata che il viaggio non sia un momento conclusivo ma una delle tappe del processo di conoscenza, che non si esaurisce nella visita. Punto di arrivo dunque di
Consideriamo decennale la durata del Progetto, dato che il viaggio del 2007 gi stato messo in programma. N. Baiesi / G. D. Cova, Educa il luogo, in T. Matta (cur.), Un percorso della memoria. Guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia, Milano, Electa, 1996, pp. 140 sgg. 3 L. Monaco / G. Pernechele (curr.), Percorsi di memoria. Viaggi di studio nei Lager nazisti 1998-2001, Citt di Moncalieri, Assessorato alla Cultura, 2002. 4 Cfr. il saggio di N. Baiesi / G. D. Cova citato supra, nota 2.
1 2
12
unattivit di ricerca che anche progettuale, e punto di partenza per una verifica delle conoscenze acquisite e della realizzabilit del Progetto, nelle sue varie articolazioni possibili. Attraverso il viaggio, quindi, il percorso conoscitivo che proponiamo, incentrato sullideologia nazifascista e sulle sue conseguenze, si fa esperienza di laboratorio, che per cos dire precipita in realizzazioni comunicative dei tipi pi diversi: la scrittura (e questo stesso libro ne una prova, speriamo riuscita), il lavoro sulle immagini fisse disegni, fotografie, forme grafiche e in movimento (film documentari e di creazione, multimedialit), la partecipazione a mostre ed esposizioni in manifestazioni locali. Il riepilogo dei nove anni di viaggi e delle realizzazioni a essi collegate, offerto nella sezione successiva, mostra un quadro abbastanza significativo per quantit e qualit di realizzazioni: senza per dimenticare che stiamo parlando non di risultati definitivi e assoluti, ma sostanzialmente di simulazioni, valide soprattutto per il metodo impiegato che sia di ricerca storica o sociale, o di realizzazione tecnica o estetica, di valutazione delle forme di memoria piuttosto che per il prodotto in s. Conseguenza di tale impostazione che il percorso del viaggio, in genere non prefissato rigidamente ma discusso durante gli incontri di preparazione, legato allargomento specifico, quasi monografico, previsto per ogni anno scolastico: il tema centrale del lavoro di studio e approfondimento indicato in testa a ogni resoconto, nelle pagine che seguono. Fin dal primo anno sono state costruite delle guide al viaggio: queste, prima ancora che illustrare la storia specifica dei luoghi da visitare, intendono mettere i luoghi in relazione alle attivit svolte, ai progetti da realizzare, a un percorso possibile di conoscenza. Tutto questo non cos ovvio come potrebbe sembrare. In effetti, se osserviamo in quale contesto avvengano i numerosi viaggi organizzati da scuole e istituzioni (non solo intorno alla data fatidica del 27 gennaio), possiamo individuare tipologie diverse. Potremmo perfino operare una classificazione schematica muovendoci nella variet di proposte e realizzazioni attuate in luoghi e in tempi diversi, a partire allincirca dagli ultimi ventanni (e muovendo lo sguardo non soltanto alla realt italiana, ma anche a quella di molti altri Paesi europei, oltre naturalmente a Israele). C (ed una tipologia pi frequente di quanto non sembri) il viaggio premio, legato a un concorso, nazionale o locale; c il viaggio istituzionale, frutto di iniziative di singole amministrazioni ed enti territoriali, caratterizzato da momenti di maggiore ufficialit e cerimonialit; c il viaggio di istruzione (non sembri blasfemo il riferimento alla vecchia gita scolastica), momento di routine scolastica in cui la visita a un luogo di memoria tende a costituire una parentesi di riflessione (ci che non rende il viaggio meno significativo, ovviamente) in un contesto dinsieme pi vicino alle dinamiche turistiche. Crediamo che il tipo di viaggio cui si avvicinano le esperienze del Progetto Memoria moncalierese sia ancora qualcosaltro, definibile certamente come viaggio di studio, se non ci fosse un elemento in qualche modo eccedente, costituito dalla presenza in un contesto di progettualit quale quello indicato di figure-chiave della memoria, ossia i superstiti dei campi, che sempre in tutti questi anni hanno accompagnato insegnanti e studenti sui luoghi dello sterminio. peraltro vero che anche negli altri tipi di viaggio il testimone presente: ma nel caso del viaggio di studio, lo studio il rapporto con il passato e il recupero dei suoi significati si carica di una dimensione di autenticit che mobilita forze di natura emotiva (e questo un processo non privo di rischi, se lasciato senza controllo) e istanze etiche profonde, messe in gioco da eventi in cui sono coinvolti valori umani fondamentali. Anche lesperienza del
Introduzione
13
testimone e della testimonianza si collocher, come quella del contatto con i luoghi, in posizione intermedia allinterno di tutto il percorso conoscitivo proposto. Restando su un piano pi concreto, va sottolineato che questa strategia di viaggio di studio e testimonianza condivisa da numerose scuole, piemontesi e non, per iniziativa di singoli insegnanti che poi si coordinano in gruppi pi ampi, in genere con apporti interdisciplinari, di cui rimangono tracce significative in pubblicazioni, film, lavori multimediali e altro.5 Ci pare per che lesperienza di Moncalieri riesca a intrecciare il piano del viaggio di studio con quello del viaggio istituzionale perch si lega, come appare da queste pagine, al territorio tramite le attivit di laboratorio (ben visibile, questo aspetto, in alcuni viaggi, come quello esplicitamente dedicato alla deportazione dei moncalieresi del 2005, nel sesto decennale della Liberazione) e tramite un momento istituzionale di ufficialit sempre presente in ogni viaggio. Crediamo che una simile prospettiva aumenti, in qualche modo, la valenza educativa e formativa del Progetto stesso, in unottica contemporaneamente locale ed europea (e forse anche pi ampia, nelle intenzioni). Moncalieri ha avuto pochi deportati, come ricordiamo in altra parte del volume. Il coinvolgimento, negli ultimi anni, di alcuni loro famigliari, divenuti in qualche modo, nel corso dei viaggi, testimoni di secondo grado, ha fatto s che il viaggio ai luoghi abbia implicitamente ricuperato una terza tipologia di viaggio, che poi la pi antica: quella del viaggio di pellegrinaggio. Un pellegrinaggio laico, beninteso, che un ritorno dei superstiti e una ricerca, da parte dei famigliari degli scomparsi, di tracce e segni, nei luoghi, delle vite perdute. Questo tipo di viaggio, carico di memoria e di affetti quindi di emotivit , si originato nei primi anni del dopoguerra; riguarda in primo luogo i superstiti e i famigliari degli scomparsi, in genere riuniti nelle prime forme associative che solo pi avanti, negli anni 60, confluiranno in quella che oggi lANED. Si configurano in quel momento due livelli di testimonianza, che riemergeranno nelle esperienze pi vicine a noi: quella del testimone diretto, del superstite, e quella che chiameremo qui di secondo grado del famigliare. Bisogna del resto pensare che il primo pellegrinaggio probabilmente quello organizzato a Torino nellottobre 1948, che port ottanta persone a Mauthausen: Alcuni di loro, gli ex soprattutto, cominceranno a fare progetti, per far s che in futuro si moltiplichino iniziative come questa e che i campi vedano, quanto prima, crescere la presenza di uomini, di donne e di giovani, soprattutto.6 una storia ancora da scrivere, ma che ha impregnato la memoria familiare e riverbera tracce nelloggi. I viaggi scolastici ai Lager, dunque, costituiscono un dato recente ma che si riallaccia a esperienze lontane e dirette dei protagonisti stessi, vissute da loro dopo la Liberazione: anche in questo si costituisce con il passato un legame diretto e tenace.7
5 Non possibile farne un censimento completo. Segnaliamo soltanto due lavori recenti e significativi ai fini del nostro discorso: G. Restelli (cur.), Auschwitz. La barbarie civilizzata: il pi grande centro di sterminio che il mondo abbia visto, Milano, RaccoltoEdizioni, / IPSIA A. Bernocchi di Legnano, 2005; Idem, Viaggio in un mondo fuori dal mondo. Dachau. Ebensee. Hartheim. Gusen. Mauthausen, Milano, RaccoltoEdizioni / IPSIA A. Bernocchi di Legnano, 2006. 6 F. Maruffi, Laggi dove loffesa (rivisitando i luoghi della memoria), Cuneo, Ramolfo, 2001, pp. 8-9. 7 In questa chiave si possono leggere le considerazioni di Ferruccio Maruffi nella Presentazione del libro (cfr. supra, pp. 8-9).
14
Crediamo che di tutto ci si possa trovare traccia nel nostro libro quando lasciamo la parola agli studenti che riflettono sulla loro esperienza di incontri con i testimoni diretti e con i testimoni che abbiamo definito di secondo grado. I testimoni, la memoria, il territorio Altra esperienza ormai decisamente diffusa quella del rapporto con la testimonianza diretta dei superstiti tenuta sui luoghi; e del resto a questultimo decennio si addice senzaltro, a livello generale, la definizione di era del testimone. Allinizio del Progetto, i viaggi ci apparivano come resi necessari proprio dalla possibilit di visitare i luoghi, i Lager, insieme con i superstiti. Essi, oltre a rendere partecipi della loro vicenda individuale, sanno indirizzare lo sguardo verso prospettive specifiche quelle del deportato italiano, che ha una sua collocazione peculiare nelluniverso concentrazionario non sempre facili da cogliere alla luce delle spiegazioni fornite, sui luoghi, dalle guide o dai pannelli rivolti a un pubblico pi vasto. Oltre a ci, se la storia di questa attivit di testimonianza (oggi quasi scontata, ma non cos dieci o pi anni fa) una difficile storia, piena di ostacoli, reticenze e rifiuti, ed forse tutta da scrivere, la figura del testimone resta fondamentale per un incontro con quel mondo fuori dal mondo di cui Primo Levi ha tracciato una sintesi cos acuta nel suo ultimo libro, I sommersi e i salvati. Nei nostri percorsi di ricerca la testimonianza stata sempre esperita nelle due forme, quella della parola (scritta, registrata) del testimone, e quella della sua presenza fisica, in un primo tempo nelledificio scolastico, per gli incontri iniziali e la presa di contatto, poi nel viaggio e sui luoghi. E abbiamo gi sottolineato quanto sia profonda, coinvolgente e formativa (nel senso veramente pi ampio del termine) lesperienza di una visita a un Lager insieme a chi vi stato, ridotto a numero, a pezzo, e ne riemerso ne riemerge ogni volta per testimoniare con le parole, o soltanto coi silenzi, con lo sguardo, con la presenza.8 Tutto questo, per, non avvenuto, e non avviene, in modo automatico e scontato, come una certa tendenza semplificatrice sembra talvolta suggerire a livello di mass media. In realt il rapporto con il testimone bidirezionale dal testimone a chi lo ascolta, ma anche da chi ascolta al testimone e necessita di un approccio consapevole. Sulla testimonianza e sul testimone come fonte di conoscenza (e non solo storiografica), alcune cose sono cambiate negli ultimi dieci anni. Il rapporto fra storia e testimonianza, fra storia e memoria oggi affrontato in modo pi complesso, nella consapevolezza di dover superare lidea (diffusa, specie in ambito scolastico, tra gli studenti) che la seconda, pi viva, prevalga sulla prima (verso la quale spesso ripetuta laccusa di essere astratta e libresca). Nel corso dellesistenza del Progetto diventata sempre pi centrale listanza a conferire il giusto ruolo a ciascun elemento e a distinguere nella complessit delle situazioni: il testimone connota e arricchisce la conoscenza storica, se gi precedentemente la possediamo; oppure il punto di partenza per allargare la visuale fino alla conoscenza ricuperata anche da altri strumenti di lavoro (pi raramente, a tale livello, viene a costituire egli stesso lunica fonte su un determinato avvenimento, o aspetto, prima ignorato). Infine oggi il testimone consapevole del ruolo che riveste, e questo talvolta genera problemi di non facile solu8
L. Monaco / G. Pernechele (curr.), Percorsi di memoria cit., p. 10.
Introduzione
15
zione. La testimonianza, anche nella situazione ideale e pi efficace che quella dellinterazione con il luogo, presuppone unallerta costante del senso critico, anzitutto ovviamente da parte del docente. Questi problemi si fanno pi acuti nella prospettiva, certo non lontana, dellutilizzazione della testimonianza viva effettuabile soltanto attraverso la sua registrazione.9 Nel nostro Progetto abbiamo seguto due strategie per fissare il rapporto con il testimone in modo da rendere pi praticabile la strada della riflessione e rielaborazione su un piano non solamente empatico o emotivo; o se si preferisce il superamento della dimensione di pura soggettivit a cui la testimonianza, da sola, rischia di rimanere confinata. La prima stata quella di fissare la testimonianza sul luogo attraverso la registrazione (cio la ripresa video) e i successivi interventi di montaggio (quindi di ri-costruzione della testimonianza) se lesperienza si calata nella successiva realizzazione di un film (si veda per questo aspetto lAppendice VII. B del libro). Certamente gli intenti in questo lavoro sono anzitutto didattici, e quindi non si pu pensare che tali materiali costituiscano dei veri e propri apporti specialistici o documentari. Tuttavia la costituzione dellArchivio Multimediale, illustrata pi avanti (nellAppendice VII. A), ha lambizione di proporre materiali utili non solo a documentare i dieci anni di attivit, ma anche le singole vicende dei testimoni che vi compaiono. La seconda si collocata sul versante della trasformazione della testimonianza in parola scritta. Si deve del resto pensare che scrivere, forse pi ancora che parlare, stato un impulso primario nei deportati sia durante la prigionia, sia allindomani della Liberazione.10 Ci piace pensare che il passaggio dalloralit alla scrittura stato, anche qui, bidirezionale: studenti che trascrivono i racconti dei testimoni, e testimoni che, forse anche dopo aver visto le proprie parole prendere forma, organizzano il loro racconto in libro.11 Le nuove scritture raccolte nel Capitolo IV del presente volume costituiscono, almeno ce lo auguriamo, un preludio a nuovi libri di memoria. Anche in questo modo, pensiamo, si pu evitare il rischio dellappiattimento, della sovrapposizione tra memoria e storia e si rinnova la possibilit di ricordare e comme9 Rinviamo alle pagine di Annette Wieviorka, Lera del testimone, trad. it. di F. Sossi, Milano, Cortina, 1999, in particolare pp. 109 sgg. 10 Laffermazione pu sembrare discutibile, ma suffragata da testimonianze capillarmente diffuse: per esempio, Orfeo Mazzoni (un deportato di Moncalieri), in unintervista del 1982 ricorda: Quando sono arrivato a casa da Mauthausen mi sono messo l e ho fatto un piccolo diario, ma il diario della, diciamo solo, della prigionia... Lho fatto perch ho fatto un diario, non un diario, ho tirato gi degli schizzi diciamo sarebbe, pi che tutto sarebbe che uno si ricorda di si ricorda dei numeri, diciamo (ADP). Pio Bigo, deportato a Mauthausen, Gusen, Linz, Auschwitz e Buchenwald, riusc a tenere un piccolo diario durante la sua permanenza a Linz, anche se poi dovette disfarsene (Il triangolo di Gliwice. Memoria di sette Lager, Alessandria, Edizioni dellOrso, 1998, p. 72). Il suo compagno di deportazione Sergio Lucco Castello stese una memoria allindomani stesso della Liberazione, allospedale di Linz. Attilio Armando, deportato a Flossenbrg, stende le sue memorie che riprender qualche anno dopo ampliandole al suo ritorno in Val di Susa (Dalla Val Sangone a Flossenbrg, Alessandria, Edizioni dellOrso, 2006). E fin qui abbiamo citato casi appartenenti alla categoria di coloro che non scrivono (cfr. P. Bigo, Il triangolo di Gliwice cit., p. 170); a maggior ragione laffermazione vale per nomi pi noti (Liana Millu, Giuliana Tedeschi, e ovviamente lo stesso Primo Levi). 11 Questo ci pare possa essere detto per Natalino Pia, che dopo la pubblicazione di un breve riassunto della sua vicenda di scampato alla ritirata di Russia e allo sterminio di Gusen (in Percorsi di memoria cit., pp. 73-74 e alle pp. 205-207 del presente volume) ha proposto il suo racconto per esteso nel volume La storia di Natale. Da soldato in Russia a prigioniero nel Lager, Novi Ligure, Joker, 2003, 20063).
16
morare affiancandosi alle forme istituzionali senza cadere in ritualizzazioni formali e in luoghi comuni mediatici. Nuove possibilit per la memoria diretta ci pare siano offerte dalla presenza dei testimoni di secondo grado di cui gi abbiamo detto. Probabilmente si tratta di un discorso ancora da affrontare e da pensare in termini teorici. La presenza, sempre discreta e mai sostitutiva, dei famigliari vogliamo qui ricordare Adriano Sattanino, i famigliari di Orfeo Mazzoni, di Pietro Paolo Bertoglio, di Antonio Temporini, la moglie e la figlia di Natale Pia (Margherita Benzi, mancata nel 2006, e Primarosa Pia) ha costituito in qualche modo un tramite empirico tra le nuove generazioni e la memoria vissuta del passato. Ma soltanto un inizio, che riteniamo debba essere ulteriormente esplorato confrontandolo anche con le esperienze legate ad altre situazioni e realt territoriali. Se poi limitiamo il discorso a Moncalieri, il legame stretto che il Progetto ha istituito con alcuni momenti celebrativi (anzitutto la ricorrenza del 27 gennaio, poi quella del 25 aprile) ed espositivi (mostre e rassegne) ha segnato in modo sempre pi marcato questi ultimi anni, come si pu notare dal riepilogo proposto pi avanti (Capitolo V) sui modi in cui le nostre esperienze si sono connesse al Giorno della Memoria. Un segno permanente quello lasciato dalle due lapidi, una posta nellatrio del Palazzo Comunale, laltra sulla scalinata di Via Monfalcone, che ricordano sia le vittime sia le attivit di memoria dei superstiti dei Lager. Un tema trasversale Il Progetto Memoria ha costituito, prima di tutto, unesperienza scolastica e didattica, e concluderemo con questi aspetti. Quando scegliemmo il termine percorsi per dare il titolo al libro che chiudeva lesperienza dei primi quattro anni era perch avevamo individuato nella storia dei Lager, della deportazione, della Shoah argomenti scomodi, inconciliati, eccedenti un nodo conoscitivo che comporta attenzione alle dimensioni letteraria, linguistica, sociologica, artistica anche per coniugare adeguatamente emozionalit e razionalit.12 Ci pare di aver proceduto con maggiore sicurezza su questo terreno, introducendo in modo pi deciso temi e metodi specifici di discipline diverse, individuate con precisione e cognizione di causa. Ci appare particolarmente evidente nellapporto (quasi unirruzione) delle nuove tecnologie digitali e multimediali e dei nuovi linguaggi. Le tecniche attuali di registrazione e manipolazione di immagini, suoni e parole permettono possibilit nuove di archiviazione e conservazione della memoria, ma anche di rielaborazione e di comunicazione delle esperienze e delle conoscenze. Nella consapevolezza che anche la multimedialit sia un modo (a sua volta trasversale e interdisciplinare, implicando diversi livelli di abilit e competenze) di trasmettere la memoria, e una modalit di comunicazione immediata ed efficace, si dato avvio a esperienze laboratoriali di questo tipo. Il coinvolgimento pi ampio si ovviamente avuto nella scuola tecnologica per definizione fra le tre, cio lITIS Pininfarina, con la partecipazione di insegnanti e specialisti informatici e unattenzione particolare alla sintassi dei linguaggi visivi e anche alla responsabilit che nasce dalle scelte formali decise nei momenti di rielaborazione dei materiali e dei
12
L. Monaco / G. Pernechele (curr.), Percorsi di memoria cit., p. 9.
Introduzione
17
documenti.13 Il libro presenta quindi, oltre al suo aspetto consueto, cartaceo, costituito dalle parole stampate, alcuni saggi di tale attivit di memoria multimediale, raccolti in due DVD. Analogamente, la dimensione estetico-artistica, legata in particolare alle arti figurative in altri termini, pi chiaramente scolastici, la disciplina di disegno e storia dellarte servita a costruire una griglia conoscitiva fondante sia dei modi di vedere i luoghi, durante il viaggio, sia delle forme di documentazione, rappresentazione e interpretazione dellesperienza comunicata al ritorno. Probabilmente il risultato pi interessante raggiunto in tale ambito costituito dal lavoro sul Monumento italiano a Mauthausen, di cui riportiamo una parziale documentazione, essendo, almeno in votis, unattivit in corso dopera suscettibile di ulteriori sviluppi. Un altro approccio trasversale e, come si dice, interdisciplinare si configurato nellapertura alle scienze biologiche, con gli apporti pi recenti della genetica, per intervenire in termini specifici nella discussione sulle teorie razzistiche che stavano alla base delle legislazioni antisemite nazista e fascista e che a tratti riemergono, trasformate o mascherate, in non poche realt del mondo contemporaneo: un intervento di rigore scientifico che conferma il carattere profondamente educativo e (cosa pi importante) formativo del Progetto, per gli studenti e i docenti che vi partecipano.14 Di queste attivit, a bilancio fortemente positivo, diamo appunto conto nel volume, in una sezione apposita, perch riteniamo che il loro inserimento esplicito e strutturato costituisca un tratto originale del Progetto. Tali scelte hanno corrisposto, del resto, alle trasformazioni intervenute in questi anni nei luoghi della memoria, cui si accennava allinizio della nostra Introduzione. Nel costituirsi dei Lager (spesso, come nel caso di Bolzano, Gusen, Ebensee, di quel che ne resta, e non molto) in musei (usiamo le virgolette perch si tratta di musei particolari, com ovvio e come apparir pi ovvio a chi legger il saggio dedicato a questo problema, un saggio che ci piace pensare nato proprio dalla interazione con i nostri viaggi, specie quelli del secondo quinquennio), la forza comunicativa dellespressione estetica, che qui diventa pi esplicitamente allusiva e simbolica, ha sostituito con maggiore ricchezza di linguaggio e di significati la precedente generazione (se cos si pu chiamare) di opere monumentali e commemorative. Il caso pi emblematico forse quello del Castello di Hartheim, dove una serie di installazioni particolarmente significative contribuiscono a far emergere e a rivelarsi alla conoscenza e alla sensibilit emotiva la realt del centro di sterminio che era stata cancellata fisicamente dai nazisti, e che n la presenza di strutture commemorative n la ricostruzione archeologica riuscirebbe a restituire con la stessa intensit. Il discorso vale per tutti quei Lager in cui non solo il ricordo, ma anche la comprensione profonda degli eventi sono affidati a installazioni ed esposizioni permanenti che seguono i canoni dellarte contemporanea o delle espressioni pi di avanguardia e talvolta sperimentali.
13 14
Si vedano pi avanti le Appendici VII. A (Archivi della memoria) e VII. B (Immagini della memoria). Su questo aspetto di educazione paritaria (docenti e discenti, in una certa fase dellattivit, imparano e crescono intellettualmente in egual misura) e continua, cos come sulla strategia dei percorsi, e sul rapporto tra memoria individuale e conoscenza storica, si vedano le considerazioni di David Sorani, Dallo studio della Shoah alla passione civile, in Ha Keillah, a. XXXI-153, n. 1 / febbraio 2006, e il precedente Esistenza, memoria e storia, ibidem, a. XXX-148, n. 1 / febbraio 2005.
18
Il percorso che passa attraverso questa somma di esperienze, e che abbiamo cercato di delineare, consente di definire il Progetto Memoria come un laboratorio di pratiche conoscitive e di intervento nella realt. Di qui limportanza, per noi, delle realizzazioni successive al viaggio, e in particolare di quelle che meglio esprimono la tensione a comunicare, pi che descrizioni o racconti, le rielaborazioni personali. consueto affidare tale compito alla parola scritta; noi abbiamo cercato di farlo anche attraverso le immagini, ed per questo che nel Capitolo III viene proposta una scelta di sguardi sui luoghi della memoria, nella forma di fotografie fortemente interpretative: una scelta seguta anche da molte istituzioni museali e che pare, oggi, tra le pi adatte a comunicare ci che sembra incomunicabile.15 E questo, nella convinzione gi espressa nei Percorsi di memoria pi volte citati, e che non possiamo non ribadire, che la conoscenza piena dei Lager nazisti e di ci che hanno rappresentato dovrebbe davvero costituire, per gli uomini di oggi che vivono uninquieta modernit, una tappa obbligatoria del loro percorso di formazione civile ed etica.
15
Un esempio tra i pi riusciti E. Balawejder / T. Kranz / B. Romm, In the middle of Europe. Konzentrationslager Majdanek, Mnster, Stadtmuseum Mnster, 2001.
19
Capitolo I - I viaggi del Progetto
1. Lo sterminio attraverso il lavoro*
27-30 aprile 1998: viaggio di studio a Mauthausen e Dachau Lucio Monaco
Questo primo viaggio di studio stato impostato, sia per il percorso di preparazione sia per quello di visita, allinsegna di un tema che si voleva ben congruente con i luoghi visitati: quello del Lager inteso come luogo non solo di sterminio, ma di sterminio produttivo e di annientamento mediante il lavoro, in stretta interdipendenza con le industrie di guerra e in prospettiva, secondo i nazisti con i bisogni economici di un ipotetico tempo di pace.1 un aspetto che caratterizza la deportazione italiana, dato il quadro cronologico, e che coinvolge anche le vicende degli ebrei deportati dallItalia, come gi notava Primo Levi nella sua Prefazione a Se questo un uomo. Mauthausen e Dachau, il primo con i suoi ottomila italiani deportati (di cui circa la met dal Piemonte, secondo Anna Bravo e Daniele Jalla2) e il secondo con i suoi oltre diecimila, disseminati in entrambi i casi nei vari sottocampi, rappresentano per la variet e la vastit delle articolazioni produttive lemblema stesso di tale dimensione del Lager. Quaranta studenti dellITCS Marro e del Liceo Scientifico Majorana, con 3 testimoni (Natale Pia, Benito Puiatti e Margherita Benzi Pia), 4 insegnanti e 2 Consiglieri comunali (Roberta Battilana, Doriano Begheldo) hanno ripercorso uno degli itinerari della deportazione italiana, sullasse del Brennero. La scelta di questo tracciato il pi diretto per giungere a Salisburgo, e di l nel bacino del Danubio obbediva anche alla volont di ricordare che lItalia di Sal ha conosciuto, allinterno del suo territorio, la presenza di campi di smistamento e di prigionia, anche se le tracce sono ormai labili. Il passaggio per Bolzano ha cos costituito loccasione per ricordare, con una breve scheda e con la stessa presenza di Natalino Pia, il campo oggi scomparso. Il giorno 28 stato dedicato interamente alla visita del Lager principale di Mauthausen (che si presenta come luogo di memoria e come museo) e del sottocampo di Gusen (di cui resta unicamente il Memoriale, opera dellarchitetto Lodovico Belgiojoso, egli stesso superstite del Lager). La visita al Lager principale, scandita da letture di pagine di memorie e di poesie di deportati, iniziata con una riflessione davanti al Monumento italiano, proseguendo poi secondo il percorso concordato con il testimo-
* 1
I titoli dei paragrafi che seguono riprendono i temi che sono stati di volta in volta al centro del Progetto. Lettera di Oswald Pohl a Heinrich Himmler, datata 30.4.1942 e cosiddetta Circolare Pohl. Cfr. La circolare Pohl. Lannientamento dei deportati politici nei Lager nazisti attraverso il lavoro, Milano, FrancoAngeli, 1991, p. 51. 2 A. Bravo / D. Jalla, La vita offesa, Milano, FrancoAngeli, 1986 sgg., p. 19.
20
Capitolo I
ne principale, Natalino Pia, cio quello stesso seguto dai deportati al loro arrivo, integrato con la visita del Museo e di altri settori del campo. Data la ristrettezza di alcuni locali, ci si divisi in due sottogruppi alternando per sempre gli interventi testimoniali a indicazioni storiche (specialmente sulle gassazioni dellaprile 1945, che hanno coinvolto numerosi italiani). Nel pomeriggio si visitato il Memoriale di Gusen, e si sono incontrati i rappresentanti di unAssociazione locale, attiva nella conservazione della memoria dei tre sottocampi dellarea di Gusen: lArbeitskreis fr Heimat- Denkmal- und Geschichtspflege (AHDG). Alla lettura di testi di memoria di superstiti italiani si cos affiancata la visita guidata al Memoriale e al vicino sistema di gallerie denominato Bergkristall, presso St. Georgen. La visita, accompagnata da spiegazioni e inquadramenti storici effettuati in inglese, durata fino al tardo pomeriggio. Il giorno successivo stato dedicato alla visita di Salisburgo e quindi allo spostamento a Monaco. Il 30 si svolta la visita al Lager e Museo di Dachau, con un momento ufficiale in cui il Sindaco di Moncalieri, Carlo Novarino, e lAssessore alla Cultura, Mariagiuseppina Puglisi, hanno incontrato il primo Vicesindaco di Dachau, Katerina Ernst, e Gabriella Hammermann, responsabile della ricerca presso il Memoriale di Dachau. Anche qui, oltre a brevi discorsi delle autorit, stata data la parola alle testimonianze scritte di superstiti (testi poetici di Giovanni Melodia e Nevio Vitelli),3 mentre Benito Puiatti, il testimone deportato a Dachau, ha poi guidato la visita allinsieme del campo e al Museo. Nel mese successivo un breve spazio di tempo, condizionato dalle scadenze della chiusura dellanno scolastico gli studenti hanno costruito un percorso fotografico, corredato di didascalie e commenti, attualmente conservato negli archivi delle due scuole. Un gruppo ha invece approfondito il contatto con Benito Puiatti, il testimone territorialmente pi vicino e raggiungibile, che ha poi steso una breve memoria della sua deportazione (pubblicata pi avanti, nel Capitolo IV, con il titolo Ricordi di Dachau), spinto dallintensit dellesperienza di questo viaggio e del colloquio con gli studenti.
2. Dalle leggi razziali nazifasciste ad Auschwitz
25-30 marzo 1999: viaggio di studio ai Lager di Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz III-Monowitz e a Cracovia
Lucio Monaco Nellanno scolastico 1998-1999 la deportazione stata studiata principalmente considerando il Lager come luogo di applicazione delle teorie razzistiche nazifasciste, anche alla luce della ricorrenza del sessantesimo anniversario delle leggi razziali italiane (1938). La scelta del luogo da visitare non poteva non ricadere su Auschwitz, con uno sforzo finanziario non indifferente, reso possibile dal contributo di altri enti e istituzioni.4
3 4
Si possono leggere nel volume apparso nelledizione originaria in tedesco e curato da Dorothea Heiser, La mia ombra a Dachau. Poesie dei deportati, trad. it. di M. G. Camia, Milano, Mursia, 1997. Oltre alla Citt di Moncalieri e ai singoli Istituti scolastici, si menzionano il Ministero della Pubblica Istruzione (circ. 411/98), la Provincia di Torino, e la filiale di Moncalieri dellallora Istituto Bancario Sanpaolo di Torino.
I viaggi del Progetto
21
Il viaggio si presentava complesso anche per lelevato numero dei partecipanti (76 studenti, 6 insegnanti, 2 testimoni, oltre a 2 Consiglieri comunali, Roberta Battilana e Arturo Calligaro), legato alla partecipazione di tutte e tre le Scuole Superiori Statali di Moncalieri (quindi con laggiunta, rispetto allanno precedente, dellITIS Pininfarina) e la ricerca di un percorso di visita adeguato alla testimonianza diretta: infatti due fra gli ultimi superstiti di Auschwitz in Piemonte, Natalia Tedeschi (deportata a Birkenau nel 1944) e Pio Bigo (politico spostato da Mauthausen a Monowitz nel dicembre 1944), si sono lasciati coinvolgere con grande disponibilit nellattuazione del programma. Si sono formati due gruppi di partecipanti che, essendo partiti a distanza di un giorno, hanno visitato in momenti separati le citt di Cracovia e Varsavia per poi ritrovarsi nel momento centrale del percorso di studio di Auschwitz (27 e 28 marzo). Il filo conduttore stato costituito dalla testimonianza di Natalia Tedeschi (si veda pi avanti, al Capitolo IV) e dalla memoria scritta di Pio Bigo che ha dovuto rinunciare al viaggio per unimprovvisa malattia contenuta nel suo libro Il triangolo di Gliwice5 letto dai partecipanti durante la fase di studio preparatoria. Il tipo di percorso proposto per il comprensorio di Auschwitz ha potuto cos seguire un itinerario in certo senso anomalo e inusuale, poich cominciato da Birkenau, proseguendo per Monowitz e per il tratto stradale Monowice-Gliwice, pervenendo quindi alla visita di Auschwitz I e del suo Museo soltanto il secondo giorno. Birkenau stato infatti il luogo darrivo dei due testimoni, e daltro canto sulla banchina di Birkenau si svolgeva la selezione che destinava alle camere a gas gli inabili, e al sistema dei sottocampi gli abili al lavoro. Il Lager di Birkenau, o Auschwitz II, stato cos visitato per primo, affiancando la testimonianza di Natalia Tedeschi alle spiegazioni della guida e a una breve ma intensa lettura di un semplice elenco di nomi di bambini ebrei italiani (tratto dal Libro della memoria di Liliana Picciotto Fargion)6 deportati e uccisi allarrivo a Birkenau, effettuata sulle rovine di uno dei crematori.
5 6
P. Bigo, Il triangolo di Gliwice. Memoria di sette Lager, Alessandria, Edizioni dellOrso, 1998. L. Picciotto Fargion, Il Libro della memoria. Gli ebrei deportati dallItalia. 1943-1945, Milano, Mursia, 1991, 20022.
Natalia Tedeschi a Birkenau (marzo 1999)
22
Capitolo I
Nel pomeriggio si cercato di ripercorrere il tragitto della marcia della morte da Monowice a Gliwice, descritto nel libro di Pio Bigo, iniziando proprio da una visita al sito del Lager di Monowitz. Lemozione di ritrovarsi sul luogo della prigionia di Primo Levi si condensata nella lettura della poesia Buna7 presso quello che un tempo era lingresso del campo. Monowitz (Monowice in polacco) un sito difficilmente ritrovabile e visitabile, perch sono state del tutto cancellate le strutture del Lager. Solo lassistenza di uno studioso del Museo di Auschwitz, Andrzej Strzelecki, autore di studi e ricerche sulla storia del Lager, ha permesso di leggere questo e gli altri luoghi della marcia di evacuazione del campo, che si potuta seguire in dettaglio da Monowice a Neu Berun e Mikolw, e non fino a Gliwice, dato il cattivo stato della strada, in rifacimento in pi luoghi. La giornata del 27 va anche vista in funzione di una pi piena comprensione delle strutture museali di Auschwitz I, visitato il 28, strutture che com noto riguardano prevalentemente Birkenau e la storia della Shoah, e che sono state quindi analizzate come momento di sintesi di unesperienza compiuta in gran parte con la visita precedente a Birkenau e a Monowitz (e naturalmente con i lavori e le ricerche scolastiche). Sempre ad Auschwitz I si svolto un momento ufficiale con lincontro del Sindaco di Moncalieri, Carlo Novarino, e dellAssessore alla Cultura, Mariagiuseppina Puglisi, con una delegazione del Comune di Os wie cim (nome polacco di Auschwitz). Le due giornate di Auschwitz sono state efficacemente inquadrate, prima e dopo, anche dai percorsi di visita dedicati ai Ghetti di Cracovia e ai luoghi del Ghetto di Varsavia e dellinsurrezione, che hanno fornito una conoscenza diretta della storia delle comunit ebraiche polacche e della Shoah. Lo spazio di tempo che ha separato il viaggio dalla conclusione dellanno scolastico ha consentito ai docenti di coordinare un ampio quadro di realizzazioni, fra cui (oltre ai lavori propriamente scolastici) vanno citati i due video I giovani e la memoria8 e Compagni di un viaggio , 9 unesposizione fotografica, analoga a quella dellanno precedente, allestita separatamente nei tre istituti scolastici e quindi alla Biblioteca Comunale di Moncalieri, e il C D -Rom multimediale Il 900. I giovani e la memoria (1999, ITIS Pininfarina).
7 Gi in P. Levi, Losteria di Brema, Milano, Scheiwiller, 1975; poi confluita in Idem, Ad ora incerta, Milano, Garzanti, 1984. 8 1999, SVHS, col., 17, regia C. Piana (ITIS Pininfarina), presentato alla rassegna torinese Big 2000. 9 1999, VHS, col., 8, regia E. Cassaro / M. Gai (L.S. Majorana), presentato a Torino Film Festival 1999 (Scuole).
Letture a Birkenau (marzo 1999)
I viaggi del Progetto
23
3. Forme della memoria (I)
26 novembre 1999: viaggio di studio al Museo del Deportato di Carpi (Modena) e a Fossoli di Carpi
Lucio Monaco Il tema scelto per lattivit dellanno 1999-2000 una riflessione sui Lager come luogo di conservazione monumentale, museale e documentale di memoria stato definito con la formula di Forme della memoria. Si sono pertanto studiati, e anche per cos dire verificati sul campo, i vari modi in cui si pu trasmettere la memoria di tali eventi, dalla parola scritta (il libro, lintervista, la ricerca storica) allimmagine, considerata nelle sue varie forme espressive (fotografia, cinema, multimedialit). Il rapporto fra le scuole si fatto pi stretto (e pi specialistico) con listituzione, presso lITIS Pininfarina, di un Laboratorio Multimediale Interscolastico espressamente dedicato allargomento. Questa prima, rapida giornata di studio ha quindi avuto la duplice funzione di alfabetizzare gli studenti che partecipavano alliniziativa per il primo anno, e contemporaneamente di introdurre al complesso problema della conservazione dei luoghi. Nessun luogo in Italia cos emblematico della cattiva coscienza nazionale come il campo di transito di Fossoli, di cui si procede lentamente e faticosamente a un difficile ricupero. La particolare formula espositiva del Museo di Carpi (efficacemente illustrata dalle responsabili, Roberta Gibertoni e Annalisa Melodi), daltro canto, oltre ad avviare allo studio della deportazione, rappresenta emblematicamente le numerose possibilit della memoria monumentale. Anche in questo caso, comunque, la memoria di un luogo abbandonato come il campo di transito di Fossoli stata resa pi viva, durante la visita, dalla lettura di una nota poesia di Primo Levi, Il tramonto di Fossoli.10
4. Forme della memoria (II)
4-8 aprile 2000: viaggio di studio al Lager di Mauthausen e ai suoi sottocampi (Melk, Gusen, Linz, Hartheim, Ebensee)
Lucio Monaco Il nuovo viaggio ai Lager del sistema Mauthausen stato concepito allo scopo di costruire unimmagine storica non solo dellorganizzazione dello sfruttamento/sterminio di esseri umani attuato dai nazisti, ma anche delle varie forme di conservazione della memoria: il luogo-museo e centro di ricerca e documentazione (il campo principale); il luogo-monumento, con le sue varie soluzioni (il Memoriale di Gusen, il Crematorio-Memoriale di Melk); il luogo restituito e parzialmente ricostruito (le gallerie di Ebensee); il luogo scomparso e solo a fatica ricostruibile (Linz). Il periodo di preparazione e di studio si principalmente basato sulla lettura di testi di memoria e su un saggio di particolare interesse.11 Partecipavano al viaggio 43 studenti delle tre scuole,
10 11
Cfr. supra, nota 7. Gordon J. Horwitz, Allombra della morte. La vita quotidiana attorno al campo di Mauthausen, trad. it. di G. Genovese, Venezia, Marsilio, 1994.
24
Capitolo I
accompagnati da 4 insegnanti e da un testimone, Pio Bigo, superstite di tre dei Lager visitati (Mauthausen, Gusen, Linz), oltre a 2 Consiglieri comunali (Pietro Aguiari, Arturo Calligaro) e al Presidente del Distretto scolastico 32, aggiuntosi ai patrocinatori delliniziativa. Anche in questo viaggio, per dare un respiro pi ampio (e, sostanzialmente, europeo) allesperienza, si stabilito un contatto con le organizzazioni locali che si fanno carico, non sempre senza problemi, dei luoghi di memoria. Il primo luogo visitato stato il Memoriale di Melk, raggiunto dopo aver visitato la nota abbazia, lungo un percorso che era, in parte, quello degli stessi deportati avviati a lavorare nelle gallerie vicine al campo. Il giorno dopo (6 aprile) il gruppo ha proceduto alla visita di Mauthausen, guidata e dettagliatamente illustrata anche sulla base del proprio vissuto dal testimone Pio Bigo, che si era in precedenza incontrato a lungo con studenti e insegnanti. Sempre nel campo principale si svolto lincontro ufficiale fra le autorit di Moncalieri e il Sindaco di Mauthausen. Il pomeriggio stato dedicato a una visita a Gusen (anchessa vivificata dalla testimonianza diretta) e quindi al luogo dove sorgevano i tre Lager di Linz, oggi non pi visibili, luogo ritrovato grazie alle indicazioni di Brigitte Kepplinger, dellUniversit di Linz. Accanto ad alcuni pannelli commemorativi di recente installazione, Pio Bigo ha cos potuto rievocare una parte della sua prigionia sui luoghi stessi della deportazione.
Mauthausen: la cerimonia ufficiale con Pio Bigo (aprile 2000)
Il 7 aprile il gruppo ha raggiunto Salisburgo passando per Hartheim: qui, grazie alla disponibilit di Brigitte Kepplinger, stato visitato nonostante le difficolt legate a imponenti lavori di restauro del Castello il Memoriale dedicato alle vittime dellOperazione T4 e ai deportati uccisi nella camera a gas, anche in questo caso inquadrando il contesto storico e richiamando le letture esaminate durante il periodo preparatorio. Nella tarda mattinata si raggiunto Ebensee, dove si affiancata la te-
I viaggi del Progetto
25
stimonianza di un deportato polacco, Wl adisl aw Zuk, che collabora con i responsabili del Memoriale, e che come Pio Bigo era stato prigioniero ad Auschwitz. La visita del sito del Lager, ricostruibile dai pochi elementi rimasti, in analogia al caso di Gusen, e le spiegazioni storiche fornite allinterno dellunica galleria oggi aperta ai visitatori hanno concluso la fase di studio del viaggio, proseguito nel pomeriggio e nel giorno seguente con una visita storica e artistica di Salisburgo. Anche in questo caso, accanto a prodotti pi legati allattivit scolastica, si possono rilevare alcune realizzazioni caratterizzanti il Progetto: i video Le forme della memoria12 e Frammenti di memorie,13 il CD-Rom multimediale Un viaggio nella memoria.14
5. Memoria e scritture
15-18 marzo 2001: viaggio di studio a Berlino, Wannsee, Sachsenhausen e Ravensbrck
Lucio Monaco Memoria e scritture stato il tema-guida del quarto anno di attivit. Scritture al plurale, per sottolineare la molteplicit dei modi di tramandare la memoria, sia da parte dei testimoni e dei protagonisti, sia da parte di chi comunica la memoria delle proprie esperienze nate, o comunque legate, a quella memoria. Scritture dunque nel senso di tracce incise con la parola scritta, o loralit raccolta e fissata con la registrazione, limmagine o la multimedialit, ultima delle scritture moderne. I percorsi nelle scritture tracciati dagli approcci di studio diversi da scuola a scuola sono poi stati riletti e, si pu dire, rivissuti nel viaggio di studio che ha avuto come meta larea di Berlino: citt della convivenza fra luoghi di memoria modernamente predisposti come lallestimento del Bebelplatz, la piazza del rogo dei libri del 1933, dove scaffali vuoti sotterranei, visibili attraverso un vetro, ricordano il gesto che avrebbe poi portato a bruciare, dopo i libri, gli uomini e documenti del passato, come i resti, per quanto modificati, dei Lager di Sachsenhausen (uno dei primi e pi importanti in territorio tedesco) e di Ravensbrck (unico Lager destinato esclusivamente alla deportazione femminile). Al viaggio hanno partecipato 54 studenti delle tre scuole, 6 insegnanti, 2 testimoni superstiti (Anna Cherchi e Natalia Tedeschi), 2 Consiglieri comunali (Arturo Calligaro, Silvia Di Crescenzo), il Presidente del Distretto scolastico 32.
Anna Cherchi e Natalia Tedeschi a Sachsenhausen (marzo 2001)
12
2000, VHS, col., 20, in concorso a Sottodiciotto Filmfestival (Torino, novembre 2000) e a Torino Film Festival 2000 (Scuole) realizzato dagli insegnanti dellITIS Pininfarina e da studenti dei tre Istituti (accluso al volume a cura di L. Monaco/G. Pernechele, Percorsi di memoria. Viaggi di studio nei Lager nazisti 1998-2001, Citt di Moncalieri, Assessorato alla Cultura, 2002). 13 2000, SVHS, col., 9, regia E. Cassaro (L.S. Majorana), presentato a Torino Film Festival 2000 (Scuole). 14 2000, Laboratorio Multimediale Interscolastico presso ITIS Pininfarina.
26
Capitolo I
Gi nel pomeriggio della prima giornata, dedicato alla visita di Berlino, il percorso di tipo urbanistico-architettonico in rapporto con la storia della citt immediatamente prima, durante e dopo la guerra ha toccato in pi punti loggetto specifico del viaggio (in particolare con linstallazione di memoria del Bebelplatz ricordata sopra). Il mattino del 16 stato impegnato dalla visita al Lager di Sachsenhausen, guidata dal personale del locale Museo, con una sosta davanti ai monumenti commemorativi, alle rovine del crematorio e della camera a gas e al luogo delle esecuzioni. I partecipanti si sono divisi in due gruppi (necessit comune in tutti i luoghi di questo tipo, che richiedono raccoglimento e stretta colloquialit con chi illustra, spiega o testimonia), che hanno seguto percorsi diversi, ritrovandosi poi al Blocco Patologia: qui si svolto il momento testimonialmente pi significativo e nel contempo pi carico di emozione, quando Anna Cherchi ha raccontato sul luogo stesso dove stata torturata la sua esperienza di vittima di un esperimento medico. Nel pomeriggio si raggiunto il Museo dellOlocausto di Wannsee, visitato a piccoli gruppi coordinati dagli insegnanti dopo una dettagliata spiegazione dellevento storico e dellarticolazione del sito di memoria. Nella villa oggi trasformata in Museo dellOlocausto, gli studenti hanno cos potuto ripercorrere attraverso documenti scritti e fotografie lintera storia del Terzo Reich, della Conferenza di Wannsee, delle sue conseguenze. Il giorno 17, insieme con il Sindaco di Moncalieri Carlo Novarino e lAssessore alla Cultura Mariagiuseppina Puglisi, il gruppo ha raggiunto il Lager di Ravensbrck. La direttrice del Memoriale, Sigrid Jacobeit, ha accolto il gruppo e ha poi ceduto la parola ai Sindaci di Moncalieri e di Frstenberg per una breve cerimonia; anche questo momento ufficiale, che ormai una tradizione dei viaggi di studio nellambito del Progetto Memoria, ha avuto un particolare significato, in quanto sottolinea la volont da parte delle istituzioni di preservare la memoria dei Lager e di sostenere unesperienza di alto valore formativo per le nuove generazioni. Nel pomeriggio una parte del gruppo si trattenuta fino a sera nel Memoriale, approfondendone la visita (in particolare allarea vera e propria del campo, in fase di ristrutturazione, e alle esposizioni in corso), effettuando riprese video e soprattutto dialogando con le due testimoni, in una straordinaria e irripetibile sinergia di esperienze legate alla dimensione per molti aspetti peculiare anche al livello dei linguaggi e delle scritture della deportazione femminile. Lultimo giorno stato poi dedicato ad alcuni aspetti culturali offerti da Berlino (principalmente la Museuminsel) e al rientro. I risultati delle attivit di ricerca e dellesperienza del viaggio sono confluiti in un CD-Rom curato dal Laboratorio Multimediale Interscolastico presso lITIS Pininfarina, intitolato Memoria e scritture , come sempre sotto la supervisione tecnica di Francesco Martino e dei suoi collaboratori, e in un video, 44145 Anna.15
15 2001, Betacam, col., 16, regia M. Cane (L.S. Majorana), presentato in una sezione di Torino Film Festival 2001 e accluso al precedente volume Percorsi di memoria cit.
I viaggi del Progetto
27
6. Lultima fase dei Lager: storia e memorie
27 febbraio-3 marzo 2002: viaggio di studio ai Lager di Buchenwald e Dora
Marcella Pepe Il percorso di studio di questanno si incentrato sulla storia della fase conclusiva dei Lager, alla luce dei luoghi scelti come meta del viaggio i Lager di Buchenwald e Dora e in considerazione dellesperienza dei due testimoni accompagnatori, Pio Bigo, superstite di Buchenwald, e Albino Moret, superstite di Dora. I due Lager rappresentarono, infatti, nel sistema concentrazionario nazista un immenso serbatoio di manodopera impiegata nellindustria degli armamenti e nella produzione missilistica (in particolare Mittelbau-Dora), che segnarono la politica economica degli ultimi anni del regime. La testimonianza di Pio, che nel suo libro16 ha dato memoria dellinsurrezione di Buchenwald, stata dunque il filo conduttore delle ricerche preparatorie, accanto ad altri testi di ex deportati del Lager,17 mentre il saggio sugli schiavi di Hitler18 ha consentito agli studenti di conoscere la storia delle gallerie di Mittelbau-Dora, premessa indispensabile per ascoltare la testimonianza appassionata di Albino. Al viaggio hanno partecipato 38 studenti delle Scuole Superiori di Moncalieri, 6 docenti, i testimoni appena ricordati, Carla Piana (in veste di regista), 2 Consiglieri comunali (Pietro Aguiari, Giuseppe Artuffo) e un rappresentante del Distretto scolastico 32 (Giuseppe De Girolamo). Il programma prevedeva, oltre alle visite delle citt di Weimar, Erfurt e Ulm, tutte e tre di notevole interesse storico-artistico, due giornate di studio da dedicare ai siti della deportazione (28 febbraio e 1 marzo). La mattina del 28 una guida del Memoriale di Buchenwald ha condotto il gruppo attraverso i resti del vastissimo Lager di Buchenwald, accompagnata nelle spiegazioni dalla testimonianza, intensa e puntuale, di Pio Bigo. Le parole di Pio hanno ripetuto instancabilmente le pagine del suo libro: lappello dei prigionieri, il ricordo della baracca n. 10, il trasporto e la cremazione dei cadaveri, linsurrezione dell11 aprile e la fuga delle SS dal campo.19
P. Bigo, Il triangolo di Gliwice. Memoria di sette Lager cit. In particolare, E. Wiesel, La notte, trad. it. di D. Vogelmann, Firenze, Giuntina, 1988; R. Antelme, La specie umana, trad. it. di G. Vittorini, Torino, Einaudi, 1969, 19972; J. Semprn, Il grande viaggio, trad. it. di G. Zannino Angiolillo, Torino, Einaudi, 1964, 19902. 18 R. Lazzero, Gli schiavi di Hitler. I deportati italiani in Germania nella seconda guerra mondiale, Milano, Mondadori,1996. 19 Si rimanda agli ultimi capitoli del Triangolo di Gliwice cit. (pp. 105-129), dove si possono ritrovare la testimonianza su Buchenwald e il racconto della sua liberazione.
17
16
Testimonianza di Pio Bigo a Buchenwald (febbraio 2002)
28
Capitolo I
Il 1 marzo, giorno della visita al Lager di Mittelbau-Dora e alle sue gallerie, in prossimit della citt di Nordhausen, il gruppo stato guidato dal Direttore del Museo, Jens-Christian Wagner, e da Albino Moret, che aggiungeva i suoi personali ricordi sulle condizioni di lavoro e di vita dei prigionieri alla ricostruzione storica (tutta in tedesco, con traduzione simultanea) della guida. Dopo la visita del Museo il gruppo si recato sul luogo vero e non quello ufficiale con la lapide commemorativa della fucilazione dei sette alpini italiani colpevoli di sabotaggio,20 ritrovato grazie ai ricordi di Albino: qui si avuto il momento forse pi alto dellesperienza testimoniale del viaggio, documentato anche dal film di Michela Cane su Albino Moret.21 Nel Lager di Dora si svolta la cerimonia ufficiale, con gli interventi del Sindaco di Moncalieri Carlo Novarino, dellAssessore alla Cultura Mariagiuseppina Puglisi, del Vicesindaco di Nordhausen e di un funzionario del Consolato italiano di Lipsia; cerimonia che era stata anticipata il giorno prima da unanaloga commemorazione davanti al Monumento alle vittime di Buchenwald (una placca-ricordo conservata a 37, temperatura del corpo umano), a sottolineare limportanza del ruolo delle istituzioni per la conservazione della memoria. Il lavoro di riflessione sul viaggio nelle singole scuole si incentrato intorno a due metodi di ricostruzione: lesame della documentazione audiovisiva dellitinerario, a cura degli studenti del Laboratorio Multimediale Interscolastico dellITIS Pininfarina, raccolta nellArchivio Multimediale dellIstituto; la rielaborazione filmica della testimonianza di Albino Moret, nellopera gi citata di Michela Cane e nel video Ricordo di Albino Moret,22 realizzato dal Laboratorio Multimediale Interscolastico.
Verso Dora con Albino Moret (marzo 2002)
20 Per la ricostruzione di questo episodio si vedano la guida Il KZ di Mittelbau-Dora fra produzione missilistica e sterminio, al Capitolo II del presente volume, e il testo di R. Lazzero, Gli schiavi di Hitler cit., pp. 114-117. 21 Matricola 0155. Un deportato inesistente, SVHS, col., 14 56, regia M. Cane, gi inserito nel DVD Nellinferno di Dora. Il tunnel delle armi segrete di Hitler (realizzato dal Comune di San Germano Chisone nel 2004) e accluso al presente volume. 22 2002, VHS / DVD, col., 16 30, regia C. Piana, presentato il 27 gennaio 2003 alla Biblioteca Civica di Moncalieri, e accluso al presente volume.
I viaggi del Progetto
29
7. Memorie di pietra
25-29 marzo 2003: viaggio di studio a Mauthausen, Gusen, Ebensee
Marcella Pepe Il ritorno nellarea di Mauthausen, dopo i viaggi del 1998 e del 2000, era motivato dallo scopo di documentare lo stato delle numerose memorie di pietra erette in quel particolare luogo-museo che il campo principale: i Monumenti delle Nazioni e, soprattutto, il Monumento italiano. Di qui il tema di studio scelto. Al viaggio, preparato da un lavoro di approfondimento sulla memorialistica e sulla storiografia concernente la deportazione, hanno partecipato 54 studenti delle Scuole Superiori di Moncalieri, 6 docenti, 2 testimoni (Giorgio Ferrero, superstite di Ebensee, e Natale Pia, superstite di Gusen), Carla Piana (coordinatrice della troupe di studenti incaricati di filmare le fasi pi importanti del viaggio) e 2 Consiglieri comunali (Michele Morabito, Giuseppe Artuffo). La mattina del 26 marzo stata dedicata alla visita di Mauthausen e al suo Museo, mentre nel pomeriggio il gruppo si spostato nel campo satellite di Gusen, dove stato accolto da Martha Gammer, responsabile del KZ Gusen Memorial Committee, unassociazione che si adopera per la conservazione del sito della memoria dellarea di Gusen. Nel Memoriale di Gusen, ai piedi del forno crematorio, unico elemento conservato intatto in un sito quasi completamente snaturato, stata posata una corona. Le testimonianze di Giorgio Ferrero e di Natale Pia hanno arricchito la visita di Mauthausen e di Gusen con la forza e lautenticit della loro esperienza di deportazione. Il 27 marzo, davanti al Monumento italiano di Mauthausen, si svolta in mattinata la cerimonia ufficiale, cui hanno presenziato il Sindaco del Comune di Mauthausen, il Sindaco di Moncalieri Lorenzo Bonardi e lAssessore alla Cultura Mariagiuseppina Puglisi. Profonda commozione ha suscitato la commemorazione della ex deportata Natalia Tedeschi, accompagnatrice nei viaggi ad Auschwitz del 1999 e a Sachsenhausen e Ravensbrck del 2001, cittadina onoraria di Moncalieri, deceduta a Torino proprio nel giorno della nostra partenza. Nella giornata del 27 marzo, dopo la cerimonia, gli studenti, divisi in quattro gruppi di lavoro, si sono poi dedicati alla lettura di testimonianze su Mauthausen e a
Giorgio Ferrero e Natalino Pia al Memoriale di Gusen (marzo 2003)
30
Capitolo I
un lavoro di schedatura dei Monumenti prima fase di un percorso di studio proseguito nei mesi successivi seguendo queste direttive di ricerca: 1) rilievo e mappatura del Monumento italiano (15 studenti del L.S. Majorana, coordinati da Alessandra Matta, Lucio Monaco, Gabriella Pernechele); 2) schedatura dei Monumenti delle Nazioni (20 studenti delle tre scuole, coordinati da Dario Molino e Luigi Turco); 3) scelta e lettura di poesie e brani tratti da libri di memorie in alcuni luoghi-simbolo del campo, come il portone di ingresso, la cava di granito, il camino del forno crematorio (10 studenti delle tre scuole, coordinati da Marcella Pepe); 4) videoripresa dei lavori (9 studenti, quasi tutti dellITIS Pininfarina, coordinati da Carla Piana). La giornata si conclusa con una breve visita di Linz.
Testimonianza di Giorgio Ferrero a Mauthausen (marzo 2003)
Il 28 marzo stata toccata lultima meta del viaggio, il sottocampo di Ebensee: qui si svolta una cerimonia presso il Monumento eretto in memoria delle vittime dalla moglie dellindustriale Lepetit, deceduto a Ebensee, seguta dalla testimonianza di Giorgio Ferrero; poi il gruppo, guidato da Wolfgang Quatember, direttore del Widerstandsmuseum (Museo della Resistenza) di Ebensee, ha visitato le gallerie destinate da Hitler alla produzione di parti di carri armati, soffermandosi sulla mostra collocata al loro interno. Il 29 marzo, dopo una visita storico-artistica della citt di Salisburgo, iniziato il viaggio di ritorno. A fine anno scolastico gli studenti del Liceo Majorana hanno allestito per la Pinacoteca a Cielo aperto della Citt di Moncalieri (maggio 2003) la mostra Ombre del tempo, con i materiali raccolti a Mauthausen sul Monumento italiano, esposta poi nellistituto, mentre le schede dei Monumenti delle Nazioni sono state raccolte in un CD-Rom da Dario Molino. La rielaborazione filmica ha invece seguto due percorsi: la ricostruzione del viaggio e della testimonianza di Natale Pia nel video Memorie di pietra23 di Paolo Bommino, e lomaggio a Natalia Tedeschi attraverso lopera di Carla Piana, Con Anna e Natalia a Ravensbrck 2001,24 raccolta di immagini e testimonianze del viaggio del 2001 conservate nellArchivio Multimediale del Progetto Memoria.
23 2003, SVHS, col., 8, regia P. Bommino (I.I.S. Majorana Sezione Scientifica), proiettato al concorso Filmare la Storia del Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, dei Diritti e della Libert di Torino (22-30 giugno 2004). 24 2003, SVHS, col., 11 08, regia C. Piana, presentato il 27 gennaio 2004, in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria, al Teatro Matteotti di Moncalieri, proiettato al concorso Filmare la Storia (2004) e accluso al presente volume.
I viaggi del Progetto
31
8. Gli spazi della memoria
23-26 marzo 2004: viaggio di studio a Cracovia, Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz III-Monowitz, Gliwice
Marcella Pepe La memoria stimolata dai luoghi. Sono i luoghi dove si consumata la vicenda della deportazione, che parlano con il loro silenzio ai visitatori e fanno riaffiorare, nei testimoni di quegli eventi, ricordi rimossi. Nei campi vengono collocate lapidi, vengono eretti monumenti in ricordo delle vittime, vengono allestiti musei dotati di documentazione scritta, di fotografie, ora sempre pi spesso di film; talvolta i campi sono monumenti in se stessi, musei a cielo aperto (come Auschwitz II-Birkenau), oppure vengono trasformati in Memoriali che alludono simbolicamente alla storia attraverso larte. Il secondo viaggio (il primo fu nel 1999) ad Auschwitz rispondeva allintento di conoscere i luoghi dello sterminio sistematico, e comprendere il senso delle letture preparatorie.25 Vi ha partecipato Pio Bigo, che ha sostituito Natalia Tedeschi, la testimone del primo, ormai scomparsa, segnando cos una notevole differenza tra i due viaggi, poich la personalit del testimone, la sua biografia, il suo essere uomo o donna, deportato politico (come Pio) o razziale (come Natalia) danno unimpronta particolare alla visita degli spazi della memoria. Con Pio Bigo hanno visitato il comprensorio di Auschwitz 28 studenti, 6 docenti, Carla Piana (come di consueto, in veste di regista) e una folta rappresentanza istituzionale della Citt di Moncalieri: lAssessore alla Cultura Mariagiuseppina Puglisi, il Vicesindaco Modesto Pucci, il Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Quattrocchi, lAssessore allIstruzione e al Turismo Fulvio Musso e 2 Consiglieri comunali (Vincenzo Cherubino e Giuseppe Artuffo). I partecipanti, divisi in due gruppi, hanno compiuto in giorni diversi la visita di Cracovia e si sono ricongiunti il 24 e il 25 marzo per il percorso di studio di Auschwitz. La visita della citt era finalizzata non solo allaspetto storico-artistico, ma anche a quello pi inerente al Progetto, comprendendo lantico quartiere ebraico di Kazimierz, con le sue sinagoghe, e la farmacia del Dottor Pankiewitz, oggi museo, dove sono conservate documentazioni sulla storia del ghetto allestito dai nazisti nel 1941. Il 24 marzo stato interamente dedicato alla visita del Museo di Auschwitz I, sotto la guida del suo direttore, Henryk wiebocki, e delle strutture del campo S principale. Di fronte al Muro della morte si svolta la cerimonia ufficiale, con la commemorazione delle vittime e la deposizione della corona.
25 La bibliografia consigliata riguardava soprattutto la Shoah ed era incentrata intorno ai testi Se questo un uomo di Primo Levi, La notte di Elie Wiesel, C un punto della terradi Giuliana Tedeschi, Il silenzio dei vivi di Elisa Springer, La parola ebreo di Rosetta Loy, 16 ottobre 1943 di Giacomo Debenedetti, La banalit del bene di Enrico Deaglio e lautobiografia di Rudolf Hss, Comandante ad Auschwitz, anche se il libro pi importante stato ancora quello di Pio Bigo, Il triangolo di Gliwice cit.
wiebocki (marzo 2004) Pio Bigo ad Auschwitz con Henryk S
32
Capitolo I
Il giorno successivo la meta stata il campo della morte, cio Auschwitz IIBirkenau, con i resti dei forni crematori e i camini delle baracche distrutte, dove evidente la scelta di far parlare i luoghi nella loro desolazione. Nel pomeriggio del 25, nonostante linclemenza del tempo, un gruppo ha seguto Pio Bigo nel sito dove sorgeva Auschwitz III-Monowitz (a 7 km dal campo principale), di cui non restano che poche vestigia: qui Pio ha raccontato il suo arrivo, il 3 dicembre 1944, e linizio della marcia della morte che lo port a Buchenwald, passando per Gliwice (17 gennaio 1945). E proprio Gliwice, il luogo dove Pio sfugg a una selezione e che d il titolo al suo libro di memorie, stata lultima tappa del nostro itinerario. Era un obiettivo che si perseguiva fin dal 1999: lindividuazione della lapide, che oggi ricorda il sito dei quattro Lager di Gleiwitz (nome tedesco di Gliwice), ha rappresentato per Pio, e per tutti noi, un momento testimoniale molto elevato e intenso. Dopo il viaggio, nella parte conclusiva dellanno scolastico, gli studenti hanno allestito mostre fotografiche, esposte alla seconda edizione della Pinacoteca a Cielo aperto della Citt di Moncalieri e poi nei rispettivi istituti, mentre un gruppo del L.S. Majorana ha rielaborato lesperienza del viaggio in un video intitolato Tracce.26
Pio Bigo a Gliwice (marzo 2004)
9. Resistenza e deportazione: dai campi del duce ai Lager nazisti. Percorsi della deportazione italiana
22-26 aprile 2005: viaggio di studio a Nonantola, Carpi e Fossoli, Bolzano, Mauthausen, Gusen, Hartheim, Ebensee
Marcella Pepe Il tema che si scelto di approfondire nellanno scolastico 2004-2005 riguarda le responsabilit del regime fascista nella deportazione e nello sterminio, responsabilit a lungo minimizzate e solo recentemente messe in luce dalla ricerca storica italiana. Limmagine del buon italiano e del fascismo come di una dittatura benigna ha resistito fino a pochi anni fa, favorita dal confronto con lefferatezza dei crimini nazisti,
26 2004, SVHS, col., 3, regia L. Anania / M. Mancuso (I.I.S. Majorana Sezione Scientifica), presentato a Sottodiciotto Filmfestival.
I viaggi del Progetto
33
ma non in alcun modo giustificabile. Anche il fascismo, infatti, attu una spietata repressione politica ed elabor dal 1938 una sua legislazione razziale; anche il fascismo ebbe fin dagli esordi una sua rete di strutture di internamento di vario tipo, che si dilat con linizio della guerra raggiungendo la massima efficienza durante la Repubblica di Sal, quando il regime provvedeva con solerzia a radunare nei campi di transito e a consegnare alle SS oppositori politici ed ebrei. Grazie agli studi di storici quali Carlo Spartaco Capogreco, Costantino Di Sante, Fabio Galluccio, Michele Sarfatti,27 la tendenza autoassolutoria entrata in una crisi irreversibile. Il nostro viaggio mirava a ripercorrere idealmente quello di tanti deportati dai campi italiani ai Lager nazisti, ed ecco il motivo delle soste a Fossoli e a Bolzano prima di raggiungere Mauthausen e i suoi sottocampi. Il quarto viaggio nellarea di Mauthausen aveva per anche altri obiettivi: dare un seguito al lavoro del 2003 sulle memorie di pietra contribuendo ad accrescerle e ricordare le vittime moncalieresi, legando ancora pi strettamente il Progetto al territorio. anche questo il senso della struttura realizzata dagli studenti dellI.I.S. Majorana Sezione Scientifica e installata al Memoriale di Gusen. Al viaggio hanno partecipato 43 studenti delle Scuole Superiori di Moncalieri, accompagnati dal testimone Natale Pia, superstite di Gusen, 5 docenti e 2 Consiglieri comunali (Giuseppe Avignone e Giuseppe Artuffo). Si sono uniti al gruppo anche alcuni cittadini moncalieresi, perlopi parenti di Natale Pia e degli altri deportati moncalieresi (fra cui Adriano Sattanino, fratello di Rinaldo), a rappresentare quanto ormai sia importante e irrinunciabile per lo studio del fenomeno concentrazionario la testimonianza di secondo grado. A causa della mancanza di tempo, dovuta allintensit del programma di viaggio e al notevole interesse suscitato in tutte le sue tappe, sono state un po sacrificate le visite di Salisburgo e Innsbruck, previste rispettivamente per il 23 e il 26 aprile. Nel vero e proprio itinerario di studio si sono visitati: - nella mattinata del 22 aprile, Villa Emma, vicino a Nonantola, in provincia di Modena, dove numerosi ragazzi ebrei furono nascosti per oltre un anno e salvati cos dalla morte; poi, nel pomeriggio, il campo fascista di Fossoli, campo di transito (Durchgangslager), da cui partirono nel 1944 i trasporti di deportati italiani verso i Lager nazisti, e il Museo del Deportato a Carpi; - nella seconda giornata (23 aprile), il Durchgangslager di Bolzano-Gries, che fu campo di transito (in sostituzione di Fossoli, smantellato il 1 agosto 1944), ma anche campo di concentramento a tutti gli effetti, con propri sottocampi. Qui si svolto un incontro ufficiale con i rappresentanti delle istituzioni locali, il Senatore Lionello Bertoldi e lAssessore alla Cultura Carlo Repetto, ed stata deposta una corona ai piedi del Monumento italiano; - la mattina del terzo giorno (24 aprile), il Lager di Mauthausen, con il suo nuovo Museo e, nel pomeriggio, il principale dei suoi campi satellite, Gusen, dove il gruppo, come gi nel 2003, stato accolto dalla responsabile del KZ Gusen Memorial Committee, Martha Gammer; - nella mattinata del 25 aprile il Castello di Hartheim, sede dellOperazione
27 Si vedano nel Capitolo II le guide a I campi fascisti e Le leggi razziali con le relative bibliografie, su cui si fondata la preparazione degli studenti per il viaggio.
34
Capitolo I
T4 fino alla sua interruzione, nel 1941, e poi luogo di morte per i deportati provenienti dal complesso di Mauthausen; nel pomeriggio dello stesso giorno, Ebensee, dove il gruppo, guidato da un collaboratore di Wolfgang Quatember, direttore del KZ-Gedenksttte und Zeitgeschichte Museum Ebensee (Memoriale del campo di concentramento e Museo di Storia contemporanea Ebensee), ha visitato i resti del campo, il Museo e le gallerie. Una riflessione non secondaria indotta dal viaggio riguarda il mutamento dei luoghi di memoria nel corso del tempo, grazie alla crescente sensibilit delle istituzioni e dellopinione pubblica, sempre pi consapevoli della necessit di non dimenticare gli orrori del passato al fine di evitare il loro ripetersi. A Gusen, infatti, il Memoriale stato notevolmente ampliato rispetto al 2003, data della nostra ultima visita; quanto a Bolzano, sono stati eretti recentemente vari monumenti, non solo in Via Resia (sede del Durchgangslager), ma anche in luoghi periferici (per ricordare il lavoro forzato e le partenze dei prigionieri Adriano Sattanino e Natalino Pia al Monumento di Bolzano (aprile 2005) per la Germania), cui ci ha condotti Carla Giacomozzi, responsabile dellArchivio Storico della citt; nuovi musei sono stati allestiti a Mauthausen e a Ebensee; infine, il Castello di Hartheim, nel 2000 ancora in un totale abbandono, stato completamente ristrutturato e arricchito di dotazioni museali. La testimonianza di Natale Pia nei Lager e durante le numerose ore trascorse in pullman stata preziosa, sommessa, com nella natura della persona, ma forse anche per questo totalmente priva di retorica Museo del Memoriale di Gusen: Natalino Pia indica la sua baracca (aprile 2005) e coinvolgente nella sua autenticit. Il libro che, spinto dalla figlia Primarosa, si da poco deciso a scrivere e ha appena pubblicato,28 stato per tutti i partecipanti quasi uneco della sua voce.
28 N. Pia, La storia di Natale. Da soldato in Russia a prigioniero nel Lager, a cura di Primarosa Pia, con Prefazione e Schede sui Lager di Lucio Monaco, Novi Ligure, Joker, 2003, 20063.
I viaggi del Progetto
35
Questanno la cerimonia ufficiale si svolta nel Monumentale di Gusen, il 24 aprile, alla presenza del Sindaco di Moncalieri Lorenzo Bonardi e dellAssessore alla Cultura Mariagiuseppina Puglisi. Lucio Monaco ha ricordato i quattro cittadini moncalieresi che, oltre al testimone e cittadino onorario Natale Pia, hanno sofferto o sono morti a Gusen: Michele Sandrone, morto a Gusen il 30 marzo 1945; Pietro Paolo Bertoglio, deportato a Ebensee il 25 marzo 1944 e morto a Gusen il 12 marzo 1945; Rinaldo Sattanino (Nando), deportato prima a Bolzano, poi a Mauthausen, morto a Gusen il 19 aprile 1945; Orfeo Mazzoni, deportato a Bolzano, a Mauthausen e poi trasferito il 20 febbraio 1945 a Gusen, dove rimase fino alla Liberazione (deceduto nel 1998). In onore dei martiri commemorati alcuni studenti del Liceo Majorana hanno deposto una installazione in terracotta realizzata da loro, che reca incisi i numeri di matricola dei caduti.29 Oltre allinstallazione appena ricordata, frutto dei due viaggi a Mauthausen (2003 e 2005) stato il DVD Parole e Segni oltre il Tempo. Mauthausen e Gusen,30 realizzato da Carla Piana con i materiali dellArchivio Multimediale del Progetto Memoria.
10. Immagini e memoria*
28 marzo - 1 aprile 2006: viaggio di studio a Buchenwald e Dora
Pier Luigi Cavanna Il viaggio di questanno ha riproposto il cammino di quello effettuato nel 2002, ma ha visto la partecipazione di un solo testimone, Pio Bigo, deportato a Buchenwald, mentre era assente Albino Moret, sopravvissuto a Dora e recentemente scomparso. Sulle tracce di Albino Moret diventato pertanto il tema del percorso di studio. La riflessione si incentrata sulle difficolt di avere ancora per un lungo periodo come compagni di viaggio testimoni di primo grado che guidino e accompagnino gli studenti durante le visite ai Lager. Questi uomini preziosi e indispensabili per consentire agli allievi di cogliere le emozioni e gli stenti che hanno vissuto i deportati, e ricevere una testimonianza storica diretta sul fenomeno concentrazionario, stanno facendo fatica a concedere la loro disponibilit. Lo stesso Pio Bigo, nellintervista video rilasciata durante il viaggio,31 ha insistito sul peso che oggi i testimoni sentono nellaccettare di partecipare ai viaggi della memoria, sottolineando, oltre allet avanzata, la crescente problematicit di raccontare e spiegare le loro tristi esperienze. Il viaggio, soprattutto la visita a Dora, ha prefigurato quale potr essere in futuro lapporto e il ruolo dei testimoni-assenti: la loro presenza si concretizzer con la testimonianza ottenuta grazie ai nuovi strumenti multimediali, accanto alla lettura dei libri che hanno scritto o delle interviste che hanno rilasciato. E non casuale che questanno, per
Viaggio preceduto da una visita di un ristretto gruppo di studenti (28 novembre 2005) al Campo di Fossoli e al Museo Monumento al Deportato di Carpi, insieme al testimone Marcello Martini (analoga al percorso del 1999, qui sopra al n. 3). Cfr. le testimonianze alle pp. 184-194. 29 Si rimanda, per un approfondimento del senso dellinstallazione e per lanalisi delle sue caratteristiche, al saggio Memoria ufficiale, memorie vive. Usi della monumentalit, pp. 128-130 del presente volume. 30 2005, SVHS, col., 26 40, regia C. Piana, presentato il 27 gennaio 2006 durante le celebrazioni per il Giorno della Memoria al Teatro Matteotti di Moncalieri, e accluso al presente volume. 31 E ora fruibile nel DVD-Video Leco della memoria. Un testimone fra i giovani, 2006, col., 40, regia e montaggio di C. Piana e F. Martino, accluso al presente volume.
*
36
testimoniare le tracce del ricordo di Albino, sia stato proiettato un video, quello realizzato da Michela Cane dopo il viaggio del 2002.32 Non solo: dal viaggio emersa anche unaltra possibilit di attingere alla storia vissuta della deportazione, e cio luso dei testimoni di secondo grado, grazie alla presenza di Adriano Sattanino, fratello del deportato moncalierese morto a Gusen nel 45.33 Al viaggio hanno partecipato, accanto a Pio Bigo, 52 studenti delle Scuole Superiori di Moncalieri, 5 docenti, lAssessore alla Cultura della Citt di Moncalieri Mariagiuseppina Puglisi, 2 Consiglieri comunali (Giuseppe Artuffo e Giancarlo Chiapello), i parenti di Rinaldo Sattanino (il fratello Adriano, la nuora Nadia e la nipote Francesca), e una cittadina di Moncalieri. Mercoled 29 marzo stato visitato il KL Buchenwald. Allarrivo al campo, intorno al Monumento ai Deportati di Buchenwald (la lapide gi ricordata, con la temperatura costante di 37), si svolta la cerimonia ufficiale, momento ormai tradizionale dei viaggi ed evento sempre carico di significato, cui ha partecipato il Sindaco di Weimar, Volkhardt Germer. Dopo cominciata la visita, seguendo il percorso proposto da Pio Bigo. stato toccante osservare il disorientamento iniziale di Pio nel non ritrovare i luoghi vivi nella sua memoria e ora parzialmente trasformati dai lavori di conservazione e restauro del Lager. La visita proseguita nel primo pomeriggio, sempre percorrendo il cammino suggerito da Pio. Poi il gruppo si diviso per una esplorazione personale del campo e del Museo, ed ripartito alla volta di Weimar per visitare la citt con lapporto di due guide locali. Gioved 30 marzo si svolta la visita al KZ Mittelbau-Dora. Durante lo spostamento stato proiettato il video di Michela Cane su Albino Moret, come abbiamo gi detto, e qui iniziato il cammino sulle tracce di Albino, concretizzatosi nella visita al campo e alle gallerie grazie alle guide Florian Schaefer e Angela Fiedermann. Momenti particolarmente significativi sono stati la scoperta delle gallerie, la sosta alla lapide che ricorda la fucilazione dei sette alpini,34 la breve cerimonia ufficiale davanti al forno crematorio presso il Monumento ai Deportati russi e la visita al Museo. La mattinata di venerd 31 marzo stata dedicata alla citt di Erfurt, e nel pomeriggio si intrapreso il viaggio di ritorno con tappa serale a Ulm. La riflessione successiva al viaggio confluita nella rielaborazione dellintervista ad Adriano Sattanino che gi stata ricordata e nello studio del materiale video, girato dagli allievi del Pininfarina, presso il Laboratorio Multimediale, in vista di un film su Pio Bigo. 35
32 33
Dora: Monumento ai Deportati russi
Cfr. supra, nota 21. Elisa Armentaro e Alessandra Gardino, della Sezione Scientifica dellI.I.S. Majorana, hanno intervistato durante il viaggio Adriano Sattanino, alla luce della nuova funzione dei testimoni di secondo grado, e hanno riportato i colloqui nellintervista di pp. 221-224, Capitolo IV del presente volume. 34 Cfr. supra, nota 20. 35 Cfr. supra, nota 31.
37
Capitolo II - Le guide della memoria
Riproduciamo qui parte delle schede elaborate in previsione dei singoli viaggi per accompagnare, composte in fascicoli secondo lordine richiesto dallitinerario e dotate di piantine, la visita ai luoghi di memoria. In alcuni casi, per i Lager visitati in pi occasioni, si riproduce soltanto la scheda pi recente. Le guide seguono due percorsi tematici: il contesto storico e le guide ai luoghi della deportazione, disposte queste ultime secondo un ordine rigorosamente alfabetico.
1. Il contesto storico
Il sistema concentrazionario nazista
Marcella Pepe Il Lager un simbolo centrale della storia del Novecento ed figlio della modernit, nel senso che la mostruosit dello sterminio avvenuta allinterno di una societ tecnologicamente avanzata, non in una societ arretrata. Non dobbiamo pensare ai campi di concentramento come al frutto di una degenerazione del regime nazista, ma come a un suo elemento caratterizzante: in essi si realizz pienamente la societ auspicata da Hitler. Il nuovo ordine nazionalsocialista, che si sarebbe imposto sullintera Europa in caso di vittoria della Germania nella seconda guerra mondiale, fu sperimentato su vasta scala nei campi di concentramento, dove vigeva la gerarchia delle razze e si prefigurava unumanit ridotta in condizione di schiavit. Il primo KL (Konzentrationslager)1 della Germania nazista fu Dachau, nei pressi di Monaco di Baviera, inaugurato il 22 marzo 1933, meno di due mesi dopo la nomina di Hitler a Cancelliere del Terzo Reich. Nel corso del 1933 ne nacquero circa altri 50 e vi furono imprigionati oppositori politici, asociali, criminali. Dal 1934 i KL passarono sotto il controllo della SS (Schutzstaffel, guardia del corpo di Hitler) e di Heinrich Himmler, capo della polizia del Reich. Tra il 1936 e il 1939 furono aperti nuovi campi: a Sachsenhausen, vicino a Berlino (1936); a Buchenwald, nei pressi di Weimar (1937); a Mauthausen, in territorio austriaco (1938); a Flossenbrg, presso il confine cecoslovacco (oggi Repubblica Ceca) (1938); a Ravensbrck, a Nord di Berlino, riservato alle donne (1939). In essi fu concentrata la popolazione dei KL, che allinizio della guerra era di circa 25.000 detenuti, mentre venivano chiusi quasi tutti i campi sorti disordinatamente nei primi mesi di potere dei nazisti. Con linizio della guerra (1 settembre 1939, invasione della Polonia), fu edificato in Germania un vero e proprio Stato delle SS. Il 27 ottobre 1939 fu creato il RSHA (Ufficio centrale per la sicurezza del Reich), che unificava sotto Reinhard Heydrich tutti i servizi di polizia, compresa la Gestapo, e sorsero altri campi: a Neuengamme, nei pressi di Amburgo, dove furono deportati soprattutto scandinavi (1940); a Gross-Rosen, nella Slesia inferiore (1941);
Le sigle KL e KZ (Konzentrationszentrum) sono sostanzialmente equivalenti e nel volume le adoperiamo indifferentemente. La prima era impiegata a livello ufficiale, la seconda era pi diffusa nellambito del parlato (anche Kazett, Katzettbar).
38
Capitolo II
ad Auschwitz, nei pressi di Cracovia, in Polonia (1940), campo principale e cuore di un triplice complesso, che comprende Auschwitz II-Birkenau (1941) e Auschwitz IIIMonowitz (1942); a Majdanek (1941), a Chel /mno (1941), a Bel /z ec (1942), a Sobibr (1942), a Treblinka (1942), tutti in Polonia e tutti, insieme con quello di Auschwitz II-Birkenau, campi di sterminio immediato, smantellati dai tedeschi prima della fine del 1944; a Bergen Belsen, nei pressi di Amburgo (1943); a Mittelbau-Dora nel centro della Germania, sede di fabbriche sotterranee per le armi V2 (1943), come Ebensee e Gusen (sottocampi di Mauthausen). Dallestate del 1944, lavanzata delle truppe sovietiche da Est e di quelle angloamericane da Ovest costrinse le SS a evacuare i KL a un ritmo che si fece sempre pi incalzante con il passare dei mesi. Lobiettivo era impedire che i deportati, testimoni di tanti crimini e atrocit, finissero nelle mani dei nemici del Reich. I prigionieri, gi ridotti a larve umane, furono allora trasportati verso i Lager che si trovavano nel cuore della Germania e costretti a vere e proprie marce della morte. Molti caddero sulle strade, uccisi dagli stenti, dal freddo, o dai fucili delle SS; molti altri furono lasciati morire di fame chiusi in vagoni ferroviari, o morirono una volta arrivati nei nuovi campi sovraffollati; altri ancora vennero eliminati perch non trasportabili.
Lo sfruttamento economico dei prigionieri
Marcella Pepe
ARBEIT MACHT FREI (Il lavoro rende liberi) era scritto allingresso di numerosi Lager nazisti. Questa scritta cinica, che promette la libert attraverso il lavoro, mentre nei Lager si attuava lo sterminio attraverso il lavoro, identifica una delle funzioni principali dei campi di concentramento: infatti, i detenuti furono unimmensa risorsa di manodopera per il regime nazista e per lindustria tedesca. Fino al 1937 le attivit svolte dai detenuti erano tutte connesse alla vita interna dei KL (manutenzione dei campi, produzione di beni e servizi destinati al consumo interno, come vestiario per i prigionieri e per le SS, coltivazione di prodotti agricoli). Dalla costruzione di Buchenwald (1937) in poi, i detenuti erano stati utilizzati anche per la realizzazione di nuovi campi e delle strade che conducevano a essi: il loro lavoro si era quindi esteso al sistema delle costruzioni e si svolgeva in cave e fornaci per la produzione di laterizi, rimanendo comunque nellambito dellapparato concentrazionario. Nel 1938 si verific un salto di qualit a livello organizzativo: la manodopera dei Lager venne inserita in vere e proprie imprese commerciali e produttive create dalla SS (la DEST e la DAW),1 gestite da un Ufficio economico e amministrativo (WVHA) diretto da Oswald Pohl, anche se, fino a tutto il 1941, le loro risorse continuarono a essere destinate a un programma edilizio esclusivamente civile. Fin dal 1940, inoltre, leconomia tedesca fece ricorso a manodopera straniera, costituita da lavoratori civili reclutati nei Paesi soggetti al Reich attraverso lOrganizzazione Todt (cos chiamata dal nome del ministro tedesco degli armamenti) e da prigionieri di guerra (da non confondere con i deportati rinchiusi nei
Deutsche Erd- und Steinwerke e Deutsche Ausrstungswerke: fornivano materiali edilizi per il rinnovamento architettonico progettato da Albert Speer nelle grandi citt tedesche, Berlino e Norimberga.
Le guide della memoria
39
Lager). Dallottobre del 1941 questi lavoratori furono impiegati anche nei settori delleconomia bellica, in aperta violazione delle convenzioni internazionali. Tra il 1940 e il 1941 i KL diventarono sempre pi dipendenti dal WVHA, ma cominciava anche a esserci un parziale impiego dei detenuti nellindustria bellica non dipendente dalla SS. Ad esempio, la scelta del sito di Auschwitz da parte della IG-Farben per la costruzione della fabbrica Buna (febbraio 1941) fu certamente determinata dalla possibilit di utilizzare come manodopera i prigionieri di quel Lager. Nel 1942 il dominio nazista raggiunse la sua massima espansione, ma lentrata in guerra degli Stati Uniti (dicembre 1941) e lestensione dei fronti richiedevano alleconomia bellica tedesca uno sforzo intenso. Era infatti fallita lipotesi strategica della guerra lampo (Blitzkrieg) e la Germania, quando ancora dominava gran parte dellEuropa, era gi allaffannosa ricerca di risorse materiali e umane per sostenere una guerra che si prolungava. Le sconfitte militari che si susseguirono a partire dalla fine del 1942 e lavvicinamento dei fronti di guerra ai confini del Reich, oltre agli attacchi aerei inglesi e americani che distrussero le citt industriali tedesche, acuirono le difficolt delleconomia nazista. Aumentava il numero dei Paesi mobilitati contro la Germania (dallautunno del 1943 ci sar anche lItalia del Regno del Sud): lesercito andava dunque potenziato, ma si dovevano anche ricostruire le fabbriche bombardate (si pens di farlo in gallerie sotterranee, puntando sul progetto della creazione di armi micidiali come i missili V1 e V2). La necessit di uomini che sostituissero gli operai tedeschi incorporati nellesercito spinse i gerarchi nazisti a rafforzare lo sfruttamento della manodopera straniera: furono cos trascinati in Germania, entro la fine del 1944, circa 7 milioni di schiavi per leconomia tedesca, cui si devono aggiungere 2 milioni di prigionieri di guerra costretti al lavoro. Le fughe e gli atti di sabotaggio di questi la-
voratori coatti erano puniti con limprigionamento nei KL. Parallelamente, a partire dallautunno del 1942, Heinrich Himmler e il WVHA di Oswald Pohl cercarono con ogni mezzo di incrementare il numero dei deportati da adibire al lavoro e di intensificarne lo sfruttamento. Tale sforzo era per in buona parte vanificato dal tasso di mortalit spaventosamente elevato allinterno dei Lager, dovuto alle condizioni di vita (freddo, sottoalimentazione) e di lavoro (turni che arrivavano a dodici ore), oltrech alle atrocit di ogni genere (dagli atti di sadismo agli esperimenti pseudoscientifici condotti su cavie umane). Si pu quindi parlare a pieno titolo di sterminio attraverso il lavoro. Le contraddizioni Nello sfruttamento dei deportati, i vantaggi degli imprenditori erano notevoli perch la tariffa che dovevano pagare ai comandanti dei campi come compenso per il lavoro di un detenuto rappresentava appena un terzo del salario di un lavoratore tedesco di qualifica equivalente. I guadagni maggiori andavano per allUfficio economico e amministrativo della SS (WVHA), che era al tempo stesso fornitore di manodopera alle industrie private (da cui riceveva un compenso) e datore di lavoro tramite le societ SS. Vi furono forti contrasti fra il WVHA e il RSHA (Ufficio centrale per la sicurezza del Reich) che perseguivano obiettivi diversi, soprattutto rispetto ai deportati razziali: lo sfruttamento produttivo (il WVHA) e lo sterminio (il RSHA). Un caso in cui la contraddizione fra lavoro schiavile e sterminio risulta evidente quello della deportazione, nellaprile del 1944, di oltre 100.000 ebrei ungheresi che avrebbero dovuto, secondo gli ordini di Hitler, essere impiegati nella costruzione di fabbriche sotterranee di aeroplani, proprio nel momento in cui pi feroce e sistematica era lattuazione della soluzione finale. Forse il fatto che i deportati razziali in gra-
40
Capitolo II
do di svolgere un lavoro produttivo siano stati almeno temporaneamente risparmiati per essere prima sfruttati fino allultima risorsa fu dovuto in parte al prevalere dellipotesi del WVHA, in una situazione che per la Germania si faceva sempre pi disperata. Le responsabilit Le responsabilit dello sfruttamento economico dei deportati, come di quello dei lavoratori stranieri e dei prigionieri di guerra uno sfruttamento tremendo che fin per coincidere con lo sterminio ricadono certamente sui gerarchi del regime hitleriano e sulla SS, ma anche in buona misura su tanti imprenditori privati tedeschi, grandi e piccoli. IG-Farben, Krupp, Siemens, BMW, Steyr, Messerschmitt, Heinkel, Volkswagen: sono soltanto alcuni fra i nomi pi noti di una lista di imprese che costruirono le loro fortune approfittando spregiudicatamente della massa di schiavi che il potere nazista metteva a loro disposizione. Nei numerosi processi del dopoguerra, infatti, saliranno sul banco degli imputati industriali e dirigenti di aziende accanto ai gerarchi nazisti.
simultanea di elementi mai prima di allora presentati congiuntamente:
uno Stato che agisce in prima persona e lo
dichiara;
uno sterminio per ragioni di biologia razziale che avviene nel cuore dellEuropa;
unopera di sterminio pianificata, condotta
con una logica e un metodo di tipo industriale; la distruzione dellebraismo dellEuropa orientale; le camere a gas e i crematori; le sedicenti sperimentazioni medico-scientifiche; il lavoro coatto sia punitivo sia produttivo; la morte in serie, organizzata secondo una logica tayloristica; la burocrazia, quel governo di nessuno che trasforma gli uomini in semplici funzionari.
Cronologia della Shoah
Adriana Mogna Shoah in ebraico significa distruzione, catastrofe, ed usato dagli storici per indicare il genocidio degli ebrei dEuropa perpetrato dal regime nazionalsocialista tedesco, e dai governi collaborazionisti durante il secondo conflitto mondiale, come parte integrante del piano per linstaurazione di un nuovo ordine europeo, che prevedeva anche leliminazione degli oppositori politici e di coloro che erano considerati sottouomini (omosessuali, zingari, slavi, neri, asociali disoccupati, lavoratori irregolari, individui affetti da malattie invalidanti ed ereditarie, prostitute, ribelli). Un evento inscritto nella modernit In quanto caratterizzato dalla presenza
Premesse ideologiche e organizzative (1933-1939) Sono da ricercarsi nellideologia nazista e in particolare in quella di Hitler, che raccoglie alcuni aspetti della cultura nazionalista, razzista e antisemita tedesca del primo dopoguerra. Nel Mein Kampf si sostiene che la Storia sia caratterizzata da una lotta fra razze superiori destinate a vincere e razze inferiori destinate a essere sottomesse. Il futuro della Germania deve dunque essere legato alla ricerca di un Lebensraum (spazio vitale) da conquistarsi a Oriente a danno dei popoli slavi, e alla lotta radicale per estirpare il marxismo bollato come bolscevismo giudaico: mistura di antisemitismo radicale e acceso antibolscevismo mutuata da Alfred Rosenberg, teorico razzista del Terzo Reich. Il sistema ideologico-organizzativo nazista poggia inoltre su due parole dordine: il Fhrerprinzip (principio del capo) e la Volksgemeinschaft (comunit di popolo). In base al primo, un movimento politico e una nazione devono essere organizzati secondo un
Le guide della memoria
41
rapporto gerarchico di subordinazione a un capo, dotato di un potere carismatico indiscusso. La comunit popolare, invece, propone lunione di tutti gli appartenenti alla razza germanica. Giunto al potere nel 1933, il nazismo prepara le misure legislative e organizzative destinate al raggiungimento di questi obiettivi. Tra il 1933 e il 1939 si preoccupa di cancellare dalla vita politica tedesca e di escludere da ogni diritto di cittadinanza gli ebrei, gli oppositori politici, gli asociali e le altre categorie di sottouomini prima menzionate: Dachau, 1933: primo campo di concentramento, allestito contro i nemici della sicurezza del Reich; eugenetica, 1933: prima legge demografica che introduce la sterilizzazione forzata e che coinvolger circa 400.000 persone; leggi di Norimberga, 1935: gli ebrei perdono la nazionalit tedesca, i diritti politici; vietati i matrimoni misti, perseguiti i contatti sessuali; arianizzazione delleconomia, 1937: gli ebrei sono costretti a rinunciare alle loro attivit industriali e commerciali; espropriazione dei loro patrimoni mediante autodenuncia; divieto di esercitare alcune professioni, medicina, avvocatura, attivit alberghiera, ogni tipo di incarico statale e direttivo; notte dei cristalli, 1938: passaggio dalla discriminazione legislativa alla violenza di massa (pogrom); incendi di sinagoghe, saccheggi, aggressioni, distruzione di negozi e case di ebrei, di cui pi di 30.000 vengono rinchiusi nei Lager, altri spinti allemigrazione; Operazione T4, 1939-1941: programma di eliminazione di malati mentali, anziani infermi, portatori di handicap fisici e mentali, neonati con malformazioni, internati in manicomi criminali. La sigla T4 deriva dallindirizzo della sede per lorganizzazione del Programma di Eutanasia, a Berlino, in Tiergartenstrasse n. 4. Il Programma provocher luccisione di circa 80.000 tedeschi per soffocamento da monossido di carbonio e rientra nel progetto nazista di miglioramento della
razza. LOperazione sar interrotta ufficialmente nel 1941 per la protesta dei famigliari delle vittime e degli esponenti delle Chiese protestante e cattolica. Ghetti / massacri allEst / campi della morte (1939-1941) Con lo scoppio della guerra il sistema concentrazionario si dilata enormemente e diventa, oltrech un ingranaggio cruciale delleconomia tedesca, lo strumento principale per il genocidio di ebrei e zingari, per lannientamento della classe dirigente polacca e dei resistenti dei Paesi occupati. 1939. Dopo loccupazione della Polonia e la sua spartizione con lURSS, il territorio viene diviso in due grandi zone: il Warthegau, annesso direttamente al Reich, e il Governatorato generale. Sono imposte subito misure per impedire agli ebrei di spostarsi, obbligandoli a portare una stella identificativa e a farsi rappresentare presso le autorit naziste dagli Judenrte (Consigli ebraici) in modo che gli ordini delle autorit tedesche siano resi operativi dagli stessi ebrei. 1940. La popolazione ebraica viene rinchiusa in ghetti circondati dal filo spinato o cintati da mura (in Polonia e in alcune citt sovietiche occupate), dov imposto il lavoro coatto senza adeguati rifornimenti alimentari e senza assistenza medica. Iperaffollate e misere anticamere della deportazione, vedranno nascere al loro interno alcune forme di resistenza (rivolta del Ghetto di Varsavia, terminata con un vero e proprio massacro nel 1943). 1941. Quando le truppe naziste invadono lURSS, viene immediatamente avviato lo sterminio degli ebrei e dei comunisti. Le Einsatzgruppen, reparti speciali al seguito della Wehrmacht, operano il massacro di pi di un milione di persone, mediante fucilazione ed eccidi di massa, e non prima di aver fatto scavare alle vittime le fosse comuni. Le operazioni sono cos efferate e sanguinose che persino i carnefici soffrono di turbe psichiche e fisiologiche; diventa inoltre sempre pi difficile, anche nei grandi spazi dellEst, occultare i
42
Capitolo II
cadaveri, mentre si delinea che tale pratica non pu essere estesa ai Paesi occidentali, fitti di citt, industrie e reti di comunicazioni. Vengono cos istituti i campi di sterminio, la cui funzione quella di uccidere in modo pulito, cio attraverso uno sterminio immediato con la gassazione. Nello stesso periodo gi in atto nei Lager lo sfruttamento economico dei deportati. La soluzione finale (1942-1945) 1942 (gennaio). Conferenza di Wannsee: si decide che lEuropa deve diventare Judenfrei (libera dagli ebrei). Ogni Paese alleato od occupato deve essere rastrellato e gli ebrei devono essere trasferiti a Est per il trattamento finale. Per gli ebrei dei ghetti si ufficializza leliminazione gi in corso, per quelli dei Paesi occidentali si decide lannientamento premeditato. 1942 (aprile). Circolare Pohl: annientamento attraverso il lavoro. Di fronte alle avvisaglie di uninversione di tendenza sul piano militare, si decide di concentrare ogni sforzo nella produzione bellica, destinando al lavoro tutti i prigionieri. I Lager si trasformano in enormi agglomerati di forza lavoro e inizia in tutta Europa la caccia agli schiavi per la guerra di Hitler. Lo sfruttamento economico: i prigionieri vengono impiegati nella costruzione di Lager, strade, in progetti di ristrutturazione edilizia, nelle industrie belliche tedesche. A prosperare sul lavoro dei deportati sono le principali industrie tedesche (Siemens, Volkswagen, Krupp, AEG, IG-Farben) che a prezzo quasi nullo comprano non lavoratori, ma Stcke (pezzi) ad altissimo ricambio. A lucrare su tale vendita la SS nella sua veste di centro di potere economico e fulcro del vastissimo circuito di corruzione che attraversa il sistema concentrazionario. Fanno parte della SS anche i medici che usano i prigionieri come cavie per i loro esperimenti scientifici.
Un sistema intricato: fino al 1945 il sistema dei campi funziona a pieno regime ed smantellato quando giungono gli Alleati, anche se cura dei nazisti in fuga distruggere quante pi prove possibili. La classificazione dei Lager (rieducazione, lavoro, sterminio), e le fasi e le finalit della deportazione (terrore interno, sterminio e sfruttamento, annientamento attraverso il lavoro), non hanno implicato uno sviluppo omogeneo e lineare: le diverse funzioni si sono intersecate, il prevalere delluna o dellaltra dipeso dallandamento della guerra, dalla lotta fra le componenti del Partito e dello Stato, o sono coesistite nella stessa struttura concentrazionaria, come ad Auschwitz, centro di sterminio e luogo di sfruttamento schiavile, esempio pi compiuto dellintreccio fra ideologia razzista e calcolo economico, assurto nel secondo Novecento a simbolo della Shoah.
Fonte bibliografica. Lo schema cronologico il frutto di una rielaborazione condotta a partire dalle pagine di A. Bravo / A. Foa / L. Scaraffia, I fili della memoria. Uomini e donne nella storia dal 1900 a oggi, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 269-276, 323-341.
La Conferenza di Wannsee
Marcella Pepe La Conferenza di Wannsee fu convocata da Reinhard Heydrich, il capo del RSHA (Ufficio centrale per la Sicurezza del Reich), e si svolse il 20 gennaio 1942 in una villa situata in un quartiere residenziale signorile del sobborgo berlinese di Zehlendorf, allindirizzo di Am Grossen Wannsee nn. 56-58.1 La scelta del luogo fu probabilmente motivata da esigenze di massima segretezza: la tenuta di Wannsee apparteneva a una fondazione creata da Heydrich stesso (la Fondazione Nordhav, che si occupava di acquistare e gestire case di riposo per i membri del Servizio di sicurezza della SS
Dal 1992 la villa diventata luogo di memoria (Gedenksttte) e sede di una mostra permanente sulla Shoah.
Le guide della memoria
43
e le loro famiglie), e il personale della villa offriva quindi garanzie di affidabilit. La Conferenza di Wannsee nota negli ambienti estranei alla ricerca storica come il momento in cui fu decisa la soluzione finale della questione ebraica. Tale convinzione, per, risulta ormai sbagliata: infatti, noto che al momento dello svolgimento della riunione parecchie centinaia di migliaia di ebrei erano gi stati uccisi in eccidi di massa. La Conferenza ebbe certamente un ruolo rilevante nellufficializzare e generalizzare la decisione e i metodi della soluzione finale, ma questa era gi in atto da molti mesi. Secondo Kurt Ptzold ed Erika Schwarz, autori del saggio fondamentale Ordine del giorno: sterminio degli ebrei,2 linizio dello sterminio degli ebrei va retrodatato al 22 giugno 1941, allindomani dellinvasione tedesca dellUnione Sovietica. Fino ad allora, la persecuzione nei confronti degli ebrei era stata attuata in vari modi e forme: con la definizione a mezzo decreto (leggi di Norimberga del 1935); con lesclusione dalla funzione pubblica, dalle professioni, dalle scuole; con le imposte sui patrimoni e la confisca dei beni; con larianizzazione delle imprese ebraiche; con la segregazione dal resto della popolazione in palazzi abitati solo da ebrei (soluzione adottata in Germania prima della guerra) o in appositi quartieri (i ghetti creati in Polonia dopo lo scoppio della guerra). Durante questa persecuzione decine di migliaia di ebrei avevano perso, oltre ai beni e al lavoro, anche la vita. Tuttavia il vero e proprio genocidio cominci soltanto dopo il 22 giugno 1941, a opera delle Einsatzgruppen, unit mobili di massacro che operavano nelle retrovie del fronte russo. La procedura dei massacri era standardizzata, con poche varianti. I tedeschi sceglievano un luogo per lesecuzione e preparavano una fossa comune. Prima della fucilazione, che avveniva talvolta sparando alla nuca, ma pi spesso con il tiro di squadra a distanza e
2
con le mitragliatrici, gli ebrei consegnavano gli oggetti di valore e gli indumenti. Poi cadevano nella fossa con infornate successive, secondo il sistema delle sardine: una prima infornata si faceva stendere sul fondo della fossa e veniva fucilata; la seconda si distendeva con la testa dalla parte dei piedi dei morti; alla quinta o sesta si chiudeva la fossa. Tale metodo, per, presentava alcuni inconvenienti: da un lato, numerosi soldati assistevano alle fucilazioni come a uno spettacolo, traendo godimento dalla morte (e questo era considerato un eccesso, non conforme alla disciplina e al prestigio dellesercito tedesco); dallaltro lato, gli esecutori materiali e gli stessi comandanti delle Einsatzgruppen accusavano difficolt psicologiche, avevano incubi notturni e disturbi somatici. Si cercarono allora altri metodi, meno traumatici delle armi da fuoco: prima la dinamite e poi camion speciali, vere e proprie camere a gas viaggianti (Gaswagen), in cui venivano eliminate fino a 60-70 vittime per trasporto. Ebrei uccisi dalle Einsatzgruppen entro la fine del 1941: 125.000 (Einsatzgruppe A, regione baltica) 45.000 (Einsatzgruppe B, Bielorussia) 59.000 (Einsatzgruppe C, Galizia e Ucraina) 76.000 (Einsatzgruppe D, Bessarabia)
Fonte: R. Hilberg, La distruzione degli Ebrei dEuropa, trad. it. 2 di F. Sessi / G. Guastalla, Torino, Einaudi, 1995, 1999 , p. 316.
Alle Einsatzgruppen fu anche affidato il compito di giustiziare i prigionieri di guerra sovietici, ebrei e non ebrei. Le ragioni di questo particolare trattamento erano ideologiche, oltrech razziali: lannientamento della subumanit bolscevica era considerato per il Reich un diritto naturale di difesa. Se agli ebrei si aggiungono dunque i prigionieri di guerra sovietici, le vittime della prima ondata di massacri salgono a 500.000.
K. Ptzold / E. Schwarz, Ordine del giorno: sterminio degli ebrei. La conferenza del Wannsee del 20 gennaio 1942 e altri documenti sulla soluzione finale, trad. it. di A. Michler, Torino, Bollati Boringhieri, 2000.
44
Capitolo II
Alla fine del 1941, inoltre, era gi in funzione il primo dei campi adibiti esclusivamente allo sterminio, nella localit polacca di Chel /mno, ribattezzata dai tedeschi Kulmhof, dove gli ebrei erano stipati in camion al cui interno venivano convogliati i gas di combustione del motore, ed era gi stata avviata la cosiddetta Operazione Reinhard,3 che prevedeva la costruzione dei campi di sterminio di Bel /z ec, Sobibr e Treblinka. Del resto, Hitler aveva gi in mente da tempo la possibilit di sfruttare loccasione della guerra per arrivare allo sterminio totale della razza ebraica: lo prova il profetico discorso che pronunci il 30 gennaio 1939, sette mesi prima dellinvasione della Polonia: In questo giorno, che forse non sar memorabile solo per i Tedeschi, vorrei aggiungere questo: nella mia vita, nel corso della mia lotta per il potere, spesso sono stato profeta, e spesso sono stato sbeffeggiato, in primo luogo dal popolo ebreo che ha accolto con risa le mie profezie, vale a dire che un giorno avrei assunto il comando dello Stato e, facendo ci, del popolo intero, e che fra le altre questioni avrei risolto il problema ebraico. Credo che nel frattempo la risata della iena giudea della Germania le si sia spenta in gola. Oggi sar di nuovo profeta: se la finanza ebraica internazionale dEuropa e fuori dEuropa dovesse arrivare, ancora una volta, a far precipitare i popoli in una guerra mondiale, allora il risultato non sar la bolscevizzazione del mondo, e dunque la vittoria del giudaismo, ma al contrario, la distruzione della razza giudea in Europa.4 Gli storici sono concordi nellaffermare che lo sterminio iniziato in seguito a disposi-
zioni date verbalmente da Hitler ai suoi pi diretti collaboratori, Hermann Gring e Heinrich Himmler. Entrambi istruirono Reinhard Heydrich, il capo del RSHA, lUfficio che aveva coordinato la persecuzione degli ebrei. Ma Heydrich volle unautorizzazione formale e, subito dopo linvasione dellUnione Sovietica, incaric Adolf Eichmann di redigere un testo di autorizzazione alla soluzione finale della questione ebraica da sottoporre alla firma di Gring: Autorizzazione del 31 luglio 1941 di Hermann Gring per il capo della Polizia di sicurezza e del SD, Gruppenfhrer della SS Reinhard Heydrich, a preparare una soluzione globale della questione ebraica A integrazione delle disposizioni dellordinanza del 24 gennaio 1939, nella quale La si incaricava di avviare la questione ebraica, mediante emigrazione o evacuazione, alla soluzione pi favorevole in relazione alle circostanze, con la presente Le assegno lincarico di predisporre tutte le necessarie misure per preparare dal punto di vista organizzativo, pratico e materiale una soluzione globale della questione ebraica nellarea dellEuropa sotto influenza tedesca. Tutte le altre istanze centrali devono cooperare allo scopo. Inoltre, La incarico di rimettermi al pi presto un piano complessivo dei provvedimenti da adottare riguardo allorganizzazione, lattuazione e i mezzi materiali necessari per realizzare la desiderata soluzione finale della questione ebraica.5 Quindi, il 29 novembre 1941, quando Heydrich convoc la Conferenza di Wannsee, la soluzione finale era gi in atto. La riunione, prevista per il 9 dicembre 1941, fu poi spostata al 20 gennaio 1942. Con
3 4 5
Azione o Operazione Reinhard (Aktion o Einsatz Reinhard), cos denominata in omaggio al suo ispiratore, Reinhard Heydrich. Tratto da R. Hilberg, op. cit., p. 431. K. Ptzold / E. Schwarz, op. cit., p. 79.
Le guide della memoria
45
lespressione eventi improvvisi, che richiedono la presenza di una parte dei signori invitati, addotta a giustificazione dello slittamento nella seconda lettera di invito ai 14 partecipanti, Heydrich intendeva probabilmente alludere
alle prime controffensive sovietiche e alla decisione di Hitler di schierarsi a fianco del Giappone, dopo lattacco giapponese alla flotta USA (7 dicembre 1941).
I partecipanti La Conferenza di Wannsee fu detta dei Segretari di Stato in quanto vi parteciparono 9 Segretari o Sottosegretari di Stato, che rappresentavano tutti i ministeri, salvo quelli delle Finanze e dei Trasporti (non perch questi ministeri non fossero importanti nellorganizzazione della soluzione finale, ma perch Heydrich voleva discutere questioni di principio e non aspetti di ordine pratico): Wilhelm Stuckart Segretario di Stato al Ministero degli Interni Roland Freisler Segretario di Stato al Ministero della Giustizia Alfred Meyer Segretario di Stato al Ministero dei Territori orientali occupati Erich Neumann Segretario di Stato presso lUfficio del Piano quadriennale Josef Bhler Segretario di Stato del Governatorato generale Martin Luther Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari esteri Gerhard Klopfer Membro della Cancelleria del partito nazista e anche Oberfhrer della SS Friedrich W. Kritzinger Rappresentante della Cancelleria del Reich (in seguito Segretario di Stato) Georg Leibbrandt Accompagnatore del Segretario di Stato Meyer Cerano poi rappresentanti della SS: Heinrich Mller Adolf Eichmann Otto Hofmann Eberhard Schngarth Rudolf Lange Capo della Gestapo (Polizia segreta di Stato, Sezione IV del RSHA) Responsabile della Sezione IV B 4 Responsabile dellUfficio centrale per la razza e la colonizzazione Comandante della Polizia di Sicurezza e del SD per il Governatorato generale Comandante della Polizia di Sicurezza e del SD per la Lettonia bunale distrettuale di Gerusalemme, Adolf Eichmann volle dipingersi come un personaggio insignificante, non seduto allo stesso tavolo dei partecipanti ma in disparte insieme a una anonima segretaria; tuttavia questa autodifesa contraddetta dal passo del verbale in cui Heydrich dichiara che proprio a Eichmann sarebbero stati affidati i compiti di organizzazione e coordinamento, e che i vari addetti allo sterminio dovevano tenersi in contatto con lui. Tutti i funzionari partecipanti alla Conferenza del 20 gennaio 1942 erano al corrente dellinizio dello sterminio, essendovi gi attivamente coinvolti in quanto esperti di questioni ebraiche. Perch dunque Heydrich aveva indetto la Conferenza e li aveva convocati?
Il verbale Il piano complessivo dei provvedimenti da adottare riguardo allorganizzazione, lattuazione e i mezzi materiali necessari per realizzare la desiderata soluzione finale della questione ebraica, di cui si parla nellautorizzazione di Gring del 31 luglio 1941, rappresentato dal verbale della Conferenza di Wannsee; non esistono altri progetti pi ampi e articolati. Il documento, redatto da Eichmann seguendo le istruzioni di Heydrich, fu ritrovato nel 1947 dagli organi investigativi americani fra gli atti confiscati al Ministero degli Affari esteri del Reich. Nel processo del 1960-61, dinanzi al Tri-
46
Capitolo II
Dalla lettura del verbale emergono quattro obiettivi principali perseguiti da Heydrich, fra loro collegati: 1. chiarire che il trattamento degli ebrei era di sua esclusiva competenza amministrativa, come dimostra il fatto che avesse allegato agli inviti lautorizzazione firmata da Gring. Il verbale riporta la sua dichiarazione introduttiva: La responsabilit della soluzione finale della questione ebraica spetta, senza riguardo a questioni di confini geografici, al Reichsfhrer della SS e capo della Polizia tedesca; 2. informare i presenti della decisione di sterminare gli ebrei integralmente. Nessuno poteva pi pensare che gli ebrei sarebbero stati uccisi in gran numero: la soluzione finale riguardava tutti gli ebrei presenti sul territorio del Reich; 3. garantire un coordinamento ottimale fra le istanze centrali del Reich. A questo proposito il verbale parla di sincronizzazione delle linee di condotta; 4. risolvere il controverso problema dei Mischlinge e degli ebrei che avevano contratto matrimonio misto, per tracciare un confine netto fra deportazione e sopravvivenza e farlo rispettare dappertutto. Era importante, infatti, determinare con esattezza le persone oggetto del provvedimento. Era questo lunico punto che i partecipanti alla Conferenza dovevano affrontare, in assenza di precise direttive da parte di Hitler, che non aveva ancora deciso come comportarsi con i Mischlinge e con coloro che avevano contratto matrimonio misto, ed era pertanto disponibile a prendere in esame contributi di idee sul problema. Le proposte su questo punto occupano una parte ampia del verbale. Nel verbale, il progetto viene presentato con un linguaggio eufemistico e con parole velate: - respingimento, emigrazione, al posto di espulsione; - evacuazione, invece che deportazione; - soluzione finale, invece che sterminio;
- riduzione naturale, invece che annientamento attraverso il lavoro; - trattare (gli ebrei) in maniera adeguata per dire che dovevano essere fucilati o eliminati nelle camere a gas; - ebrei interessati al provvedimento, ovvero condannati a morte; - ripulire, setacciare, per dare lidea che si stava risanando lEuropa da parassiti; - trasportare (gli ebrei) a Est, ovvero deportarli nei campi di sterminio; - possibilit di soluzione, invece che modi di uccidere. La verit a Wannsee fu dunque pronunciata con reticenza: non si parl di campi di sterminio n di progetti di una loro costruzione; non si parl dei massacri delle Einsatzgruppen, n delle fucilazioni n dei Gaswagen; non si fece cenno agli ebrei che erano gi stati uccisi. Tuttavia, c un punto in cui il verbale non lascia adito a dubbi: quando riferisce la dichiarazione di Heydrich secondo cui neppure una cellula germinale di una nuova rinascita ebraica sarebbe sopravvissuta. E impressiona, nella sezione III del verbale, lelenco degli 11 milioni di ebrei interessati al provvedimento, divisi in base al Paese di provenienza: risulta evidente lintenzione, poi realizzata solo a met, di eliminare sistematicamente tutti gli ebrei viventi sul continente europeo. Heydrich scelse di presentare la nuova politica antiebraica della evacuazione verso lEst come la naturale continuazione della precedente politica, che tendeva a favorire lemigrazione degli ebrei, solo adeguata alle mutate circostanze; scelse quindi di non enfatizzare la rottura. Ma significativo il fatto che nessuno dei partecipanti alla riunione abbia chiesto se fosse possibile continuare a incoraggiare lemigrazione, segno che erano tutti daccordo con lidea di distruggere anche le cellule germinali di una futura generazione ebraica, e quindi con lidea del genocidio del popolo ebraico. Sulla durata della riunione il verbale non dice nulla. A Gerusalemme, durante il processo in cui comparve in veste di imputato,
Le guide della memoria
47
Eichmann afferm che era durata circa unora e mezzo: quindi largomento fu trattato in modo estremamente conciso e senza difficolt, e del resto anche il verbale breve (15 pagine). Alla fine della riunione rifer Eichmann al processo Heydrich era di ottimo umore e si trattenne a bere del cognac insieme a Mller e allo stesso Eichmann. Conseguenze della Conferenza Subito dopo la Conferenza, lUfficio IV B4 del RSHA, diretto da Adolf Eichmann, eman direttive dettagliate in merito alle operazioni preparatorie per la soluzione finale perch non sfuggisse nemmeno uno degli ebrei residenti nei territori sottoposti al dominio del Reich: censimento delle vittime, confisca dei loro beni, restrizioni alla loro libert di movimento. Poi si pass allazione: dopo Chel /mno (Kulmhof), dove gi nel dicembre 1941 gli ebrei venivano uccisi nei camion a gas, sorsero i campi di sterminio di Bel /z ec (aperto nel marzo 1942), Sobibr (maggio 1942), Treblinka (luglio 1942), attrezzati con camere a gas che utilizzavano il monossido di carbonio, gi sperimentato nellambito del Programma di Eutanasia, ma non dotati di forni crematori; intanto procedevano, sotto la direzione di Rudolf Hss, i lavori per dotare di camere a gas il grande campo di sterminio di Auschwitz II-Birkenau; qui vennero eretti quattro massicci fabbricati, che contenevano camere a gas e forni crematori, e fu usato lacido cianidrico (lo Zyklon-B, un prodotto fino ad allora impiegato contro insetti e roditori); dal febbraio 1942 una raffica di provvedimenti colp gli ebrei tedeschi, i cui beni furono confiscati prima del loro trasferimento nei ghetti polacchi; fin il privilegio degli ebrei del Ghetto di Theresienstadt (Terezn), in Boemia, un ghetto speciale per anziani, invalidi di guerra o decorati e per ebrei importanti (si temevano interventi in loro favore da parte dellesercito), che fu lultima creazione di Heydrich prima della sua morte, avvenuta il 4 giugno 1942 in
seguito alle ferite riportate in un attentato: nellottobre 1942 partirono da Theresienstadt i primi convogli diretti ad Auschwitz e gi prima di quella data, a luglio, erano partiti diciotto convogli diretti a Treblinka; nellautunno del 1944 Himmler ne ordin la quasi totale evacuazione. Unaltra istituzione centrale, insieme al RSHA, fu essenziale nellattuazione della soluzione finale: il Ministero dei Trasporti, in particolare le ferrovie del Reich (Reichsbahn). Il RSHA requisiva i convogli ferroviari e pagava alla Reichsbahn una tariffa di gruppo, pari alla met del costo del biglietto di III classe (biglietto di sola andata), perch i deportati erano caricati su vagoni merci. La soluzione finale, messa dunque in atto a partire dal 22 giugno 1941 e perfezionata dopo la Conferenza di Wannsee, fu portata avanti sino alla fine della guerra. E, se vero che il 26 novembre 1944, di fronte allincalzare degli alleati a Occidente e dellArmata rossa a Oriente, il Reichsfhrer della SS Himmler ordin lo smantellamento delle installazioni di sterminio di Auschwitz, anche vero che gli ebrei continuarono a morire, dopo quella data, nelle marce di evacuazione e nei campi sovraffollati dove venivano trasportati, o fucilati o falcidiati dalla fame, dagli stenti e dalle malattie. Gli storici concordano nel calcolare in circa 6 milioni gli ebrei vittime del nazionalsocialismo.
Bibliografia. Kurt Ptzold / Erika Schwarz, Ordine del giorno: sterminio degli ebrei cit., raccoglie i documenti sulla Conferenza di Wannsee, fra cui il verbale redatto da Eichmann. Raul Hilberg, La distruzione degli Ebrei dEuropa cit., rappresenta uno dei pi completi contributi alla comprensione del meccanismo burocratico-amministrativo che ha consentito lo sterminio di sei milioni di ebrei. Sul processo ad Adolf Eichmann: Hannah Arendt, La banalit del male. Eichmann a Gerusalemme, trad. it. di P. Bernardini, Milano, Feltrinelli, 1964, e il film di Eyal Sivan, Uno specialista. Ritratto di un criminale moderno, FR./GERM./BELG./AUSTR./ISR.,1999.
48
Capitolo II
I campi fascisti
Marcella Pepe La ricerca storica contemporanea si sta orientando a contrastare lopinione, molto diffusa nel senso comune, degli italiani brava gente, umani verso le popolazioni dei Paesi invasi e vittime anchessi della dittatura di Mussolini, costretti a subire un regime vessatorio, mandati a combattere una guerra non sentita. Questa immagine buonista degli italiani, che affonda le sue radici nel Ventennio, ma perdura ed stata riproposta anche recentemente, ad esempio dal film Mediterraneo di Gabriele Salvatores (1991), fu rafforzata nellimmediato dopoguerra da una serie di fattori politici e psicologici: a) il paragone con la ferocia dei crimini nazisti, che non fu oggetto di una seria comparazione storica ma un comodo alibi, in quanto non si pu tacere che nei Paesi occupati lesercito italiano abbia attuato una politica repressiva nei confronti dei civili (devastazioni, intimidazioni, internamenti, fucilazioni di ostaggi) oltrech contro le forze della Resistenza partigiana; b) linsabbiamento dei processi contro i criminali di guerra italiani1 e dunque la mancanza di una Norimberga italiana che accertasse i misfatti delloccupazione fascista in Africa e nei Balcani; c) il fallimento dellepurazione inizialmente progettata dal governo di unit nazionale presieduto da Bonomi (luglio 1944), quindi il mancato ricambio degli apparati statali e il colpo di spugna sulle responsabilit fasciste anche ad alti livelli, in seguito allapplicazione estensiva dellamnistia concessa dal Ministro
1
della Giustizia Togliatti il 22 giugno 1946; d) le scelte dei partiti della sinistra e degli antifascisti, che preferirono sottolineare i meriti della Resistenza piuttosto che insistere sulle colpe del fascismo, e considerare il fascismo stesso come una parentesi ormai chiusa della storia italiana, in unottica di riconciliazione nazionale e di normalizzazione; e) gli oggettivi interessi degli angloamericani, in sintonia con la classe dirigente moderata italiana (dal maggio 1947 entr definitivamente in crisi lunit antifascista e De Gasperi form un governo monocolore democristiano), a ristabilire la continuit dello Stato e il ritorno allordine in una nazione di confine tra i due blocchi come lItalia, quando cominciava a profilarsi la guerra fredda; f) latteggiamento degli stessi ebrei italiani, che, pur essendo stati fra le vittime principali della dittatura, sdrammatizzarono lorigine della persecuzione, oscurata in un certo senso dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti dopo l8 settembre 1943, e si rifugiarono in una memoria di carattere riconciliatorio.2 A questa autorappresentazione assolutoria del comportamento degli italiani corrisponde una tendenza a minimizzare le colpe del regime, visto come un totalitarismo dal volto umano, non paragonabile al nazismo o allo stalinismo. Eppure, anche il fascismo si serv sistematicamente fin dai suoi esordi della repressione politica e razziale; anche il fascismo ebbe numerose strutture di vario tipo (campi ed edifici come ex monasteri, caserme, ville) destinate allinternamento degli oppositori politici, degli stranieri, delle minoranze etniche. Oggi per i campi fascisti non sono sentiti come luoghi di memoria, e di conseguenza si trovano in uno
Fin dai mesi successivi all8 settembre, i Ministeri della Guerra e degli Affari Esteri svilupparono unazione mirata a eludere larticolo 29 dellarmistizio, che conteneva la clausola della consegna agli Alleati dei criminali di guerra. Lo fecero percorrendo contemporaneamente due strade: la presentazione di una documentazione difensiva, che ammetteva le violenze ma le giustificava come risposte alla barbarie dei ribelli, e la rivendicazione del diritto dellItalia a processare in proprio i presunti colpevoli. La strategia italiana volta a impedire lestradizione dei criminali e a rassicurare gli Alleati continu nel dopoguerra con listituzione di una Commissione dinchiesta nellaprile del 1946, ma il mutamento delle condizioni geopolitiche fece passare in secondordine la questione e, nel 1951, tutti i procedimenti aperti furono archiviati. Per un approfondimento si leggano C. Di Sante, Crimini senza giustizia n memoria in Idem (cur.), Italiani senza onore. I crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941-1951), Verona, ombre corte/documenta, 2005, e G. Oliva, Si ammazza troppo poco. I crimini di guerra italiani. 1940-1943, Milano, Mondadori, 2006. 2 C. S. Capogreco, I campi del duce. Linternamento civile nellItalia fascista (1940-1943), Torino, Einaudi, 2004, p. 5.
Le guide della memoria
49
stato di abbandono: edifici e baracche sono stati distrutti o riconvertiti ad altri usi, e soltanto qualche testimone diretto dei fatti ricorda la vicenda dellinternamento. I campi italiani ridati alla storia e alla riflessione sono, guarda caso, quelli considerati in qualche modo anche patrimonio nazista, come Fossoli di Carpi, presso Modena (primo campo di transito verso la Germania, diviso dal marzo 1944 in due settori gestiti rispettivamente dalle autorit italiane della RSI e dalla SS), dove c una baracca ricostruita e vengono effettuate visite guidate; o come la Risiera di San Sabba a Trieste (campo di detenzione di polizia, allestito dai tedeschi fra lottobre-novembre 1943 nella Zona del Litorale Adriatico), che stata dichiarata monumento nazionale nel 1965. Cerchiamo ora di ricostruire la storia dellinternamento fascista nelle sue varie fasi e tipologie. Il confino di polizia (1926-1943) Se Hitler, appena nominato Cancelliere, nel 1933, rinnov tutta la legislazione precedente, Mussolini scelse invece la via della continuit con il passato, apparentemente senza brusche rotture, utilizzando spesso le leggi vigenti in epoca liberale, ma ovviamente forzandole e snaturandole. Un esempio il confino di polizia, che derivava dal domicilio coatto di epoca liberale e, analogamente a questultimo, si fondava su misure di prevenzione decise dalla polizia, sottraendo individuazione e definizione dei comportamenti pericolosi alla legislazione e alla magistratura. Diversamente dal domicilio coatto, che era comminato prevalentemente ai delinquenti comuni con saltuarie eccezioni,3 il confino nel fascismo si applicava anche e soprattutto agli oppositori politici. La semplicit della procedura ne fece lo strumento pi adottato dal regime fascista: infatti, a differenza del Tribunale speciale, che doveva basarsi su una prova anche minima per emet3
tere una condanna, il confino prevedeva la deportazione per via amministrativa (apposite commissioni presiedute dal Prefetto decidevano le assegnazioni al confino, anzi ratificavano decisioni gi prese dal dittatore) e fu utilizzato, oltrech per gli antifascisti attivi, anche per quegli oppositori potenziali su cui non cerano prove, ma solo dicerie, come gli scontenti, i fannulloni, gli operai che si lamentavano del salario ribassato, gli scrittori, gli stessi fascisti dissidenti. Le localit scelte per il confino furono di due tipi: 1) piccole isole; 2) piccoli agglomerati dellItalia centromeridionale. Isole. Il confino nelle isole, che diventarono una sorta di carceri allaperto, riguard in particolare gli oppositori politici ritenuti pi pericolosi, cio gli attivisti di partito, e mirava a spegnere la loro capacit di resistenza e il loro ribellismo attraverso lozio forzato, le vessazioni dei carcerieri, la vita in ambienti promiscui e deprimenti. I primi confinati vennero mandati in isole gi sedi di domicilio coatto: Favignana, Lampedusa, Pantelleria, Ustica (dove fu confinato Antonio Gramsci nel 1926). A esse si aggiunsero Lipari (soppressa nel 1933 e teatro della celebre evasione di Carlo Rosselli, Emilio Lussu e Francesco Fausto Nitti, che riuscirono a raggiungere la Francia), Ponza (aperta nel 1928 e chiusa nel luglio 1939, dove fu internato nel 1935 Sandro Pertini), Ventotene (popolata dal 1939, dopo la chiusura di Ponza, da 800 confinati, fra cui Altiero Spinelli, Eugenio Colorni ed Ernesto Rossi, antesignani del federalismo europeo, che qui scrissero il Manifesto di Ventotene), lArcipelago delle Tremiti (adibito a partire dal 1937-38 a luogo di detenzione punitiva per confinati indisciplinati o incorreggibili e teatro di clamorose proteste, come quella contro limposizione del saluto romano). Agglomerati dellItalia centromeridionale. In un primo tempo erano confinati nelle localit della terraferma gli oppositori
Il domicilio coatto fu usato a fini di repressione politica nel 1894, da Francesco Crispi, e dopo i tumulti del 1898.
50
Capitolo II
considerati meno temibili, sorvegliati da podest e carabinieri, ma lincremento del numero dei confinati negli anni Trenta e il timore che le isole di deportazione non fossero sufficienti a contenerli spinsero il Ministero dellInterno a creare colonie di confino sulla terraferma anche per gli oppositori pi pericolosi. Nel 1939 a Pisticci, in provincia di Matera, fu allestita una colonia confinaria che potrebbe essere definita il primo campo di concentramento italiano, recintata, non subito ma in un secondo tempo, da filo spinato. Diretta dallimpresario Eugenio Parrini (personaggio in stretto rapporto con il Ministero dellInterno), la colonia di Pisticci fu, nelle intenzioni del regime, un esperimento a sfondo sociale per togliere i confinati dallozio e per unire alla bonifica agraria la bonifica umana:4 i confinati vennero utilizzati in lavori artigianali, agricoli (dissodarono e coltivarono terreni), edili (costruirono le infrastrutture della colonia, le casette previste dal piano di riassetto fondiario, oltre a un intero villaggio in stile fascista denominato Marconia in onore dello scienziato appena scomparso), in cambio di una paga giornaliera di 5 lire, in aggiunta alla normale mazzetta di 6 lire. La rieducazione non ebbe in ogni caso lesito sperato e nei confinati costretti a lavorare si rafforz la determinazione di opporsi al regime, come risulta dalle loro testimonianze.5 Nel 1926 i dissidenti politici confinati erano 900; nel 1943 raggiunsero quota 12.330 (su un totale di 16.876 confinati).6 Cifre sicuramente ben lontane da quelle della deportazione politica interna del nazismo. I motivi di tale differenza, lungi dal configurare una supposta dittatura benigna, sono da ricercarsi nella volont del duce di presentare agli occhi dellopinione pubblica mondiale limmagine di un antifascismo debole e di un governo che godeva di largo consenso sociale. Daltronde, gi nella
4 5 6
prima met degli anni Venti lo squadrismo fascista aveva inferto un colpo mortale al dissenso politico e numerosi antifascisti militanti erano ormai allestero. Inoltre, sui giornali di regime, la vita nelle colonie di confino era presentata in modo tranquillizzante, come una specie di villeggiatura volta soltanto a eliminare dalla circolazione chi avrebbe intralciato il cammino dellItalia verso un futuro radioso, offrendogli al contempo la possibilit di redimersi. I campi coloniali Nel 1930 lItalia realizz 15 campi di concentramento nella Libia orientale (Cirenaica), organizzati in tendopoli recintate da filo spinato (il pi duro fu quello di el-Agheila, destinato ai famigliari dei guerriglieri, dove persero la vita migliaia di libici). Alla loro chiusura, nel 1933, dei 100.000 deportati reclusi nelle tendopoli insieme con duecentomila capi di bestiame erano rimasti in vita meno di 60.000.7 Fortemente voluti da Mussolini, ordinati dal governatore Badoglio, materialmente organizzati dal generale Graziani e creati, seppur in tempi e con modalit differenti, in tutti i territori doltremare (anzitutto in Cirenaica, ma poi anche in Somalia e in Etiopia), i campi coloniali del regime fascista rappresentarono un salto di qualit rispetto alla prassi di internamento vigente in epoca liberale e furono il terreno di sperimentazione di metodi che potevano poi essere applicati nella penisola (e furono in effetti applicati soprattutto nei campi per slavi), come la legislazione razziale o il lavoro forzato o la stessa struttura in tendopoli. I campi del fascismo monarchico (1940-1943) Con linizio della guerra, nel 1940, il regime fascista cre dei veri e propri campi di internamento che si possono suddividere sostanzialmente in due tipologie:
Cos si esprime il Capo della polizia Arturo Bocchini in una relazione a Mussolini del 6 agosto 1938. Cfr. C. S. Capogreco, op. cit., p. 30. C. Ghini / A. Dal Pont, Gli antifascisti al confino (1926-1943), Roma, Editori Riuniti, 1971, p. 289. C. S. Capogreco, op. cit., p. 30. 7 Ibidem, pp. 54-55. Per unanalisi pi ampia si legga il contributo di Nicola Labanca, Linternamento coloniale italiano, nel libro a cura di C. Di Sante, I campi di concentramento in Italia. Dallinternamento alla deportazione (1940-1945), Milano, FrancoAngeli, 2001, pp. 40-67.
Le guide della memoria
51
1. campi dellinternamento civile regolamentare, dipendenti dal Ministero dellInterno; 2. campi dellinternamento civile parallelo, dipendenti dal Ministero della Guerra e dal Regio Esercito. La definizione di campi di internamento si adatta ai primi, mentre per la seconda tipologia sarebbe pi appropriata la definizione di campi di concentramento. 1. I campi dellinternamento civile regolamentare. I civili internati dal Ministero dellInterno sono ulteriormente classificabili in due categorie: internati stranieri, la cui pericolosit consisteva nellessere sudditi di nazioni nemiche; internati italiani, la cui detenzione era motivata da esigenze di pubblica sicurezza. Gli ebrei si trovarono, dopo le leggi del 1938, in una condizione a met strada fra le due categorie. Le leggi razziali stabilirono che gli ebrei stranieri (tali erano considerati quelli entrati nel Regno dopo il 1919, tra cui moltissimi affluiti dalla Germania e dai Paesi sottomessi al Terzo Reich per sfuggire alle persecuzioni naziste) dovessero allontanarsi dallItalia entro il 12 marzo 1939, pena lespulsione. Sebbene per non tutti gli ebrei stranieri fossero riusciti a emigrare, la minacciata espulsione di massa non avvenne, e una circolare emanata il 20 maggio 1940 dal Ministero dellInterno li includeva fra i civili da internare. Gli ebrei stranieri furono concentrati prevalentemente nel campo di Ferramonti di Tarsia, oltrech in altri campi e in centinaia di localit destinate allinternamento libero. Anche gli ebrei italiani, una volta esclusa perch tecnicamente irrealizzabile a guerra iniziata la possibilit di una loro espulsione, vennero concentrati nei campi di Urbisaglia, Campagna e Gioia del Colle a partire dal 1941. Furono circa 400 gli ebrei italiani inter8
nati dallentrata in guerra fino al 25 luglio 1943: il numero potrebbe apparire esiguo, ma in percentuale alto, poich in Italia gli ebrei erano soltanto 46.656;8 inoltre, la motivazione principale del loro internamento era quella dellappartenenza razziale, pur non essendo chiaro se lintenzione di Mussolini fosse quella di internare tutti gli ebrei o solo quelli di reale pericolosit. La persecuzione degli ebrei in Italia tra il 1938 e il 1943 fu poco considerata dagli storici nel dopoguerra, a fronte di una forte sottolineatura della deportazione nazista nel periodo 1943-45, e anche nella memorialistica non le stato dato lo stesso rilievo. Analogamente agli ebrei, gli zingari si trovarono inclusi in entrambe le categorie. Gli zingari stranieri, che in Italia erano 25.000, tra i primi a essere sorvegliati dalla polizia fascista (fin dal 1926) per motivi di igiene pubblica e prevenzione della criminalit, furono arrestati numerosi a partire dal 1938 e respinti oltre frontiera o deportati in campi nomadi allestiti da loro stessi. Dal 1941 le carovane di zingari che affluivano in Italia dalla Croazia e dalla Bosnia-Erzegovina furono dirottate nei campi gestiti dal Ministero dellInterno a Baiano, Agnone, Tossicia, Ferramonti, Tremiti, Vinchiaturo e in diverse localit di internamento libero. Per gli zingari italiani (vittime anchessi del clima creato dalle leggi razziali bench non fossero esplicitamente menzionati in esse), i primi ordini di internamento giunsero con la circolare inviata dal Capo della polizia Bocchini ai prefetti l11 settembre 1940. Presso il Ministero dellInterno furono attivati un Ufficio internati stranieri e un Ufficio internati italiani, che ricevevano le segnalazioni dalle prefetture, dai ministeri, dalle ambasciate e dai consolati italiani, dallOvra, dalla Demorazza (Direzione generale demografia e razza). Gli arresti iniziarono nel giugno 1940, subito dopo lentrata in guerra del-
M. Sarfatti, Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi, Torino, Einaudi, 2002, p. 10.
52
Capitolo II
lItalia, e i fermati potevano essere destinati a un campo, se ritenuti molto pericolosi, o a una localit di internamento dove vivevano non fisicamente separati dagli abitanti del posto ed erano definiti internati liberi. Come appare evidente nella tabella che segue,9 nel corso degli anni la persecuzione del internati stranieri ottobre 1940 novembre 1942 aprile 1943 4.251 (2.412 ebrei) 7.369 6.832
regime ebbe sempre pi di mira la categoria dei nemici interni, cio gli oppositori in genere, oltrech gli ebrei e gli allogeni (slavi della Venezia Giulia e tedeschi del Sud Tirolo), e numerosi internati liberi furono trasferiti nei campi.
internati italiani 1.373 (331 ebrei) 4.366 12.285
totale 5.624 11.735 19.117
I campi dellinternamento civile regolamentare furono ubicati nellItalia centrale e meridionale ed erano pi di 40. Oltre a quelli riportati in tabella,10 svolsero funzione di campi di internamento anche il Emilia-Romagna Toscana Marche Umbria Lazio Abruzzo-Molise 2 3 6 1 3 19
centro di lavoro di Castel di Guido (Roma) e quattro colonie di confino funzionanti: Ventotene (Lazio), Tremiti (Puglia), Pisticci (Lucania), Ustica (Sicilia).
Montechiarugolo; Scipione di Salsomaggiore Bagno a Ripoli; SantAndrea a Rovezzano; Oliveto Fabriano; Sassoferrato; Urbisaglia; Pollenza; Treia; Petriolo Colfiorito (Foligno) Fraschette (Alatri); Badia di Farfa; ex colonia confinaria di Ponza Civitella del Tronto; Corropoli; Isola del Gran Sasso; Nereto; Tortoreto; Tossicia; Notaresco; Citt SantAngelo; Casoli; Istonio; Lama dei Peligni; Lanciano; Tollo; Chieti; Agnone; Boiano; Casacalenda; Isernia; Vinchiaturo Campagna; Ariano Irpino; Monteforte Irpino; Solofra Manfredonia; Alberobello; Gioia del Colle Ferramonti di Tarsia ex colonia confinaria di Lipari
Campania Puglia Calabria Sicilia
4 3 1 1
10
Rielaborazione dei dati riassunti da C. S. Capogreco, op. cit., pp. 65-66. Anche questa tabella una ricostruzione a partire dalla mappatura dei campi in calce a C. S. Capogreco, op .cit., pp. 179-247.
Le guide della memoria
53
2. I campi dellinternamento civile parallelo. Teoricamente soltanto il Ministero dellInterno aveva titolarit riguardo allinternamento dei civili, ma di fatto fu il Regio Esercito a gestirlo nelle zone della ex Jugoslavia occupate o annesse nel 1941, nel contesto di unoccupazione contraddistinta da particolare violenza verso le popolazioni inermi e da intenti esplicitamente razzisti, in quanto volta oltrech contro il movimento partigiano a realizzare una sorta di pulizia etnica, in continuit con la ventennale politica del fascismo di frontiera contro le minoranze slave in Italia. Accanto a quello regolare, ci fu dunque un internamento civile parallelo. Un documento davvero impressionante la Circolare 3C-L, emanata il 1 marzo 1942 dal generale Mario Roatta, comandante della II Armata stanziata in Slovenia, che prevedeva lincendio e la distruzione di case e villaggi, nonch linternamento massiccio della popolazione maschile dai 16 ai 60 anni e, in una correzione successiva alla prima stesura, anche di donne e bambini. In base alle direttive della Circolare, che divent un riferimento per le disposizioni antiguerriglia emanate da altri generali nelle zone occupate, avrebbero dovuto essere internati operai, disoccupati, profughi, senzatetto, ex militari, frequentatori di dormitori pubblici, persone trasferitesi in Jugoslavia dalla Venezia Giulia dopo lavvento del fascismo, simpatizzanti del movimento partigiano, abitanti delle case prossime ai luoghi dove fossero stati compiuti sabotaggi, famiglie in cui risultassero assenti componenti di sesso maschile, studenti e intellettuali a prescindere dalleventuale militanza politica. Roatta prescrive la massima durezza nella repressione, raccomanda il ripudio delle qualit negative compendiate nella frase bono italiano e sintetizza lo spirito della Circolare
3C-L nel motto: non dente per dente, ma testa per dente.11 I campi previsti dalla Circolare 3C-L erano distinti in repressivi e protettivi: questi ultimi erano destinati a coloro che si presentavano spontaneamente per essere protetti dalle azioni del movimento partigiano, ma servirono in realt a tutelare spie e collaborazionisti. Tre furono le strutture principali dellinternamento parallelo situate in territorio occupato: Arbe (Rab) per il settore dellAdriatico settentrionale, cio larea di Fiume e la Slovenia, il campo pi grande e tristemente famoso, definito da molti autori jugoslavi un campo di sterminio a causa dellalta mortalit (lo storico sloveno Tone Ferenc ha documentato 1.436 morti);12 Melada (Molat) per il settore dellAdriatico centrale, cio la Dalmazia; i campi integrati di Mamula e Prevlaka per il settore dellAdriatico meridionale. Dal 1942 si svilupp anche una rete di strutture per internati jugoslavi situate in territorio italiano e allestite perlopi in ex caserme: Gonars e Visco, nel Friuli-Venezia Giulia; Monigo e Chiesanuova, in Veneto; Renicci, in Toscana; Colfiorito (gi campo di internamento civile regolamentare), in Umbria; Cairo Montenotte, in Liguria, un campo messo a disposizione dal 23 febbraio 1943 per allogeni sloveni e croati residenti nei vecchi confini del Regno: i reclusi ancora presenti nel campo dopo l8 settembre 1943 furono tutti deportati in Germania. Sulla base di fonti attendibili, soprattutto le relazioni della Croce Rossa Internazionale, si pu valutare in circa 100.000 il numero dei civili ex jugoslavi internati dallItalia fascista. Con lincremento sempre pi massiccio de-
11 Della Circolare 3C-L parla C. S. Capogreco, op. cit., pp.70-72. Si tratta di un testo diviso in 23 capitoli, parzialmente riprodotto in appendice al gi citato saggio di G. Oliva, Si ammazza troppo poco. La versione integrale consultabile presso lIntitut za Novejo Zgodovino di Lubiana. 12 T. Ferenc, Rab-Arbe-Arbissima. Confinamenti-rastrellamenti-internamenti nella Provincia di Lubiana. 1941-1943. Documenti, Drutvo piscev zgodovine NOB-Intitut za novejso zgodovino, Ljubljana, 2000, citato in C. S. Capogreco, op. cit., p. 147.
54
Capitolo II
gli internamenti, lAutorit militare cerc di fare in modo che i civili ex jugoslavi passassero sotto la giurisdizione del Ministero dellInterno. Ma la Direzione generale di Pubblica Sicurezza afferm che i propri 40 campi erano ormai saturi e che era impossibile pensare di costruirne di nuovi. Alla fine del 1942 fu raggiunto un compromesso: in attesa che il Ministero dellInterno provvedesse a edificare nuovi campi, degli ex jugoslavi avrebbe continuato a occuparsi il Regio Esercito. Il Regio Esercito e il Ministero dellInterno non erano dunque n separati n in concorrenza sulla questione dellinternamento civile. Tra la fine del 1941 e linizio del 1942, infatti, la Direzione generale di Pubblica Sicurezza riserv agli ex jugoslavi i propri campi di Casoli, Citt S. Angelo, Corropoli, Lanciano, Notaresco e Scipione; ne istitu uno nuovo a Sassoferrato; riattiv le ex colonie di confino di Ponza e Lipari. Nellaprile 1943 Mussolini, su proposta dellAlto Commissario per la Provincia di Lubiana Emilio Grazioli, dispose che i campi ubicati nella Penisola, tranne Visco, passassero in breve al Ministero dellInterno, ma con gli Alleati prossimi allo sbarco e il regime fascista ormai in crisi, lo scambio di consegne rimase sulla carta. Al momento dellarmistizio dell8 settembre 1943, dunque, i campi per slavi, sia in Italia sia nei territori occupati, erano ancora in mano allesercito. Condizioni di vita nei campi del fascismo monarchico Nei campi dellinternamento civile regolamentare la crescente penuria di cibo, la convivenza in promiscuit fra persone diversissime per et e ceto, lozio forzato (solo dal luglio 1942 fu consentito lo svolgimento di attivit lavorative allesterno del campo agli internati non pericolosi) determinarono una situazione di grande disagio. Il sussidio giornaliero (inizialmente di 6,50 lire, poi aumentato) consent negli anni 1940-41 un vitto sufficiente (anche perch cerano mense autogesti-
te), ma la successiva perdita di valore della lira fece diminuire il potere dacquisto del sussidio: si svilupp il mercato nero e gli internati cominciarono a soffrire la fame. Le giornate erano tutte uguali, scandite dagli appelli, dal pranzo, dalla distribuzione della posta (che era consentito ricevere, ma solo da famigliari, ed era sottoposta a censura), dallarrivo di nuovi internati o dalla partenza di altri. Era vietato (principale differenza rispetto agli internati liberi) avere rapporti con la popolazione locale; inoltre, era vietato leggere pubblicazioni non autorizzate e possedere apparecchi radio. La vigilanza allesterno dei campi era svolta dalla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e/o dai Carabinieri. Sia gli internati nei campi regolamentari sia gli internati liberi non dovettero quasi mai subire crudelt gratuite, ed eventuali azioni di questo tipo venivano disapprovate e perseguite dalle autorit superiori. Neppure gli ebrei furono sottoposti a particolari angherie, per vivevano nel timore di essere prima o poi consegnati ai nazisti. Tuttavia latteggiamento dei dirigenti e del personale di custodia divent pi duro anche nei campi regolamentari a partire dal 1942, quando vi arrivarono in gran numero deportati slavi. Nei campi per slavi dellinternamento civile parallelo le condizioni di vita furono molto pi gravose che nei campi amministrati dal Ministero dellInterno: gli internati non avevano sussidi economici n mense autogestite; venivano frequentemente alloggiati in tendopoli senza arredi e situate in riva al mare, su terreni renosi e fangosi, dove, privi di indumenti adeguati, spesso non reggevano ai rigori e allumidit dellinverno. In questi campi il sovraffollamento, la drammatica situazione igienico-sanitaria e la denutrizione generalizzata determinarono un alto tasso di mortalit. Le razioni giornaliere previste dal Regio Esercito erano di 877 calorie, corrispondenti a meno della met del fabbisogno calorico minimo di un essere umano: dunque la fame e le malattie a essa connesse
Le guide della memoria
55
regnavano sovrane e, del resto, erano considerate dalle autorit militari ottime alleate per neutralizzare eventuali velleit dei prigionieri. Celebri, a questo proposito, sono le dichiarazioni del generale Gastone Gambara: Logico e opportuno che campo di concentramento non significhi campo di ingrassamento. Individuo malato = individuo che sta tranquillo. 13 I medici dellospedale di Treviso, dove erano condotti gli internati in fin di vita, restavano esterrefatti di fronte alla loro denutrizione: identici a quelli di Buchenwald li defin il Professor Menenio Bortolozzi.14 Le condizioni peggiori dal punto di vista ambientale e alimentare furono nei campi di Arbe e di Melada, ma anche nei campi ubicati in Italia il tasso di mortalit fu molto alto. I campi del fascismo repubblicano (1943-1945) Alla vigilia dello sbarco degli Alleati e del colpo di Stato15 che determin la caduta del fascismo monarchico il 25 luglio 1943, i deportati vennero trasferiti dalle isole di confino e dai campi del Sud verso lItalia centrosettentrionale, in campi ritenuti pi controllabili. In tali trasferimenti, ultime esibizioni di potere del regime ormai allo sbando, che avvenivano spesso sotto i bombardamenti alleati, parecchi furono i feriti. Il Governo Badoglio, pur affrontando la questione della liberazione dei deportati nei quarantacinque giorni precedenti larmistizio, lo fece con cautela eccessiva e la macchina burocratica si mise in moto con estrema lentezza: dal 27 luglio al 21 agosto furono necessarie sette circolari perch si dichiarassero prosciolti
gli internati di nazionalit italiana, e la liberazione degli internati stranieri, prevista esplicitamente come clausola dellarmistizio, fu ordinata solo il 10 settembre 1943, con il rischio, per gli oltre 6.000 ebrei detenuti, di cadere nelle mani dei tedeschi che avevano occupato la Penisola. Ci dimostra come lapparato burocratico del Regno dItalia fosse ancora legato al regime mussoliniano. Il 12 settembre, subito dopo lannuncio dellarmistizio, un commando di aviatori e paracadutisti tedeschi liber Mussolini dalla sua prigione a Campo Imperatore, sul Gran Sasso. Il 23 settembre il duce cre la Repubblica Sociale Italiana, schierandola a fianco dei vecchi alleati, e immediatamente, il 1 novembre 1943, il Ministero dellInterno del nuovo Stato abrog per lItalia centrosettentrionale le misure liberatorie adottate dal Governo Badoglio nellestate del 1943. La RSI non utilizz pi il confino di polizia, ma continu lapplicazione dellinternamento, indirizzandolo soprattutto contro gli oppositori politici, i partigiani, i renitenti alla leva e accentuandone laspetto punitivo. Una speciale attenzione venne dedicata agli ebrei, sia italiani sia stranieri: con lordinanza di polizia n. 5 del 30 novembre 1943, emanata dal ministro dellInterno Buffarini Guidi, venne disposto lallestimento di campi di concentramento provinciali, dove i rastrellati venivano reclusi in attesa di essere consegnati alle SS e trasportati nei Lager nazisti. I campi di transito consegnati dalla RSI ai nazisti furono quattro: Fossoli di Carpi, Borgo San Dalmazzo, Bolzano-Gries, e la Risiera di San Sabba. Essendo la Zona del Litorale Adriatico sotto amministrazione tedesca dopo
13 Ars, II, XI Corpo dArmata, b. 726, s.f. VII, nota del generale Gastone Gambara, 17 dicembre 1942, riportata in C. S. Capogreco, op. cit., p. 142. 14 Ibidem, p. 144. Capogreco cita la testimonianza del Professor Menenio Bortolozzi, tratta da R. Bolis, Chi erano quei 2.800 sloveni nel Lager fascista a Monigo, in LUnit, 25 aprile 1980. 15 Lespressione, usata da storici come M. Salvadori, E. Ragionieri, P. Spriano, C. S. Capogreco, pare appropriata anche considerando gli esiti del 25 luglio 1943; generalmente, infatti, un colpo di Stato implica lapporto delle Forze armate e non comporta un ricambio di classe dirigente (come invece accade dopo una rivoluzione): quello di Badoglio fu un governo di militari e tecnici, che doveva, nelle intenzioni, garantire la continuit con il fascismo.
56
Capitolo II
larmistizio dell8 settembre,16 la Risiera nacque verso la fine di ottobre del 1943 direttamente dallesperienza dello Einsatzkommando Reinhard (reparto operativo formato da uomini agli ordini del generale SS austriaco Odilo Lotario Globocnik, triestino di nascita, addestrati in Polonia nei campi di sterminio immediato di Treblinka, Bel /z ec, Sobibr) e fu un Lager polifunzionale: non solo di transito verso la Germania, ma di detenzione di polizia, di sfruttamento della forza lavoro prigioniera e anche di sterminio, in quanto dotato di forno crematorio.
Il campo di Fossoli oggi (novembre 2005)
16
Bibliografia. Il libro di Carlo Spartaco Capogreco, I campi del duce. Linternamento civile nellItalia fascista (1940-1943), Torino, Einaudi, 2004, stato il punto di partenza e il filo conduttore della guida, in quanto rappresenta senzaltro lopera pi completa, rigorosa e sistematica finora pubblicata sullinternamento fascista, soprattutto riguardo al periodo 194043 in cui lItalia era ancora uno Stato sovrano. Capogreco, presidente della Fondazione Ferramonti, inoltre autore di studi su singoli campi, come quelli di Ferramonti di Tarsia e di Renicci. Utili ai fini dellapprofondimento del tema sono anche i testi curati da Costantino Di Sante, fra cui si segnala larticolo Origine e sviluppo del sistema concentrazionario fascista comparso ne LUnit del 21 gennaio 2002 e il volume I campi di concentramento in Italia. Dallinternamento alla deportazione (1940-1945), Milano, FrancoAngeli, 2001. Il libro la raccolta degli atti del Convegno nazionale tenutosi presso lUniversit di Teramo nel marzo del 1998 e ripropone in modo complesso il problema della conservazione e della trasmissione della memoria, per anni colpevolmente trascurata, dei campi fascisti. Interessante anche il saggio di Fabio Galluccio, I Lager in Italia. La memoria sepolta nei duecento luoghi di deportazione fascisti, Civezzano, Nonluoghi Libere Edizioni, 2002: animato dalla volont di far conoscere questa triste storia al di l della ristretta cerchia degli studiosi, Galluccio sviluppa molti riferimenti allattualit (al rinascere di movimenti xenofobi in Italia e altrove) e alle responsabilit dei popoli, ieri come oggi. E racconta del suo viaggio sulle tracce dei campi italiani dimenticati (situati perlopi in ex monasteri, ville abbandonate, caserme), con particolare attenzione agli ebrei di ogni nazionalit in essi prigionieri. Ne risulta cos un diario tra il giallo e lautobiografia, in cui lautore confessa i propri dubbi, gli scoramenti, le frustrazioni di una ricerca che procede tra mille difficolt (pochissimi sanno o ricordano, rare sono le pur utilissime pubblicazioni di storici locali). Sul nodo dei campi per slavi o dellinternamento civile parallelo, si vedano, ancora, Carlo Spartaco Capogreco, Una storia rimossa. Linternamento dei civili jugoslavi da parte dellItalia fascista (1941-43), Annali di studi istriani e mediterranei, Koper (Capodistria), 22/2000, e Costantino Di Sante, Italiani senza onore. I crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941-1951), Verona, ombre corte/documenta, 2005, in cui il curatore seleziona e commenta una scelta significativa di documenti sulla vicenda dei crimini italiani in Jugoslavia e dei mancati processi, argomentando con la mancanza di una Norimberga italiana il persistere dello stereotipo del bravo italiano. Unopera seria di divulgazione, che utilizza i risultati delle ricerche di Capogreco e Di Sante, oltre a contributi di altri studiosi e a materiali darchivio, il libro di Gianni Oliva, Si ammazza troppo poco. I crimini di guerra italiani. 1940-1943, Milano, Mondadori, 2006.
Due erano le Zone doperazione soggette allamministrazione tedesca e sottratte alla sovranit italiana, non a caso due zone di frontiera, destinate a essere incorporate nel Reich se la Germania avesse vinto la guerra: la prima comprendeva le province di Belluno, Trento e Bolzano (dunque anche il campo di Bolzano-Gries); la seconda comprendeva le province di Udine, Gorizia, Trieste, Fiume, Pola, Lubiana. Si veda, a questo proposito, E. Collotti, Loccupazione tedesca in Italia con particolare riguardo ai compiti delle forze di polizia, nel volume a cura di C. Di Sante, I campi di concentramento in Italia cit., p. 252.
Le guide della memoria
57
Le leggi razziali
Marcella Pepe Nel 1938 il governo fascista eman le leggi razziali, proseguendo lallineamento con la politica dellalleato nazista (le leggi di Norimberga sono del 1935), iniziato dopo la stipulazione dellAsse Roma-Berlino (1936). Tra il 1938 e lestate del 1939, il Terzo Reich estese la legislazione antiebraica vigente in Germania allAustria, alla Lituania, al territorio dei Sudeti, al protettorato di Boemia, ed ebbero una propria normativa persecutoria anche Romania, Ungheria, Slovacchia. Nei primi due anni di guerra, agli Stati gi con una legislazione antisemitica si aggiunsero la Francia di Vichy (ottobre 1940), la Bulgaria (gennaiofebbraio 1941), la Croazia nata dalla disgregazione della Jugoslavia (aprile 1941), che scelsero fin dallinizio per le loro leggi il criterio classificatorio razziale tedesco e italiano, cui si uniformarono subito anche Romania, Ungheria e Slovacchia. LEuropa si ritrov cos antisemita in pieno XX secolo, a centocinquantanni dalla Rivoluzione francese e dalla Dichiarazione dei diritti delluomo e del cittadino. Lantisemitismo tradizionale e lantisemitismo moderno Occorre premettere che lantisemitismo, ovvero la pregiudiziale ostilit nei confronti degli ebrei, molto pi antico del nazismo e del fascismo e attraversa tutta la storia dellEuropa cristiana. Per i cristiani, infatti, gli ebrei erano il popolo deicida, colpevole delluccisione di Cristo. N le persecuzioni antiebraiche sono una prerogativa del XX secolo, bens una costante della storia europea a partire dal Medioevo. Fondata su accuse assurde, come quella di avvelenare i pozzi per diffondere le malattie epidemiche, la caccia allebreo ha sempre coinvolto grandi masse che si accanivano contro minoranze facilmente riconoscibili e di dimensioni troppo piccole per potersi difendere, facendone un capro espiatorio. Tuttavia, mentre lantigiudaismo tradizionale si basava su motivazioni prevalentemente teolo-
giche, quello moderno si distingue per due elementi nuovi. Uno quello biologico: esiste una razza semitica, e tale rimane a meno che non si diluisca attraverso le generazioni (quattro, secondo le leggi di Norimberga). E nella gerarchia nazista delle razze, nel nuovo ordine nazionalsocialista che prefigurava unumanit ridotta in schiavit al servizio della razza ariana dominatrice, gli ebrei erano al fondo, insieme agli zingari, agli slavi, ai neri. Il secondo elemento, cui si presta generalmente scarsa attenzione, quello politico. Nella ideologia di Hitler, ispirata ad Alfred Rosenberg, il teorico razzista del Terzo Reich, autore del libro Il mito del XX secolo (1930), lantisemitismo si coniugava con la lotta contro il marxismo, bollato come bolscevismo giudaico, e si giustificava come necessit di abbattere la cospirazione giudaica mondiale sostenuta dai cosiddetti Protocolli dei Saggi di Sion, un clamoroso falso probabilmente redatto dalla polizia zarista di inizio Novecento. Nemmeno la legislazione antisemitica in assoluto una novit del XX secolo, bench non avesse mai raggiunto prima una tale sistematicit di elaborazione (fondandosi su presupposti che pretendevano di essere scientifici) e un tale grado di ferocia nellapplicazione (ne furono vittime, secondo stime attendibili, sei milioni di ebrei), da indurre gli storici a usare termini come genocidio (dal greco ghnos, stirpe, a indicare lo sterminio di un intero popolo), Olocausto (sacrificio) o Shoah (che in ebraico significa disastro, catastrofe). Questultimo termine si affermato fuori di Israele sullonda dellemozione suscitata nel 1985 dal film Shoah di Claude Lanzmann e descrive levento dal punto di vista delle vittime, mentre Endlsung (soluzione finale) appartiene allambito burocratico e al linguaggio velato dei persecutori. La legislazione antiebraica in Germania Il 7 aprile del 1933 il Terzo Reich eman le prime leggi razziali, con cui gli ebrei tedeschi vennero esclusi da numerose professioni e as-
58
Capitolo II
sociazioni. Fu definito come non ariano chi avesse anche soltanto un nonno appartenente a una Comunit ebraica. Tale formulazione, poich valutava laspetto religioso, rischiava per di escludere dai non ariani i discendenti di ebrei secolarizzati e non soddisfaceva tutto lestablishment nazista. Fecero chiarezza le leggi di Norimberga del 1935, che aprirono la strada allo sterminio, distinguendo gli ebrei in due categorie: lebreo puro (privato di ogni diritto) e il mezzosangue, librido (Mischling), che a sua volta fu distinto in ibrido di primo grado (al 50%, di incerto destino) e in ibrido di secondo grado (al 25%, destinato allassimilazione con il popolo tedesco). Nel 1938 fu avviato il censimento degli ebrei e di tutti i loro beni e, nella notte tra il 9 e il 10 novembre (detta notte dei cristalli), si scaten il pi gigantesco pogrom che la storia occidentale ricordi, con la distruzione di 267 sinagoghe, 7.500 negozi e larresto di 26.000 ebrei. Con linizio della guerra e linvasione della Polonia (1939) le dimensioni del problema ebraico diventarono enormi. Si calcola infatti che nei territori occupati (da Oslo a Salonicco, da Parigi a Varsavia) gli ebrei fossero circa 3.000.000 e che solo nella parte della Polonia sottomessa al Terzo Reich (il Warthegau, annesso direttamente, e il Governatorato generale) risiedessero almeno 1.800.000 ebrei. Le norme emanate per escludere gli ebrei tedeschi dal consorzio civile si rivelarono di conseguenza largamente insufficienti. I nazisti provvidero allora alla creazione dei ghetti (al primo, costruito a / L dz , seguirono quelli di Varsavia, Cracovia, Lublino, Cze stochowa, Kielce, Lww), dove gli ebrei furono costretti a traslocare abbandonando le loro case e i loro beni. In seguito, dopo linvasione dellUnione Sovietica (22 giugno 1941), il problema della presenza ebraica nelle terre da germanizzare si fece sempre pi grave (erano altri 4.000.000 gli ebrei nella nuova area raggiunta dallavanzata delle truppe tedesche); fu allora che ven-
nero organizzati i gruppi di intervento (Einsatzgruppen) incaricati dei primi feroci massacri, dei quali, secondo calcoli approssimativi, furono vittime circa 800.000 persone. Contemporaneamente venivano aggiunti al gi imponente sistema concentrazionario nazista nuovi Lager adibiti allo sterminio: Auschwitz fu inaugurato il 14 giugno 1940, e nel 1941 furono aperti altri cinque campi nella zona tedesca della Polonia. Quando, il 20 gennaio 1942, nella Conferenza di Wannsee, presso Berlino, fu decisa la soluzione finale ( Endlsung ) del problema ebraico, lo sterminio era gi in atto, sia pure in forma non ancora sistematica, e si trattava soltanto di sincronizzare le linee di condotta di tutte le istanze centrali del Reich al fine di raggiungere lobiettivo in modo ottimale. Il capo del RSHA (Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich), Reinhard Heydrich, inform i partecipanti alla Conferenza dellintenzione di non lasciar sopravvivere neppure una cellula germinale di una nuova rinascita ebraica: tutti gli ebrei presenti sul territorio del Reich dovevano essere trasferiti nei campi dellEst europeo per subire il trattamento finale, ovvero lo sterminio attraverso il lavoro. Le nuove disposizioni giunsero ai comandanti dei KL il 30 aprile 1942 con la Circolare Pohl.
Auschwitz I (marzo 2004)
Le guide della memoria
59
Campi di sterminio immediato Auschwitz II-Birkenau Majdanek Chel /mno Bel /z ec Sobibr Treblinka
Stime approssimative dei morti da 1.500.000 a 2.000.000 da 100.000 da 200.000 da 150.000 a 300.000 600.000 da 250.000 a 500.000 da 750.000 a 1.000.000
Fonte: F. Francavilla, I Lager nazisti fra repressione, sterminio e sfruttamento economico, Consiglio Regionale del Piemonte, 1982.
In Italia Precedute dal Manifesto degli scienziati razzisti (14 luglio 1938), sottoscritto da 180 scienziati e redatto (secondo i diari di Botta e Ciano) quasi completamente dallo stesso Mussolini, e da una campagna di stampa che doveva preparare il Paese alla loro ricezione, furono emanate a pi riprese, a partire dal 5 settembre 1938, le leggi razziali, cui fecero immediatamente seguito le ordinanze applicative: 5 settembre 1938: provvedimenti per la difesa della razza nella scuola italiana; 7 settembre 1938: provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri; 15 novembre 1938: integrazione delle norme per la difesa della razza nella scuola italiana; 17 novembre 1938: provvedimenti per la difesa della razza italiana; 29 giugno 1939: disciplina dellesercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica. Il 6 ottobre 1938 era stata approvata dal Gran Consiglio del Fascismo la Dichiarazione sulla razza. La lettura del Manifesto degli scienziati razzisti sbalordisce per limpudenza, la palese arbitrariet e linfondatezza storica di certe affermazioni che vengono presentate come scientifiche.
Alcune citazioni: Il concetto di razza concetto puramente biologico. Esso quindi basato su altre considerazioni che non i concetti di Popolo e di Nazione, fondati su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Per alla base delle differenze di Popolo e di Nazione stanno delle differenze di razza. La popolazione dellItalia attuale nella maggioranza di origine ariana e la sua civilt ariana []. Dopo linvasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della Nazione []. Questa antica purezza di sangue il pi grande titolo di nobilt della Nazione italiana. tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta lopera che finora ha fatto il Regime in Italia in fondo del razzismo. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale rimasto.1 Il re Vittorio Emanuele III firm tutti i decreti; il papa Pio XI protest soltanto contro la norma che vietava i matrimoni misti, invocando il Concordato del 1929; n Pio XI n il suo
1 Il testo complessivo del Manifesto si pu leggere nel saggio di G. Israel / P. Nastasi, Scienza e razza nellItalia fascista, Bologna, il Mulino, 1998, pp. 365-367.
60
Capitolo II
successore Pio XII si pronunciarono pubblicamente su altri provvedimenti. Le leggi razziali italiane si preoccuparono in primo luogo di definire lebreo, con una casistica ancora pi minuziosa di quella delle leggi di Norimberga. Vennero considerati di razza ebraica coloro che avessero: entrambi i genitori di razza e di religione ebraica; un solo genitore di razza ebraica e laltro di nazionalit straniera; un solo genitore di razza o di religione ebraica e laltro di nazionalit italiana; madre di razza ebraica, in caso di padre ignoto. Non venne invece considerato di razza ebraica chi fosse nato da genitori entrambi di nazionalit italiana, di cui uno solo di razza ebraica, ma non appartenente alla religione ebraica. Per il fascismo, dunque, le persone erano di razza ebraica o di razza ariana. La categoria giuridica dei misti, tanto importante in Germania, in Italia non fu considerata. Per questo aspetto le leggi italiane non erano affatto pi lievi di quelle tedesche, anche se non prevedevano violenze fisiche ai danni degli ebrei e non introdussero, neppure durante la Repubblica Sociale Italiana, lobbligo di portare un segno distintivo come la stella gialla. Inoltre, le leggi razziali, nel loro insieme, stabilivano che era proibito ai cittadini italiani di razza ebraica: contrarre matrimonio con persone appartenenti ad altra razza; prestare servizio militare in pace e in guerra; esercitare lufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica; essere proprietari o gestori di aziende con pi di 100 dipendenti e proprietari di terreni con un estimo superiore a 5.000 lire o di fabbricati con un imponibile superiore a 20.000 lire; avere alle proprie dipendenze, in qualit di domestici, cittadini di razza ariana;
iscriversi alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani; insegnare nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle universit (con immediata sospensione dallinsegnamento o dalla libera docenza); esercitare le professioni di notaio e giornalista (per gli altri professionisti era obbligatoria la denuncia di appartenenza alla razza ebraica e liscrizione in elenchi aggiunti da istituirsi in appendice agli albi professionali). Era fatto divieto di avere alle proprie dipendenze persone di razza ebraica: alle amministrazioni civili e militari dello Stato; al Partito Nazionale Fascista; alle Province, ai Comuni e a tutti gli enti pubblici; alle amministrazioni delle aziende municipalizzate e delle aziende collegate agli enti pubblici; alle amministrazioni di imprese private di assicurazione. Cerano tuttavia categorie di ebrei cui non erano applicabili le disposizioni contro la razza: i componenti delle famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola e dei caduti per la causa fascista; i mutilati, gli invalidi, i volontari e i decorati al valore nelle guerre sopracitate; gli iscritti al Partito Nazionale Fascista dal 1919 fino al secondo semestre del 1924; i legionari fiumani. Le leggi razziali disponevano, infine, lallontanamento dallItalia di tutti gli ebrei stranieri entro il 12 marzo 1939; quelli ancora presenti sul suolo della Penisola nel maggio del 1940 furono internati nel campo di concentramento calabrese di Ferramonti di Tarsia. Discriminare e non perseguitare era il motto iniziale di Mussolini. Tuttavia, gi nel febbraio del 1940 era stata comunicata ufficialmente allUnione delle Comunit israelitiche italiane lintenzione del regime di espellere entro dieci anni tutti gli ebrei (non solo gli ebrei
Le guide della memoria
61
stranieri) dallItalia, anche se lo scoppio della guerra rese poi impossibile qualsiasi uscita, e il progetto fu accantonato nel corso del 1941. Furono invece emanate disposizioni amministrative per linternamento degli ebrei ritenuti pericolosi (maggio-giugno 1940) e per il lavoro obbligatorio (maggio 1942). Secondo Renzo De Felice (Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino, Einaudi, 1993) la politica del fascismo nei confronti degli ebrei sub una svolta radicale a partire dal 1943, dopo l8 settembre e la costituzione della Repubblica Sociale Italiana, che implic la totale sudditanza del regime mussoliniano rispetto allalleato nazista. In effetti da quel momento la Milizia fascista fu attivissima nel ricercare gli ebrei per consegnarli alle SS, che li caricavano su vagoni blindati e li deportavano nel Reich (il principale campo di smistamento era a Fossoli, presso Modena). E certamente dallautunno del 1943 la discriminazione si trasform in aperta persecuzione. Lo storico Michele Sarfatti imposta per il problema diversamente.2 Secondo Sarfatti, occorre retrodatare lavvio in Italia di una vera e propria politica antisemitica e correggere lidea di un antisemitismo italiano blando e in fondo propagandistico, almeno fino alla Repubblica di Sal. Egli afferma che fin dal 1936 Mussolini aveva deciso di risolvere la questione ebraica dotando lItalia di una moderna politica antiebraica e che la decisione di promulgare le leggi razziali non fu leffetto di pressioni tedesche, bens unazione politica autonoma, sebbene correlata a fattori quali lalleanza con la Germania, la conquista dellEtiopia, lesigenza di forgiare il carattere fa-
scista degli italiani e di giungere a un totalitarismo perfetto. E fu una decisione attinente pi alla politica interna che alla politica estera, influenzata dallostilit verso le prese di posizione critiche degli ebrei contro la guerra imperiale e dalla loro solidariet nei confronti dei correligionari perseguitati dai nazisti. Insomma, le leggi avevano una finalit antiebraica, non furono un atto strumentale ad altre politiche.3 Comunque lantisemitismo fascista prepar il terreno allo sterminio deciso dalla Germania nazista, come sottolinea Liliana Picciotto Fargion.4 E lo storico Enzo Collotti fa rilevare che il compito delle SS fu enormemente agevolato dalla preesistenza di strumenti della individuazione nominativa, della localizzazione, con tanto di indirizzi di residenza e di abitazione, degli ebrei italiani e stranieri residenti in Italia [], raccolti presso le anagrafi e una serie di altri enti pubblici []. Alla stessa stregua, luso dei campi di concentramento e delle strutture di reclusione allestite dal regime fascista offr ai tedeschi la possibilit di procedere con relativa rapidit alla fase preliminare della deportazione.5 Si potrebbe dire, parafrasando Michele Sarfatti, che la politica antiebraica del regime fascista si articol in due distinte fasi, autonome ma nello stesso tempo legate luna allaltra: quella della persecuzione dei diritti (autunno 1938-estate 1943), caratterizzata dalla promulgazione delle leggi razziali, e quella della persecuzione delle vite (8 settembre 1943-25 aprile 1945), segnata per gli ebrei dagli arresti e dalle deportazioni, o dalla vita in clandestinit e dalla partecipazione alla Resistenza.6
2 Numerose sono le pubblicazioni di Michele Sarfatti sulla persecuzione antiebraica in Italia, a partire da Gli ebrei negli anni del fascismo (pubblicato nel secondo dei due volumi Gli ebrei in Italia, curato da Corrado Vivanti per gli Annali della Storia dItalia, Torino, Einaudi, 1997), cui sono seguti, sempre per la Einaudi, i saggi: Gli ebrei nellItalia fascista. Vicende, identit, persecuzione (2000); Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi (2002); La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo (2005). Si tratta di opere serie e rigorose, ma al contempo sintetiche e di scorrevole lettura, dunque particolarmente adatte al mondo della scuola. 3 M. Sarfatti, Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi cit., p. 14 e La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo cit., pp. 77-78. 4 L. Picciotto Fargion, Il Libro della memoria. Gli ebrei deportati dallItalia. 1943-1945, Milano, Mursia 2002 (edizione aggiornata rispetto a quella del 1991). Il libro cataloga tutte le vittime identificate per nome, dati biografici essenziali, notizie principali sullarresto e la deportazione o luccisione in Italia. 5 E. Collotti, Introduzione a C. Di Sante (cur.), I campi di concentramento in Italia. Dallinternamento alla deportazione (1940-1945), Milano, FrancoAngeli, 2001, p. 12. 6 M. Sarfatti, La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo cit., p. 75.
62
Capitolo II
I perseguitati dalle leggi razziali italiane furono 51.100, di cui 46.656 ebrei e 4.500 non ebrei (41.300 italiani e 9.800 stranieri).7 Loperazione pi importante ai danni degli ebrei italiani, se non altro per il numero di vittime (1.023), fu quella del primo rastrellamento compiuto allalba del 16 ottobre 1943 nel Ghetto di Roma: ce ne d una stupenda, vivissima descrizione Giacomo Debenedetti in 16 ottobre 1943 (Milano, OET, 1945; Palermo, Sellerio, 1993). Tra emigrazioni, fughe, uccisioni, deporta-
zioni, il calo della popolazione ebraica in Italia dal 1938 al 1945 fu del 48%: nel 1945, infatti, i 46.656 gli ebrei presenti sul territorio italiano nel 1938 si erano ridotti a 26.938.8 Alle vittime identificate vanno aggiunti tutti coloro che furono arrestati senza lasciare traccia o non sono identificabili per nome e cognome perch entrati in Italia senza essere stati registrati alle frontiere. Si tratta di almeno altre 900-1.000 persone, che portano il totale delle vittime ad almeno 8.529.9
Le vittime identificate della Shoah in Italia furono 7.579, come appare dalla seguente tabella. arrestati e deportati arrestati e morti in Italia arrestati e scampati in Italia 6.806 322 (di essi 42 non furono in realt arrestati: si suicidarono o furono uccisi mentre sfuggivano allarresto o morirono per gravi disagi o privazioni) 451 (numero indicativo in quanto non possibile al momento elaborare tabelle complete; si tratta di evasi, di liberati o di altri casi) 7.579
totale identificati
Fonte: L. Picciotto Fargion, Il Libro della memoria cit., Tavola 1.
Ibidem, p. 83. Si veda anche Idem, Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi cit., p. 22. Dati tratti dal sito della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, www.cdec.it. Sul sito si possono trovare i testi delle leggi razziali dellItalia fascista, la statistica generale degli ebrei vittime della Shoah in Italia (tavole riportate dal gi citato Libro della memoria di L. Picciotto Fargion), bibliografie e strumenti. 9 http://www.cdec.it, visitato nel giugno-ottobre 2006.
8
Le guide della memoria
63
2. I luoghi della deportazione
Cenni sulla storia del Lager di Auschwitz
Lucio Monaco La storia di Auschwitz si pu articolare in tre fasi, in cui sincrociano e si sovrappongono gli aspetti che caratterizzano listituzione concentrazionaria nazista (repressione, sterminio, sfruttamento economico): 1940-1941: costruzione e ampliamento del Lager principale (complesso duraturo che sarebbe dovuto servire per molti anni ancora come luogo di detenzione e di annientamento degli avversari del Reich1), delle installazioni agricole e degli stabilimenti industriali a esso collegati; ottobre 1941-autunno 1944: potenziamento delle strutture produttive e industriali; installazione delle strutture di sterminio (impiego dellacido cianidrico; camere a gas; soluzione finale a Birkenau); inverno 1944-gennaio 1945: smantellamento e abbandono del Lager. Auschwitz, il pi grande centro di sterminio che il mondo abbia mai visto,2 concentra e riassume in tutta la sua complessit la vicenda centrale nel Novecento del totalitarismo nazifascista e della sua politica di sterminio. Eccezionale si presenta anzitutto per lestensione: la zona di interesse del campo ricopriva unarea di 40 km quadrati. Venne prevista, fin dai primi progetti (1940), una compresenza di impianti produttivi di ogni tipo (dallagricoltura alla chimica), che sfruttavano la manodopera schiavile fornita dal Lager. La quarantina di sottocampi sorta cos fra il 1941 e il 1944 ser-
viva direttamente alleconomia della SS (aziende agricole), ma soprattutto agli apparati produttivi di grandi consorzi tedeschi, di cui i pi noti sono la IG-Farbenindustrie, gli Hermann Gring Werke, la Siemens-Suckert. Si trattava di attivit legate allindustria bellica e ad alcune ricerche sperimentali: miniere di carbone, industria chimica, armamenti, edilizia. A partire dallestate 1941 il territorio di Auschwitz fu individuato anche come localit in cui collocare le strutture distruttive necessarie allattuazione della soluzione finale. Il progetto del sottocampo per prigionieri di guerra di Auschwitz II-Birkenau, risalente allinizio del 1941, fu trasformato in progetto di campo di sterminio immediato. Larea interessata era quella di Brzezinka (in tedesco Birkenau), a circa 3 km dal campo principale. I deportati (prevalentemente russi e polacchi) lavorarono alla costruzione del campo fra il marzo del 1941 e il febbraio del 1942, mentre sorgeva contemporaneamente un altro Lager (detto poi Auschwitz III) presso lo stabilimento industriale di Buna, nelle vicinanze di Monowice (Monowitz in tedesco), a circa 7 km dal campo principale. Allingegneria della guerra e dello sterminio contribuirono non solo gli imprenditori e i capitalisti tedeschi, ma anche imprese di vari Paesi, Italia compresa. Nel marzo 1942 a Roma i dirigenti della IG-Farben firmarono un accordo con un consorzio di imprese edili italiane, il Gruppo italiano, per la costruzione degli edifici della nuova fabbrica [cio Buna]; le imprese fornivano anche la manodopera. Lo storico Brunello Mantelli ha ricostruito la vicenda e ha ritrovato pure una copia del contratto, pubblicato nel 1942 a cura della Federazione nazionale fascista costruttori edili. Raggruppamenti Germania, con il nome delle aziende che vinsero lappalto.3
1 D. Czech, Genesi, costruzione e ampliamento del campo, in Auschwitz. Il campo nazista della morte, Os wie cim, Museo AuschwitzBirkenau, 1995, p. 26. 2 2 R. Hilberg, La distruzione degli Ebrei dEuropa, trad. it. di F. Sessi / G. Guastalla, Torino, Einaudi, 1995, 1999 , p. 957. 3 G. Nebbia, Lingegneria dello sterminio, in T. Bastian, Auschwitz e la menzogna di Auschwitz, trad. it. di E. Grillo, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, p. 124; cfr. B. Mantelli, Il cantiere di Babele, in Storia e dossier, a. V, n. 44 / ottobre 1990.
64
Capitolo II
Per le uccisioni di massa i dirigenti del Lager in primo luogo il comandante Rudolf Hss sperimentarono una tecnica di gassazione diversa da quelle usate nel Programma di Eutanasia (T4) e negli altri centri di sterminio immediato. Al monossido di carbonio Hss sostitu lacido cianidrico (nome commerciale: Zyklon-B, un potente antiparassitario). Gli esperimenti furono condotti nel campo principale (Auschwitz I) a partire dallagosto 1941. In settembre, nei sotterranei del Blocco 11, fu eseguita la prima gassazione di massa: 600 prigionieri di guerra sovietici e 250 malati. Venne poi attrezzato un locale presso il crematorio: vi furono uccisi centinaia di prigionieri di guerra sovietici e, a partire dallautunno 1941, gli ebrei che arrivavano con i primi trasporti destinati allo sterminio. I trasporti giungevano in treno; le vittime venivano avviate verso il crematorio e portate nelle finte docce adiacenti. Il basso rendimento del crematorio, costruito nel 1940 per scopi pi ordinari, port al trasferimento di queste operazioni nel nuovo campo di Birkenau. Con Birkenau si venne a creare una sistematica e specifica industria di morte, organiz-
zata in fasi e suddivisioni del lavoro di tipo industriale: la disposizione dei settori, delle baracche e degli edifici, la dislocazione dei raccordi ferroviari, le attivit e i ritmi delle squadre di lavoro interne al campo furono resi funzionali al progetto di sterminare principalmente gli ebrei e gli altri gruppi giudicati inferiori (gli zingari). Nelle camere a gas erano inviati, allarrivo, i gruppi destinati alla soppressione immediata o gli inabili al lavoro (selezionati in base a criteri variabili, a seconda del momento); a essi si aggiungevano i prigionieri deperiti, malati e giudicati inutili nel corso delle periodiche selezioni. Nellestate 1942 vennero messe in funzione le prime due camere a gas (Bunker I e II), collocate in edifici rurali riadattati. I morti erano sepolti, e pi tardi incinerati, in fosse adiacenti. Lintensificazione di tale attivit distruttiva di massa port, verso la fine del 1942, a un ulteriore e pi vasto progetto, comprendente, al termine dei lavori, quattro edifici, denominati Crematorio II, III, IV, V. I primi due comprendevano camere a gas sotterranee (Badeanstalten, bagni-docce), depositi per i corpi (capacit di 2.000 cadaveri), montacarichi, forni crematori. I Crematori IV e V avevano le camere a gas in superficie e presentavano dimensioni pi ridotte. Fu perfezionata anche lorganizzazione dei convogli in arrivo. Allinizio, i treni scaricavano i deportati nei pressi del campo principale; dallestate del 1942 i convogli si fermarono allo scalo merci di Os wie cim, circa a met strada fra Auschwitz I e Auschwitz II: la selezione degli inabili al lavoro avveniva sulla banchina darrivo. Dal maggio del 1944 i convogli furono fatti arrivare direttamente a Birkenau: la selezione si teneva sulla banchina, o rampa, posta fra il settore
Il campo di Birkenau (marzo 2004)
Le guide della memoria
65
Alla fine del 1943 larea di Auschwitz presentava il seguente assetto: a) il campo principale (campo maschile), con settori per le esecuzioni, limprigionamento (Bunker), un crematorio (la camera a gas annessa aveva avuto unutilizzazione limitata dal 1942 alla primavera 1943), settori amministrativi e archivi; b) il campo di Birkenau, diviso in settori: un grande campo femminile (settori BIa e BIb), due settori maschili, un ospedale maschile e uno femminile, in cui fra laltro si svolsero efferate sperimentazioni pseudo-mediche e farmacologiche (Clauberg, Mengele) su uomini, donne e bambini, con la complicit di istituti di ricerca e di aziende farmaceutiche; il Campo per famiglie di zingari, quello per le famiglie ebraiche provenienti da Terezn, e larea dei crematori per lo sterminio immediato. Comandante del campo, fino al novembre 1943, fu lSS Rudolf Hss, poi sostituito nel momento in cui Auschwitz venne definitivamente suddiviso in tre settori: il campo principale (Stammlager), KL Auschwitz I; il KL Auschwitz II (Birkenau); il KL Auschwitz III (Monowitz) e i circa quaranta sottocampi, pi
4
o meno lontani dallarea principale. Verso lautunno-inverno 1944, anche in seguito alla grande rivolta dei Sonderkommando dei Crematori IV, V e II di Birkenau, che distrusse completamente il Crematorio IV (7 ottobre), le operazioni di sterminio immediato vennero gradatamente sospese e si avvi un progressivo smantellamento del campo, anche in considerazione della vicinanza dellesercito sovietico (attestato a 200 km di distanza). Furono predisposti piani di evacuazione del campo, con trasferimenti di prigionieri ad altri KL. Si disloc anche la maggior parte del contenuto dei magazzini (proveniente dalla spoliazione delle vittime allarrivo); vennero distrutti in parte gli archivi e si smantellarono i crematori, spostandone le parti utili in Germania e distruggendo le strutture fisse. Il Crematorio V e le relative camere a gas funzionarono al massimo del loro rendimento fino alla seconda met di gennaio del 1945.4 Lultimo tragico capitolo della storia di Auschwitz riguarda il piano di abbandono del
A. Strzelecki, Evacuazione, liquidazione e liberazione del campo, in Auschwitz. Il campo nazista della morte cit., p. 246.
Quel che resta di Monowitz (marzo 2004)
maschile e quello femminile del campo. Il sistema dello sterminio mediante il gas, gi allusivamente preannunciato da Hitler nel Mein Kampf, aveva cos raggiunto il suo livello organizzativo e tecnologico pi elevato. Fra lestate del 1942 e lestate del 1944 furono mandati a morte centinaia di migliaia di ebrei dEuropa e gli zingari del Campo per famiglie di Birkenau (settore BIIe), che aveva imprigionato, fra il febbraio e il luglio 1944, pi di 20.000 uomini, donne e bambini.
66
Capitolo II
campo, messo a punto alla fine del 1944 e attuato a met gennaio 1945. Dai campi e dai sottocampi, fra il 17 e il 21 gennaio, circa 60.000 prigionieri vennero avviati in lunghe colonne appiedate verso alcuni centri ferroviari, costretti a camminare per decine e in qualche caso centinaia di chilometri. I superstiti furono caricati su vagoni ferroviari scoperti e trasportati verso altri KZ: Sachsenhausen, Bergen Belsen, Buchenwald, Dora, Flossenbrg, Dachau, Mauthausen Questi trasporti, denominati marce della morte, causarono migliaia di morti e furono accompagnati da esecuzioni individuali e di massa. Nel frattempo, ad Auschwitz, le SS distrussero i crematori e incendiarono magazzini, archivi, in alcuni casi anche le baracche con i prigionieri incapaci di marciare. Nei tre campi (Auschwitz I, Birkenau, Monowitz) erano comunque rimasti circa 7.000 prigionieri, liberati dai soldati sovietici il 27 gennaio. Il calcolo dei prigionieri passati per Auschwitz reso complesso, oltrech dalla scomparsa della documentazione, distrutta in gran parte con labbandono del Lager, dal duplice carattere (sterminio immediato e sterminio mediante il lavoro) del campo. Il numero dei prigionieri ufficialmente registrati assomma a circa 400.000 persone, di cui poco pi della met ebrei, e per il resto polacchi (140.000), zingari (21.000), prigionieri di guerra sovietici (12.000) e appartenenti a varie nazionalit. Soggetto a valutazioni anche molto distanti fra loro il numero dei non registrati (tutti ovviamente uccisi). Secondo Frantiek Piper, dei circa 1.300.000 deportati ne sopravvissero 223.000, i restanti 1.100.000 perirono nel campo, e se questo dato da considerare approssimato per difetto, allo stato attuale delle ricerche [] non vi sono elementi per affermare che una tale cifra sia stata superiore a 1.500.000 individui.5
Bibliografia. La bibliografia su Auschwitz vastissima. Oltre allormai classico volume di Hermann Langbein, Uomini ad Auschwitz. Storia del pi famigerato campo di sterminio nazista , trad. it. di D. Ambroset, Milano, Mursia, 1984, si pu segnalare la veloce ma precisa (e spesso innovativa) messa a punto di Sybille Steinbacher, Auschwitz. La citt, il Lager , trad. it. di U. Grandini, Torino, Einaudi, 2005. Fra numerosi altri testi si possono vedere: i due C D Destinazione Auschwitz (1: Verso Auschwitz; 2: La fabbrica dello sterminio), ProediCDEC, Milano, 2000; ledizione italiana del Kalendarium di Danuta Czech (reperibile soltanto su www.deportati.it; prevista unedizione a stampa, in traduzione italiana, per il 2007): una minuziosa cronologia di avvenimenti, anno per anno e giorno per giorno, con le indicazioni delle fonti, perlopi archivistiche, da cui sono desunte le informazioni; per riflessioni di tipo storiografico, che affrontano anche il problema del cosiddetto revisionismo: Giovanni Gozzini, La strada per Auschwitz. Documenti e interpretazioni sullo sterminio nazista , Milano, Bruno Mondadori, 1996; Till Bastian, Auschwitz e la menzogna su Auschwitz. Sterminio di massa e falsificazione della storia , trad. it. di E. Grillo, Torino, Bollati Boringhieri, 1996; sul funzionamento della catena dello sterminio ad Auschwitz e sul rapporto fra tecnologia e genocidio: Jean-Claude Pressac, Le macchine dello sterminio. Auschwitz 1941-1945, trad. it. di M. Chamia, Milano, Feltrinelli, 1993; per un inquadramento generale dello sterminio del popolo ebraico: Shoah. Gli ebrei e la catastrofe , Milano, Electa/Gallimard, 1995, oltre naturalmente allopera fondamentale di Raul Hilberg, La distruzione degli Ebrei dEuropa, trad. it. di F. Sessi / G. Guastalla, Torino, Einaudi, 1995, 19992 (2 voll.); anche la memorialistica richiederebbe una trattazione specifica. Non citiamo ovviamente le note opere di riferimento di Primo Levi. Ci limitiamo a segnalare: Giuliana Tedeschi, Questo povero corpo, Milano, Edit, 1946, ora ristampato in ed. anastatica (Alessandria, Edizioni dellOrso, 2005) e C un punto della terra... Una donna nel Lager di Birkenau, Firenze, Giuntina, 1988 sgg.; Liana Millu, Il fumo di Birkenau, Genova, Locatelli, 1947 e ora Firenze, Giuntina, 1986 sgg.; Charlotte Delbo, Un treno senza ritorno , trad. it. di L. Collodi, Casale Monferrato, Piemme, 2002; Pio Bigo, Il triangolo di Gliwice. Memoria di sette Lager, Alessandria, Edizioni dellOrso, 1998 sgg. Si pu avere un panorama pi completo al sito gi citato www.deportati.it.
F. Piper, Il numero delle vittime del KL Auschwitz, in ibidem, p. 176.
Le guide della memoria
67
Le deportazioni dallItalia ad Auschwitz
Lucio Monaco Gli italiani deportati ad Auschwitz appartenevano, per la quasi totalit, alle comunit ebraiche dellItalia del Centro-Nord (quindi dopo il settembre 1943, del territorio della Repubblica di Sal e della Zona del Litorale Adriatico). Accanto a essi si devono considerare gli ebrei del Dodecaneso (sotto amministrazione italiana fino all8 settembre) e un certo numero di ebrei stranieri che avevano trovato rifugio in Italia. Pi ristretto invece il numero degli italiani finiti ad Auschwitz in qualit di politici (su di loro si possiedono ancora pochi dati). Deportati appartenenti alle comunit ebraiche italiane ed ebrei stranieri residenti o rifugiati in Italia Secondo le ultime ricerche, i convogli partiti dallItalia (territorio della Repubblica di Sal) per Auschwitz furono 11, per un totale di circa 4.500 deportati, di cui risultarono superstiti, alla liberazione, poco pi di 250 persone. A questi occorre aggiungere gli ebrei stranieri rifugiatisi, nel settembre 1943, a Borgo San Dalmazzo (in provincia di Cuneo), poi concentrati in una caserma e di l deportati al campo di transito francese di Drancy e quindi ad Auschwitz: 328 persone, 10 superstiti. Dal Litorale Adriatico (Adriatisches Kstenland, cio Trieste e lIstria, cedute da Mussolini alla SS) furono fatti partire per Auschwitz almeno 20 convogli, con 1.117 persone (81 superstiti). Dal Dodecaneso infine furono deportate 1.820 persone, con un unico convoglio AteneAuschwitz (179 superstiti). Il quadro complessivo che ne risulta di un
1
totale di circa 7.500 deportati con 518 superstiti, pari a poco pi del 7%. A tale cifra vanno naturalmente sommati per completare il quadro della deportazione ebraica dallItalia, che costituisce un aspetto della Shoah i circa 1.000 ebrei deportati dallItalia verso Lager diversi da Auschwitz (Ravensbrck, Flossenbrg, Buchenwald, Bergen Belsen). Liliana Picciotto Fargion ha identificato 8.566 nominativi di persone deportate (poco pi di 1.000 superstiti alla liberazione). 1 La disaggregazione di questi dati statistici rivela aspetti impressionanti. Pi di 100 risultano i bambini di et inferiore a un anno, circa 500 quelli di et compresa fra due e dieci anni. Oltre 500 furono gli ultrasettantenni deportati.2 Diversamente dagli altri Paesi dellEuropa occidentale occupati dai nazisti, in Italia non vi fu alcuna fase preparatoria nellorganizzazione dei rastrellamenti, dal momento che le leggi razziali del 1938 avevano creato le condizioni necessarie allattuazione dei piani nazisti: in particolare, la schedatura degli ebrei, costantemente aggiornata dal regime fino al 25 luglio 1943, e la presenza di un organismo che presiedeva, dipendendo dal Ministero dellInterno, allattuazione delle norme antiebraiche, la Direzione generale per la demografia e la razza (Demorazza). Anche se fra i due regimi, fascista e nazista, non vi fu coordinamento n intenzione di continuit [...] occorre sottolineare con forza che lantisemitismo fascista prepar il terreno allo sterminio deciso dalla Germania nazista.3 La prima grande deportazione di ebrei italiani si verifica quindi a breve distanza dalla nascita della Repubblica di Sal: il 16 ottobre 1943 vengono rastrellati a Roma 1.023 ebrei, che giungeranno ad Auschwitz il 22 ottobre. Di essi, 839 saranno immediatamente elimi-
L. Picciotto Fargion, Il Libro della memoria cit., pp. 28, 34, anche se, come s detto, sul sito della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (www.cdec.it, visitato nel giugno-ottobre 2006) si trova laggiornamento della cifra a 8.529. Cfr. la guida Le leggi razziali, p. 62, n. 9. 2 Ibidem, pp. 26-33. 3 Ibidem, p. 810.
68
Capitolo II
nati nelle camere a gas. Fino a dicembre, le retate e gli arresti furono organizzati e gestiti dai nazisti, mentre a partire dal 1944 la situazione divenne pi complessa, e sintrecciarono, nella dinamica dei rastrellamenti e delle deportazioni, decisioni e competenze sia italiane sia tedesche. Fu creato un campo di transito a Fossoli di Carpi, presso Modena, dove i prigionieri ebrei attendevano il formarsi dei convogli per Auschwitz. Con levoluzione del conflitto, il campo fu smantellato (luglio-agosto 1944) e ne venne organizzato uno pi a Nord, il campo di transito di Bolzano. Anche di qui partirono convogli di ebrei per Auschwitz e talora per altri Lager (Ravensbrck, Flossenbrg). Altri trasporti per Auschwitz partirono dalla Zona del Litorale Adriatico. Gli ebrei erano concentrati nel Lager triestino della Risiera di San Sabba (un vecchio essiccatoio di riso situato alla periferia di Trieste), che fungeva anche da magazzino di raccolta dei beni razziati e da luogo di imprigionamento e assassinio di partigiani e antifascisti (nella Risiera fu allestito un forno crematorio, segno di una elevata mortalit). Dalla Risiera si formavano poi i convogli per Auschwitz, sovente misti (politici ed ebrei). Deportati politici italiani ad Auschwitz Un esiguo numero di politici italiani, ancora poco conosciuto, risulta immatricolato ad Auschwitz, come si potuto rilevare da quanto detto in precedenza. Si registrano scrive Liliana Picciotto Fargion da Trieste molti casi di politici deportati verso Auschwitz anzich verso i Lager tedeschi loro destinati.4 Ma Auschwitz poteva essere raggiunto anche in modo meno diretto. Si segnalano qui, a titolo desempio della complessit dei percorsi seguti, due casi: 1. un gruppo di operaie milanesi fu arrestato in occasione degli scioperi del marzo 1944. Imprigionate prima a San Vittore, poi in una ca-
serma di Bergamo, il 24 marzo partono per la Germania su un convoglio misto: in un vagone le donne (una settantina secondo la testimonianza di Loredana Bulgarelli5), negli altri gli uomini. Arrivate a Mauthausen le donne sono chiuse nella prigione del campo; non ricevono matricola, e quindi il loro passaggio non viene registrato. Il 25 aprile 1944 sono deportate ad Auschwitz, dove ricevono un numero di matricola compreso tra le serie 79000 e 81000. Alcune di loro risultano poi trasferite nel Lager di Flossenbrg, e l nuovamente immatricolate; 2. da Mauthausen, a fine novembre 1944, circa 1.120 deportati (tra loro 165 italiani, di cui 23 giunti nel Lager austriaco il 20 marzo 1944) sono spostati ad Auschwitz. Un mese e mezzo dopo, i superstiti italiani ritorneranno a Mauthausen o saranno evacuati su altri Lager (Buchenwald; solo uno, il saluzzese Armando Zoccola, sar liberato dai sovietici ad Auschwitz). un gruppo professionalmente compatto: meccanici con varia specializzazione, saldatori, elettricisti (anche se non tutti furono poi impiegati in modo coerente), che vennero mandati ad Auschwitz III per ultimare i lavori di Buna.
Bibliografia. Uno strumento fondamentale di ricerca costituito dallo studio gi pi volte citato di Liliana Picciotto Fargion, Il Libro della memoria. Altrettanto rilevante (anche se dimpianto pi discorsivo) il volume di Susan Zuccotti, LOlocausto in Italia, Milano, Mondadori, 1988. Per il tragico capitolo dei bambini deportati si veda I bambini deportati dallItalia e dal Dodecaneso, in Lidia Beccaria Rolfi / Bruno Maida, Un futuro spezzato. I nazisti contro i bambini, Firenze, Giuntina, l997, pp. 155 sgg. Sulla storia e la dinamica dei trasporti dallItalia verso i Lager nazisti si veda Italo Tibaldi, Compagni di viaggio. DallItalia ai Lager nazisti. I trasporti dei deportati 1943-1945, Milano, FrancoAngeli, 1994. La vicenda degli ebrei rifugiatisi nel settembre 1943 a Borgo S. Dalmazzo stata ricostruita da Alberto Cavaglion, Nella notte straniera. Gli ebrei di St-MartinVsubie, Cuneo, LArciere, 1991.
4 5
Ibidem, p. 867. Cfr. M. Paulesu Quercioli, Lerba non cresceva ad Auschwitz, Milano, Mursia, 1994, pp. 53-72.
Le guide della memoria
69
Bolzano: il Durchgangslager di Gries (luglio 1944-aprile 1945)
Lucio Monaco Levoluzione della guerra sul fronte italiano nellestate del 1944, con gli angloamericani in lenta ma progressiva risalita verso Nord, spinse i nazisti a chiudere il campo di transito di Fossoli (attivo dal gennaio 1944 e riservato a deportati sia politici sia razziali, inviati poi ad Auschwitz o in altri Lager come Mauthausen e Buchenwald) e ad aprirne uno pi a Nord, vicino al Brennero. Fu prescelta Bolzano, dove si trasferirono, a partire dal 21 luglio 1944, diversi componenti del nucleo SS che aveva operato a Fossoli: fra loro Karl Thito, Hans Haage e alcuni collaborazionisti ucraini. La scelta risult funzionale: il campo di Bolzano (per la precisione, Bolzano-Gries, chiamato anche campo di Via Resia) rimase attivo per dieci mesi e smist complessivamente circa diecimila deportati avviandoli ai Lager in Germania e Polonia. Un certo numero di prigionieri rimase a Bolzano (tra essi Laura Conti ed Egidio Meneghetti); qualcuno fu liberato prima che il campo cessasse di funzionare. Alla liberazione, il 3 maggio 1945, erano presenti 3.500 prigionieri. Il campo fu poi utilizzato per attivit benefiche, promosse da don Daniele Longhi, che vi era stato imprigionato. Negli anni Sessanta era ancora utilizzato da famiglie senza casa. Demolite le strutture, larea fu riconvertita a scopo edilizio. Una lapide-ricordo e un gruppo scultoreo, che rappresenta alcuni deportati, sono stati collocati nelle vicinanze di Via Resia, presso la Chiesa San Pio X. Nel campo di Gries (localit nelle immediate vicinanze di Bolzano) furono rinchiusi uomini, donne e bambini, distinti da triangoli di tela di diversi colori applicati sulluniforme o sui vestiti: rosso per i politici, rosa per i rastrellati civili, azzurro per i civili stranieri nemici, verde per gli ostaggi altoatesini, giallo
per gli ebrei. Ebrei e zingari vennero schedati su registri a parte, ma non immatricolati (secondo le ultime ricerche avrebbero costituito circa il 10% delle 12.000 presenze nel campo). Le donne imprigionate o in transito furono circa un migliaio; si trattava di ostaggi (parenti di partigiani altoatesini), di prigioniere politiche di passaggio (destinate prevalentemente al Lager di Ravensbrck), di ebree italiane e di altre nazioni europee, quasi tutte avviate ad Auschwitz; si segnala anche la presenza di un gruppo di zingare italiane. I bambini (in numero non superiore alla ventina) erano prevalentemente ebrei e vivevano con le madri nella baracca femminile. La detenzione a Gries poteva durare da pochi giorni a molti mesi, dato il suo carattere di Lager prevalentemente di transito (Durchgangslager). A partire dal 2 febbraio 1945, i bombardamenti della linea ferroviaria impedirono le deportazioni di gruppi consistenti di prigionieri, che poterono essere avviati in Germania solo con automezzi (circa 30 persone inviate a Dachau). Pot cos salvarsi un centinaio di ebrei italiani, fra cui Giacomo Debenedetti, chazan presso la Sinagoga di Torino, arrestato mentre si prodigava per i superstiti della Comunit, ridotti a vita clandestina. Le strutture gerarchiche, che potevano coinvolgere anche i prigionieri (capilavoro, capiblocco), erano analoghe a quelle degli altri Lager, e cos pure lorganizzazione della giornata, comprendente operazioni di appello mattutino, squadre di lavoro allesterno o allinterno del campo (mediamente 10 ore lavorative), appello serale. Le squadre di lavoro esterno erano sfruttate come manodopera gratuita per lavori pesanti e pericolosi in citt e nei dintorni: produzione bellica, rimozione macerie dei bombardamenti e brillamento mine, lavori agricoli, immagazzinamento beni razziati dai nazisti. Furono anche istituiti alcuni sottocampi (in baracche, attendamenti, caserme) in varie localit altoatesine: Merano, Certosa di Val Senales, Val Sarentino, Vipiteno, Dobbiaco, Colle Isarco.
70
Capitolo II
Particolarmente dure erano le condizioni dei prigionieri giudicati pericolosi (blocchi D ed E) o rinchiusi nelle celle, esposti alle violenze continue di due guardie SS ucraine oltremodo crudeli, Michael Seifert e Otto Sain. Nel campo operava anche un comitato clandestino di resistenza, che aveva contatti con lesterno e pot agevolare numerosi tentativi di fuga, non sempre riusciti.
Bibliografia. Per una ricostruzione dettagliata si rimanda alla voce di Frediano Sessi nel Dizionario della Resistenza, a cura di E. Collotti / R. Sandri / F. Sessi, Torino, Einaudi, 2001, vol. II (Luoghi, formazioni, protagonisti), pp. 404-406.
goria pi numerosa, in quellepoca, era costituita dai cosiddetti asociali (60%), seguti dai politici (20%), dai criminali comuni (14%), dai Bibelforscher (Testimoni di Geova, 5%) e da un pi ristretto gruppo di triangoli rosa (omosessuali). Un ulteriore afflusso si ebbe con lAnschluss dellAustria (1938); da Dachau arrivarono pi di 2.000 ebrei austriaci. Altri ebrei (oltre 9.000) vi furono rinchiusi, ma per un breve periodo, in seguito alla Kristallnacht (notte dei cristalli, 9-10 novembre 1938). Con lo scoppio della guerra (settembre 1939) il KL Buchenwald accentu il suo carattere di campo di annientamento, ma si trasform poco dopo anche in luogo di produzione bellica. Nellautunno-inverno 1939, mentre la popolazione del KL toccava le 20.000 unit, fu creata una zona di attendamenti (campo tenda) presso il piazzale dellappello: deportati polacchi ed ebrei austriaci vi furono lasciati morire di fame e di freddo. Nel settembre 1940 la DAW (unindustria di propriet SS)1 install, ai margini del KL, una zona di produzione; lesempio fu poi seguto dalla Gustloff, altra industria di armamenti gestita dalla SS. Per i prigionieri inabili al lavoro in conseguenza dei maltrattamenti fu praticato, verso la fine del 1941, il sistema delle selezioni e delleliminazione nei Centri di Eutanasia istituiti per lOperazione T4 (vennero uccisi oltre 500 prigionieri, in maggior parte ebrei). Unaltra eliminazione sistematica fu quella dei prigionieri di guerra sovietici, fucilati in una zona esterna al campo, tra il 1941 e il 1943, dalla squadra SS del Kommando 99 (oltre 8.400 vittime, non immatricolate). Allinizio del 1942 risale listituzione di un settore destinato agli esperimenti medici. Un apposito settore a Nord dei blocchi ven-
Il KL Buchenwald
a) Breve storia del Lager
Lucio Monaco Il KL Buchenwald, situato nella Germania centrale, in Turingia, a breve distanza da Weimar, fu aperto il 15 luglio 1937, con il nome di KL Ettersberg, mutato in KL Buchenwald (bosco dei faggi) alla fine dello stesso mese. Un fianco della collina di Ettersberg venne disboscato dai primi 150 prigionieri, in maggioranza detenuti comuni, provenienti dal KL Sachsenhausen (sorto un anno prima). Altri deportati, in genere politici, furono trasferiti poco dopo dal KL Lichtenburg. I lavori di costruzione durarono fino al 1939, culminando nelledificazione del crematorio (inverno 1939-40). Larea recintata da pi di tre chilometri di filo spinato misurava 40 ettari. Concepito per una capienza massima di 6.000 prigionieri, il Lager ne contava 7.723 gi nellestate 1938 (tutti maschi; solo nellestate 1944 affluirono donne deportate). La cate-
Cfr. la guida Lo sfruttamento economico dei prigionieri, nota 1, p. 38.
Le guide della memoria
71
ne poi ulteriormente recintato e adibito a campo di quarantena. In questarea, chiamata Piccolo campo (Kleines Lager), venivano anche confinati gli inabili per morirvi dinedia e di mancanza di cure (vi per fra gli altri il sociologo francese Maurice Halbwachs). Il KL sub una crescita esponenziale nel numero dei prigionieri, passando dalle 8-9.000 presenze del 1941 e 1942 alle oltre 37.000 del dicembre 1943. Furono progressivamente aperti oltre cento sottocampi (Lager dipendenti, Nebenlager), di cui alcuni confluirono nel KZ principale di Mittelbau-Dora. Lavorarono e morirono nei 129 sottocampi e nel complesso di Dora prigionieri di ogni nazionalit: fra gli italiani, molti rifugiati in Francia, deportati fra il 1942 e il 1943; militari italiani, giunti alla fine del 1943; e politici italiani soprattutto dalla Venezia Giulia nel 1944. Le prime donne deportate iniziarono ad affluire nellestate 1944: costituiranno un terzo delle presenze, su un totale, per quellanno, di oltre 60.000 deportati (solo met detenuti nel Lager principale). Il culmine del processo di sovrappopolazione del Lager si ebbe tra le due prime settimane di gennaio 1945. Lappello del 1 gennaio, infatti, registr 63.189 prigionieri maschi e 24.210 femmine; il 15, erano diventati rispettivamente 83.906 e 26.650. Su Buchenwald venivano fatti confluire i prigionieri evacuati dai Lager orientali; a sua volta la direzione del KL cerc di alleggerire questa pressione demografica insostenibile con trasporti successivi verso altri Lager (Mauthausen, Bergen Belsen). La liberazione del KL Buchenwald legata alla storia delle organizzazioni clandestine di Resistenza sviluppate gi a partire dalla fine del 1938, quando i politici tedeschi e austriaci (caratterizzati dal triangolo rosso) prendono il controllo delle posizioni prima riservate ai delinquenti comu-
ni (triangolo verde). Quando giunsero deportati di altre nazionalit prese forma lILK (Internationale Lager Komitee, presieduto dal comunista tedesco Walter Bartel, luglio 1943) che diede vita nel 1944 allIMO (Internationale Militrische Organisation), che arriv a raccogliere oltre 900 membri, di dodici nazionalit. Tale rete organizzativa, in cui confluiva anche il Comitato italiano di Solidariet coordinato da Fausto Pecorari e da Ferdinando Zidar, riusc a impedire la realizzazione del piano nazista di evacuazione, di liquidazione del campo e di uccisioni mirate di prigionieri. L11 aprile lIMO guid la rivolta che port alla liberazione del campo prima dellingresso dellesercito USA (13 aprile). Un calcolo approssimato per difetto assomma a 240.000 il totale dei deportati a Buchenwald (Lager centrale e sottocampi); di questi risultano deceduti circa 56.000 prigionieri (con un tasso di mortalit oscillante intorno al 25%. Gli italiani furono una minoranza piccola ma attiva: circa 2.500-3.000 persone, di cui, nei giorni della liberazione, 178 erano presenti nel Lager centrale. Su 2.471 nominativi sicuramente rintracciati, il totale degli italiani deceduti di 995 persone. Salvo poche eccezioni, la quasi totalit fu deportata dallarea triestina.
Monumento alle vittime di Buchenwald (febbraio 2002)
72
Capitolo II
b) Aspetti della storia del KL Buchenwald attraverso la memoria dei testimoni
Marcella Pepe Il nome Buchenwald fu dato al campo da Heinrich Himmler il 28 luglio 1937. I comandanti furono Karl Otto Koch, dal luglio 1937 al settembre 1941, e Hermann Pister, dal settembre 1941 al 1945. Si pensava che quello fosse il peggiore campo di concentramento che potesse esistere, perch Buchenwald era immenso [], un mondo furiosamente eretto contro i vivi, tranquillo invece e indifferente di fronte alla morte.2 Al campo si accedeva attraverso un grande viale asfaltato, fiancheggiato da imponenti colonne di pietra sormontate dalle aquile del Reich: Di qui i Kommando partivano per il lavoro, nella luce grigia o dorata dellalba, oppure, dinverno, alla luce dei riflettori, al suono allegro delle marce suonate dallorchestra del campo. [] Partenza in musica, verso il lavoro quotidiano, verso le fabbriche Gustloff, i Deutsche AusrstungsWerke, abbreviato, DAW, la Mibau, tutto quel rosario di fabbriche di guerra intorno al campo.3 Il viale terminava con un cancello sul quale campeggiava la scritta in grandi lettere di ferro battuto JEDEM DAS SEINE (A ciascuno il suo). Allinterno del recinto di Buchenwald cerano il campo grande, dove alloggiavano i detenuti dopo limmatricolazione; e il Piccolo campo o campo di quarantena o campo tenda, costruito nel 1939 per ospitare i
2 3
prigionieri provenienti dalla Polonia. Inoltre cerano il complesso degli edifici dellamministrazione, le baracche delle SS, le fabbriche del campo e il camino del forno crematorio, dal quale usciva in permanenza il fumo nero dei cadaveri bruciati. Al centro, limmenso rettangolo della piazza dellappello e, intorno, il filo spinato percorso da corrente elettrica ad alta tensione. Allesterno del campo cerano le baracche, dette villette, degli ospiti speciali, tra cui lex Presidente del Consiglio francese Lon Blum e la Principessa Mafalda di Savoia. Oggi la struttura del campo pressoch intatta. Sono ancora visibili il perimetro di filo spinato, gli uffici del comando, la piazza dellappello. Le aree dove sorgevano le baracche (distrutte nel dopoguerra per motivi igienici) sono indicate da varie superfici di pietrisco. Un museo illustra la vita del campo e i suoi orrori. Levacuazione e la liberazione Negli ultimi mesi di guerra Buchenwald era sovraffollato a causa dei trasporti provenienti da altri campi, ma ormai il cerchio intorno alla Germania si stringeva sempre pi e il 5 aprile 1945, di fronte allincalzare delle truppe alleate, le SS cominciarono a evacuare il campo principale e i campi satelliti. Dei 28.250 prigionieri evacuati dal campo principale, circa 13.500 furono uccisi o morirono di stenti e di fatica nel corso dellevacuazione. Il numero complessivo di prigionieri di Buchenwald e dei campi satelliti che furono vittime dellevacuazione stimato in 25.500. Ma i nazisti non riuscirono a completare loperazione perch i membri della Resistenza clandestina, sabotando gli ordini delle SS, ne rallentarono lo svolgimento. E l11 aprile 1945, mentre molti uomini della SS si davano alla fuga, ordinarono linsurrezione e presero il controllo del campo senza attendere larrivo dellesercito americano, liberando 21.000 prigio-
R. Antelme, La specie umana, trad. it. di G. Vittorini, Torino, Einaudi, 1969, 19972, p. 15. J. Semprn, Il grande viaggio, trad. it. di G. Zannino Angiolillo, Torino, Einaudi, pp. 152, 218.
Le guide della memoria
73
nieri, tra cui 4.000 ebrei inclusi circa 1.000 bambini. Gli anglomericani arrivarono il 13 aprile 1945. La Resistenza Gruppi di prigionieri organizzati erano presenti a Buchenwald fin dai primi anni della sua esistenza: ne facevano parte militanti e dirigenti del Partito Comunista tedesco. Allinizio, il loro scopo fu quello di collocare i loro membri in posti strategici per rendersi utili agli altri detenuti e aiutare i pi deboli; infatti, sino alla fine del 1938, lamministrazione interna di Buchenwald era per la maggior parte in mano ai prigionieri criminali, contrassegnati dal triangolo verde, il cui potere si esprimeva soprattutto in delazioni e in violenze nei confronti dei prigionieri a loro affidati. Quando si scopr che i triangoli verdi, insieme ad alcune SS, erano coinvolti in episodi di corruzione e in furti, lamministrazione del campo provvide a rimuovere molti di loro dai posti che occupavano e gradualmente i politici, i triangoli rossi, li sostituirono. Qualche cellula di Resistenza si preoccup altres di collocare alcuni dei suoi componenti in posizioni-chiave al fine di facilitare lattivit clandestina. Pi tardi, dopo linizio della guerra e laffluenza a Buchenwald di prigionieri politici provenienti dai Paesi occupati, si formarono pi gruppi di Resistenza sulla base della nazionalit. E a partire dallestate del 1942 si costitu un Comitato Clandestino Internazionale che riusc addirittura a creare una propria organizzazione militare: grazie al coraggioso contributo di deportati che lavoravano nelle officine e nelle fabbriche per la produzione bellica situate nei dintorni del campo, fu possibile compiere azioni di sabotaggio e trafugare parti di armi, riassemblate poi di nascosto in attesa delloccasione per usarle. Loccasione si present nei primi giorni dellaprile 1945, quando i tedeschi decisero levacuazione di Buchenwald: l11 aprile il Comitato Clan4
destino Internazionale si mise in contatto con le truppe americane, tramite unemittente costruita in segreto per chiedere aiuto, e nello stesso tempo ordin linsurrezione generale. Quando, il 13 aprile, gli Alleati giunsero a Buchenwald, il campo era gi stato liberato dagli stessi deportati ed era diretto dal Comitato Clandestino Internazionale. Leggiamo le testimonianze di Pio Bigo e di Elie Wiesel sugli avvenimenti del giorno della liberazione. Il giorno 11 aprile eravamo tutti nel campo, chi in baracca, chi nel via vai delle stradine del Lager. Il rumore delle cannonate era molto forte, a pochi chilometri. Verso le ore 10,30 lo ricordo come fosse ora le sirene suonarono lallarme, mentre due apparecchi sorvolavano il campo a bassa quota. Io e altri compagni che eravamo fuori, storditi dalle sirene, guardammo gli aerei, credendo che fossero i tedeschi venuti per distruggere noi e il Lager. Dopo un istante i velivoli ritornano per un secondo giro: noi li guardiamo e vediamo sui fianchi la stella bianca. In molti avevamo capito quel simbolo, ci siamo messi a gridare Sono loro, gli americani! Fecero diversi giri a bassa quota quasi sfiorando le garitte di guardia delle SS. L11 aprile 1945, di primo mattino, il comandante del campo aveva ricevuto una telefonata dal comando SS di Weimar (che dista nove chilometri da Buchenwald) con lordine di sterminare i prigionieri e di bruciare tutto. Il prigioniero spagnolo che era addetto come scrivano, conoscendo perfettamente il tedesco, e in contatto con lorganizzazione segreta del comitato di liberazione, avvis subito i responsabili. Poco dopo part linsurrezione dei prigionieri, a cui partecipai con Prato e Fioris. Nel pomeriggio i componenti del Comitato ci riferirono tutto quello che ho appena spiegato.4
P. Bigo, Il triangolo di Gliwice. Memoria di sette Lager, Alessandria, Edizioni dellOrso, 1998, p. 119.
74
Capitolo II
Alle dieci del mattino le SS si sparpagliarono per il campo e si misero a spingere le ultime vittime verso il piazzale dellappello. Il movimento di resistenza decise allora di entrare in azione. Uomini armati sorsero allimprovviso un po dappertutto. Raffiche, scoppi di bombe a mano. Noi ragazzi restammo sdraiati per terra nel blocco. La battaglia non dur a lungo. Verso mezzogiorno tutto era ritornato calmo; le SS erano fuggite e i resistenti avevano preso la direzione del campo. Verso le sei del pomeriggio il primo carro armato americano si present alle porte di Buchenwald.5 Esperimenti medici e crudelt Anche a Buchenwald, come in altri Lager, cera una baracca, il Block 50, dove i medici nazisti facevano esperimenti su cavie umane (inoculazione di tifo petecchiale, di colera, di difterite, di sostanze venefiche, di plasma sanguigno non fresco). Il nome di Ilse Koch tristemente famoso tra quelli dei tedeschi che hanno commesso atrocit. Ilse Koch era la moglie del comandante del campo di Buchenwald. Dopo la guerra sub due processi, uno davanti a una corte internazionale e uno nel suo Paese, in cui fu accusata di crudelt ai danni dei deportati, incluso lassassinio, ma ci per cui tutti la ricordano la sua passione per gli ornamenti in pelle umana, in particolare per i paralumi. Lasciamo la parola ai testimoni. Il socialista Bonino [] ci rifer una cosa che mi rimasta impressa a distanza di anni ed sempre presente in me come un ricordo allucinante: Ilse Koch, moglie del comandante SS del campo, amava gli abatjour costruiti con la pelle umana dei prigionieri che portavano bei tatuaggi sul corpo. La pelle veniva recuperata dai cadaveri nei
5 6 7
crematori; quando gli addetti si accorgevano di un bel tatuaggio, avvisavano gli esperti, che provvedevano alla concia per ricavarne paralumi. Anche le teste dei prigionieri che sembravano interessanti venivano vuotate e imbalsamate []. In certe occasioni, se i prigionieri con i tatuaggi erano vivi, venivano immediatamente uccisi, per poi inviare la pelle alla concia.6 Quegli occhi chiari di Ilse Koch posati sul petto nudo, sulle braccia nude del deportato che si era scelto come amante, qualche ora prima, mentre il suo sguardo gi ritagliava la pelle bianca e malsana secondo il punteggiamento del tatuaggio che laveva attirata, mentre il suo sguardo gi immaginava il belleffetto di quelle linee azzurrastre, di quei fiori o quei velieri, quei serpenti, quelle alghe marine, quelle lunghe capigliature femminili, quelle rose dei venti, quelle onde marine, e quei velieri, di nuovo quei velieri distesi come gabbiani squittenti, il loro belleffetto sulla pelle pergamenata, cui qualche trattamento chimico dava una tinta davorio, dei paralumi che schermavano tutte le lampade del suo salotto, dove, a sera, proprio l dove aveva fatto entrare, sorridente, il deportato scelto come strumento di piacere, duplice strumento, nellatto stesso del piacere, prima, e poi per il piacere ben pi durevole della sua pelle pergamenata, trattata a dovere, davorio, zebrata dalle linee azzurrastre del tatuaggio che dava al paralume un tono inconfondibile, proprio l, sdraiata su un divano, radunava gli ufficiali delle Waffen-SS, intorno a suo marito, comandante del campo, per ascoltare uno di loro che suonava al piano qualche romanza, oppure un vero pezzo per pianoforte, qualcosa di serio, un concerto di Beethoven, chiss7
E. Wiesel, La notte, trad. it. di D. Vogelmann, Firenze, Giuntina, 1980, pp. 111-112. P. Bigo, op. cit., p. 113. J. Semprn, op. cit., p. 140.
Le guide della memoria
75
Gli ebrei a Buchenwald I primi ebrei tedeschi arrivarono a Buchenwald nella primavera del 1938; a loro si aggiunsero, il 23 settembre 1938, gli ebrei provenienti dallAustria e i 10.000 arrestati dopo la notte dei cristalli (9-10 novembre 1938). Il trattamento riservato agli ebrei fu, anche in questa prima fase, particolarmente crudele: lavoravano 14-15 ore al giorno, generalmente nella cava di Buchenwald, e vivevano in condizioni molto dure. Tuttavia, lobiettivo iniziale dei nazisti non era sterminarli, ma costringerli a emigrare dalla Germania. Cos, nellinverno 1938-39, furono rimessi in libert 9.370 ebrei, anche se morirono ben 600 prigionieri della notte dei cristalli. Dopo lo scoppio della guerra il numero dei deportati ebrei nel campo sal di nuovo: gi nel settembre 1939 erano circa 2.700. Poi, in seguito allordinanza emessa il 17 ottobre 1942 che prevedeva il trasferimento ad Auschwitz di tutti gli ebrei detenuti nel Reich, gli ebrei di Buchenwald tranne 204 lavoratori ritenuti essenziali furono mandati in quel Lager. Solo nel 1944 giunsero a Buchenwald trasporti di ebrei ungheresi provenienti da Auschwitz e, dopo una breve permanenza nel campo principale, la maggior parte di loro fu distribuita in vari campi satelliti e adibita alla produzione di armi. A cominciare per dal 18 gennaio 1945, quando Auschwitz e gli altri campi dellEst furono evacuati, affluirono a Buchenwald migliaia di prigionieri ebrei, sopravvissuti a una estenuante marcia della morte nella neve, durata diversi giorni e compiuta in parte a piedi in parte in carri bestiame. Fra gli evacuati cerano parecchie centinaia di bambini, che vennero alloggiati nel Block 66, eretto appositamente per loro nel Piccolo campo. Leggiamo una pagina particolarmente toccante di Jorge Semprn sullatroce morte di alcuni bambini ebrei. Era lultimo inverno di quella guerra, linverno pi freddo di quella guerra la cui conclusione stata decisa dal freddo e dal-
la neve. I tedeschi erano investiti da una grande offensiva sovietica che si rovesciava attraverso la Polonia, e facevano evacuare, quando ne avevano il tempo, i deportati che avevano radunato nei campi polacchi. [] Un giorno, in uno di quei vagoni in cui cerano alcuni sopravvissuti, quando hanno spostato il mucchio di cadaveri gelati, spesso incollati gli uni agli altri per via dei vestiti gelati e rigidi, hanno scoperto tutto un gruppo di bambini ebrei, [] circa una quindicina, che si guardavano intorno con aria stupita, che guardavano i cadaveri ammucchiati come sul ciglio delle strade sono ammucchiati a volte i tronchi dalberi gi privi di corteccia, che aspettavano di esser trasportati altrove, che guardavano gli alberi e la neve sugli alberi, che guardavano come guardano i bambini. E le SS, dapprima, sono parse seccate, come se non sapessero che farsene di quei bambini dagli otto ai dodici anni, su per gi, bench alcuni, per lestrema magrezza, per lespressione dello sguardo, sembrassero dei vecchi; [] li hanno radunati in un angolo, forse per avere il tempo di chiedere istruzioni, mentre scortavano sul grande viale le poche decine di adulti sopravvissuti di quel convoglio. [] Comunque, sono tornati in forze, con dei cani, e ridevano rumorosamente, gridavano spiritosaggini che li facevano ridere a pi non posso. Si sono disposti ad arco ed hanno spinto davanti a s, sul grande viale, quella quindicina di bambini ebrei. Mi ricordo, i ragazzini si guardavano intorno, guardavano le SS, allinizio devono aver creduto che li scortassero semplicemente verso il campo, come poco prima avevano visto fare con gli adulti. Ma le SS hanno mollato i cani e hanno incominciato a picchiare i bambini con le mazze, per farli correre, per mettere in moto quella caccia spietata sul grande viale, quella caccia inventata da loro, o che era stato ordinato loro di organizzare, e i bambini ebrei, sotto i colpi dei randelli, tirati e malmenati dai cani che saltavano in-
76
Capitolo II
torno a loro, che li mordevano alle gambe, senza abbaiare, senza mugolare, erano cani addestrati, i bambini ebrei si sono messi a correre sul grande viale, verso la porta del campo. Forse in quel momento non avevano ancora capito che cosa li attendeva, forse avevano pensato che era solo unultima angheria, prima di farli entrare al campo. E i bambini correvano, con i loro grandi berretti con lunghe visiere, infilati fino alle orecchie, e le loro gambe si muovevano goffamente, a scatti e lentamente nello stesso tempo, come al cinema quando proiettano un vecchio film muto, come negli incubi quando si corre con tutte le proprie forze senza riuscire ad avanzare di un passo, e la cosa che vi insegue vi raggiunger, vi raggiunge e voi vi svegliate col sudor freddo, e la cosa, la muta di cani e di SS che correva dietro ai bambini ebrei, ebbe presto inghiottito i pi deboli, quelli che avevano solo otto anni, forse, quelli che presto non ebbero pi la forza di muoversi, che erano rovesciati, calpestati, randellati per terra, e che restavano distesi lungo il viale, segnando coi loro corpi magri, scomposti, la progressione di quella caccia, di quella muta che si rovesciava loro addosso. E presto non ne rimasero che due, uno grande e uno piccolo, che avevano perso i berretti nella corsa disperata, e i loro occhi brillavano come scoppi di ghiaccio nei visi grigi, e il pi piccolo cominciava a perdere terreno, le SS urlavano dietro di loro, e anche i cani hanno cominciato a urlare, lodore del sangue li faceva impazzire, e allora il pi grande dei bambini ha rallentato la corsa per prendere la mano del pi piccolo, che gi inciampava, e hanno fatto ancora qualche metro, insieme, il maggiore che con la destra stringeva la sinistra del pi piccolo, diritto davanti a loro, fino al momento in cui i randelli li han8 9
no abbattuti, insieme, con la faccia contro la terra, le mani strette per sempre. Le SS hanno radunato i cani, che ringhiavano, e hanno rifatto la strada in senso inverso, sparando a bruciapelo alla testa di ognuno dei bambini caduti nel grande viale, sotto lo sguardo vuoto delle aquile hitleriane.8 Elie Wiesel, che allepoca della sua detenzione a Buchenwald aveva quindici anni, racconta ne La notte la storia della sua deportazione dalla piccola citt di Sighet, in Transilvania, ad Auschwitz e Buchenwald. Cos descrive larrivo del suo convoglio a Buchenwald: Era notte fonda. Dei guardiani vennero a scaricarci. I morti furono abbandonati nei vagoni. Soltanto coloro che potevano ancora tenersi sulle gambe furono fatti scendere. [] Lultimo giorno era stato il pi micidiale: eravamo saliti in cento in quel vagone e scendemmo in dodici, fra cui io e mio padre. Eravamo arrivati a Buchenwald. Sulla porta del campo alcuni ufficiali delle SS ci aspettavano. Ci contarono, e poi fummo condotti verso il piazzale dellappello. Gli ordini venivano dati dagli altoparlanti: In file di cinque. In gruppi di cento. Cinque passi avanti.. Io stringevo forte la mano di mio padre. Il vecchio e familiare timore: non perderlo. Accanto a noi si alzava lalto camino del forno crematorio, ma non cimpressionava pi; era molto se attirava la nostra attenzione.9
Bibliografia (a cura di Lucio Monaco) Un quadro dinsieme della storia di Buchenwald si pu ricavare dal resoconto analitico di A. Berti, Viaggio nel pianeta nazista. Trieste-BuchenwaldLangenstein, Milano, FrancoAngeli, 1989, pp. 61-92. Le memorie europee di superstiti di Buchenwald annoverano alcuni dei libri di deportazione pi noti per la qualit e la complessit dellelaborazione let-
Ibidem, pp. 154-157. E. Wiesel, op. cit., pp. 101-102.
Le guide della memoria
77
teraria, ma anche i primi saggi, stesi sempre da superstiti, che indagano la struttura e i meccanismi totalitari delluniverso concentrazionario. Proprio questo infatti il titolo del breve scritto di David ditions De Rousset, Lunivers concentrationnaire, Paris, E Minuit, 1946; Luniverso concentrazionario, trad. it. di L. Lamberti, Milano, Baldini & Castoldi, 1997. A Buchenwald, per incarico della Psychological Warfare Division, aggregata alle truppe americane, un ex prigioniero austriaco, Eugen Kogon, stese un rapporto di un centinaio di fogli dattiloscritti accompagnato da oltre cento testimonianze dirette di superstiti. Da tale materiale scatur lopera di Eugen Kogon, Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager, Mnchen, Alber, 1946 / Dsseldorf, Schwann, 1946, ampliata negli anni successivi (lultima edizione del 1974, pubblicata dalla casa editrice Kindler di Monaco) e tradotta in francese (si veda LEtat SS, Paris, Seuil, 1970). Limportanza di questo studio, che coordina lesperienza diretta dellautore con molte informazioni sullintero sistema, notevole. Fra i testi che rielaborano la testimonianza utilizzando gli strumenti della letteratura si segnalano: R. Antelme, La specie umana, trad. it. di G. Vittorini, Torino, Einaudi, 1969, 19972, uscito nel 1947, che rievoca soprattutto lesperienza dellautore nel sottocampo di Gandersheim; D. Rousset, Les jours de notre mort, Paris, Hachette, 1993, complesso romanzo a base autobiografica che illustra con efficacia i problemi politici ed etici del progetto di organizzazione di un movimento clandestino di resistenza allinterno del Lager; J. Semprn, Il grande viaggio, trad. it. di G. Zannino Angiolillo, Torino, Einaudi, 1964, 19902, narrazione autobiografica di eccezionale valore letterario in cui, assumendo come luogo fondamentale il vagone piombato che lo trasport dalla Francia a Buchenwald, lautore ricostruisce, con flash-back e flash-forward, la propria vicenda di esilio, resistenza e deportazione; E. Wiechert, La selva dei morti. Una cronaca, trad. it. di L. Mazzucchetti, Verona, Mondadori (Arianna), 1947, un volumetto di notevole qualit narrativa, in cui la testimonianza di una pur breve prigionia nel campo raggiunge la tensione etica di certe pagine di Primo Levi. Tra i libri di testimoni che arrivarono a Buchenwald in seguito allevacuazione di Auschwitz dopo la massacrante marcia della morte, ricordiamo E. Wiesel, La notte, trad. it. di D. Vogelmann, Firenze, Giuntina, 1980, e P. Bigo, Il triangolo di Gliwice. Memoria di sette Lager, Alessandria, Edizioni dellOrso, 1998. Nellambito della memorialistica italiana, citiamo almeno: Antonino Garufi, Diario di un deportato. Da Dachau a Buchenwald comando Ohrdruf, Palermo, Gelka, 1990; Gianni Longhetto, 43936. Buchenwald gli altri e io, Verona, s. n., [1980?], con una lunga testimonianza sul Piccolo campo; Fausto Pecorari, Vita e morte, a Buchenwald, di S. A. R. la principessa reale Mafalda di Savoia-Hessen, s.l., s. n. (ma Roma, Salomone, [1945?]), breve opuscoletto di 14 pp.
Il campo di concentramento di Dachau (1933-1945)
Lucio Monaco Lapertura del Lager di Dachau (22 marzo 1933) fu annunciata da Heinrich Himmler (capo della polizia politica bavarese oltrech Reichsfhrer della SS) in una conferenza stampa tenuta il giorno prima. Definito il primo campo di concentramento (das erste Konzentrationslager), il campo aveva una capienza prevista di 5.000 prigionieri; la sorveglianza era affidata alle SS. Ai primi politici (in maggioranza comunisti e socialdemocratici tedeschi) si aggiunsero ben presto le altre categorie (asociali, immigrati, ebrei, ecc.). Gi un mese dopo, la magistratura della vicina citt di Monaco cerc di far luce sui primi assassinii: Himmler allora escluse la polizia bavarese dal controllo del campo e nomin comandante lSS Theodor Eicke, che fece di Dachau un vero e proprio laboratorio di sperimentazione del sistema dei KL. Il regolamento di Eicke e tutto linsieme di norme, scritte o meno, per leliminazione e la punizione dei prigionieri, e lo sfruttamento del lavoro (a vantaggio anzitutto delle imprese di propriet SS), costituirono il modello di base per tutti gli altri Lager. Non a caso a Dachau ebbe sede la scuola di addestramento per il personale SS di custodia da impiegare nei KL. Tra il 1937 e il 1938 il campo fu completamente ristrutturato e assunse laspetto che in parte conserva ancora oggi: un rettangolo di circa 600 metri per 300, in cui si entrava da un ingresso con la scritta ARBEIT MACHT FREI (Il lavoro rende liberi). Da un lato si accedeva a una grande costruzione riservata ai servizi e allamministrazione del campo; essa si affacciava sullAppellplatz, della capienza di circa 40.000 persone. Di fronte, in direzione Nord, si apriva una strada (Lagerstrasse) lunga circa 300 metri, bordata di pioppi, ai cui lati erano disposte una trentina di baracche (Blcke), indicate con lettere dellalfabeto e con numerazione da 1 a 30. Misuravano 90 m x 10 ed
78
Capitolo II
erano previste per 200 persone ciascuna. In realt questo numero fu ampiamente superato, con condizioni di sovraffollamento e di malattie tali che dopo la liberazione tutte queste costruzioni vennero bruciate (oggi sono conservati solo i perimetri delle fondamenta). Per far fronte allinnalzarsi del tasso di mortalit, si predisposero impianti di cremazione: dapprima un solo forno crematorio (installato nel 1939), poi un complesso di quattro forni ognuno della capienza di pi corpi (fino a 8). In questi locali avvenivano anche esecuzioni per impiccagione. Soltanto nel 1942 fu progettata e costruita una camera a gas, camuffata da doccia, che per non entr mai in funzione, salvo una prova di collaudo con alcune vittime. Per le eliminazioni di massa, specialmente degli inabili e dei malati, si us il Castello di Hartheim, che disponeva di una camera a gas. La funzione punitiva del campo, caratterizzata da regole spietate (punizioni corporali, mancanza di cibo, palo, impiccagioni e fucilazioni, celle di rigore nel Bunker) e da esecuzioni individuali e di massa, fu affiancata fin dallinizio dal sistema di sfruttamento della forza lavoro costituita dai prigionieri. Anche in questo, Dachau funzion da modello (tanto pi che Eicke nel 1934 divent ispettore generale dei KL). Alcuni detenuti erano impegnati nelle attivit necessarie al funzionamento e alla manutenzione del campo; altri furono trasferiti nelle fabbriche di propriet SS (la prima fu lindustria ceramica di Allach, dove sorse un sottocampo) e, con la progressione del conflitto, furono sempre pi sfruttati nella produzione bellica (BMW, Krauss-Maffei, Messerschmitt), nei sottocampi esterni (Kommandos). Alla fine del conflitto i sottocampi risultavano almeno 165, dislocati in Baviera, nel Wrttenberg e anche in area austriaca. I pi importanti, oltre ad Allach, erano quelli di Augsburg (costruzioni aeronautiche), di Kaufering, di Mhldorf, di Monaco-Riem e di Burgau (Messerschmitt), con migliaia di prigionieri. Al momento della liberazione, su un totale di circa 67.000 prigionieri presenti nel
sistema Dachau, pi della met (35.000) si trovava nei Kommando esterni. Il campo fu la sede di numerosi esperimenti medici e pseudomedici, con la complicit delle industrie farmaceutiche; migliaia di deportati furono vittime di queste pratiche crudeli e spesso inutili (esperimenti sulla malaria, sulla sopravvivenza ad alta quota e a basse temperature, sulla cancrena). Dachau funzion anche da campo di transito (sia per Auschwitz sia per altri KL) e da luogo di custodia per prigionieri speciali (politici di rilievo dei Paesi occupati, come il cancelliere austriaco Schuschnigg o litaliano Sante Garibaldi). I prigionieri in transito (specialmente ebrei e zingari) non sempre erano registrati. Con lavanzata degli eserciti alleati, Dachau divenne (insieme a Bergen Belsen e Mauthausen) uno dei punti darrivo delle marce di evacuazione dai Lager abbandonati o smobilitati dai nazisti: le cosiddette marce della morte. Un esempio: dei 5.000 evacuati da Buchenwald il 9 aprile 1945 ne arrivarono a Dachau il 28 aprile 1.600; gli altri morirono nel tragitto. A loro volta, in aprile, le SS cercarono di svuotare il campo inviando migliaia di prigionieri a Sud o verso Mauthausen; un convoglio di centinaia di ebrei fu abbandonato sulla linea ferroviaria con i portelli dei vagoni bloccati, e si lasciarono morire di fame e sete i prigionieri. Il piano di abbandono del Lager non ebbe successo anche per una serie di interventi dei prigionieri, organizzati in un comitato internazionale: essi riuscirono ad avvertire lesercito americano accelerandone lavanzata, e fu organizzata unazione armata nella stessa Dachau, in cui si sacrificarono deportati austriaci e tedeschi. Le SS abbandonarono il Lager il 27 aprile; la prima jeep americana vi entr due giorni dopo. Nel campo principale si trovavano 32.000 prigionieri: pi di 3.000 morirono nei giorni successivi. A partire dalla fine del 1940, in seguito ad accordi con la Santa Sede, tutti i preti cattolici erano stati concentrati a Dachau (Block 26 e
Le guide della memoria
79
Bibliografia. Per un approfondimento della storia del Lager di Dachau si rimanda alla voce di Frediano Sessi, Dachau, in E. Collotti / R. Sandri / F. Sessi (curr.), Dizionario della Resistenza , Torino, Einaudi, 2001, vol. II (Luoghi, formazioni, protagonisti), pp. 451-454.
Il monumento sul piazzale dellappello di Dachau (aprile 1998)
Block 28: il secondo era riservato ai sacerdoti polacchi; nel primo fu costruita anche una cappella). Nel campo vennero complessivamente imprigionati circa 2.700 religiosi (preti cattolici, pastori protestanti, ortodossi) di cui 700 morirono. Non tutti i preti cattolici vennero portati o trasferiti a Dachau. Ad esempio, per quanto riguarda i religiosi italiani, 32 (su un totale di 50) sono direttamente deportati, o trasferiti entro lestate 1944, a Dachau (ne sopravvivranno 27); i rimanenti, imprigionati in altri Lager, vi rimarranno fino alla morte o alla liberazione (7 superstiti al maggio 1945). I religiosi di tutta Europa deportati nei Lager nazisti sono calcolati in numero di circa 5.000. I rabbini furono tutti inviati ad Auschwitz o negli altri campi di eliminazione immediata (nessun sopravvissuto fra i 16 rabbini e chazanim deportati dallItalia). I primi italiani giunsero a Dachau nel settembre 1943: si trattava di detenuti del penitenziario militare di Peschiera. Una trentina di trasporti, perlopi da Trieste, si susseguirono fino al marzo del 1945: in prevalenza antifascisti, partigiani e rastrellati. Alla liberazione del campo, gli italiani presenti erano 3.388 (su 32.000 prigionieri): poco pi della met di quanti, allo stato attuale dei conti, vi erano stati deportati (5.000). Si calcola che passarono sicuramente da Dachau pi di 200.000 persone, con una mortalit di circa il 30%.
Ebensee, Kommando di Mauthausen
Italo Tibaldi A 100 km da Mauthausen, campo principale, Ebensee un grazioso villaggio austriaco situato a Sud del Lago Traunsee. A Nord del lago si trova la citt turistica di Gmunden, vicino allautostrada Salisburgo-Linz. Il piccolo villaggio di Ebensee ha il suo porticciolo ed circondato da grandi massicci montuosi fra cui lHllen Gebirge (1.862 m) e la stazione sciistica di Feuerkogel. Nellinsieme un piccolo paradiso per le vacanze e il riposo. Ed in questo quadro incantato che, nellinverno 1943-44, fu creato il campo di Ebensee, Kommando di Mauthausen. Il campo funzion, durante circa diciassette mesi, per la costruzione di officine sotterranee finalizzate alla creazione di benzina sintetica e alla produzione di missili. Siniziarono 14 tunnel, divisi in due gruppi di 7. Il lavoro era dei pi difficili: ventiquattro ore su ventiquattro le squadre di uomini lavoravano alla loro perforazione. Lurgenza per lentrata in funzione delle officine e la crescita della mor-
80
Capitolo II
talit con la conseguente sostituzione continua degli uomini deceduti a causa del lavoro, dei colpi, del freddo, della fame e dei trattamenti subiti nel campo hanno inevitabilmente determinato laumento progressivo delle dimensioni del Kommando. Il campo entr in funzione il 24 novembre 1943 con il primo convoglio di 400 detenuti e cess le sue funeste attivit il 6 maggio 1945, data della liberazione, presente, a quel momento, un effettivo di 16.650 uomini. Per Ebensee passarono approssimativamente da 25 a 30.000 prigionieri. Il numero ufficiale dei decessi registrati di 8.749 al 30 aprile 1945, ma in realt fu di quasi il doppio. Tra il 1 e il 6 maggio 1945 morirono pi di 300 detenuti al giorno. Per diversi giorni dopo la liberazione la mortalit era ancora di circa 200 decessi al giorno. Costruzione del campo Il campo fu impiantato a 5 km dal villaggio sul fianco della montagna. Allarrivo del primo convoglio, il campo non esisteva ancora e i deportati dormivano alla stazione merci di Ebensee. Di sera, dopo una giornata di lavoro trascorsa alla preparazione dei tunnel, intraprendevano la costruzione del futuro campo di Ebensee: abbattimento di alberi, livellamento del terreno, edificazione delle prime baracche in legno, dove avrebbero ben presto abitato. In dicembre, gennaio e febbraio, linverno non era ancora rigido, ma pioveva ininterrottamente. Lacqua era fredda: era neve fusa. Eravamo poco vestiti: soltanto una giacca e una camicia. Lacqua, che scorreva sui nostri corpi, ci gelava. Alla fine del mese di gennaio la prima baracca era abitabile. A quellepoca la futura piazza dellappello era ancora in uno stato indescrivibile e, con labbattimento degli alberi, il livellamento con mezzi rudimentali e la pioggia, eravamo in un mare di fango. Dovevamo rimanere per ore in questo pantano durante gli appelli del mattino e della sera. Il campo fu costruito progressivamente: ogni mese due baracche nuove entravano in funzio-
ne. Il risultato finale fu un campo di una trentina di baracche. Nel corso del 1944 furono installati i magazzini di approvvigionamento, le cucine, la baracca per la disinfezione, linfermeria, il forno crematorio. Il campo era cintato con filo spinato elettrificato ad alta tensione. Si costruirono anche, fuori del campo, baracche e villette per lalloggiamento dei nostri guardiani SS. Linsieme rappresentava il campo e i lavori svolti dai prigionieri, oltre quelli fatti nelle officine. Costruzione delle officine sotterranee Il nostro lavoro consisteva, allinizio, nellabbattimento del fianco della montagna per ottenere una superficie ben diritta. su questa facciata che, in seguito, inizieranno gli scavi per le entrate dei tunnel. Al mattino ci alzavamo alle 6 e partivamo alle 6.30, dopo aver bevuto unindefinibile acqua annerita, chiamata caff, e nullaltro. Percorrevamo a piedi il tragitto dal campo al Grande Steinbruch, l dove sarebbero dovuti nascere i primi tunnel. Si trattava di circa 4 km allandata e altrettanti alla sera per il ritorno al campo. Cominciammo lo scavo di 7 tunnel in fila. Nel marzo 1944 si aprirono i cantieri di un nuovo insieme di tunnel, il Piccolo Steinbruch, sito vicino al campo, contro la parete attigua. Eravamo soggetti alle stesse condizioni di lavoro: lunico vantaggio, ed era molto importante, era il non dover percorrere 8 km per andare e ritornare. Inoltre, essere chiamati per il lavoro al Grande Steinbruch era una punizione terribile, poich significava una morte pi rapida. Anche qui furono iniziati 7 tunnel: quindi alla liberazione esistevano complessivamente 14 entrate di tunnel. Dopo le entrate, che formavano delle volte di circa 10 m di larghezza per 4 di altezza, entravamo in vaste sale dalle dimensioni allucinanti, delle vere cattedrali: da 25 a 30 m di larghezza, 160 di lunghezza e 15 di altezza. Gallerie trasversali collegavano i tunnel fra di loro. Al termine dello scavo le sale erano interamente costruite in calcestruzzo. Saranno usate tonnellate di calce. Si ottennero diversi piani. Il pianterreno fu
Le guide della memoria
81
previsto per linstallazione di macchinari vari, il primo piano per gli uffici, i servizi tecnici ecc.; lultimo piano doveva alloggiare i lavoratori delle officine. Costoro non conosceranno pi la civilt esterna, il sole, le stagioni, la vita: la schiavit pi inumana mai esistita fino alla morte. Il lavoro sotto i colpi Nel tunnel la roccia era calcarea e a mano a mano che ci si addentrava nella montagna laria diventava irrespirabile. Le esplosioni nella miniera, i gas che si ammucchiavano, la polvere fine e bianca del calcare che si alzava, facevano s che gli uomini che respiravano questa atmosfera, con i polmoni incrostati, non resistessero a lungo. I Kapo, signori del Kommando, prendevano continuamente a colpi di bastone, di cavo elettrico o a pedate tutti coloro che si trovavano sul loro passaggio per farli lavorare pi velocemente. Ma non dimentichiamo le SS, che sorvegliavano il tutto e facevano accelerare i lavori: l dove servivano tre uomini per spingere un vagoncino, ne toglievano uno, mentre i Kapo picchiavano i due rimanenti affinch riuscissero a spingere. La media del lavoro era di tre mesi continuati, al Grande Steinbruch. In seguito, con i polmoni pieni di calcare, il prigioniero, ormai divenuto scheletrico, aveva dato tutta la sua forza e, non potendo pi continuare, veniva percosso. Allora, non essendo pi in grado di lavorare, era trasportato nelle baracche in cui erano ammassati quelli in attesa della morte. Si aggiunga a tutto ci il clima. Nel marzo 1944, fecero la loro apparizione la neve e il freddo. Durante linverno cadde fino a un metro di neve. La temperatura raggiunse i -20. Ma il disagio pi terribile era il vento che si riversava nella valle. Gli uomini che lavoravano avevano diritto a un paio di mutande, una camicia, una giacca, un paio di pantaloni e, qualcuno, un cappotto e un paio di zoccoli di legno. Con il passare dei mesi e laggravarsi della guerra, gli abiti cominciarono a mancare, e ben presto
quelli che non lavoravano non ebbero pi n giacca n pantaloni n zoccoli. Si comprende allora come, vestiti soltanto con mutande e camicia, moriranno di freddo rimanendo per ore sotto tempeste di neve in attesa degli appelli. Lo spettacolo era indescrivibile. I tunnel sembravano dei formicai. Ogni uomo era occupato sia a portare via le pietre con i vagoncini sia a trasportare legna per erigere le gallerie. Si lavorava di notte e di giorno accompagnati dalle urla dei Kapo, dalle grida dei deportati, dal rumore dei martelli pneumatici. Era infernale: qui, gli uomini rimanevano a terra, colpiti a morte dai Kapo; l, cera un ferito, ferito da una pietra nel tunnel, con la testa fracassata; altrove, un detenuto colto da dissenteria che i compagni portavano via prima che i carnefici lo vedessero. Anche se si aveva un malessere passeggero, non si poteva smettere il lavoro perch, se si veniva scoperti, si era pestati a morte. Ecco linferno dove i deportati lavoravano continuamente, stanchi, nutriti a mezzogiorno con una specie di minestra che, allinizio, era composta di patate e di verdura, ma che nel 1945 consisteva di ortiche e bucce di patata. La cena della sera era ridotta a un pezzo di pane nero e una ciotola con un piccolo quadrato di margarina ogni 4 deportati; in seguito la ciotola era per 8, unicamente per quelli che lavoravano. La vita al campo Il campo, con il passare del tempo, prende landamento di una piccola citt di 400 uomini, poi si passa a 5.000, 10.000 e infine 15.000 uomini. Tutte le nazionalit europee vi sono rappresentate. Il regime interno molto diverso a seconda dei periodi; allinizio dobbiamo sistemare linterno del campo, oltre alla nostra giornata di lavoro, cio abbattere alberi, livellare il terreno, inghiaiare, ecc.; ogni capo baracca comanda ai deportati che vi abitano di effettuare questi compiti. Tra i capi dei blocchi, alcuni sono vecchi criminali o asociali, violenti e cattivi. Colpiscono a morte i deboli. Quando i lavori sono me-
82
Capitolo II
no importanti, vengono allora prolungati gli appelli del mattino e della sera per ore. Avremo appelli che variano da mezzora a 3 e anche 4 ore, sullattenti, al freddo, sotto la neve o la pioggia. Al termine, si rientrer ai blocchi. Ma non potremo fare niente, poich non ne abbiamo il diritto. Dovremo aspettare la distribuzione della minestra che si prolunga per ore, seguendo lumore del capo. In seguito, anzich il riposo tanto atteso, sar il momento del controllo dei pidocchi. Durante interminabili ore ciascuno a turno dovr essere esaminato. Frattanto, si subir il supplizio di 25 colpi sulle reni mentre tutti quelli del blocco dovranno assistere a questo spettacolo. La notte di riposo sar breve nella baracca. Le finestre resteranno aperte, anche quando far molto freddo, e dopo quattro o cinque ore di sonno ci sar il risveglio, che sar diverso a seconda dei capi dei blocchi: alcuni con lacqua e un attizzatoio, altri con forti fischi o manganellate. Dopo la distribuzione del caff, ancora lappello, poi la formazione in comando per andare a lavorare nei diversi luoghi. Ogni tanto, dopo lappello serale, ci riuniscono in semicerchio, le prime file accovacciate, le altre in ginocchio e in piedi; scorgiamo che al centro di questa siepe umana stata eretta una forca. Una SS avanza con il capo blocco, che cinforma che avranno luogo una o pi impiccagioni; il motivo sar sempre lo stesso: tentata evasione. Dovremo assistere allo spettacolo nel pi assoluto silenzio. Nel campo si trovano una prigione, i blocchi destinati agli invalidi, che sono stesi a terra senza coperte, i blocchi di sterminio e, accanto a questi, una camera fredda dove sono deposti i cadaveri prima di essere bruciati nel forno crematorio che abbiamo costruito nellagosto 1944. C anche linfermeria, ma i medici devono curare i feriti e i malati con quelle poche medicine che ricevono, senza contare la mancanza di spazio. incredibile questa sofferenza umana, questi uomini che aspettano la vita o la morte. Abbiamo anche uno stabilimento di disin-
fezione con docce, che per serviranno per uccidere. Nel periodo fra il marzo e laprile 1945 due convogli in evacuazione su Ebensee saranno quasi annientati. Riceveranno una doccia calda e fredda e dovranno aspettare nudi per diverse ore nella tempesta di neve. La mortalit registrata nellaprile 1945 stata ufficialmente di 4.500 morti. Nel 1945 i nostri effettivi aumentano a causa dellevacuazione dei campi che si trovano sui diversi fronti. In quattro mesi si passa da 10.000 a 16.500 deportati. Lalimentazione rimane sempre la stessa e ben presto le razioni diminuiscono. Poco prima della liberazione contiamo i giorni che possiamo resistere perch molto difficile sopravvivere con un nutrimento cos misero. Nellaprile 1945 la mortalit tanto intensa che si devono scavare delle fosse comuni per metterci i cadaveri, visto che il forno crematorio non pu pi bruciarli. Il campo un inferno. La morte l e si avvicina sempre pi a noi. Tutte le mattine, allappello, ci guardiamo e cerchiamo quelli che mancano. Ci osserviamo e cerchiamo di capire chi sar ancora in grado di resistere. Lorganizzazione per la sopravvivenza Solidariet non una parola vana. Si tenta tutto per cercare di aiutare i pi sfavoriti. Alcuni possono procurarsi dei rifornimenti, grazie alla loro particolare situazione di lavoro, e li mettono a disposizione per nutrire altri. Non possiamo soccorrere tutti, ma il poco che riusciamo a raccogliere permette di sostenere il morale della collettivit e non ci sentiamo abbandonati in questa marea umana che si batte per sopravvivere. La solidariet e lamicizia assumono allora tutto il loro valore. Nellaprile 1945 gli uomini sono ridotti a scheletri: sono quasi tutti nudi o mal vestiti. Il 5 maggio avverr il nostro ultimo appello prima della liberazione. Grazie allorganizzazione internazionale clandestina, molto attiva, apprendiamo che le SS hanno deciso il nostro
Le guide della memoria
83
sterminio. Allappello del mattino, prima di raggrupparci sulla piazza, i responsabili internazionali di solidariet ci informano sulla necessit di armarsi di bastoni, martelli, tenaglie, ecc. per battersi, poich meglio battersi liberi che morire rinchiusi in un tunnel la cui entrata stata minata con una locomotiva imbottita di esplosivo. Eravamo stati avvertiti da un soldato della Luftwaffe. In effetti, a quellepoca, lesercito tedesco aveva sostituito una parte delle SS. Allordine di andare al tunnel, un NO! unanime fu pronunciato da tutti i deportati. Per la prima volta vedemmo i capi SS andarsene senza infierire. Rimanemmo per tutto il giorno liberi nel campo e, allindomani, 6 maggio 1945, nel pomeriggio, avvenne la liberazione del campo con lentrata di due carri americani. Eravamo liberi e stava per cominciare unaltra vita; ma a Ebensee molti non conosceranno questa gioia, perch la mortalit stata grande. Ecco, in poche parole, una memoria di Ebensee. Vico Canavese, 17.2.2000 Italo Tibaldi Torino Porta Nuova, 13.1.1944 Mauthausen, 14.1.1944 (42307) Ebensee, 28.1.1944-6.5.1945 Torino, 15.7.1945
Italo Tibaldi, autore di studi e ricerche archivistiche e documentarie sui convogli di deportati partiti dallItalia, curatore di ANED-ricerche, ha pubblicato fra laltro il volume Compagni di viaggio. DallItalia ai Lager nazisti. I trasporti dei deportati 1943-1945, Milano, FrancoAngeli, 1994; deportato a Mauthausen ed Ebensee, Vicepresidente del Comitato Internazionale di Mauthausen e svolge la sua attivit di ricerca in ambito internazionale. Bibliografia. Per la storia di Ebensee fondamentale il saggio di Florian Freund, KZ Zement Ebensee. Il campo di concentramento di Ebensee, commando di Mauthausen, e lindustria missilistica, trad. it. di E. Caserio, Burolo, ANED / LArtigiana, 1990. Un testo di memoria costituito principalmente da disegni il libro di Giovanni Baima Besquet, Deportati a Mauthausen 1943-1945, Torino, Teca, 1946 / Torino, Assessorato alla Cultura della Provincia di Torino, 1979.
Il Durchgangslager di Fossoli di Carpi. Cronologia
Lucio Monaco 30 maggio 1942: requisizione di terreni agricoli e istituzione del Campo per prigionieri di guerra n. 73. Vi sono destinati prigionieri britannici e del Commonwealth; luglio 1942: vengono internati i primi 1.800 prigionieri, distribuiti in 191 tende. Si fabbricano anche baracche in muratura, destinate a sostituirle, e nel giro di un anno larea si presenta divisa in due zone: il campo originario, o Campo vecchio, e il suo ampliamento, o Campo nuovo, separato da un canale; 8 settembre 1943: le truppe tedesche occupano il campo arrestando e internando in Germania i militari italiani e i prigionieri; 14 novembre 1943: nella Carta di Verona (atto costitutivo della Repubblica Sociale Italiana, o Repubblica di Sal) si dichiara che gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri, durante questa guerra appartengono a nazionalit nemica; 30 novembre 1943: ordinanza di polizia n. 5 del Ministero degli Interni della RSI: Tutti gli ebrei [] residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento; 10 dicembre 1943: una ordinanza del Capo della polizia prescrive che si faccia eccezione per i malati gravi et vecchi oltre anni 70; sono per ora esclusi i misti e le famiglie miste salvo adeguate misure di vigilanza. Tuttavia nellottobre 1944 il Ministro degli Interni dispone che siano inviati in campo di concentramento anche coloro che pur essendo di origine mista sono stati per considerati appartenenti alla razza ebraica. Queste direttive si sovrapponevano alle operazioni di attuazione della soluzione finale verso gli ebrei italiani da parte dei nazisti in territorio italiano, a partire dalla fine di settembre 1943 (deportazione degli ebrei romani: 16 ottobre 1943; deportazio-
84
Capitolo II
ni degli ebrei di Firenze, Siena, Bologna, Montecatini, Torino, Genova, Milano: novembredicembre 1943); sono cos predisposti dalle autorit di Sal campi di concentramento provinciali, affidati alle prefetture e diretti da funzionari di Pubblica Sicurezza o dai podest; 5 dicembre 1943: apertura ufficiale del Campo concentramento ebrei di Fossoli dove le autorit italiane prevedono di far affluire tutti gli ebrei internati nei campi di concentramento provinciali (oltre ai nuovi arrestati). Il campo gestito, con diverse competenze, dalla Prefettura e dalla Questura di Modena, e dal Podest di Carpi; larea su cui sorge il campo quella del cosiddetto Campo nuovo, facente parte del dismesso Campo per prigionieri di guerra n. 73. Era di fatto impossibile, per le ridotte dimensioni (capaci di ospitare circa 3.000 persone) internarvi tutti gli ebrei presenti in Italia (circa 35.000); a fine dicembre risultavano gi internati circa 900 ebrei; gennaio 1944: i nazisti aprono a Verona un Ufficio antiebraico della Gestapo (IV B4) con a capo Friedrich Bosshammer, funzionario dellufficio di Eichmann. Fossoli individuata come campo di transito per concentrare e poi avviare gli ebrei verso Auschwitz. Il passaggio del controllo del campo ai tedeschi avviene gradualmente tra febbraio e marzo; febbraio 1944: primi trasporti da Fossoli per Bergen Belsen, 146 persone, ebrei libici di nazionalit inglese (19,2%), e per Auschwitz, circa 650 persone, ebrei italiani (22,2%: il trasporto di Primo Levi); 15 marzo 1944: passaggio dei poteri e spartizione del campo. Larea del Campo vecchio affidata ad autorit italiane (RSI), che vi custodiscono prigionieri politici ed ebrei non destinati alla deportazione; larea del Campo nuovo gestita dai nazisti che vi custodiscono, in due aree definite, prigionieri politici ed ebrei, entrambi destinati alla deportazione. Comandanti del campo tedesco sono nominate le SS Karl Titho e Hans Haage;
5 aprile 1944: secondo trasporto per Auschwitz, circa 600-800 persone, ebrei italiani (il convoglio di Giuliana Tedeschi); 16 maggio 1944: terzo trasporto per Auschwitz, circa 600 persone, ebrei in maggioranza italiani. Secondo trasporto per Bergen Belsen, 167 persone, ebrei libici in prevalenza di cittadinanza britannica; 21 giugno 1944: primo trasporto per Mauthausen, circa 500 persone, politici italiani; 22 giugno 1944: uccisione dellantifascista Poldo Gasparotto, esponente del Partito dAzione; 26 giugno 1944: quarto trasporto per Auschwitz, circa 600 persone (cui si aggiungono altre centinaia, fino a un totale di circa 1.000, caricate a Verona); luglio 1944: i tedeschi occupano il Campo vecchio e ne assumono il controllo. I prigionieri sono inviati in Germania come lavoratori volontari, oppure rilasciati; inizia il trasferimento di prigionieri e delle strutture del Campo nuovo nel Durchgangslager di Bolzano-Gries; 12 luglio 1944: fucilazione, al poligono di Cibeno (presso Fossoli), di 67 prigionieri, partigiani e antifascisti (due riescono a salvarsi; un altro condannato, Teresio Olivelli, esponente dellAzione Cattolica, scampa alla morte nascondendosi allappello: sar poi scoperto e deportato a Bolzano e a Flossenbrg, dove morir); 1 agosto 1944: svuotamento del Campo nuovo e ultimo trasporto per Auschwitz, almeno 300-500 persone, ebrei italiani. Il pi giovane: Umberto Nacamulli, nato a Venezia il 27.4.1944. La pi anziana: Natalie Camerini, nata a Trieste il 21.12.1852. Altri deportati furono inviati a Bergen Belsen, Buchenwald, Ravensbrck; agosto-novembre 1944: larea del campo rimane sotto il controllo di militari tedeschi, mentre vi transitano i lavoratori volontari reclutati in prevalenza con rastrellamenti, da inviare in Germania; autunno 1945: nel Campo nuovo attivato
Le guide della memoria
85
il Centro di raccolta dei profughi stranieri in attesa di smistamento; maggio 1947-giugno 1952: insediamento dellOpera Piccoli Apostoli e fondazione di Nomadelfia, una comunit di bambini orfani o abbandonati fondata da don Zeno Saltini (oggi attiva presso Grosseto); 1952-1965 ca.: insediamento del Villaggio San Marco, per profughi giuliani e dalmati; 1984: cessione dellarea del campo al Comune di Carpi e progettazione di recupero del sito.
Bibliografia . E. Collotti / P. Dogliani (curr.), Arbeit macht frei , catalogo della mostra tenutasi a Carpi nel 1985; il saggio di L. Picciotto Fargion, Il Libro della memoria pi volte citato; L. Klinkhammer, Loccupazione tedesca in Italia 1943-1945, trad. it. di G. Sajia Panzeri, Torino, Bollati Boringhieri, 1994; la ricostruzione spesso citata di Italo Tibaldi, Compagni di viaggio; T. Matta (cur.), Un percorso della memoria. Guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia, Venezia, Electa, 1996; gli studi di Anna M. Ori, La memoria stratificata del campo di Fossoli, in Il presente e la Storia, n. 65 / giugno 2004, pp. 125-178, e Il campo di Fossoli. Da campo di prigionia e deportazione a luogo di memoria 1942-2004, Carpi, APM, 2004.
Gusen I, Gusen II, Gusen III: sottocampi di Mauthausen (1940-1945)
Lucio Monaco I tre sottocampi costruiti intorno al villaggio di Gusen (a 5 km da Mauthausen), denominati Gusen I, Gusen II, Gusen III, hanno costituito una realt a s per quantit di deportati e durezza di condizioni di prigionia e di lavoro. I lavori di costruzione di Gusen I furono avviati nel marzo del 1940; anche in questo campo uno degli obiettivi economici era costituito dallo sfruttamento delle vicine cave di granito. Fin dallinizio il lavoro costitu uno dei mezzi di eliminazione dei prigionieri, in prevalenza polacchi, fra cui molti religiosi, e repubblicani spagnoli deportati dalla Francia. Nel 1941 fu installato il crematorio e si diede inizio alle eliminazioni sistematiche di malati, inabili, portatori sospetti di malattie contagiose, sia al Castello di Hartheim sia nel campo stesso (bagni di acqua gelida, annegamenti anche di massa, iniezioni al cuore, gassazioni su veicolo). Nellarco di tre anni il campo viene a contenere un numero di prigionieri superiore a quello del campo principale di Mauthausen, con larrivo di deportati sovietici, jugoslavi, francesi, italiani e lapertura di altre attivit produttive (Steyr-Daimler-Puch AG) legate alla produzione bellica. Nel marzo del 1944 cominciano i lavori per la costruzione di Gusen II (St. Georgen). I deportati, oltre a costruire il campo, sono impegnati nello scavo di un sistema di gallerie in cui sono collocati impianti per la produzione di armi e parti di aerei (SteyrDaimler, Messerschmitt). In dicembre si d il via allallestimento di Gusen III, destinato alla produzione di laterizi (DEST).1
Cfr. nota 1, p. 38 del presente volume.
Nel campo di Fossoli (novembre 1999)
86
Capitolo II
Furono scavati nella montagna circostante e nei pressi di St. Georgen 7 km di tunnel (larghi da 6 a 8 m, alti da 10 a 15) per ubicarvi la produzione bellica e i macchinari dellIstituto di ricerca della Scuola Superiore Tecnica di Vienna, relativamente alla produzione missilistica (V1 e V2). I lavori furono eseguiti senza badare alla sicurezza degli operai, e provocarono quotidianamente morti e feriti. La ricostruzione delle presenze di prigionieri e della mortalit lascia intravedere le durissime condizioni di vita e di lavoro dei deportati. Secondo gli ultimi dati, su circa 21.000 presenze registrate fra il 1940 e il 1942, si sono avuti almeno 14.000 decessi. Nel 1943, il numero di prigionieri pi alto registrato di 9.000 unit, quello dei morti di 5.225. Nel 1944, si contano rispettivamente 22.000 e 4.700 unit; nel 1945, 15.000 e 8.800. Sono documentate almeno due circostanze in cui si procedette a eliminazioni di massa con il gas Zyklon-B, in baracche adattate per tale operazione: il 2.3.1944 (164 prigionieri di guerra sovietici) e il 22.4.1945 (pi di 800 malati e invalidi). Una terza strage, il 2.3.1942 (300 polacchi e spagnoli malati di tifo), non risulta sufficientemente documentata.
alluniverso chiuso e al labirinto di morte costituiti dal Lager, si trova collocato il forno crematorio.
Bibliografia. Testi e disegni nel Diario di Gusen di A. Carpi (Milano, Garzanti, 1971, 1993); si vedano anche i testi poetici di Q. Osano, Perch ricordare. Ricordi e pensieri di un ex deportato, Alessandria, ANED / Edizioni dellOrso, 1992. Per la memorialistica si ricordano le memorie di F. Malgaroli, Domani chiss. Storia autobiografica 1931-1952, Cuneo, LArciere, 1992, e di F. Maruffi, Codice Sirio. I racconti del Lager, Casale Monferrato, Piemme, 1986 /Carr, Stamperia Ramolfo, 2003; la testimonianza di N. Pia, La storia di Natale. Da soldato in Russia a prigioniero nel Lager, Novi Ligure, Joker, 2003, 20063, e le pagine dedicate a Gusen nel libro gi citato di Pio Bigo, Il triangolo di Gliwice, pp. 27-47.
Il Memoriale di Gusen e la conservazione dellarea Il campo di Gusen I ha subto vicende che ne hanno alterato irrimediabilmente la fisionomia. Alla fine degli anni Cinquanta se n decisa la lottizzazione ed sorta una fitta serie di costruzioni abitative. naturalmente scomparsa la recinzione, sono state eliminate baracche e strutture concentrazionarie. Rimane riconoscibile, per quanto riconvertito in abitazione, ledificio dellingresso e del comando del campo, ben visibile dalla rotabile asfaltata Mauthausen-Gusen. Lassociazione dei superstiti ha acquistato un lotto di terreno e vi ha eretto una struttura commemorativa, opera dellarchitetto Lodovico Barbiano di Belgiojoso, che fu egli stesso prigioniero a Gusen. Allinterno di questo edificio, la cui materia e il cui spazio alludono Lingresso di Gusen I negli anni 40 (in alto) e oggi (in basso)
Le guide della memoria
87
Hartheim e il Programma di Eutanasia (ottobre 1939-agosto 1941)
Lucio Monaco Esercizio di calcolo proposto in un libro scolastico di matematica per il primo ciclo, Germania nazista, a. s. 1935-1936: La costruzione di un manicomio richiede 6 milioni di marchi. Quante nuove abitazioni, al costo di 15.000 marchi, si potrebbero invece costruire con questa somma? Riprendendo ed esasperando concezioni di eugenetica sviluppatesi in Europa e in Germania a partire dal primo decennio del Novecento, il nazismo educ progressivamente allidea di vite inutili (lebensunwerte Leben, vite che non valgono la pena di essere vissute), dannose per molti aspetti da quello economico a quello razziale alla collettivit. Il 1 settembre 1939 sono attribuiti poteri speciali a una commissione che proceder a definire le complicate vie burocratiche con cui sopprimere le vite inutili. Il comitato ha sede a Berlino, in una villa di un quartiere residenziale, al n. 4 della Tiergartenstrasse: da cui il nome in codice T4, che indica il centro organizzativo della Fondazione di utilit pubblica per la cura e il ricovero in istituti, eufemismo per celare il Programma di Eutanasia. Coperto dal segreto di Stato, organizzato minuziosamente, il Programma rivolto alle persone affette da malattie giudicate incurabili, agli individui portatori di handicap, o definiti anormali o asociali, di ogni et e sesso, residenti in Germania e nellAustria occupata, e considerati bocche inutili, vite indegne di essere vissute. Li aspetta una morte misericordiosa. Una complessa rete di collaboratori medici ha lincarico di schedare gli individui da eliminare, ricoverati in cliniche e ospedali pubblici e privati, dividendoli in tre categorie: 1) ricoverati affetti da schizofrenia e sindromi neurologiche;
2) ricoverati da pi di cinque anni; 3) ricoverati nei manicomi criminali, appartenenti alle cosiddette razze inferiori, oppure stranieri, anche se non affetti dalle patologie suindicate. Prelevati dagli ospedali e dagli istituti in cui si trovano, essi vengono condotti nei centri specializzati dipendenti dal T4 e qui soppressi con metodi studiati appositamente. Leliminazione con il gas monossido di carbonio si rivela la pratica pi efficace, anche per lespediente delle finte docce. Il Programma, esteso agli inabili al lavoro (per esempio, ai grandi invalidi tedeschi della prima guerra mondiale e, sembra, ai feriti gravi nella guerra in corso) e alla popolazione dei Paesi orientali conquistati, viene interrotto ufficialmente nellagosto del 1941, soprattutto per lopposizione delle Chiese, luterana e cattolica; ma continuer in altre forme sino alla fine della guerra. I centri T4 furono sei (Grafeneck, Brandenburg, Bernburg, Hartheim, Sonnenstein, Hadamar). Complessivamente si ebbero oltre 70.000 vittime, nel corso dellintera operazione. Il trattamento 14f13 Le strutture del T4 furono utilizzate poi per i prigionieri dei KL malati e/o inabili al lavoro. Commissioni si recavano nei Lager e compilavano liste dei destinati alla soppressione dopo un esame sommario, talvolta raccogliendo adesioni volontarie con la prospettiva di inesistenti campi di riposo. Le vittime del trattamento 14f13 erano portate prevalentemente a Sonnenstein e Hartheim. Da Mauthausen e Gusen sono documentati trasporti di questo tipo per un totale di circa 5.000 vittime; da Dachau furono inviate pi di 3.000 persone; circa 1.400 da Buchenwald e poco pi da Ravensbrck. Il Castello di Hartheim Sorto nel Rinascimento, divenuto poi ricovero per bambini gravemente ammalati, il Castello trasformato nella primavera del 1940 in fabbrica di morte: fino al 1943 vi sono uccise migliaia di persone. Funziona anche
88
Capitolo II
come camera a gas per il Lager di Dachau e per quello di Mauthausen (che pur possiede una sua camera a gas). I prigionieri sono trasportati in autobus che hanno lassoluta precedenza, i cui vetri sono rivestiti da tendine e da uno strato di vernice. Arrivati a Hartheim vengono introdotti nella camera a gas, camuffata da stanza per docce, dopo che sono stati marcati tutti quelli con denti doro; a distruggere i cadaveri provvede il forno crematorio. I centri del Programma di Eutanasia furono gestiti in prevalenza da uomini della SS, che con la fine del T4 si ritroveranno a capo dei grandi campi di sterminio immediato (Bel /z ec, Sobibr, Treblinka) ma anche in altri Lager (la Risiera di San Sabba a Trieste). Essi poterono familiarizzarsi con le tecniche di programmazione e di organizzazione dello sterminio, per imparare a compierlo in modo rapido ed efficiente: i centri furono dunque vere e proprie scuole dello sterminio. Hartheim divent il principale centro di esecuzione del trattamento 14f13. La camera a gas era accessibile dal cortile interno; le bombole di CO si trovavano in un ripostiglio attiguo e il gas era fatto affluire tramite un tubo posto allaltezza del pavimento. La stanza era camuffata da doccia, con finti spruzzatori al soffitto. Fra il dicembre 1944 e il gennaio 1945 limpianto fu smantellato, e a guerra conclusa vi furono alloggiate famiglie. Il Castello fu sede di abitazioni private; soltanto qualche lapide e targa commemorativa e pochi materiali documentari, radunati in una stanza al pianterreno, ricordarono per molto tempo latroce passato. Dal 1999 sono per iniziati i lavori per lallestimento di un Memoriale pi ampio.
Bibliografia. Gordon J. Horwitz, Il Castello, in Idem, Allombra della morte. La vita quotidiana attorno al campo di Mauthausen, trad. it. di G. Genovese, Venezia, Marsilio, 1994, pp. 77-109. Un pi ampio discorso sul T4 si pu trovare in Gitta Sereny, In quelle tenebre, trad. it. di A. Bianchi, Milano, Adelphi, 1975, 19992.
Linz I, Linz II, Linz III: sottocampi di Mauthausen
Lucio Monaco Presso Linz, importante citt austriaca e centro di industrie metallurgiche, sorsero tre campi dipendenti da Mauthausen. La loro storia ricostruibile con difficolt, per carenza di documentazione e di ricerche. Linz I fu attivo dal febbraio 1943 al 3 agosto 1944. I prigionieri erano impiegati in lavori di costruzioni edili e in metallurgia (lavorazione dellacciaio), alle dipendenze della DEST 1 e dei Reichswerke (Hermann Gringswerke). Dopo alcune incursioni aeree il campo fu chiuso e i prigionieri spostati a Linz III, poco distante. Il campo conteneva circa 800 prigionieri. A Linz II, in funzione dal febbraio 1943 al marzo-aprile 1945, alcune centinaia di prigionieri (numero pi alto raggiunto: 285) lavoravano alla costruzione di rifugi antiaerei e di edifici militari. Periodo di attivit: febbraio 1944-marzo/aprile 1945. Maggiore importanza ebbe invece il campo di Linz III, sorto nel maggio 1944 e liberato dagli Alleati il 5 maggio 1945. Il numero pi alto di prigionieri raggiunto (da non confondersi con il totale, su cui non vi sono dati precisi) risulterebbe, secondo le ricerche pi recenti, di 5.615 unit. Una buona parte dei prigionieri era sfruttata nel lavoro agli attigui Hermann Gringswerke (acciaio, carri armati). Nei primi giorni di maggio le SS distrussero gli archivi e prepararono levacuazione dei deportati (circa 6.500 stando a Enea Fergnani, superstite del campo) su Ebensee; loperazione fu interrotta dallavanzata alleata, che liber i prigionieri il 5 maggio 1945. Lager relativamente piccolo e di lavoro
Cfr. supra, nota 1, p. 38.
Le guide della memoria
89
produttivo, Linz III non possedeva crematorio. I morti erano periodicamente raccolti e inviati al crematorio di Mauthausen. Negli ultimi mesi vennero seppelliti in fosse comuni, per la difficolt di comunicazioni con il campo principale.
Bibliografia . Per la memorialistica italiana su Linz si ricordano: Pio Bigo, Il triangolo di Gliwice. Memoria di sette Lager, Alessandria, Edizioni dellOrso, 1998, pp. 49-70 (Linz I e III); Enea Fergnani, Un uomo e tre numeri, Milano, Speroni, 1945 / Milano2 Roma, Avanti, 1955 , pp. 184-229 (Linz III) (il volume stato ripubblicato nel 1991 dal Comune di Venezia, dallAssessorato agli Affari istituzionali); Antonio (Ivo) Tonussi, Ivo. Una vita di parte , Treviso, Matteo, 1991, pp. 154-166.
met dei prigionieri. Cfr. D. Goldhagen, I volonterosi carnefici di Hitler. I tedeschi comuni e lOlocausto , trad. it. di E. Basaglia, Milano, Mondadori, 1996, parte V. Forse la pi vasta operazione di tale genere fu costituita dalle marce della morte per lo sgombero di Auschwitz, culminate fra il 17 e il 21 gennaio 1945. Linverno, la mancanza di cibo e di abbigliamento, la prostrazione fisica e le violenze falcidiarono i deportati. Da alcuni sottocampi i prigionieri (circa 2.000) partirono con trasporti ferroviari. Da altri vennero avviati interamente a piedi: il caso dei 3.200 prigionieri di Jaworzno che camminarono per 250 km fino al Lager di Gross-Rosen. Il grosso dei prigionieri (circa 50.000 persone nei vari campi, compresi Auschwitz I, II e III) fu instradato a piedi verso i due nodi ferroviari di Wodzislaw Sla ski e Gliwice. Di qui vennero smistati verso Buchenwald, Bergen Belsen o Mauthausen, con trasporti ferroviari effettuati in condizioni spaventose (carri bestiame aperti sotto la neve e al gelo) che causarono molte altre vittime.
Bibliografia. Sullo sgombero di Auschwitz si veda A. Strzelecki, Evacuazione, liquidazione e liberazione del campo in Auschwitz. Il campo nazista della morte, Os wie cim, Museo Auschwitz-Birkenau, 1995, pp. 243 sgg. Le testimonianze dei superstiti italiani si possono leggere nelle rispettive opere di memorialistica. Per una panoramica sulla situazione nei vari KZ e il racconto di tre superstiti si veda il volume di E. Vincenti (cur.), Gli ultimi giorni dei Lager, Milano, FrancoAngeli, 1992. Per il racconto dellevacuazione di Buna verso Gliwice e Buchenwald si veda il testo di Pio Bigo, Il triangolo di Gliwice. Memoria di sette Lager cit., pp. 93-107.
Le marce della morte
Lucio Monaco Con questo termine ormai entrato nelluso storiografico (Death Marches, Todesmrsche) sindicano i trasferimenti massicci di prigionieri (a piedi e su ferrovia) da un Lager campo principale o sottocampo a un altro. Ci avvenne nella fase finale della storia di molti KZ: di fronte allavanzata degli angloamericani o dei russi, i Lager venivano fatti sgomberare completamente (Nessun prigioniero deve cadere vivo nelle mani dei nemici, era lordine). Allo stesso tempo erano attuate, in genere, la distruzione o lasportazione degli archivi e di parte delle installazioni. Non dovevano rimanere testimonianze n testimoni: i malati erano uccisi, gli altri si incamminavano a piedi o con altri mezzi verso i Lager di destinazione. Incolonnati talvolta per chilometri, caricati su carri bestiame, erano scortati dalle SS, da guardie armate e dai Kapo, che sopprimevano chiunque non riuscisse a tenere landatura richiesta. Leliminazione dei pi deboli poteva avvenire anche durante le soste e coinvolgere decine o centinaia di vittime. In generale, nelle marce della morte la mortalit di prigionieri raggiunse punte elevate, stimate intorno alla
90
Capitolo II
Il Lager di Mauthausen e lo sterminio mediante il lavoro (1938-1945)
Lucio Monaco 1938: dopo lAnschluss (annessione dellAustria al Reich) viene costruito il Lager principale, su unaltura sovrastante la cittadina di Mauthausen (presso Linz), in prossimit di una cava di granito ceduta dal Comune di Vienna alla DEST,1 unimpresa di propriet della SS. Alledificazione del campo (1938-1939) sono destinati prigionieri tedeschi, austriaci, cechi e boemi, provenienti in gran parte dal Lager di Dachau. Nellarco di tre anni il numero dei prigionieri raggiunge le 8.000 unit. In questo periodo i prigionieri appartengono alle seguenti categorie: criminali comuni, asociali, politici, Testimoni di Geova (Bibelforscher), zingari. Il cuore dellattivit lavorativa del campo la cava di granito, che fornisce anche il materiale per ledificazione dei muri perimetrali, delle torri, dei portali dingresso. 1940: si allestisce il Lager dipendente (Nebenlager ) di Gusen, a circa 5 km da Mauthausen (4.000 prigionieri alla fine dellanno). il primo dei 56 sottocampi, distribuiti in tutta larea industriale adiacente a Vienna e nella regione dellAlta Austria centrale. La loro funzione principale era quella di impegnare i prigionieri in attivit produttive di tipo bellico (in molti casi con macchinari collocati in gallerie, per via dei bombardamenti alleati) e nella costruzione delle infrastrutture (gallerie, impianti). Nel marzo 1940 giungono a Mauthausen i primi deportati stranieri (cio non provenienti da territori del Reich): 448 polacchi. Seguiranno i combattenti repubblicani spagnoli esuli in Francia (invasa dai nazifascisti), circa 8.000 (ne
sopravviveranno 1.600), cechi (circa 4.000) ed ebrei olandesi (circa 2.000). Il gruppo nazionale maggioritario risult, nel corso degli anni, quello dei polacchi, fra cui numerosi sacerdoti cattolici. Sempre nel 1940 arrivano anche i primi giovanissimi (tra 13 e 18 anni), in genere famigliari dei combattenti repubblicani spagnoli. Tra campo e sottocampi si raggiunge la quota di circa 8.200 prigionieri. Si tratta, come s visto, prevalentemente di politici, destinati a crescere in numero con levoluzione della guerra: scioperanti, resistenti di ogni genere, partigiani, prigionieri di guerra sovietici. In previsione del numero crescente di internati e di un accrescersi della mortalit (dovuta anche alle condizioni particolarmente rigide di disciplina e sfruttamento) il campo fu dotato di un forno crematorio cui se ne aggiungeranno altri due; di crematori si forniranno anche, pi avanti, i sottocampi di Gusen (1941), Ebensee (1944) e Melk (1944). 1941: Mauthausen catalogato da Heinrich Himmler come campo di III livello (di massimo rigore), cio di annientamento dei prigionieri, mediante lavoro o altro. Alla fine dellanno il sistema di campi conta quasi 16.000 prigionieri; circa 8.500 sono concentrati a Gusen. Verso la fine del 1941, la configurazione del Lager quella in parte riconoscibile oggi. Si possono individuare tre aree: 1) il campo principale, posto in cima a una collina, recintato sul lato meridionale da un grande muro di granito, alto quattro metri, con torri e ingressi, con aggiunta di filo spinato e reticolato elettrificato; a settentrione la recinzione era incompleta e prevaleva il reticolato. In questarea erano situate le baracche dei prigionieri, il piazzale dellappello, i locali di doccia e disinfezione, le cucine e, a partire dal 1941, il Bunker: un complesso in buona parte sotterraneo con celle, locali per sperimentazioni mediche ed esecuzioni, crematorio e camera a gas (si veda pi avanti);
Cfr. supra, nota 1, p. 38.
Le guide della memoria
91
2) la cava di granito, profonda 100 metri e lunga un chilometro, cui si accedeva scendendo una scalinata dai gradini sconnessi e irregolari. Vi lavoravano da 1.000 a 3.000 prigionieri, compresi quelli assegnati al distaccamento di punizione (Strafkommando), costretti a portare sulle spalle massi di 30-60 chili; molti prigionieri vennero fatti precipitare lungo la scala o dalle pareti della cava; 3) il campo ospedale ( Krankenlager ), unarea rettangolare, racchiudente una decina di baracche, con cucina e servizi, che si trovava al di sotto del campo principale, a fianco della strada di accesso. Circondato da reticolati elettrificati, fu denominato Campo russo (dagli italiani Camporosso), perch allorigine era destinato ai prigionieri di guerra sovietici; ma dal 1943 fu usato per i malati e gli invalidi e divent una struttura a s, mentre i prigionieri sovietici vennero rinchiusi nelle baracche 1619 del campo principale (di quarantena) o nella baracca 20, ulteriormente isolata con filo spinato, i cui cinquecento prigionieri, nel febbraio 1945, effettuarono una fuga in massa salvandosi soltanto in dodici.2 1942: il sistema dei sottocampi si avvia al massimo sviluppo. Il 30 aprile 1942 il capo dellUfficio centrale economico amministrativo della
SS dirama una circolare (Circolare Pohl) per sfruttare nel modo pi completo la manodopera costituita dai prigionieri: lindustria bellica tedesca aveva un crescente fabbisogno di forza lavoro. I sottocampi nascono dallesigenza di collocare le industrie belliche al riparo dai bombardamenti (in gallerie scavate nelle montagne) e di decentrare e distribuire lenorme quantit di prigionieri che serviva allo scopo, e che non poteva essere concentrata in un unico campo, spesso molto distante dai luoghi di lavoro. I prigionieri sono impiegati in tre settori: costruzione di infrastrutture (strade, centrali elettriche, indotto); trasferimento sotterraneo delle industrie belliche (scavi gallerie, installazione macchinari); produzione di armamenti. Il Lager principale di Mauthausen nel 1942 assume funzioni nuove legate a questi sviluppi. Si presenta infatti come: sede amministrativa centrale del sistema di raccolta, selezione e distribuzione della manodopera schiavile, secondo le richieste provenienti dalle varie industrie; direzione finanziaria per controllare i proventi derivanti dallaffitto dei prigionierischiavi alle varie industrie; direzione centrale dellorganizzazione di sorveglianza. Di conseguenza, ogni nuovo trasporto inviato nellarea di competenza di Mauthausen arrivava al Lager centrale, dove i prigionieri erano registrati, selezionati e predisposti alle durissime condizioni di disciplina e lavoro del Lager mediante la quarantena. Oltre ad assolvere a questa funzione di smistamento, Mauthausen serviva anche come luogo di raccolta ed eliminazione degli inabili
2 Cfr. il capitolo Fuga da Mauthausen, in G. J. Horwitz, Allombra della morte. La vita quotidiana attorno al campo di Mauthausen, trad. it. di G. Genovese, Venezia, Marsilio, 1994, pp. 161-183 (per la cifra dei sopravvissuti, in particolare p. 163).
La cava di granito di Mauthausen (marzo 2003)
92
Capitolo II
(divenuti tali in conseguenza dei trattamenti subiti durante la prigionia e il lavoro forzato), e come centro di annientamento di particolari categorie di nemici del Reich, soprattutto prigionieri di guerra sovietici (eliminati con il gas), ebrei olandesi e un consistente numero di intellettuali cecoslovacchi. Gli ebrei deportati a Mauthausen erano in genere stati arrestati con imputazioni di tipo politico. La loro sorte era comunque incomparabilmente peggiore: fra i 90 ebrei arrivati nel 1940, alla fine dellanno 80 erano gi deceduti. I circa 2.600 ebrei deportati da Olanda, Austria, Polonia, Cecoslovacchia e Romania fra il 1941 e il 1942 morirono nel giro di un anno dallarrivo; i pochi superstiti furono trasferiti ad Auschwitz. Alcune migliaia di ebrei ungheresi (provenienti da Auschwitz) e polacchi giungeranno poi a Mauthausen nellestate del 1944. Va ricordato che, fra il 1938 e il 1945, il numero degli ebrei morti a Mauthausen risulta di circa 39.000 persone. Un ruolo importante nelle operazioni di annientamento era ricoperto dalla camera a gas (gas Zyklon-B): essa venne messa in funzione nel maggio 1942, con leliminazione di 208 prigionieri di guerra sovietici. Nel corso di quattro anni vi furono eliminate circa 5.000 persone, oppositori politici ritenuti pericolosi, malati e inabili al lavoro (provenienti dal Revier). Inoltre, fra il 1941 e il 1942, gli inabili e i malati di Gusen furono anche uccisi in un veicolo che faceva la spola fra Gusen e Mauthausen, in cui i trasportati (a gruppi di 30) venivano asfissiati probabilmente con monossido di carbonio. Infine, fra lagosto 1941 e il dicembre 1944, la camera a gas del Castello di Hartheim (a 20 km da Linz) elimin altri malati, inabili e selezionati provenienti dai Lager di Mauthausen, Gusen e Dachau (nome in codice: Operazione 14f13): in tutto circa 8.000 persone, di cui 5.000 trasferite da Mauthausen e Gusen. Alla fine del 1942 il sistema Mauthausen conta 14.000 prigionieri.
1943: si completa il sistema dei sottocampi austriaci e della produzione in fabbriche sotterranee, che va dagli impianti di benzina sintetica agli aerei superveloci agli armamenti pi convenzionali. A questi campi si assegna spesso un nome in codice: Cemento (Ebensee), Cristallo di rocca (St. Georgen presso Gusen), Quarzo (Melk), ecc. Migliaia di deportati furono anche impiegati in fabbriche esterne, spesso di propriet SS (i Gringswerke). I turni di lavoro erano massacranti (12 ore), anche se gli addetti ad alcune lavorazioni potevano usufruire di un vitto leggermente migliore. Ma in numerosi campi il lavoro significava la morte o linabilit nel giro di tre mesi; malati e inabili erano mandati al Revier, al Campo russo di Mauthausen o direttamente eliminati nelle camere a gas o con altri sistemi. Dal 1943 arrivano a Mauthausen gli italiani (per la maggior parte resistenti e antifascisti). Essi vengono accolti come traditori dai nazisti, e come nemici fascisti dagli altri deportati (che ignoravano i mutamenti politici avvenuti in Italia dopo il 25 luglio). Di qui una condizione particolarmente difficile che pot essere modificata soltanto dopo molti mesi. Il primo trasporto italiano (ottobre 1943, 300 persone) proveniva dal campo dinternamento di Cairo Montenotte, dove si trovavano cittadini di Gorizia, Trieste, Capodistria, deportati dai fascisti. Fino al febbraio 1945 si ebbe una ventina di trasporti, per un totale di deportati che, allo stato attuale delle ricerche, stimato in circa 8.000 persone. Alla fine del 1943 i deportati di Mauthausen (e sottocampi) assommano a 25.000 unit (8.000 a Gusen). 1944: nellintensificarsi dei trasporti (prevalentemente di politici) da tutta Europa, si segnalano dallItalia i convogli di prigionieri arrestati in occasione degli scioperi del marzo 1944. L11 marzo arriva un convoglio con 597 deportati dalla Toscana, dal Piemonte, dalla Lombardia; il 16 marzo la volta di 563 deportati da Piemonte, Lombardia e Liguria; ai primi di aprile giungono altri 600 italiani, dal-
Le guide della memoria
93
la Lombardia. In tutto lanno si avranno 15 trasporti dallItalia. Le donne deportate (perlopi operaie scioperanti) non rimangono a Mauthausen, ma vengono spostate ad Auschwitz o a Ravensbrck. Verso la fine del 1944 i nazisti iniziano levacuazione dei Lager orientali e di Auschwitz, facendo affluire i superstiti delle marce della morte su Mauthausen. I pi deboli sono eliminati, gli altri smistati nei campi secondari. La popolazione dei campi del complesso di Mauthausen aumenta cos fino a superare le 72.000 unit (tra cui circa 1.000 donne). 1945 : le condizioni del campo peggiorano a causa del sovraffollamento (84.000 prigionieri in marzo) e della mancanza di cibo. Aumenta lafflusso degli evacuati da Auschwitz (9.000 persone, in prevalenza ebrei), Gross-Rosen, Sachsenhausen, Nordhausen, Ravensbrck. Con loro giungono gli ebrei inviati a lavorare alle fortificazioni della frontiera austro-ungherese. Nel settore pi settentrionale dellarea sorvegliata del campo viene costruita una tendopoli in cui tifo, denutrizione e malattie provocano centinaia di vittime (molte di esse
sepolte in fosse comuni, perch i crematori non bastavano pi allo smaltimento dei cadaveri). In aprile una serie di trattative con la Croce Rossa permette la liberazione di alcune centinaia di detenuti (in maggior parte francesi). Ma fra il 20 e il 28 aprile vengono eliminate nella camera a gas del campo principale diverse centinaia di prigionieri (sicuramente almeno 650) prelevati dal Krankenlager o Revier (Campo russo). Tra loro vi un alto numero di italiani. Il 29 aprile la camera a gas viene parzialmente smantellata. Il 5 maggio 1945 il Lager di Mauthausen raggiunto da due autoblindo alleate e il Comitato Internazionale di Resistenza (tra i componenti, litaliano Giuliano Pajetta), sorto clandestinamente nel marzo, simpadronisce del campo, liberandolo con le armi strappate ai nazisti. Si trovavano nel campo principale, in quel momento, circa 20.000 prigionieri, quasi tutti al limite della sopravvivenza. Pi del 10% moriva nel mese successivo alla liberazione. Si calcola che siano passati per il complesso dei Lager dipendenti da Mauthausen circa 230.000 deportati. I morti furono almeno 120.000.
Questa tabella ricavata dalle ricerche pi autorevoli: anno presenze (*) morti (**) 1938 1.010 36 1939 2.995 445 1940 8.200 3.486 1941 1942 15.900 15.900 8.114 14.293 1943 25.607 8.481 1944 72.392 14.776 1945 64.800 36.214
(*) Non il numero totale di prigionieri, bens il numero di prigionieri pi alto registrato nellanno. Sono escluse le donne, presenti a Mauthausen in modo consistente solo nel 1944 (959) e nel 1945 (1.734). (**) Il dato del 1945 sottostimato di circa 16.000 persone, giunte a Mauthausen gi morte nei trasporti dallEst, oppure morte nel mese successivo alla liberazione. Tasso complessivo di mortalit: 52,5%. Fonte: H. Maralek, Die Geschichte des Konzentrationslager Mauthausen, Wien, sterr. Lagergemeinschaft Mauthausen, 1980. Bibliografia. Lo studio di Hans Maralek citato sopra stato finalmente tradotto in italiano (La storia del campo di concentramento di Mauthausen, trad. it. di P. Ferrari, Wien, sterreichische Lagergemeinschaft Mauthausen, 1999). A esso si deve aggiungere il saggio molto interessante, gi menzionato in nota, di Gordon J. Horwitz, Allombra della morte. La vita quotidiana attorno al campo di Mauthausen, trad. it. di G. Genovese, Venezia, Marsilio, 1994. La memorialistica italiana molto ampia e rinviamo ad A. Bravo / D. Jalla, Una misura onesta. Gli scritti di memoria della deportazione italiana 1944-1993, Milano, FrancoAngeli, 1994. Fra i testi pi noti: P. Caleffi, Si fa presto a dire fame, Milano, Mursia, 1979; V. Pappalettera, Tu passerai per il camino, Milano, Mursia, 1965; F. Maruffi, Codice Sirio. I racconti del Lager, Casale Monferrato, Piemme, 1986; A. Buffulini / B. Vasari , II Revier di Mauthausen. Conversazioni con Giuseppe Calore, Alessandria, Edizioni dellOrso, 1992, e le pagine gi citate di N. Pia, La storia di Natale. Da soldato in Russia a prigioniero nel Lager, e di P. Bigo, Il triangolo di Gliwice.
94
Capitolo II
Melk: il sottocampo di Mauthausen e il lavoro in galleria
Lucio Monaco Il sottocampo di Melk fu fondato nellambito del progetto di dislocazione delle industrie belliche (cfr. la guida su Mauthausen, allanno 1942). La cittadina, dominata dalla celebre abbazia benedettina, fu scelta per la presenza di alcune caserme risalenti alla prima guerra mondiale, dove sinsediarono le SS. Il campo (ufficialmente sorto il 20 aprile 1944, in omaggio al compleanno di Hitler) venne fatto costruire dai prigionieri trasferiti da Mauthausen, il cui primo nucleo giunse a Melk il 23 aprile (un migliaio di deportati politici francesi). Ai deportati furono fatte costruire le infrastrutture per raggiungere, con la ferrovia, la localit di Roggendorf, circa 4 km a Est, dove si cominci a realizzare un complesso sistema di gallerie per la produzione di cuscinetti a sfera e di altri componenti per lindustria bellica. Linsieme delloperazione, cui era principalmente interessata la ditta Steyr-Daimler-Puch AG (collegata, dopo il 1938, agli Hermann Gring Reichswerke), fu denominato in codice Progetto Quarzo. Ogni mattina i deportati erano caricati su carri bestiame per raggiungere il cantiere delle gallerie; qui la produzione bellica fu avviata nel dicembre 1944, mentre proseguivano parallelamente i lavori di scavo. In marzo gli stabilimenti 2 sotterranei coprivano unarea di ben 7.880 m . I lavori si svolgevano in condizioni disumane: in particolare, quelli per lo scavo delle gallerie portavano al rapido esaurimento fisico dei deportati, insufficientemente nutriti, alloggiati e vestiti. (Di 10.000 uomini non pi di 1.000-1.200 erano dotati di camicia e solo la met possedeva delle scarpe, scrive Horwitz.)1 Il clima, le sevizie, le condizioni di lavoro aggravavano la situazione. Nel novembre 1944,
1 G. J. Horwitz, Allombra della morte. La vita quotidiana attorno al campo di Mauthausen , trad. it. di G. Genovese, Venezia, Marsilio, 1994, p. 135.
nel campo fu costruito un crematorio dalla ditta Topf la stessa che si aggiudic lappalto di Auschwitz-Birkenau mentre gli inabili e i malati gravi venivano rinviati a Mauthausen per leliminazione diretta (camere a gas del campo centrale o di Hartheim) o tramite il passaggio al Revier (Campo russo). A Melk furono trasferiti prigionieri di ogni nazionalit: fra gli altri, polacchi e ungheresi (in gran parte ebrei provenienti da Auschwitz nellestate 1944), francesi, italiani, sovietici, jugoslavi, austriaci e tedeschi, greci. Una statistica delle SS registra un totale di 5.000 decessi (tra cui 300 italiani); a questa cifra, non completa, vanno aggiunti pi di 1.500 malati uccisi a Mauthausen o Hartheim. Circa 14-15.000 persone furono complessivamente deportate a Melk, dove il numero pi alto di prigionieri raggiunto fu di circa 10.000 presenze. Con lavvicinarsi dei sovietici, le SS evacuarono il campo. L11 aprile 1945 si cominci lo sgombero dei 7.800 prigionieri presenti: 1.500 giovani, giovanissimi e malati furono inviati a Mauthausen; una quarantina di malati gravi e intrasportabili fu eliminata sul posto, secondo una pratica usata in numerosi sottocampi di Mauthausen. Il grosso dei prigionieri fu avviato con trasporti fra il 13 e il 15 aprile 1945 verso il campo di Ebensee, ormai sovraffollato e ridotto in condizioni indescrivibili. Del campo di Melk rimane soltanto un Memoriale contenente il crematorio.
Bibliografia. Fondamentale lo studio di Bertrand Perz, Projekt Quarz. Steyr-Daimler-Puch und das Konzentrationslager Melk, Wien, Verlag fr Gesellschaftskritik, 1991, 523 pp. (la cui riduzione, pubblicata a Vienna nel 1992, stata tradotta in italiano con il titolo Il campo di concentramento di Melk: commando di Mauthausen, impianto sotterraneo Quarz, trad. it. di E. Caserio, Burolo, LArtigiana / ANED, 1993, 57 pp.). Molti disegni del deportato francese Daniel Pique-Audrain (reperibili in Idem, Mauthausen 62978. Plus jamais a! 22 dessins la plume 1945-1947, Paris, Amicale de Mauthausen, s. d., o nel testo di Maurice Petit, A leurs mmoires, [Dports], pour lamiti entre les peuples, Paris, Petit et Rousseau, 1964) si riferiscono a Melk. Nel gi citato studio di Gordon J. Horwitz, Allombra della morte. La vita quotidiana attorno al campo di Mauthausen, trad. it. di G. Genovese, Venezia, Marsilio, 1994, il capitolo Fuori dal monastero (pp. 131-159) interamente dedicato al Lager di Melk.
Le guide della memoria
95
Il KZ di Mittelbau-Dora fra produzione missilistica e sterminio
Lucio Monaco Le premesse: i progetti missilistici della Wehrmacht e levoluzione del conflitto (1932-1943) La storia della progettazione missilistica tedesca precede lavvento del nazismo. Il primo lavoro teorico sullargomento esce nel 1923; qualche anno pi tardi ritroviamo il suo autore, il matematico Hermann Oberth, come consulente del regista Fritz Lang in uno dei primi film di fantascienza, Una donna sulla luna (1929). Il coinvolgimento dellesercito tedesco (settore Artiglieria dellUfficio Armamenti) inizia nel 1932. Legami sempre pi stretti tra uffici militari e universit portano al primo lancio di razzi del modello Aggregat (1934); due anni dopo viene creata una base missilistica a Peenemnde, sul Mar Baltico, diretta dallingegnere Wernher von Braun, attivo nei progetti missilistici fin dal 1932 (quando era ancora studente) e dal generale Walter Dornberger. Levoluzione delle ricerche missilistiche di Peenemnde non n scontata n lineare. Il progetto, allinizio della guerra (1939), sembrava eccessivamente costoso e non necessariamente prioritario rispetto al potenziamento dellaviazione (Luftwaffe): dei vari tipi della serie Aggregat (da A1 ad A12) soltanto il razzo A4 risulta affidabile, ma i primi lanci (estate 1941) falliscono o danno risultati scadenti. Il rallentamento della guerra lampo, la sconfitta nella battaglia aerea dInghilterra, la prospettiva di una guerra di logoramento portano a una maggiore attenzione di Hitler verso Peenemnde (novembre 1941) e allappoggio,
dal 1942, del nuovo ministro per gli Armamenti e la Produzione bellica, Albert Speer. Alle rivalit (la Luftwaffe per parte sua sta lavorando alla bomba volante Fi 103, poi nota come V1), ai conflitti di competenza nellapparato burocratico nazista e a quelli di interesse (con lintromissione di Himmler e della SS) si aggiungono gravi problemi produttivi. Per una massiccia produzione in serie di A4 (poi soprannominati V2) occorre reperire materie prime, individuare e attrezzare le zone di produzione, procurare manodopera sufficiente. Il progetto missilistico si sta per rivelando un interessante affare per tutti: Ci si riprometteva di ottenere prestigio, guadagno, accesso alle materie prime e alla manodopera, e infine ampliamento della propria sfera di potere. Le SS volevano il prestigio, indipendenza nellaccedere alle armi e influenza sullindustria; il Ministero per le armi e munizioni cercava di ottenere il controllo su tutte le parti della produzione bellica, in competizione con lUfficio Armamenti dellesercito. [] Strettamente in connessione con il Ministero delle munizioni agiva lindustria, che aveva il massimo interesse allaccesso gratuito alle nuove tecnologie avanzate, ripromettendosi di ottenere grandi vantaggi e possibilit di guadagno dal nuovo prodotto. [] Si andarono formando di volta in volta differenti coalizioni da parte dei gruppi di potere coinvolti.1 Questa rete di rivalit e la stessa concorrenza tra i razzi Fi 103 e gli A4 da un lato finiscono per produrre un eccesso di fiducia nelle nuove armi, con importanti conseguenze sul piano strategico e politico, dallaltro chiariscono il ruolo delle forze in competizione fra loro. A favore dellindustria privata prevalgono mo-
F. Freund, KZ Zement Ebensee. Il campo di concentramento di Ebensee, commando di Mauthausen, e lindustria missilistica, trad. it. di E. Caserio, Burolo, ANED / LArtigiana, 1990, p. 26.
96
Capitolo II
delli organizzativi e giuridici, come quello delle societ a responsabilit limitata (GmbH), che facilitano laccesso a impianti e brevetti di propriet dellesercito, sia per la produzione finita sia per il lucroso aspetto delle componenti e dei semilavorati. Alla questione della manodopera provveder invece, con rilevanti guadagni sul piano economico e di peso politico, tutta la macchina organizzativa dei campi di concentramento strettamente controllati dalla SS di Himmler. Un fattore non previsto tuttavia modifica bruscamente questi sviluppi: la notte fra il 17 e il 18 agosto 1943, 600 apparecchi alleati bombardano Peenemnde. I nazisti salvano progetti e documenti, ma muoiono 168 tecnici, oltre a centinaia di operai (molti sono polacchi e prigionieri sovietici). Nel giro di due settimane viene varato un progetto di dislocazione sotterranea della produzione missilistica principale in una serie di gallerie gi esistenti (ma non completate), ai piedi del Monte Kohnstein (332 m, sullaltopiano dello Harz), presso Nordhausen, in Turingia, scavate dalla societ WIFO (Societ di studi economici, creata nel 1934 dal Ministero dellIndustria del Reich) per realizzare un deposito sotterraneo di carburanti e prodotti chimici. Espropriata la WIFO, per il progetto di completamento e realizzazione del tunnel e del suo complesso sistema di gallerie si fonda una societ denominata Mittelwerke GmbH. Viene creato un Kommando di lavoro, dipendente dal KL Buchenwald: nome in codice, Dora. il settembre del 1943. I Progetti Kammler. LObergruppenfhrer SS Hans Kammler incaricato dellampliamento del progetto di dislocazione sotterranea delle attivit produttive legate alla produzione missilistica, dislocazione che per nel corso del 1944 verr estesa a un po tutta la produzione bellica. Nascono cos altri impianti sotterranei, per la maggior parte situati in territorio austriaco e quindi dipendenti da Mauthausen: Redl-
Zipf, Ebensee, Gusen, Melk, Hinterbrhl fra i principali. I nomi in codice. Dallestate 1943 si usano sistematicamente nomi in codice per indicare i progetti legati alla produzione missilistica. Mittelwerk, Mittelraum, Mittelbau con allusione alla collocazione geografica dello Harz, allincirca al centro (Mitte) della Germania indicano il coordinamento generale (e anche, come s visto, il nome di una societ). Dora indica il Kommando distaccato nel Kohnstein, poi lo stesso KZ, quando verr costruito. Laura, il Kommando per il collaudo dei motori dei razzi situato a Lehesten, fra Turingia e Baviera, in una cava di ardesia; Zement (Cemento) e Quarz (Quarzo) sono attribuiti a Ebensee e Melk, Malachit a Langenstein, e cos via. Lassegnazione di codici dilaga verso la fine del 1944, con la produzione ormai sistematica dei missili. Talvolta sono usati nomi in codice anche per le persone, come lingegnere Porsche, che aveva progettato una visita a Dora nellestate 1944, ed citato dai documenti segreti come Doktor Piek. Lo stesso nome di Dora sembra essere acronimo (estremamente generico) di Deutsche Organisation Reichs Arbeit (ma se ne danno altre spiegazioni). La prima fase del KZ Dora (28 agosto 1943-febbraio 1944) In questo periodo Dora uno degli oltre cento Aussenkommando di Buchenwald. I primi deportati arrivano nella conca dove si accede al Tunnel della WIFO il 28 agosto 1943: sono 107 polacchi scortati da 40 SS. Altri trasporti si susseguono: in ottobre i prigionieri sono circa 4.000. Di un vero e proprio Lager esterno al Tunnel (con perimetro di recinzione, baracche, edifici di servizio) si potr parlare solo a partire dal marzo 1944: nei primi mesi si d priorit assoluta alla sistemazione del Tunnel, vista lemergenza creatasi con la distruzione di Peenemnde.
Le guide della memoria
97
Il Tunnel WIFO consisteva in due gallerie parallele, A e B, distanti circa 200 m, collegate fra loro da gallerie di raccordo larghe undici metri e alte otto per una superficie totale occupata di circa 100.000 m2. Nellagosto 1943 per i lavori non sono ancora stati portati a termine, e inoltre per la produzione missilistica si rende necessaria qualche modifica, soprattutto con lampliamento delle gallerie trasversali. Soltanto luscita Sud della galleria B era stata ultimata. Si d dunque priorit allo scavo interno. Le SS alzano alcune tende presso luscita della galleria B mentre i deportati vengono destinati al Tunnel: l dentro per la maggior parte vivono, lavorano e muoiono senza vedere lesterno per mesi. Le condizioni di lavoro sono inimmaginabili: turni di 12-14 ore, ambiente saturo di umidit e di polvere prodotta dalle esplosioni e dai lavori di scavo nella roccia polverosa (anidrite). A parte gli specialisti, chi fortunato lavora con piccone o pala, gli altri a mani nude. Per dormire si sono innalzate strutture di legno a castello in alcune gallerie trasversali prive di aerazione; la distanza fra i piani di mezzo metro, la carenza di ossigeno indebolisce ancora di pi i prigionieri alimentati in modo assolutamente insufficiente. Manca lacqua potabile: lunico apporto idrico quello del surrogato di caff al mattino e alla sera, e della zuppa di mezzogiorno: quando va bene, due litri in tutto. E questo in un ambiente permanentemente saturo di polvere di calcio. Il sistema di controllo quello del Lager: ogni mancanza punita con feroci bastonature o, se ritenuta sabotaggio, con la morte immediata, spesso nella forma di impiccagioni collettive particolarmente crudeli: i prigionieri sono appesi a decine alle travi della volta, o ai carrelli delle gru, con un morso alla bocca perch non gridino. Nel Tunnel si muore ogni giorno, per
sfinimento, per le percosse: a ogni turno un Kommando porta allesterno 40, 80 cadaveri e pi. In genere i morti sono cremati a Buchenwald: dalle registrazioni rimaste, si ricava un totale di 2.882 decessi tra ottobre 1943 e marzo 1944. Non si muore per solo nel Tunnel: invalidi e malati sono anche inviati al Revier esterno (inizialmente una tenda, poi un blocco vero e proprio, quando nascer il campo con una struttura organizzata); da qui, nel gennaio 1944, partono alcuni trasporti per Majdanek (KL in territorio polacco, fornito di camere a gas) e Bergen Belsen. Andr Sellier ha valutato in 3.000 il numero dei deportati eliminati in questi trasporti: secondo il suo calcolo, fondato su documenti, sui 17.535 deportati entrati in Lager dal settembre 1943 al marzo 1944, i deceduti nello stesso periodo risultano 5.882: un terzo circa del totale.2 A poco a poco viene ultimata la galleria A. Nel dicembre 1943 una parte della galleria B, dove sono previste le operazioni di montaggio, attrezzata al punto da poter ricevere in forma ufficiale il ministro Speer, il quale, nelle sue memorie, si dichiara impietosito dalle condizioni fisiche dei deportati e si attribuisce il merito di aver fatto avviare il progetto che porter alla costruzione del campo esterno, con baracche per i 10.000 prigionieri. A fine mese vengono ultimati tre razzi A4, conclusi simbolicamente la sera del 31 dicembre. Tuttavia la produzione sistematica sar avviata solo dopo il completamento delle strutture interne, che si accompagna alla costruzione pianificata e stabile del campo esterno. La costruzione del KZ e lorganizzazione del lavoro produttivo (marzo-settembre 1944) A partire dal marzo 1944 una parte dei deportati di Dora lavora alledificazione del cam-
A. Sellier, Histoire du camp de Dora, Paris, La Dcouverte, 1998, pp. 399-403.
98
Capitolo II
po esterno e delle sue strutture. Sul modello di Buchenwald, il campo si presenta come una piccola citt, con un centinaio di costruzioni (numerate da 1 a 150, ma i numeri 43-100 non furono assegnati): 50 blocchi dormitorio, 9 blocchi destinati al Revier e altri per servizi amministrativi e diversi, tra cui una biblioteca e un cinema (sul modello di Buchenwald), una caserma di pompieri. Nellestate del 1944 il campo, ripulito e svuotato dei prigionieri, inviati nel Tunnel, verr visitato dalla Croce Rossa. Gi da marzo, comunque, Dora stato dotato di un forno crematorio che lo rende autonomo nelloperazione di smaltimento dei cadaveri. Si tratta allinizio di un forno crematorio di tipo leggero, collocato provvisoriamente in una baracca; nel settembre 1944 sostituito da quello tuttoggi conservato nelledificio originario. Lorganizzazione di Dora si sviluppa secondo un vero e proprio modello industriale. I prigionieri non dormono pi nelle gallerie, e molti di loro escono finalmente a rivedere la luce dopo sei mesi. La maggior parte lavora, a turni, nel Tunnel, e utilizza il campo esterno per dormire, per i rari momenti di riposo, e per il ricovero in Revier. Una serie di squadre destinata ai lavori di manutenzione e di gestione delle strutture esterne e al trasporto dei semilavorati e delle parti prodotte in altri sottocampi od officine, mentre gli addetti alla perforazione continuano a vivere permanentemente in galleria, notte e giorno, salvo periodiche uscite per la disinfestazione. La lavorazione degli A4 (cio V2) comprende una serie molto differenziata di operazioni, dalle meno qualificate (trasporto materiali), affidate alle Transportkolonnen, sorta di sottoproletariato del campo, a quelle specialistiche a vari livelli, che mettono sovente a contatto prigionieri e civili tedeschi, capisquadra ( Meister ) o inge3
gneri. Il sistema diventa pienamente operativo in autunno; nella stessa epoca lestremit Sud della galleria A (chiamata Werk II) viene riservata alla produzione dei Fi 103 (noti come V1), sotto il controllo della Luftwaffe (le V2 sono invece di responsabilit Wehrmacht). Tutta la procedura costruttiva, in alcune fasi di elevato livello tecnologico, sintetizzata nelle pagine di Ricciotti Lazzero.3 Il funzionamento del campo esterno presenta numerose analogie con quello dei KL nella fase dello sterminio produttivo (Vernichtung durch Arbeit) prevista, in sostanza, dalla Circolare Pohl. Una particolarit di Dora comunque costituita dal Revier, che nel periodo estate-autunno 1944 vede la presenza di personale medico (costituito da prigionieri) competente e in grado, per una serie fortunata di combinazioni, di aiutare per quanto possibile i malati. Il medico capo SS, Kahr, favorevole ai miglioramenti e allefficienza dellospedale; Kapo e Schreiber sono due politici tedeschi, comunisti, che godono della stima generale e sono bravi organizzatori. Fra i medici c un noto chirurgo mastoideo francese, Louis Girard; francese anche il chirurgo capo, Jacques Poupault, affiancato da specialisti cechi, belgi e francesi. Oltre a salvare, nei limiti della situazione, i compagni, il personale del Revier diventa punto di riferimento per lorganizzazione della Resistenza del campo; rete che subir un duro colpo con una serie di arresti e uccisioni alla fine del 1944. possibile tracciare un bilancio quantitativo di Dora nei mesi che vanno dallaprile allottobre 1944. In questi mesi il campo registra la presenza di un numero di prigionieri relativamente costante, tra le 11.000 e le 12.000 unit, che salgono a 12.000 per settembre e ottobre. La mortalit media di 150 persone al mese.
R. Lazzero, Gli schiavi di Hitler. I deportati italiani in Germania nella seconda guerra mondiale, Milano, Mondadori, 1996, pp. 132-133.
Le guide della memoria
99
Lorganizzazione del lavoro si articola anche in una rete via via pi complessa di sottocampi che, pur dipendendo come del resto Dora da Buchenwald, fanno per capo a Mittelbau-Dora per il ciclo produttivo dinsieme. Come s detto, il progetto generale, in particolare per quanto riguarda le dislocazioni sotterranee, era affidato a Hans Kammler e al suo Sonderstab (Stato maggiore speciale) con sede a Porta Westfalica, presso Minden, e diviso in quattro ispettorati (Sonderinspektionen). Questi uffici individuavano le localit e creavano i nomi in codice. Fra questi sottocampi ricordiamo, anche per la presenza di italiani, quello gi citato di Lehesten Laura (collaudo propulsori dei V2), con un migliaio di prigionieri; quello di Ellrich Erich, con una media di 5-6.000 prigionieri e una mortalit molto elevata a partire dal dicembre 1944 (381 morti) fino al picco del mese di marzo (circa 1.000 morti); quello di Zwieberge-Langenstein, che tocc un massimo di 5.000 prigionieri (vi perirono 97 italiani); quello di Gandersheim, reso noto dallintensa testimonianza di Robert Antelme, La specie umana. Lautonomia del campo e gli ultimi mesi (ottobre 1944-aprile 1945) Nellautunno 1944 Dora cessa di dipendere da Buchenwald e diventa un Lager autonomo (e principale) con il nome di KZ Mittelbau. La decisione applicata dal 1 novembre anzich dal 1 ottobre inizialmente previsto, e pu essere spiegata come presa datto della concentrazione nellarea del Mittelraum di tutto il sistema di fabbricazione delle armi segrete, di fatto secretato e svincolato, nella gestione, dal KL Buchenwald, da cui alcuni sottocampi, come Zwieberge-Langenstein, continuano tuttavia a dipendere. Sono per possibili anche altre interpretazioni che individuano una dialettica interna ai comandi SS.
4 5 6
I Kommando dipendenti da MittelbauDora assommavano a una quarantina: se ne pu vedere un elenco nel gi citato saggio di Ricciotti Lazzero. 4 Tra di essi, Ellrich Erich e Harzungen Hans contano migliaia di prigionieri. Per avere unidea della distribuzione dei deportati, si considerino le cifre di novembre 1944 (secondo A. Sellier):5 13.441 presenti a Dora, 7.870 a Ellrich, 4.009 a Harzungen, e i restanti distribuiti in 5 sottocampi. Un documento dellamministrazione centrale dei KZ rileva, allappello del 15 gennaio 1945, un totale di 29.323 prigionieri presenti in tutto il complesso di Mittelbau (a fronte dei 33.797 del 1 gennaio 1945). Mentre continua la produzione ormai a pieno ritmo di V1 e V2, a Mittelbau, dopo gennaio, cominciano ad affluire i convogli provenienti dai Lager dellEst caduti in mano ai sovietici: Auschwitz, Gross-Rosen. Chi non muore allarrivo viene spostato a Nordhausen, nella Caserma Boelcke: questo luogo diventa un terribile centro di raccolta dove, insieme con gli inabili al lavoro inviati da Ellrich e Harzungen, i prigionieri vengono abbandonati a se stessi e lasciati morire. Nel Tunnel i nazisti si accaniscono contro i sovietici, con drammatiche impiccagioni collettive effettuate sia nelle gallerie sia sullAppellplatz del campo. A questo proposito osserva Sellier: I sovietici paiono essere stati eliminati in quanto sovietici, per razzismo, come lo era stato un numero considerevole di prigionieri di guerra fin dal 1941. [] Il secondo aspetto notevole di queste esecuzioni la scelta del Tunnel. [] Sembra che si sia voluto impressionare i civili tedeschi, la cui fedelt al regime non era pi cos sicura.6 La fine di Mittelwerk segnata il 1 aprile, con lavvicinarsi degli Alleati (pi lontani, comunque, di quanto fosse stato riferito a von Braun). La produzione viene interrotta, si na-
Ibidem, pp. 164-167. A. Sellier, op. cit., p. 263. Ibidem, p. 286.
100
Capitolo II
scondono nella miniera di Drnten progetti, piani e documenti; i tecnici abbandonano la Turingia. Nei giorni successivi Nordhausen bombardata (moriranno anche alcuni deportati superstiti nella Boelcke Kaserne, diventata, come s visto, un deposito di malati, inabili e moribondi abbandonati a se stessi), e la struttura organizzativa del campo collassa. Ha allora inizio una serie di marce della morte che da Dora o dai sottocampi porta i prigionieri (quelli che sopravvivono) a Bergen Belsen, Ravensbrck, Sachsenhausen, Lubecca. A Gardelegen, il 15 aprile, i nazisti chiudono in un fienile un migliaio di deportati, poi appiccano il fuoco e sparano su chi cerca di fuggire. Muoiono quasi tutti: 1.016 persone. Due russi, tre francesi, un ebreo ungherese e due polacchi si salvano e segnaleranno agli Americani, una settimana dopo, il massacro. Le fotografie di Gardelegen e della Boelcke Kaserne (molto diffuse, anche se quasi sempre prive di didascalie) restano fra i documenti pi atroci della storia di Dora e dei Lager nazisti. Quale fu il bilancio umano di Dora e dei suoi sottocampi? Secondo Andr Sellier, per un complesso concentrazionario il cui ordine di grandezza era, in definitiva, di circa 40.000 prigionieri, le perdite umane in poco pi di venti mesi saranno state di circa 26.500 vittime: 15.500 nel campo o nei trasporti e 11.000 al momento delle evacuazioni.7 La deportazione degli italiani a Dora Il primo gruppo di deportati italiani giunge a Dora l8 ottobre
1943. Si tratta di prigionieri militari IMI8 da questo momento per sottoposti allo stesso trattamento dei deportati politici e cosiddetti razziali.9 In particolare a Dora gli IMI sono immatricolati con un numero preceduto da zero (tra i primi morti in galleria, le matricole 0333, 0388, 0316, 019) che li distingue rispetto ai triangoli rossi (i politici) immatricolati con le serie di Buchenwald (cinque cifre). I deportati IMI nel campo del Tunnel risultano, secondo alcune fonti,10 748. Un elenco pi preciso di nominativi completi, ma riferito anche ai sottocampi di Dora e comprendente altre categorie di deportati, assomma a 1.453 persone. Di questi mor circa un terzo, stando ad alcune ricerche ancora in corso.11 Il 14 dicembre 1943 sette IMI addetti alle perforatrici, a cui il Kapo ha sottratto parte della razione di cibo, protestano: il gesto considerato sabotaggio e il giorno dopo vengono fucilati davanti agli altri prigionieri. I loro nomi sono ricordati su un pannello posto presso il luogo della fucilazione.
Testimonianza di Albino Moret sul luogo della fucilazione degli IMI (marzo 2002)
7 8
Ibidem, p. 403. IMI: Internati Militari Italiani, deportati nel territorio del Reich dopo l8 settembre e rinchiusi in appositi Stalag (doppio acronimo per Mannschaftsstammlager, campo principale per prigionieri di guerra) e Offlag (Offizierlager, campo per ufficiali). In alcuni casi, militari italiani e IMI furono inviati in KZ (Dachau e Buchenwald-Dora sono i casi pi noti). 9 Usiamo lespressione cosiddetto perch il concetto di razza, scientificamente infondato, non pu essere condiviso nemmeno sul piano linguistico e terminologico. 10 A. Sellier, op. cit., pp. 130-131. 11 Ricciotti Lazzero, negli Allegati del suo saggio gi citato, riporta un elenco di 430 nomi.
Le guide della memoria
101
La produzione missilistica e i suoi sviluppi postbellici Anche su tale argomento si possono proporre alcune cifre non dei morti, bens dei missili prodotti. Andr Sellier valuta in 4.575 il numero di V2 prodotte fra il gennaio 1944 e il 18 marzo 1945, con un totale di 3.255 tiri riusciti (1.610 sul Belgio, 1.403 sulla Gran Bretagna quasi tutti su Londra e il resto in altri Paesi europei). Ricciotti Lazzero, che utilizza altre fonti, fa salire la quantit di V2 prodotte a 5.789. Quanto ai V1, il dato pi sicuro lindice di produzione per il mese di febbraio 1945 (concentrata dunque nel Tunnel A): 2.275 esemplari. I tiri riusciti di razzi V1 (solo in parte prodotti a Dora) furono nel complesso 21.770.12 La vicenda di Dora si prolunga nei decenni del dopoguerra. Si suole dire che il KZ Mittelbau-Dora si colloca alle origini dei voli spaziali e del programma Apollo della NASA. La questione naturalmente pi complessa e vi si accenner qui per sommi capi. a) La divisione della Germania e la spartizione delle tecnologie di Dora. Liberata dalle forze franco-anglo-americane, la Turingia inclusa nellarea di controllo sovietico a partire dal luglio 1945. Tuttavia, ai primi di maggio gli americani avevano rintracciato von Braun, Dornberger e numerosi tecnici. Larchivio di Drnten viene ricuperato poco prima che la zona passi sotto il controllo britannico: quattordici tonnellate di documenti sono inviate negli USA. Si avvia parallelamente un piano per il ricupero di parti di V2 e di macchinari necessari al loro assemblaggio: 450 tonnellate di materiali prendono cos la strada degli Stati Uniti, verso la base militare di White Sands. Il 17 luglio, superando una serie di difficolt di tipo politico, prende avvio lOperazione Overcast, per il reclutamento da parte degli USA di specialisti tedeschi in bombe volanti, guidati da von Braun, interlocutore privi12
legiato degli americani. Il contingente di scienziati e tecnici comprender 146 persone di cui 127 specialisti in V2 stabilite negli Stati Uniti a partire dai primi mesi del 1946. A White Sands saranno eseguiti, tra il 1946 e il 1947, 66 lanci di V2. Gli inglesi per parte loro tentano di assoldare von Braun e Dornberger nellestate 1945, ma senza successo; compiono quindi alcuni lanci di V2 che sono riusciti a ricostruire, nella base di Cuxhaven e pi avanti in Australia. I risultati insoddisfacenti li convincono ad abbandonare la ricerca in questo campo (Piano Blackfire). Nel luglio 1945 i sovietici assumono il controllo della Turingia e quindi di Dora; gli americani hanno asportato documenti e macchinari, ma le installazioni sono rimaste intatte. I sovietici rintracciano alcuni specialisti, fra cui Helmut Grttrup, e li trasferiscono in Unione Sovietica. Nellottobre 1947 vengono effettuati i primi di una serie di 11 lanci di V2 dalla base di Kapustin Yar (200 km a Est di Stalingrado). Anche la Francia sinteressa ai V1 e V2 e si assicura la collaborazione di tecnici tedeschi. Fra loro lingegnere Heinz Bringer, del gruppo di Peenemnde, che decenni pi tardi ideer il motore Viking del razzo europeo Arianna. b) Loccultamento del passato. Nessuno di questi tecnici con una sola eccezione sar indagato per le responsabilit nella conduzione della fabbrica di missili a Dora, cio del KZ Mittelbau. Va poi notato che soltanto negli Stati Uniti il gruppo di scienziati tedeschi rimane protagonista anche nel passaggio alla ricerca spaziale (dopo una prima fase incentrata sulla ricerca di nuove armi). Il ricordo di Dora e del ruolo degli scienziati nazisti viene occultato sia negli Stati Uniti sia in Gran Bretagna. La spettacolarit del programma spaziale (satellite Explorer I, febbraio 1958; programma Apollo, 1961; Saturno V, no-
Cfr. i saggi citati di Sellier e di Lazzero rispettivamente alle pp. 163 e 145-146.
102
Capitolo II
vembre 1968, seguto dallo sbarco sulla Luna due anni dopo) fa di von Braun una figura di primo piano della ricerca tecnologica, e invano le associazioni dei deportati francesi protestano fin dal 1966: le loro denunce sono ignorate. Solo alla fine degli anni Settanta si solleva il velo sulla tragedia di Dora e sulle responsabilit degli scienziati, soprattutto grazie a un libro-testimonianza di un deportato francese, Jean Michel, dal titolo significativo: Dora. Nellinferno del campo di concentramento dove gli scienziati nazisti preparavano la conquista dello spazio (Parigi, 1975), tradotto in inglese quattro anni dopo.
Bibliografia. Uno dei pi recenti lavori su Dora in francese: Andr Sellier, Histoire du camp de Dora, Paris, La Dcouverte, 1998, 537 pp., con ricca bibliografia di riferimento (una delle pi aggiornate, complete e interessanti), anche scientifica. specificamente dedicato a Dora il capitolo V (La fabbrica pi crudele dEuropa) in Ricciotti Lazzero, Gli schiavi di Hitler. I deportati italiani in Germania nella seconda guerra mondiale , Milano, Mondadori, 1996, pp. 109-153 / 163-195. La memorialistica italiana su Dora non molto ricca e comprende un solo resoconto di una matricola zero (quello di Pialli). Ecco un elenco quasi completo: Osiride Brovedani, Linferno dei vivi. Memorie di un deportato, Trieste, Grafad, 1971; Gregorio Pialli, Una voce da Buchenwald. Campo Dora-Buchenwald, Verona, Bettinelli, 1966 / Vicenza, Scuola Grafica I.S.G., 19732 (edizione riveduta e aggiornata); Carlo Slama, Lacrime di pietra. Gli orrori del Lager segreto dove si costruivano le V2, Milano, Mursia, 1980 sgg.; Calogero Sparacino, Diario di prigionia. Un siciliano nel Lager, Milano, La Pietra, 1984 (ora disponibile in rete: www.deportati.it).
Il KL di Ravensbrck
Lucio Monaco Ubicazione e topografia Ravensbrck, campo di concentramento femminile, si trova nei pressi di Frstenberg sulla Havel, 90 km a Nord di Berlino, nella regione del Brandeburgo. dunque un Lager insediato nel cuore del Reich, per la sua vicinanza al centro del potere politico. La struttura del Lager grosso modo rettangolare, anche se si modificata con il tempo. Cinto da un muro alto 4 metri, attrezzato con corrente ad alta tensione, il Lager fu in origine dotato di 14 baracche, di cui ciascuna ospitava da 200 a 250 donne, pi linfermeria e i servizi. Dopo gli ampliamenti, il settore delle prigioniere venne a comprendere una sessantina di baracche (Blcke) allineate dentro due rettangoli adiacenti. Il crematorio si trovava a met strada fra il Lager e il Lago Schwed (dove erano versate le ceneri). Fuori del campo, a Nord, cerano le installazioni industriali (Siemens). Vicino al Lager, separato dalla zona amministrativa SS, era ubicato il piccolo campo maschile. Circa 1 km a Ovest esisteva il sottocampo di Uckermark, o Jugendlager, concepito allinizio (1942) come campo di rieducazione per giovani tedesche, ma diventato dalla fine del 1944 il luogo di eliminazione delle prigioniere malate e inabili al lavoro prelevate nel campo principale. Storia e cronologia del campo 1937-1939: i primi progetti di centri di detenzione esclusivamente riservati alle donne come Ravensbrck risalgono al 1936 (la fortezza casa di lavoro di Moringen, presso Hannover).1 Dalla fine del 1937 le donne di Moringen, che allinizio erano una settantina, vennero tutte trasferite nel centro di Lichtenburg, anchesso attivo dal 1933 ma diventato, dal 1937,
Bundesgesetzblatt 1977, al n. 957 dellelenco. Essa fu attiva fra il marzo 1933 e il marzo 1938, anche se soltanto negli ultimi due anni ebbe la funzione di accogliere esclusivamente donne tedesche internate.
Le guide della memoria
103
campo femminile (Frauenschutzlager); vi erano rinchiuse prigioniere di diversa provenienza: politiche, comuni, ebree, Testimoni di Geova, emigrate rientrate in Germania, donne accusate di reati contro la purezza razziale. Questi due KZ costituiscono il prototipo del campo di Ravensbrck, aperto il 15 maggio 1939 come unico campo destinato a ricevere esclusivamente detenute donne: al termine della sua costruzione (maggio 1939) vi confluiranno per prime proprio le circa 2.000 prigioniere di Lichtenburg. Lager femminile dalla parte delle detenute, Ravensbrck lo fu anche dalla parte della guarnigione: non per al livello delle strutture di comando, assegnate a uomini SS, riproducendo in tal modo la gerarchia dei sessi che fu tipica del Terzo Reich. Lorganizzazione del Lager non si differenziava da quella di tutti gli altri KL; il servizio di sorveglianza era svolto da 150 guardiane (Aufseherinnen) tre di loro nel dopoguerra saranno giustiziate alle dipendenze di una Oberaufseherin. Oltre a essere KL, Ravensbrck fu anche sede di campo daddestramento per le sorveglianti dei settori femminili dei KL (creati verso il 1941-42). Si calcola che fra il 1942 e il 1945 fossero state istruite a Ravensbrck circa 3.500 ausiliarie della SS. Quando Ravensbrck comincia a popolarsi di prigioniere, i KL hanno mutato la propria fisionomia rispetto ai primi campi selvaggi e al prototipo di Dachau. Nuove categorie si aggiungono a quella, dominante fino al 1936, dei politici: sono gli asociali (termine assai generico che pu comprendere una casistica piuttosto vasta, dal vagabondaggio alla microdelinquenza al disturbo mentale), i dissenzienti per ragioni religiose (a cominciare dai Bibelforscher, i Testimoni di Geova, Studiosi della Bibbia), gli zingari, gli ebrei (le leggi di No-
rimberga risalgono al 1935) e ancora i detenuti comuni, gli omosessuali, i politici arrivati a fine pena carceraria e non scarcerati. Un mutamento che riflette la politica di serrata nazificazione dellesercito e della diplomazia, attuata da Hitler per estendere in profondit il potere del partito su tutti i settori della societ tedesca, e che comporta un estendersi del numero dei KL. Questa composizione variegata appare nel campo dai primi mesi: il Block 1 assegnato alle politiche; il 2 alle zingare e alle asociali; il 3 alle Testimoni di Geova, e cos via nei mesi successivi. Oltre 400 zingare arrivano a giugno portando con s i loro bambini: si pu intravedere qui uno dei caratteri pi specifici e drammatici della deportazione femminile. 1939-1940: con le invasioni territoriali (Sudeti) e lo scoppio del conflitto, Ravensbrck si popola di unaltra categoria di deportate: le politiche straniere. la fase della internazionalizzazione dei KL. Nei Paesi conquistati si sviluppa la Resistenza nelle sue varie forme: a Ravensbrck arrivano prima le resistenti polacche (dal 23 settembre 1939), poi le cecoslovacche (dallagosto 1940). Accanto allinternazionalizzazione, il campo segue anche levoluzione del sistema concentrazionario, con il collegamento alleconomia e allindustria del Reich. Ancora in tempo di pace, nellinverno 1938-39, Himmler aveva fondato due societ, DEST e DAW,2 che avrebbero sfruttato il lavoro degli internati facendo capo allUfficio economico SS diretto da Oswald Pohl. Le SS si trasformano in imprenditori che realizzeranno affari colossali sia con le industrie di guerra (a partire dalla crisi del 1942) sia con i fabbricanti dinstallazioni di morte di massa (camere a gas, crematori). In questo processo, contrastato e contraddittorio (per lopposizione allattivit di Pohl da parte del capo della Gestapo, Heydrich, e di Eicke, capo dellIspettorato dei campi), sinseriscono le donne deportate, che popolano il loro campo a rit-
Cfr. supra, nota 1, p. 38.
104
Capitolo II
mo crescente: oltre 3.000 nellaprile 1940, oltre 4.000 in agosto. 1941: installato nel Lager uno stabilimento, di propriet SS, per la confezione di divise militari. Lo stabilimento (Industriehof) costruito da squadre di detenuti di Dachau, che edificheranno anche un piccolo Lager maschile (circa 2.000 prigionieri). In agosto scoppia unepidemia e il campo abbandonato a se stesso per alcune settimane, sorvegliato a distanza dalle SS. A settembre si attribuisce la matricola 7935. Ripresa in mano la situazione, le SS verso la fine dellanno inaugurano il sistema delle selezioni: le deportate anziane, malate o invalide vengono trasferite in altri Lager o centri di eliminazione. 1942: lattivit produttiva di Ravensbrck conosce un grande sviluppo. La Siemens vi trasferisce una filiale, collocata oltre la cinta del Lager, che utilizzer la manodopera del campo; vengono ampliati o costruiti nuovi blocchi, capannoni, magazzini: siamo nel 1942, Ravensbrck diventata una citt che passa nel corso dellanno da 7.000 a 10.000 abitanti (ma le matricole toccano il numero 15558 in dicembre). Lo stesso anno vede avviarsi linfamia delle sperimentazioni mediche: anche su questo versante la condizione delle donne deportate, specie se appartenenti alle categorie inferiori come le slave (in questo caso le polacche) eguaglia quella degli uomini (sottoposti a sperimentazioni analoghe a Dachau e Sachsenhausen). Unottantina di prigioniere polacche, russe, Testimoni di Geova tedesche, e una belga sono sottoposte a esperimenti di vivisezione fra lagosto 1942 e il gennaio 1943. Molte muoiono, altre verranno uccise in seguito. Un piccolo gruppo sopravviver grazie alla solidariet delle compagne e potr testimoniare contro i responsabili degli esperimenti.
Alla fine del 1942, quando erano gi iniziati gli invii ad Auschwitz (deportate ebree e zingare), e la curva della mortalit era in costante ascesa, si calcola che le deportate presenti nel Lager fossero salite a 10.800. Intorno al 1942 il sistema del lavoro ormai orientato verso lindustria di guerra si espande, e Ravensbrck, citt concentrazionaria, si circonda di sottocampi e Kommando di lavoro esterni (saranno pi di 40 nel 1945) oppure affitta la manodopera ad altri KL. Per tutti scrive Lidia Beccaria Rolfi basti ricordare la miniera di sale di Beendorf, [] dove le detenute hanno lavorato alla produzione di pezzi di aereoplano in una fabbrica sotterranea installata a 600 metri sotto terra, in una vecchia miniera di sale. Levacuazione di queste deportate [nel 1945] fra le pi drammatiche, un viaggio dinferno durato 12 giorni in vagone bestiame, in condizioni cos inumane che quando il treno arriva a Neuengamme ha abbandonato sul percorso circa 1.000 cadaveri.3 1943: in aprile immatricolata la prigioniera n. 19.244. Si costruisce il crematorio. La funzione del campo per limpiego di manodopera femminile nelleconomia di guerra diventa sempre pi massiccia: le donne sono impiegate in ogni tipo di lavoro, dalla produzione industriale ai lavori pesanti, al trasporto di materiali edilizi. Si completa il sistema dei sottocampi e il numero delle prigioniere cresce progressivamente, nonostante le strutture restino quelle del 1942 (ne consegue il sovraffollamento del campo). Un tentativo di eliminare le polacche sopravvissute agli esperimenti medici viene sventato da una ribellione delle compagne di Block. 1944: la produzione industriale bellica spin-
3 L. Beccaria Rolfi, Il Lager di Ravensbrck. La popolazione femminile dalla nascita del campo alla liberazione, in L. Monaco (cur.), La deportazione femminile nei Lager nazisti, Milano, FrancoAngeli, 1995, p. 36.
Le guide della memoria
105
ta al massimo e le prigioniere crescono costantemente di numero. Il numero di matricola passa dal 38818 di aprile al 91748 di dicembre, le prigioniere presenti a un appello da 24.720 a 43.733 negli stessi mesi (questi dati sono stati conservati grazie a prigioniere francesi addette agli uffici di registrazione). Per aumentare la capacit ricettiva del campo viene installata una grande tenda su una zona paludosa (Block 25) in cui furono ammassate e morirono migliaia di prigioniere, specialmente polacche. Allo sfruttamento intensivo per il lavoro consegue una crescita della mortalit, accanto alleliminazione fisica degli elementi non desiderati (anziane, donne incinte, prigioniere con problemi psicologici). Il 1944 vede un afflusso di massa di nuovi arrivi da tutte le parti dEuropa, Italia compresa, e anche da Auschwitz (soprattutto di polacche da Birkenau). La filiale della Siemens, posta fuori della recinzione, si organizza e diventa un vero e proprio sottocampo, con cinque blocchi dormitorio, un blocco di servizi estremamente primitivo e un blocco per la cucina (le malate sono inviate al campo principale). Il tutto cinto da filo spinato sotto tensione. 1945: lappello del 15 gennaio registra 46.070 prigioniere e 7.848 prigionieri. Al sovraffollamento del campo le SS rimediano con trasferimenti mediante selezione al campo di Uckermark, dove le prigioniere vengono uccise con veleno e con iniezioni. Accanto al crematorio sinstalla una camera a gas Zyklon-B, adattando una baracca di legno, del cui funzionamento si occupano, dalla fine di gennaio, alcune SS trasferite da Auschwitz (abbandonato dai nazisti il 18 gennaio). Il Sonderkommando di prigionieri addetti alla camera a gas e alla cremazione sar sterminato dalle SS il 25 aprile 1945, ma vi sono testimonianze di prigionieri e dichiarazioni giurate di SS che permettono di ricostruire la vicenda. In totale, le vittime della camera a gas di Ravensbrck assommano a circa 6.000. Unaltra camera a gas in muratura era in
fase di costruzione ma fu distrutta dalle SS ai primi di aprile per non lasciare tracce di questa tecnica di sterminio (si trattava di una struttura complessa, simile a quelle di Hartheim o di Birkenau, anche se di minori dimensioni). Nel marzo 1945 tutte le deportate francesi classificate NN (Nacht und Nebel, cio condannate a morte), e un gruppo di donne zingare con i bambini vengono inviate a Mauthausen, da dove le pi anziane e malate e le madri con bambini verranno rinviate a Bergen Belsen. In aprile vengono liberate, dopo trattative con la Croce Rossa, pi di 300 francesi, norvegesi, belghe e olandesi. Il 26 aprile il campo evacuato con una terribile marcia della morte diretta a Nord. Le superstiti sono raggiunte e liberate dallArmata Rossa a Schwerin, e lo stesso avviene per alcune centinaia di prigioniere rimaste, perch malate o incapaci di muoversi, nel Lager principale. Il lavoro Il lavoro inutile. Praticato soprattutto nella fase della quarantena, o a scopo punitivo, ecco come lo descrive Lidia Beccaria: Il lavoro consiste nel prendere una palata di sabbia nel mucchietto di sinistra e gettarla in quello di destra dove la compagna di fianco esegue la medesima operazione. La sabbia viaggia in tondo e ritorna al luogo di partenza dopo essere passata sulla pala di tutte le deportate addette al lavoro. Se la compagna di sinistra pi forte, se sa usare la pala, e se non ha ancora capito o non vuole capire il gioco delle aguzzine, il mucchio di sinistra cresce, lSS se ne accorge, incomincia a urlare: Schnell! e spesso picchia con le mani o con il frustino la deportata che non sa reggere al ritmo, che non si adegua al tirocinio del lavoro a catena, e la malcapitata deve per forza accelerare i tempi. Il lavoro della sabbia un lavoro che massacra: avviene per noi sotto il sole di luglio che batte sul capo scoperto, non concede un attimo di sosta, elimina
106
Capitolo II
tutti i tempi morti, perch durante quelle ore proibito bere, fermarsi, accedere alla latrina (che non esiste). Sinterrompe a mezzogiorno, giusto il tempo per rientrare a passo di marcia al campo, correre nel blocco, consumare la zuppa velocemente, tornare; poi la danza in tondo della sabbia riprende e dura fino a sera. La giornata non finisce mai, il lavoro spezza le reni, le mani non abituate a tenere la pala gonfiano e si riempiono di vesciche, la testa scoppia per il caldo e la fatica. Alla fatica fisica si aggiunge la rabbia per quel lavoro inutile, assurdo, che non possibile inquadrare nemmeno nella logica del profitto, perch distrugge la manodopera prima ancora di averla sfruttata nella produzione.[] E tuttavia anche questo lavoro senza senso ha uno scopo: a Ravensbrck tutto ha un senso, se visto nella logica della citt concentrazionaria. La vita inattiva delle deportate nel blocco di quarantena [] temuta dalle SS, perch pu trasformarsi in unorganizzazione di resistenza alla disumanizzazione e in una scuola di educazione politica.4 Il lavoro produttivo. Lo sfruttamento della manodopera schiavile costituita dalle deportate cominci con linstallazione della sartoria di propriet SS. Il reparto era comandato da una SS, Gustav Binder, particolarmente feroce, capace di picchiare fino alla morte, senza ragione evidente, le prigioniere; viveva con la moglie e il figlio nellarea riservata alle SS. Le deportate erano poi impiegate nelle attivit produttive dei vari sottocampi (in tutto una quarantina) di cui il pi vicino era a poche decine di metri, il Campo Siemens (Siemenslager). Ecco come lo descrive Lidia Beccaria: Il lavoro si svolge in due turni: dodici ore per il turno di giorno [] e dodici ore di
4 5 6
notte [] Giorno e notte le schiave lavorano a pieno ritmo, senza tempi morti, senza nemmeno andare alle latrine. Le operaie assenti per malattia sono sostituite immediatamente, quelle che non dnno la buona produzione sono licenziate e rimpiazzate [].5 Le prigioniere di Ravensbrck, oltre a lavorare nei sottocampi, potevano anche essere affittate alle amministrazioni di altri Lager per svolgere attivit produttive. Svolgere unattivit produttiva poteva rappresentare una possibilit di sopravvivenza, ma significava in qualche misura collaborare con i nazisti. Ecco perch si svilupparono comunque varie forme di resistenza, da quella estrema del rifiuto del lavoro (che coinvolse le Testimoni di Geova) alle forme di sabotaggio, spesso scoperte e punite con la morte. Il lavoro disponibile. Le squadre venivano formate ogni giorno, con compiti diversi, scegliendo le prigioniere dalla colonna delle disponibili (verfgbaren), non impegnate in Kommando stabili. Sono i lavori pi duri e massacranti: bonifica dei terreni paludosi lungo le rive del lago, rimboschimento di zone brulle, taglio di pini, carico e scarico di vagoni e di battelli, [] pulizia dei pozzi neri, disinfestazione.6 Lo sterminio: esperimenti medici e selezioni Nel Lager si pratic sistematicamente lo sterminio delle persone improduttive (per et o per malattia) seguendo sistemi diversi a seconda dei periodi e del livello di affollamento: a) trasporti neri: le prigioniere selezionate come inabili erano inviate in luoghi di sterminio (Majdanek, Hartheim e altri luoghi col-
L. Beccaria Rolfi / A. M. Bruzzone, Le donne di Ravensbrck, Torino, Einaudi, 1978, pp. 33-34. Ibidem, p. 83. Ibidem, p. 73.
Le guide della memoria
107
legati alle Operazioni T4 e 14f13). Il primo trasporto di questo tipo risale al dicembre 1941. Poi i trasporti neri si susseguirono al ritmo di due o tre al mese, fino alla fine di novembre-inizio dicembre 1944. Effettuati di notte, quasi clandestinamente, non comprendevano che 50-70 donne alla volta.7 Altri trasporti simili potevano essere molto pi numerosi, come quello diretto a Majdanek (gennaio 1944, 900 prigioniere e qualche decina di bambini); b) Jugendlager: le inabili erano inviate pure al vicino sottocampo di Uckermark, che con i suoi 6 Blcke divent, dalla fine del 1944, campo di eliminazione, attuata con metodi vari (avvelenamento, inedia, assideramento e abbandono). Anche a Uckermark si svolgevano ulteriori selezioni per linvio nella camera a gas del Lager principale; c) esperimenti medici: quelli pi noti si svolsero fra lagosto 1942 e la primavera 1943 nel reparto di osteologia chirurgica del medico SS Karl Gebhardt. Con il pretesto di sperimentare rimedi per la cancrena gassosa e altre patologie legate alle ferite da arma da fuoco, si effettuarono interventi disumani e crudeli: asportazioni di ossa, induzione di infezioni, mutilazioni (in realt tali pratiche vanno viste anche alla luce delle forti rivalit fra ambienti medici SS). Si svolsero inoltre pratiche di sterilizzazione e di aborti forzati. C da ricordare che i numerosi neonati furono in un primo tempo uccisi subito, poi lasciati morire di fame in un apposito reparto, il Kinderzimmer (settembre 1944-aprile 1945). Qui nacquero (nel periodo di tempo indicato) almeno 500 bambini. Solo cinque sopravvissero grazie alla solidariet delle prigioniere. Molti bambini temporaneamente sopravvissuti vennero inviati in trasporto a Bergen Belsen, insieme alle madri; d) camere a gas: come gi detto prima, a Ravensbrck fu attuato anche lo sterminio mediante gas Zyklon-B, per un totale di circa 6.000
vittime, a partire dal gennaio 1945. Lintera organizzazione faceva capo alla SS Johann Schwarzhuber, gi comandante ad Auschwitz fino allottobre 1944, trasferito a Ravensbrck nel gennaio del 1945. Le vittime rientravano perlopi nella categoria delle malate e delle inabili al lavoro e venivano in genere trasferite in precedenza al campo di Uckermark; di l erano inviate alla camera a gas, ma il trasferimento si registrava come trasferimento a Mittwerda, in modo da non farlo figurare nelle statistiche della mortalit del campo. Non sono comprovate occasionali uccisioni con il gas in ambienti provvisori (come i vagoni ferroviari). Le cifre Il calcolo delle deportate presenta numerose difficolt. Dallapertura del KL al febbraio del 1945 si calcola che le deportate immatricolate a Ravensbrck siano state 107.753. Partendo da questa cifra come approssimata per difetto, si proposta la cifra totale di 125.000 persone deportate in Lager. In termini generali i gruppi nazionali erano in percentuale cos ripartiti: polacche 24,9%; tedesche 19,9; russe e ucraine 19,l; ebree di varie nazionalit 15,l; altre 2,2. Le francesi erano 793; le zingare, forse, 534; le belghe 279; le ceche 179; le jugoslave 173. Difficile anche il calcolo delle vittime, per la pratica di registrare come trasferite numerose deportate inviate alla morte. Secondo alcune stime, le vittime sarebbero state circa 90.000. Le italiane Il primo convoglio di italiane deportate comprendeva 14 politiche piemontesi, giunte da Torino il 30 giugno 1944. Seguirono almeno 7 trasporti (ma la cifra andr probabilmente aumentata) per un totale, approssimato per difetto, di 313 persone (lultimo arriv il 16 gennaio 1945). Questa cifra aumenter sicuramente con il proseguimento delle ricerche an-
G. Tillion, Ravensbrck, Paris, Seuil, 1988, p. 221.
108
Capitolo II
cora in corso, che hanno individuato, a tuttoggi, 919 nomi di italiane e italiani immatricolati a Ravensbrck, provenienti sia dallItalia sia da altri Lager. Scrive Lidia Beccaria Rolfi: A parte poche eccezioni, credo comunque che le italiane in campo abbiano avuto un destino abbastanza simile: arrivate tardi, quando gi Ravensbrck sovraffollato, sono partite in trasporti di lavoro o sono rimaste mescolate fra la folla anonima ed eterogenea del sottoproletariato con rari contatti con le privilegiate. Alcune, come me, riescono a risalire il primo scalino della scala sociale, a diventare operaie e ad arrivare a Siemens o al Betrieb, dove tuttavia hanno sempre una situazione peggiore di altre in quanto sono isolate, possono contare raramente sullappoggio di deportate di altre nazionalit, non ricevono pacchi n corrispondenza, devono comprare tutti gli oggetti essenziali con moneta pesante: razioni di pane e di zuppa. La maggior parte di quelle che sono rimaste sottoproletariato, verfgbar sempre, sono scomparse, travolte dalla macina del sistema che ha condannato a morte tutte, ma per prime le deportate non produttive.8
Bibliografia. Sono fondamentali le seguenti opere di memoria (in italiano): L. Beccaria Rolfi / A. M. Bruzzone, Le donne di Ravensbrck, Torino, Einaudi, 1978; M. Massariello Arata, Il ponte dei corvi. Diario di una deportata a Ravensbrck, Milano, Mursia, 1979; M. BuberNeumann, Prigioniera di Stalin e di Hitler, trad. it. di M. Margara, Bologna, il Mulino, 1994; M. Coslovich, Storia di Savina. Testimonianza di una madre deportata, Milano, Mursia, 2000. Fra gli studi si segnala: L. Monaco (cur.), La deportazione femminile nei Lager nazisti, Milano, FrancoAngeli, 1995 (Atti del Convegno internazionale di Torino, 20-21 ottobre 1994, con numerosi interventi su Ravensbrck). Sugli esperimenti medici si pu vedere: L. Sterpellone, Le cavie dei Lager. Gli esperimenti medici delle SS, Milano, Mursia, 1978, 19852.
Il KZ di Sachsenhausen e la sua storia
Lucio Monaco Situato a 35 km a Nord di Berlino, nei pressi di Oranienburg, il campo di Sachsenhausen fu di fatto aperto il 12 luglio 1936. Si tratta dunque del secondo Lager installato dai nazisti, dopo quello di Dachau (1933). In questa data (luglio 1936) presero possesso della prima baracca 50 deportati trasferiti dal KL di Esterwegen nello Emsland. Sempre da Esterwegen vi furono trasportati nel giro di tre settimane altri 1.000 detenuti, cui se ne aggiunsero altri provenienti da Lichtenburg (che divent campo femminile) e Sachsenburg. Gradualmente il KL di Sachsenhausen si configur come il pi grande KL della Germania settentrionale: dai 31 ettari del primo impianto, con attrezzature industriali e podere per il lavoro agricolo, si espanse fino a coprire 388 ettari, compresi gli edifici industriali e i quartieri per le SS. La sua pianta era quella di un gigantesco triangolo. Destinato in origine a circa 10.000 detenuti con 68 baracche ed edifici accessori per la produzione e la guarnigione, fin per comprendere oltre 210 baracche. Queste ultime si allineavano su quattro file a semicerchio intorno allAppellplatz. Il campo era cinto da un muro alto 2,7 m, con 9 torri di guardia, da filo spinato con corrente ad alta tensione e allesterno da cavalli di Frisia della larghezza di 1 m e 20. Nel 1940 nello Industriehof fu costruito il crematorio con due forni. Dallautunno 1941 fu avviato un programma di eliminazione sistematica e pianificata dei prigionieri di guerra sovietici. Fu innalzato un apposito Block denominato Centro di ricerche mediche, con annesso un crematorio. Il settore del campo in cui si trovava era isolato da un ulteriore muro di cinta che impediva la visuale. I prigionieri erano fucilati o impiccati, oppure uccisi in veicoli a gas (monossido di
L. Beccaria Rolfi / A. M. Bruzzone, op. cit., p. 107.
Le guide della memoria
109
carbonio) appositamente concepiti. Fu costruita anche una camera a gas che funzionava con Zyklon-A (liquido in capsule) e con il pi noto Zyklon-B: un dispositivo automatico permetteva lapertura del contenitore del gas e un ventilatore spingeva il gas allinterno della camera. Un aspiratore aerava il locale; i corpi venivano poi avviati al crematorio. Questo ciclo di uccisione e distruzione programmata in sostanza simile a quello dei campi di eliminazione immediata come Treblinka o Birkenau. Non tuttavia possibile indicare il numero complessivo dei deportati uccisi nella camera a gas. Sicuramente, oltre ai 18.000 sovietici eliminati nel campo, vi fu uccisa una parte dei 4.000 deportati malati nel febbraio 1945; verso la fine del 1944, secondo una testimonianza del Rapportfhrer Bhm, furono gassate 27 lavoratrici coatte dellEst. Oltre a essere uno dei pi estesi KL sul territorio del Reich, Sachsenhausen divent una sorta di citt delle SS, con grandi baraccamenti e depositi, in quanto sede centrale dellIspettorato di tutti i KL, alla cui testa fu posto Theodor Eicke, lex comandante di Dachau. Il trattamento particolarmente feroce che fu praticato nei confronti dei deportati a Sachsenhausen responsabile dellelevata mortalit registrata: fra il gennaio e il marzo del 1940 morirono 2.000 dei 12.000 deportati presenti, sterminati da epidemie, dal freddo, dalla fame. In un primo tempo i pi deboli erano smistati su Dachau, poi furono spediti alleliminazione alla volta di Auschwitz, Majdanek e degli altri campi di sterminio fuori del Reich. La massima mortalit colp comunque i prigionieri sovietici. Nel novembre del 1938 aveva avuto inizio la deportazione degli ebrei tedeschi, cui si aggiunsero 1.200 studenti cecoslovacchi dopo loccupazione del 1939 e, fra gli altri gruppi, i minatori francesi deportati dopo gli scioperi del Pas de Calais. possibile ricostruire, anche se la docu-
mentazione incompleta, una tabella indicativa delle presenze nel KL: 31 dicembre 1941: 10.705 deportati; 31 dicembre 1942: 28.224; 31 marzo 1944: 47.709; 31 gennaio 1945: 56.624; 20 aprile 1945: 36.687. tuttavia difficile stabilire con certezza quanti deportati siano passati per il campo di Sachsenhausen; il tribunale sovietico che nel 1947 condann le SS del campo valut i deportati a Sachsenhausen sulle 200.000 unit, di cui almeno 100.000 hanno trovato la morte. Dal dicembre del 1944 gli eccidi in massa si susseguirono in concomitanza con levacuazione di altri KL che si riversavano su Sachsenhausen sotto lincalzare dellavanzata sovietica. Nella graduatoria dei gruppi nazionali che ebbero il maggior numero di vittime si trovano al primo posto i sovietici, seguti da polacchi, tedeschi, francesi, olandesi, belgi, norvegesi e altri ancora. La mortalit a Sachsenhausen fu alimentata dal rigore stesso delle pene corporali. Strafexerzieren e Strafsport (tra cui il cosiddetto Sachsengruss: fare flessioni per ore con le braccia incrociate dietro la testa) erano modi tanto diversi quanto inutili e sadici per spossare i deportati, al pari delle fustigazioni, del palo, degli appelli in piedi per ore al gelo sino allo sfinimento. Ancor pi metodiche erano le torture che avvenivano nel Bunker, il carcere del KL. Le forche servivano per esecuzioni segrete o pubbliche, a scopo di intimidazione, specie per impedire tentativi di fuga. Le celle disolamento, in cui fu rinchiuso anche il pastore Martin Niemller e furono uccisi numerosi politici, e soprattutto la compagnia di punizione (i cui componenti erano costretti a marciare anche per 50 km al giorno con zaini carichi di 15 kg di sabbia), fecero parte del complesso organizzato per lassassinio premeditato dei deportati. Tra i diversi eccidi, si ricorda quello dell11 ottobre 1944 in occasione del quale furono fucilati, fra gli altri, tre ex deputati comu-
110
Capitolo II
nisti al Reichstag (Ernst Schneller, Mathias Thesen e Gustl Sandtner). Del lavoro dei deportati nei 61 sottocampi di Sachsenhausen profittarono anzitutto le imprese economiche della SS, in particolare la DAW e la DEST,1 ma anche un folto gruppo di industrie private che noleggiavano i deportati pagando al comando del KL un prezzo ancora pi alto di tali imprese. Le SS lucravano poi anche sullo sfruttamento dei cadaveri e sulla rapina dei valori asportati ai prigionieri e depositati presso la Reichsbank. Tra le industrie dellarea berlinese che sfruttarono i deportati di Sachsenhausen si citano almeno Demag, Heinkel, Henschel, Argus, DaimlerBenz, IG-Farben, Brabag, UFA, Siemens, AEG, Registratori Krupp. Oltre al lavoro, mezzo diffuso di sterminio a Sachsenhausen fu rappresentato dalla pratica degli esperimenti medici eseguiti sui deportati nella cosiddetta infermeria modello (Block di Patologia), che in realt era una vera e propria camera di tortura. Vi furono sperimentati nuovi gas, nuovi farmaci contro il tifo petecchiale, la tubercolosi, lepatite epide-
mica e per il rallentamento dellattivit cardiaca, leffetto di nuove granate e di pallottole venefiche. Si testarono unguenti contro le ustioni al fosforo. Questultima risultava una pratica particolarmente dolorosa perch i detenuti dovevano essere per prima cosa ustionati. Il 10 aprile 1945 il campo principale sub un grave bombardamento aereo. Sotto lincalzare dellavanzata sovietica, il 21 aprile 1945 le SS ordinarono levacuazione, trasformatasi in una lunga teoria di detenuti avviati a marce forzate verso il Mar Baltico che lasciava, strada facendo, una scia ininterrotta di cadaveri. Le prime truppe sovietiche che arrivarono a Sachsenhausen allalba del 22 aprile liberarono i superstiti. Questi erano in gran parte ammalati che non avevano potuto essere evacuati e furono assistiti da medici sovietici e polacchi, impegnati poi a contenere ulteriori decessi. Italiani deportati a Sachsenhausen Le pi recenti ricerche hanno rintracciato 421 nominativi di italiani deportati a Sachsenhausen, direttamente o da altri Lager, fra cui risultano 10 donne provenienti dallIstria e dalla Venezia Giulia. Antonio Temporini (19222001), che abit a Moncalieri dal 1946, fu deportato anche a Sachsenhausen-Oranienburg (matricola 72496). Anna Cherchi, prigioniera a Ravensbrck, fu portata nel Blocco di Patologia di Sachsenhausen per esservi sottoposta a una sperimentazione pseudomedica, come racconta nei video gi citati, 44145 Anna e La necessit di sopravvivere, questultimo allegato al volume.
Lingresso al Lager di Sachsenhausen (marzo 2001)
38
Cfr. supra, nota 1, p. 38.
111
Capitolo III - Percorsi di memoria
Scienza, razza, biologia: un percorso possibile
Rosella Cocciolo Il cos tenero e delicato zinco, cos arrendevole davanti agli acidi, che se ne fanno un solo boccone, si comporta invece in modo assai diverso quando molto puro: allora resiste ostinatamente allattacco. Se ne potevano trarre due conseguenze filosofiche tra loro contrastanti: lelogio della purezza, che protegge dal male come un usbergo; lelogio dellimpurezza, che d adito ai mutamenti, cio alla vita. Scartai la prima, disgustosamente moralistica, e mi attardai a considerare la seconda, che mi era pi congeniale. Perch la ruota giri, perch la vita viva, ci vogliono le impurezze, e le impurezze delle impurezze Ci vuole il dissenso, il diverso, il grano di sale e di senape: il fascismo non li vuole, li vieta, e per questo tu non sei fascista; vuole tutti uguali e tu non sei uguale perch ebreo sono anchio Sono io limpurezza che fa reagire lo zinco, sono io il granello di sale e di senape. Limpurezza, certo: poich proprio in quei mesi iniziava la pubblicazione di La Difesa della Razza, e di purezza si faceva un gran parlare, ed io cominciavo ad essere fiero di essere impuro. Primo Levi, Zinco, da Il sistema periodico
Le origini delluomo moderno Il cervello delluomo, 300.000 anni fa, aveva dimensioni uguali alle nostre; anzi, un volume un po superiore a quello attuale, anche se ci non implica che la struttura interna fosse uguale alla nostra. Nel corso dei 100.000 o 200.000 anni successivi scompaiono le parti pi primitive della fisionomia di Homo sapiens arcaico e si assiste a una evoluzione degli strumenti; ma possibile che luomo abbia dovuto subire ulteriori cambiamenti per giungere allattuale livello di evoluzione. La maggior parte delle scoperte importanti di resti fossili stata fatta scavando, spesso non a scopi archeologici, soprattutto in Europa, dove vi unalta densit di popolazione pi che altrove e quindi una maggiore necessit di costruire. Questo ci spiega perch lEuropa sia stata molto studiata, sia dal punto di vista archeologico che paleoantropologico e ci abbia fornito grandi quantit di materiale. Ed proprio in Europa che, negli ultimi 200.000 anni, si sviluppa un tipo particolare di Homo sapiens, luomo di Neanderthal, mentre in Africa si trova un sapiens arcaico pi simile alluomo moderno. LAfrica sicuramente al centro dellorigine e dellespansione delluomo, anche se non tutti i paleoantropologi concordano: alcuni danno molta importanza alle scoperte fatte in Cina, dove i reperti di Homo erectus sarebbero somiglianti ai cinesi attuali. Questi studiosi sostengono che luomo moderno non si sia sviluppato in unarea geografica particolare ma nel mondo intero e quindi sono a favore di unorigine policentrica cio di una ipotesi di evoluzione multiregionale, secondo la quale le popolazioni di Homo erectus migrarono dallAfrica in tempi remoti e si evolsero poi localmente in Homo sapiens, mantenendo reciproche relazioni grazie a un flusso genico.
112
Capitolo III
Altri paleoantropologi sostengono lipotesi africana, secondo la quale lantenato delluomo moderno era africano; esso si sarebbe evoluto in diverse specie di Homo sapiens arcaiche, rimpiazzate successivamente dalla linea delluomo moderno. Le testimonianze pi antiche dei nostri diretti progenitori sono due e vengono entrambe dal Sudafrica: le caverne dette Border Caves e quelle alla foce del fiume Klasies. La datazione dei due siti compresa fra i 130.000 e 74.000 anni fa per il primo, fra i 15.000 e 74.000 anni fa per il secondo. Altri siti archeologici, abitati da uomini di tipo moderno, sono stati scoperti in Medio Oriente: il pi importante in Qafzeh (Israele) datato fra i 109.000 e 92.000 anni fa. Grazie a questi ritrovamenti si conferma lipotesi che luomo moderno abbia avuto origine in Africa, ipotesi suffragata dal fatto che lHomo sapiens arcaico africano (che in precedenza viveva in Africa) molto pi simile alluomo moderno che non lHomo sapiens arcaico di altre parti del mondo. Vari tipi di Homo sapiens arcaico abitavano diverse parti del Vecchio Mondo gi 300.000 anni fa: Neanderthal in Europa 200.000 anni fa, e luomo moderno in Africa del Sud e Israele 100.000 anni fa; successivamente, nellarco di tempo di poco pi di 60.000 anni, lHomo sapiens sapiens raggiunge tutti gli angoli del pianeta mostrando di sapersi avventurare e adattare. Sembra che luomo moderno abbia raggiunto la Nuova Guinea e lAustralia circa 60.000 anni fa costruendosi delle imbarcazioni per attraversare il mare, che a quei tempi era meno esteso ma rappresentava comunque un ostacolo da superare solo con mezzi nautici. In Australia si trovano siti archeologici datati intorno a 55.000-60.000 anni fa e resti fossili di uomo moderno che risalgono a 40.000-35.000 anni fa. In Europa luomo moderno giunge un po pi tardi: probabilmente provenendo da Oriente arriva in Francia intorno ai 35.000 anni fa. In seguito raggiunge le parti pi fredde dellAsia e successivamente le Americhe intorno ai 15.000 anni fa approfittando del fatto che lo Stretto di Bering, nel corso dellultima glaciazione, si presentava come terra emersa (TAV. 1).
TAV. 1 - Espansione delluomo moderno. (Fonte: L. e F. Cavalli-Sforza, Chi siamo, p. 182)
Percorsi di memoria
113
Eva africana e il DNA mitocondriale Una nuova ipotesi, basata sul modello africano e sugli studi del DNA mitocondriale, sostiene che una popolazione di uomini moderni visse in Africa 200.000 anni fa, cominci a migrare attraverso il Medio Oriente verso lAsia e lEuropa circa 100.000 anni fa sostituendo, con il suo arrivo, Homo erectus e Homo neanderthalensis. Questa ipotesi nasce da una ricerca di laboratorio sui mitocondri condotta da Allan Wilson, un biochimico che ha lavorato allUniversit di Berkeley in California. Nel gennaio del 1987 A. Wilson e i suoi collaboratori pubblicano su Nature Mitochondrial DNA and Human Evolution, un articolo destinato a segnare unepoca:
A giudizio di Wilson e colleghi, i dati relativi al DNA mitocondriale indicano che la trasformazione dalle forme arcaiche di Homo sapiens a quelle moderne avvenuta in Africa, prima che altrove, in un periodo compreso fra 100.000 e 140.000 anni fa, e che tutti gli esseri umani attuali discendono da quella popolazione africana.1
Lo studio di Wilson e colleghi la prova pi convincente, a livello molecolare, a sostegno dellipotesi dellorigine delluomo moderno da una popolazione africana primitiva. Ma prima di spiegare questa ipotesi necessario parlare un po di Biologia. (TAV. 2) I meccanismi che regolano leredit biologica in tutti gli organismi viventi sono controllati dal nucleo e in particolare dai suoi cromosomi, dai geni e dal DNA. I cromosomi sono strutture costituite da DNA e proteine, contengono linformazione genetica e sono visibili soltanto durante i processi di divisione cellulare. Il gene ununit ereditaria presente nel cromosoma, sequenza di nucleotidi che svolge una funzione specifica come codificare la sintesi di una molecola di RNA o di una proteina. Il DNA (acido desossiribonucleico) una macromolecola costituita da zucchero, fosfato e base azotata (nucleotide), ha una struttura elicoidale a doppio filamento e contiene tutte le istruzioni genetiche. La trasmissione dei caratteri ereditari dai genitori ai figli avviene al momento del concepimento, quando lo spermatozoo feconda la cellula uovo: in queste cellule germinali contenuto tutto il DNA destinato a formare un nuovo individuo e a renderlo
1
R. Lewin, Le origini delluomo moderno, trad. it. di I. C. Blum, Bologna, Zanichelli, 1996, pp. 89-90.
TAV. 2 - La cellula
114
Capitolo III
simile ai suoi genitori. I loro nuclei partecipano in egual modo alla formazione del nuovo individuo, portando ognuno un corredo cromosomico quantitativamente eguale (23 cromosomi) ma qualitativamente diverso come patrimonio genetico ereditario; il citoplasma della nuova cellula (zigote) fornito invece esclusivamente dalluovo. (TAV. 3) I mitocondri sono organelli presenti in tutte le cellule degli organismi superiori, talvolta a decine di migliaia, che si occupano della produzione di ATP. Si pensa che in origine fossero batteri, che si sono legati in simbiosi con le cellule; si riproducono indipendentemente dal nucleo, seppure sotto il suo controllo. Il mitocondrio per indipendente dal resto della cellula in quanto provvisto di un suo piccolo cromosoma costituito, come tutti i cromosomi, da DNA e, in un cromosoma umano, si compone di 15.600 nucleotidi. Un fatto importante da considerare che i mitocondri sono trasmessi ai figli solo dalla madre. Quindi, il DNA dei mitocondri di due fratelli identico, anche se hanno un padre diverso. Nel DNA mitocondriale, per, ogni tanto, hanno luogo dei piccoli cambiamenti (succede anche nel DNA nucleare) che chiamiamo mutazioni, per cui uno dei quindicimila e pi nucleotidi viene sostituito da un altro. Da quel momento in poi i discendenti di una stessa madre avranno quel filamento di DNA mitocondriale mutato. Le mutazioni sono un fenomeno abbastanza raro, e quando osserviamo il DNA mitocondriale di individui che hanno la stessa madre non ne troviamo; se prendiamo individui senza legami parentali le differenze si trovano. Il DNA mitocondriale offre dati facilmente interpretabili ai fini della ricostruzione di alberi filogenetici. Esso accumula le mutazioni da 5 a 10 volte pi velocemente del DNA nucleare ed utile per documentare tempi evolutivi relativamente brevi. Le indagini di Allan Wilson e collaboratori rivelano che due individui che differiscono per un solo nucleotide hanno ascendenti comuni pi vicini nel tempo rispetto a individui che differiscono per due o pi nucleotidi e che la prima separazione nellalbero del DNA mitocondriale umano ha avuto luogo 190.000 anni fa, data di nascita della cosiddetta Eva africana. Quindi lidea che tutto ha avuto origine in Africa: Homo abilis e Homo erectus si sono originati in Africa; le osservazioni archeologiche suggeriscono la stessa cosa per luomo moderno. Ma quando avvenuto tutto ci? Per Homo habilis due milioni e mezzo di anni fa; Homo erectus ha lasciato lAfrica un milione di anni fa e Homo sapiens sapiens 100.000 anni fa, poich a partire da questa data troviamo tracce di uomo moderno in Africa e Medio Oriente. La data indicata da A. Wilson di 190.000 anni ed in accordo con lorigine africana, ma come giustifichiamo la
TAV. 3 - DNA
Percorsi di memoria
115
differenza tra i 190.000 anni suggeriti dalle ricerche sul DNA mitocondriale e i 100.000 anni dei reperti archeologici trovati in Sudafrica e Israele? I 190.000 anni in realt segnano linizio della prima mutazione avvenuta nel DNA mitocondriale di una singola donna, la cui figlia risultata diversa dagli altri. I discendenti di quella donna hanno avuto destini geografici diversi: molto probabilmente non hanno lasciato subito lAfrica, anzi devessere trascorso molto tempo fra lorigine della mutazione e il formarsi di un gruppo di discendenti che dal continente africano penetr in Medio Oriente e in Arabia. La data della migrazione anteriore a quella del ritrovamento dei primi crani fossili in Israele ed pi tarda di quella in cui avvenuta la mutazione mitocondriale. Le date mitocondriale e archeologica sono diverse: la prima pi antica della seconda. Siamo diversi
Per le attuali popolazioni il termine razza andrebbe bandito, sostituito dallespressione descrittiva neutra gruppo etnico.2
Le differenze che vi sono tra gli individui sono differenze dovute a diversi fattori: una buona parte di queste di natura biologica ed ereditaria, determinata dai nostri geni e quindi dal nostro DNA. Laltra parte dovuta allinfluenza che lambiente ha sullindividuo, a fattori accidentali o a modificazioni volontarie. La genetica moderna applicata alla teoria dellevoluzione ci ha permesso di riconoscere lesistenza di forze che determinano le differenze biologiche tra gli individui e che sono sostanzialmente quattro: la mutazione, la selezione naturale, il caso e la migrazione. Le differenze che vi sono tra i vari gruppi etnici e che colpiscono, ancora oggi, molti di noi, sono il risultato di mutazioni e cio di piccoli cambiamenti che avvengono in modo casuale nel DNA e che possono essere vantaggiosi per lindividuo perch lo migliorano. Il colore della pelle, dei capelli e degli occhi, la forma del corpo e le sue caratteristiche hanno tutte una componente biologica e quindi ereditaria: lespansione delluomo moderno dallAfrica agli altri continenti ha generato un adattamento, culturale e biologico, alle diverse condizioni climatiche, conseguenza di una vera e propria differenziazione genetica. Per esempio abbiamo colori diversi della pelle perch pi vantaggioso avere la pelle chiara nelle regioni settentrionali e scura nelle regioni tropicali: la pelle chiara in grado di assorbire i raggi ultravioletti e trasformare il precursore della vitamina D, presente nei cereali, in vitamina; la pelle scura protegge dagli ultravioletti e impedisce la formazione della vitamina: quindi sufficiente, in questi casi, mangiare pesce o carne. La mutazione pu anche essere non vantaggiosa perch danneggia lindividuo modificandone una o pi funzioni ( il caso di alcune malattie ereditarie come la talassemia, la corea di Huntington, la sindrome di Down), oppure vantaggiosa per il portatore di una data malattia ereditaria (vantaggio delleterozigote) come la talassemia: lindividuo eterozigote pi resistente alla malaria. Ma vi sono anche mutazioni completamente invisibili ai nostri occhi: il sistema dei
2 J. S. Huxley / A. C. Haddon, Noi Europei. Unindagine sul problema razziale, trad. it. di F. Mastrorilli / M. Nani, Torino, Edizioni di Comunit, 2002, p. 199.
116
Capitolo III
gruppi sanguigni A, B, AB, 0 un esempio di mutazione umana ereditaria. Gli esempi appena descritti sono anche casi di selezione naturale: lespressione, coniata da Darwin nella sua teoria dellevoluzione, indica il processo mediante il quale la natura sceglie lindividuo pi adatto allambiente. Il caso una componente importante nella storia dellevoluzione: una mutazione pu andare perduta, specialmente dopo parecchie generazioni, o al contrario pu salvarsi; pu anche avere un successo tale da soppiantare definitivamente il tipo precedente. La storia delluomo fatta di piccole e grandi migrazioni: dal punto di vista genetico i cambiamenti di residenza di unintera famiglia, lo spostamento seguto da un matrimonio, le colonizzazioni sono spostamenti importanti che hanno dato vita a strutture molto caratteristiche. Quindi la teoria dellevoluzione pu aiutarci a comprendere la storia dellumanit, anche se un grosso contributo, oggi, ci viene dato dagli studi sul DNA mitocondriale e dalla ricerca genetica. Lalbero riportato in figura (TAV. 4) fa riferimento allo studio di 110 geni: sono i geni dei gruppi sanguigni, delle proteine del sangue, di enzimi e altri caratteri. Si pu osservare che la differenza pi grande quella che separa gli africani dai non africani, e questo rafforza le ipotesi di molti paleoantropologi secondo i quali luomo moderno ha avuto origine in Africa e da l si poi spostato in altre parti del mondo. possibile, quindi, ricostruire la storia delluomo a partire dalle popolazioni attuali? Se studiamo un solo gene non sar possibile dire molto, anche se impossibile dire a priori quale devessere il numero di geni studiato. Sicuramente un criterio corretto quello di continuare a esaminare nuovi geni sino a quando non si raggiunger una stabilit delle conclusioni tale da non evidenziare alcun cambiamento nonostante laumento del numero osservato. Oltre al numero necessario considerare anche la velocit di variazione di un gene, velocit che cambia molto dalluno allaltro ed difficile da misurare. Sicuramente la selezione naturale pu avere una grande influenza riducendo o aumentando in modo notevole la velocit evolutiva anche se vi sono geni (geni silenziosi) che non vengono influenzati dalla selezione naturale. Al contrario vi sono geni che variano pochissimo da una popolazione allaltra: quindi non facile prevedere e calcolare la velocit evolutiva di un gene.
TAV. 4 - Albero delle popolazioni. (Fonte: L. e F. Cavalli-Sforza, Chi siamo, p. 179)
Percorsi di memoria
117
Grazie agli studi condotti da Luigi Luca Cavalli-Sforza, se a questo punto mettiamo a confronto i valori tra dati archeologici e dati genetici, otteniamo la seguente tabella: Separazione fra popolazioni Africa e resto del mondo Asia S.E. e Australia Asia ed Europa Asia N.E. e America Tempo in cui avvenuta 100.000 anni fa 55-60.000 anni fa 35-40.000 anni fa 15-35.000 anni fa Distanza genetica 100 62 48 30
Nota: nello studio della Genetica di popolazioni una delle applicazioni maggiormente riscontrate il confronto di popolazioni diverse attraverso lanalisi delle frequenze alleliche (geni). A questo proposito si usa la distanza genetica che misura la differenza genetica tra le popolazioni confrontando le frequenze degli alleli tenendo conto di tutti i loci analizzati. Per esempio la frequenza del gene Rh- in Inghilterra del 41,1%, presso i baschi del 50,4% e presso i lapponi del 18,7%: la distanza tra baschi e inglesi del 9,3% e tra baschi e lapponi del 31,7%. Quindi, quanto pi tempo trascorso dal momento della separazione di due popolazioni tanto maggiore la distanza genetica tra esse.
Osservando i valori della tabella si nota che la distanza genetica tra due popolazioni diminuisce con il diminuire del tempo trascorso dalla separazione. Se proviamo a calcolare la velocit evolutiva di numerosi geni otteniamo i seguenti valori e riscontriamo che le distanze genetiche tra lAfrica e gli altri continenti, secondo gli studi di L. L. Cavalli-Sforza, sono: 24,7 con lOceania 20,6 con lAsia 16,6 con lEuropa 22,6 con lAmerica La distanza minore quella tra lAfrica e lEuropa, seguta da quella tra Africa e Asia. Essendo Africa ed Europa continenti vicini, vi sono state sicuramente migrazioni in entrambe le direzioni e scambi genetici importanti: quindi lo scambio genetico tra popolazioni altera le distanze genetiche riducendole tra quei popoli che hanno avuto grossi scambi migratori. Diversi, ma in superficie
Siamo pochissimo diversi. Abituati a notare le differenze tra pelle bianca e pelle nera o tra le varie strutture facciali siamo portati a credere che debbano esistere grandi differenze fra europei, africani, asiatici e cos via. La realt che i geni responsabili di queste differenze visibili sono quelli cambiati in risposta al clima. Tutti coloro che oggi vivono ai Tropici o nellArtico devono, nel corso dellevoluzione, essersi adattati alle condizioni locali; non tollerabile troppa variazione individuale per caratteri che controllano la nostra capacit di sopravvivere nellambiente che abitiamo. Dobbiamo inoltre tenere a mente unaltra necessit: i geni che rispondono al clima influenzano caratteri esterni del corpo, perch ladattamento al clima richiede modifiche della superficie del corpo. Appunto perch esterne, queste differenze catturano in modo prepotente il nostro occhio e automaticamente pensiamo che differenze della stessa entit esistano anche per tutto il resto della costituzione genetica. Ma questo non vero: siamo poco diversi per il resto della nostra costituzione genetica.3
3
L. e F. Cavalli-Sforza, Chi siamo. La storia della diversit umana, Milano, Mondadori, 1993, p. 185.
118
Capitolo III
La razza
Il significato con cui la parola razza usata dagli scienziati, quello con cui usata dai razzisti e quello con cui usata nel linguaggio popolare si sono inestricabilmente mescolati e confusi. La concezione che il profano ha della razza cos confusa e carica di elementi emotivi che qualsiasi tentativo di modificarla sembrerebbe incontrare grossi ostacoli un vocabolo che suscita rapide reazioni risposte emotivamente condizionate.4
Ladattamento climatico ha originato, quindi, caratteri visibili sulla superficie corporea delluomo e ci ci porta a pensare che possano esistere le razze. Ai tempi di Gobineau, diplomatico e scrittore francese del XIX secolo, abbagliato dallideale della razza pura, si conoscevano solo i caratteri visibili e non si sapeva ancora che per ottenere la purezza e quindi lomogeneit genetica necessario, per decine di generazioni, incrociare tra loro parenti molto stretti come fratelli e sorelle, genitori e figli; e con quale risultato? Le conseguenze sarebbero assai negative sia per la fecondit sia per la salute dei figli; e poi non mai accaduto nella storia delluomo. corretto parlare di razza per luomo? La storia delluomo paragonabile a quella di altre specie animali? Qual il significato di questo termine? Partiamo da questultima domanda: secondo Battaglia la razza linsieme di animali o piante della stessa specie, contraddistinti da caratteri pressoch omogenei, trasmessi ereditariamente. Con riferimento alluomo, indica ciascuno dei gruppi omogenei (gruppi bianco, negro e giallo) in cui (secondo concezioni scientifiche proprie del secolo XIX) si suddividerebbe lumanit in base a un insieme di specifici caratteri biologici, somatici, e psico-attitudinali che inciderebbero in modo determinante nelle capacit intellettive ed emotive e nel comportamento socio-culturale degli appartenenti a ciascun gruppo. Nella seconda met del secolo XX, dopo le tragiche esperienze derivate dalle ideologie razziste e, in particolare, da quella nazista che pretendeva di trovare in tale concezione il fondamento oggettivo delle sue proposte e attivit politico-criminali, le scienze antropologiche, biologiche e genetiche hanno rimesso in discussione la validit scientifica del concetto di razza proponendo di definirlo semplicemente come ciascuna popolazione che si distingue dalle altre per la frequenza relativa di certi tratti somatici ereditari.5 In biologia la razza concepita come la suddivisione di una specie che eredita le caratteristiche fisiche di una data popolazione, distinguendosi cos da altre popolazioni di quella specie. Il termine ha unorigine non molto chiara e a questo proposito nel 1959 il filologo romanzo Gianfranco Contini6 ha individuato letimologia della parola razza nel francese antico haraz, letteralmente allevamento di cavalli, deposito di stalloni (da cui lespressione cavallo di razza). Nel 1749 L. L. de Buffon lo introduce nella letteratura scientifica, nel suo significato zoologico. Per quanto riguarda lorigine delluomo possiamo dire che tutte le variet umane appartengono alla stessa specie e che derivano da un unico ceppo. Per gli animali corretto parlare di razze perch essi non vagano al di fuori del loro normale habitat e
4 5 6
A. M. F. Montagu, La razza. Analisi di un mito, trad. it. di L. Lovisetti Fu, Torino, Einaudi, 1966, pp. 365-366. S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, Torino, UTET, 1990, vol. XV, s. v. G. Contini, I pi antichi esempi di razza, in Studi di filologia italiana, 1959, vol. XVII, pp. 319-327.
Percorsi di memoria
119
la stabilit delle loro consuetudini fondamentale nella formazione delle razze; quando si vogliono fare paragoni tra luomo e gli altri esseri viventi dobbiamo tenere conto che la storia delluomo unica e tipica della sua specie, fatta di migrazioni e di incroci. Se esaminiamo numerosi geni tra gli individui di due Paesi vicini o di due citt italiane potremo scoprire che vi sono differenze, ma che sono poco significative; la distanza genetica cresce con la distanza geografica ma, anche tra un africano e un europeo o altro, tale distanza sempre troppo poco significativa. vero che i biologi e i naturalisti sono abituati a classificare: Linneo fu il primo ad adottare un metodo di classificazione; ma pu essere utile alluomo classificare la sua specie in razze? Sappiamo che la migrazione d origine a nuovi incroci producendo frequenti mescolanze tra geni: per es. la migrazione degli africani condotti come schiavi in America ha prodotto un importante flusso genico e gli studi effettuati sui RFLP (polimorfismi della lunghezza dei frammenti di restrizione) di individui europei mostrano che anche loro sono il frutto di una mescolanza tra geni (intermedi tra africani e orientali). Dunque, nella specie umana, il concetto di razza non serve a nulla: la struttura delle popolazioni umane talmente complessa, fatta di continue migrazioni e incroci attraverso tutti i continenti e le nazioni, da rendere impossibile una netta separazione. Studiando qualsiasi sistema genetico ritroviamo sempre un grado elevato di variet genetica, cio un gene si pu presentare nelle sue diverse forme (polimorfismo), e questo avviene per una piccola popolazione, per una grande popolazione, per una nazione, per un intero continente: non esiste la purezza genetica. Il razzista convinto di appartenere a una razza biologicamente superiore a qualsiasi altra, ritenendo che la propria sia la migliore indipendentemente dal fatto che ci che viene lodato di pi siano questioni biologiche o socioculturali: quindi per lui indispensabile mantenere la purezza affinch questa sua presunta superiorit non vada perduta. Ma forse il razzismo anche una manifestazione di odio e paura per tutto ci che diverso: se da un lato conosciamo molte cose sulla biologia del corpo umano, dallaltro continuiamo a ignorare o a saper molto poco del perch un uomo non riesca ad amare, perch tenda a distruggere, perch odi e perch non riesca a comunicare con un altro essere umano. Purtroppo la societ moderna reprime le capacit delluomo potenzialit artistiche, intellettuali e affettive e tutto il mondo delle sue emozioni, trasformandolo in uomo macchina e allontanandolo sempre pi dal proprio nucleo biologico. Ci ha portato alla disumanizzazione, con conseguente crisi didentit: sono le emozioni che danno valore, colore e senso a qualsiasi azione umana e consentono alluomo di entrare in relazione con se stesso e con tutto il mondo.
Bibliografia. Si citano qui di seguito i saggi fondamentali per un approfondimento del tema, segnalati secondo un comodo ordine alfabetico: L. L. Cavalli-Sforza, Geni, popoli e lingue, Milano, Adelphi, 2001; L. e F. Cavalli-Sforza, Chi siamo. La storia della diversit umana, Milano, Mondadori, 1993; L. e F. Cavalli-Sforza, Chi siamo, Milano, Mondadori, 2004; H. Curtis / N. Sue Barnes, Invito alla Biologia, trad. it. di F. Cecere, Bologna, Zanichelli, 2003; S. Gould, Intelligenza e pregiudizio, trad. it. di A. Zani, Roma, Editori Riuniti, 1985; J. S. Huxley / A. C. Haddon, Noi Europei. Unindagine sul problema razziale, trad. it. di F. Mastrorilli / M. Nani, Torino, Edizioni di Comunit, 2002; R. Lewin, Le origini delluomo moderno, trad. it. di I. C. Blum, Bologna, Zanichelli, 1996; M. F. A. Montagu, La razza. Analisi di un mito, trad. it. di L. Lovisetti Fu, Torino, Einaudi, 1966; N. Myers (cur.), Atlante di Gaia, trad. it. di A. Bellomi / L. Serra, Bologna, Zanichelli, 1987. Molto interessante risulta anche larticolo di Alberto Piazza, Esistono i razzisti, non le razze, in La Stampa. Tuttoscienze, n. 557 / 17 marzo 1993.
120
Capitolo III
Percorsi di memoria
121
Memoria ufficiale, memorie vive. Usi della monumentalit
Alessandra Matta
1. Il Monumento italiano nel Lager di Mauthausen
Il contesto* Lungo il percorso che dallingresso del Lager di Mauthausen conduce alla cava di granito, nellarea un tempo occupata dalle residenze del personale SS, sorgono oggi venti monumenti commemorativi. Si tratta di installazioni a ricordo degli appartenenti a popoli e nazioni dEuropa che furono deportati nel Lager. Alcuni monumenti presentano un aspetto pi consueto, celebrativo; altri si propongono pi esplicitamente come installazioni a carattere simbolico ed espressivo.
Il primo a essere realizzato, in ordine cronologico, fu quello della Francia (1949). Sei anni dopo venne edificato il Monumento italiano (1955); lanno successivo fu la volta della Polonia, seguta dallUnione Sovietica (1957), dalla Jugoslavia (1958), dalla Cecoslovacchia (1959) e dal Belgio. Un comitato di repubblicani spagnoli in esilio fece sorgere, nel 1962, un monumento a ricordo degli spagnoli antifranchisti. Sempre agli anni Sessanta risalgono i monumenti dellUngheria (1964), della Repubblica Democratica Tedesca (1967), del Lussemburgo (1968) e dellAlbania (1969). Al decennio successivo appartengono i monumenti di Gran Bretagna (1970), Bulgaria (1976), e quello dedicato agli Ebrei (1976). Dopo gli altri monumenti nazionali di Grecia (1980), Repubblica Federale Tedesca (1983), Olanda (1986) e Slovenia (1995), lultimo in ordine di tempo dedicato a un altro popolo perseguitato, i Sinti e Rom (1998).
Il Monumento italiano si distingue dagli altri perch lunico a presentare un affastellamento di lapidi, targhe commemorative, fotografie e altri oggetti che ne ricoprono interamente il retro, ossia il lato che si offre alla vista del visitatore nel momento in cui questi accede allarea monumentale uscendo dal Lager, o comunque percorre la strada verso la cava. Il lato opposto quello ufficiale, presso il quale si tengono le cerimonie commemorative e si collocano le corone lasciate dai gruppi in visita. Il modello per questa duplicit (memoria ufficiale e memoria viva di singoli e gruppi) costituito dal Monumento francese, di pochi anni anteriore, in cui per le lapidi e le targhe hanno dimensione e configurazione uniformi, e inoltre restano nascoste a una vista dallesterno, a causa della struttura circolare della costruzione (un muro simile a quello italiano, ma pi articolato). La parte privata e viva, nel Monumento francese, risulta la meno immediatamente visibile e presenta comunque un carattere pi ordinato e strutturato, anche se meno spontaneo.
* I paragrafi Il contesto, La storia, Aspetto attuale, sono in larga misura tratti da una scheda didattica di presentazione del viaggio di studio a Mauthausen, Gusen, Ebensee, elaborata da Lucio Monaco in occasione della mostra Ombre del tempo, Pinacoteca a Cielo aperto, Moncalieri, maggio 2003.
122
Capitolo III
Giorgio Lab (al centro, con gli occhiali) in un disegno di Renato Guttuso2
La storia Lidea di uninstallazione commemorativa italiana era nata durante uno dei primi viaggi di superstiti e famigliari di deportati morti nel Lager, organizzato dallANED di Torino nellautunno 1948. Lanno successivo si form a Genova un comitato diniziativa per la realizzazione del Memoriale, seguto, nel 1950, dalla costituzione di un Comitato nazionale. Lintervento decisivo, anche e soprattutto sul piano finanziario, dellANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e dellUPI (Unione Province Italiane) port infine alla realizzazione del Monumento, inaugurato il 2 luglio 1955.1 Progettato a titolo gratuito dallarchitetto Mario Lab, padre di Giorgio, studente partigiano torturato e fucilato ventitreenne a Roma nel 1944,3 si pone dallinizio come proposta alternativa rispetto a quella curata negli stessi anni dallente diplomatico (la Legazione italiana) a Vienna, che, pi economica, prevedeva la realizzazione di una colonna marmorea sormontata dalla lupa capitolina. A uninopportuna estetica tradizionalista, ben poco significativa nel contesto della deportazione, e che fra laltro riprendeva paradossalmente la retorica fascista della romanit, il progetto di Lab contrapponeva una soluzione essenziale, insieme simbolica e funzionale nella sua capacit di accogliere manifestazioni spontanee popolari. Descrizione Il Monumento consiste in un muro (dimensioni approssimative 3 x 15 x 1,5 m) costruito con conci di granito ricavati dalla cava di Mauthausen, analogo quindi alle mura perimetrali del Lager. Il prospetto anteriore, pi alto e imponente, rivolto a valle (verso la cava), reca una scritta a carattere ufficiale, mentre la facciata posteriore, pi bassa per via della pendenza del terreno e prospiciente il Lager, era nel progetto destinata allapposizio-
Cfr. Come fu ideato e attuato il Monumento italiano nel campo di Mauthausen, a cura del Comitato genovese Per un monumento a Mauthausen e lapidi negli altri campi tedeschi di eliminazione, Novi Ligure, Arti grafiche novesi, [1959?]. Il disegno fa parte della raccolta Gott mit Uns, realizzata in clandestinit durante la guerra e pubblicata nel 1945. Cfr. Antonello Trombadori, Gott mit Uns. 24 tavole in nero e a colori di Renato Guttuso (Roma, La Margherita, 1945), cit. in Werner Haftmann, Guttuso, FirenzeMilano, Giunti, inserto allegato a Art e Dossier n. 208 / febbraio 2005; la tavola pubblicata in Filippo Tuena, Il critico artificiere, in Art e Dossier, n. 219 / febbraio 2006, p. 23. 3 Cfr. la biografia di Giorgio Lab sul sito www.anpi.it; e Biografie della Resistenza romana, a cura di M. Avagliano, in it.geocities.com/memoriadiclasse/resistenza/bioresistenzaromana.htm (entrambi i siti sono stati visitati nellottobre 2006).
2
Percorsi di memoria
123
ne di omaggi alla memoria degli Scomparsi, sotto forma di fotografie, corone, ecc..4 Una breve scalinata supera il dislivello tra le due parti della costruzione, invitando a muoversi intorno a essa. Come tutta la vasta area monumentale, cos anche la zona prospiciente il fronte ufficiale del Monumento italiano a prato, percorso da viottoli. A differenza di questo, concepito per attirare lattenzione da lontano, il fronte posteriore dotato di un marciapiede lastricato che risponde allesigenza di fruire di quella parte dellopera da vicino, utilizzandone la superficie. La porzione di muro destinata allapposizione di omaggi alla memoria si distingue dal resto anche per essere intonacata e percorsa da un ripiano sul quale negli anni sono stati appoggiati gli oggetti che per vari motivi non si potevano fissare alla superficie verticale. La dicotomia della forma, ispirata al Monumento francese, idea-guida della progettazione, criterio coerente delle scelte tecnologiche, architettoniche, paesaggistiche e, con i suoi risvolti semantici, ne fa unopera incisiva e originale. Lo schema seguente un tentativo di esplicitare in sintesi le caratteristiche di contrasto fra le due facciate suggerite da unanalisi del Monumento.
Monumento italiano a Mauthausen
fronte anteriore ufficiale... normativo... imponente... ordinato... spoglio... definitivo... pietra... alto... lontano... esterno... entrando (nel Lager)... sfondo Lager... freddo...
fronte posteriore ...popolare ...libero ...accogliente ...disordinato ...affastellato ...in trasformazione ...intonaco ...basso ...vicino ...interno ...uscendo (dal Lager) ...sfondo cielo ...emozionante
Come fu ideato e attuato il Monumento italiano nel campo di Mauthausen cit., p. 14.
124
Capitolo III
Aspetto attuale Nel Monumento italiano si sono cos sovrapposti pi di cinquanta anni di memorie. Famigliari, amici e compagni di prigionia, istituzioni e associazioni, da ultimo anche scuole hanno lasciato un segno sul retro del muro; non c per una successione ordinata per cronologia, o una disposizione strutturata per forme. Solo le prime lapidi, pi ufficiali (a destra, a cominciare dalla prima, firmata dal Governo italiano, dallANCI/Decorati al V. M., dallANCI e dallUPI) sono uniformi; il resto delle targhe, fotografie, lapidi e strutture commemorative segue modelli diversi, stratificati nel tempo, inizialmente simili ai sacrari partigiani edificati in Italia in quegli stessi anni. Il risultato una sorta di creazione artistica spontanea e collettiva, fondata sullaccumulo di memoria e di materiali visivi che cercano di restituire una fisionomia individuale agli scomparsi. Nel corso del tempo, tuttavia, molti di questi elementi si sono deteriorati; alcune fotografie sono cadute, le iscrizioni su alcune lapidi si sono cancellate. Inoltre lo spazio disponibile stato interamente saturato e non rende possibile la continuazione di questa forma di ricordo, che per di pi non appare proporzionata al numero degli italiani morti nel Lager (circa 5.000). Il mantenimento degli oggetti applicati affidato alla cura dei singoli che li hanno apposti: noi stessi, nel corso della nostra visita,5 Monumento italiano a Mauthausen, particolare abbiamo effettuato con Natalino Pia testimone e superstite di Mauthausen e Gusen il restauro di una piccola lapide da lui applicata negli anni Cinquanta in memoria di suo cognato. Dato lo stato di degrado e la necessit di un intervento di restauro, soprattutto nel retro, sono allo studio progetti di recupero del Monumento. Alcuni di essi prevedono la rimozione dei materiali (da conservare altrove, in un muro aggiuntivo da costruirsi appositamente a fianco di quello originale, oppure in locali del Museo di Mauthausen) e la loro sostituzione con una formula pi esplicitamente rappresentativa della totalit degli italiani morti nel Lager. Membri dellANED sostengono invece limportanza di tutelare la peculiarit di opera viva, emozionante, specificamente prevista e voluta dal suo progettista, rispettando i sentimenti di chi si adoperato per lasciare segni tangibili di memoria, effettuando interventi minimi di consolidamento, ripristino, pulizia degli oggetti esistenti e diramando linvito a non prevedere in futuro lapposizione di altri oggetti. Per evitare in ogni caso che si perda o che si attenui la specifica e originale storia di questo Monumento, abbiamo pensato di documentare la sua forma attuale, costruendone una mappa. Lintento era quello di approfondirne il contenuto negli anni successivi, ricomponendo la successione cronologica degli oggetti applicati e, dove possibile, ricostruendo le vicende delle persone e dei gruppi di cui questi segni hanno voluto conservare la memoria.
5
Si tratta del viaggio del Progetto Memoria del marzo 2003 a Mauthausen, Gusen, Ebensee (cfr. Capitolo I 7 Memorie di pietra).
Percorsi di memoria
Rilievo del Monumento italiano a Mauthausen. Pianta e quattro alzati. A cura di Elisa Migliore. Disegni colorati da Giulia Romano.
125
126
Capitolo III
Rilievo del Monumento italiano a Mauthausen Mappa degli oggetti apposti. A cura di Silvia Colombo, Francesca Muttoni.
Percorsi di memoria
127
Il rilievo Durante il viaggio di studio del 25-29 marzo 2003 si condotta unoperazione di rilievo finalizzata allanalisi, conservazione e valorizzazione di questa testimonianza di memoria. Ne sono stati fattivamente coinvolti: - gli studenti dellI.I.S. Majorana Sezione Scientifica, Emanuela Antonucci, Paolo Bommino, Valentina Carta, Silvia Colombo, Elisa De Grandi, Federica Giorda, Elisa Migliore, Francesca Muttoni, Annalisa Procopio, Aurora Rapalino; - gli insegnanti Alessandra Matta, Lucio Monaco, Gabriella Pernechele; - il consigliere comunale Giuseppe Artuffo. Un gruppetto ha effettuato il rilievo metrico, registrando con schizzi forme e quote relative allarchitettura. La studentessa che ha tenuto le fila delloperazione ha successivamente eseguito a scuola i disegni geometrici (pianta e quattro prospetti) in scala 1:50. Il resto del gruppo, ripartito ordinatamente il muro in settori, ha rilevato ogni singolo oggetto, annotando per ciascuno la posizione, una descrizione comprendente le caratteristiche di forma e materiali, leventuale presenza di fotografie e il contenuto completo delle iscrizioni. I dati raccolti sono stati sistemati a scuola in elenchi in ordine topologico, per settore, in cui tutti gli oggetti rilevati sono distinti da una numerazione riferibile a una mappa: si tratta del prospetto posteriore del Monumento, rappresentato in scala 1:20, con lindicazione di ciascuno degli oggetti della memoria lapidi, fotografie, targhe, corone, cornici, urne, sassi che costituisce la sintesi di questa parte del lavoro.
128
Capitolo III
2. Una installazione nel Memoriale di Gusen
Opera del 1967 dellarchitetto Lodovico Barbiano di Belgiojoso (1909-2004),6 superstite del campo, il Memoriale di Gusen I un recinto labirintico spiraliforme costituito da muri in calcestruzzo grezzo di altezza crescente che conduce al forno crematorio, tutto ci che resta del sottocampo di Mauthausen. Il percorso allinterno del Memoriale separa simbolicamente il forno crematorio dal quartiere residenziale che ha completamente cancellato o profondamente trasformato le tracce del Lager sul territorio. I muri del Memoriale sono limiti, gli spazi interni sono vuoti. Custodiscono la memoria delimitando il solitario resto del passato dai segni invasivi del presente. Le alte pareti grigie evocano nel visitatore lidea di reclusione, Esterno del Memoriale di Gusen I Sullo sfondo, a ridosso, edifici costruiti sul terreno gi occupato dal Lager di costrizione, di spoliazione. Un gruppo di studenti dellI.I.S. Majorana Sezione Scientifica (Manuel Cane, Alessandra Gardino, Matteo Garitta, Fabrizio Iannone, Alessandro Ossola, Andrea Tosco) ha voluto installare nel cuore del recinto, in prossimit del forno crematorio, unopera commemorativa dei quattro moncalieresi deportati a Gusen.
S. Maffioletti (cur.), BBPR, Bologna, Zanichelli, 1994.
Percorsi di memoria
129
Si tratta di un oggetto in terracotta smaltata a freddo progettato e realizzato dagli stessi studenti presso il Laboratorio artistico territoriale Tabl con il supporto dellartista Marilena Bergamini.7 Si compone di due parti non separabili: la superiore recante le iscrizioni (un prismoide triangolare) e la base, entrambe realizzate con la tecnica delle lastre (largilla stesa in fogli tagliati secondo sagome definite e, dopo una parziale asciugatura, assemblati). Lidea iniziale di incidere una targa pi o meno tradizionale stata superata quando i ragazzi hanno cominciato a progettare. Il triangolo rosso che in Lager contrassegnava i deportati politici stato interpretato come forma da elaborare e scomporre in quattro moduli tridimensionali che rappresentano i quattro deportati.
Disegno di Federica Abrate, Giulia Romano.
Disegno di Lucia Martinelli, Luca Picchi.
Disegno di Vanessa Saracino, Margherita Trimboli.
7
Cfr. il sito www.marilenabergamini.com.
130
Capitolo III
Le facce principali sono speculari; su una sono incisi i nomi con le rispettive date di nascita e di morte, sullaltra i numeri di matricola assegnati allingresso nel campo con i quali gli individui venivano privati della propria personalit. Ogni deportato rappresentato da un prisma; a differenza degli altri quello di Orfeo Mazzoni non allineato e il vertice del triangolo rivolto verso lalto per rappresentare il suo contributo alla memoria portato ai giovani dopo il ritorno a casa. Su una faccia laterale abbiamo riportato un verso tratto dalla poesia di Primo Levi Shem, posta a premessa di Se questo un uomo. La scelta strettamente legata al senso della memoria e al ricordo del passato per la nostra generazione e per quelle future. Un altro elemento simbolico il materiale, la terracotta, fragile: vuole essere uno stimolo a rinnovare la memoria. Questo anche rappresentato dallesigua altezza dellopera che spinge losservatore a piegarsi verso di essa partecipando attivamente allazione del ricordare.8
Disegno di Sara Di Francia, Lorena Vioglio.
Abbiamo voluto definire installazione questo lavoro degli studenti perch trae gran parte del suo significato dallintento originario di essere collocato allinterno del Memoriale di Gusen. Ci che distingue linstallazione dalla scultura il fatto che lopera non solo un oggetto tridimensionale, ma comprende lintero ambiente, senza il quale non avrebbe senso.
8 M. Cane / D. Fabbro / A. Gardino / M. Garitta / F. Iannone / A. Ossola / A. Tosco, In ricordo dei deportati moncalieresi a Gusen, in W Moncalieri, luglio 2005, p. 18.
Lucio Monaco e Bruno Mazzoni a Gusen (aprile 2005)
Percorsi di memoria
131
3. Riflessioni a margine
MURO Il Monumento italiano di Mauthausen e il Memoriale di Gusen hanno in comune tra altre caratteristiche quali la concezione architettonica anzich scultorea, il rigore formale e una impostazione razionalista il fatto di essere entrambi, in grande sintesi, dei muri. In questa caratteristica risiede una certa carica simbolica. Nonostante nella maggioranza dei Lager esistessero pochi muri veri e propri (le baracche erano in legno, le recinzioni di filo spinato), il muro unimmagine che rimanda efficacemente al mondo concentrazionario, attraverso i concetti di separazione, chiusura, isolamento, reclusione; il muro pesante, inamovibile, definitivo come il sopruso. COLLEZIONE Una seconda caratteristica espressiva del Monumento italiano di Mauthausen quella di essere il luogo di una raccolta, di una collezione. La collezione risponde allesigenza di conservare in modo ordinato e sistematico, nella prospettiva di approfondire conoscenze, ma anche di esporre, rendere pubblico. Jonathan sta conducendo una ricerca; la sua collezione paragonabile a una raccolta di dati, di informazioni. Al tempo stesso il modo per avvicinarsi a un passato perduto e mai conosciuto; cos la sorella di Augustine colleziona gli oggetti che trova nei campi intorno alla sua casa, dove prima dello sterminio nazista sorgeva il suo shtetl, per trattenere qualcosa di un mondo inesorabilmente scomparso. La sabbia raccolta sul greto del Brod acquista significato nel momento in cui Jonathan se ne appropria chiudendola in uno dei suoi sacchetti: in questo modo sabbia qualsiasi diventa sabbia di Trachimbrod, e Trachimbrod dimenticato shtetl raso al suolo sessantanni prima riprende a esistere, nella memoria. Collezionare anche atto del radunare per capire, e in questo senso si dice raccogliere le proprie idee, raccogliersi, col significato di pensare. Latto del raccogliersi per ritirarsi ANONIMO La grande quantit di oggetti affastellati sul Monumento italiano di Mauthausen per la quasi totalit dei fruitori (non in grado di riconoscere nomi e volti) risulta di fatto un insieme anonimo. Il pensiero che molti tra coloro che hanno un tempo apposto le lapidi sono ormai morti non fa che sottolineare lanonimato e acuire ancora una volta langoscia di fronte al tempo, alla morte, allinevitabile labilit della memoria stessa. Su questo spaesamento (limmagine nata per ricordare non pi ricordabile da nessuno) fa leva lopera di Boltanski, con le sue interminabili serie di fotografie anonime o di scatole chiuse. Il panico che ci prende quando ci troviamo di fronte ai mucchi di scarpe, di valigie, di occhiali, di pentole nelle vetrine del Museo di Auschwitz I non proviene soltanto dalla percezione diretta e concreta delle dimensioni enormi dello sterminio, e nemmeno dalla intollerabile evidenza che le cose pi infime, le cose deperibili, i banali oggetti del quotidiano ci sopravvivono, ma anche dallimpossibilit di attribuire quelle cose, cos vere, cos attuali, cos nostre, a qualcuno. Degrado. Il tempo lascia le sue tracce inconfondibili: le fotografie sbiadiscono, le cornici si staccano, le
Felix Nussbaum, Autoritratto con passaporto per ebrei,1943, Osnabrck, Kulturgeschichtliches Museum
132
Capitolo III
Lartista francese Christian Boltanski (1944) 9 tratta il tema del tempo e della memoria coprendo muri di riproduzioni di vecchie fotografie illuminate ciascuna da una lampadina; con scatole di latta o di cartone recuperate costruisce alte pareti che delimitano percorsi labirintici, configura opprimenti superfici verticali costituite da abiti usati appesi. Il muro separa, dunque pu svolgere il ruolo negativo di chiusura; al tempo stesso la sua superficie apre uno spazio che pu essere di rappresentazione ed esposizione. Come Boltanski, Jonathan, il protagonista del film Ogni cosa illuminata,10 appende a un muro la sua collezione di ricordi sistematicamente cellophanati, nella necessit di fissare su un supporto visibile e duraturo oggetti che non sono che lemblema della fugacit dellesistenza e della stessa conoscenza. Il muro elemento base nella definizione di spazio e dunque di architettura. Senza divisori non hanno senso i concetti di interno/esterno, anteriore/posteriore, cos significativi, come abbiamo visto, nei due memoriali.
in una dimensione interiore rimanda proprio alla potenzialit conoscitiva e creativa dellelenco. Agostino di Ippona11 tratta la memoria come un contenitore di immagini sparse disordinatamente che il pensiero raccoglie e dispone alla considerazione dello spirito. In questottica la raccolta di lapidi e altri oggetti non sarebbe mero affastellamento disordinato e casuale, ma esito di un progetto razionale di costruzione di una sorta di allegoria della memoria come facolt dellintelletto umano.
vernici si scrostano, le pietre si spaccano. I volti svaniscono, i nomi sono sempre meno leggibili, le date sempre pi incomplete. Lanonimato avanza con il tempo, e a esso anche gli oggetti si arrendono.12
Museo di Hartheim: oggetti appartenuti alle vittime del Programma di Eutanasia
Monumento italiano, Mauthausen
9 D. Semin / T. Garb / D. Kuspit, Christian Boltanski, New York, Phaidon, 1997. 10 L. Schreiber, Everything is illuminated, USA, 2005.
11 Cfr.. Agostino, Le confessioni, libro X, 8.1227.38.
Cfr. P. Cresto-Dina, Memoria e secolarizzazione. Il Lager come museo, in F. Luisetti / G. Maragliano (curr.), Dopo il museo, quaderni di estetica & ermeneutica, Torino, Trauben, 2006, pp. 129-162.
12
Percorsi di memoria
133
4. Esposizioni
OMBRE DEL TEMPO Materiali raccolti ed elaborati dal viaggio di studio a Mauthausen, Gusen, Ebensee (25-29 marzo 2003) Pinacoteca a Cielo aperto, Moncalieri, maggio 2003 I.I.S. Majorana Sezione Scientifica, giugno 2003
134
Capitolo III
UN UN PUNTO PUNTO DELLA DELLA TERRA TERRA Mostra Mostra fotografica fotografica Progetto Progetto Memoria Memoria 2003 2003 2004 2004 Viaggio Viaggio di di studio studio in in Polonia Polonia
I.I.S. I.I.S. MAJORANA MAJORANA sezione sezione scientifica scientifica Moncalieri Moncalieri
UN PUNTO DELLA TERRA Fotografie, filmati, ricostruzioni letterarie, elaborati grafici dal viaggio di studio ad Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz III-Monowitz, Gliwice (23-26 marzo 2004) Pinacoteca a Cielo aperto, Moncalieri, maggio 2004 I.I.S. Majorana Sezione Scientifica, giugno 2004
Percorsi di memoria
135
SEGNI, NOMI, UOMINI Commento grafico-fotografico dal viaggio a Carpi e Fossoli (28 novembre 2005) I.I.S. Majorana Sezione Scientifica, anno scolastico 2005-2006
136
Capitolo III
5. Immagini
Birkenau, 2004
Percorsi di memoria
Birkenau, 2004
Birkenau, 2004
137
138
Birkenau, 2004
Birkenau, 2004
Capitolo III
Percorsi di memoria
Mauthausen, 2005
Mauthausen, 2003
139
140
Bolzano, 2005
Bolzano, 2005
Capitolo III
Percorsi di memoria
Ravensbrck, 2001
Ravensbrck, 2001
141
142
Sachsenhausen, 2001
Dachau, 1998
Capitolo III
Percorsi di memoria
Buchenwald, 2006
Dora, 2006
143
144
Hartheim, 2005
Buchenwald, 2002
Capitolo III
Percorsi di memoria
145
Il Lager come museo*
Piero Cresto-Dina Ho voluto dipingere il grido, pi che lorrore Francis Bacon Lestetizzazione della memoria Oggi laffermazione di una coscienza storica dello sterminio non sembra pi tanto dover lottare contro le tendenze alloblio e alla rimozione che hanno segnato i primi decenni del dopoguerra, quanto contro un eccesso di produzione simbolica che ne caratterizza il diffondersi sul piano della cultura di massa. I Lager hanno attraversato le diverse fasi di una progressiva museizzazione. Si tratta probabilmente di un fenomeno molto simile a quello che ha coinvolto altri luoghi della storia castelli, rovine, campi di battaglia , da tempo mete di un turismo culturale che sembra attestare la convergenza fra il compimento della storia e la sua risoluzione in finzione. Difficilmente nellesperienza dei visitatori lo sguardo pu posarsi su qualcosa che non sia una forma estetizzata dellevento, e ci in modo del tutto indipendente dal grado di consapevolezza e concentrazione con il quale ci si accosta ai luoghi. La dimensione espositiva ovunque dominante. Ma se vero che il turismo la forma compiuta della guerra, come ha scritto Marc Aug a proposito di Waterloo,1 non vi turismo che possa portare a compimento la storia dei Lager. Il Lager resiste al turismo di massa, levento che vi si svolto non , in quanto tale, suscettibile di compimento. Il destino delle vittime, sia esso costituito dalla morte di milioni di uomini o dalla sofferenza di coloro che sono sopravvissuti, non si lascia porre troppo facilmente in relazione con le circostanze grazie alle quali se ne conserva oggi il ricordo. Se la coscienza arretra di fronte alle implicazioni di una simile ipotesi, forse perch levento, nella sua enormit, ci pare irredimibile e vorremmo salvaguardare, insieme con il suo essere definitivamente compiuto, anche la sua unicit. La visita ai campi, cos come il mero esercizio della rammemorazione, non pu costituire una sorta di risarcimento postumo nei confronti dei deportati.2 Lappagamento che potrebbe nascere da questa convinzione renderebbe insignificante lesperienza del viaggio. Davanti allo sterminio non siamo disposti a prendere in considerazione un esito finzionale. Non perch la violenza consumata in altri contesti ci appaia meno reale, ma perch la memoria della deportazione tocca in modo pi diretto la nostra coscienza postmoderna, mettendo esplicitamente in causa e rendendo in qualche modo incomprensibile, come ha detto Zygmunt Bauman, tutta la civilt occidentale.3 Nessun episodio della storia moderna ha assunto in maniera altrettanto precisa, nella coscienza culturale occidentale, il valore di evento capace di descrivere la forma genera-
* Il saggio apparso, in forma leggermente diversa, nel volume a cura di F. Luisetti / G. Maragliano, Dopo il museo, quaderni di estetica & ermeneutica, Torino, Trauben, 2006, con il titolo Memoria e secolarizzazione. Il Lager come museo (pp. 129-162). 1 M. Aug, Disneyland e altri nonluoghi, trad. it. di A. Salsano, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, p. 8. 2 Com noto, limpossibilit di unaffermazione di positivit di fronte a eventi che ridicolizzano la costruzione di ogni senso dellimmanenza stata esemplarmente argomentata da Adorno nelle pagine finali della Dialettica negativa (Th. W. Adorno, Dialettica negativa, trad. it. di C. A. Donolo, Torino, Einaudi, 19752, pp. 326-69). 3 Z. Bauman, Modernit e Olocausto, trad. it. di M. Baldini, Bologna, il Mulino, 1992, p. 126.
146
Capitolo III
le della Storia, la sua essenza forse catastrofica, la sua possibile mancanza di senso. Lyotard ha proposto limmagine di un terremoto che abbia distrutto gli strumenti stessi di misurazione.4 Cos, la memoria della Shoah divenuta un modello per la costruzione della memoria storica in generale. Daltra parte, pochi altri eventi storici hanno raccolto fino a oggi cos tante forme di rappresentazione, e assai di rado la memoria storica si legata altrettanto strettamente a luoghi, spazi, paesaggi, immagini. In nessun altro caso si cos assiduamente condensata nellesperienza del viaggio e del confronto con i testimoni, considerata come indispensabile complemento alla lettura dei testi. Il compito allora quello di porre a confronto la profusione delle immagini e delle narrazioni con lenunciata impossibilit di unarticolazione discorsiva dellunicit dellevento. Nel tentativo di aggirare una certa convenzionalit del tpos della memoria per richiamarsi alla costitutiva distanza dello sguardo, si rischia in effetti di incorrere in un tpos altrettanto convenzionale: quello dellinesprimibilit, dellineffabilit, dellalterit radicale, enfatizzando il paradosso che si formula nella costrizione a dire lindicibile.5 vero, il nucleo dellevento, il punto di vista dei morti, destinato a restare inespresso.6 La testimonianza dei superstiti si scontra sempre con un fondo intestimoniabile, con una impossibilit della testimonianza, alla quale non pu che far riscontro linevitabile tendenza alla sua estetizzazione.7 Eppure non vi altro modo di procedere, se non quello di tenere fermo a questo nucleo irriducibile, ausdruckslos, nella consapevolezza che in ogni caso non potremo evitare il lento trascorrere della memoria. Dire tutto quello che si pu dire, sapendo che non si pu dire tutto e che sulla cosa pi importante abbiamo perso da tempo la possibilit di parlare. Trascendenza e visibilit sono i due fuochi a partire dai quali si orienta qualsiasi discorso sulla storia dei campi. Pensare al Lager come a un pezzo di mondo al di fuori del mondo ordinario, uno spazio sottratto alla sfera della finzione generalizzata ci pare, da un lato, essenziale. Alla base di tutte le tendenze revisionistiche e relativistiche c, in fondo, il mancato riconoscimento di ci che nello sterminio resta inspiegabile e intraducibile nella lingua ordinaria della comunicazione, inaccessibile a qualsiasi considerazione fondata su concetti come equivalenza, scambio, compensazione. Questo elemento irrecuperabile ha probabilmente qualcosa a che fare con quello strato antropologicamente profondo al quale i Lager rinviano, costringendoci a porre in una forma spaventosa la domanda: che cos luomo?8 Daltro canto, i Lager, come tutte le cose nellepoca dellestetizzazione diffusa, sono condannati alla visibilit, alla dimensione pubblicitaria, espositiva. La loro affinit con i luoghi nei quali si esprime la tendenza umana al collezionamento, alla raccolta, allesposizione e allarchiviazione li rende inavvertitamente solidali con quelle manifestazioni che nel mondo contemporaneo, per sua essenza museale, cadono sotto il controllo delle diverse
4 5 6
J.-F. Lyotard, Il dissidio, trad. it. di A. Serra, Milano, Feltrinelli, 1985, p. 81. Cfr. R. S. C. Gordon, Primo Levi: le virt delluomo normale, trad. it. di D. Bertucci / B. Soravia, Roma, Carocci, 2003, pp. 69-70. Cfr. P. Levi, I sommersi e i salvati, in Opere, vol. I, Torino, Einaudi, 1958-1987, p. 716: Non siamo noi, i superstiti, i testimoni veri. [...] Noi sopravvissuti siamo una minoranza anomala oltre che esigua: siamo quelli che, per loro prevaricazione o abilit o fortuna, non hanno toccato il fondo. Chi lo ha fatto, chi ha visto la Gorgone, non tornato per raccontare, o tornato muto; ma sono loro, i mussulmani, i sommersi, i testimoni integrali, coloro la cui deposizione avrebbe avuto significato generale. 7 Cfr. G. Agamben, Quel che resta di Auschwitz. Larchivio e il testimone, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, pp. 32-33. 8 significativo che la domanda antropologica compaia, fin dal titolo, quale nodo tematico dei primi e fondamentali scritti di memoria, da Levi (Se questo un uomo) ad Antelme (Lespce humaine).
Percorsi di memoria
147
agenzie dellestetizzazione. Che siano organizzati a tutti gli effetti come musei il caso ad esempio di Auschwitz I, di Buchenwald, di Mauthausen , o che assumano in modo pi generico i caratteri del luogo di memoria e ammonimento (Mahn- und Gedenksttte), essi non sfuggono a una condizione elementare di leggibilit: la cornice entro la quale sinscrivono i loro progetti espositivi deve risultare familiare, i codici che presiedono allorganizzazione degli spazi e allo svolgimento della narrazione devono essere noti in anticipo, il visitatore deve poter attivare quegli stessi a priori della percezione che lestetizzazione generale del mondo della vita gli ha messo in funzione. Il turista che fotografa limpressionante fuga dei binari dalla torretta daccesso a Birkenau o si raccoglie a Buchenwald presso la lastra metallica con i nomi delle nazioni (che una fiamma invisibile tiene costantemente alla temperatura del corpo umano) assume, nel bene e nel male, un contegno di tipo estetico. Che un tale atteggiamento resti precluso al superstite, assai pi attento a registrare i cambiamenti che il tempo introduce nellaspetto originario dei luoghi, una circostanza piuttosto rilevante, sulla quale dovremo tornare. Il rischio implicito nellassunzione del Lager in una logica di tipo museale ovviamente quello della banalizzazione, della neutralizzazione tranquillizzante. Qualcosa di analogo avvenuto nei musei darte nel corso del Novecento, con lassorbimento della forza durto dellavanguardia nel quadro di una concezione storico-evolutiva della crisi. Ma qui in gioco una conciliazione ben pi decisiva dal punto di vista sociale. Nonostante tutti gli appelli a considerare leventualit di un ritorno di ci che stato, il Lager-museo sembra rassicurare sul fatto che la nostra societ funziona secondo leggi del tutto diverse da quelle che vigevano al suo interno. Noi contempliamo la violenza al riparo delle nostre certezze, forti della convinzione che la societ, nel suo complesso, sia qualcosa che nasce precisamente per impedire il Lager.9 Il Lagermuseo diviene cos una dimostrazione e contrario della bont dellordine sociale. Il potenziale ideologico insito in una tale opzione pu essere colto soprattutto se si riflette su certe tendenze che sono tipiche della nostra epoca. Lapertura al turismo di massa fa leva sulla spettacolarizzazione della vita sociale e sullassuefazione del pubblico a un orizzonte interamente dominato da simboli e immagini. Il modo di essere dei semiofori divenuto il modo di essere di tutte le cose. Elementi dello spazio quotidiano (strade, case, negozi, villaggi) sollecitano sempre pi spesso una fruizione estetica, di carattere museale. Come ha rilevato Baudrillard, il mondo ormai un ready made e il museo uno spazio per la trasposizione di oggetti duso comune, dove la banalit del quotidiano acquista connotati estetici. Ne consegue la situazione esemplare di un mondo di simulazione, in cui la realt sparisce senza lasciare traccia.10 In che modo una tale autoreferenzialit tocca le forme alle quali consegnata la memoria storica, la ricezione dellevento massimamente reale? A un primo sguardo, la parola dordine della derealizzazione, allinsegna della quale sociologi e filosofi della cultura sono soliti rubricare i fenomeni tipici della postmodernit, non trova conferma pi piena di quella che viene dalla considerazione dei modi di fruizione della Storia. Basta pensare al carattere spettacolare acquisito dallOlocausto in certe ver-
10
Z. Bauman, Modernit e Olocausto cit., p. 18. Cfr. J. Baudrillard, Il complotto dellarte & interviste sul complotto dellarte, trad. it. di L. Frausin Guarino, Milano, Pagine dArte, 1999, pp. 79-90; Idem, Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realt?, trad. it. di G. Piana, Milano, Cortina, 1996, p. 9.
148
Capitolo III
sioni cinematografiche o al fascino surrettiziamente esercitato da talune rappresentazioni finzionali del nazionalsocialismo. La curiosit indifferentemente sollecitata dalle strategie militari come dalle procedure di annientamento degli uomini nelle camere a gas, dalle biografie romanzate dei potenti come dagli esperimenti criminali dei medici nazisti, non molto pi proficua, al fine di una giusta conoscenza, dellatteggiamento di chi, di fronte allorrore, si rifiuta di superare una modesta soglia di informazione, pago del grado di consapevolezza acquisito. Tuttavia, lovvia constatazione che quella curiosit si alimenta dellapparenza di ineffettualit conferita alla rappresentazione del dolore dai meccanismi dellindustria culturale non rende insignificante tutto quello che si svolge sotto il segno dellestetizzazione. Se vero che anche Auschwitz pu essere digerito come un aspetto del tutto conseguente al moltiplicarsi dei nessi funzionali nella realt e andare incontro alla crescente disponibilit delle persone a cogliere ovunque il lato normale delle cose, lestensione della dimensione simbolica allo spazio della Storia anche oggi pi che mai una condizione necessaria per il persistere della memoria. Soltanto, si tratta di domandarsi che cosa propriamente venga ricordato laddove levento da ricordare, il suo esser stato, si ripropone continuamente come un trascendens al quale non possibile accostarsi con i concetti generici che orientano la nostra comprensione ordinaria della Storia. La rappresentazione che dilegua Ipotizziamo che questo rapporto fra inesprimibilit ed esponibilit possa essere pensato alla luce del concetto di secolarizzazione, almeno nella forma che un tale concetto assume nel quadro della proposta filosofica di Gianni Vattimo, dove indica soprattutto un nesso di provenienza che lega la modernit a un nucleo di esperienza del sacro che rimane attivo anche dopo la dissoluzione delle strutture sacrali nella societ laica e moderna. Certo, prima di assegnare un qualunque significato religioso alla memoria della Shoah occorrer considerare come lesperienza della Storia dopo Auschwitz sia entrata in una fase del tutto nuova, che non solo impone la radicale riformulazione di tutti i problemi tradizionali della teodicea,11 ma vanifica in anticipo ogni ulteriore tentativo di filosofia della storia, se vero che la moderna filosofia della storia giusta la lezione di Karl Lwith dipendeva in modo sostanziale dallinterpretazione teologica della Storia come storia della salvezza.12 Ci che per una coscienza laica, in un tale clima di congedo, mantiene tuttavia in vita la forma dellesperienza religiosa non tanto la meditazione sul silenzio degli di, quanto quella sul silenzio delle vittime. Lessenza museale del Lager, con i rituali di raccoglimento che comporta, reagisce anzitutto alla privazione della voce, a quel torto che consiste nellimpossibilit per le vittime di portare a conoscenza il danno subto. Contro la tendenza a scorgere nei fenomeni di estetizzazione il segno di una dissoluzione della sacralit e di un esonero diffuso, occorre domandarsi se non sia proprio il museo, grazie a quella funzione di scambio fra visibile e invisibile che pertiene in generale alla pratica del collezionare,13 a ereditare nella realt secolarizzata parte della sacralit un tem-
11
Nel modo pi lucido lo ha dimostrato H. Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica, trad. it. di C. Angelino, Genova, il melangolo, 1993. Cfr. K. Lwith, Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia della storia, trad. it. di F. Tedeschi Negri, Milano, Edizioni di Comunit, 19652. 13 Cfr. K. Pomian, Collezione, in Enciclopedia, vol. III, Torino, Einaudi, 1978, pp. 341-46.
12
Percorsi di memoria
149
po appartenuta alla Chiesa. La visita ai campi si configura di fatto come una sorta di rituale secolarizzato, un rituale dello sguardo e del silenzio.14 La domanda pi importante riguarda per, ancora una volta, la possibilit stessa di una citabilit del passato. Come pu un pensiero che si pone in dialogo con la tradizione, e dunque con loblio e la rimozione, confrontarsi con loggetto trascendente e reale per antonomasia, con lindicibile non-trasmissibile, con il dissidio che scaturisce dallimpossibilit di rendere testimonianza del torto subto, con il silenzio che avvolge levento improponibile? In effetti, il paradigma della secolarizzazione postula precisamente la traducibilit in senso profano di unorigine non pi direttamente esperibile e insieme lammissione che uneventuale esperienza del passato non potrebbe in ogni caso dipendere da una decisione individuale o da unattestazione di autenticit testimoniale. Per Vattimo il tramonto postmoderno della nozione di soggetto trae inevitabilmente con s la crisi della testimonianza. Tutta la problematicit e langoscia che avvolge la figura del superstite in quella che Annette Wieviorka ha definito lre du tmoin15 verte probabilmente sulla consapevolezza che lavvio di una nuova epoca pu dipendere solo da un nuovo ordine del mondo che la testimonianza non , in quanto tale, in grado di evocare,16 se non in forma indiretta e messianica. Come pensare allora forme di rappresentazione capaci di trarre un contenuto di verit dal suo isolamento per tradurlo sul piano della visibilit e della fruizione sociale senza riproporre, insieme con la trascendenza delloggetto, la vocazione sostanzialistica della metafisica? In et moderna il problema della possibilit/legittimit della rappresentazione si pone in un contesto gi fortemente segnato da opzioni di carattere estetico e teologico emerse nel dibattito medioevale sullo statuto dellimmagine e sul suo valore di verit.17 Assumendo il significato paradigmatico di quelle riflessioni e dandone per acquisiti gli snodi principali, ci accingiamo ora a tracciare un itinerario del tutto particolare nel territorio fin qui descritto: a) ammettiamo, a titolo di ipotesi, la rappresentabilit del Lager, b) tentiamo in secondo luogo di giustificare questipotesi col definire le condizioni di una buona rappresentazione; c) cerchiamo infine di verificare se queste condizioni siano in linea di principio soddisfatte dallimmagine estetica, svolgendo alcune considerazioni sullarte e sulla sua dimensione testimoniale. abbastanza naturale scegliere quale punto di partenza lirriducibilit dellimmagine alla mera riproduzione (o copia).18 Vale la pena ricordare come gi nellantichit uno dei significati dellimago fosse quello che la poneva in relazione con la maschera funebre; questultima non era in linea di principio sottoposta a un vincolo di tipo mi14 Cfr. J. Kugelmass, Why We Go to Poland. Holocaust Tourism as Secular Ritual, in J. E. Young (cur.), The Art of Memory. Holocaust Memorials in History, Mnchen-New York, Prestel, 1994, pp. 175-83. Romano Boico, vincitore nel 1966 del concorso per la sistemazione della Risiera di San Sabba, concepisce il cortile cintato del campo come una basilica laica, a cielo libero (M. Rossi, Il Museo-Monumento della Risiera: la visita, in T. Matta (cur.), Un percorso della memoria. Guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia, Milano, Electa, 1996, p. 133). 15 Cfr. A. Wieviorka, Lera del testimone, trad. it. di F. Sossi, Milano, Cortina, 1999. 16 Cfr. G. Vattimo, Tramonto del soggetto e problema della testimonianza, in Idem, Le avventure della differenza, Milano, Garzanti, 1980, p. 64. 17 Cfr. L. Russo (cur.), Vedere linvisibile. Nicea e lo statuto dellImmagine, trad. it. di C. Gerbino, Palermo, Aesthetica, 1997; cfr. inoltre il volume, a cura del Centro Internazionale Studi di Estetica, Nicea e la civilt dellimmagine, Aesthetica Preprint, n. 52 / aprile 1998. 18 Nota la sintesi di Gadamer, secondo la quale si deve intendere per immagine (Bild) una realt autonoma che resta legata alloriginale senza tuttavia sopprimersi a suo favore, come accade invece alla copia (Abbild); a differenza della riproduzione, il Bild realizza una sorta di incremento ontologico che coinvolge loggetto rappresentato e gli conferisce unit e senso: cfr. H. G. Gadamer, Verit e metodo, trad. it. di G. Vattimo, Bompiani, Milano 19907, pp. 168-79.
150
Capitolo III
metico, ma era piuttosto chiamata a preservare la memoria, a rendere presente lassente e ad affermare lessenzialit del legame fra visibile e invisibile.19 Una fondamentale funzione simbolica veniva assicurata mediante la risoluzione del passato in presenza visibile, del tempo in spazialit. Jean-Pierre Vernant spiega come anche il kolosss che nella Grecia arcaica si sotterrava nella tomba vuota (ma che spesso veniva eretto al di sopra della tomba, in posizione visibile) non riproducesse affatto i lineamenti del defunto (dando lillusione della sua apparenza fisica), ma avesse piuttosto la funzione di incarnare la sua vita nellaldil, costituendone una sorta di doppio.20 Vorremmo avanzare lipotesi che nella rappresentazione estetica dello sterminio sia in gioco qualcosa di molto simile allincontro con una sfera per sua natura sottratta allo sguardo e tuttavia almeno potenzialmente soggetta alla figurazione. Nel tentativo di definire le condizioni di rappresentabilit dello sterminio, JeanLuc Nancy stigmatizza come idolo limmagine che vuole imporsi come presenza massiccia e autosufficiente, in grado di sostituire un originale assente.21 Possiamo caratterizzare in questo modo la cattiva rappresentazione. Vi sono monumenti e memoriali della Shoah che vogliono esprimere sul piano sensibile nella pietra, nel bronzo, nel cemento o nella celluloide lorrore materiale degli eventi. Nel loro sforzo riproduttivo, opere come queste sfuggono a ogni criterio estetico, non rappresentano, ma commemorano o segnalano, manifestando al contempo la loro impotenza a rappresentare, il loro fallimento artistico.22 Rappresentazione estetica invece quella che non vuole essere descrizione o sostituirsi alloriginale assente, ma resta consapevole del vuoto che si apre nel dato sensibile. Nancy chiama rappresentazione interdetta una messa in presenza sospesa davanti a questaltro dalla presenza,23 sospensione che mette in gioco la stessa rappresentabilit, che inscrive la distanza direttamente nella rappresentazione, anzich fare di questa la riproduzione di qualcosa. Il paradosso qui il seguente: per il modo in cui si svolto, lo sterminio coincide con la cancellazione della possibilit stessa della rappresentazione, ma proprio questa circostanza, questa impossibilit, ci che si dovrebbe (e non si pu) rappresentare. Se la Shoah rappresenta qualcosa nella storia del mondo, non si tratta daltro che dello statuto particolare cui si vede costretta la rappresentazione dopo la Shoah stessa. La domanda con la quale deve misurarsi limmagine allora quella sulle condizioni in cui il Lager ha ridotto la rappresentazione nel mondo moderno. Quale arte pu essere allaltezza di un simile compito? Che la domanda sulle condizioni della rappresentazione in s ineludibile per larte contemporanea possa scaturire da una riflessione sulla temporalit e sulla memoria dopo Auschwitz risulta evidente quando si pensi al lavoro di artisti come Jochen Gerz, Hans Haacke, Ronald B. Kitaj, George Segal o Christian Boltanski. Il fatto che non tutte le loro produzioni siano monumenti allOlocausto non implica la leggibilit del loro progetto artistico al di fuori delle condizioni instaurate da quellevento. Ci particolarmente evidente
Cfr. R. Debray, Vita e morte dellimmagine. Una storia delle sguardo in Occidente, trad. it. di A. Pinotti, Milano, Il Castoro, 1999, pp. 22-25. J.-P. Vernant, Figurazione dellinvisibile e categoria psicologica del doppio: il kolosss, in Idem, Mito e pensiero presso i Greci. Studi di psicologia storica, trad. it. di M. Romano / B. Bravo, Torino, Einaudi, 19782, pp. 344-345. 21 Cfr. J.-L. Nancy, Tre saggi sullimmagine, trad. it. di A. Moscati, Napoli, Cronopio, 2002, pp. 57-63. 22 Ibidem, p. 64. 23 Ibidem, p. 65.
20
19
Percorsi di memoria
151
nel caso di Boltanski. Alle tracce in via di estinzione, allimpossibilit per limmagine di restituire loriginale, allorientamento soggettivo della memoria, allaspetto reliquiale e frammentario della testimonianza lartista francese ha dedicato un percorso che denuncia costantemente la propria dipendenza dalla condizione epocale in cui ci si trova a proposito della rappresentazione.24 Si potrebbe obiettare che si tratta pur sempre di una riflessione di secondo grado e che altra cosa sono le opere create dai deportati stessi nel periodo della loro detenzione. Ma la circostanza che, riflettendo sulla memoria del genocidio, larte possa tematizzare in generale la struttura della rappresentazione e la sua portata conoscitiva invita a mettere in secondo piano quella distinzione pure legittima in sede storica fra arte dellOlocausto e arte sullOlocausto25 con la quale sintende rimarcare lassoluto valore testimoniale di opere realizzate nei campi a rischio della vita e con materiali di fortuna, e poi miracolosamente messe in salvo dopo la liberazione. Accentuare troppo questa distinzione porterebbe da un lato a ridimensionare il significato di testimonianza delle opere nate negli anni successivi alla liberazione dei campi (anche di quelle realizzate dagli stessi ex deportati sulla base di unelaborazione non esente da conflitti, come per i tanti scritti di memoria faticosamente venuti alla luce nel dopoguerra), dallaltro a trascurare la dimensione artistica di disegni e dipinti coevi agli eventi, ai quali si vorrebbe attribuire unesclusiva funzione documentaria. Ma come non ricordare la tematizzazione baudelairiana del conflitto, artisticamente fecondo, fra visione e memoria, fra obbedienza allimpressione e sintesi formale, fra velocit di esecuzione e bellezza? Se da un lato una barbarie inevitabile, sintetica, infantile, che scaturisce dalla volont di vedere tutto e registrare il transitorio, traspare spesso anche in unarte perfetta, dallaltro nessun grande artista dipinge, propriamente parlando, dal vero, ma sempre affidandosi alla propria capacit di assorbire e trattenere limpressione, il colore generale, il contorno.26 Cos si pu dire che la giusta restrizione del concetto di esteticit alla rappresentazione artistica, in base alla quale Nancy nega valore estetico a forme di presentazione sensibile artisticamente fallimentari, non deve far dimenticare che nella rielaborazione figurativa dellesperienza del Lager gli stessi confini fra rappresentazione artistica e presentazione extra-artistica tendono a confondersi: anche il pi semplice dei disegni, fissando lattimo del ricordo e costringendo losservatore a ricostruire la continuit dei vissuti, gli istanti che precedono e
La catastrofe ebraica compare esplicitamente al centro di installazioni come Canada o La fte de Pourim (cfr. ad esempio Christian Boltanski. Lessons of Darkness, Jerusalem, The Israel Museum, 1989, o Christian Boltanski. Rserves La fte de Pourim, Basel, Museum fr Gegenwartskunst, 1989), ma linterpretazione delle icone di Boltanski come monumenti ai bambini scomparsi ad Auschwitz o a Treblinka non esclude la presa datto di una riflessione pi generale sulla sopravvivenza della memoria individuale e collettiva, sul tempo e sulla perdita. Scrive lo stesso Boltanski: sicuro che tutto deve scomparire. Tutti i tentativi di lottare contro la morte, contro la scomparsa, sono vani. Quando qualcuno muore, quella che io ho chiamato la piccola memoria che sparisce veramente. Tutto quello che sapeva, le sue storie, i suoi libri preferiti, i suoi ricordi... Tutto ci che ci forma e che ci costruisce sparisce totalmente quando si muore, citato in D. Eccher (cur.), Christian Boltanski, Milano, Charta, 1997, p. 36. Nel suo commento alla Festa di Purim il filosofo e critico darte Arthur Danto ha scritto: Nella nostra cultura, quando muore lultima persona che sa, senza bisogno che glielo spieghino, a chi si riferisce una determinata immagine, quella la morte definitiva del soggetto ritratto. Niente pi profondamente anonimo dellimmagine di un viso che nessuno riconosce. Lequiparazione dellirriconoscibilit delle immagini che erano un tempo immediatamente riconosciute con la morte stessa con la morte della memoria la metafora che anima le opere caratteristiche di Boltanski (ibidem, p. 106). 25 Cfr. le voci Arte e Arte in Italia, in W. Laqueur (cur.), Dizionario dellOlocausto, ed. it. a cura di A. Cavaglion, Torino, Einaudi, 2004, pp. 39-47. Per la distinzione citata, cfr. in particolare p. 40. Per quanto riguarda larte dellOlocausto, Sybil Milton classifica cinque categorie principali di opere: 1) ritratti e autoritratti, 2) rappresentazioni di oggetti, paesaggi e nature morte, 3) dipinti di carattere documentario sulla vita nei campi, 4) caricature, 5) lavori astratti (cfr. ibidem, pp. 44-45). 26 Cfr. C. Baudelaire, Il pittore della vita moderna, in Idem, Scritti sullarte, trad. it. di G. Guglielmi / E. Raimondi, Torino, Einaudi, 1992, pp. 290-292.
24
152
Capitolo III
seguono quello irrigidito nellimmagine, ad animare lorrore del quotidiano, esprime una verit per nulla circoscritta allaspetto illustrativo. Anche di fronte a opere in cui prevale lintento di esporre con precisione documentaria la vita e la morte dei deportati, come nei dipinti eccezionalmente perspicui di Wl /adysl /aw Siwek,27 lo choc percettivo rivendica la propria centralit. Tutta la discussione sulla legittimit del giudizio estetico per opere che sembrano scaturite anzitutto da un impulso allesattezza e alla veridicit diviene privo di senso se si considera la capacit propria dellimmagine di restituire la forza cruda dellocchio che ha visto e trasmette la sua indignazione.28 Abbiamo unespressione artistica che anche testimonianza, cos come molti scritti di memoria non rinunciano a essere letteratura. Il ricorso allespressione figurativa da parte dei prigionieri dei campi invita a prendere atto di un peculiare orientamento immaginale della memoria e ci spinge a riconoscere la possibilit di una dimensione secolarizzata dellesperienza, di una sua virtuale traducibilit. Il Lager proveremo in seguito ad argomentare uno spazio tendenzialmente aperto alla figurazione. Prendiamo in esame lopera di Zoran Music. lartista stesso a dircelo: Senza Dachau avrei fatto della semplice illustrazione. Dopo Dachau dovevo andare al cuore delle cose.29 Il bisogno di rappresentare nasce dalla visione della morte. Music porta i cadaveri in primo piano, prende in consegna i corpi rimasti senza sepoltura, ne fa loggetto centrale della propria testimonianza. I disegni eseguiti a Dachau nellestremo del pericolo e certamente non nati per il museo diventano la sorgente di tutta lopera successiva. Una sorta di anamnesi lo induce a rielaborare dopo il 1970 le visioni gi una volta fissate sulla carta e fino a quel momento tenute nascoste. A partire dal ciclo Nous ne sommes pas les Derniers esse tornano a occupare il cuore dellopera e a nutrirla.30 I mucchi di corpi emaciati, gli arti aggrovigliati e contratti, la bocca aperta, la pelle quasi trasparente, le lunghe membra scarnificate, le dita sottili, la rete ancora visibile delle vene: davanti a queste immagini che Music dice di aver avuto la rivelazione improvvisa di una bellezza tragica. Nei cadaveri fragili e disseccati vede qualcosa come una grazia che il disegno, omaggio ultimo a ci che resta di umano in queste forme, non deve tradire.31 Per Music dipingere come aspettare che le cose arrivino a poco a poco, comparendo dalloscurit, cos come le forme compaiono allocchio di colui che, provenendo dallesterno luminoso, entra nel buio di una cattedrale e vede gli oggetti delinearsi a poco a poco. Egli attende che le immagini affiorino, che i ricordi escano dalloblio:
Cfr. W. Siwek, Kie dys to namaluje ..., Os wie cim, Pan stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2000. P. Levi, Presentazione, in A. Benvenuti, K.Z. Disegni dai campi di concentramento nazifascisti. Arte come testimonianza, Treviso, edizione fuori commercio con la partecipazione della Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana, 1983, p. 7. Il volume curato da Benvenuti costituisce, per quanto ne sappiamo, il pi ampio catalogo pubblicato in Italia di disegni eseguiti nei Lager. La rassegna comprende pi di duecentosettanta opere di un centinaio di artisti. Benvenuti ha raccolto le riproduzioni prendendo visione degli originali nelle collezioni di Budapest, Lubiana, Novi Sad, Terezn, Varsavia, Belgrado, Praga, Os wie cim, Gerusalemme e di molti centri concentrazionari. Fra i disegni presenti nel catalogo ricordiamo quelli eseguiti da Jerzy Adam Brandhuber e Xavery Dunikowski ad Auschwitz, da Corrado Cagli, Karol Konieczny, Jsef Szajna e Boris Taslitzky a Buchenwald, da Aldo Carpi a Gusen, da Carlo Slama e Lon Delarbre a Dora, da Leo Haas a Terezn, da Zoran Music e Boz o Pengov a Dachau, da Wl /adysl /aw Siwek a Birkenau. Molti luoghi deputati alla memoria della Shoah ospitano collezioni permanenti. Ad Auschwitz si trovano pi di seimila dipinti, sculture e lavori grafici. Presso lo Yad Vashem di Gerusalemme, dove si trova la pi ampia collezione di opere dedicate al genocidio, le creazioni degli artisti ebrei che nei vari Paesi europei operarono sotto loccupazione tedesca si affiancano a quelle di artisti della seconda o terza generazione dei superstiti. 29 Cit. in Zoran Music. uvres de 1947 2001, Genve, Galerie Jan Krugier, Ditesheim & Cie, 2001, p. 36. 30 J. Clair, La barbarie ordinaire. Music Dachau, Paris, Gallimard, 2001, p. 59. 31 Ibidem, p. 32.
28
27
Percorsi di memoria
153
cose da tempo scomparse, immagini di cui resta solo lessenziale.32 La sua pittura coglie il breve istante del disvelamento, che anche quello in cui le cose ricominciano a sprofondare nel nulla. Gli ultimi dipinti sono figure del superstite: personaggi solitari, con il volto quasi illeggibile, seduti o con le braccia innaturalmente tese, a malapena emergenti da uno sfondo indistinto e scuro, quasi confusi con esso. A volte si tratta dellartista nel suo atelier. Gli impressionanti autoritratti cui alla fine si consacra in modo quasi esclusivo sembrano apparizioni, spettri che sorgono dal regno dei morti. Da essi si pu capire in quale misura lelaborazione del proprio tema abbia portato Music a problematizzare lessenza stessa della rappresentazione, ossia il suo carattere sospeso, violentemente esposto al nulla e alloblio. Questi dipinti non si limitano a registrare apparizioni in forma di ricordi, ma mostrano la pittura in se stessa come apparizione. Secondo le parole di Jean Clair: la pittura come manifestazione, sorgere del visibile alle soglie dellinvisibile.33 Su un punto non dunque possibile ingannarsi: lintento non quello di rivelare lorrore in quanto tale, documentando o illustrando qualcosa come la realt. Dipingere lorrore vorrebbe dire narrare, attendere ancora alla dimensione figurativa. Music non disegna la camera a gas, che del resto non vede se non dopo la liberazione, ma piuttosto cerca di comprendere la morte da pittore, riflettendo sulle condizioni stesse della visibilit. Questa dimensione apofatica dellorrore entro la quale si inscrive la sua pittura ci porta in prossimit delle Figure di Francis Bacon, per molte delle quali un interprete come Deleuze ha sottolineato lestraneit a ogni forma di brutalit o tortura. La Figura, vale a dire il modo rappresentativo con il quale Bacon supera la figurazione (lillustrativo, il narrativo), compare qui anche nel suo antico significato di apparizione, larva. La violenza che le appartiene non quella del rappresentato, ma quella della sensazione, che agisce direttamente sul sistema nervoso.34 Anche il progetto di dissoluzione del volto che Deleuze attribuisce a Bacon potrebbe caratterizzare altrettanto bene gli ultimi dipinti di Music. Fin dallinizio questi aveva potuto assimilare dal vivo le deformazioni cui, in modo programmatico, Bacon sottopone il corpo in vista della sua interpretazione pittorica. Ci che viene meno in entrambi la sintesi organica della figura: essa viene colta piuttosto nellatto di disfarsi. Del resto, la carne macellata in Bacon e le cataste di cadaveri in Music rappresentano in modo ancor pi eloquente quello stato del corpo in cui la carne e le ossa, anzich comporsi strutturalmente, si confrontano localmente.35 Ancora una volta non si tratta di descrivere, ma di pensare fino in fondo le condizioni della rappresentazione in unepoca di crisi della rappresentazione, vale a dire in unepoca in cui ci che pi di ogni altra cosa dovrebbe essere mostrato si definitivamente sottratto alla visibilit. Ladempimento dellantica profezia secondo la quale tutto deve ritornare in polvere viene verificato nel corpo stesso di una pittura che non pu pi essere rivelazione, ma non accetta per questo di consegnarsi alla pura immanenza.
32 33
Cfr. Zoran Music. uvres de 1947 2001 cit., pp. 80-81. J. Clair, La barbarie ordinaire. Music Dachau cit., pp. 66-67. 34 G. Deleuze, Francis Bacon. Logica della sensazione, trad. it. di S. Verdicchio, Macerata, Quodlibet, 19993, p. 88. 35 Ibidem, pp. 55-56.
154
Capitolo III
Fig. 1 - Museo di Auschwitz-Birkenau
36 37
Architettura del vuoto Nel dispositivo nazista di rappresentazione, alla crisi della rappresentazione fa riscontro un eccesso simbolico che Nancy definisce iper-rappresentazione: la pura e semplice esibizione di una presenza totale, satura, che rimanda solo al proprio esserpresente, alla propria immanenza, che non manifesta altro che se stessa. Poich non rivela nulla, una rappresentazione senza resti, senza scavo [...], senza linee di fuga.36 Ma oggi ci troviamo forse di fronte a una paradossale linea di continuit fra loggetto della musealizzazione e i modi in cui questa si realizza. Sembra anzitutto che il Lagermuseo erediti dalla realt totalitaria limpulso parossistico alla raccolta e alla catalogazione dei propri materiali. Si pensi ad esempio alla cura maniacale con la quale nei campi venivano registrati uomini e cose, alla quasi sistematica trascrizione delle immatricolazioni e dei decessi (cui negli ultimi anni si oppose soltanto la volont di sterminio totale), alla meticolosa definizione di spazi e funzioni, allintrinseca musealit della Effektenkammer, nella quale trovavano posto ad Auschwitz gli oggetti tolti ai deportati al momento del loro ingresso nel Lager (figg. 1 e 2).37 La vocazione rappresentativa e mediatica del nazismo non si esercitava soltanto nelle parate militari e nellarte monumentale, ma aveva un suo momento specificamente collezionistico, che non pu essere spiegato solo sulla base delle pur evidenti motivazioni di carattere economico o amministrativo (quantificazione della disponibilit di manodopera, trasformazione delle cose in vista del loro reinserimento nel circuito delle merci).38 Vi qualcosa di dispendioso, di celebrativo, di gratuito e di esemplare nel modo in cui il Lager organizza il proprio dispositivo interno, larticolazione delle funzioni, la delimitazione degli spazi, lassegnazione dei ruoli. Nessun oggetto, nessuno strumento (inanimato o animato), nessun luogo deve restare privo della sua cornice, della sua descrizione, di una tassonomia che determini la posizione che gli compete. un sistema che si autolegittima nellesibire la propria capacit inclusiva, nel mettere alla prova la propria tenuta con laumento della complessit: ma qui la coesistenza della serie e della singolarit assoluta si afferma a spese della seconda.
Fig. 2 - Museo di Auschwitz-Birkenau
Cfr. J.-L. Nancy, Tre saggi sullimmagine cit., pp. 74, 79. Scarpe, valigie, capelli, vestiti, occhiali, protesi, ombrelli, bottoni, oggetti legati alla vita e al lavoro dei deportati: la tesi dellessenza allegorica del museo postmoderno potrebbe venirne corroborata. 38 La creazione di musei e archivi sui propri nemici era una mania dei nazisti. Hannah Arendt ricorda come Eichmann, allinizio del suo incarico presso il Servizio di sicurezza, fosse stato assegnato allUfficio informazioni in vista della creazione di un museo massone (cfr. H. Arendt, La banalit del male. Eichmann a Gerusalemme, trad. it. di P. Bernardini, Milano, Feltrinelli, 19922, p. 45).
Percorsi di memoria
155
A confermare limpressione di una strana dialettica dellapparenza sono poi le forme stesse del campo di sterminio: effetti prospettici, linee di fuga, contrasti di luce, monumentalit non esente da ambizioni formali.39 Primo Levi osserva come una predisposizione scenografica e architettonica, per quanto funzionale a un progetto di sistematica falsificazione della realt, fosse insita nella stessa struttura concentrazionaria.40 Nonostante le profonde trasformazioni che hanno cancellato molte delle tracce e definitivamente mutato il volto dei campi ancora esistenti,41 la suggestione del luogo continua ad agire sul visitatore a un livello che si potrebbe definire aptico o ambientale, prima ancora che attraverso precisi riscontri fattuali. Non so se questo tipo di fruizione sia corretta, voglio soltanto osservare che si tratta del livello minimo di penetrazione, senza il quale non si dischiude la strada della conoscenza. Possiamo avanzare lipotesi che nella sistemazione museale dei Lager sia stata decisiva la disponibilit dei luoghi a una trasformazione in senso simbolico, come se il linguaggio formale di carattere architettonico e visivo cui di volta in volta si fatto ricorso fosse gi quello della realt preesistente e non si trattasse di altro che di recepirne e rovesciarne talune indicazioni, al fine di creare una sorta di racconto esteticamente leggibile.42 Ci vale naturalmente non solo per gli spazi esterni, ma anche per lallestimento dei percorsi che costituiscono la parte propriamente museale dei luoghi della memoria. Impianti espositivi di tipo tradizionale e persino gi un po invecchiati, come quelli che si osservano nei padiglioni di Auschwitz I, possono comunque contribuire a instaurare un certo grado di tensione estetica, con effetti atmosferici di volta in volta suggeriti da unilluminazione ridotta, dalla studiata assenza di didascalie, dal monocromatismo delle superfici. In anni recenti si affermata sempre pi lesigenza di unarchitettura del silenzio, espressa da una lingua minimale e fondata su unestrema semplificazione dei segni.43 Ovviamente si pone qui il problema del rispetto degli spazi preesistenti, ma questo non significa che i modi di presentazione non possano trarre spunti decisivi dalle esperienze pi innovative maturate in sede progettuale. Se pensiamo ad esempio allo Jdisches Museum di Berlino o al Dansk Jdisk Museum di Copenhagen, entrambi realizzati su progetto dellarchitetto Daniel Libeskind, siamo in grado di riconoscere due condizioni essenziali che potrebbero essere riprese in ogni intervento sui luoghi della memoria: 1) il museo rivendica una sorta di autosufficienza visiva e teorica, in quanto realt che vuole essere interpretata ed esperita essa stessa come opera compiuta, a prescindere dai contenuti espositivi; 2) di qui lesigenza di evitare ogni sovraccarico nellallestimento, puntando invece su un programmatico svuotamento dello spazio; il museo devessere organizzato in-
39 Sulla fantasiosa tipologia kitsch delle torri di guardia si soffermavano ad esempio Alain Resnais e Jean Cayrol in una celebre sequenza di Nuit et brouillard. Pi spesso, tuttavia, larchitettura del Lager recepisce la monumentalit stereotipata delle installazioni militari. 40 P. Levi, Pagine sparse 1981-1987, in Opere, vol. II, Torino, Einaudi, 1997, p. 1269. 41 Non sto quindi pensando alla scomparsa dei luoghi, cancellati dalla ricostruzione, rioccupati da edifici civili o da capannoni industriali, e nemmeno alla soppressione di singoli elementi per volont dei nazisti (distruzione dei crematori, delle strutture produttive ecc.), ma allaspetto generale dei campi superstiti, al loro impatto visivo immediato. 42 Cfr. ad esempio le considerazioni sulle valenze simboliche connesse alla risistemazione del complesso museale di Carpi da parte del gruppo di architetti BBPR in R. Gibertoni / A. Melodi, Il Campo di Fossoli e il Museo Monumento al deportato di Carpi, in T. Matta (cur.), Un percorso della memoria cit., pp. 104-05; cfr. anche B. Zevi, Cinetica per tollerare i massacri. Museo monumento al Deportato di Carpi, in Idem, Cronache di architettura, vol. IX, Roma-Bari, Laterza,1975, pp. 182-185. 43 Questo ad esempio lorientamento degli architetti dello studio MSP-H nella realizzazione del nuovo centro di accoglienza per i visitatori del campo di Mauthausen (cfr. Abitare, n. 442 / settembre 2004).
156
Capitolo III
torno a un vuoto fisicamente percepibile dai visitatori e tale da costituire il vero oggetto del museo; questo svuotamento pu avere un valore altamente evocativo,44 proprio perch non indotto da una tematizzazione esplicita, essendo larchitettura stessa a trasmettere il senso di un percorso erratico, labirintico, con evidenti effetti di spaesamento. Nei progetti di Libeskind lelemento perturbante rafforzato anche dalla contestazione dellortogonalit delle superfici, dallinclinazione delle pareti, dallapertura di tagli luminosi obliqui, dal variare della pendenza del piano di calpestio. Certo, non pensabile la pura e semplice trasposizione di queste soluzioni alla realt del Lager, laddove in gioco semmai la prospettiva del restauro e della ricostruzione storicamente attendibile. Ma assumere il punto di vista di una logica autonoma dello spazio museale servir quantomeno a evitare svolgimenti narrativi incentrati su princpi cronologici e storicistici tipici di un orientamento museografico, purtroppo assai diffuso nei luoghi della memoria, che non riesce a individuare contenuti pedagogici al di fuori di quelli affidati alla funzione didascalica delle presentazioni. Luoghi e identit Nel nostro ambito lefficacia di ogni relazione simbolica legata alla presenza di un luogo reale che diviene monumento, spazio destinato allelaborazione del lutto e alla celebrazione del ricordo nel luogo stesso degli eventi. Il Lager rivela al massimo grado quanto siano divenuti fluidi i tradizionali confini fra museo, monumento e prassi storiografica.45 In questo senso andrebbero lette tutte le forme attraverso le quali la memoria tende a fissarsi nel paesaggio: la lapide, il segno collocato nella pi stretta prossimit con il luogo dove la morte ha colpito o dove la vita continua a svolgersi.46 Nei vari allestimenti di forme diffuse di museo, collegate allo spazio urbano ed extraurbano e a tutti gli altri luoghi di memoria presenti su un dato territorio, si deve scorgere una medesima esigenza di radicamento e contestualizzazione. Lesperienza della traccia inserita nel territorio genera unemozione del tutto particolare, che al tempo stesso di carattere storico ed estetico: si tratti della traccia autentica che sincontra sul luogo dellevento (traccia magari quasi scomparsa, come a Monowice, dove fra le nuove costruzioni ben poco ricorda ancora la presenza del campo), oppure della traccia intenzionalmente posta, ma perlopi inosservata, disattesa (liscrizione, il monumento, la fotografia). I Lager e i luoghi della memoria raccontano anche storie locali e trasmettono ricordi spazialmente situati.47 Il luogo nasce propriamente con il suo riconoscimento come luogo, con la sua istituzionalizzazione a monumento da parte di una collettivit. solo il monumento a legare levento alla sua rappresentazione, facendo del luogo un luogo.48 Che nei con-
44 Cfr. G. Alessandri, Le parole del vuoto. Lo Jdisches Museum di Berlino, in Art e Dossier, n. 196 / gennaio 2004, pp. 8-13. Riferendosi alla memoria specifica dellebraismo europeo, cui dedicato il museo berlinese, Alessandri ricorda come vuoto, oltre allo spazio del genocidio e dellesilio, sia anche lo spazio sacro della cultura ebraica, rigorosamente iconoclasta e intrisa di una valenza messianica. 45 A. Huyssen, Monument and Memory in a Postmodern Age, in J. E. Young (cur.), The Art of Memory cit., p. 16. 46 Cfr. C. Dellavalle, Nota introduttiva, in N. Adduci / L. Boccalatte / G. Minute, Che il silenzio non sia silenzio. Memoria civica dei caduti della resistenza a Torino, Torino, Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Societ Contemporanea Giorgio Agosti, 2003, p. 9. 47 A un impatto non del tutto diverso puntano oggi i tentativi degli artisti di ristrutturare lesperienza percettiva del fruitore mediante la creazione di opere integrate nel paesaggio e determinate a esplorare le relazioni offerte dalla topografia o dalla storia del luogo (site specific art, environmental art). 48 Cfr. N. Baiesi / G. D. Cova, Educa il luogo, in T. Matta (cur.), Un percorso della memoria cit., p. 143.
Percorsi di memoria
157
fronti del luogo persino lesperienza personale possa assumere valore fondante dipende in ultima analisi dal fatto che anche questa esperienza pu essere partecipata ad altri e divenire oggetto di un riconoscimento comune. Del resto, nellodierna tipologia di contatto con i Lager, la riscoperta del luogo scomparso, non monumentalizzato e pressoch cancellato (Monowice, appunto, o Gliwice o Linz), costituisce solo uno dei casi possibili (bench tuttaltro che raro), al quale sar comunque possibile attribuire una sorta di monumentalit implicita o virtuale. Di solito il visitatore si trova di fronte a un grado pi o meno accentuato di monumentalizzazione esplicita: il memoriale in assenza del campo scomparso (Gusen), il memoriale-crematorio quale residuo di un campo preesistente (Melk), il luogo in corso di recupero (Fossoli), il luogo parzialmente ricostruito (le gallerie di Ebensee o di Mittelbau-Dora), il luogo museo o centro di documentazione (Auschwitz I, Mauthausen, Buchenwald, Dachau).49 Il concetto antropologico di luogo presuppone una serie di relazioni di identit e differenza che hanno il loro terreno di applicazione nella Storia. Marc Aug ha caratterizzato lidea di modernit (anche in senso baudelairiano) in termini di integrazione dellantico nel nuovo, coesistenza di diverse temporalit fondata sullindividuazione di luoghi identitari e relazionali presso i quali possono essere sperimentate quelle forme di socializzazione dellesperienza che sono decisive per il consolidarsi delle singole tradizioni culturali. Ma a questo modello ha poi contrapposto il concetto di una surmodernit caratterizzata invece dallassenza di vere e proprie forme di integrazione tra i diversi piani temporali e nella quale i luoghi antichi si limitano a occupare un posto circoscritto e specifico, come luoghi della memoria repertoriati e classificati. La nostra epoca afferma non produce pi luoghi, ma solo nonluoghi, ossia spazi non identitari, n relazionali, n storici.50 La riflessione da noi condotta sul rapporto fra luogo e visitatori, fra evento e turismo, fra memoria e rappresentazione, non ci ha forse spinti a formulare lipotesi che la fruizione museale resti sempre condizionata da uninsormontabile dissociazione tra individuo e spazio, da una costitutiva incapacit del soggetto di adeguarsi al livello di esperienza richiesto? I Lager-museo sembrano a tutti gli effetti nonluoghi, proprio perch in essi la Storia rischia continuamente di diventare uno spettacolo specifico, dove convivono, in qualit di clienti o passeggeri, individualit poco rilevate che stentano a tradursi in veri nuclei di identit collettiva. Questa circostanza viene anzitutto
49
Per lapprofondimento di questa tipologia nel quadro di un percorso didattico e formativo sui luoghi della memoria, cfr., in questo volume, il Capitolo I 4, Forme della memoria (II). Un caso particolare, ma tuttaltro che raro, quello del museo-memoriale senza rapporto con il luogo in cui sorge. Poich questa dimensione espositiva non rientra, per varie ragioni, nellorizzonte da noi considerato, ci limitiamo a segnalare tre casi che mettono in luce come anche in queste fondazioni siano in corso procedure complesse di legittimazione culturale, politica e comunitaria. a) Pi o meno discutibilmente, nel caso del centro Yad Vashem di Gerusalemme, la peculiare ubicazione del sito tale da fornire una legittimazione etica, in chiave secolarizzata, al moderno Stato di Israele, come spazio di redenzione in rapporto alla catastrofe della Shoah (cfr. S. Friedlnder, Memory of the Shoah in Israel. Symbols, Rituals and Ideological Polarization, in J. E. Young (cur.), The Art of Memory cit., p. 153). b) La prossimit spaziale dello United States Holocaust Memorial Museum di Washington, inaugurato nel 1993, con gli edifici simbolo della storia americana sembra conferire a questo museo il compito di custodire non soltanto la memoria dellOlocausto, ma anche lintegrit degli ideali di democrazia e uguaglianza sui quali si costruita lidentit nazionale degli USA (ibidem, p. 33). c) In Italia, in forme pi ridotte, il Museo della Deportazione di Prato concepito come un viaggio simbolico in un campo di lavoro e di sterminio nazista. Il legame con la realt locale suggerito, in questo caso, dalla vicenda degli operai del Pratese deportati nei Lager di Mauthausen ed Ebensee. 50 Cfr. M. Aug, Finzioni di fine secolo seguto da Che cosa succede?, trad. it. di A. Salsano, Torino, Bollati Boringhieri, 2001, pp. 83-84; Idem, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernit, trad. it. di D. Rolland, Milano, Eluthera, 1993, p. 73. Come esempi di nonluoghi Aug indica grandi magazzini, spazi commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie, mezzi di trasporto, catene alberghiere, strutture per il tempo libero, punti di transito, spazi soggetti a occupazioni provvisorie, bidonville, campi profughi, centri di transito per emigranti e, in generale, tutte le installazioni necessarie per la circolazione accelerata delle persone e dei beni (ibidem, p. 36).
158
Capitolo III
sperimentata sulla pelle del superstite. Come s detto, il ritorno sui luoghi non si ricompone per lui nella forma di una relazione estetica. Per il deportato il luogo luogo, senza disgiunzione, senza la possibilit di unestraneit o di una distanza. Dove gli altri vedono vuoti, egli vede solo luoghi pieni, antropologicamente densi. La sua attenzione per la conservazione del dettaglio e il senso di perdita che avverte di fronte alle trasformazioni cui vanno incontro le cose si lega al ricordo di un tempo in cui i Lager hanno mostrato in modo pi brutale la loro originaria natura di nonluoghi: aree di transito pi che di residenza, aree di estrema concentrazione demografica segnate da una sostanziale trasformazione del rapporto con lo spazio e dalla imposizione di un presente assoluto negatore della Storia, centri di trasferimento di intere popolazioni e interi gruppi sociali, compatibili soltanto con limpiego delle pi efficaci procedure per laccelerazione del trasporto su vasta scala. Ma proprio il riconoscimento della centralit della figura del superstite e del nesso che continua a legarlo al Lager sia nella prospettiva della visita, laddove risulta evidente limportanza della sua funzione di accompagnamento, sia in una pi ampia prospettiva di contatto e negoziazione fra le associazioni internazionali degli ex deportati e le amministrazioni dei luoghi di memoria dovrebbe indurci a considerare la portata regolativa della fruizione museale (in senso kantiano). Forse entrambe le esperienze, quella del testimone che ritorna sui luoghi e quella del visitatore estetico che partecipa a una sorta di cerimoniale laico, tendono a realizzare una peculiare valenza identitaria, come se fosse davvero possibile costruire una tale identit contro quel nemico comune che, secondo Walter Benjamin, non ha smesso di vincere.51 La possibilit di ricostituire rapporti identitari con certi luoghi storici appare, nel caso del Lager, rovesciata. Qui abbiamo degli spazi che sono nati come nonluoghi e vorrebbero oggi diventare per la prima volta luoghi. Dire che il Lager-museo un monumento significa riconoscere che nella sua orbita va costituendosi una lingua che non pi quella istituita nel campo ai fini di unelementare economia di scambio e tante volte descritta negli scritti di memoria. Se il nonluogo lo spazio della comunicazione non umana fra individuo e potenza collettiva,52 il monumento una delle forme della condivisione e si oppone alla solitudine del nonluogo come la lingua autentica si oppone alla comunicazione funzionale alle esigenze della nuda vita. Certo, il monumento rischia di produrre non solo ricordo e consapevolezza, ma anche oblio, irrigidimento, distacco dal passato e dagli spazi della vita quotidiana. Non un caso che si sia affacciata alla coscienza artistica lesigenza di creare monumenti che fossero anche contro-monumenti come quello di Jochen ed Esther Gerz ad Amburgo ,53 monumenti che mettono in discussione i presupposti stessi del pro-
51
W. Benjamin, Sul concetto di storia, trad. it. di G. Bonola / M. Ranchetti, Torino, Einaudi, 1997, p. 27: [Il pericolo] minaccia tanto lesistenza stessa della tradizione quanto i suoi destinatari [...]. In ogni epoca bisogna tentare di strappare nuovamente la trasmissione del passato al conformismo che sul punto di soggiogarla. 52 M. Aug, Nonluoghi cit. p. 108. 53 Cfr. S. Schmidt-Wulffen, The Monument Vanishes. A Conversation with Esther and Jochen Gerz, in J. E. Young (cur.), The Art of Memory cit. pp. 69-75. Si tratta di un singolare monumento che dilegua nel tempo, inizialmente costituito da una colonna alta dodici metri a base quadrata, sulla cui superficie di piombo i passanti potevano incidere i propri nomi, attestando cos il loro antifascismo. Via via che le singole porzioni della colonna fossero state piene di iscrizioni, lintero monumento sarebbe sprofondato nella propria base in fasi successive, fino eventualmente a scomparire del tutto. Una sezione della colonna sarebbe comunque stata sempre visibile attraverso una vetrina posta nel sottostante passaggio pedonale. Inaugurato nel 1986, il monumento fu abbassato per lottava e ultima volta nel 1993. Nellintenzione degli artisti, il vuoto cos intervenuto sul sito del monumento sarebbe stato per tutti un invito ad assumere personalmente il carico della memoria e della lotta contro lingiustizia.
Percorsi di memoria
159
prio esserci e vogliono sottolineare pi il loro carattere di opposizione al fascismo che la loro funzione di memoriali. Recentemente Peter Eisenman ha realizzato in una citt carica di storia, di strutture significanti e di architettura come Berlino un monumento senza significati, senza centro e senza bordi.54 Ma non proprio questa capacit destrutturante nei confronti degli spazi in cui normalmente vengono definiti valori e significati, e in cui altrettanto normalmente si legittimano selezioni e oblii, a costituire la condizione primaria per la vita futura dei luoghi della memoria? azzardato affermare che il Lager-museo, in quanto monumento, porta la dispersione postmoderna dei luoghi storici al suo punto critico, dove lesistente denuncia la propria cattiva coscienza? Lidentit che in esso si costituisce sempre unidentit problematica, plurale, mutevole, oggetto di periodiche rinegoziazioni e di aspri confronti sul terreno della coscienza sociale e delle definizioni religiose o nazionali.55 Archivio che racchiude in nuce tutta la nostra storia pi recente, eterotopo chiamato a contestare e a rovesciare tutti gli altri posizionamenti della cultura,56 il Lager ci ricorda come il modello di razionalit strumentale su cui si costituita la nostra idea di modernit, e in nome della quale lOccidente continua a giustificare le proprie scelte strategiche nel contesto mondiale, non sia in linea di principio estranea a quel progetto di ingegneria sociale che aveva come obiettivo la produzione seriale della morte e lo sfruttamento sistematico delle risorse umane e materiali in vista del puro dominio.57 Pedagogia museale opportuno cercare di capire che cosa il Lager possa insegnare sul museo inteso come pratica occidentale di collezionamento. Tutti i musei sono oggi un invito a gettare sul passato, sulle tradizioni locali come sul concetto di cultura in generale, quello sguardo etnografico al quale ci hanno reso avvezzi i luoghi della memoria, con il loro appello a fissare lalterit radicale, il non assimilabile per antonomasia. Bisogna evitare lillusione che il Lager-museo possa offrire una rappresentazione adeguata della totalit. Vi sempre tensione tra la memoria come frammento, dettaglio, e lintero irrico-
54 In Germania il Memoriale per lassassinio degli ebrei dEuropa stato oggetto di un forte dibattito in fase di definizione del progetto. Jrgen Habermas ha sostenuto lidea del monumento in funzione dellautocomprensione politica dei cittadini tedeschi, in quanto caratterizzata in modo determinante dal rapporto storico con Auschwitz. Contro coloro che argomentavano limpossibilit di innalzare un monumento alla propria vergogna (Hermann Lbbe, Martin Walser), il filosofo francofortese ha sottolineato lesigenza di un monumento che testimoniasse in modo esemplare la volont e il messaggio dei suoi fondatori, ossia di quei cittadini che risultano eredi diretti della cultura che rese possibile il misfatto (cfr. J. Habermas, Lindice ammonitore. I tedeschi e il loro monumento, in Idem, Tempo di passaggi, trad. it. di L. Ceppa, Milano, Feltrinelli, 2004, pp. 22-33). 55 sufficiente pensare alle reazioni suscitate dalla rivendicazione del carattere essenzialmente ebraico dello sterminio in un Paese come la Polonia, dove limmagine degli eventi di guerra si sempre caratterizzata in termini di sacrificio nazionale (pi di cinque milioni di cittadini polacchi persero la vita per le misure di terrore e sterminio messe in atto dalle truppe tedesche di occupazione, la met dei quali di origine ebraica: cfr. T. Bastian, Auschwitz e la menzogna su Auschwitz. Sterminio di massa e falsificazione della storia, trad. it. di E. Grillo, Torino, Bollati Boringhieri, 1995, p. 51; W. Laqueur (cur.), Dizionario dellOlocausto cit., p. 554). Superfluo notare come in questa lettura nazionale abbia avuto un peso decisivo, oltre alla posizione ufficiale dello Stato socialista, la forte identit cattolica del Paese. Il 7 giugno 1979 Giovanni Paolo II definiva Auschwitz il Golgota del mondo contemporaneo, avallando lidea del martirio di Cristo quale sintesi simbolica del genocidio ebraico. Cinque anni dopo, il trasferimento di un gruppo di suore carmelitane in un edificio adiacente al perimetro di Auschwitz I apriva un conflitto destinato a trascinarsi per diversi anni, fra accordi disattesi, proteste ebraiche e posizioni di chiusura da parte della Chiesa polacca, fino allintervento del Vaticano che nel 1989 ratificava laccordo stipulato due anni prima a Ginevra fra le delegazioni delle due parti, che prevedeva lo spostamento del convento e la sua trasformazione in centro interconfessionale di incontro e preghiera (cfr. J. E. Young, The Texture of Memory. Holocaust Memorials and Meaning, New Haven-London, Yale University Press, 1993, pp. 144-147). 56 Per il concetto di eterotopia, cfr. M. Foucault, Des espaces autres, in Idem, Dits et crits. 1954-1988, vol. IV (1980-1988), Paris, Gallimard, 1994, pp. 752-762. 57 Cfr. Z. Bauman, Modernit e Olocausto cit., pp. 37-38.
160
Capitolo III
struibile. Anche qui una certa tradizione si inventa. Nonostante laura di autenticit che circonda loggetto della memoria, i Lager non possono nascondere il carattere selettivo della propria sistemazione. Se per il collezionista darte vale il principio che si colleziona sempre il proprio io,58 per il museo storico si pu assumere la regola secondo la quale sempre una certa cultura che si colleziona, anche quando gli oggetti collezionati appartengono ad altre culture o, come nel nostro caso, rappresentano qualcosa da cui la cultura prende esplicitamente le distanze. Simporrebbe quindi anche per i Lager quella riflessione sui criteri di collezionamento che James Clifford ha impostato in termini antropologici ed etnografici osservando come siano sempre contingenze locali e politiche a legittimare le varie forme di narrazione. Come ogni museo, anche il Lager dovrebbe esibire la storia della propria collezione.59 Tuttavia, considerare la configurazione attuale dei luoghi della memoria come espressione di una relazione storica in corso, che non si limita a restituire una serie di eventi passati, ma registra le trasformazioni in atto nella nostra societ, significa concepire il Lager-museo come un eterotopo caratterizzato da una spiccata qualit dialogica, dove lo spazio del lgos si apre fra lo spaesamento indotto dai luoghi lo choc percettivo che ci costringe a un riassestamento delle nostre coordinate estetiche e lapertura di nuovi significati nello spazio del museo. qui in atto un conflitto (o un movimento dialettico) molto simile a quello descritto da Martin Heidegger a proposito della portata veritativa dellopera darte. Forse leffetto estetico del Lager nasce proprio dal suo duplice funzionamento, come (a) esposizione (Aufstellung) di un mondo e (b) produzione (Her-stellung) della terra. a) Esporre un mondo significa qui fondare o aprire un contesto di appartenenza storico-culturale, esibire i tratti costitutivi che definiscono lesperienza del mondo propria di una societ o di una cultura. Le linee fondamentali della nostra esistenza storica sono apparse negli ultimi anni sempre pi strettamente intrecciate a una cul-
J. Baudrillard, Il sistema degli oggetti, trad. it. di S. Esposito, Milano, Bompiani, 1972, p. 118. Cfr. J. Clifford, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, trad. it. di M. Marchetti, Torino, Bollati Boringhieri, 19992, pp. 25-26, 249-55, 264; Idem, Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, trad. it. di M. Sampaolo / G. Lomazzi, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, pp. 17-18. Per i Lager, il problema si rivela in tutta la sua portata se si pensa alle complesse vicende che hanno segnato negli anni del dopoguerra lallestimento museale dei campi tedeschi e polacchi, o anche alla contrastata presa di coscienza, nel nostro Paese, del ruolo svolto dalla Repubblica Sociale Italiana nella realizzazione del pi grande crimine della storia moderna. Laddove solo a fatica e con grande ritardo si manifestata in Italia la necessit di un recupero e di una valorizzazione dei Lager presenti sul territorio, in Germania lesigenza di un confronto con il passato, avvertita su un piano di coscienza nazionale, ha indotto a una precoce monumentalizzazione dei luoghi, senza che tuttavia fosse avviata una qualche riflessione su quanto era stato perduto con la distruzione dellebraismo europeo. Se nella Repubblica federale si tendeva a concepire i campi alla stregua di cimiteri o luoghi in cui dovevano essere genericamente ricordate le vittime della guerra, nella Germania democratica i Lager sono stati sottoposti a un significativo processo di ideologizzazione e presentati come monumenti alla lotta al fascismo. La categoria della vittima, in questo caso, passava decisamente in secondo piano rispetto a quella del combattente (cfr. V. Knigge, Die Gedenksttte Buchenwald seit 1989/90, in AA.VV., Die Neukonzeption der Gedenksttte Buchenwald, Weimar, Stiftung Gedenksttten Buchenwald und Mittelbau-Dora, 2001, p. 5). Dopo la Wiedervereinigung la museografia dei luoghi della memoria ha dovuto affrontare problemi di non facile soluzione. Nei primi anni Novanta non sono mancate accese discussioni. A titolo di esempio, si pu ricordare la decisione degli amministratori di Buchenwald di recuperare come luogo di memoria larea delle fosse comuni dello Speziallager sovietico, che ospit tra lagosto del 1945 e il febbraio del 1950 circa 28.500 prigionieri tedeschi, per il 43 % dei quali stato possibile verificare liscrizione al partito nazionalsocialista (cfr. P. Reif-Spirek / B. Ritscher (curr.), Speziallager in der SBZ. Gedenksttten mit doppelter Vergangenheit, Berlin, Links, 1999, pp. 140-141). interessante osservare come i responsabili della risistemazione abbiano tenuto a precisare lopportunit di distinguere nettamente le due forme della memoria: quella dedicata alle vittime della violenza nazista nel complesso museale di Buchenwald e quella relativa al periodo delloccupazione sovietica nellarea adiacente al campo principale. La commissione di esperti istituita dal Ministero per la Scienza e lArte del Land della Turingia giunse alla conclusione che il KZ nazionalsocialista doveva costituire ancora il fulcro della rappresentazione museale, mentre la memoria dello Speziallager sovietico doveva essere garantita in subordine. I due luoghi dovevano, inoltre, restare nettamente distinti da un punto di vista spaziale (cfr. ibidem, p. 253). Sulla diversit delle forme di rappresentazione della memoria rispettivamente in ambito tedesco, nei Paesi vittime dellaggressione nazista e negli Stati alleati vincitori cfr. J. E. Young, The Texture of Memory cit.
59
58
Percorsi di memoria
161
tura della memoria entro la quale la pedagogia del Lager svolge un ruolo essenziale. Sono naturalmente in gioco, in questo caso, quei tratti di discorsivit che Hans Belting indica come decisivi per il futuro dei musei in generale e ai quali Gianni Vattimo assegna una specifica valenza sociale e comunicativa: i musei devono diventare soggetti collettivi realizzando uno spostamento di accento dalloggetto allattivit, cessando cio di fare delle opere esposte il fulcro di un interesse prevalentemente feticistico e guardando invece ai mondi possibili che le opere stesse eventualmente annunciano.60 Come luogo dedicato allarchiviazione e alla conservazione dei documenti, il Lager anche un luogo di ricerca, di studio e di incontro.61 b) Questidea del museo come centro di attivit, che ci sembra strettamente correlata allapertura, allesposizione e allintensificazione di orizzonti mondani di significato, destinata a confrontarsi, in misura probabilmente unica nel caso del Lager, con la percezione di una permanente riserva, intraducibile nei termini di un qualsivoglia significato culturale. In questo senso, Vattimo ha interpretato lidea dellopera darte come Her-stellung della terra nel senso del suo puntuale manifestarsi come qualcosa che richiama sempre di nuovo lattenzione. Lopera darte pu essere messa in opera della verit solo in quanto i rimandi che costituiscono il mondo da essa aperto presuppongono un riferimento primario allaltro dal mondo, che in Heidegger ha i caratteri della physis.62 Sono dunque i caratteri unheimlich, perturbanti, del Lager, gli elementi di una storia-natura benjaminianamente intesa come accumulo catastrofico di rovine, ad agire sullo spettatore come strati mitici profondi e a mettere in moto con il loro dinamismo solo apparente ( storia, ma storia-natura), con limmobilit che li caratterizza in quanto divenire ciclico del sempre-uguale il processo storico dellinterpretazione. Il richiamo alla mortalit racchiuso nella nozione di terra dunque essenziale al fine di sottrarre la pedagogia del Lager alle tendenze edificanti eventualmente favorite da unaffrettata identificazione del ricordo come vaccinazione contro il ritorno del passato. A questo ritorno tutti siamo esposti. Per questo una pedagogia del Lager pu essere soltanto una pedagogia della resistenza, una pedagogia che si astiene in linea di principio dalla celebrazione e si mantiene in prossimit essenziale con il proprio oggetto, mediante lo studio. La consapevolezza dellestrema diversificazione dei modi in cui si svolto levento dello sterminio ha reso evidente negli ultimi anni la necessit di unimpostazione di carattere idiografico, tesa a valorizzare la storia di tutti i gruppi di vittime e dei loro specifici destini. Nel quadro di una tale rielaborazione, si sono moltiplicati in ambito museale i percorsi espositivi dedicati alle singole comunit di deportati,63 ai traspor60 61
Cfr. H. Belting, Il museo: riflessione o sensazionalismo?; G. Vattimo, Il museo e lesperienza dellarte nella postmodernit: entrambi i saggi in F. Luisetti / G. Maragliano (curr.), Dopo il museo cit., rispettivamente alle pp. 209-224 e 13-21. Vattimo sottolinea come la funzione di raccolta di informazioni e documenti sia un tratto essenziale del museo postmoderno. Negli archivi del Museo di Auschwitz vi sono alcune decine di migliaia di negativi di fotografie scattate ai prigionieri al momento del loro ingresso nel campo o nel corso delle periodiche selezioni, fotografie scattate clandestinamente dai membri del Sonderkommando nei pressi delle camere a gas, quarantotto volumi con i certificati di morte di circa 70.000 prigionieri, documentazioni tecniche e planimetrie relative alla costruzione del campo, lettere e altri scritti di deportati e molto altro materiale destinato allapprofondimento e alla ricerca. Presso molti Lager vi sono oggi centri di documentazione, che mettono a disposizione moduli didattici e organizzano corsi sulla didattica dello sterminio. Le amministrazioni allestiscono mostre itineranti, rassegne, visite guidate, seminari e curano pubblicazioni (alcune centinaia i titoli pubblicati a cura del Dipartimento per le pubblicazioni di Auschwitz). Allidea del Lager come centro di attivit si ricollega altres la presenza ad Auschwitz di un ufficio informazioni presso il quale possibile ottenere, anche per corrispondenza, notizie sulla sorte dei singoli deportati. 62 G. Vattimo, La fine della modernit, Milano, Garzanti, 1985, p. 71. 63 Il campo di Auschwitz I di fatto un museo nel quale i singoli padiglioni sono dedicati alla memoria delle diverse nazioni.
162
Capitolo III
ti provenienti dai diversi paesi, alla sorte dei singoli prigionieri nelle cosiddette marce della morte, alla specifica dimensione economico-produttiva dei centri concentrazionari, ai movimenti di resistenza, a fatti particolari e ad autori identificabili di crimini: flessibilit della forma-museo, in grado di trasformarsi da veicolo di metaracconti a contenitore di storie individuali.64 Giova qui sottolineare ancora una volta la logica richiesta da questo tipo di operazioni. Dove limpulso primario la volont di conoscenza, il maximum informativo non deve pregiudicare la portata estetico-simbolica delloperazione; n daltra parte si pu tollerare una rinuncia alla conoscenza a esclusivo vantaggio dellelaborazione formale. Credo che nel caso della memoria dello sterminio il salvataggio dellindividuale trovi gi nella relazione allegorica con la totalit infranta la sua fondamentale declinazione estetica. Mi limito qui a considerare un particolare tipo di rapporto con la singolarit assoluta: quello che si determina in presenza dei nomi propri o dei ritratti fotografici. Questo rapporto pu verificarsi anzitutto in una dimensione espositivo-monumentale, dove la stilizzazione formale massima e la portata estetica del gioco pi scoperta. Nei cataloghi di nomi della Hall of Names allo Yad Vashem, della Pinkasova Synagga di Praga o del Museo Monumento al Deportato di Carpi (fig. 3), cos come nelle milletrecento fotografie di ebrei lituani della Tower of Faces di Washington (fig. 4) o nelle iscrizioni comparse anno dopo anno sul muro del Monumento italiano a Mauthausen, vi un potenziale epistemologico che lintenzione rappresentativa, pi o meno esplicita, si limita a precisare, lungi dal sopprimere.65 Ma la stessa produttiva duplicit si pu ritrovare in forme di scrittura che non sono legate alla monumentalit di un singolo luogo o edificio, ma si collocano sul terreno specifico dellindagine storica. Penso a casi emblematici di libri-monumento, come quelli di Liliana Picciotto Fargion, di Italo Tibaldi, di Dario Venegoni, di Danuta Czech, scaturiti dallintenzione asintotica di pronunciare tutti i nomi e raccogliere i destini rimasti senza espressione.66
Quasi esemplare, in questo senso, lesposizione permanente inaugurata a Buchenwald nel 1995: cfr. Konzentrationslager Buchenwald 1937-1945. Begleitband zur stndigen historischen Ausstellung, Gttingen, Wallstein Verlag, 20002. A Birkenau, un luogo che difficilmente potrebbe essere classificato come museo in senso stretto, ha trovato posto nei locali della cosiddetta Sauna una collezione di fotografie tratte da album di famiglia di ebrei polacchi di Be dzin e Sosnowiec, ritrovate fra gli effetti personali dei deportati. Nella penombra delle sale, sotto leffetto straniante del grande pavimento riflettente che rovescia le immagini appese alle pareti, il visitatore invitato a seguire la vicenda dei singoli gruppi familiari e a ripercorrere le storie individuali, spesso ricostruibili nel confronto tra fotografie che ritraggono le persone in attivit e situazioni diverse (figg. 5 e 6). Come in certi lavori di Christian Boltanski, qui chiaramente percepibile un contrasto fra linstallazione, caratterizzata da una monumentalit geometricamente svilupwiebocki, Auschwitz monumento alla pata, e il ritratto fotografico, nel quale si concentra tutta la dimensione emotiva del ricordo (cfr. H. S wiebocka / T. Zbrzeska, A Project for the Interior Arrangement of memoria, in Il presente e la storia, n. 65 / giugno 2004, p. 191; T. S wiebocka (cur.), The Architecture of Crime. The Central Camp Sauna in Auschwitz the Former Camp Bathhouse Building in Birkenau, in T. S II-Birkenau, trad. ingl. di W. Brand, Os wie cim, Auschwitz-Birkenau State Museum, 2001, pp. 195-200). 66 Cfr. L. Picciotto Fargion, Il Libro della memoria. Gli ebrei deportati dallItalia (1943-1945), Milano, Mursia, 1991, 20022; I. Tibaldi, Compagni di viaggio. DallItalia ai Lager nazisti. I trasporti dei deportati 1943-1945, Milano, FrancoAngeli, 1994; D. Venegoni, Uomini, donne e bambini nel Lager di Bolzano. Una tragedia italiana in 7.809 storie individuali, Milano, Mimesis, 2004. Questultimo testo altres disponibile in rete sul sito dellANED e della Fondazione Memoria della Deportazione (www.deportati.it), dove si trova anche la fondamentale, dettagliata cronologia di D. Czech, Kalendarium. Gli avvenimenti nel campo di concentramento di Auschwitz 1939-1945, trad. it. di G. Piccinini, a cura di D. Venegoni, 2002 (nella presentazione Lucio Monaco sottolinea la triplice valenza del libro: storica, archivistica e narrativa). Una portata per certi versi analoga a quella dei testi citati pu essere attribuita alla ricostruzione filmica realizzata da Claude Lanzmann con il suo Shoah, vero e proprio film-monumento della durata di nove ore, montaggio di materiali costituiti da interviste a ex deportati, ex SS e civili, alcune delle quali di insostituibile valore documentario e testimoniale (se ne veda la trascrizione in C. Lanzmann, Shoah, trad. it. di G. Cillario, Milano, Rizzoli, 1987). Sempre nellambito della testimonianza visiva, non sarebbe neppure da scartare lipotesi di una valenza estetica implicita nel progetto della Shoah Visual History Foundation di Steven Spielberg, che, con le sue forme invero piuttosto standardizzate, appare come una sorta di enorme museo in progress della memoria. La fondazione raccoglie a tuttoggi pi di 50.000 video-interviste a sopravvissuti della Shoah da tutto il mondo (cfr. il sito: www.vhf.org). Annette Wieviorka ne ha evidenziato la dimensione industriale in un contesto di esplosione globale della testimonianza a partire dagli anni Novanta (cfr. A. Wieviorka, Lera del testimone cit., pp. 122-129).
65 64
Percorsi di memoria
163
I musei presuppongono, e talora creano, una cornice volta a determinare il senso delle loro inclusioni e delle relative esclusioni. Michel Foucault li concepisce, in analogia con gli archivi e le biblioteche, come metatesti che istituiscono e organizzano altri livelli testuali, a loro volta implicati in una serie di relazioni e rimandi. Cos come ogni libro moderno un libro aperto alla serie infinita dei libri (in un rapporto essenziale con quanto gi stato scritto) e ogni pittura moderna pittura da museo (nata per rendere esplicita la propria parentela essenziale con ci che gi stato dipinto),67 anche il Lager deve essere pensato come un luogo di raccolta delle storie, un punto di convergenza delle testimonianze e dei linguaggi che intorno alla deportazione sono nati negli ultimi sessantanni, uno spazio caratterizzato da una costitutiva vocazione metamorfica, da una permanente tendenza alla ridefinizione delle proprie funzioni. Nel Lager si produce intertestualit:68 lenorme mole degli scritti di memoria e delle testimonianze scritte e orali, per la quale non esiste a tuttoggi una bibliografia esauriente,69 trova in esso il proprio centro ideale. Libro dei libri, archivio virtuale delle forme della testimonianza, il luogo della memoria non si limita ad accogliere elementi linguistici precostituiti: li pone in essere, li costituisce come tali, crea nuovi contesti di esperienza e nuove modalit di organizzazione della conoscenza storica. Al tempo stesso, per, un catalogo aperto, suscettibile di ampliamenti e nuove combinazioni. Come ogni museo, anche metamuseo, in quanto vive da un lato delle serie di oggetti/documenti che vi sono confluite, mentre contiene dallaltro indicazioni su ci che in esso rimane infinitamente aperto alle possibili integrazioni. Nessuno dei linguaggi che entrano a far parte della cornice museale pu aspirare a dire lindicibile, a descrivere ci che per essenza si sottrae al gioco della finzione; lesito fantasmagorico descritto da Foucault attraversa tutto lo spazio della scrittura, delle memorie, delle immagini. Ma qui limmaginazione sperimenta anche la propria insufficienza di fronte alla valu-
Cfr. M. Foucault, Un fantastico da biblioteca, in Idem, Scritti letterari, trad. it. di C. Milanese, Milano, Feltrinelli, 19963, pp. 136-139. Cfr. A. Huyssen, Monument and Memory in a Postmodern Age cit., p. 16. 69 Cfr. per A. Devoto, Bibliografia delloppressione nazista fino al 1962, Firenze, Olschki, 1964; Idem, Loppressione nazista: considerazioni e bibliografia 1963-1981, Firenze, Olschki, 1983. Per la storia dei deportati italiani cfr. A. Bravo / D. Jalla (curr.), Una misura onesta. Gli scritti di memoria della deportazione dallItalia 1944-1993, Milano, FrancoAngeli, 1994. Per il campo di Mauthausen il ministero degli Interni austriaco ha dato avvio nel 2001 a un progetto di raccolta di testimonianze di deportati denominato MSDP (Mauthausen Survivors Documentation Project), che comprende circa ottocento interviste raccolte in una ventina di Paesi (cfr. V. Frenkel, Conservare la memoria. Le interviste ai deportati di Mauthausen, in Il presente e la storia, n. 65 / giugno 2004, pp. 207-226).
68
67
Fig. 4 - United States Holocaust Memorial Museum di Washington: la Tower of Faces
Fig. 3 - Museo Monumento al Deportato di Carpi
164
Capitolo III
tazione di un oggetto estraneo alle regole della comunicazione estetizzata. Ogni testimonianza in un rapporto museale con tutte le altre testimonianze (e pi in generale con le diverse forme rappresentative accanto alle quali si espone) e tuttavia istituisce al contempo una relazione unica e insondabile con il fondo dal quale tutte le testimonianze provengono. Tutto questo rester per molto tempo a disposizione degli uomini futuri, ma limpatto che oggi i luoghi della memoria esercitano (ancora o di nuovo) non assicurato per sempre. Quando anche gli ultimi testimoni oculari se ne saranno andati, i campi avranno bisogno di testimoni secondari, o mentali, come stato detto con espressione quanto mai esatta.70
70
A. Bravo, Gli archivi dellANED piemontese e la loro importanza per la didattica, in L. Monaco (cur.), La deportazione nei Lager nazisti. Didattica e ricerca storiografica, Milano, FrancoAngeli, 1999, p. 24.
Fig. 6 - Esposizione permanente nella Sauna di Birkenau
Fig. 5 - Esposizione permanente nella Sauna di Birkenau
165
Capitolo IV - Testimoni e memorie
I fili della memoria che hanno guidato e continuano a guidare i nostri percorsi vanno molto indietro nel tempo, ben pi dei dieci anni che il volume cerca di riassumere. Nelle scuole italiane, e piemontesi in particolare, lincontro di testimoni, diretti e indiretti, con le classi e con studenti e insegnanti tradizione pluridecennale, e cos avvenuto anche per le Scuole di Moncalieri (medie superiori e inferiori, un ambito questultimo purtroppo poco noto). Gli incontri pi lontani hanno posto le basi metodologiche e conoscitive per il Progetto Memoria: per noi che scriviamo queste pagine si tratta di risalire a oltre ventanni fa. Pi precisamente, al 30 novembre 1984, quando un gruppo di studenti del Liceo Scientifico Majorana incontr Leonella Bellinzona, Anna Cherchi, Ferruccio Maruffi e, un mese dopo, Attilio Armando, Quinto Osano, Luigi Scala. Da quei momenti nomi come Flossenbrg, Ravensbrck, Mauthausen, Gusen, Sachsenhausen e anche Fossoli, Bolzano accanto a quello pi noto di Auschwitz, sono entrati a far parte della formazione e della coscienza civile di gruppi inizialmente molto ridotti, poi pi ampi di studenti e insegnanti. Testimoni, e anche studiosi e storici, hanno contribuito alla nostra lunga attivit di ricerca, che come abbiamo detto soltanto negli ultimi dieci anni ha assunto, con il nome di Progetto Memoria, la configurazione di cui si occupa il libro. Ai nomi gi fatti dobbiamo aggiungere, per i superstiti dei Lager, quelli di Lidia Beccaria Rolfi, di Beppe Berruto, di Pio Bigo, di Giorgio Ferrero, di Felice Malgaroli, di Marcello Martini, di Albino Moret, di Quinto Osano, di Natalino Pia, di Alessandro Roncaglio, di Giuliana Fiorentino Tedeschi, di Natalia Tedeschi, di Gino Valenzano, di Bruno Vasari; e in particolare dei moncalieresi Orfeo Mazzoni e Antonio Temporini; e di tre deportati e studiosi stranieri, passati per linferno di Auschwitz: Rose e Maurice Goldmann, e un grande amico di Primo Levi, Hermann Langbein. E poi dobbiamo ricordare quelli che abbiamo chiamato testimoni di secondo grado, a cominciare dai famigliari cui abbiamo accennato nellIntroduzione: a essi aggiungeremo il nome di Nedelia Tedeschi, figlia di deportati e testimone diretta della persecuzione da cui fu investita, tra il 1943 e il 1945, la Comunit ebraica di Torino. Con Nedelia commemorammo nellAuditorium del Liceo i cinquantanni della liberazione di Auschwitz, quando ancora questo evento non occupava lo spazio mediatico di cui dispone oggi (e non era semplice districarsi tra le polemiche di revisionisti e negazionisti). E infine vogliamo sottolineare la discreta ma fedele presenza di Mario Pettinati, partigiano nelle Langhe, che ci ricorda, standoci accanto in ogni incontro a Moncalieri, come deportazione e Resistenza siano strettamente legate, sul piano storico come su quello etico e ideale. Un legame pi profondo si naturalmente creato con i superstiti e i testimoni che hanno partecipato ai viaggi. Vogliamo qui tracciarne brevemente le vicende di deportazione e i dati biografici, e a loro diamo la parola per ascoltarne la testimonianza di memoria.
166
Capitolo IV
Anna Cherchi era nata a Torino il 15 gennaio 1924. Data in affidamento, vissuta con la famiglia adottiva dei Penna fino al 1944, nella cascina Ca d bs (o cascina Basso), presso la frazione di Santa Libera, nel comune di Loazzolo (nella Langa, allepoca provincia di Alessandria). Questo dato biografico, da lei comunicato a poche persone, contribuisce forse a spiegare la grande capacit comunicativa e il ricco calore umano che la caratterizzavano, e che erano tipici, come raccontava in privato, della famiglia di accoglienza: famiglia contadina, in cui si respirava una forte ostilit al fascismo. Cos dopo l8 settembre la cascina diventa un centro di assistenza e aiuto per i militari sbandati, e successivamente per le prime formazioni partigiane. Il 7 gennaio 1944 la casa incendiata dai nazifascisti, Anna arrestata ma riesce fortunosamente a fuggire, raggiungendo le formazioni partigiane autonome, dove si trova il fratello Giuseppe (Basso). Entra nella 22a Divisione Langhe, 6 Brigata Belbo, assumendo nei documenti il falso nome di Maria Bruni. Il 19 marzo, durante un rastrellamento, si fa catturare dai nazifascisti per consentire al resto del gruppo partigiano di mettersi in salvo. Portata a Torino, interrogata e torturata in Via Asti e allAlbergo Nazionale, quindi imprigionata alle Carceri Nuove. Il 27 giugno deportata a Ravensbrck dove viene immatricolata con il n. 44145. In luglio trasferita, con altre nove italiane dello stesso convoglio, al sottocampo di Schnefeld (Berlino), dove le viene assegnato il numero 1721. Qui, insieme alle compagne, lavora alla produzione di parti di aereo da bombardamento. Alla fatica e ai ritmi massacranti di un lavoro schiavile si aggiunge, il 15 e il 16 gennaio 1945, un disumano esperimento pseudomedico subto nel reparto Patologia del Lager di Sachsenhausen (da cui, per qualche tempo, dipese il sottocampo di Schnefeld), con lestrazione, senza anestesia, di quindici denti, e il rinvio immediato al lavoro. Anna si salva certamente per la sua fibra forte, ma anche grazie alla solidariet delle compagne un tema su cui insisteva sempre la sua testimonianza. Cessata la produzione alla fine di febbraio, il campo evacuato il 26 o 27 aprile 1945, e le deportate sono avviate verso Ravensbrck; ma sulla strada sono intercettate e liberate dai sovietici tre giorni dopo. Dopo un travagliato rientro in Italia, Anna Cherchi, in precarie condizioni di salute, lasci la famiglia di adozione e si trasfer a Torino, dove si spos e lavor come operaia alla Fiat Ferriere, dal 1949 al 1979. Soprattutto negli ultimi ventanni la sua attivit di testimone si espressa in una presenza capillare e costante a incontri nelle scuole di ogni tipo e a viaggi ai luoghi di memoria organizzati dallANED, dai singoli istituti scolastici o dalla Regione Piemonte. Un impegno di testimonianza che assolveva con serenit e sollecitudine anche nei momenti resi difficili da problemi di salute sempre pi gravi. Anna Cherchi si spenta a Torino nel gennaio 2006.
Immagini e parole di Anna Cherchi
Con questangoscia e questo dubbio nel cuore torno a ripetere che tuttavia ricordare bisogna; anche se il ricordare costituisce ogni qualvolta un rinnovarsi di sofferenza, siamo convinte di poter far capire al mondo limmensit del male che luomo pu fare alluomo, e che da questo nato il flagello della deportazione, che la pi grande sofferenza e la pi vasta strage che il mondo abbia mai conosciuto. A parte gli incubi che ancora oggi, e forse per sempre, ci perseguitano, essere ritornate degli esseri umani indescrivibilmente bello.
Testimoni e memorie
167
Certo per comprendere il significato della parola libert, bisogna esserne stati privati. Comprendendo questo, unaltra cosa ho potuto comprendere: il perch milioni di uomini e donne si sono buttati volontariamente in quella lotta senza temere la morte, disposti anche a rinunciare alla vita perch volevano che rivivesse nuovamente ci che meritava di vivere pi a lungo di loro.1 Anna Cherchi lascia una testimonianza particolarmente viva e vicina a noi in una serie di documentari e di film. A quelli allegati al presente volume, in formato DVD (per i quali rimandiamo anche allAppendice VII. B, Immagini della memoria, pp. 251-270) sono da aggiungere: Pane, pace, libert (1943-1945), regia M. Calopresti, VHS PAL, 43, 1994 (Archivio audiovisivo del Movimento operaio e democratico); La guerra alla guerra, regia A. Gasco, VHS, 63, 1995 (Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Societ Contemporanea Giorgio Agosti); Il fiore e il passero, regia D. Cambiano / D. Giacometti, VHS PAL, 35, 1995 (Quarta Rete TV s.r.l. / Consiglio Regionale del Piemonte); I detenuti politici del Carcere delle Nuove di Torino , regia F. Tagliente, VHS, 1999; Il viaggio, regia D. Cambiano, VHS, 50, 1999 (Quarta Rete T V s.r.l.). Si veda anche la trascrizione dellintervista filmata contenuta nel sito www.testimonianzedailager.rai.it (con stralci video), senza indicazione di data, ma 2001 (per cura di Carla Gacomozzi e Giuseppe Paleari). Quanto alla parola scritta, vi sono ovviamente numerose interviste, ma difficilmente rintracciabili perch riportate su stampa periodica o di fatto ancora inedite. Costituiscono comunque un sicuro punto di riferimento per la sua memoria autobiografica: Anna Cherchi, La parola Libert. Ricordando Ravensbrck, a cura di L. Monaco, Alessandria, Edizioni dellOrso, 2004; e le sue pagine Deportazione al femminile, in A. Cassara / E. Castelli / A. Lichtenstein (curr.), Voci della memoria. Testimonianza e racconto della deportazione, Roma, 2005 (allegato a LUnit del 27.1.2005), pp. 20-25.
Natalia Tedeschi e Anna Cherchi al Memoriale di Ravensbrck (marzo 2001)
1
A. Cherchi, La parola Libert cit., pp. 31, 24.
168
Capitolo IV
Natalia Tedeschi era nata a Genova il 19 giugno 1922. Trasferita a Torino, al momento dellemanazione delle leggi razziali deve interrompere gli studi (1938). Con levoluzione della guerra, nel 1943 una parte della famiglia sfolla a Saluzzo; poi Natalia si rifugia con la madre, Bice Sacerdote, e la nonna, Celeste Muggia, a Sampeyre e a Casteldelfino. Qui le tre donne sono arrestate dai tedeschi, su delazione di un italiano, il 28 marzo 1944, e imprigionate a Venasca e poi a Torino, quindi tradotte a Fossoli. Il 16 maggio sono deportate ad Auschwitz: il convoglio comprende 581 persone; ne saranno immatricolate 256 (186 uomini e 70 donne), mentre gli altri verranno immediatamente eliminati nelle camere a gas. Anche la madre e la nonna saranno uccise allarrivo. Natalia Tedeschi immatricolata con il n. A 5404. Trasportata in seguito a Bergen Belsen, Dessau, Theresienstadt, viene liberata in questultima localit. Vissuta a Torino, testimone schiva e riservata, Natalia ha seguto con crescente attenzione le attivit del Progetto Memoria, assicurando la sua presenza nelle prime commemorazioni del 27 gennaio. mancata nel marzo 2003.
Il racconto di Natalia Tedeschi
Auschwitz, marzo 1999 (Studentesse dellITCS Marro) Lebraismo, le mie radici Sono nata a Genova il 19 giugno 1922, sono cresciuta in una famiglia ebraica credente, ma non assidua e praticante. Anchio non sono rigorosa nel seguire i numerosissimi precetti della mia religione... Per la mia identit, la mia cultura, le mie origini, quelle le sento profondamente. Quando sono arrivate le leggi razziali nel 1938, eravamo increduli. Ci chiedevamo: Cosa ci possono fare? Non abbiamo fatto niente Invece ci hanno mandati via da scuola. Mio fratello Cesare riuscito ancora a laurearsi, e pensare che non era facile, non si doveva fallire nessun esame, altrimenti non si poteva pi continuare. Mio fratello Vittorio era iscritto a Economia e Commercio. Un giorno tornato a casa e ci ha detto: Io non continuo pi perch avr la vita corta. Lo so, lo sento che morir giovane. ( poi mancato a Mauthausen. Il 25 aprile! Era nei partigiani ed stato denunciato da un amico. Anche quellamico morto a Mauthausen.) Io avevo iniziato il ginnasio, poi sono passata allIstituto professionale M. Letizia, ma nel 38, al primo anno di superiori, ho dovuto lasciare. Da un giorno allaltro sono rimasta a casa. Mia mamma mi ha ancora iscritta allIstituto filologico in Via delle Orfane, ma anche l non mi stato consentito di continuare. La fuga e larresto Eravamo a Saluzzo, dove viveva una sorella di mia nonna. Eravamo l, sfollati, perch a Torino cerano i bombardamenti. Ero con mia mamma e mia nonna. Due miei fratelli erano nei partigiani, laltro era nascosto a Torino, in una soffitta di Via Belfiore, dove il nostro amministratore gli portava da mangiare. A Saluzzo alloggiavamo allAlbergo della Luna dove cerano altri ebrei. Era un al-
Testimoni e memorie
169
berghetto modesto: al piano terreno una reception, se possiamo chiamarla cos, cera un bancone, al primo piano una sala da pranzo e un corridoio con le camere e, sopra, altri locali. Un giorno scendo e sento dire: Siamo venuti ad arrestare quella famiglia di ebrei. Sono tornata in camera e abbiamo cercato di raccogliere le cose essenziali per fuggire. Ancora oggi mi rimasto questo incubo: dover fare in fretta le valigie e non riuscire a raccogliere tutte le cose. Avevamo la stanza vicino alle scale che portavano al piano superiore e da l siamo fuggite e abbiamo chiesto ospitalit a una famiglia allultimo piano delledificio. Oggi, a distanza di tempo, mi chiedo se le persone che sono venute ad arrestarci abbiano voluto darci questa possibilit. In effetti, abbiamo avuto il tempo di prepararci e loro avrebbero potuto benissimo trovarci. Non lo sapr mai. La notte, per non mettere in pericolo le persone che ci avevano ospitato, abbiamo trovato un taxi e ci siamo fatte portare a Sampeyre, dove avevamo degli amici. Adesso mi rendo conto che ci siamo messe in una situazione senza via duscita. Quando sono arrivati i partigiani a Sampeyre, ci siamo sentite al sicuro e anche loro ci hanno rassicurate, invece i tedeschi stavano risalendo la vallata. Noi ci siamo spostate pi su, verso il confine, a Casteldelfino, ma stato anche peggio; forse fossimo state in una grande citt avremmo potuto spostarci, anche solo da una zona a unaltra, ma l Quando sono arrivati i tedeschi, una guardia di finanza (il suo nome non lo dimenticher mai) ci ha denunciato per cinquemila lire. Evidentemente gli facevano comodo! Nella notte ci hanno portato a Venasca. Stavamo nelle scuole pubbliche insieme a tutti gli altri che i tedeschi avevano rastrellato ed eravamo libere di muoverci, ovviamente allinterno della scuola. Di notte, invece, ci portavano nelle celle della Pubblica Sicurezza, dove dormivamo sui tavolacci, senza una coperta, tutti ammassati, uomini, donne, vecchi e bambini. Siamo rimaste a Venasca tre o quattro giorni. Una mattina ci hanno condotto a Torino, allAlbergo Nazionale che era sede del Comando Tedesco, ci hanno interrogato e poi trasferito alle Carceri Nuove, dove siamo rimaste una ventina di giorni. Il ricordo pi tremendo di quei giorni sono le cimici che ci divoravano giorno e notte. Poi ci hanno portato a Fossoli, e di l ad Auschwitz. Auschwitz Il mio trasporto partito da Fossoli il 16 maggio del 1944, con 581 deportati. stato il convoglio pi lungo di tutti, diviso poi a Innsbruck e giunto ad Auschwitz il 23 maggio 1944. Alla liberazione i sopravvissuti erano 60. Appena scesi sulla rampa ci hanno separato: gli uomini dalle donne, gli abili dai disabili. Io ero con mia mamma e mia nonna. Ci hanno divise e ho ancora limpressione del braccio tremante di mia mamma che si stacca dal mio. Aveva quarantanove anni! Ed stata avviata alle camere a gas e ai forni con i vecchi, gli inabili e i bambini. Il numero che mi hanno tatuato sul braccio A 5404. Entrata nel campo di Auschwitz-Birkenau, dopo pochi giorni sono finita al Revier: non si pu dire che fosse un ospedale da campo, era piuttosto una sorta di lazzaretto. Avevo uninfezione alla caviglia, una gamba gonfia, spaventosa, piena di siero, di sangue. Non potevo camminare. Non cera medicazione mi hanno messo un po di
170
Capitolo IV
carta e, comunque, era possibile cambiarla solo il marted e il venerd! Allingresso in campo mi avevano detto: Non andare al Revier, non andare! Muori in campo, ma non entrare l. Ogni mattina, tutte le mattine, passava Mengele e segnava col frustino chi doveva andare alla selezione. Ma chi veniva scelto non andava a morire subito, era portato in una baracca particolare, aspettava tre giorni, riceveva una supernutrizione, poi, di notte, veniva mandato a morire. Wanda Maestro, di Torino, partigiana, morta cos. Sono rimasta quaranta giorni al Revier, in completa immobilit. I primi dieci giorni li ho trascorsi su un tavolaccio vicino a unaltra prigioniera, forse olandese, che aveva il tifo e si sporcava in continuazione. Eravamo completamente nude e con una sola coperta, che si pu ben immaginare in quali condizioni fosse. Solo dopo dieci giorni ci hanno dato una specie di camicione Uscita dal Revier mi sono lasciata andare, non avevo pi voglia di vivere. Mi ha salvata unamica. Quellincontro stato uno dei momenti fortunati nella mia esperienza drammatica. Era veneta, nove anni pi vecchia di me, energica. Si chiamava (si chiama, ancora viva) Enrichetta Polacco, ma era detta Cea (in veneto significa piccola, bambina); lei mi scuoteva: Vergognete, te si cus grasa e te voi morir? Vergognete, lavete, movete, non lassarte andar. Non dovemo darghea vinta! Cea lavorava alle cucine, portava da mangiare al Revier e allora ha chiesto alla Rosi, uninternata polacca che dirigeva il lavoro delle cucine, di prendere anche me a lavorare con lei. stata per me una fortuna. I primi tempi sono stati faticosi, anche perch, essendo Cea piccolina e io molto alta, risultava difficile mantenere in equilibrio i pentoloni da 100 litri di zuppa che dovevamo trasportare. Con questo lavoro, per, non sono mai uscita dal campo, cosa che avrebbe comportato pericoli ben pi gravi. Mia cugina Giuliana, per esempio, doveva fare ogni giorno tre chilometri allandata e tre al ritorno per andare a lavorare in una fabbrica e nelle condizioni in cui eravamo Trasportare il cibo non era invece un gran vantaggio per la nostra alimentazione: qualche volta si poteva raschiare sul fondo, ma erano occasioni rarissime. C invece un ricordo terribile legato a quel mio lavoro: al Revier succedeva che nascessero dei bambini e al mattino, arrivando, li vedevo sul davanzale della finestra, nudi, abbandonati l, morti o a morire, e li vedevo ancora muoversi ed era terribile, terribile Per me, inoltre, tornare al Revier era una sofferenza, un rivivere le condizioni disumane in cui ero stata. Con Cea sono rimasta in campo a Birkenau e dal campo siamo uscite insieme, poi lho persa di vista e non ho pi saputo niente di lei. Solo al ritorno ci siamo ritrovate. Da Birkenau a Bergen Belsen e poi a Buchenwald Quando si annunci lavanzata sovietica verso Auschwitz, iniziarono i trasferimenti di prigionieri verso altri campi. Un giorno dellottobre 44, a Birkenau, dove mi trovavo, ci fu un appello generale durato dal mattino fino a notte. Ero malata, avevo la febbre alta e tutto quel giorno davanti alla baracca, sdraiata per terra, fu terribile. Dopo lappello, fummo caricate su un camion per essere trasferite, ma non sapevamo assolutamente dove e cerano i forni crematori che funzionavano cosa dovevamo pensare? Comunque fummo trasportate sui camion, poi sul treno per un viaggio durato, credo, quattro giorni. Non ci hanno mai dato da bere, e la sete terribile, simpazzi-
Testimoni e memorie
171
sce. Nel nostro vagone cerano due SS o tre, mangiavano davanti a noi e noi abbiamo chiesto che ci dessero la pelle del salame, la pelle ma niente! Siamo poi scese a Bergen Belsen disidratate, io credo di aver bevuto sei litri dacqua. Pioveva, non cerano le baracche pronte per noi, cos abbiamo dormito per terra, sotto la pioggia. Dopo qualche tempo, un nuovo trasferimento: hanno scelto quelle pi in carne per andare a lavorare in fabbrica a Dessau, vicino a Lipsia. Era un sottocampo di Buchenwald. Io ero stata scartata perch ero troppo magra, ma la mia amica Cea, che mi aveva gi salvata quando mi ero lasciata andare, facendosi capire a gesti perch non sapeva neppure una parola di tedesco, ha chiesto a una Aufseherin, che in quel momento si vede non era cos terribile e forse ha provato un po di piet, di lasciare con lei sua sorella, e la Aufseherin mi ha tolto dal gruppo che era stato scartato e mi ha messa nellaltro. Siamo quindi andate a lavorare a Dessau presso la ditta Junkers-Flugzeug und Motorenwerke AG. Si lavorava 12 ore al giorno, dalle 6 del mattino alle 6 di sera o dalle 6 di sera alle 6 del mattino. Nonostante questo la nostra condizione era leggermente migliore, almeno non cera la paura dei forni crematori. L non cerano. Si lavorava a gruppi di venticinque, con cinque SS e i cani lupo di guardia. Ma dove mai avremmo potuto fuggire? Io ero al tornio, levigavo delle barre, era un lavoro faticoso, sempre in piedi. Ogni quattro ore avevamo un intervallo di dieci minuti; cerano delle cassette e noi piombavamo a sedere sulle cassette e, sfinite, ci addormentavamo immediatamente. Dessau: un segno di vita Uscendo dal campo, fuori del cancello (mi pare che fosse appoggiato proprio al cancello), cera un gelsomino, o forse era un altro fiore bianco; ogni giorno lo vedevo pi fiorito, era primavera, la primavera del 1945 e quel fiore mi dava lidea della vita che resisteva, che andava avanti, era un ritorno alla vita. Quel fiore mi ha dato una grande speranza mi rimasto in mente come qualcosa di bello e commovente. Devo per dire che, forse perch ero giovane, io lidea della morte non lho mai avuta. Eppure la morte ci sfiorava continuamente. Theresienstadt: la liberazione Sono stata liberata il 6 maggio del 1945 a Theresienstadt, lattuale Terezn, dovero stata molto malata, avevo il tifo petecchiale. Quarantotto ore prima che ci mandassero ai forni sono arrivati i russi. stato un caso fortunato, come del resto mi era gi capitato ad Auschwitz, da dove il mio era stato lultimo convoglio a uscire, mentre dopo ci sono state le marce della morte che hanno visto decimare i prigionieri per strada. Altrettanto casuale stata la guarigione dal tifo petecchiale, senza una cura, perch non cera niente. Quando sono arrivati i russi ho avuto una pastiglia, una, non so di cosa, ed stata lunica cura. Il ritorno Da Terezn siamo stati portati a Praga. Ero con un gruppo ditaliani. In sette o otto siamo andati alla Casa dItalia, dove ci hanno dato un po di soldi; e con quei soldi sapete cosa abbiamo comprato? Eravamo in condizioni pietose, conciate male, come potete immaginare, con i capelli rasati per i pidocchi, eppure abbiamo comprato un rossetto. Era la vita che ricominciava. Pensate comeravamo
172
Capitolo IV
belle! In quelle condizioni! Siamo poi state trasferite a Vienna e, di l, in un campo di raccolta a Wiener Neustadt. Le condizioni igieniche erano molto precarie. Non ricordo molto, solo che mangiavamo ceci con i vermi, le mosche ci cadevano nei piatti Siamo rimaste circa quaranta giorni, ma poi siamo scappate perch avevamo paura dei russi: volevano che andassimo a lavorare con loro di notte. Siamo andate a Sopron, in Ungheria, poi dallUngheria, con tutti i mezzi di fortuna possibili, siamo arrivate a Tirana e finalmente a Trieste, sempre con vari mezzi. Lunico regalo che abbiamo ricevuto, da un capostazione, stato un pomodoro, lo ricorder sempre! A Trieste siamo andate alla Comunit ebraica, dove ci hanno messo a disposizione delle brande con delle lenzuola, ma noi abbiamo dormito per terra, non eravamo pi abituate al letto. A terra si dormiva cos bene! A Postumia avevo addirittura dormito sul davanzale di una finestra! Abbiamo poi impiegato nove giorni per arrivare a Milano. Da Trieste avevo mandato un telegramma al nostro amministratore per avvisare del mio arrivo. La mia casa cera ancora, ma io non lo sapevo, non sapevo chi avrei trovato. Cera mio fratello Carlo, tornato dalla Svizzera dove si era rifugiato e dove si era sposato, con la moglie che aspettava un figlio al quale stato dato il nome di Vittorio (morto a Mauthausen), e con laltro fratello Cesare. Erano stati avvertiti dallamministratore. Avrebbero voluto venirmi a prendere, ma dove? Non lo sapevano. Sono scesa a Porta Susa, ho preso il tram; la gente vedendomi in quelle condizioni mi diceva: Ma lei arriva da molto lontano, e io: Arrivo dalla Polonia, campi di concentramento. Arrivata a casa, in Corso Regina Margherita, sono scesi tutti dal tram a darmi la mano, a farmi gli auguri. Ho suonato il campanello di casa senza sapere se avrei trovato qualcuno. Ho aspettato tanto a parlare perch la gente non voleva sapere, non voleva ascoltare, era appena finita la guerra, si voleva vivere e non pensare pi al passato. E i miei, forse, non chiedevano per non riaprire una ferita. Ho cominciato a raccontare molti anni dopo, messa alle strette dal Centro di Documentazione Ebraica (CDEC) di Milano. Oggi ho molti rimpianti. Vorrei sapere tante cose, anche della mia famiglia, ma non ho pi nessuno a cui chiedere. Nessuno, ed un rimpianto grande.
Un viaggio*
Maria Clara Avalle Lavevo incontrata per la prima volta nella sua casa di Corso San Maurizio a Torino, in occasione del viaggio ad Auschwitz che si stava preparando nella nostra scuola per la primavera successiva, nel marzo 1999. Sapevo che era ritornata ad Auschwitz dopo la Liberazione, ora le chiedevo di accompagnare i nostri studenti nei luoghi terribili della sua prigionia.
* Il ricordo di Natalia, scritto da Maria Clara Avalle, apparso su Ha Keillah, n. 2 / aprile 2003, nissan 5763, p. 13, e viene qui pubblicato per gentile concessione del suo Direttore, David Sorani.
Testimoni e memorie
173
Mi apriva la sua casa con gioia, con quel sorriso luminoso che sempre accoglieva e metteva a proprio agio linterlocutore. Le parlai dei miei studi, del mio lavoro e soprattutto del mio interesse per la storia della deportazione, la sua storia, che ero l per ascoltare. Disse che era contenta di incontrare dei giovani, e nel rievocare quel suo indicibile passato si rammaricava di non avere pi la memoria di un tempo. Tornai altre volte nella sua casa e diventammo amiche. Parlava lentamente, rivivendo le sensazioni pi angosciose come il momento del distacco violento dal braccio tremante di sua madre poi avviata con la nonna alle camere a gas ad Auschwitz, ancora cos vivo in lei; o limmagine del Dottor Mengele che ogni mattina, tutte le mattine, passava e segnava col frustino chi doveva andare alla selezione. Parlava con forza, con coraggio, con grande simpatia umana, sdrammatizzando anche certe situazioni, come lincontro in Lager con Enrichetta Polacco, Cea, di nove anni pi vecchia di lei, che come il Sergente Steinlauf dellesercito austroungarico, il quale esortava Primo Levi a lavarsi per non morire scuoteva Natalia con queste parole: Vergognete, te s cus grasa e te voi morir? Vergognete, lavete, movete, no lassarte andar. No dovemo darghea vinta! Quanto abbiamo riso quella volta! Natalia sapeva ridere e mi faceva sentire che lei, dopo Auschwitz, era vissuta anche di unaltra vita. Nata a Genova il 19 giugno 1922, era cresciuta in una famiglia ebraica ed era profondamente legata alla sua cultura, alle sue origini. Quando venne nella nostra scuola, raccont alle mie scolare adolescenti la sua incredulit di adolescente di fronte alle leggi razziali, che nel 1938 lavevano cacciata da scuola. Parl della sua famiglia e di suo fratello Vittorio, partigiano, morto a Mauthausen il 25 aprile 1945. Poi rievoc la sua cattura a Sampeyre, ci disse di Fossoli e degli altri campi in cui era stata oltre ad Auschwitz, Bergen Belsen, Dessau, e poi la liberazione a Terezn il 6 maggio 1945 a opera dei soldati dellArmata Rossa. Le studentesse ascoltavano attonite, in un grande silenzio; poche di loro riuscirono a parlare, e la ringraziarono soltanto per scritto. Accett di accompagnarci nel grande Lager polacco e la sua presenza fu per me molto importante. Non potr mai dimenticare come fu vicina alle studentesse e la forza danimo che dimostr nella visita al campo. Porto nel cuore i giorni trascorsi con lei in albergo a Cracovia, a raccontarci le nostre vite, ad ascoltare, a scherzare, a godere in ogni istante della citt. Sentivo che era un privilegio averla incontrata, averla vicina, e cercavo di non perdere nulla di quel dono inaspettato. Standole accanto, si coglieva la sua forza interiore, la capacit di non arrendersi e di non perdere mai la speranza di ricominciare. E voglio renderle omaggio, ora che non pi qui, rievocando un episodio della sua vita di deportata, che un giorno mi raccont e che rivela un poco il suo animo. Uscendo dal campo di Dessau, vicino a Lipsia, fuori dal cancello della fabbrica dove lei, nella primavera del 1945, lavorava al tornio, cera un gelsomino bianco che fioriva ogni giorno, e quel fiore mi disse mi dava lidea della vita che resisteva, che andava avanti, era un ritorno alla vita. Quel fiore mi ha dato una grande speranza... mi rimasto in mente come qualcosa di bello e commovente. Grazie Natalia! Moncalieri, 28 marzo 2003
174
Capitolo IV
Pio Bigo nato a Druento nel 1924; dopo la morte della madre, ragazzo, si sposta a Torino con i fratelli e il padre. Nel febbraio 1944 raggiunge le prime formazioni partigiane in Val di Lanzo; qui viene catturato durante i combattimenti di marzo, legati alla repressione degli scioperi in Alta Italia. Imprigionato alle Carceri Nuove, il 13 marzo trasportato con altri 246 compagni a Bergamo, e di qui, dopo una sosta di due giorni, a Mauthausen, in un convoglio che conta quasi 600 deportati. Con la matricola 59719 trasferito, dopo la quarantena, nei sottocampi di Gusen, Linz I e III, e di nuovo a Mauthausen, alla fine di novembre. La ragione del trasferimento che stato inserito in un grande trasporto per Auschwitz, comprendente 1.120 prigionieri; tra questi, 165 sono italiani. La Transportliste dispone i nominativi non in ordine alfabetico, ma distribuiti per specialit professionali. Ci sono tra loro jugoslavi, francesi, ungheresi. Immatricolato nella cosiddetta Zentralsauna di Birkenau con il n. 201561, dopo una breve quarantena deportato ad Auschwitz III-Monowitz, per lavorare nei cantieri attigui alla Buna. Il 17 gennaio 1945 il Lager viene evacuato, e Pio sfugge fortunosamente alla morte nella selezione dei pi deboli attuata durante una sosta a Gleiwitz (Gliwice). Dopo un terribile viaggio per ferrovia, su vagoni scoperti, sotto la neve, giunge a Buchenwald dov nuovamente immatricolato (n. 123377). Scampato ad altre selezioni, partecipa con i gruppi del Comitato di Resistenza alla liberazione del campo (11 aprile 1945). Attivissimo e infaticabile testimone, ha accompagnato innumerevoli scuole in viaggi ai Lager. Vive a Piossasco (Torino).
Memorie e testimonianze di una vita da schiavo
Pio Bigo Erano trascorsi ormai trentotto anni dalla fine dellultima guerra e prigionia nei Lager nazifascisti in Germania, ero a fatica riuscito a rifarmi una vita normale; mi ero sposato e mi ero formato una famiglia con un figlio, ma non ce lavevo fatta a cancellare quella profonda ferita che nel passato mi avevano inferto. Nel maggio del 1983, dietro invito della nostra Associazione, lANED di Torino, e di altri amici, ho deciso di accettare di ritornare sui luoghi della sofferenza e delloffesa assieme a un gruppo di storici dellUniversit di Torino e a molti insegnanti. Mauthausen, Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Ravensbrck... limpressione stata pi forte nei luoghi dove ero stato; solo al ricordare il passato di sofferenze e maltrattamenti schiavili mi veniva langoscia, piangevo, non riuscivo a spiegare e a parlare, mi vedevo davanti il quadro del passato. Ricordo che il Professor Federico Cereja mi prese per braccio e passeggiando nel Lager di Mauthausen mi faceva delle domande sul trattamento, sul modo di vita del passato: riuscivo a stento a spiegare alcune sequenze di ricordi, ma poi subentrava la commozione, e piangevo. Fu quello il primo viaggio nei Lager della morte; negli anni seguenti, in compagnia dei miei cari amici e compagni di deportazione, riuscimmo a fare anche tre o quattro viaggi allanno. Vi portavamo anche le nostre mogli: portavo Angela, mia moglie, perch potesse capire quello che suo marito da ragazzo aveva tragicamente vissuto e passato.
Testimoni e memorie
175
Gli insegnanti che in seguito ho conosciuto mi invitarono nelle scuole come testimone per parlare e spiegare ai loro studenti il passato. Venne lautunno dellanno 1996; ero stato invitato dal Professor Lucio Monaco, conosciuto nei viaggi degli anni precedenti 1990, 1991, 1992, come testimone al Liceo Majorana di Moncalieri. Laula era gremita di giovani studenti e studentesse, e feci una lunga spiegazione sulla vita nei Lager nazifascisti, sulle sofferenze, la fame, il deperimento, il trattamento sul lavoro, il lavoro schiavile, il genocidio degli ebrei. A fine spiegazione gli studenti mi facevano delle domande su alcuni episodi: questo mi coinvolgeva dandomi occasione di offrire loro chiarimenti pi profondi, affinch potessero rendersi conto e capire. Nel marzo 1999 a Torino fu presentato il mio libro della memoria vissuta, curato dallamico Lucio Monaco, Il triangolo di Gliwice. La Citt di Moncalieri, con il Sindaco Carlo Novarino e lAssessore alla Cultura Mariagiuseppina Puglisi, organizzarono con gli insegnanti una visita ai Lager di Auschwitz, Birkenau e Monowitz. Insieme con unaltra superstite, Natalia Tedeschi, dovevamo accompagnare studenti e insegnanti, ma purtroppo il giorno della partenza fui costretto a rinunciare, a causa di una broncopolmonite, e mi dispiacque davvero moltissimo. Negli anni successivi continuai a partecipare agli inviti nelle Scuole di Moncalieri come testimone. Lorganizzazione dei percorsi sulla memoria del passato si ampliata e consolidata moltissimo, da allora, fino a quando il Sindaco e lAssessore alla Cultura proposero e attuarono liniziativa, davvero straordinaria, di dare la cittadinanza onoraria ai sei deportati che avevano accompagnato in quegli anni i viaggi della memoria nei Lager. Questo fu eseguito il Giorno della Memoria, 27 gennaio 2002, presenti molto pubblico e parenti. Le sale erano piene zeppe, non cera posto per tutti. Fu cos data la cittadinanza onoraria ad Anna Cherchi (Lager di Ravensbrck), Natalia Tedeschi (Lager di Auschwitz), Albino Moret (Lager di Mittelbau-Dora), Natalino Pia (Lager di Mauthausen), Benito Puiatti (Lager di Dachau) e a me (che ero stato a Mauthausen, Auschwitz e Buchenwald). Devo dire che dopo anni di incontri e viaggi nei luoghi delloffesa avevo preso una maggiore confidenza, avevo fatto ormai una certa abitudine: riuscivo a spiegare e parlare del tragico passato senza emozionarmi e piangere, come succedeva allinizio. Magari in quei posti ero commosso, ma rispondevo alle domande dei giovani studenti con positivit. Da allora quasi tutti gli anni ho accolto, oltre a quello della Regione Piemonte e di molti istituti, anche linvito delle Scuole di Moncalieri e ne ho conosciuto gli insegnanti: Lucio Monaco, Alessandra Matta, Adriana Mogna, Marcella Pepe, Gabriella Pernechele, Carla Piana, Piero Cresto-Dina, Pier Luigi Cavanna, Dario Molino, Luigi Turco. Insieme con loro ho visitato cos tutti i Lager e i sottocampi della mia deportazione: anche Linz, naturalmente Monowitz, e Gliwice, a cui siamo arrivati ripercorrendo la strada della marcia della morte del gennaio 1945. Ricordo che in quei viaggi, con gli studenti, quando dovevo raccontare sul posto le tragedie del passato mi sentivo a volte imbarazzato nello spiegare ai giovani avvenimenti cos crudeli: un compito non facile trasmettere queste conoscenze alle nuove generazioni, oggi abituate a vivere in democrazia, senza sofferenze brutali, ma lho fatto nella speranza che non abbia a ripetersi mai pi tanto tragico orrore, tanto tragico passato, quando luomo trattava come bestie altri uomini.
176
Capitolo IV
Cos ricordo i viaggi della memoria di Moncalieri. Nel 2000, ai primi di aprile, visitammo i Lager di Melk, Mauthausen, Gusen, Ebensee e il famoso (per me) Lager di Linz III. Ma questo scomparso: dove cera il Lager esiste una zona residenziale di palazzine! Eppure visitando quel posto riuscii a riconoscere dove esisteva la piazza dellappello, ancora con qualche resto di recinzione. Trovammo anche una lapide a ricordo del Lager, con il disegno di comera costruito il campo: notai che era come lo ricordavo. Mi sono state fatte domande, e ho risposto per esempio che dal luogo dove esisteva la piazza dappello si vedeva il ponte ferroviario e lo si vedeva ancora, certamente cambiato, ma la direzione era quella giusta. Nel 2001, invalido per una frattura del femore, non ho potuto partecipare. Nel 2002, dal 27 febbraio al 3 marzo, abbiamo visitato i Lager di Buchenwald e Mittelbau-Dora. Testimoni Albino Moret reduce di Dora, e Pio Bigo, reduce anche da Buchenwald. Insieme abbiamo visitato il Museo, dove giacciono ancora poche cose mancano gli abat-jour fatti con pelle umana tatuata e altri oggetti che fino al 1995 erano esposti (ora trasferiti, dicono, a Boston). Il 2004 (dal 23 al 26 marzo) stato lanno del ritorno ad Auschwitz-Birkenau e a Gliwice. Visitato il Museo di Auschwitz I nel mattino, il pomeriggio passammo a Birkenau, facendo un lungo giro oltre i Crematori II e III, arrivando poi ai resti dei Crematori IV e V e alla Sauna, completamente restaurata: il luogo della mia immatricolazione. La Professoressa Carla Piana, attrezzata con la telecamera, mi ha intervistato sui luoghi delle camere a gas e dei crematori; e specialmente alla Sauna, dove facevano le immatricolazioni, mi ha fatto molte riprese quando spiegavo a tutti i fatti di cui ero stato testimone. Visitammo, quella volta, anche Gliwice dove durante una selezione riuscii a salvarmi con un triangolo rosso francese. Dove esisteva il Lager ora c una fabbrica di carbone coke; ai bordi di una strada che portava al Lager hanno costruito un monumento con il triangolo a ricordo delle tante vittime fucilate sul posto. Ricordo la gradita sorpresa organizzata dagli studenti e dagli insegnanti la sera del 25 marzo nel ristorante dellalbergo per la ricorrenza del mio ottantesimo compleanno. Giunti alla fine del pasto, in un attimo si alzarono in piedi insegnanti e studenti, mettendosi in fila nel corridoio: immediatamente arrivarono davanti a me ancora seduto al tavolo, con il cameriere che mi pos sul tavolo una grande torta con la candela accesa, gridando Auguri auguri! per gli ottantanni che compivo tre giorni dopo, il 28 marzo 2004. Ero commosso, ho pianto di gioia, con studenti, studentesse e professori attorno a me. Molti facevano foto: che bella serata indimenticabile! Ancora oggi sono commosso, grazie! Nel 2006 siamo tornati a Buchenwald e Mittelbau-Dora. Il 29 marzo, giunti nel Lager di Buchenwald, abbiamo incontrato il Sindaco della Citt di Weimar. Finita la cerimonia, c stata la visita al campo: ma certamente dopo tanti anni ne rimasto poco, mi sono sentito spaesato. Faceva freddo: ho girato per ritrovare le tettoie dove, nel periodo che siamo giunti in tradotta sui vagoni merci scoperti da Auschwitz, ci mettevamo al riparo dalla neve e dal freddo nellattesa di passare alla doccia. Ma ormai tutto sparito. Poi per mi sono reso conto che si trovavano a fianco del locale dove cerano le docce: allora ho individuato la scala che scendeva, ormai senza tettoia, verso il luogo dove mi ero rifugiato al riparo da freddo e neve aspettando di essere chiamato alla doccia. Questo mi ha fatto perdere tempo, solo pochi mi hanno seguto. Cincontrammo poi per la visita al forno crematorio, e l ho dato le spiegazioni sul
Testimoni e memorie
177
trattamento dei cadaveri. Visitammo il Museo, ma poi, tornati in albergo, la sera sono stato male e con rincrescimento non ho potuto accompagnare il gruppo alla visita del campo di Dora. Certamente capisco che molti dei deportati non sono tornati a visitare quei luoghi, e rifiutavano di parlare del passato, perch ricordare voleva dire soffrire, perch parlare voleva dire ricordare e rivivere il tragico dramma. Molti sono morti senza raccontare, o almeno hanno un poco raccontato ai loro famigliari. Ottobre 2006
Pio Bigo durante il viaggio di studio a Buchenwald e Dora (marzo 2002)
178
Capitolo IV
Giorgio Ferrero nasce a Vigone, in provincia di Torino, il 24 maggio1924 e da bambino si trasferisce con la famiglia a Torino, in una casa in Piazza Bengasi. Dallestate del 1943 si rifugia con un gruppo di compagni in montagna, a Borgata Soprana, presso Garessio, al confine tra Piemonte e Liguria, e dopo l8 settembre diventa partigiano (nome di battaglia: Gino) allinterno di una delle prime bande. arrestato il 23.12.1943 in Val Salice, sulla collina di Torino, durante unazione finalizzata alla cattura di un ufficiale tedesco per lo scambio di prigionieri, e recluso alle Nuove nel reparto dei condannati a morte, da cui viene prelevato ogni giorno per dieci giorni e condotto allAlbergo Nazionale per subire gli interrogatori. Il 13.01.1944 caricato su un treno che parte dalla stazione di Porta Nuova e lo porta al Lager di Mauthausen, dove arriva il giorno successivo ed registrato con il numero di matricola 42885. Si tratta del primo trasporto da Torino per Mauthausen (50 deportati, trasporto n. 18, secondo la ricostruzione di Italo Tibaldi nel libro gi citato Compagni di viaggio). Dopo il periodo di quarantena, trascorso a Mauthausen, assegnato al Kommando di Ebensee, dove rimarr fino alla liberazione del campo (6.05.1945) e oltre. A Ebensee e a Mauthausen tornato molte volte: la prima gi nel settembre del 1945 insieme con i famigliari dei compagni caduti e poi come testimone con scolaresche in visita. Membro dellANED fin dalle origini dellAssociazione e Presidente della sezione ANPI di Orbassano, vive a Trana (TO).
Intervista a Giorgio Ferrero
Marcella Pepe Il mio primo incontro con Giorgio Ferrero risale al lontano 1988, e loccasione fu unintervista che un gruppo di mie allieve, in vista della preparazione al tema per il concorso indetto dal Consiglio Regionale del Piemonte, chiese a quattro ex deportati allora poco pi che sessantenni: Anna Cherchi, Pio Bigo, Giuseppe Berruto e, appunto, Giorgio Ferrero. Ebbi poi modo di conoscerlo meglio nella primavera del 2003, durante il viaggio del Progetto Memoria a Mauthausen, Gusen, Ebensee (si veda il Capitolo I 7 Memorie di pietra), cui partecip come testimone insieme con Natale Pia. Prendendo in esame le registrazioni delle sue testimonianze conservate nellArchivio Multimediale del Progetto Memoria, mi sono per resa conto che dai numerosi interventi, pur molto interessanti, non emergeva compiutamente la sua storia. questa la ragione che mi ha spinto a chiedergli un colloquio. Quale impressione hai avuto del viaggio fatto con noi nel 2003? Buona. stato un bel viaggio; i ragazzi erano attenti e il viaggio era organizzato molto bene. Mi ha colpito il fatto che la visita ai campi fosse la cosa principale, mentre in tutte le altre gite in Austria Vienna il pezzo forte del programma. E poi i ragazzi non si limitavano ad ascoltare, ma lavoravano: mi ricordo che disegnavano il Monumento italiano a Mauthausen, che fotografavano gli altri monumenti, che facevano riprese con la videocamera... Chi era Giorgio Ferrero prima della deportazione a Mauthausen e a Ebensee? Era un ragazzo antifascista, un sabotatore gi prima di andare in montagna. Correggevo manifesti fascisti (ad esempio, scrivevo Perderemo al posto di Vinceremo)
Testimoni e memorie
179
e infilavo nelle buche delle lettere o sui tram i volantini delle tipografie clandestine. E un partigiano. Delle Brigate Garibaldi. Sono andato in montagna prima dell8 settembre, in agosto, vicino a Garessio, dove occupavamo un vecchio castello disabitato. Dopo l8 settembre arrivarono da Savona e da Albenga soldati renitenti alla leva, perch sapevano che cera un gruppo gi formato. Poi arriv il commissario da Torino. Quando e come sei stato catturato dai fascisti? Ci hanno presi in cinque il 23 dicembre 1943: uno morto subito; altri tre sono stati deportati insieme con me a Mauthausen e a Ebensee, e sono morti l. Io sono lunico sopravvissuto. stato il nostro commissario che ci ha fatto arrestare... ci ha venduto per la taglia. Natale e Capodanno li ho trascorsi alle Nuove, nel braccio della morte. Di pomeriggio mi portavano allAlbergo Nazionale per gli interrogatori: volevano sapere dei nomi... non ne ho detti! Quante botte ho preso! Alla fine dellanno mi hanno letto la condanna: la pena capitale. La mattina del 13 gennaio 1944 saranno state le tre sono venuti a prelevarmi. Era notte; sento delle celle che si aprono, si apre anche la mia e penso: Teh, stavolta finita, non andr neanche pi allAlbergo Nazionale... mi porteranno al Martinetto! Invece mi hanno fatto scendere nel cortile, mi hanno caricato insieme ad altri su un camion, fino a Porta Nuova, poi su un vagone piombato. Destinazione Mauthausen. Siamo stati i primi italiani internati a Mauthausen. Racconta il tuo arrivo a Mauthausen. Era il 14 gennaio, di mattina presto. Cerano cinquanta centimetri di neve e faceva molto freddo. Appena arrivati, ci hanno fatto andare subito a destra, nellangolo dei lamenti... Due ore di attesa: nel frattempo i Kapo ci chiedevano lorologio o altri oggetti che non ci sarebbero serviti pi, e in cambio ci promettevano aiuto in futuro. Infine riceviamo lordine di spogliarci nudi, nudi nella neve... poi ci mandano nelle docce, dove veniva gi acqua bollente inframmezzata da getti di acqua gelata, e poi alla tosatura e alla disinfezione... con polvere di conegrina [candeggina], che bruciava da matti sulle ferite! Lultima procedura umiliante stata quella di affibbiarci ciascuno una targhetta con un numero, da portare al braccio sinistro: da allora noi eravamo quel numero, non avevamo pi un nome e una personalit. Con una camicia di tela e un paio di mutande da infilare mentre percorrevamo di corsa il lungo piazzale dellappello, siamo stati alloggiati nella baracca che avremmo occupato per tutta la durata della quarantena: ci dovevamo stare in 500-600 e dormivamo sul nudo pavimento; laffollamento era tale che, se per caso uno di notte si alzava per fare i suoi bisogni nellunico bidone che cera, quando tornava non trovava pi il suo posto... e allora erano urla e strepiti e, quindi, botte! Del resto la quarantena era studiata apposta per far apprendere i riti del Lager e lobbedienza assoluta, per spersonalizzare. Ricordo che ci era spesso ripetuto: Di l siete entrati e veniva indicata la porta e di l uscirete!, ma questa volta il dito indicava il camino del forno crematorio. Dopo la quarantena, che per me stata di circa dieci giorni, si veniva assegnati a un Kommando di lavoro. Io sono stato mandato a Ebensee. A Ebensee sei rimasto a lungo, vero? S, dagli ultimi giorni di gennaio del 1944 fino alla liberazione, il 6 maggio 1945, e oltre.
180
Capitolo IV
Che tipo di lavoro svolgevi a Ebensee? Diversi lavori. Nei primi giorni ho dovuto abbattere alberi e caricare i pannelli delle baracche alla stazione: si era ancora nella fase iniziale della costruzione del Lager e cera ununica baracca-dormitorio, riservata ai prominenti; tutti gli altri, in mancanza di baracche per gli alloggiamenti, erano provvisoriamente sistemati nel piazzale dellappello, esposti al freddo e alle intemperie. Gi dopo tre o quattro giorni, per, ho lavorato come manovale nella Galleria A: i turni erano di 12 ore e, finito il turno, si lavorava ancora 3-4 ore alledificazione del campo. Scavavo nella galleria, con lacqua fino ai polpacci, poi caricavo i materiali su carrelli che svuotavo nella vallata: questo per circa sei mesi, fino a giugno, quando successo un fatto che ha avuto come conseguenza per me il cambiamento di lavoro. Una notte un minatore russo, chiss se per sabotare o per disattenzione, ha acceso la miccia in galleria senza avvertire e tutti sono saltati in aria: centinaia di deportati che lavoravano, i capisquadra, anche alcune SS... La mattina dopo sono arrivato sul luogo del disastro e ho visto che stavano portando via morti e feriti. Cera anche lingegnere, che, preoccupato perch aveva un minatore in meno, mi ha chiesto se avevo conoscenze tecniche in materia di esplosivi, e cos da manovale sono diventato minatore. In cosa consisteva, precisamente, il lavoro di minatore? Dovevo mettere dinamite e tritolo dentro delle buche e accendere la miccia allontanandomi poi il pi in fretta possibile. Allinizio lingegnere minsegnava il lavoro, poi, quando ha visto che avevo imparato, mi ha lasciato fare da solo. In un certo senso, lingegnere mi aveva preso a benvolere: mi faceva assistere al suo pasto notturno, nella sua baracca, e di tanto in tanto mi lanciava un pezzo di pane, come se fossi stato il suo cane (era unumiliazione, ma era anche un favore, perch nessuno aveva un supplemento di cibo di notte); mi ha pure raccontato della morte dei suoi due figli sul fronte russo. Una notte, subito dopo la morte del secondo figlio, si lasciato sfuggire in mia presenza unesclamazione di sconforto: Il nazismo ha sbagliato tutto! Non voglio pi sentirne parlare. Per svolgere il mio lavoro prendevo con me due prigionieri e dicevo loro di aspettare fuori, di riposarsi mentre io preparavo la miccia e, prima di accenderla, cercavo di metterci pi tempo possibile. Questo era una specie di sabotaggio, perch rallentava le operazioni; i due prigionieri lo capivano e, quando uscivo dalla galleria, mi guardavano con un sorriso dintesa. Sorriso... si fa per dire, perch in Lager cera poco da sorridere. Lordine veniva dallorganizzazione clandestina del campo, di cui facevo parte. Cera quindi unorganizzazione clandestina di Resistenza nel Lager di Ebensee? Qual era il tuo ruolo in essa? Cerano gruppi di Resistenza clandestina di varie nazionalit, pi o meno numerosi (del gruppo italiano cero solo io), in cui entravano perlopi i prominenti, cio coloro che avevano razioni supplementari di cibo e occupavano posti chiave come cuochi, infermieri o Kapo. E poi cera un Comitato Internazionale cui partecipavano delegati dei vari gruppi nazionali in misura proporzionale alla loro consistenza numerica; le riunioni si tenevano al Block 18 e si fecero pi frequenti dalla primavera del 1945. Il tutto naturalmente si svolgeva nella massima segretezza; non si conoscevano neppure i nomi degli altri aderenti allorganizzazione. Io, per esempio, avevo come punto di riferimento un francese, Jean Lafitte, ma non conoscevo nessun altro; le no-
Testimoni e memorie
181
tizie gliele portavo al gabinetto, sedendo vicino a lui e parlando pianissimo, per paura che qualche altro prigioniero potesse sentire e fare la spia. Cera anche un amico della Val di Susa, anche lui prominente, che mi forniva dei pezzetti di ferro: io li avvolgevo nella carta insieme allesplosivo e confezionavo cos delle bombe-carta, sempre su ordine dellorganizzazione clandestina. Siccome a ogni fine turno mi perquisivano, avevo un nascondiglio nella galleria dove mettevo queste bombe-carta, e poi qualche altro membro dellorganizzazione che non conoscevo (ma doveva essere un manovale, perch i manovali non erano soggetti a perquisizione) le prelevava e le consegnava. Quali erano le condizioni di vita nel campo? Pessime fin dallinizio, ma peggiorarono nellultima fase, a partire dallinverno 1944-1945, quando, per larrivo di numerosi trasporti, la popolazione del Lager sal a oltre 18.000 prigionieri. Il 90% dei deportati andava a lavorare senza cappotto, maglioni o guanti, e molti erano scalzi, veramente scalzi: senza calze e senza scarpe. Avvolgevano i piedi in un pezzo di carta ricavato dai sacchi di cemento, in uno straccio o in un pezzo di coperta, rischiando, se scoperti, di essere frustati. Linfermeria era strapiena: fino a 4-5 malati stavano in un solo letto. La razione di cibo era stata ridotta, e consisteva in 1/2 litro di caff senza zucchero al mattino, 3/4 di litro di brodaglia dove galleggiava qualche buccia di patata, a pranzo e, alla sera, in una pagnotta di circa un chilo da dividere in 6, se lavoratori, e in 9, se ammalati. La fame aveva trasformato i prigionieri in veri e propri scheletri che camminavano, apatici, oppure con scatti da belva feroce, pronti ad aggredire i compagni per qualche briciola di pane. A che cosa devi, secondo te, il fatto di essere riuscito a sopravvivere allinferno di Ebensee? Ci ho riflettuto sovente. Forse ce lho fatta perch mi sono sforzato di non accettare la logica del Lager: non pensavo alla vita quotidiana del Lager, ma a quello che facevo prima di entrarci, con gli amici, a scuola. Ad esempio, fantasticavo sognando un bel pranzo, ed era un po come farlo davvero. Mi aiutavano i ricordi e i sogni, ma mi aiutavano anche la fede politica e lesperienza, che mi serviva a evitare le botte o a procurarmi qualcosa in pi da mangiare. Una volta, per, mi sono sentito veramente perduto: stato nel marzo del 1944, quando mi si sono congelati i piedi e mi hanno portato a Mauthausen. Questo lepisodio di cui avevi parlato a Mauthausen ai nostri studenti proprio sul luogo dove sorgeva il Blocco 20, quello da cui i prigionieri russi tentarono la fuga nella notte del 2 febbraio 1945? S, proprio quello: mi fa piacere che te ne ricordi. Per, nella primavera del 1944, il Blocco 20 era ancora uninfermeria speciale; solo in seguito diventer il Blocco dei russi, e il Campo russo, che si trova fuori della fortezza, diventer infermeria. Io sono stato portato al Blocco 20, e ci sono rimasto per quattordici giorni. Mi hanno levato tutte le unghie dei piedi, per via del congelamento, ed ero molto gi. Sono sopravvissuto solo grazie allo scrivano del blocco, un lussemburghese che mi ha dato medicinali e cibo. Non era un aiuto del tutto disinteressato: lui, infatti, voleva che io tornassi a Ebensee per portare notizie a suo fratello che era prigioniero l, e mi ha dato un biglietto da consegnargli. Anche il fratello del lussemburghese, poi, a Ebensee, mi ha aiutato, trovandomi un posto di Kapo in galleria.
182
Capitolo IV
Vuoi raccontare come avvenne la liberazione di Ebensee, il 6 maggio 1945? Vorrei prima raccontare lultimo giorno, il 5 maggio. La mattina eravamo tutti allineati sullAppelplatz secondo i blocchi, come ogni giorno: eravamo pi di 16.000, e circa 6.000 ammalati che non potevano muoversi stavano nellinfermeria. Ma quella mattina fu tutto diverso: i prigionieri non vennero contati. Arriv il Comandante Anton Ganz, attorniato da SS con le mitragliatrici imbracciate, e nella folla dei deportati la tensione cresceva, aumentavano mormorii e brusii. Finalmente Ganz cominci a parlare con insolita cordialit e disse che il fronte si stava avvicinando al Lager, e che quindi il Lager avrebbe potuto essere bombardato: perci era necessario che andassimo tutti nelle gallerie, dove saremmo stati al sicuro. Linterprete tradusse la proposta di Ganz in molte lingue e, a ogni traduzione, crescevano i brontolii, poi, sempre pi alto e determinato, si lev un NO! espresso in tutte le lingue del Lager. Fu un grande momento: per la prima volta i prigionieri si erano rifiutati in gran numero di obbedire alle SS e da quel momento smisero di essere dei prigionieri. Fummo sopraffatti da unondata di gioia, che subito per si mut in paura: Come avrebbe reagito Ganz? ci chiedevamo Avrebbe dato lordine di sparare e di spingerci con la violenza nelle gallerie, o avrebbe rinunciato? Comunque non avevamo scelta: le gallerie volevano dire morte sicura e, quindi, non avevamo nulla da perdere. Ganz stava immobile, pallido, silenzioso. Si consult con le SS per alcuni istanti che a noi parvero interminabili e poi parl, con voce tremante e rabbiosa, che cercava di controllare perch ci fosse un nesso con quanto aveva detto prima. Scegliendo lentamente le parole disse che non dovevamo andare nelle gallerie se non volevamo, che quellidea era stata trovata unicamente nel nostro interesse, perch non ci fossero perdite inutili e che, se decidevamo di non andare nelle gallerie, lo facevamo a nostro rischio e pericolo, e ne avremmo subto le conseguenze. Nel pomeriggio i sorveglianti SS se ne andarono, affidando il controllo del Lager al Volkssturm (Milizia popolare) e ad alcuni soldati della Wehrmacht. Ma noi deportati non eravamo ancora liberi: avevamo ancora le armi dei nuovi sorveglianti puntate contro di noi; il filo spinato era ancora percorso da corrente elettrica e temevamo sempre di veder tornare le SS. I prigionieri legati ai gruppi di Resistenza presero non mi ricordo bene mi pare sette pistole che alcuni addetti alle pulizie avevano sottratto in precedenza allarmeria e nascosto per questa occasione, per organizzare la difesa se le SS fossero ritornate, e si assunsero il compito della gestione del campo, precipitato nel caos pi totale. Bisognava impedire razzie al magazzino viveri, per evitare che andasse perduto quel po che restava; bisognava occuparsi dellapprovvigionamento di viveri per pi di 20.000 persone e trovare dei volontari che si prendessero cura dei 6.000 ricoverati... E intanto il furore represso dei prigionieri si scatenava contro chiunque avesse collaborato con le SS... I liberatori americani arrivarono alle 14.50 del 6 maggio: due carri cingolati mandati in avanscoperta. Liberarono il campo e proseguirono per la loro guerra. Il giorno dopo la liberazione il Lager era ancora, e sempre di pi, nel caos. Sei tornato subito in Italia, dopo la liberazione? No. Come ho detto prima, facevo parte dei gruppi di Resistenza, e questi gruppi si occupavano di governare il campo lasciato a se stesso; sono rimasto anchio nel campo fino allarrivo del grosso degli americani e dei rifornimenti. Circa un mese. Ho assistito al seppellimento dei morti e ho insistito perch fossero almeno ordinati per nazionalit. Poi sono andato allospedale di Salisburgo perch avevo la scabbia e la pol-
Testimoni e memorie
183
monite. Sono arrivato a Torino alla fine di agosto, dopo un viaggio massacrante, su una jeep fino al Brennero e poi sul rimorchio di un camion. Qual stato limpatto con la tua citt? A Porta Nuova, dove il camion ci ha scaricato, ho preso il tram per Piazza Bengasi, dove abitavo. Sul tram sono andato in fondo: tutta la gente mi guardava, guardava gli stracci di divise americane che avevo addosso. Non vedevo lora di scendere per sottrarmi a quegli sguardi. In Piazza Bengasi, vado verso casa ed entro perch la porta non era chiusa; mi vedo davanti una signora sconosciuta e impaurita dal mio aspetto e penso subito al peggio, che i miei genitori siano morti. Ma poi la signora mi spiega che hanno venduto la casa e sono andati a stare a Nichelino. Li trovo finalmente, nella nuova casa, per non vedo neppure una mia fotografia alle pareti; non c pi nemmeno la mia camera, n il mio letto n il mio posto a tavola. Non avendo avuto mai notizie di me, evidentemente avevano creduto che fossi morto. Hai cercato di raccontare la tua esperienza nel Lager? vero quello che dicono molti ex deportati, che nessuno voleva ascoltarvi? Io non ho mai detto niente neppure ai miei genitori, per non addolorarli, ed evitavo di uscire per non incontrare gente che mi facesse domande. Se avessi risposto raccontando quello che veramente ho subto e avessi descritto la realt del campo di concentramento, non mi avrebbero creduto. Del resto, altri erano i racconti che si volevano ascoltare appena finita la guerra, quelli dei combattenti: loro erano i vincitori, io mi sentivo un perdente, uno sconfitto. Solo molto tempo dopo ho cominciato, spinto dallAssociazione, dallANED, a testimoniare.
Giorgio Ferrero con una studentessa (marzo 2003)
184
Capitolo IV
Marcello Martini nato a Prato nel febbraio del 1930. Quattordicenne, partecipa alla Resistenza (il padre, Mario, comandante militare del CLN di Prato). arrestato a Montemurlo dove la famiglia era sfollata il 9 giugno 1944, rinchiuso nel carcere fiorentino delle Murate, quindi deportato al campo di transito di Fossoli il 13 giugno. Otto giorni dopo trasferito a Mauthausen (trasporto n. 53 dellelenco di Italo Tibaldi, 21-26 giugno 1944: circa 470 persone; ne moriranno in Lager 311, se non di pi: si tratta di una delle pi elevate mortalit calcolate per trasporto, per quanto riguarda i deportati politici italiani). Qui immatricolato con il n. 76430. Poco dopo inviato al sottocampo di Wiener Neustadt, ma il 19 dicembre, dopo il rientro a Mauthausen, trasportato in un altro sottocampo, quello di Mdling-Hinterbrhl. Qui si lavorava sottoterra, nelle gallerie di unantica miniera di sale, per la Heinkel Werke AG: produzione di testate per missili V2, parti per laereo HE 216 (caccia notturno) e fusoliere per gli HE 162 (caccia a reazione). In aprile il Lager sgomberato e i prigionieri (previa soppressione dei malati) sono riportati a Mauthausen con una marcia durata otto giorni. Trasferito nel settore della quarantena, Marcello Martini liberato con larrivo dellesercito statunitense (5 maggio 1945). Ripresi gli studi, si laurea in chimica. Attualmente vive fra il Piemonte e la Toscana. Da qualche tempo Marcello Martini ha steso i ricordi delle sue vicende di deportato politico: poich la sua presenza e la sua memoria ci hanno introdotto e poi accompagnato alla visita a Fossoli del 2005, presentiamo il resoconto degli otto giorni di permanenza nel campo di smistamento, seguto da quello del viaggio che lo porter, insieme con i suoi 474 compagni di prigionia, a Mauthausen. Le memorie di Marcello Martini, dalla partecipazione, con i famigliari, alle attivit della Resistenza fino alla deportazione e al ritorno in Italia, dopo la Liberazione, raccolte da Elisabetta Massera, verranno presto pubblicate in volume.
Fossoli 13-21 giugno 1944
Marcello Martini Lautobus su cui ci avevano fatto salire a Firenze si diresse verso Via Bolognese e inizi a salire verso Pratolino; super il Passo della Futa e alle prime luci dellalba raggiungemmo Bologna, per proseguire per Modena, Carpi e finalmente giungemmo a Fossoli. Nel valicare gli Appennini in mezzo a boschi abbastanza solitari, in ognuno di noi prigionieri divent sempre pi forte la speranza di un attacco partigiano che ci liberasse. In fondo allautobus e vicino allautista cerano militari armati di mitra, non ricordo se tedeschi o italiani, e inoltre il nostro mezzo era preceduto e seguto da auto piene di soldati. Sarebbe stato quindi quasi impossibile, in caso di attacco, scampare al fuoco dei sorveglianti, ma si sa: sperare non proibito! Purtroppo invece tutto fil liscio e in mattinata fummo scaricati davanti al cancello di filo spinato del campo di raccolta e transito di Fossoli. I miei ricordi di questo periodo sono piuttosto frammentari, forse per laccavallar-
Testimoni e memorie
185
si degli avvenimenti dei giorni precedenti, per il brusco passaggio da una tranquilla vita in famiglia a quella di detenuto, solo, senza nessuna persona di cui fidarsi. Penso che le ultime giornate trascorse avrebbero sconvolto chiunque, anche se adulto, figuriamoci leffetto che ebbero su un ragazzo di quattordici anni, che non aveva ancora dovuto subire personalmente la dura realt della guerra. I successivi tragici avvenimenti della mia deportazione hanno inoltre certamente contribuito a sbiadire i dettagli del ricordo. Nella mia memoria Fossoli appare ancora unoasi felice, dove tutti i prigionieri e i carcerieri parlavano la stessa lingua, e dovera possibile muoversi senza rischiare continuamente percosse, o addirittura la vita. Allarrivo a Fossoli fummo interrogati uno per uno, declinammo le nostre generalit, vuotammo il contenuto delle nostre tasche su un grande tavolone, e ci fu assegnato un numero di matricola. Ebbi subito conferma che il nuovo luogo di prigionia in cui mi trovavo era particolarmente favorevole; mi ricordo infatti che minterrogarono due o tre prigionieri politici, e uno di questi quasi mi costrinse a dire che soffrivo per una punta dernia, per evitare che mi facessero lavorare; poi mi restitu tutto il contenuto delle tasche, facendomi cenno di nasconderlo. I miei averi erano costituiti da un portafoglio con documento di riconoscimento, duemila lire, una piccola roncola pieghevole, un temperino, un fazzoletto, lo spazzolino da denti e un tubetto di dentifricio. I due coltelli che portavo quasi sempre in tasca mi servivano per uno scopo ben preciso. Conoscevo infatti a memoria tutti i tipi di aerei italiani e tedeschi, e il mio passatempo preferito era quello di riprodurli in piccola scala, intagliando pezzetti di legno di recupero che giudicavo adatti per il tipo di aereo che volevo riprodurre. I miei modelli erano lunghi 6 o 7 centimetri: il pi grande, il quadrimotore Piaggio P 108, era lungo 12 centimetri; le ali e i piani di coda venivano ricavati dalla balsa delle scatole dei fiammiferi e dei formaggini, incollate alla fusoliera pazientemente intagliata; infine verniciavo mimeticamente, con gli acquerelli, laereo cos completato. Ricordo ancora che fummo rapati, ma non a zero, che ci fu dato ago e filo per cucire la striscia di stoffa bianca con il numero di matricola sulla giacca (io dovetti cucirlo sul golf di lana blu), e infine fummo portati nella baracca in muratura che ci era stata assegnata. Non ricordo assolutamente il numero di matricola che mi fu attribuito, mi sembra che iniziasse con un 2 e fosse di sole quattro cifre. Ho un vago ricordo dellinterno della baracca: rivedo file di brande di tipo militare sia lungo le pareti della costruzione in mattoni sia nel centro dello stanzone. Sul fondo cerano i gabinetti; dallingresso della baracca invece si accedeva direttamente a un vasto spiazzo. Cerano diverse costruzioni analoghe una accanto allaltra, ma non ne saprei precisare il numero. Tutto il campo era circondato da filo spinato, piuttosto fitto ma non elettrificato, con garitte e lampade a intervalli regolari che lasciavano poche zone dombra durante la notte. Il cortile confinava a sinistra con un altro recinto di filo spinato al di l del quale cerano costruzioni in muratura dove alloggiavano altri prigionieri. Non ricordo particolari cerimoniali di appello o ulteriori sistemi di controllo. Il capo del campo che mi aveva interrogato al mio arrivo e i responsabili delle baracche erano tutti italiani e prigionieri politici; la verifica dei presenti era senzaltro eseguita ma non in maniera traumatica, cos che non mi rimase impressa nella memoria. Nella prima baracca sulla destra, oltre lingresso al campo, cera una costruzione suddivisa in celle: era il car-
186
Capitolo IV
cere del campo. Seppi poi che vi erano rinchiusi dei detenuti comuni che erano stati trasferiti l forse da Parma o da Pavia perch il carcere mandamentale era stato colpito dai bombardamenti alleati. Anche i detenuti comuni furono deportati a Mauthausen, dove ebbi modo di conoscerli. Uno dei ricordi pi nitidi di questo periodo il buon sapore del minestrone di riso che ci veniva distribuito a mezzogiorno: era caldo e abbondante e, dopo le forzatamente ridotte porzioni casalinghe di minestre di piselli secchi e radicchio selvatico e lindefinibile brodaglia delle Murate, finalmente potei riempire lo stomaco con qualcosa di piacevolmente saporito! Non ricordo comerano le stoviglie o se venivano fatte pi distribuzioni di cibo e di pane; il mio ricordo si concentra su quello scodellone di riso, che consumavo seduto sulla branda a me assegnata e che finalmente saziava la fame di un adolescente! Durante la breve permanenza a Fossoli avvennero alcuni episodi che per non ricordo in ordine cronologico; ma soprattutto ebbi i primi contatti con persone che gi conoscevo. Lavvenimento per me pi importante fu il ricongiungimento con Guido Focacci. Un giorno uscendo nello spiazzo antistante la baracca vidi concretamente lesempio dellEcce Homo: un uomo cio con la faccia tanto livida e gonfia da renderlo quasi irriconoscibile, con una mano slogata, la sinistra, e la schiena ridotta a un indecifrabile geroglifico di colore bluastro. Queste erano le conseguenze di tre giorni di torture nella Villa Triste di Firenze, inflitte dalla famigerata Banda Carit.1 Aver riconosciuto Guido e averlo accanto mi fecero sentire meno solo: finalmente ero con qualcuno che conosceva tutta la mia famiglia e anche se era molto mal ridotto dal punto di vista fisico costitu per me un grande elemento di forza. Guido, nome di battaglia Tenente Colombo, era un esperto pilota; aveva fatto parte delle formazioni degli Aerosiluranti, con i vecchi e lenti trimotori S79, e poi aveva pilotato i bombardieri pesanti quadrimotori Piaggio P109. Dopo l8 settembre era entrato nella Resistenza, aveva conosciuto mio padre, era consulente aeronautico della sua formazione e aveva sovrinteso alla realizzazione del campo di lancio allestito nellarea controllata dal Comandante Nicolai, cio mio padre.2 Avevo cos fatto la sua conoscenza. Appassionato comero di aerei e di aviazione ero ovviamente fiero di conoscere in carne e ossa uno di quegli eroi alati che, ai miei occhi di adolescente, compivano eroiche gesta, del resto ampiamente glorificate dalla propaganda fascista. Guido per mi raccont il vero volto della guerra aerea, e della guerra in generale. Caddero cos tutti i miti costruiti dalla propaganda fascista di cui ero, come tanti, imbevuto e mi resi conto di quanto tragico fosse dover mettere in pratica la dura legge di guerra: cio colpire per non essere colpiti, e obbedire a ordini disumani nel nome di una presunta supremazia nazionale e razziale.
1
Reparto di polizia speciale comandato da Mario Carit, specializzato in torture ed efferatezze nei confronti di sospetti partigiani e antifascisti. Come altre formazioni militari poliziesche la Koch, la X Mas, la Muti, la Nembo si muoveva in autonomia dalle autorit costituite della Repubblica di Sal, ma in collegamento con alcuni grandi gerarchi fascisti e con il SD (Servizio di sicurezza) germanico. Fondata a Firenze, ebbe sede a Villa Triste fino al luglio 1944; poi si trasfer presso Rovigo e quindi (novembre 1944) a Padova, a Palazzo Giusti. Qui la Banda ag con particolare ferocia sino allaprile 1945, torturando, uccidendo e facendo deportare membri della Resistenza e del CLN regionale veneto. Con leccezione di Carit, ucciso in un conflitto a fuoco con gli angloamericani nel maggio 1945, e dellesecuzione di un suo collaboratore, gli altri componenti della Banda finirono amnistiati o assolti tra il 1946 e il 1951. Cfr. M. Franzinelli, Lamnistia Togliatti, Milano, Mondadori, 2006, pp. 247-249 passim; la voce Reparto servizi speciali Carit di E. Gallo nel Dizionario della Resistenza, a cura di E. Collotti / R. Sandri / F. Sessi, Torino, Einaudi, 2001, vol. II (Luoghi, formazioni, protagonisti), pp. 414-416. 2 Il maggiore Mario Martini era comandante militare del CLN di Prato.
Testimoni e memorie
187
Ebbi unaltra buona notizia, che mi giunse dal recinto femminile che confinava con il nostro. Se ben ricordo le detenute erano soprattutto ebree; una di queste, che conosceva Focacci, mi diede notizie della mamma e di Anna, mia sorella, perch proveniva dal Carcere di Santa Verdiana3 e l le aveva conosciute. Le notizie furono rassicuranti: nessuna delle due era stata interrogata dalle SS. Questo significava aver quasi certamente evitato le terribili torture i cui effetti erano ben visibili sul corpo di Guido. Ricordo inoltre un altro particolare: durante la notte spesso mancava improvvisamente la corrente elettrica, quindi la recinzione era completamente al buio; le guardie illuminavano come potevano, con torce elettriche, la loro zona di controllo; nelle notti senza luna o con il cielo coperto loscurit era quasi totale, e potevano quindi essere favorite le fughe. Un giorno mi si avvicin un compagno di prigionia e mi chiese di vedere i due coltellini a serramanico che avevo in tasca. Probabilmente rimase un po deluso dalle loro dimensioni (la lama era lunga solo quattro o cinque centimetri), ma mi chiese egualmente di prestargliene uno, senza naturalmente dirmi che quella notte stessa avrebbe tentato la fuga, approfittando della mancanza di corrente elettrica. Non ricordo nulla di lui, salvo che era molto alto e forse aveva un paio di baffi; la sua fuga comunque riusc perch non lo vidi pi in campo! Esisteva anche la possibilit di corrompere una delle camicie nere addette alla sorveglianza del reticolato, magari da parte di parenti o amici allesterno. Questo si diceva in campo. Ricordo invece unaltra evasione conclusasi tragicamente: il fuggitivo fu ripreso e picchiato a sangue; e fu mostrato a tutti i prigionieri riuniti. Il poveretto, lordo di sangue e in stato di semincoscienza, era sorretto da due nostri compagni, che poi lo trascinarono in una delle celle della prima baracca. Non so che fine abbia fatto, ma le alternative non erano molte, e di tutte la migliore era quella di essere deportato in Germania. Mi tornano in mente due persone arrestate e inviate al campo di Fossoli, pur appartenendo uno alle Brigate Nere, mi pare con il grado di maggiore, che chiamer X; laltro invece era un interprete delle SS di Milano. Il suo nome era N., era di origine svizzera, parlava correntemente sia litaliano sia il tedesco, e approfittando della sua posizione poteva venire a conoscenza dei rari mandati di scarcerazione dei politici detenuti nel Carcere di San Vittore. Si recava allora immediatamente dalle loro famiglie, facendosi consegnare denaro e preziosi perch proprio lui avrebbe avuto facolt di far liberare il famigliare arrestato. Questi effettivamente usciva di prigione, ma il merito non era sicuramente di N.! Scoperto dalle SS, attuarono lunico atto di giustizia che posso loro attribuire: lo internarono prima nel Carcere di San Vittore poi a Fossoli. Il Maggiore X, alto e quasi calvo, aveva la tracotanza tipica del gerarca fascista; era stato sorpreso con le mani nel sacco mentre rubava a man bassa, certamente laveva fatta proprio grossa per essere internato. Alcuni compagni mi dissero che quando era arrivato indossava ancora la divisa fascista con la camicia nera. Il nero, si sa, prende molto facilmente la polvere quindi fu necessaria una bella spolverata da parte
Carcere femminile di Firenze.
188
Capitolo IV
dei compagni di prigionia, che per, distrattamente, si dimenticarono di togliere X dalla camicia per batterla con coscienziosa seriet! Passarono cos i giorni nel campo di Fossoli, ma stranamente non ci domandavamo quale sarebbe stato il nostro futuro! Per quanto ricordo sembrava di vivere in una specie di limbo, sperando con ottimismo eccessivo che la permanenza nel campo di Fossoli fosse la nostra condanna! Il viaggio (21-24 giugno 1944) Rivivo la mia permanenza a Fossoli come una condizione di felice semitorpore; il risveglio fu improvviso e doloroso. La mattina del 21 giugno fui chiamato insieme ad altri compagni e tutti fummo inquadrati sul piazzale antistante le baracche.Tutti avevano il loro bagaglio a eccezione di me e di Guido: a Fossoli infatti era possibile ricevere dallesterno pacchi con indumenti e vettovaglie che arrivavano quasi integri ai destinatari; molti quindi avevano valigie capienti con scorte di scatolame, che in seguito risult molto utile. Ricordo il primo episodio di violenza cui fui costretto ad assistere. Fino a quel momento avevo visto solo le conseguenze di un pestaggio. Il Maggiore F., ex ufficiale di cavalleria, fu violentemente strattonato da una SS perch doveva uscire pi velocemente dalla baracca. Non posso dire che F. si sia ribellato, ma si svincol dalla presa del soldato nazista, assumendo contemporaneamente latteggiamento di chi esige rispetto. Questo non poteva essere tollerato da chi riteneva di appartenere alla razza superiore e quindi fu immediatamente colpito pi volte dal mitra usato come clava, finch il caricatore fer a fondo il cuoio capelluto di F. facendolo sanguinare abbondantemente. Solo la vista del sangue sembr placare la SS, e F. pot raggiungere il nostro gruppo tamponandosi come meglio poteva lampia ferita con i fazzoletti prontamente messi a disposizione dai compagni. Poco dopo arrivarono alcuni camion sui quali fummo fatti salire per essere portati alla stazione ferroviaria di Carpi, sotto cospicua scorta. Un lungo treno composto da rossi carri bestiame ci attendeva sui binari! Divisi in gruppi di circa cinquanta prigionieri fummo fatti salire sui vagoni, dove rimanemmo con i portelloni aperti per diverse ore. Quante? A me parvero moltissime. A un certo momento vedemmo avvicinarsi al treno in sosta una colonna di carri e carretti zeppi di cassette di frutta che furono caricate su tutti i vagoni. I contadini della zona consapevoli di quanto ci attendeva provvedevano volontariamente a donare il frutto del loro lavoro per evitare, o almeno limitare, i sintomi della fame e soprattutto della sete che avremmo patito durante il viaggio che stavamo per compiere. Il nostro vagone fu rifornito in abbondanza di ciliegie, pesche, albicocche che resero il nostro viaggio non cos terribile come nelle intenzioni dei nostri aguzzini. Infatti non ci furono distribuzioni di viveri o di acqua da parte delle SS per tutta la durata del viaggio; fortunatamente molti compagni di carro bestiame avevano scorte di cibo con loro. La domanda che tutti noi ci ponevamo era: Dove ci stanno portando? Con quale scopo? Lunica risposta che riuscivamo a darci era che ci avrebbero portato a lavorare in Germania; non sapevamo nulla di pi, ma ottimisticamente nutrivamo ancora un po di speranza! Se ci facevano lavorare era segno che avevano bisogno di noi. Tutti conoscevamo le campagne di reclutamento della Todt,4 che erano continue e insi4
Organizzazione tedesca per il reclutamento (spesso forzoso o coatto) di lavoratori nei Paesi alleati della Germania o occupati dai nazisti.
Testimoni e memorie
189
stenti; un discreto numero di giovani vi aveva aderito, preferendo scavare trincee piuttosto che presentarsi al distretto militare RSI5 per fare il soldato in camicia nera. I lavoratori volontari Todt erano infatti esentati dal servizio di leva. Essere mandati a lavorare non faceva dunque presagire alcuna tragedia. Il popolo italiano non era a conoscenza dellesistenza dei Lager nazisti! Come bestie da macello andavamo incontro alla morte assolutamente ignari del nostro destino. Prima di lasciare il campo per una minaccia ci era stata fatta in modo molto esplicito: per ognuno di noi che fosse fuggito sarebbero stati fucilati dieci degli altri! Ancora non ci rendevamo conto che le minacce delle SS potevano diventare realt! Le ore passavano lente sul vagone fermo sotto il sole di fine giugno sul binario di Carpi. Dei miei compagni di viaggio rammento solo Guido, il Maggiore F. e un istriano, residente a Firenze, di nome K., piuttosto grosso e simpatico. K. parlava diverse lingue, tra cui il tedesco; anche sua madre era stata arrestata e si trovava nel Carcere di Santa Verdiana insieme a mia madre e a mia sorella Anna. Gli altri compagni di viaggio sono senza volto e senza nome. Il mio trasporto fu il numero 53,6 portava in Austria 475 persone: queste informazioni le devo al lungo e paziente lavoro di ricerca del compagno di deportazione Italo Tibaldi, che ha dedicato tutte le sue energie al consolidamento della memoria e alla scrittura della storia della deportazione italiana nei Lager nazisti. Finalmente nel pomeriggio, quando il sole era ancora alto, con grande fragore i portelloni dei vagoni vennero chiusi uno per uno, e il gancio fu sigillato dallesterno. Ci ritrovammo per un attimo in una quasi totale oscurit; eravamo attoniti e confusi, e a fatica potemmo di nuovo distinguere il contorno delle cose alla luce fioca che entrava dallunica apertura rettangolare posta in alto sul lato sinistro del vagone. Alla finestra mancava la griglia di ferro, che era stata sostituita allesterno da filo spinato. Questa apertura era lunica sorgente di luce e di aria per il vagone in cui eravamo ammassati in cinquanta. Finalmente il treno si mosse, acquist velocit e noi provammo sollievo per quel po daria che entrava allinterno. Guido e io eravamo entrambi seduti appoggiati alla parete di fondo del vagone. Il mio amico era ancora dolorante, la mano sinistra era slogata e quasi insensibile, probabilmente a causa della compressione di qualche nervo dovuta alle torture subite dalla Banda Carit; tutto questo era particolarmente grave essendo Guido mancino. Fra uno scossone e laltro il treno si dirigeva verso Nord, mentre si approssimava la sera e la luce nel vagone si faceva sempre pi fioca. Nel fondo di una delle cassette di frutta fu trovata una lamina di ferro lunga circa sessanta centimetri; probabilmente era stata nascosta l per consentirci di far saltare il gancio del portellone, introducendola nella fessura fra la porta e la parete del vagone. Non rammento per che ci sia stato alcun tentativo di provare a fuggire in questo modo: infatti sarebbe stato pi agevole per tutti saltare dal pavimento del vagone dopo aver aperto lo sportello. Non ho per ricordi precisi; sicuramente ebbero luogo varie discussioni tra i favorevoli alla fuga e quelli che la ritenevano troppo pericolosa. Non ci fu quindi una decisione collettivamente condivisa. []7
La Repubblica Sociale Italiana con sede a Sal e Verona. Com detto poco dopo, si tratta del numero dordine nellelenco ricostruito da Italo Tibaldi in Compagni di viaggio. DallItalia ai Lager nazisti. I trasporti dei deportati 1943-1945, Milano, FrancoAngeli, 1994. 7 Omettiamo la narrazione degli eventi successivi, lo svolgimento del viaggio nelle tappe principali e i tentativi di fuga.
6 5
190
Capitolo IV
Finalmente, la sera del 24 giugno, il treno si ferm. I portelloni furono aperti e nella incerta luce dei lampioni che illuminavano la pensilina completamente deserta leggemmo il nome della nostra stazione darrivo: MAUTHAUSEN. Revisione e cura del testo: Sara Di Francia e Lorena Vioglio (I.I.S. Majorana Sezione Scientifica)
Marcello Martini a Fossoli (novembre 2005)
Testimoni e memorie
191
Frammenti di riflessione da un viaggio a Fossoli
Studenti dellI.I.S. Majorana Sezione Scientifica Queste note sono state scritte dopo una visita al campo di Fossoli e al Museo Monumento al Deportato di Carpi avvenuta nel novembre 2005. Per molti degli studenti si trattato di un primo contatto con i luoghi della memoria. La lucida testimonianza di Marcello Martini, seguta con grande attenzione da tutti i partecipanti, stata messa in relazione, nei giorni successivi, con le pagine di Se questo un uomo nelle quali Primo Levi ha fissato il ricordo della sua breve permanenza nel campo. Il giorno 28 novembre 2005 la classe III G della Sezione Scientifica dellI.I.S. Majorana, insieme con alcuni partecipanti al Progetto Memoria, ha visitato il campo di concentramento e transito di Fossoli, nei pressi della citt di Carpi, in provincia di Modena. La visione dei resti del campo e la testimonianza dellex deportato Marcello Martini in pochi minuti ci hanno permesso di immaginare la vita che i deportati, sia ebrei sia politici, conducevano nel campo. Allinterno dellunica baracca oggi ricostruita nella sua forma originaria, si trova il plastico dellintero campo. La ricostruzione non del tutto esatta, perch le testimonianze dei deportati sono quasi tutte diverse. Questo ci ha fatto capire che lesperienza dei campi successivi (Auschwitz e Mauthausen) stata cos atroce, per alcuni, da condizionare il ricordo di Fossoli e dei primi giorni della loro deportazione. (Valeria Cuzzumbo, Marta Pareschi, Valentina Pennini) Allinizio il campo di Fossoli era destinato allinternamento di ufficiali e sottoufficiali dellesercito britannico. In seguito assunse valore di campo di smistamento in cui venivano imprigionati oppositori politici ed ebrei. Sulla base delle memorie giunte fino a noi, possiamo dire che il campo era suddiviso in tre parti: gendarmeria, settore destinato ai prigionieri politici e settore destinato agli ebrei. Si hanno diverse testimonianze sulla composizione delle baracche, che a ogni modo contenevano latrine, lavatoi e brande. (Monica Mosso, Judith Ccasa Caceres, Ilenia De Stefani) A Fossoli passato anche Primo Levi. Lo sappiamo dalle prime pagine del suo libro Se questo un uomo, che tra le righe tiene nascosta la sofferenza di migliaia di uomini. La parte pi toccante di queste prime pagine la descrizione della notte prima della partenza, perch tutti quanti si preparano nel modo che credono pi opportuno: le donne si prendono cura dei loro bambini e li preparano come se dovessero partire per una semplice vacanza con tutta la famiglia, altri invece pregano, bevono a dismisura e fanno delle strane cerimonie con candele dappertutto. Allalba, le poche speranze svaniscono del tutto, perch si viene a conoscenza che per ogni persona mancante allappello dieci saranno uccise. Alla fine dellappello i seicento ebrei si rassegnano a non essere pi considerati persone, ma soltanto Stcke, cio pezzi. (Valeria Cuzzumbo, Marta Pareschi, Valentina Pennini) Una delle testimonianze che ci sono pervenute su Fossoli quella di Primo Levi. Nel libro Se questo un uomo, egli racconta lesperienza della deportazione a partire dal suo arrivo a Fossoli e si sofferma a descrivere lultima notte prima della deportazio-
192
Capitolo IV
ne. Lultima notte al campo descritta come la preparazione a un comune viaggio: tutti preparano le valigie e le madri lavano i bambini. Comunque alla fine ognuno si congeda dalla vita nel modo che preferisce, perch non sa cosa accadr lindomani. Prima della partenza gli animi dei prigionieri sono abbattuti; nemmeno il fatto di essere chiamati pezzi li colpisce. Salgono sui vagoni ormai coscienti di ci che li attende. Marcello Martini, che ci ha accompagnati durante questo viaggio della memoria, parla dellesperienza a Fossoli come meno dolorosa rispetto alla detenzione nel Lager di Mauthausen. Nonostante la sua esperienza di deportazione, egli non ha mai perso la voglia di vivere. Nel suo racconto verbale, a nostro parere, d libero sfogo ai suoi sentimenti, ma li vela con una sottile ironia. (Monica Mosso, Judith Ccasa Caceres, Ilenia De Stefani) Abbiamo avuto la fortuna di ascoltare direttamente le riflessioni e le emozioni di un ex deportato politico che ha vissuto in prima persona questa drammatica vicenda: Marcello Martini. Viene spontaneo cogliere analogie fra Levi e Martini, poich internati entrambi nel campo di transito di Fossoli. La nostra visita ci ha aiutati in parte a capire quella che poteva essere la condizione dei deportati. La permanenza in questo campo non era che linizio di un viaggio verso il nulla, quando lunica certezza era la morte. Levi con accurata sensibilit rappresenta gli ultimi giorni di persone e famiglie che si congedarono dalla vita nel modo che era loro possibile: pregando, e trascorrendo la vigilia della partenza assaporando ogni dettaglio, per quanto fosse possibile. La paura, la disperazione che Levi vide in s e nei suoi compagni sono le stesse che noi abbiamo scorto, sebbene celate dallironia, negli occhi di Marcello Martini. Un aspetto comune ai loro racconti riguarda la violenza fisica subta dai deportati: lessere percossi, malmenati. Primo Levi afferma: Come si pu percuotere un uomo senza colpa? Allo stesso modo, Marcello ricorda come i tedeschi non si facessero scrupoli a picchiare un prigioniero che ai loro occhi non era altro che uno Stck. (Sara Sottolano, Chiara Sabbadini, Barbara Dominelli) Leggendo le prime pagine di Se questo un uomo dopo la visita al campo di Fossoli, ci appaiono pi chiare le descrizioni degli avvenimenti e in particolare degli stati danimo dei prigionieri in attesa dellesodo verso i Lager nazisti. comune quel senso di angoscia, del non sapere inizialmente cosa potr accadere. Primo Levi e Marcello Martini sono stati arrestati in Italia (il primo perch ebreo e partigiano, il secondo perch, ancora ragazzo, aveva partecipato alla Resistenza in Toscana) e deportati, attraverso Fossoli, rispettivamente ad Auschwitz e Mauthausen. Per quanto riguarda le differenze, possiamo dire che diverso il modo di esporre la testimonianza: Primo Levi assume toni pi gravi e drammatici, mentre Marcello punta maggiormente sullironia nel ricostruire ci che gli successo. Inoltre, nel raccontare la propria storia, Marcello parla da un punto di vista pi personale, Primo Levi descrive una situazione generale, rievocando la tensione e la drammaticit del momento. (Davide Ruga, Christian Terlizzi, Igor Ventura) Molto toccante stata la visita al Museo di Carpi, dove, oltre ai reperti del campo, sono incise sui muri delle frasi scritte da deportati che sapevano di dover morire. I dipinti che si trovano nel Museo ci hanno colpite profondamente per la straordinaria in-
Testimoni e memorie
193
terpretazione delle diverse situazioni da parte dellartista. Le figure sono dipinte con assoluta schiettezza, ovvero senza mai celare la crudelt utilizzata verso chi non ha neanche pi una propria dignit o identit. Nella Stanza dei nomi abbiamo avuto coscienza del grande (anche se questa unespressione alquanto limitativa) numero di vittime innocenti: persone morte per i propri ideali o anche solo per la loro appartenenza a una razza. (Monica Mosso, Judith Ccasa Caceres, Ilenia De Stefani) Una cosa che ci ha molto colpito sono le frasi scritte sui muri del Museo di Carpi; ce n una, in particolare, che pensiamo possa riassumere il pensiero di tanti deportati: notte. Improvvisamente si sente la chiave che stride nella serratura. Ecco, arrivato ci che aspettavo da molto tempo. Per spiegare questa frase basti pensare che la morte era molte volte vista come liberazione dal vivere in quel modo, ammesso che in questo caso si possa parlare di vita. (Davide Ruga, Christian Terlizzi, Igor Ventura) Le frasi incise sulle pareti del Museo al deportato di Carpi hanno la rara capacit di trasmettere in modo diretto e rapido tutto ci che i deportati provavano in quei momenti o sapevano di dover provare di l a poco. La morte era il loro destino, un destino tragico cui coraggiosamente andavano incontro. La paura era tanta: ma chi non lavrebbe avuta in una situazione del genere? Chi avrebbe avuto la forza di guardare avanti in simili circostanze? Eppure loro hanno trovato la forza di mettere per iscritto semplicemente quello che sentivano, affidando alla scrittura la memoria di quanto subto. E cos, leggendo in silenzio tali parole, immaginiamo una madre che porge lestremo saluto alla figlia (Figlia, ora tuo padre sar anche madre per te), un ragazzo che desidera vivere (Ho solo ventanni, devo morire, ma voglio vivere) o, ancora, un uomo che si augura la salvezza di due compagni (Oggi saranno fucilati cinque compagni su sette: spero che gli altri due si salvino). Nazionalit diverse, culture opposte, ma tutti, nessuno escluso, vittime della stessa disumana ingiustizia: hanno affrontato la morte consapevoli di non aver commesso alcuna colpa, con la viva speranza che nessuno avrebbe mai dimenticato i loro nomi e le loro storie (Quando il tuo corpo non sar pi, il tuo spirito rimarr vivo nella memoria di chi resta). La memoria di ci che stato risvegliata non tanto dallo studio dei reperti pervenuti direttamente dai campi (ci pi che altro utile ai fini di una ricostruzione storica), quanto dalla lettura delle parole dei deportati, parole ricche di emozioni, che sanno raccontare la storia di chi le ha scritte con unevidenza estrema. In quel Museo rivivi in pochi attimi la vita di milioni di persone; i pensieri riportati sulle pareti risuonano come veri e propri moniti, che invitano a non dimenticare, a impedire che il grembo fecondo da cui natura nacque (Bertolt Brecht) possa divenire sterile. (Ilaria Biasato, Veronica Cicileo, Ingrid Stel) Durante la nostra visita a Fossoli, non ci siamo resi conto di come quel campo fosse sessantanni fa, ma grazie alla testimonianza di Marcello ci siamo immedesimati nella sua esperienza e abbiamo compreso meglio come si viveva nei Lager. Marcello ci ha resi partecipi di un suo pensiero circa la possibilit che un perso-
194
Capitolo IV
naggio simile a Hitler possa tornare al potere in un futuro prossimo, visto che i giovani doggi sono alquanto vulnerabili. (Federico Vercellino, Aleksandr Feodosei, Lara Barberis) Ancora una volta siamo stati messi davanti alla pi grande catastrofe della storia mondiale, avvenuta a met del XX secolo. Parlando con Marcello Martini, gli abbiamo chiesto se secondo lui sar possibile il ritorno di un Hitler. La sua risposta stata pi o meno questa: Hitler probabilmente torner, perch gli uomini e in particolare i giovani sono schiavi dei beni materiali e finch saranno schiavi di marche, vestiti, gioielli e automobili saranno sempre succubi di qualcuno che vender loro il suo pensiero, ed essi lo seguiranno senza riflettere. (Davide Ruga, Christian Terlizzi, Igor Ventura)
Marcello Martini a Fossoli (novembre 2005)
Testimoni e memorie
195
Albino Moret era nato presso Treviso nel 1923; la famiglia si trasfer pi tardi in Piemonte, a San Mauro Torinese, da dove Albino part per la guerra sul fronte jugoslavo. Fatto prigioniero nel settembre 1943 in Jugoslavia, dopo avere opposto resistenza ai nazisti insieme ai suoi commilitoni del Battaglione Exilles, a conclusione di un breve periodo dinternamento in uno Stalag (campo di internamento militare), fu avviato al Lager di Mittelbau-Dora (allepoca, 1943, dipendente da Buchenwald) dove gli venne assegnato il numero di matricola 0155. La sua lunga odissea dapprima in galleria, senza vedere la luce del giorno per mesi, e poi nel sottocampo di Ellrich, dove viene liberato nellaprile 1945, raccontata nel testo inedito che segue. Nel dopoguerra, ritornato a Torino, si battuto appassionatamente per il pieno riconoscimento delle vicende dei militari deportati a Dora, e delle responsabilit degli scienziati nello sfruttamento del lavoro schiavile. mancato nel settembre 2003.
Dalla cattura alla liberazione
Albino Moret Sono Albino Moret, nato il 7 aprile 1923 a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso, chiamato alle armi il 2 settembre 1942 al Distretto di Chivasso, destinato negli Alpini e mandato nel Forte di Exilles, 3 Reggimento Alpini, Battaglione Exilles, 33a Compagnia. Dopo un periodo di istruzione sono stato mandato a Pinerolo alla Caserma Berardi e di l nei Balcani, precisamente in Montenegro (Vis egrad, Priboj, Nova Varos , Pljevlja, Prijepolje, Foc a, ecc.). Il giorno 8 settembre l943 mi trovavo a Viluse (vicino alle Bocche di Cattaro) e fino al 16 settembre 1943 ho combattuto contro i tedeschi. Sono stato fatto prigioniero in un primo tempo e poi mandato a Gravosa, vicino a Ragusa (Dubrovnik, Jugoslavia), poi nelle vicinanze di Sarajevo (Alipasimost); le date precise non me le ricordo. Quindi, su un carro bestiame, sono stato mandato in Germania; la prima tappa stata fatta nelle vicinanze di Berlino in un Lager di cui non ricordo il nome. Poi mi hanno fatto proseguire fino a Knigsberg, nella Prussia Orientale, dove ho fatto qualche giorno di sosta in quel Lager (Stalag); ero vestito ancora da alpino e ci avevano gi portato via la gavetta, perci il rancio lo mettevo nel cappello da alpino. Dopo qualche giorno, non avendo aderito alla Repubblica Sociale, mi hanno mandato in un campo di smistamento chiamato Bad Sulza; in quel campo mi hanno chiesto tutte le mie generalit, compreso il mestiere (facevo il modellatore in legno e metallo), e dopo qualche giorno, precisamente il 13 ottobre 1943, mi hanno inviato al Lager Dora. Come ho sentito il nome Dora, tra me dicevo: Ma questo un nome italiano. Si vede che il comandante del campo ha sposato unitaliana. Invece Dora vuol dire: Deutsche Organisation Reichsarbeit, cio Organizzazione Tedesca Lavoro del Reich. Mi ricordo che sono arrivato al Lager di Mittelbau-Dora (il Lager ai piedi di una collina) che pioveva, e il fango ci arrivava sopra le calcagna. Dopo la conta delle SS e dei Kapo mi hanno mandato in galleria; a Dora non cera ancora nessuna baracca allinfuori di qualche baracca rotonda dove cerano i nostri carnefici. Dora stato aperto nellagosto del 1943; nella collina di Dora prima cerano dei cunicoli che venivano
196
Capitolo IV
utilizzati dalle SS come magazzini di lubrificanti. Mi hanno lasciato il vestito militare, ma sul retro della giacca hanno scritto KLB (Konzentrationslager Buchenwald) perch Dora, fino a settembre 1944, era un sottocampo di Buchenwald, poi divenuto Mittelbau-Dora, con 32 sottocampi,1 di cui il principale era Ellrich, dotato come Dora di forno crematorio. Mi hanno dato un numero, lo 0155, e da quel momento non mi chiamavo pi Albino Moret, ma 0155. Lo zero, perch? Perch noi, come militari, non potevamo essere messi con i politici; in base alla Convenzione di Ginevra avremmo dovuto essere prigionieri nei campi degli internati militari. Alla fine del 1944 cerano oltre 140 baracche, tra le quali il cinema, il bordello, lo spaccio, ecc., tutta roba che serviva alle SS e ai Kapo. Sono uscito dalla galleria per la prima disinfezione dopo quasi quattro mesi (un mio amico dopo otto mesi e mezzo). In galleria nei primi mesi era veramente un inferno; se non eri pi che sano diventavi pazzo tra i rumori, la fame, la sporcizia, la mancanza dacqua e di luce, la puzza di cadavere e le botte. Mi hanno messo subito a fare il minatore con 1Ammoniak-Kommando;2 credo che fosse il lavoro pi infame che Dio abbia mai creato. Si lavorava in turni di 12 ore. Ho quasi sempre lavorato negli avanzamenti, cio nellapertura di nuove gallerie. Si sono costruite due gallerie principali di circa due chilometri ciascuna, con altre gallerie trasversali, oltre sessanta, che univano le due gallerie principali; pi di trenta chilometri di roccia perforata. Nei primi mesi vedevi i compagni pi deboli che cadevano mentre lavoravano. Nei primi tre mesi in galleria sono morti oltre 5.000 uomini. Inizialmente, quando non cera ancora una vera organizzazione, i compagni morti venivano ammucchiati contro la parete; finito il turno di lavoro venivano presi, svestiti e portati allinizio della galleria, dove venivano caricati sui camion e inviati a Buchenwald nei forni crematori. Mi toccato questo ingrato compito pi di una volta. Poi, quando Dora diventato un campo indipendente, cerano gli addetti che se ne occupavano. Nella galleria cera solo un rubinetto di acqua potabile, ma quasi nessuno riusciva ad avvicinarsi; se non si aveva proprio la fortuna di lavorare l vicino, noi deportati, per dissetarci e pulirci un po la bocca dalla polvere della roccia, leccavamo le pareti della galleria (se le SS ci vedevano ci davano dieci nerbate). Come servizi igienici ci mettevano delle file di bidoni a seconda della lunghezza della galleria, e quando si chiedeva di andare a fare il proprio bisogno il Kapo dava dai due ai cinque minuti. Ne ho visti tanti finire dentro ai bidoni. In galleria le SS avevano le mascherine e si davano il cambio sovente. La prima volta che il ministro Speer venuto in galleria svenuto. Il nostro alloggio in galleria era formato da letti a castello, ma non sempre cera posto per tutti; malgrado noi fossimo minimo in tre o quattro per pagliericcio, ogni pagliericcio doveva avere una sola coperta. In un angolo cera un mucchio di coperte che quasi camminavano da sole! Sovente si trovava qualche compagno morto al fianco e allora la prima cosa da fare era quella di guardare se aveva un pezzo di pane nascosto tra la camicia e la pelle.
Si segnala che in altri testi, per, il numero dei sottocampi di Dora 29, mentre sul sito ufficiale del KZ Mittelbau-Dora (www.dora.de, visitato nellottobre 2006) si citano circa 40 campi nel 1945. Il progetto di sistemazione di Dora fu appaltato allinizio a una societ Ammoniak (da cui il nome del Kommando citato da Albino Moret) consociata della IG-Farben. Dopo lagosto 1944 la gestione pass alla Mittelwerk GmbH, una societ a responsabilit limitata, controllata dalla SS con la partecipazione di Albert Speer. Si veda la voce su Mittelbau-Dora in www.deportati.it (visitato nellottobre 2006).
2 1
Testimoni e memorie
197
Anche in galleria esisteva la borsa nera: i deportati che riuscivano ad avere dei sacchi di cemento li vendevano per un pezzo di pane; quello che li vendeva, se veniva scoperto, veniva impiccato, mentre a chi lo comprava venivano date dieci nerbate. I sacchi venivano messi tra la camicia e la pelle per ripararsi dallumidit. Una sera io e il mio amico Gino siamo riusciti ad andare nel piano pi alto del letto a castello; il pagliericcio era tutto bagnato dallacqua che colava dalla galleria. L ci siamo messi a contare i pidocchi che avevamo addosso. Non si poteva stare seduti, perch come si era nel pagliericcio ci si doveva coricare. Quella sera a osservarci cera un nostro compagno di Torino che allora era gi fuori di testa; piangeva sempre e non ricordava il suo cognome. Il mio amico Gino aveva gi contato oltre 400 pidocchi o cimici, mentre io avevo superato i 375; in quel momento arrivata una SS e ha incominciato a far roteare il nerbo di bue e lamico di Torino ci ha rimesso un orecchio. Lho poi rivisto a Torino, prima che morisse, e quando mi vedeva mi chiamava Biro Dora e piangeva. Abitava in Via Mazzini. In galleria sono rimasto circa quattordici mesi e sono uscito per la disinfezione cinque volte. Il nostro Ammoniak-Kommando, ogni settimana, ci dava un buono per la birra ma, in quelle poche volte che sono uscito e mi sono recato allo spaccio del Lager, di birra non sono mai riuscito a berne, era sempre finita. Verso il settimo od ottavo mese, non ricordo pi bene, mi venuta una forte febbre. Allora sono andato al Revier, linfermeria, e mi pare di esserci rimasto otto giorni. Sono stato fortunato, perch invece di mandarmi alla Boelcke Kaserne in Nordhausen per la convalescenza, che era lanticamera della morte, mi hanno mandato al Block 18 (il Block degli italiani), dove cera un Kapo con Stubendienst, aiutanti italiani. L ho conosciuto Gianni Araldi di Salsomaggiore; tornati a casa siamo diventati come due fratelli. Ci sono stato solo dieci giorni: era troppo bello, ma poi sono stato rispedito in galleria a fare il minatore. In quei dieci giorni non mi pareva pi di essere un prigioniero, tanto era diverso dallesperienza in galleria. Intanto il lavoro in galleria andava avanti. Nel 1944 avevamo gi scavato le due gallerie principali, lunghe circa due chilometri, e le altre oltre sessanta gallerie trasversali, lunghe dai duecentocinquanta ai trecento metri; alcune di queste gallerie trasversali sono state finite bene, tutte intonacate con temperatura costante per la costruzione dei missili V1 e V2. Alla guida di questa fabbrica missilistica cerano scienziati tedeschi quali Wernher von Braun, il generale Walter Dornberger e i collaboratori Walter Riedel, Ernst Steinhoff e Helmut Grttrup. Von Braun poi divenuto il padre della missilistica statunitense e Helmut Grttrup di quella sovietica. Lunico che mi hanno fatto vedere e che ricordo stato von Braun, come mi ricordo del ministro Speer; erano sovente in galleria, specialmente nella fabbrica missilistica. Speer venuto una volta a vedere gli avanzamenti della galleria e, come ho gi detto, svenuto a causa dellodore dei cadaveri, dei bidoni che servivano per fare i propri bisogni, della polvere di roccia, dei rumori, ecc. Nei primi tre mesi in galleria i compagni pi deboli morivano come mosche, ti cadevano vicino mentre lavoravano e non si svegliavano pi. Lalimentazione nelle gallerie era di un mestolo di caff (acqua sporca) nella mezzora di pausa, un litro di zuppa (al venerd la zuppa era zuccherata), un pezzo di pane che pesava dai trecento ai cinquecento grammi e venti grammi di margarina; alle volte una fettina di salame (allesterno al sabato davano un pezzo di carne). Buona parte dei deportati aveva la dissenteria, la scabbia o gli orecchioni. In galleria non hanno mai guardato se avevamo i pidocchi, a loro interessava che si andasse avanti con la produzione.
198
Capitolo IV
Negli avanzamenti le SS avevano tutti la mascherina e cambiavano il turno sovente. Anche il nostro maestro, che era un civile, aveva la mascherina in galleria. AllAmmoniak-Kommando dopo qualche mese cerano solo quelli che erano in buona salute. Eravamo gruppi formati da quattro deportati, un civile, una guardia e un Kapo che guardava pi avanzamenti. Ho cambiato diversi compagni; nei primi mesi ero con un caro amico, Giorgio Sibona, col quale avevo gi fatto il servizio militare, con Beniamino Merlo e con un ragazzo di Fossano di cui non ricordo il nome (morto sul lavoro, dopo tre mesi). Al posto del compagno di Fossano morto ci hanno mandato un altro italiano, Lino Pignatari; allora, siccome io ero il pi vecchio delle gallerie, me lhanno messo assieme. Eravamo quattro alpini e, quando non potevamo parlare, ci capivamo solo con lo sguardo; se ti beccavano a parlare mentre lavoravi, erano nerbate. Con Sibona e Pignatari sono stato fino verso settembre 1944, perch un giorno ci hanno portati nel sottocampo di Ellrich: loro sono rimasti l, mentre il sottoscritto dopo qualche giorno tornato in galleria. Con me cerano poi Beniamino Merlo, Boccia di Salerno e Ivan di Stalingrado. Sono stato a Dora fino alla fine del 1944 o allinizio del 1945, poi sono stato trasferito nel sottocampo di Ellrich. Devo raccontarvi due fatti avvenuti durante la mia permanenza in galleria. Nel mese di dicembre del 1943, dopo pochi mesi di Lager, un gruppo di italiani ha reclamato che la zuppa era poca, dato il lavoro da minatore che si faceva. Il Kapo, un tedesco, ha fatto il rapporto che gli italiani si rifiutavano di lavorare. Cos, il giorno 15 dicembre 1943, dopo il turno di lavoro, il comandante del campo ha radunato una cinquantina di italiani e ci ha fatto un discorso di cui si capiva solo la parola sabotaggio. Poi arrivato il plotone di esecuzione: sei sono stati fucilati e uno, prelevato dal Revier in barella, stato ucciso con un colpo di pistola. Mi ricordo che presenti con me cerano Pignatari, Sibona e Morbi (lamico ancora vivo).3 Laltro fatto capitato al sottoscritto e a Sibona. Stavamo lavorando di notte. Eravamo sul ponte e quella sera avevamo una perforatrice (pistola) che non aveva il pistone ad aria; allora dovevamo mettere una tavola di legno sotto la perforatrice e spingere. Stavamo perforando la roccia con lultimo ferro, cio quello di 4,20 m; sar stato per la stanchezza o per il troppo mangiare, ci siamo addormentati, siamo caduti dal ponte e il ferro si rotto. arrivato subito il Kapo che ci ha gridato Sabotage! Alle kaputt!. Era linizio della settimana; quel giorno l il mio amico aveva gi preso dieci nerbate perch lavevano trovato con la carta del cemento addosso, cosa che per loro era Sabotage. Alla domenica, quando avrebbero dovuto impiccarci tutti e due, abbiamo invece sentito dallinterprete i nostri numeri e abbiamo preso solo venticinque nerbate, di cui porto ancora i segni sulla spina dorsale. Al luned, dopo il turno di lavoro, sono andato alla disinfezione fuori dalla galleria; era la terza volta che uscivo, tutto contento perch ero pulito con la mia cresta in testa (a noi italiani della galleria tagliavano i capelli ai lati e lasciavano la cresta in mezzo, ai russi il contrario). Avevo fatto pochi passi allinterno della galleria, non so ancora adesso che cosa ho fatto, ma
Sullepisodio riferito da Albino Moret altre fonti attestano che la protesta degli italiani, scaturita dalla richiesta di un vitto uguale a quello degli altri prigionieri, fu accompagnata altres dal richiamo alla Convenzione di Ginevra, secondo cui i prigionieri di guerra non possono essere impiegati nella produzione di armamenti (cfr. H. Stein, Konzentrationslager Buchenwald 1937-1945. Begleitband zur stndigen historischen Ausstellung, Gttingen, Wallstein Verlag, 20002, p. 212).
Testimoni e memorie
199
una delle SS mi ha colpito con il pugno di ferro e mi ha spaccato il labbro e i denti. Un compagno francese che, come i cecoslovacchi, riceveva i pacchi dai famigliari, con uno spicchio daglio mi ha disinfettato e poi mi ha messo un cerotto di carta; anche l porto ancora i segni. Vi racconto alcuni fatti successi nelle gallerie del Lager Dora. Un giorno, dopo che il civile che era con noi aveva messo tutte le cariche di dinamite nei fori fatti da noi deportati sulla roccia, siamo usciti dallavanzamento della galleria aspettando che il civile facesse brillare la dinamite per fare saltare la roccia. Mi sono seduto qualche istante e subito la guardia SS ha incominciato a inveire contro di me dandomi nerbate, calci al basso ventre e colpi di moschetto nello stomaco; io non ho fatto una piega, cio non un lamento, non un grido, e questo a loro faceva male, non potevano gioire del male che ti facevano. Mi ricordo che un mio caro amico russo, Ivan, che lavorava poco distante, finito tutto mi ha detto: Albino dobra! cio bravo. Ho sempre avuto un carattere che, piuttosto di piegarmi, sarei morto. I miei amici di Lager italiani mi dicevano: Ma non le senti le botte, che non ti lamenti mai? Ero troppo testone e sono ancora testone oggi; cosa voglio, voglio, cio la verit su questo maledetto Lager Dora. Ogni trenta o quaranta giorni ci davano del tabacco per fare qualche sigaretta. Credetemi: quando arrivava il tabacco, i veri fumatori non capivano pi niente; prendevano la carta dei sacchi del cemento e la usavano come cartine per avvolgere il tabacco. Io non fumavo e la mia razione la davo al mio amico Gino che era un fumatore accanito; aveva sei anni pi di me ed era tanto amico di mio padre. Un bel giorno mi accorsi che anche lui dava via la fetta di pane per il tabacco. Allora gli dissi: Caro Gino, il tabacco da me non lo prenderai pi. Vender anchio il tabacco per il pane. Lui diceva che non era vero, invece lavevo proprio visto io; siamo stati qualche giorno senza parlarci, pur lavorando in coppia in galleria. Poi, alla fine, ho ceduto io e gli ho detto: Senti Gino, io il tabacco te lo dar di nuovo, per la tua razione di pane la tengo io. Non era tanto soddisfatto, ma poi alla fine ha ceduto. Delle due razioni di pane che ci davano facevamo sei pezzi, li avvolgevamo in un pezzo di carta e facevamo un pacchetto; questultimo lo mettevo tra la camicia e la pelle. Mangiavamo quei pezzi di pane, uno al mattino, uno a mezzogiorno e uno alla sera. Quando tiravo fuori quel pacchetto, era tutto nero, ricoperto di pidocchi. Siamo andati avanti cos fino a quando abbiamo lavorato in galleria. Siccome eravamo dello stesso paese, San Mauro Torinese, quando ritornato a casa Gino ha detto alla sua fidanzata: Se sono qui con te devo dire grazie ad Albino che non mi lasciava vendere il pane per il tabacco. In galleria, appena arrivato, mi hanno dato in dotazione una gamella di ferro che, dopo poco tempo, si tutta arrugginita. Questa gamella serviva per prendere il mezzo litro di caff, acqua sporca che per prendevo volentieri per bere un po di liquido, visto che in galleria non si poteva bere. La gamella serviva anche per prendere quel mestolo di zuppa; pure senza lavarla era sempre lucida perch anche lultima briciola veniva tolta con le dita. Poi avevo il pesino per pesare il pane quando facevo la divisione. Il pesino era nientaltro che un pezzo di legno con due piccoli ganci per poter pesare le fette di pane. Gamella e pesino si portavano sempre attaccati dietro la schiena. In galleria non bisognava mai mollare, salute permettendo, perch, credetemi, se si mollava un momento era finita. Qualche sera, quando ci sentivamo un po pi sereni (rare volte), cercavamo di farci forza luno con laltro. Ricordo una sera che Gino, tutto serio, mi disse: Senti Albino, io non vado tanto in chiesa, ma se abbiamo la fortu-
200
Capitolo IV
na di tornare a casa, partiamo da San Mauro a piedi e andiamo fino a Oropa. Quando sono tornato io ci sono andato, ma non a piedi; anche lui tornato, ma morto in un incidente stradale. Pensate la disperazione che cera dentro di noi in quelle maledette gallerie. Invece con un altro caro amico, Lino, che venuto a lavorare con me in galleria quando mancato lamico di Fossano, alla sera ci raccontavamo la nostra vita militare. Lui mi diceva sovente: Anche stasera siamo qua, chiss domani sera come sar? Si viveva alla giornata. Mi parlava sempre di andare al suo paese a bere il Lambrusco. Anche lui ritornato, ma adesso non c pi. Questi amici di prigionia che hanno sofferto con me nelle tremende gallerie del Lager Dora non potr mai dimenticarli. Al Lager Dora cerano anche dei deportati che ogni tanto ricevevano dei pacchi di viveri dai loro famigliari, quali i francesi e i cecoslovacchi. Il perch non lho mai saputo. Per noi era un bene perch il giorno che loro avevano questi viveri qualche cucchiaiata in pi di brodaglia del Lager finiva nella nostra pancia. Credetemi: la fame brutta, ma la sete una cosa terrificante. Io la sete lho patita veramente e quando sono ritornato a casa, di notte, per tanto tempo, ho avuto degli incubi; mia mamma, poverina, mi diceva che gridavo, che dicevo dei nomi di persone, chiedendo loro dellacqua (forse compagni di Lager). Dopo qualche giorno il mio letto stato messo nella sua camera, cos ero vicino a lei; mi metteva sempre dei bicchieroni dacqua sul comodino da notte. Ce ne sarebbero diversi di episodi da raccontare, successi nel Lager. In dotazione ho avuto gli zoccoli olandesi. Me li legavo con un pezzo di filo di ferro per non perderli, perch sulle pietre della galleria non riuscivo ad abituarmi a portarli; oltretutto, dopo un po di tempo, si rompevano sotto, quindi pizzicavano la pelle e avevo sempre i piedi insanguinati. Io, come tutti gli altri compagni di sventura che lavoravano facendo i minatori e caricando il materiale sui vagoni ribaltabili, non ho mai avuto la possibilit di tagliarmi le unghie delle mani e dei piedi. Quelle delle mani, lavorando nella roccia, si consumavano, ma per quelle dei piedi era una tortura. I capelli e la barba ce li tagliavano quando andavamo fuori per la disinfezione (io sono uscito per la prima volta dopo circa tre mesi e mezzo). Quando sono tornato a casa il mio barbiere, con un paio di pinzette, per diverso tempo mi ha tolto i peli della barba che poi sincarnivano nuovamente e formavano delle pustoline. Avevo i pantaloni legati con uno spago. Una notte ho visto indosso a un compagno francese, che era appena morto, una bella cinghia; mi sono subito buttato su di lui per prenderla, ma in un momento ci siamo trovati in diversi a fare la stessa cosa. Il Kapo si accorto di ci e, dopo averci dato qualche nerbata, la cinghia se l presa lui. Sono riuscito per a recuperare un pezzo di pane del francese. Il Lager Dora era diviso in due Lager, cio le gallerie e lesterno; questultimo, per sentito dire dai miei compagni, era veramente bello da vedere, non da starci: bordello, cinema, campi da calcio, orchestrina, giardini attorno alle baracche. Era un luogo dove, per la fabbrica missilistica, venivano molte autorit: Himmler, Goebbels e altri, con le rispettive signore; mi hanno anche detto di Hitler. Noi in galleria non vedevamo quasi mai nessuno; poi, se non cera qualcuno che te lo diceva, a noi non interessava. Non ricordo bene se alla fine del 1944 o allinizio del 1945, mi hanno trasferito definitivamente nel sottocampo di Ellrich, che si trovava dallaltra parte della collina; un Lager con forno crematorio, un Lager di 6.500-7.000 deportati, mentre a Dora il numero variava dai 16.000 ai 22.000 (cerano deportati di diciassette naziona-
Testimoni e memorie
201
lit). Appena arrivati a Ellrich abbiamo saputo da alcuni nostri compagni arrivati da Dora dopo di noi che il crematorio che funzionava giorno e notte non bastava pi a bruciare tutti i cadaveri. Allora hanno fatto delle cataste di legno e i deportati li hanno bruciati cos. A Ellrich ho ritrovato lamico Lino Pignatari, Boccia, Beniamino Merlo, De Taddeo e un nuovo amico, Sergio Gabbianelli, che dopo pochi giorni si buscato dieci nerbate. Credetemi che dal fuoco sono caduto nella brace; l si lavorava solo di giorno, dalle sei del mattino alle sei di sera. Lavoravo in un cementificio che era stato bombardato dagli Alleati, quindi avevano bisogno di manodopera. Si partiva dal Lager e dopo qualche chilometro si arrivava al cementificio. Eravamo 300-400 deportati e si trattava di riempire i sacchi di polvere di cemento; eravamo quattro deportati per sacco, due tenevano il sacco e due con la pala ci mettevano dentro la polvere di cemento. Facevamo turni di mezzora con alle calcagna continuamente SS o Kapo: Los, los! gridavano tutto il giorno, Schnell, schnell, e se ti fermavi un momento erano nerbate. Con me c sempre stato Boccia di Salerno, pi in gamba di me; mi ha veramente aiutato tanto, alle volte faceva mezzora di seguito al posto mio. Non ce la facevo pi, la galleria mi aveva ucciso, cercavo in tutti i modi di farcela, ma era dura. Dopo due o tre ore che lavoravi non vedevi pi niente; allora di nascosto ti facevi la pip in mano e ti pulivi gli occhi. Alla sera, quando si tornava al Lager in baracca, otto volte su dieci non cera lacqua per lavarsi; l i capo Block erano quasi tutti polacchi e se reclamavi erano nerbate o calci al basso ventre o dove capitava. Il mio amico Algeri aveva fatto il minatore per sei mesi e poi era andato a stare bene; era con dei civili e faceva i pozzi artesiani. Morbi era in una baracca distante dal Lager, anche lui se l cavata abbastanza bene. Ho tenuto duro fino alla met di febbraio del 1945, poi sono crollato. Un mattino, mentre andavo al lavoro incolonnato con gli altri deportati del Lager e con le SS e i cani ai nostri fianchi, uscendo dal portone sono crollato a terra svenuto; credevo veramente che fosse arrivata la mia ora. Un mio compagno mi ha poi riferito che mi hanno preso a calci e tirato da una parte; eravamo in diversi per terra. Come sono usciti tutti, mi sono ripreso e rialzato. Il capoporta non era una SS, ma un maresciallo dellaviazione tedesca. Gli altri li hanno portati via, non so dove, mentre a me il maresciallo ha fatto prendere la scopa e spazzare il corpo di guardia. Quando siamo rimasti soli, vedendo che ero italiano, mi ha chiesto come mai mi trovavo l e di dove ero. Io non ho osato chiedergli se era italiano, ma ho avuto il coraggio di chiedergli un po dacqua; lho avuta e ho avuto anche una fettina di pane. Alla sera mi ha detto che il giorno dopo avrei di nuovo dovuto presentarmi al corpo di guardia alle ore sei per pulire. Il terzo giorno, in un momento che era solo, mi ha detto che faceva servizio alla porta perch lui era venuto da Milano ai funerali di suo padre in un paese vicino ad Amburgo, e che aveva sposato una milanese; aveva due figli ed era ingegnere alla Siemens a Milano. Sono stato a pulire fino allinizio dellaprile 1945. Questo maresciallo mi aveva salvato la vita, perch di nascosto cera sempre un po di zuppa e qualche fettina di pane per me. Ero proprio allo stremo delle forze, non ce la facevo veramente pi, ma non era ancora la mia ora! Verso i primi di aprile c stata levacuazione di Dora e dei suoi sottocampi. Si sono formate diverse colonne di deportati che dovevano arrivare a Bergen Belsen; quelli di Dora sono arrivati, mentre noi da Ellrich abbiamo raggiunto Malchow dopo circa 1.572 chilometri, in parte a piedi e in parte su carri bestiame. Questa marcia di trasferimento poi praticamente stata una marcia della morte; abbiamo perso molti compagni per la strada, era sufficiente restare indietro che ti sparavano in testa e ti
202
Capitolo IV
buttavano al lato della strada. Una sera, era gi buio, abbiamo subto un mitragliamento, non sappiamo da chi; abbiamo avuto circa 300 morti. Allora le SS ci hanno procurato dei badili, ci hanno fatto fare una grande buca e i morti li abbiamo buttati l. Il mio amico Sergio Gabbianelli, che tra i morti aveva un suo amico di Jesi, ha avuto il coraggio di chiedere alla SS se gli faceva tagliare una ciocca di capelli da portare alla mamma; gli stato concesso. Passando per Ravensbrck siamo arrivati in un bosco dove siamo rimasti, mi pare, dodici giorni. Eravamo come delle capre perch, per tutti quei giorni, non abbiamo avuto niente da mangiare e mangiavamo erba e radici. Un mattino non abbiamo pi visto le SS: erano sparite. Si sentiva solo sparare. Allora, a gruppetti, cera chi andava da una parte e chi dallaltra. Mi sono trovato vicino a un cartello segnaletico con su scritto SCHWERIN. Le strade erano piene di automezzi tedeschi abbandonati e noi, come tanti animali affamati, razziavamo per mangiare. Molte donne tedesche (cerano solo donne) ci facevano entrare e ci davano quello che avevano; tante volevano anche fare lamore, ma noi non eravamo pi uomini, io pesavo 37 chilogrammi. Dopo quattro o cinque giorni gli americani hanno fatto un rastrellamento e ci hanno invitati a salire sui loro camion; se non salivi ti facevano salire per forza! stata una fortuna. Ci hanno portati in una caserma e l, per un po di tempo, ci davano le razioni di rancio. Tanti di noi, che non sono stati presi, sono morti per il troppo mangiare. Anche l ho avuto un colpo di fortuna: durante la visita alla caserma da parte di truppe americane, il comandante mi ha visto con un altro mio compagno di prigionia in uno stato da far paura e ci ha chiesto se volevamo andare ad Amburgo con loro; il comandante americano era figlio di italiani emigrati in America, di Pompei. stata la nostra fortuna. Ci hanno puliti tutti, medicati di tutte le pustole e ferite che avevamo addosso e vestiti come loro; non ci pareva vero, ci volevano molto bene. Io sono stato con loro fino a met agosto 1945. Mi sono ripreso in maniera impressionante: quando sono andato con loro pesavo 37 chilogrammi, quando sono arrivato a casa, il 30 agosto 1945, a San Mauro Torinese, ne pesavo 80. Non potevo dire che avevo sofferto molto, perch non ti credevano. Ad aspettarmi cera lintero paese, perch io e lamico Sibona eravamo gli unici di cui non avevano mai avuto notizie. Quando sono tornato a casa dal Lager, per parecchio tempo mi sono chiuso in un guscio e assolutamente non volevo pi sentire parlare della prigionia, volevo dimenticare tutto, ma purtroppo veramente una cosa impossibile dimenticare la tua giovinezza passata in quei posti terribili. Dopo circa venticinque anni ho ricevuto una lettera dallamico Araldi di Salsomaggiore, in cui mi diceva che aveva intenzione di radunare il maggior numero possibile di ex deportati del Lager Dora. stato fatto, e da quella volta, per pi di ventanni, ci siamo radunati a Salsomaggiore, compagni di Lager dal Friuli alla Sicilia. Allinizio non eravamo in tanti, ma dopo qualche anno eravamo circa settanta deportati pi i famigliari: una bella festa, era diventata la famiglia di Dora. Tra i nostri amici cera anche Carlo Slama, che ha scritto un libro sul Lager Dora, Lacrime di pietra, cera quel simpaticone di Ferraci (ora morto), che allora faceva il venditore ambulante e sul telone del camion aveva scritto La Belva di Buchenwald. In mezzo a noi avevamo anche un resuscitato: era finito nel carretto che portava i morti al crematorio (poverino, soffriva di crisi epilettiche), lavevano visto muoversi, era stato salvato e portato al Block 18, quello degli italiani; anche lui adesso morto, lamico Montanari di Fidenza. Adesso questi raduni non si fanno pi perch siamo rimasti in pochi vivi, ma noi amici stretti continuamente ci vediamo o ci sentiamo. Noi deportati di Dora in Salsomaggiore abbiamo un nostro monumento; il
Testimoni e memorie
203
Comune gentilmente ci ha dato un giardino denominato KZ Dora e l noi abbiamo fatto costruire questo monumento chiamato Deportati nei campi di sterminio. Tutti gli anni, dopo la Messa ai caduti, facevamo il corteo per le vie cittadine, con fanfare e majorettes e andavamo a posare le corone sui monumenti di Salsomaggiore. Nel settembre del 1996 da Torino part un pellegrinaggio al Lager Dora; avevano gi aperto parti delle gallerie. A quel viaggio volle partecipare un deportato di Ebensee, lamico Italo Tibaldi. Dopo la visita alle gallerie, Tibaldi mi disse: Albino, dobbiamo fare il primo Convegno Internazionale sul Lager Dora. Grazie al suo interessamento, a quello dellamico Araldi e al Presidente dellANED, Senatore Gianfranco Maris, il Convegno stato fatto a Salsomaggiore nellottobre del 1997. Ha avuto un grande successo e molte partecipazioni di studenti e storici, italiani e stranieri, deportati e famigliari, oltre alla popolazione di Salsomaggiore, che a noi sempre stata vicina. Grazie Italo! Anche questo Congresso rappresenta un pezzo di storia del Lager Dora, per troppi anni dimenticato. Sono gi stato al Lager Dora tre volte, ma la migliore stata la visita del mese di settembre 1996. Hanno riaperto tratti di galleria, dove sono stato sepolto per circa quattordici mesi. stata molto dura, credevo che mi mancasse il cuore da un momento allaltro ma, grazie agli amici che avevo attorno, mi sono ripreso abbastanza in fretta. Del campo Dora oggigiorno la miglior cosa che sia stata riaperta una parte di quelle maledette gallerie, perch la storia del Lager Dora stata l sotto. Poi ci sono ancora i tre forni crematori, che funzionavano giorno e notte (la media era di circa 80 cadaveri bruciati al giorno). Ci sono anche il locomotore (allingresso del Lager), quello che trainava i vagoni con i missili fuori dalle gallerie, parte del Bunker, un museo, vari monumenti e tanta altra roba. Sembra che poco alla volta le verit su Dora vengano a galla, perch Dora era un Lager segreto e nessuno ne parlava, noi compresi, perch la gente non credeva che fossero successe cose cos terribili; solo chi le ha vissute e ha avuto la fortuna di avere la salute e un carattere forte pu saperle. Molti di noi italiani eravamo sotto il servizio militare e per farci riconoscere come ex deportati in un campo di sterminio c voluto molto tempo. Tutto questo silenzio sul Lager Dora credo sia una questione politica, perch, terminata la guerra, gli scienziati tedeschi che erano al Lager Dora, dove sono stati costruiti i missili V1 e V2 lanciati su Londra nel 1944, se li sono presi lAmerica, la Russia e la Francia, che sono state le conquistatrici dello spazio. Questa una vera vergogna, perch anche la storia viene falsata. Io, riguardo alla verit su Dora, ho gi scritto a un mucchio di personalit; lunico che forse mi stato vicino stato il Presidente della Repubblica, Onorevole Scalfaro, ma forse anche lui ha le mani legate. Ma state tranquilli che non mollo! Non volevo scrivere niente sul Lager Dora, dove ho vissuto i momenti pi terribili della mia vita, perch non sono uno scrittore ma, grazie a una mia carissima amica che ha capito la mia prigionia, la Professoressa e Assessore al Comune di Verbania Silvia Magistrini, non ho potuto tirarmi indietro. Certo che ricordare tutto duro; vorr dire che, se ci sono tanti errori, mi perdonerete. Il primo impatto con il Lager Dora stato veramente brutto; vedendo tutte queste persone vestite a righe (zebrate) credevo di essere stato mandato in un penitenziario. A ventanni non avevo mai visto una cosa simile! Non mi ero sbagliato, anzi, stato peggio: mi hanno messo subito a fare il minatore in galleria, dove la luce lho vista raramente. Ero diventato un sepolto vivo. Mi chiedevo: Ma cosa avr mai fatto di male per essere trattato
204
Capitolo IV
cos? Non solo. Per diverso tempo eravamo bersagliati sia dai tedeschi, che ci tacciavano di traditori, sia dai compagni deportati che ci consideravano dei fascisti; c voluto molto tempo per far capire ai compagni di Lager che se si era l un motivo ci doveva essere, cio che non si aveva aderito alla politica di Hitler. Finalmente, quelli che allinizio ci trattavano male sono diventati dei veri amici. Io, che ero molto schizzinoso, ho imparato subito come si doveva vivere con gli altri e, credetemi, con il mio carattere, non stato per niente facile. Un accademico francese, forse si chiamava Franois Denivad, diceva: Spesso ho sognato di creare unassociazione senza presidente, senza tesoriere, senza iscrizione, senza patronato, i cui membri sapessero solamente che sono membri, senza bisogno di scriverlo o di dirlo perch sono presenti (ci sono). In galleria purtroppo sono successe tante cose disgustose; tanti Kapo, per un pezzo di pane, approfittavano del deportato, ma per fortuna non tutti erano cos. Non lho mai detto, ma la settimana che con il mio amico dovevo essere impiccato, e invece con un po di fortuna lho aggiustata con venticinque nerbate, successo un episodio sgradevole. Andavamo a prendere dei ferri da lavoro in unaltra galleria insieme al civile, quando il nostro Kapo tedesco, chiamato da noi italiani il Bavoso, sempre ubriaco di birra e facile a menare le mani e i piedi, ha preso in disparte il mio amico e, aperti i pantaloni, voleva farsi succhiare il pene. Il mio amico glielo ha morsicato facendolo gridare e scappando subito. Sono accorse le SS e il giorno successivo abbiamo visto il Kapo appeso alla gru, senza pantaloni. Hanno fatto bene! Le impiccagioni in galleria, come le nerbate, avvenivano sempre di domenica: cera una gru con una putrella e ne impiccavano dieci alla volta. Durante lultimo viaggio al Lager Dora, dove per la prima volta ho rivisto il posto dove sono rimasto sepolto vivo per circa quattordici mesi, uscendo dalle gallerie una studentessa della Professoressa Marta Montevecchi mi ha detto che noi deportati siamo pezzi di museo ambulante, e altri studenti mi chiedevano come mai ero sempre allegro. vero, il mio carattere sempre stato forte al punto che, grazie alla salute, ho riportato in patria ossa e ceneri del mio corpo: cos non hanno potuto usarle per concimare i campi tedeschi. Noi deportati non siamo stati degli eroi, come qualche studente ci ha detto, ma purtroppo i nostri anni migliori li abbiamo vissuti nei Lager. Ci sono ancora tanti particolari che, scrivendo, non si possono raccontare, perch Dora era la galleria, cio la storia dei sepolti vivi, cosa che non si potr mai raccontare. Torino, maggio-giugno 1998
Albino Moret a Moncalieri (27 gennaio 2003)
Testimoni e memorie
205
Natale Pia (ma per tutti Natalino) nato a Montegrosso dAsti nel 1922. Il 17 dicembre, ci tiene a precisare: perch se fosse nato due settimane dopo avrebbe certamente evitato la prima delle due odissee che ha recentemente narrato nel suo libro autobiografico.1 Chiamato alle armi per la leva 1922, assegnato come autista al II Reggimento di Artiglieria del Corpo dArmata, Divisione Ravenna, sul fronte del Don. Sopravvive alla ritirata di Russia (della sua batteria scampano in quattro, sui 144 soldati che la componevano), partecipando allo sfondamento di Nicolajewka. Rientrato in Italia, collabora allorganizzazione di gruppi partigiani, ma catturato in un rastrellamento a Vinchio dAsti nel dicembre 1944; fra gli altri compagni di prigionia c Vittorio Benzi, il giovanissimo fratello della fidanzata. Incarcerati alle Nuove di Torino, vengono entrambi inseriti nel gruppo che trasferito al campo di Bolzano e poco dopo, l8 gennaio 1945, a Mauthausen, in un convoglio di circa 500 persone. Immatricolato con il n. 115658, trasferito a Gusen dove rimane fino alla liberazione. Vittorio invece, da cui stato separato, morir a Gusen il 22 marzo. Nel dopoguerra Natalino, sempre vissuto a Montegrosso dAsti, tornato precocemente e molto spesso sui luoghi della sua deportazione, con viaggi personali o insieme allANED, testimoniando nelle scuole e nelle manifestazioni commemorative.
Il racconto di Natalino Pia
Mauthausen, aprile 1998 (Studentesse dellITCS Marro) Sono nato nel 1922 a Montegrosso dAsti, sono partito militare nel 1941 e ho partecipato alla campagna di Russia. Dopo l8 settembre, mi sono unito alle forze partigiane. Il 2 dicembre 1944 sono stato catturato a Vinchio dAsti e deportato a Mauthausen, e in seguito trasferito a Gusen. Ricordo che la prima volta che siamo entrati nel campo abbiamo visto una carriola carica di cadaveri destinati al crematorio, e ci pareva impossibile! Ma non si poteva fare a meno di notare il fumo. Noi logicamente, allora, del crematorio abbiamo solo sentito la puzza, perch se lavessimo visto non saremmo qui. Nelle camere a gas in genere finiva chi non riusciva a morire lavorando, e resisteva di pi; bastava anche avere la dissenteria e sporcare due o tre volte per terra Anche chi aveva troppi pidocchi finiva l. Mi ricordo quando andavamo a fare la doccia. In genere si ha un asciugamano, qualcosa, noi eravamo nudi, completamente. Lacqua arrivava a momenti bollente, altri gelata. Dopo la doccia si girava attorno alla stanza, dove cerano gli addetti che con il rasoio ci depilavano dalla testa ai piedi e intanto cercavano anche nelle parti pi intime per vedere se cera qualcosa di nascosto. Poi si usciva, sempre nudi, e senza la possibilit di asciugarci; se uno aveva un pezzettino di carta o un pezzettino di straccio era considerato un sabotatore, con tutte le conseguenze. Nella camera attigua venivano disinfestati gli indumenti. Su di noi cerano tanti pidocchi; quando uno aveva vo1
N. Pia, La storia di Natale. Da soldato in Russia a prigioniero nel Lager, a cura di Primarosa Pia, Alessandria, Joker, 2003, 20063.
206
Capitolo IV
glia di scherzare (ma erano poche le volte!) giocavamo a chi ne tirava fuori di pi. Le baracche sono come quelle di allora. Noi dormivamo in 200-250 nello stesso spazio, i Kapo dormivano in tre o quattro per stanza. Quando siamo arrivati qui a Mauthausen, dentro la nostra baracca non cerano neanche i letti a castello, di conseguenza alla sera per dormire ci mettevamo come delle acciughe. Daltronde, per dormire 250 persone in una stanza, per forza si doveva stare stretti! Ci facevano entrare a colpi di scudiscio. Per farci stare zitti ci picchiavano con gli zoccoli che ci avevano dato in dotazione. Se uno aveva delle necessit durante la notte, doveva uscire per andare alle latrine, ma il problema era trovare di nuovo il posto al ritorno. Nei letti a castello si dormiva in tre, a volte quattro, bisognava stare stretti Negli ultimi tempi per cera pi spazio, perch si diminuiva di peso. Quelli che morivano non ci davano fastidio; a volte, egoisticamente, se avevamo un morto vicino cercavamo di prenderci la sua razione di acqua. Ogni mattina, infatti, ci davano delle razioni di acqua per non farci disidratare: a loro lacqua costava poco perch la prendevano dal Danubio, la facevano semplicemente bollire. Se riuscivamo ad avere dellacqua in pi era come avere qualcosa in pi dentro. Un giorno mi sono preso venticinque legnate per essermi riscaldato vicino a una lampadina, dopo aver lavorato tutta la notte. Il Kapo, un polacco, aveva visto che avevo finito il mio lavoro, faceva molto freddo, cerano due lampadine e io ho messo le mani davanti per riscaldarmi. Mi ha chiamato, mi ha messo l e mi ha dato venticinque legnate. La gente del luogo ci vedeva, eccome! Anche perch si transitava per il paese e si arrivava alla stazione per raggiungere gli altri campi di lavoro. Prima lavoravo in officina, poi, gli ultimi mesi, sono passato a un settore in cui avevo il compito di pulire gli otturatori. Il lavoro pi lungo per me stato portare via il materiale lavorato e trasportare il materiale da lavorare dai vagoni della ferrovia allofficina. Anchio mi stavo avviando alla morte: a volte, seduto per terra, non mi alzavo pi e dovevo far finta di fare qualcosa. Penso a gente che ha sofferto anche dieci mesi, per ha avuto la possibilit di avere qualcosa in pi, per esempio lavorare al coperto Io posso dire che aver fatto la campagna di Russia mi ha aiutato molto, perch il corpo riuscito a reagire. Non ho mai avuto qualcosa in pi di altri, ma sono riuscito a sopravvivere per quattro mesi e mezzo, invece tanti, per esempio mio cognato che aveva 17 anni, non ce lhanno fatta. Io avevo una costituzione gi abituata alla fatica, e questo penso mi abbia aiutato. Ci voleva fortuna e determinazione per sopravvivere. Ho sempre detto ai miei amici di farsi forza. Cera gente in apparenza robusta, ma che andava gi di morale nel giro di tre, quattro giorni. Non era pensabile ribellarsi. Sui reticolati cerano 2.000 volt, bastava che uno fosse a due metri di distanza e gi veniva bruciato. Bisogna poi considerare che, se uno tentava in qualche modo di fuggire, tutti i compagni di prigionia ne avrebbero pagato le conseguenze; loro colpivano tutti gli altri e uno si sarebbe sentito responsabile. In quel posto non distribuivano carezze, ma cose di cui meglio non parlare! Se non mai scappato nessuno, una ragione c; troppo facile dire: Perch non siete scappati? Quelli che hanno tentato sono rimasti nei reticolati. Vedete, questo il Monumento agli italiani, fatto con la pietra del campo. Dietro ci sono le fotografie portate dai famigliari delle vittime. A me questo Monumento dice molto, perch ricorda tutti i miei compagni, anche quelli che non ho conosciuto direttamente. Sono sempre dentro di noi. Purtroppo fra loro c anche mio cognato. Qui la guerra finita l8 maggio. I primi liberatori sono stati gli americani, poi
Testimoni e memorie
207
questo territorio, fino al Danubio, stato ceduto ai russi quando c stata la spartizione fra i vincitori. Sono tornato a casa dopo un mese, forse due. Per me andata abbastanza bene, perch sono stato portato in un altro campo militare al di l del Danubio, e non sono stato pi riportato a Mauthausen, com successo ad altri che, per le loro condizioni, sono stati rimandati qui. S, per curarli, ma curare una persona facile, curarne diecimila molto pi difficile. Io invece in quel campo militare ero lunico di Mauthausen. Tornare alla vita normale stato molto difficile. Penso che sia difficile ancora oggi, da allora non cambiato niente. Se ci hanno riconosciuti come invalidi di guerra per quello che abbiamo sofferto vuol dire che non abbiamo tolto niente dalla nostra mente. Abbiamo dovuto accettare le cose e cercare in tutti i modi di ritornare alla vita, ma noi siamo sempre l, ancora oggi. Voi, giovani, non crediate che queste cose, solo perch accadute tempo fa, non avvengano pi; purtroppo sono molto vicine, possono ritornare, perci, se possibile, cercate di far in modo che non avvengano di nuovo, sono cose che portano soltanto dolore e male. Io torno qui con i giovani o anche da solo, non la prima volta, per rendere omaggio a quelli che sono rimasti, perch mi sento in dovere di farlo, glielo devo. Margherita Benzi Pia e Primarosa Pia, madre e figlia, ci hanno accompagnato nei viaggi come famigliari di deportati. Margherita Benzi, moglie di Natalino Pia (mancata nel 2005), sorella di Vittorio Benzi (1927-1945), giovane partigiano deportato a Mauthausen (matr. 115573) e deceduto a Gusen nel marzo del 1945: una semplice lapide, tra le pi vecchie, lo ricorda nella parte privata2 del Monumento italiano a Mauthausen. Primarosa Pia figlia di Margherita e di Natale Pia. Oltre a Vittorio, vanno ricordati gli altri zii: Biagio Benzi, deportato a Flossenbrg, e Giovanni Benzi, deportato a Bolzano, tutti partigiani coinvolti nel rastrellamento nella zona di Nizza Monferrato del 3 dicembre 1944. Primarosa curatrice del libro del padre, La storia di Natale, e della sua versione integrale on-line.3
Natalimo Pia e Margherita Benzi a Mauthausen (aprile 1998)
2 3
Si veda il saggio di A. Matta, Memoria ufficiale, memorie vive. Usi della monumentalit, in particolare alle pp. 121-127 del presente volume. Per il sito www.deportati.it.
208
Capitolo IV
Viaggio della memoria
Primarosa Pia Il viaggio inizia l dove iniziava il loro, da quel troncone di binario, a Bolzano, candidi bagagli abbandonati a ricordare chi non tornato a recuperarli... poi il confine, verde paesaggio daprile, acque tranquille, linde casette color pastello, stucchi di neve... Forse cos lEden, puoi pensare. Ma dopo quel gomito di strada tra i boschi scopri che lass puoi trovare linferno: la tua mente sa ci che trovi, ma il tuo cuore trema, i passi percorrono i passi infiniti dei dannati innocenti, due volte dannati. Lo sguardo valuta lestensione, la simmetria, lordine assoluto del disegno tragico... che ne sanno le tue scarpe morbide, il tuo maglione caldo, di quei geli, di quelle corse frenetiche battuti e incalzati dai cani... quanto sono alti questi muri per chi ridotto a unombra di se stesso? Quali lamenti e gemiti, quale disperazione, quali incrollabili speranze nascoste tra quei massi... una vita un masso... una vita un masso... una vita un masso... una vita un masso... quante lacrime, quanto sangue fra quei legni consunti... nostalgia... frustrazione... rabbia... dolore... Chi tornato non mai uscito, chi vi entra ne resta prigioniero: la vita cambia se si sa capire... esiste linferno, esiste, lho visto con i miei occhi, lho calpestato con i miei piedi, mi ha graffiato dentro la sua disperazione. Se Dio esiste deve chiedermi scusa, sta scritto su quei muri... orgoglio, coraggio, capo eretto e consapevolezza... non si esce da quel disegno, da quel destino da altri disegnato, non c via duscita dalla macchina perfetta... Espressioni smarrite, vestite di affettata indifferenza tra quei giovani, radici che mai sono state cos salde. Mio nonno... raccontano... e il loro cuore aperto come un libro molte volte letto, abiti alla moda e pensieri consueti... Come potuto accadere... Sotto la fronte scorrono immagini attuali... Come pu accadere, ragazzo... E il binario si perde in quelle gallerie di gelo, il fiato di mille e mille che non sanno riscaldare e non se ne possono andare. In viaggio con Natalino Pia e gli studenti di Moncalieri Fossoli, Bolzano, Mauthausen, Gusen, Hartheim, Ebensee 7 gennaio 1945-25 aprile 2005
Testimoni e memorie
209
Benito Puiatti nato a Prato di Pordenone nel 1923. Dopo il 1943, mentre un fratello arrestato dai nazifacisti e laltro comandante partigiano nella Divisione GL Osoppo, Benito, che studente, vive con la madre ma fa parte di una rete di assistenza e informazioni coordinata con le formazioni partigiane. Il 2 dicembre 1944 incappa in unazione di rastrellamento nel paese, in seguito alla quale incarcerato a Pordenone e Udine, da dove aggregato con altri compagni a un convoglio di un centinaio di deportati. Partito da Trieste l8 dicembre e giunto a Dachau tre giorni dopo, Benito Puiatti immatricolato con il numero 135506, quindi trasferito al sottocampo di Augsburg. Riportato a Dachau per malattia nel mese di marzo, vi rimane fino alla liberazione. Nel dopoguerra, dopo avere terminato gli studi ( ingegnere), vissuto a Torino (attualmente a Pino Torinese). La sua testimonianza stata inserita nellArchivio della Deportazione Piemontese, ed stato con Natale Pia uno dei due primi testimoni del nostro Progetto.
Ricordi di Dachau
Benito Puiatti Quanto riporter in questi appunti potr non seguire qualche volta una giusta sequenza temporale, ma ricordare dopo oltre mezzo secolo mi autorizza a sperare di essere perdonato. Stendere per queste note per me un atto di riconoscenza verso coloro che mi hanno voluto quale testimone oculare, per rendere noto quanto quella tragedia sia stata immensa e per sottolineare la necessit che essa non sia dimenticata dalle generazioni attuali e future. Sono stato preso in rastrellamento il 2 dicembre 1944 senza motivi che potessero interessare i nazifascisti. Infatti la mia adesione al movimento della Resistenza non era ancora stata sancita ufficialmente, anche se mi erano affidati compiti di informazione sulla situazione locale ai diversi gruppi operativi. Questo anche per la situazione familiare in cui mi trovavo, dopo la morte improvvisa di mio padre nel giugno precedente, larresto con carcerazione, da parte dei nazifascisti, di mio fratello maggiore nella zona di Trieste, precisamente a Ronchi dei Legionari (zona particolarmente bersagliata per la presenza di formazioni partigiane jugoslave molto attive), e con lassenza dellaltro fratello, che in qualit di comandante nellambito delle formazioni della Divisione Osoppo doveva necessariamente stare latitante senza comunicare con la famiglia (mia madre e me). Questa situazione aveva creato uno stato di tensione e paura che non mi consentivano di far partecipe mia madre delle mie intenzioni. Conosciuto per il pensiero e la posizione di mio fratello nella Divisione Osoppo, concordai con lui la mia partecipazione alla Resistenza pur continuando a vivere in famiglia, anche se questa in ultima analisi si dimostrata una scelta poco fortunata. In questa veste potei intervenire con pi autorit nellavvisare, consigliare ed equipaggiare (nei limiti concessi) le formazioni partigiane locali e in transito. Abitavo in un comune del Pordenonese1 al confine con la provincia di Treviso, al1
Prato di Pordenone.
210
Capitolo IV
lora conglobato nel Litorale Adriatico, territorio sotto il controllo delle autorit tedesche. Questa posizione geografica si prestava a puntate offensive da parte delle formazioni partigiane di diversa tendenza politica, per cui venivo a essere frequentemente contattato. Cos, per esempio, ospitai il comandante locale delle formazioni garibaldine e fortunosamente riuscii a metterlo in salvo da unimprovvisa incursione di militari tedeschi. Altre incursioni improvvise ci sono state, ma la conoscenza del luogo e il continuo contatto fra noi locali ci hanno sempre aiutato a non cadere nelle maglie dei nazifascisti. Questo fino al 2 dicembre 1944, mattina tranquilla e non in allarme per presenze o movimenti sospetti, quando improvvisamente da tutti i lati sono sbucati fascisti armati e nessuna possibilit di fuga si poteva intravedere. Nonostante lassicurazione di persone autorevoli sulla tranquillit del paese e degli abitanti, e addirittura di un ex commilitone del comandante fascista, nulla ha potuto farli recedere dal caricarci su un autocarro e, scortati da armati, proseguire in altri paesi per altri rastrellamenti. Ricordo qui, e mai dimenticher, la disperazione di mia madre che, capita la gravit del fatto, si vedeva privata dellultimo figlio ancora presente. Tentativi di fuga non erano possibili, tant che cercai un approccio con uno della scorta ma larma puntata contro mindusse a non insistere oltre. La partenza verso il carcere di Pordenone dopo un altro rastrellamento in un paese confinante avvenne verso mezzogiorno, con arrivo alle tredici. Quattro giorni dopo, incatenati come comuni delinquenti, scortati da fascisti, fummo trasferiti nel carcere di Udine. Dopo tre giorni in questo carcere, caricati in vagoni merci sprangati naturalmente dallesterno, siamo partiti per Dachau.2 Qui cominciano le tragedie: non ancora la fame, date le scorte di casa, ma, essendo in ogni vagone pi di trenta persone, la situazione igienica divent drastica sia per gli odori che per mancanza daria. Alcuni di noi furono colpiti da crisi di nervi e da svenimenti. Durante il viaggio, uno in possesso di un piccolo coltello riusc ad aprire un piccolo vano sulla testata del vagone. Uscendo da questa apertura e facendo leva sui respingenti, qualcuno, con un balzo, riuscito a raggiungere la scarpata, o meglio a fuggire, ma a uno toccata la cattiva sorte di lanciarsi mentre il vagone transitava su un ponte. Lurlo che abbiamo sentito ci ha fatto desistere da ogni altro tentativo di fuga. Al ritorno in patria abbiamo saputo che la fortuna era stata amica con alcuni, ma altri sono stati subiti ripresi. Dopo tre giorni di viaggio arrivammo a Dachau e, scortati da nazifascisti, facemmo lingresso al campo dalla porta, ora famosa, su cui campeggiava la scritta
ARBEIT MACHT FREI3
naturalmente4 infissa su un cancello di ferro ben sprangato.
2 Cfr. I. Tibaldi, Compagni di viaggio. DallItalia ai Lager nazisti. I trasporti dei deportati 1943-1945, Milano, FrancoAngeli, 1995, p. 110. Benito Puiatti, numero di matricola 135506, ha fatto parte del trasporto 109 dellelenco di Italo Tibaldi, partito da Trieste l8 dicembre 1944 e giunto a Dachau l11 dicembre 1944 dopo aver fatto sosta a Gorizia e a Udine per completare il carico di prigionieri. Il numero dei deportati compreso approssimativamente fra i 400 e i 450, di cui 100 furono caricati a Udine. Tra i 116 deportati identificati, nel 1984 ne risultavano superstiti 24. Furono assegnate matricole dal n. 135181 al 135583. Il totale dei deportati pu essere stimato intorno a 403, di cui circa un centinaio caricati a Udine. 3 Il lavoro rende liberi, scritta che si trova allingresso di molti campi di concentramento, fra cui Dachau e Auschwitz I (campo principale). 4 In questo avverbio si rileva una traccia del distacco ironico tipico del nostro testimone, che coglie il grottesco della situazione: la parola libero allingresso di un luogo di prigionia. Naturale associazione per i nazisti
Testimoni e memorie
211
Il nostro convoglio era costituito di circa 150 prigionieri tutti italiani.5 Subito abbiamo avuto la sensazione che la tragedia in cui eravamo coinvolti fosse pi grande di ogni immaginazione. Parecchi carri trainati da cavalli portavano casse accatastate disordinatamente non chiuse e, data la loro posizione sui carri, contenenti, come si poteva intuire, pi corpi in ognuna.6 A questi seguivano altri carri equipaggiati con bandine laterali: dalla parte posteriore penzolavano gambe, braccia, teste e altre parti del corpo. Ma la magrezza di quegli arti e il colore grigiastro di quei corpi, seppure visti da un paio di decine di metri di distanza, davano da dubitare che fossero morti recenti. A noi appena arrivati, in attesa di inoltro e di immatricolazione, ancora con la presenza dei fascisti,7 venivano impartiti ordini incomprensibili e comandi a suon di scudisciate da parte di una SS che in bicicletta si divertiva a intrufolarsi fra noi. Se poi qualcuno accennava a un bench minimo gesto di difesa quello si accaniva con un sadismo incomprensibile, credo, non solo a noi appena arrivati. Questo dur circa due ore, con un po di tranquillit quando quella SS se ne and. Finalmente cominci un controllo e limmatricolazione. Attraverso un percorso ben delimitato allinterno di una baracca in prossimit dellentrata siamo stati spogliati di tutto (vestiti, biancheria intima, portafogli e ogni altro oggetto personale) e, nudi, introdotti nella sala docce, che visto laspetto tetro sembrava veramente una sala di morte (si saputo poi che era stata approvata come camera a gas ma mai usata perch considerata non idonea e sostituita da altre pi adatte e anche queste usate solo per il collaudo). Usciti allesterno, nudi naturalmente, hanno proceduto alla disinfezione (a base di creosoto), quindi alla consegna di indumenti e siamo stati avviati alle baracche per lalloggiamento. Faccio presente che i miei indumenti consistevano in una camicia che copriva appena lombelico e in un paio di pantaloni (forse mutande), mentre fui in grado di tenermi le scarpe e un paio di calze. Le baracche (Blcke), suddivise in due coppie di stanze (Stuben) equipaggiate ognuna con posti letto su tre piani a castello per una capienza di 70-80, forse 100 persone, ospitavano in quel periodo circa 250 prigionieri. I servizi consistevano in due file di circa dieci WC ognuna e un locale con due lavabo del diametro di circa un metro e mezzo, capaci di accogliere da 10 a 15 persone in tutto per una rinfrescata appena possibile. Tutti noi del paese arrivati a Dachau (alcuni furono avviati ad altri campi) fummo alloggiati nella baracca 17, Block 1, Stube 1. Qui la vita fu abbastanza tranquilla almeno per noi della prima Stube; infatti il capo Stube (austriaco internato fin dal 1934 per motivi politici e con numero di matricola 8) fu prodigo di consigli e suggerimenti e attuava quegli accorgimenti che attenuavano i gravi disagi e spesso facevano risparmiare punizioni talvolta gravi. Lappello al mattino, contemporaneo alla pulizia delle stanze, eseguito allesterno in presenza di SS, impiegava circa due ore, e sempre a petto nudo (da non dimenticare che labbigliamento personale era in linea di massima per tutti come il mio); il controllo pidocchi che lo seguiva prolungava non poco quella permanenza. Questo controllo poi, eseguito dalle SS, anche se preventivamente attuato dagli internati, considerata la si-
5 6 7
Cfr. supra, nota 2. La discordanza si pu spiegare con il fatto che Puiatti circoscrive losservazione al gruppo proveniente da Udine. Cadaveri dei prigionieri deceduti nei Kommando pi vicini erano portati in questo modo al campo per la cremazione. Dettaglio importante, raro nella memorialistica della deportazione.
212
Capitolo IV
tuazione generale, portava quasi sicuramente a un esito positivo e, come effetto, a unulteriore permanenza allesterno condita con numerose vergate. La conseguenza era che il punito veniva ricoverato in infermeria, depennato dalla lista della Stube e inviato nel Block di rigore. Del nostro gruppo uno (Gabriele Puiatti) sub tale trattamento, ma linteressamento del capo Stube lo riport da noi. Questo periodo che, secondo la prassi, era lattesa di richiesta di manodopera da parte dei sottocampi di Dachau, termin l8 gennaio 1945 con linvio al sottocampo di Augsburg.8 Prima della partenza ci fu consegnata la classica divisa dei Lager: pantaloni, giacchino e cappotto a righe grigie e azzurre e nessuna biancheria. Il trasporto fu attuato con camion senza nessuna protezione e alcuni gi debilitati da un lungo digiuno, colpiti da infiammazioni alle vie respiratorie, furono ricoverati in infermeria; due del nostro gruppo non sono stati inseriti nei turni di lavoro. Ad Augsburg fummo alloggiati in due capannoni della capienza di circa 1.500 prigionieri e subito furono stabiliti i turni di lavoro. Con pochi conoscenti fui assegnato al turno notturno (dalle 18 alle 6). E comincia cos la tragedia per tutti noi (posso dire per noi del turno notturno, ma non fu molto diversa per gli assegnati al turno di giorno). La sveglia alle 14.30 era linizio della tortura che si protraeva fino alle 9.30 del mattino successivo. Prima fase lappello, allesterno del capannone, che veniva attuato a furia di scudisciate, calci e pugni, pi che a chiamata. Di norma luscita dal campo avveniva per il tramite di un cancello secondario troppo stretto per consentire il passaggio di cinque uomini allineati. Pertanto chi anticipava era colpito da SS poste allesterno, gli altri invece subivano lo stesso trattamento dalle SS allinterno del cancello. Unica possibilit di passare indenni era quella di mettersi al centro di tre prigionieri. Se poi ci avviavamo alluscita principale, ci era solo perch alcuni corpi penzolavano dalle traverse e a noi non era concesso piegare il capo per non sbattere contro i piedi di quei poveri impiccati. Durante il percorso per raggiungere il posto di lavoro, tre ore circa,9 scortati da SS, cani particolarmente addestrati erano sempre l, pronti ad azzannare chiunque sporgesse minimamente dalla colonna. Particolarmente tragici erano questi trasferimenti, sia per lo sforzo necessario per continuare il cammino, sia per le sofferenze causate dalla dissenteria e dalla perdita di liquido organico che trasformava i pantaloni in una lastra di ghiaccio, e per le percosse che questi mostri di sadismo infliggevano in continuazione. Se poi capitava che qualcuno stremato dai patimenti finiva disteso a terra, intralciando il normale avanzamento della colonna, alle solite percosse si aggiungevano i morsi dei cani che terminavano solo con la ripresa del cammino di quel disgraziato. Quasi sempre per il prigioniero non era pi in grado di camminare e veniva raccolto dal carro che seguiva la colonna, da noi chiamato raccolta cadaveri. Lunica solidariet fra noi consisteva nel mettere in posizione intermedia nel grup-
Augsburg (Augusta) una cittadina tedesca che dista circa 30 km da Dachau. Vi si trovavano alcuni Kommando di lavoro dipendenti da Dachau; il sottocampo di cui parla lautore quello di Augsburg-Pfersee, come si ricava dal documento Arolsen della Croce Rossa Internazionale, i cui deportati producevano, in una fabbrica a circa 10 km di distanza, componenti di aerei per lindustria bellica Messerschmitt. Il numero di detenuti era mediamente di 1.500. Se consideriamo una permanenza media di 5 mesi, durante i suoi 38 mesi di esistenza (dal 14.2.1942 al 14.4.1945), ospit, secondo un nostro calcolo, circa 11.000 deportati. I sottocampi di Dachau furono 169. 9 Nellintervista realizzata per lArchivio della Deportazione Piemontese lautore parla di una distanza di circa 10-12 chilometri fra il campo e i capannoni della Messerschmitt.
Testimoni e memorie
213
po dei cinque quello che sembrava il pi debole. Il freddo poi contribuiva non poco a peggiorare la situazione. C da tener presente che al corredo assegnatoci mancavano calze e scarpe. Le prime sostituite con pezzi di stoffa non sufficienti a coprire tutto il piede; le seconde costituite da un paio di zoccoli che aperti posteriormente non riparavano molto dal freddo pungente di quei luoghi in quella stagione. Laccorgimento di difesa adottato, per chi ci riusciva, consisteva nellasportare del grasso dal mozzo dei carrelli interni alla fabbrica e spalmarlo sui piedi (il grasso, nero per luso, finiva per rendere dello stesso colore la pelle dei piedi). Il lavoro anche se in ambiente riparato, richiedeva uno spreco di energie che non veniva certamente compensato dalle razioni di cibo giornaliero. Questo infatti consisteva in circa 120 grammi di pane, 15-20 grammi di margarina o salame, un litro di brodo di rape o altre verdure simili e una tazza di t al mattino. In pi cerano i bombardamenti aerei che non permettevano quelle poche ore di sonno che restavano a completare la giornata. Durante le ore di lavoro, alle SS si aggiungeva il fanatismo dei sorveglianti civili che pretendevano il massimo rendimento quantitativo e qualitativo, da noi ormai miseri esseri dalla parvenza umana. S, perch facendo unanalisi della nostra giornata risultavano: - dodici ore di lavoro; - sei di cammino; - due per appelli e controlli; - vitto insufficiente; - tempo necessario per raggiungere il rifugio in caso di allarmi; - dosi abbondanti di colpi inferti con somma ferocia; - quasi nessun riposo. Credo che un uomo non possa durare a lungo, anche nella pienezza della sua integrit fisica, in una simile situazione: polmoniti, pleuriti, tubercolosi, infezioni conseguenti a ferite, inferte anche volontariamente, erano malattie assai gradite per sottrarsi a un tale inferno. La dissenteria e la perdita di liquidi organici con tutte le conseguenze immaginabili erano calamit assai temute poich in pochi giorni portavano il prigioniero alla fine dei suoi patimenti. E anche a me successo! Colpito fortunatamente da pleurite con conseguente innalzamento della temperatura, mi presentai alla visita medica. E qui incappai in una SS che con evidente manifestazione di gioia cominci a colpirmi con calci, pugni e vergate con lintento di farmi desistere dallentrare in infermeria. Il medico di turno con una decisione quasi incosciente, viste le mie condizioni, sintromise per togliermi da quel pestaggio, ma la SS era in attesa probabilmente di un mio ritorno; il medico per decret il mio ricovero. L incontrai uno del paese che non mi riconobbe! Lo stupore mi port a rispecchiarmi sul retro di una porta. Capii perch non ero stato riconosciuto: io stesso non vedevo pi in quellessere magro, senza capelli, quello che ero pochi mesi prima. Le condizioni igieniche, lodore di cadavere che impregnava tutto lambiente, la sporcizia, il caos imperante, questo era linfermeria. Il riposo per miglior la mia situazione fisica e psichica anche se il ricordo della mia immagine riflessa dal vetro mi port alla realt e alla conclusione (per fortuna errata) che mai sarei uscito da quellinferno. Infatti il peso controllato al momento del ricovero (35 kg circa), la pleurite minacciante Tbc, il cuore affaticato con battito aortico (diagnosticato successivamente come aneurisma), la possibilit di ripresa nulla visto il tipo di alimentazione, davano
214
Capitolo IV
come sola possibilit di miglioramento la fine immediata della guerra. E qui lo sconforto fu talmente grande che pi nulla minteressava. Attendevo solo la fine, convinto che non ci fosse altra prospettiva per me! Ecco per che un piccolo miracolo si presenta sotto forma dellarrivo di mio cugino, Carlo Puiatti, preso con me, il quale mi port la lieta notizia che i ricoverati sarebbero stati trasferiti al campo base di Dachau. Cos avvenne infatti il 20 marzo 1945. Anche se il trasporto fu come allandata, noi eravamo convinti di arrivare in un autentico Eden. Forse un po lo fu. I sospetti Tbc godevano di un trattamento particolare: vitto pi abbondante, minestre pi sostanziose e nessuna violenza. Purtroppo per me questo dur molto poco poich al controllo medico fui dimesso e mandato al Block 19. Qui eravamo alla merc di uno di quei famigerati Kapo, che per acquisire meriti dalle SS era particolarmente crudele nelle punizioni che somministrava: eravamo continuamente picchiati nudi allaperto, legati ai pali e picchiati. Se poi uno veniva preso di mira, per quello era segnata una fine atroce. Nonostante questo il pericolo di morte era minore che ad Augsburg, purch si adottassero certe precauzioni: non incontrare il Kapo, dormire in stato di allerta per non essere considerati morti e accatastati in lettighe con altri cadaveri avviati ai forni crematori, non chiedere n medicine n il ricovero in infermeria, perch si veniva prelevati e curati, correva voce, con iniezioni di petrolio. In ultimo poi, sperare di non essere incluso in qualche trasporto. Si saputo da Radio Campo che un trasporto di prigionieri (2.000-3.000), sembra russi, equipaggiati per una lunga trasferta, non lontano dal campo fu passato per le armi e i cadaveri sepolti in fosse comuni. Se lesistenza era pi tranquilla e meno faticosa, per la mancanza delle ore di lavoro e di cammino, i pericoli di morte erano pi presenti. Leliminazione fisica a Dachau, anche se meno appariscente, era pi reale per queste improvvise svolte della sorte. Ritengo che la politica fosse quella di sfruttare lindividuo sino alla fine delle sue possibilit, rimandandolo poi al campo base per una eliminazione meno appariscente. cos che le SS costruivano i Kapo, quali bastoni per distruggere le ultime risorse fisiche del prigioniero ed eliminarlo in modo pi tecnico. In questo periodo (dalla data del rientro al campo base di Dachau, dal 20 marzo al 10-12 aprile) vissi nel modo pi anonimo possibile, non mettendomi in vista neppure per la stecca (eventuale aggiunta di minestra). Finalmente alcuni avvenimenti e la solita voce di Radio Campo hanno fatto nascere la speranza di una vicina fine dellinferno. I fatti: - sostituzione delle SS con militari della Wehrmacht, miglioramento nella qualit e anche quantit del vitto, meno controlli, sparizione di alcuni Kapo, e naturalmente Radio Campo che dava per certo larrivo degli americani entro aprile; - un mirato bombardamento aereo alla sola stazione ferroviaria (contrariamente a quelli a tappeto che distrussero Monaco e a quelli che subimmo ad Augsburg); - un bombardamento indefinito, come un rimbombo, ha fatto dedurre che ci fosse un cannoneggiamento, pertanto lesercito americano doveva essere molto vicino; - un forte frastuono di autocarri (forse), considerato, con un raziocinio tutto speranzoso, come una puntata di carri armati. Fatti, questi, che fortunatamente furono ben interpretati. Poi finalmente una motocarrozzetta con tre uomini armati, di cui uno posizionato in modo particolare, che
Testimoni e memorie
215
fatto il periplo del campo usc senza colpo ferire. La perplessit di tutti noi era evidente in quanto molti avevano riconosciuto militari americani. La certezza di alcuni port la speranza a tutti e la gioia della libert. Il terrore per di una rappresaglia aleggiava un po dappertutto (da non dimenticare il telegramma di Himmler che ordinava la distruzione col fuoco di tutto il campo), ma la gioia per quanto visto ci rendeva imprudenti fino allincoscienza. Ormai la tragedia stava per finire. Dopo poche ore, circondato il campo dai carri armati, avvenne la resa dei militari preposti alla sorveglianza e lentrata dei liberatori. Era il 29 aprile 1945, ore 16 circa. Cosa dire ora? La guerra finita!!! Linferno terminato!!! La fame passer!!! Il ritorno vicino!!! La nostra gioia era immensa, ma immensa era anche lincredulit sui volti dei liberatori nel vedere quelle mostruosit. Mi ricordo di due americani che, circondati dalla folla, a un certo momento mi si pararono davanti e guardandomi mi chiesero (meglio mi fecero segno) di aprire la camicia e non seppero cosa dire nel guardare la mia magrezza. Quelle ore non le dimenticher mai, non solo per aver avuto salva la vita, ma anche per aver capito che il passato era finito. Quanto successe nei giorni seguenti comprensibile solo pensando a quanto noi avevamo sofferto. Il capo del campo appeso a testa in gi ad altezza duomo al cancello dentrata sotto i colpi dei liberati, immagino fino alla morte. La ricerca per una meritata punizione dei Kapo, che spesso, ma inutilmente, cercavano di confondersi in mezzo alla confusione. Molti forse saranno riusciti nellintento, ma altri seguirono senzaltro la sorte delle SS che ancora si trovavano nei loro alloggiamenti. Aggiungo qui che la sera stessa della liberazione, presa coscienza della situazione, gli americani fecero distribuire una scatola di carne a tutti (circa 30.000) e una sostanziosa minestra di semolino. E questa stata veramente la dimostrazione della nostra salvezza e della potenza dellAmerica. La fine di una guerra comporta sempre linizio di unaltra epoca, ma qui lepoca nuova era la necessit di riconquistare lintegrit fisica e psichica. Alcuni per, troppi, ormai stremati dalle sofferenze, non riuscirono a superare questo repentino cambiamento. La fine li accolse almeno con la gioia nel cuore! Il controllo sanitario per tutti e la disinfezione, sia pur superficiale, del campo furono subito attuati per eliminare latenti epidemie. Qui per me ci fu un periodo di crisi, sia per la recrudescenza della pleurite sia per uninfezione alla gola (angina) che dai primi di maggio si protrasse oltre la met di giugno (18-20). Ma il trasferimento in un altro ambiente (caserme tedesche adattate a ospedale) e le cure di medici e infermieri altamente professionali mi hanno aiutato a riprendere le forze e permesso il rientro in patria. Questo avvenne per me il 25 giugno con larrivo a Bolzano e il 28 finalmente nella mia casa natale. Devo aggiungere che il mio ritorno fu traumatizzante per tutta la gente del paese, perch, pur essendo stato preceduto da un prigioniero dello stesso campo, ero il primo esempio di quanto avevano sopportato i deportati in quei campi. Infine arrivarono le notizie riguardanti gli altri rastrellati:
216
Capitolo IV
- due deceduti ad Augsburg: Turiani Cesare (cl. 1914) e Pezzutto Giovanni (cl. 1925); - uno, sembra, deceduto a Buchenwald: Puiatti Ivo (cl. 1924); - uno disperso: Puiatti Carlo (cl. 1928); - e, crudelt della sorte, uno arrivato allospedale di Pordenone alle ore 2 del 2 agosto 1945, deceduto alle ore 14 dello stesso giorno: Puiatti Carlo (cl.1923); - infine i ritornati: Puiatti Gabriele (cl. 1920), Rosolen Bruno (cl. 1922), Rosolen Antonio (cl. 1923), Corazza Luigi (cl. 1926), Pezzutto Mario (cl.1928), Miccio Lauro (cl. 1923), Miccio Lucio (cl.1924), Puiatti Benito (cl. 1923). Quali insegnamenti si possono trarre da simili tragici eventi? Molto tempo passato prima che io mi decidessi a ritornare in quei luoghi, e poco amavo parlarne, perch raccontare tali avvenimenti mi portava a uno stato di nervosismo e commozione che solo dopo alcuni giorni riuscivo a superare. Ma dopo un primo ritorno sono un po cambiato, e qualche volta riuscivo a dire pi di quanto io stesso pensavo. Questo ritorno10 poi mi ha molto rafforzato nellidea che fosse utile, istruttivo e necessario trasmettere questa esperienza e far conoscere alle generazioni attuali e future come luomo pu trasformarsi di fronte a ideologie che stravolgono il senso del rispetto e dei diritti delluomo: e ogni nostra azione deve tendere a che questo non avvenga mai pi.
10
Quello del viaggio del Progetto Memoria a Mauthausen e a Dachau del 1998 (si veda Capitolo I 1, Lo sterminio attraverso il lavoro).
Benito Puiatti durante la visita a Mauthausen (aprile 1998)
Testimoni e memorie
217
Antonio Temporini, nato a Castellazzo Bormida (Alessandria) nel 1922, ha abitato a Moncalieri nel dopoguerra, fino alla morte avvenuta nel 2001. Di lui abbiamo riportato nel precedente volume1 unintervista che non riprendiamo perch per il nuovo libro preferiamo attenerci alle sole testimonianze di superstiti accompagnatori nei viaggi di studio. Affidiamo per alla moglie, Luisa Bonelli, questa breve testimonianza da lei letta a Moncalieri nel Giorno della Memoria 2002. Militare di leva, sorpreso in Veneto dagli eventi dell8 settembre, arrestato pochi giorni dopo, rinchiuso a Peschiera del Garda e deportato il 20 settembre a Dachau. Immatricolato con il numero 53899, viene per trasferito insieme a 61 compagni dello stesso convoglio al Lager di Sachsenhausen il 23 ottobre. Qui sar nuovamente immatricolato con il numero 72496. difficile seguire, anche per mancanza di riscontri documentari, una serie di spostamenti, in genere temporanei, in altri Lager, quali risultano dalla testimonianza resa nel 1984 per lArchivio della Deportazione Piemontese. Rientrato a Sachsenhausen, liberato durante la marcia di evacuazione del campo.
Sono stato prigioniero e bon. Ricordo di Antonio Temporini
Luisa Bonelli Oggi, essendo la Giornata della Memoria, voglio parlarvi di Temporini Antonio, mancato il 18 aprile 2001, deportato politico, arrestato nei pressi di Peschiera del Garda, inviato a Dachau il 25 settembre 1943 (n. di matricola 53899) e liberato l8 maggio 1945. La sua frase pi ricorrente era: Raccontare poco non era giusto. Raccontare il vero, non si era creduti. Allora ho evitato di raccontare. Sono stato prigioniero e bon. Era una frase vera.2 Lui non ha veramente mai raccontato le sue sofferenze, solo dopo essere stato cercato dalle scuole ha detto cose ai ragazzi perch capissero che la guerra era una cosa sbagliata. Infatti i suoi racconti pi dolorosi erano raccontati alla moglie, come uno scambio consolidato. Neanche ai figli, per non fargli ereditare dolori e disagi. Gli sembrava un impegno troppo pesante, per una fragilit che perdura. Ma ora la moglie che vuole raccontare un aneddoto che lui non ha mai detto ai ragazzi delle scuole. Un giorno, portando un pentolone vuoto nella cucina, con un giovane ragazzo, un soldato tedesco disse al giovane: Tu napoletano! Canta O sole mio; lo fecero salire su una cassa, e il ragazzo, anche se non sapeva e non poteva cantare per le condizioni di degrado e di fame, fu obbligato. Era giovane e bello, e loro gli diedero una spinta e lo fecero cadere dentro il pentolone sul fuoco, che bolliva, e mor.
L. Monaco / G. Pernechele (curr.), Percorsi di memoria cit., pp. 75-81. La frase si trova anche nellintervista effettuata da Lilia Davite il 24 febbraio 1984 nellambito della ricerca dellArchivio della Deportazione Piemontese. Cfr. A. Bravo / D. Jalla (curr.), La vita offesa, Milano, FrancoAngeli, 1986, p. 57.
2
218
Capitolo IV
Temporini, quando ricordava questo episodio, piangeva come un bambino. Per queste cose e tante altre la moglie vuole ricordare Temporini Antonio, bravo marito, padre esemplare. E si sentiva nei pochi racconti fatti ai ragazzi con il luccichio negli occhi, da cui Antonio ancora oggi aspettava una parola di conforto, un poveretto di cui qualcuno sarebbe gi stato contento. E sono giuste le frasi dette da Primo Levi: Meditate che questo stato: / Vi comando queste parole. / Scolpitele nel vostro cuore / Stando in casa andando per via, / Coricandovi alzandovi: / Ripetetele ai vostri figli.
Da Moncalieri ai Lager nazisti: i deportati moncalieresi
Lucio Monaco Tra il 1944 e il 1945 furono deportati in Lager quattro moncalieresi. Per tutti la destinazione fu il campo di Mauthausen; tre di loro non sopravvissero. In queste quattro storie si trovano riassunti gli aspetti pi significativi della deportazione politica (non legata, cio, alle dottrine razzistiche nazifasciste) nellarea piemontese: la lotta nelle fabbriche specialmente la settimana di scioperi del marzo 19441 e la guerra partigiana. I primi due deportati Michele Sandrone e Pietro Paolo Bertoglio furono arrestati rispettivamente il 3 e il 4 marzo 1944, dopo i primi giorni di sciopero. I materiali a disposizione per ricostruire la dinamica degli arresti sono pochi. Di Michele Sandrone, nato a Moncalieri nel 1916, si sa che lavorava alla Fiat-Materiale Ferroviario: essendo stato arrestato fra i primi possiamo forse dedurre che era stato individuato come uno degli organizzatori dellagitazione. Pietro Paolo Bertoglio, gi operaio calderaio alle Officine di Savigliano (sua citt natale, da dove si era trasferito, trentenne, a Moncalieri nel 1934) e poi alla Fiat (ma al momento dellarresto lavorava in unaltra fabbrica), figurava da molti anni fra gli antifascisti sovversivi segnalati dalla polizia del regime. La sua avversione al fascismo aveva radici lontane essendo stato vittima di azioni squadriste anni prima e costitu certo una ragione sufficiente per inserirlo nelle liste compilate dalla polizia (fascista) dopo il comunicato del capo della provincia, Zerbino, che fin dal 1 marzo 1944 aveva minacciato, fra le altre misure repressive, anche la deportazione. Incarcerati alle Nuove, Sandrone e Bertoglio (del secondo sappiamo, per testimonianza dei famigliari, che non gli era stato consentito di incontrare la moglie in carcere) partirono il 6 marzo 1944 per Verona. Qui, insieme con unottantina di compagni, furono poi caricati su un treno proveniente da Firenze, via Fossoli. Il convoglio, che in tutto assommava a 597 deportati, arriv a Mauthausen l11 marzo. I prigionieri, immatricolati dal n. 56885 al 57481, furono avviati dopo la cosiddetta quarantena
1 Per la ricostruzione e lanalisi degli scioperi del marzo 1944 si vedano soprattutto il saggio di C. Dellavalle nel volume Gli scioperi del marzo 1944, Milano, FrancoAngeli, 1986, pp. 21-40 (raccolta degli interventi alla Tavola rotonda tenutasi a Torino, presso il Centro incontri della Cassa di risparmio, il 17 marzo 1984), e quello di L. Klinkhammer, Loccupazione tedesca in Italia 1943-1945, trad. it. di G. Sajia Panzieri, Torino, Bollati Boringhieri, 1993, pp. 212 sgg.
Testimoni e memorie
219
ai vari sottocampi di Mauthausen, nei quali il sistema nazista aveva distribuito una complessa e avanzata rete di produzione bellica a opera dei deportati-schiavi (realizzando cos il previsto sterminio attraverso il lavoro, o Vernichtung durch Arbeit, caratteristico di questa fase della storia dei Lager). Dalla certificazione della Croce Rossa Internazionale si ricava che Pietro Paolo Bertoglio (matricola 56955) fu trasferito il 25 marzo a Ebensee: qui erano appena stati aperti i cantieri di un nuovo insieme di tunnel, il Kleine Steinbruch, ci che richiedeva un aumento dellorganico di lavoratori-schiavi. Il loro numero sal rapidamente a pi di 10.000, con tassi elevatissimi di mortalit a causa del trattamento disumano. Il 17 febbraio del 1945 Bertoglio risulta trasferito al sottocampo di Gusen altro luogo di lavoro schiavile e di morte dove per decedeva meno di un mese dopo, il 12 marzo. Anche Gusen era diventato un campo enorme, con migliaia di prigionieri (15.000 nel 1945) e una mortalit molto alta (9.000 nello stesso periodo, senza contare i decessi immediatamente successivi alla liberazione). Sul registro dei morti di quel periodo il decesso, avvenuto alle 6.20, attribuito a debolezza cardiaca e deperimento generale. Di Michele Sandrone (matricola n. 57392) certo il trasferimento a Gusen, ma non si conoscono (allo stato attuale delle ricerche) dettagli pi precisi. Anche a lui tocc di morire in questo sottocampo il 30 marzo 1945, a poco pi di un mese dalla liberazione. La stessa sorte sub almeno il 60% dei 597 deportati giunti a Mauthausen l11 marzo 1944 (ricerche quantitative pi precise sono ancora in corso). Gli altri due deportati moncalieresi, Rinaldo Sattanino (1926-1945) e Orfeo Mazzoni (1924-1998), furono arrestati nellambito della loro militanza partigiana ma in tempi e luoghi diversi, anche se poi sarebbero stati accomunati dallo stesso trasporto diretto a Mauthausen. Rinaldo Sattanino (Nando), diciottenne, entra nella IX Divisione di Giustizia e Libert, Brigata Tamietti (operante nellAstigiano), nel giugno del 1944; catturato a fine estate con altri compagni nella zona di Villafranca, viene portato a Torino, in Via Asti e quindi alle Carceri Nuove, dove rimane fino al 14 dicembre. In questa data viene deportato, insieme ad altri prigionieri, al campo di concentramento e transito di Bolzano. Qui resta fino al trasferimento a Mauthausen, con un convoglio ferroviario di circa 500 deportati, partito da Bolzano l8 gennaio 1945 e giunto a Mauthausen l11 gennaio. Anche Sattanino, che ha dichiarato la qualifica professionale di tornitore, dopo il periodo di cosiddetta quarantena inviato (il 1 febbraio) al lavoro forzato nel sottocampo di Gusen, dove muore il 19 aprile 1945. Era stato immatricolato con il n. 115713. Suo compagno di trasporto e di deportazione stato Orfeo Mazzoni, combattente nella V e poi nella XV Brigata Garibaldi, arrestato in Val Varaita nellottobre 1944, in concomitanza con leccidio di Masueria.2 Imprigionato prima a Saluzzo e
Per maggiori dettagli sulleccidio di Masueria si veda La pagina. Dentro i fatti del Saluzzese, a. XI n. 38/304 (1989), che riporta un racconto di Orfeo Mazzoni.
220
Capitolo IV
poi alle Nuove di Torino, segue la sorte di Sattanino a Bolzano (dove fallisce un tentativo di fuga collettiva, tramite un cunicolo scavato sotto la baracca) e quindi a Mauthausen (matricola n. 115610). Dopo un breve trasferimento a Grein, il 20 febbraio assegnato al sottocampo di Gusen e vi rimane fino alla liberazione. Per anni insegnanti e studenti di Moncalieri hanno potuto ascoltare la sua appassionata e sofferta testimonianza, che ha lasciato un segno profondo in chi lo ha conosciuto. Una sua testimonianza si trova depositata anche presso lArchivio della Deportazione Piemontese. Si ricorda infine il gi citato Antonio Temporini, moncalierese di adozione (allepoca residente nellAlessandrino), deportato il 29 settembre 1943 da Peschiera a Dachau, con il primo grande convoglio di massa di deportati italiani (circa 1.800 persone). Immatricolato con il n. 53899, fu successivamente trasferito a SachsenhausenOranienburg (matricola 72496) e in altri sottocampi fino alla liberazione (maggio 1945). Su questa sua vicenda, fra le pi lunghe nella storia della deportazione italiana,3 Temporini ha lasciato testimonianza nellArchivio della Deportazione Piemontese e in incontri con gli studenti di alcune Scuole di Moncalieri.* Alla memoria di Bertoglio, Sandrone e Sattanino stata scoperta una lapide commemorativa, posta nellatrio del Palazzo Comunale di Moncalieri, il 25 aprile 2001. Vi sono riportate le seguenti parole: Meditate che questo stato (Primo Levi) Pietro Paolo Bertoglio 1894 12.3.1945 Mauthausen Michele Sandrone 1916 30.3.1945 Mauthausen Rinaldo Sattanino 1926 19.4.1945 Mauthausen
Sulla deportazione dal Piemonte e sullArchivio della Deportazione Piemontese, cfr. fra laltro il saggio gi pi volte citato di A. Bravo e D. Jalla, La vita offesa. Storia e memoria dei Lager nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti, Milano, FrancoAngeli, 1986. Si veda anche E. Occhiena (cur.), Moncalieri ricorda, Moncalieri, 1988, pp. 82-83. * Si ringraziano le famiglie Bertoglio-Calabrese, Mazzoni, Sattanino e Temporini.
Testimoni e memorie
221
Adriano Sattanino, che vive a Moncalieri, fratello di Rinaldo. Ha partecipato ai viaggi del Progetto Memoria del 2005 e del 2006. Nellultimo quello a Buchenwald e Dora stato accompagnato dalla nuora Nadia e dalla nipote Francesca, e ha cominciato a parlare, ricordando la vita e la figura del fratello Rinaldo, morto partigiano a Mauthausen. I suoi ricordi sono stati raccolti nellintervista che riportiamo qui sotto.
Un ragazzo di Borgo San Pietro
Elisa Armentaro, Alessandra Gardino (I.I.S. Majorana Sezione Scientifica) In occasione del viaggio del Progetto Memoria a Buchenwald e Dora nel marzo 2006, abbiamo realizzato unintervista ad Adriano Sattanino, fratello di Rinaldo, uno dei quattro moncalieresi deportati nei campi di concentramento nazifascisti. Lo scopo del nostro breve lavoro quello di indagare sulla storia delle famiglie dei deportati per capire il contesto socio-culturale che ha influenzato un ragazzo per cos dire qualsiasi, portandolo alla scelta di diventare partigiano e opporsi al fascismo: per questo abbiamo ascoltato la parola di Adriano che, attraverso la sua testimonianza di secondo grado, ci ha aiutato a ricostruire il panorama che si mostrava agli occhi di un bambino di nove anni durante la Resistenza. Alla richiesta di parlarci di suo fratello Adriano ci racconta, con un po di timidezza, che Rinaldo nasce nel 1926 a Moncalieri, in Borgo San Pietro, dove pi tardi trova lavoro in una fabbrica di tornitori. Dopo l8 settembre viene chiamato sotto le armi, ma diserta e si rifugia nellAstigiano da una zia, a Bricco Barrano, per poi spostarsi da unaltra a Tigliole. La situazione per lui si fa difficile perch i fascisti repubblicani di Sal bruciano le cascine di chi nasconde i disertori; quindi Rinaldo, sentite le voci di diversi gruppi organizzati, si unisce ai partigiani di Asti. Pi precisamente, grazie alla documentazione fornitaci da Adriano, possiamo ricostruire che Rinaldo, con il nome di battaglia Nando, entra nella IX Divisione GL (Giustizia e Libert), Brigata Tamietti, il 1 giugno 1944.1 Nellestate del 1944, tra il giugno e il luglio, Adriano lo va a trovare ma non viene a conoscenza dei contatti del fratello, che non gli d informazioni sulle sue recenti scelte. Rinaldo combatte con i suoi compagni e nel novembre 44 catturato durante un rastrellamento di partigiani a Ferrere dAsti, vicino a Villafranca; prima detenuto
La IX Divisione GL agiva nella zona dellAstigiano, tra il Monferrato e il Chierese. Comprendeva tre brigate, tra cui appunto la Domenico Tamietti, poi ridotte a due, e contava tra i 590 e gli 800 combattenti, allepoca di Rinaldo male armati. Parteciper alla liberazione di Torino (cfr. Le formazioni GL nella Resistenza, a cura di G. De Luna et alii, Milano, FrancoAngeli, 1985, pp. 406-7). Non abbiamo rintracciato dati su Rinaldo Sattanino nella Banca Dati del partigianato piemontese (www.istoreto.it, ultimo nostro accesso ottobre 2006); pertanto le nostre informazioni risalgono al documento n. 4280, in data 11.4.1946, del Ministero dellAssistenza postbellica / Commissione regionale piemontese per la qualifica di partigiano. In tale documento, basato sul foglio notizie, su testimonianze dei membri delle Formazioni partigiane in questione, e su altri accertamenti, si dichiara la qualifica di partigiano caduto appartenente alla XI Div. GL Brigata Tamietti (ma XI errore di battuta per IX) dal 1.6.1944 al 15.4.1945. Probabilmente 15 sta per 19, data della morte a Gusen. La famiglia possiede anche il Brevetto di Partigiano caduto, n. 021350, del 25.4.1945, in cui il nome scritto in modo errato (Sottanino).
222
Capitolo IV
in Via Asti a Torino, viene poi portato alle Carceri Nuove. Qui riceve i pacchi di vestiti e cibo portatigli dal padre, che non ha per il permesso di vederlo; pacchi che dopo un breve periodo sono rimandati indietro alla famiglia, cui la direzione del carcere comunica che Rinaldo stato mandato in Germania a lavorare; si perde quindi ogni sua traccia. In realt, a dicembre, Rinaldo viene caricato sul trasporto per Bolzano e nel gennaio 45 parte per Gusen.2 Altri percorsi che sintrecciano, in modo significativo per noi del Progetto Memoria: nello stesso trasporto di Natalino Pia e Orfeo Mazzoni il quale, essendo suo vicino di casa, lo riconosce e tempo dopo testimonier alla famiglia di aver perso sue notizie allarrivo nel campo. I parenti perdono completamente le sue tracce e per un anno Rinaldo viene considerato disperso, anche se i documenti della Commissione regionale piemontese per la qualifica di partigiano lo considerano caduto; le ricerche dei famigliari continuano, chiedendo informazioni anche ad altri deportati: uno di questi, che Adriano non riuscir mai a incontrare, rilascia a Roma la testimonianza di aver visto Rinaldo morire. La notizia della morte giunge ai famigliari circa un anno dopo, attraverso lUfficio di ricerca delle persone scomparse di Arolsen, che venuto in possesso dei documenti ufficiali del campo centrale di Gusen attestanti la morte del giovane Sattanino il 19.04.45 per dissenteria.3 Ricostruiti gli ultimi mesi di vita di Rinaldo, Adriano ci ha raccontato che la sua testimonianza iniziata entrando a far parte dellANED4 e visitando i campi di concentramento: la sua prima visita a Gusen stata infatti in occasione del ventennale della Liberazione (1965) con gli ex deportati Bolognesi, Calosso e Goria che portavano le corone commemorative della Fiat. Lo spettacolo che gli si manifesta allora quello di un campo in cui sono ancora presenti le baracche e il forno crematorio in muratura; il Museo non ancora stato costruito, quindi il Lager si trova pressappoco nelle sue condizioni originarie. Durante la sua prima visita, Adriano ripercorre il viaggio compiuto dal fratello: il treno, lingresso a Gusen e il procedere verso lignoto affrontato da Rinaldo, ascoltando le testimonianze degli ex deportati. Il suo ruolo di testimone di secondo grado andr nascendo pi tardi attraverso la collaborazione attiva con le scuole nello studio del fenomeno concentrazionario: ne sono esempio i viaggi del Progetto Memoria 2004-2005 e 2005-2006, cui Adriano ha preso parte accompagnando gli studenti delle Scuole Superiori di Moncalieri. Collaborando in queste occasioni, con la sua figura, Adriano rappresenta la memoria ancora viva nei parenti dei deportati. La sua riservatezza e il suo stare in disparte indicano il suo non volersi sostituire alla testimonianza diretta del fratello, ma il suo essere testimone di secondo grado, ovvero il portatore di un ricordo che rispetto
2 Pi precisamente Rinaldo dovrebbe essere stato portato, con altri prigionieri, da Torino a Bolzano tra il 14 e il 15 dicembre; l8 gennaio 1945 fu avviato a Mauthausen con altri 483 compagni, arrivandovi l11 gennaio. Cfr. D. Venegoni, Uomini, donne e bambini nel Lager di Bolzano, Milano, Mimesis, 2005, e il saggio gi citato nel corso del volume di I. Tibaldi, Compagni di viaggio (in cui compare il trasporto n. 115). 3 Le fonti sono il Totenbuch di Gusen, elenco archivistico recuperato dagli americani dopo la liberazione del campo, e altri registri originali (indicati nel documento inviato alla famiglia dalla Croce Rossa Internazionale / Ufficio di Arolsen). Abbiamo riportato le date come le ricorda Adriano, tuttavia i documenti Arolsen da noi consultati risalgono al 1964. La Commissione italiana per le Onoranze ai caduti, Delegazione di Vienna, si era messa in contatto con la famiglia nel 1953-1954. 4 Per ricordare Rinaldo il padre si iscritto allANED, seguto anni dopo da Adriano.
Testimoni e memorie
223
allesperienza di Rinaldo s esterno, ma non per questo marginale. Il racconto delle esperienze che Adriano ha fatto negli ultimi momenti passati con Rinaldo ci aiuta a ricostruire il clima denso e teso della Resistenza, facendo conoscere allascoltatore contemporaneo il background della societ antifascista che ha influenzato molti uomini nella scelta di diventare partigiani. La partecipazione di Adriano alle attivit del Progetto Memoria sottolinea la centralit che assume la testimonianza, diretta e di secondo grado, nel mantenimento della memoria, in quanto la visione soggettiva portata dalle parole dei deportati si affianca alloggettivit della importante documentazione archivistica conservata dalle famiglie. Il borgo antifascista Le origini della scelta di Rinaldo di unirsi ai partigiani vanno cercate nelle radici politiche e sociali della sua famiglia e del suo luogo di origine. Rinaldo nasce in Borgo San Pietro, quartiere di Moncalieri noto per essere di tradizione antifascista, anche se luogo della sede del Fascio. Pur avendo per obbligo la tessera da balilla, nessuno dei Sattanino e dei loro amici siscrivono regolarmente al Fascio tesserandosi, in quanto di famiglia antifascista. Rinaldo, come gli altri giovani del borgo, avrebbe potuto aderire al fascismo, mosso dalla prospettiva di un accesso facilitato al lavoro come dice Adriano: Era facile seguire la Repubblica di Sal, aveva il Partito in fondo alla strada ma i ragazzi erano spesso eredi delle idee familiari sullantifascismo: Non si aveva lo spirito per prendere la tessera. Abbiamo cercato di ricostruire la situazione politico-ideologica del Borgo San Pietro degli anni Quaranta: i ragazzi erano balilla e partecipavano alle manifestazioni fasciste il sabato pomeriggio, giocavano a calcio in una squadretta ufficiale la cui sede era nei locali del Fascio, punto di ritrovo dove sincontravano per ballare e giocare a carte. Adriano ci ha consegnato due preziosi documenti, le fotografie che riproduciamo qui. Abbiamo proceduto, grazie alla buona memoria di alcuni superstiti di quei due gruppi, da noi contattati, allindividuazione di quasi tutte le persone fotografate. Nessuno dei partecipanti a queste manifestazioni sportive, per, dimenticava la propria provenienza sociale e le proprie idee. A parte il padre di uno che ci sgridava che dovevamo fare la tessera e andare a lavorare,5 la maggior parte delle famiglie del borgo era mossa da sentimento antifascista. I genitori di Rinaldo avevano infatti appoggiato la sua scelta, preferendo, secondo quanto ci ha testimoniato Adriano, un figlio combattente nella Resistenza a un figlio che sostenesse il governo repubblichino. Il clima sociale ed economico non era per dei pi distesi, in quanto gli uomini difficilmente potevano trovare lavoro se non tesserati: un esempio riportato da alcuni testimoni larresto di un gruppo di operai colpevoli, agli occhi delle autorit, di aver preso parte ai massicci scioperi in fabbrica del marzo 1944.6 Tutti noi ragazzi del Progetto Memoria conserviamo il ricordo del 24 aprile 2005 a Gusen, in cui un Adriano commosso assiste alla posa della installazione da noi realizzata per ricordare il fratello Rinaldo e gli altri deportati moncalieresi Pietro Paolo
5 6
Chi parla Otello Merighi, che compare insieme a Rinaldo nelle foto 1 e 2 alla pagina seguente. Informazione orale che andrebbe naturalmente controllata pi accuratamente, anche se due deportati di Moncalieri, Michele Sandrone e Pietro Paolo Bertoglio, furono arrestati proprio in quelloccasione.
224
Capitolo IV
Bertoglio, Michele Sandrone e Orfeo Mazzoni, in occasione del sessantesimo anniversario della Liberazione dei campi di sterminio. Parlando di quella importante giornata, Adriano si dice soddisfatto del nostro lavoro e dellimportanza che ricopre il ruolo di Moncalieri nellazione del Progetto Memoria: fa piacere il grande impegno dellex Sindaco Novarino, dellattuale Sindaco Bonardi, e la partecipazione assidua dellAssessore Puglisi che ci tiene, va nei campi e se le sente ste cose qua. Adriano conclude cos la nostra intervista con un giudizio positivo sul Progetto Memoria e sui suoi partecipanti, siano questi giovani o autorit, annoverando la nostra citt fra i Comuni che pi si prodigano per la Memoria con la M maiuscola, dicendo: na fuisa tant d Muncal
1. Un gruppo di giovani di Borgo San Pietro. In ordine (in alto da sinistra): Rinaldo Sattanino, Dino Fissore, Livio Bianciotto, Giovanni Fissore, Dino Frisoni, Sandro Mina, Eusebio Crivello, Serafino Girola, Otello Merighi, Angelo Lucchetta. (Fotografia scattata in Borgo San Pietro prima del luglio 1943, forse nei pressi del deposito dellaviazione.)
Il disegno mostra gli esiti della ricerca effettuata in Borgo San Pietro sulle radici di Rinaldo Sattanino. Grazie allaiuto di alcuni amici dinfanzia di Rinaldo e di altri anziani abitanti del quartiere siamo riusciti a identificare tutti i giovani immortalati nella foto. Le silhouettes contenenti i nomi degli uomini sono volutamente in contrasto con il disegno di un Rinaldo giovane e immutato nel tempo, cos come lo ricorda Adriano prima della partenza. Si ringraziano Adriano Sattanino, Otello Merighi, Sergio Vicentini, Annamaria Bonnin e Cristina Gili
2. La squadra di calcio del Fascio. In alto da sinistra: Rinaldo Sattanino, Vaira (portiere), Gianni Battistini, Mario Giordano (allenatore), Valter Bruzzi, Lucio Battistini (centro mediano), Angelo Lucchetta, Vincenzo Merigo (ala destra), Otello Merighi (ala sinistra), Sergio Vicentini. (La fotografia probabilmente stata scattata a cavallo fra il 1943 e il 1944 in Piazza Brennero, a Borgo San Pietro, di fronte al muro di cinta del Gino Lisa. Il Gino Lisa era un campo dellaeronautica Fiat che comprendeva anche un piccolo aeroporto omonimo e che, nel primo dopoguerra, fu trasformato nella Maggiora, fabbrica di componenti auto della Fiat.)
225
Capitolo V - I Giorni della Memoria. La commemorazione del 27 gennaio nella Citt di Moncalieri
Mariagiuseppina Puglisi
Ogni anno, con costanza e coerenza programmatica, sono state realizzate iniziative culturali e didattiche che fossero occasioni di conoscenza e di approfondimento dei fatti storici del Novecento che hanno sconvolto le coscienze del mondo, come il fenomeno concentrazionario nazifascista, o che hanno fondato la storia del nostro Paese, come il 25 aprile 1945. Numerosi sono stati i momenti istituzionali con cui si sottolineata limportanza della memoria di quei fatti, a ribadire costantemente lattualit dei valori della democrazia e della dignit delluomo oltrech il rifiuto fermo della violenza. I Giorni della Memoria sono stati occasioni per ricordare, ai giovani in particolare, i valori ispiratori di quelle libert che essi hanno il privilegio di vivere e il dovere di custodire. Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche liberarono Auschwitz, il pi grande campo di sterminio dEuropa, svelando al mondo lorrore e lunicit della pi immane tragedia del Novecento. Quella data, assurta a simbolo dellOlocausto, diventata la Giornata della Memoria. In Italia stata promulgata da una legge firmata dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi per ricordare la persecuzione e lo sterminio del popolo ebraico e dei deportati italiani, razziali, politici e militari, nei campi nazisti (legge 20 luglio 2000, n. 211). Abbiamo ritenuto di richiamare lattenzione degli adulti e dei giovani, ogni anno, sul diritto-dovere della memoria per arrivare a capire la Shoah e i crimini contro la libert di pensiero e di parola e a riflettere sui delitti di una societ evoluta e sulle aberranti teorie della superiorit razziale. Occorre ricordare altres che fu pagato un prezzo altissimo anche dai deportati militari e politici e furono decine di migliaia i partigiani, uomini e donne, uccisi nei campi di concentramento. Nelle nostre iniziative, e in particolare nel 2005 in occasione del 60 anniversario della Liberazione, abbiamo sottolineato la continuit fra antifascismo, Resistenza e deportazione. Crediamo che molti buoni motivi giustifichino il Giorno della Memoria. La memoria il mezzo pi efficace per contrastare la tendenza a banalizzare e a rimuovere dalla coscienza alcuni nodi cruciali del secolo scorso, quali la Resistenza e la Shoah, poich ci riconosciamo nei valori di libert e democrazia della nostra Costituzione, i soli su cui possibile costruire una coscienza autenticamente civile. Bisogna essere consapevoli del significato di un progetto di annientamento e sterminio scientificamente studiato, calcolato e programmato e di come sia stata possibile la sua condivisione e accettazione da parte di milioni di persone. necessario ricordare le ragioni per cui si combattuto e rintracciare i progetti per cui i singoli si sono battuti, per non mettere tutti sullo stesso piano giustificandone la buona fede.
226
Capitolo V
La storia recente cinsegna inoltre che le tradizioni civili dei popoli vanno protette e coltivate, altrimenti immiseriscono e muoiono cedendo il passo allirrazionalit e alla barbarie. necessario quindi ricordare e testimoniare per il passato e per il presente affinch la memoria produca gli anticorpi che ci costringano a fare i conti con ci che accaduto e che accade. Oggi il pericolo non passato: in Europa e nel mondo tornano inquietanti e ripetuti segnali dintolleranza, e dunque non deve scendere loblio sul passato perch non prevalgano il silenzio, il qualunquismo, la complicit, lestraneit e non si riproduca quel terreno fecondo che allora ha causato ci che non deve pi ripetersi. Il Giorno della Memoria, pertanto, non deve essere rito o cerimonia ma occasione di riflessione, il punto pi alto della riflessione di una nazione e di un continente, e deve originare una memoria attiva, con contenuti che mettano in discussione il mondo e la societ e rendano capaci di evitare i rischi dellufficialit e di dare un contributo alla costruzione del futuro. Il Giorno della Memoria deve essere anche un impegno a continuare perch, inevitabilmente, quando verranno a mancare i testimoni diretti, sui giovani sar riposta la speranza di trasmettere la memoria storica dei racconti e delle testimonianze che essi ci hanno lasciato. Abbiamo condiviso tutti questi buoni motivi e sostenuto le scuole poich crediamo che la formazione delle nuove generazioni sia strumento essenziale per il futuro del nostro Paese ed anche nelle aule, attraverso lo studio, che i giovani possono e devono apprendere a non essere intolleranti. Pensiamo, infine, che la memoria sia un dovere verso coloro che sono morti e verso i giovani cui si devono trasmettere la consapevolezza e la conoscenza del passato, perch possano conservare il patrimonio morale rappresentato dalla continuit della storia delluomo. Mossi da tali intenti profondi abbiamo ritenuto importante realizzare, ogni anno, una programmazione differenziata che tenesse in considerazione anche le giovani generazioni e il loro bisogno di conoscere, apprendere e crescere, e ne vogliamo riportare qui un resoconto riassuntivo che anche bilancio di un impegno realizzato.
I Giorni della Memoria. La commemorazione del 27 gennaio nella Citt di Moncalieri
227
La commemorazione del 27 gennaio nella Citt di Moncalieri
28 gennaio 2001 ore 10 Vecchia Sala Consigliare Palazzo Comunale Interventi di Carlo Novarino (Sindaco di Moncalieri), Lucio Monaco (Progetto Memoria), Mario Treves (Comunit ebraica) e Pio Bigo (ex deportato). 27 gennaio 2002 ore 10 Real Collegio Carlo Alberto Via Real Collegio 20 Interventi di Carlo Novarino (Sindaco di Moncalieri), Mariagiuseppina Puglisi (Assessore alla Cultura), Ferruccio Maruffi (Presidente dellANED di Torino). ore 10.30 Conferimento della cittadinanza onoraria ai testimoni: Pio Bigo, Anna Cherchi, Albino Moret, Natalino Pia, Benito Puiatti, Natalia Tedeschi. Interventi dei testimoni e di Gianni Oliva (Assessore al Sistema Formativo della Provincia di Torino). ore 11.30 Presentazione del volume Percorsi di memoria. Viaggi di studio nei Lager nazisti 1998-2001 con interventi di Lucio Monaco e Marcella Pepe (Progetto Memoria). 27 gennaio 2003 ore 10 Biblioteca Civica A. Arduino Via Cavour 31 Interventi di Lorenzo Bonardi (Sindaco di Moncalieri), Mariagiuseppina Puglisi (Assessore alla Cultura). Proiezioni di video dellArchivio del Progetto Memoria sui Lager di Auschwitz e Dora e del filmato Abitare la Buna (regia di Carla Piana). Dibattito con interventi di Natalia Tedeschi (superstite di Auschwitz-Birkenau), Albino Moret (superstite di Dora), Benito Puiatti (superstite di Dachau-Augsburg), Carla Piana (video operatrice del CIVES). ore 21 Proiezione del video-documentario Romani Rat (La notte dei Rom) con intervento del regista Maurizio Orlandi. 27 gennaio 2004 ore 9 Teatro Civico Matteotti Via Matteotti 1 Apertura della giornata con un video sullattualit di Auschwitz. Interventi di Lorenzo Bonardi (Sindaco di Moncalieri), Mariagiuseppina Puglisi (Assessore alla Cultura). Letture di brani tratti dalla letteratura della deportazione e proiezione di diapositive sul Lager di Auschwitz-Birkenau. Proiezione del film-documentario KZ di Giorgio Treves. Nel foyer del Teatro Matteotti, mostra Immagini e pensieri delle visite ai luoghi di Mauthausen e Auschwitz. Dedicato ai bambini dellOlocausto curata e allestita da Giuseppe Basile. ore 11 Proiezioni del video Con loro nei campi (regia di Carla Piana), sui passi di Natalia
228
Capitolo V
Tedeschi e Albino Moret, e del documentario Gli Ebrei a Roma dal 1938 al 1944 realizzato dallArchivio Centrale di Stato e dalla Shoah Foundation di Los Angeles. ore 21 Spettacolo teatrale La moglie ebrea, di Bertolt Brecht, con la regia di Orlando Manfredi, interpretato da Alessia Donadio e Michele Guaraldo di Teatranzartedrama. Proiezione del filmato di repertorio Quel viaggio, girato da una SS su un trasporto di ebrei e zingari verso Auschwitz-Birkenau nel maggio del 1944. Proiezione del film Train de vie di Radu Mihaileanu. (In collaborazione con Piemonte Movie e Associazione Novecento). 26-27 gennaio 2005 26 gennaio 2005 ore 18 Biblioteca Civica A. Arduino Via Cavour 31 Saluto delle Autorit cittadine. Presentazione del libro di Anna Cherchi La parola Libert. Ricordando Ravensbrck. Interventi di Anna Cherchi, Gianni Oliva (Assessore al Sistema Formativo della Provincia di Torino), Mariarosa Masoero (docente dellUniversit di Torino), Ferruccio Maruffi (Presidente dellANED di Torino), Lucio Monaco (Progetto Memoria e curatore del libro), Marcella Pepe (Progetto Memoria). Proiezione del video-intervista ad Anna Cherchi a Sachsenhausen La necessit di sopravvivere (regia di Carla Piana). 27 gennaio 2005 ore 9 Cinema King Kong Castello Via Alfieri 44 Apertura della giornata con un video sulla tragedia dei bambini africani. Interventi di Lorenzo Bonardi (Sindaco di Moncalieri) e Mariagiuseppina Puglisi (Assessore alla Cultura). Letture sui temi della Giornata della Memoria. Intervento delle Scuole del Progetto Memoria e proiezione del video-intervista ad Anna Cherchi a Sachsenhausen, La necessit di sopravvivere (regia di Carla Piana). Proiezione del film La finestra di fronte di Ferzan zpetek. (In collaborazione con Piemonte Movie). 26-27 gennaio 2006 26 gennaio 2006 ore 18 Biblioteca Civica A. Arduino Via Cavour 31 Saluto delle Autorit cittadine. Presentazione del libro di Giuliana Tedeschi Questo povero corpo. Interventi di Giuliana Tedeschi, Gianni Oliva (Assessore alla Cultura della Regione Piemonte), Mariarosa Masoero (docente dellUniversit di Torino), Lucio Monaco (curatore del libro) e Marcella Pepe (Progetto Memoria). 27 gennaio 2006 ore 9 Teatro Civico Matteotti Via Matteotti 1 Apertura della giornata con interventi di Lorenzo Bonardi (Sindaco di Moncalieri) e Mariagiuseppina Puglisi (Assessore alla Cultura). Intervento delle Scuole del Progetto Memoria e di Pio Bigo. Proiezione del video dellArchivio del Progetto Memoria Parole e Segni oltre il Tempo. Mauthausen-Gusen (regia di Carla Piana). Spettacolo teatrale multimediale Fuga a due voci, a cura dellAssociazione Il Trapezio di Torino.
I Giorni della Memoria. La commemorazione del 27 gennaio nella Citt di Moncalieri
229
Le attivit realizzate per celebrare i Giorni della Memoria nella Citt di Moncalieri, a sei anni dalla legge istitutiva, fanno emergere la forte valenza formativa sottesa e il lavoro progettuale delle scuole come uno dei suoi pi significativi risvolti. Esiste infatti un rapporto intrinseco, e necessario, tra il fare memoria e leducare: i processi formativi si attivano consegnando ai giovani valori, significati, nuove istanze di comprensione della Storia. Due o pi generazioni si collegano in tal modo, nel presente, nel passato e nel futuro, ed per queste ragioni che si avvalora laffermazione fondante della Giornata della Memoria: chi non conosce il passato condannato a ripeterlo e non ha futuro.
Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (27 gennaio 2002)
Il conferimento della cittadinanza onoraria ai sei testimoni: da sinistra Natalino Pia, Anna Cherchi, Natalia Tedeschi, Carlo Novarino (allora Sindaco), Pio Bigo, Albino Moret, Benito Puiatti, Lucio Monaco (Progetto Memoria)
230
Capitolo V
Immagini relative alla cerimonia del 27 gennaio 2002
231
Capitolo VI - Intitolazione della Sala dei Cento a Primo Levi (Moncalieri, 28 maggio 1999)
LAmministrazione Comunale ha sostenuto il Progetto Memoria con diverse iniziative. Nel maggio del 1999 ha intitolato la Sala dei Cento a Primo Levi ritenendo importante lasciare memoria. ben nota langoscia che ha attanagliato coloro che hanno vissuto la drammatica esperienza della deportazione: il timore di non lasciare testimonianza n elementi di credibilit. Noi sappiamo che le nostre societ esistono in quanto hanno radici, e le radici reggono sulla memoria. Primo Levi ha avuto conoscenza diretta della pi grande tragedia dellumanit e ha sentito lurgenza e il richiamo del dovere di testimoniare. Necessit ed efficacia promanano fortemente da lui e dalla sua opera. La sua eredit artistica e morale sono state sicuramente un forte impulso allo sviluppo dei valori della convivenza e alle istanze democratiche della tolleranza. Queste le motivazioni dellintitolazione della Sala dei Cento, occasione per riflettere sulle conseguenze dellintolleranza, della guerra, del razzismo, dellesclusione. Mariagiuseppina Puglisi
Primo Levi tra memoria e profezia
Carlo Ossola (Universit di Torino) Sento di avere in questa occasione il dovere della sobriet: il dovere di quella equivalenza che Primo Levi nelle sue pagine nette poneva fra giustezza della scrittura e giustizia della vita. Quel poco di equivalenza alla verit che concesso allesperienza umana e che nella sua opera, come nella sua vita, era perfino pi alto del dovere di testimonianza; da ci quella scarnificazione del ricordo per attingere a una serenit che potesse varcare il periodo stesso della vita di un uomo. Sono fra due mesi ottantanni dalla nascita di Primo Levi, che nato nel 1919 ed morto nel 1987. Viene particolarmente importante questa dedica, questa presenza della Citt di Moncalieri a unopera che in mezzo a noi. Quando Primo Levi mor Claudio Magris scrisse queste parole: Se questo un uomo un libro che reincontreremo al giudizio universale, offre unimmagine quasi volontariamente attenuata dellinfamia che il testimone Levi racconta scrupolosamente, ci che ha visto di persona, e anzich calcare le tinte sullo sterminio, come pure sarebbe stato logico e comprensibile, vi allude pudicamente, quasi per rispetto a chi stato annientato dallo sterminio dal quale egli in extremis si salvato. In questa tranquilla sovranit egli incarnava la regalit sabbatica ebraica intrecciata alla sua confidenza di scienziato con la natura e con la materia di cui siamo fatti; ed dunque questa religiosa autonomia della contingenza temporale, quale che essa sia, lunica che concesso alluomo di vivere.
232
Capitolo VI
Ebbene, questo ritratto di Claudio Magris ci porta nel cuore di quelli che sono i libri che hanno fatto Primo Levi, prima ancora dei libri che egli ha scritto: ci porta in questa che doveva essere unautobiografia intellettuale, la scelta delle proprie letture che Giulio Bollati gli aveva chiesto per Einaudi. presente allinizio del libro (La ricerca delle radici), molti lo ricorderanno, una sorta di schema: in testa c Giobbe, luomo giusto che patisce ingiustamente; al fondo, i buchi neri delluniverso. La pazienza umana e lincomprensibile della vita: da Giobbe ai buchi neri; quattro linee di percorso che si intitolano cos: la salvazione del riso (egli che aveva cos tanto patito), luomo soffre ingiustamente, la statura delluomo (da Marco Polo a SaintExupry) e la salvazione del capire. Credo che proprio perch posta al vertice del quadruplice percorso, come lo chiamer Italo Calvino che fece la postfazione a questo libro, la salvazione del capire sia probabilmente quella pi cara a Primo Levi, pi ancora che la stessa dignit delluomo, tante volte dalluomo stesso calpestata. In effetti non aspettava molto dal cielo. Nel paragrafo intitolato I buchi neri, dedicato allesperienza di Auschwitz, egli scriveva: Nel cielo non ci sono Campi Elisi, bens materia e luce distorta compresse, dilatate, rarefatte in una misura che scavalca i nostri sensi e il nostro linguaggio. Anche questo voleva dire per Levi attraversare la materia delluniverso e porre domande pi importanti delle risposte stesse. La salvazione del capire anche in una scrittura che faccia capire. Un altro testimone della tristezza del genocidio della seconda guerra mondiale era soltanto parzialmente caro a Levi, cio Paul Celan. Perch, come egli disse, aveva scritto in una maniera che spesso non si faceva capire e nella sua antologia cita una poesia sola, quella diventata un po il punto di riferimento di coscienza per i giovani che nella rinata Germania hanno frequentato per generazioni la scuola media, e cio La fuga di morte di Celan, che in realt una sorta di ballata di cui desidero legge linizio e la fine: Nero latte dellalba noi lo beviamo la sera / lo beviamo a mezzogiorno e al mattino lo beviamo la notte / beviamo e beviamo / scaviamo una tomba nellaria l non si giace stretti. / Nella casa abita un uomo che gioca con i serpenti che scrive / che scrive allimbrunire in Germania i tuoi capelli doro Margarete / lo scrive ed esce dinanzi a casa e brillano le stelle e fischia ai suoi mastini / fischia ai suoi ebrei fa scavare una tomba nella terra. / Ci comanda ora suonate nella danza. [] [...] Nero latte dellalba ti beviamo la notte / ti beviamo a mezzogiorno la morte un maestro tedesco / ti beviamo la sera e la mattina beviamo e beviamo / la morte un maestro tedesco il suo occhio azzurro / ti colpisce con la palla di piombo ti colpisce preciso. / Nella casa abita un uomo i tuoi capelli doro Margarete. / Aizza i suoi mastini contro di noi ci regala una tomba nellaria / gioca con i serpenti e sogna la morte un maestro tedesco / i tuoi capelli doro Margarete / i tuoi capelli di cenere Sulamith. Questa poesia cos terribile, che pure Celan per lo stesso scrupolo di Levi di una giustezza al di sopra della giustizia rinneg, pure era molto cara a Levi per unaltra ragione: perch parlava con quella nettezza e con quella trasparenza che deve farsi intendere ai ragazzi delle scuole cui ha dedicato quasi tutte le prefazioni, le conferenze, il cammino della verit nel tempo. Il cammino della verit nel tempo che egli aveva
Intitolazione della Sala dei Cento a Primo Levi (Moncalieri, 28 maggio 1999)
233
patito anche come scrittore. Non bisogna dimenticare, ed un punto che rimorde la nostra coscienza, non quella altrui. Se questo un uomo usc nel 1947 nella collana di Franco Antonicelli e fu perch luomo fragile e ha bisogno di dimenticare fu in realt presto dimenticato. Del resto la Casa editrice di Franco Antonicelli cess le pubblicazioni e soltanto con molta lentezza venne ripubblicato nel 1958; dovettero passare altri undici anni. Tuttavia Primo Levi non lautore di un solo libro e meno che mai del secondo, che diventato ahim un film, che appunto La tregua: anche un profeta del tempo. Proprio qui a Moncalieri sono state rappresentate, in forma di spettacolo teatrale, Le storie naturali. Vorrei ricordare che in tempi di tecnologia della vita in mano a incontrollabili istanze, gi nel 1966 in Storie naturali Primo Levi pubblic un racconto, che di gran lunga precede quello che noi chiamiamo il metodo della clonazione. Alcune applicazioni del Mimete un dialogo immaginario fra due protagonisti, di cui uno ha iniziato a clonare, duplicare la moglie: tutto un apologo sulla incontrollabilit della tecnologia, egli che ne aveva vissuto le applicazioni pi perverse. uno dei grandi temi testimonianza, ma anche di lucida profezia di Primo Levi. Tra i neologismi che la nostra sete di futuro incamera ogni giorno andrebbe ricordato questo cos severamente ammonitorio, il mimete. Siamo tutti un po fatti di questo parossismo. Ricorder ancora Vizio di forma del 1971, Il sistema periodico del 1975, che una riscrittura dei propri elementi autobiografici, e un libro prezioso di poesie, Losteria di Brema, diventato poi citando un verso che egli aveva tradotto Ad ora incerta, che una delle pi belle testimonianze di quanto possa la poesia stessa nonostante il monito di Adorno, nessun verso pi dopo Auschwitz: ebbene, proprio per riparare quei buchi neri Primo Levi ebbe il coraggio della poesia. Altri titoli che sono stati tradotti in tutto il mondo: La chiave a stella, la paziente dedizione al lavoro di Faussone, che molti ricorderanno e che consiglio caldamente ai giovani, Lilt e altri racconti, e poi nuovamente il romanzo (questa alternanza fra il racconto breve e il romanzo lo caratterizza), Se non ora, quando?, gli articoli di critica e di riflessione sulla societ, Laltrui mestiere e poi I sommersi e i salvati. So che dovrei parlare di letteratura, e non voglio andare oltre, per voglio anche ricordare che Levi non avrebbe ammesso che si possa parlare di letteratura. C una pagina sparsa, ora raccolta in due ottimi volumi da Marco Belpoliti: un intervento del 1976 che sintitola Pi realt che letteratura. Ecco, io credo che questo sia un elemento che lo contraddistingue: se ha fatto letteratura, perch essa contenesse pi realt che non la cronaca, la memoria, lautobiografia, il diario: perch contenesse e ammonisse con pi realt, non con meno realt, o magari con il desiderio di evasione. Secondo elemento che vorrei ricordare da queste opere che chiedono ancora di essere rilette la ragione per la quale io credo che giustamente una comunit civile, un Comune, dedichi un luogo collettivo, un luogo politico, a Primo Levi. Se fossi stato consultato sullinterrogativo se eventualmente intitolare la biblioteca, un luogo di lettura, o un luogo civile a Primo Levi, ebbene, credo che avrei risposto: questo luogo civile. Egli, in un capitolo dellAltrui mestiere che sintitola I padroni del destino e che veramente un monito per il nostro tempo (dico monito perch Primo Levi non rifuggiva dalla coscienza morale, anzi direi che nel finale della Ricerca delle radici, sui libri che lhanno formato, si trova proprio un titolo come Conclusione e ammonimento), ebbene, in questo capitolo egli scrive: Non siamo una specie stupida. Non saremo capaci di erodere le barriere poliziesche, e di trasmetterci da popolo a popolo la
234
Capitolo VI
nostra volont di pace? Non potremmo, ad esempio, portare sul tavolo dei vertici internazionali una vecchia proposta, che sspira al giuramento che Ippocrate aveva formulato per i medici? Che ogni giovane che intenda dedicarsi alla fisica, alla chimica, alla biologia, giuri di non intraprendere ricerche e studi palesemente nocivi al genere umano? ingenuo, e lo so; molti non giureranno, molti spergiureranno, ma qualcuno ci sar pure che terr fede, e il numero degli apprendisti stregoni diminuir. La parola ci differenzia dagli animali: dobbiamo imparare a fare buon uso della parola. Menti pi rozze delle nostre, mille e milioni di anni addietro, hanno risolto problemi pi ardui. Dobbiamo far sentire pi forte il mormorio che sale dal basso, anche nei Paesi in cui mormorare vietato. un mormorio che scaturisce non solo dalla paura ma anche dal senso di colpa di una generazione. Dobbiamo amplificarlo. Dobbiamo suggerire, proporre, imporre poche idee chiare e semplici agli uomini che ci guidano, e sono idee che ogni buon mercante conosce: che laccordo laffare migliore, e che a lungo termine la buona fede reciproca la pi sottile delle astuzie. Non credo che ci sia bisogno di aggiungere altro. Leggo soltanto, per concludere, alcune delle poesie, due soltanto, di Primo Levi. Egli ebbe tale coscienza del fatto che ogni parola va appunto usata come fosse oro, va bilanciata dunque, va soppesata, che anche le poesie sono di estrema rarefazione, e non c una parola in pi, e non c nessuna volont di retorica, n di intrattenimento, n di sfogo. Anche pensando alla letteratura egli la pensava come qualche cosa che stava nella giustezza e dalla quale era impossibile aggiungere o togliere. Per questo credo durer nel tempo non soltanto come testimone, ma anche davvero come colui che ha fabbricato lopera oltre il tempo. La poesia sintitola appunto Lopera: Ecco, finito: non si tocca pi. Quanto mi pesa la penna in mano! Era cos leggera poco prima, Viva come largento vivo: Non avevo che da seguirla, Lei mi guidava la mano Come un veggente che guidi un cieco, Come una dama che ti guidi a danza. Ora basta, il lavoro finito, Rifinito, sferico. Se gli togliessi ancora una parola Sarebbe un buco che trasuda siero. Se una ne aggiungessi Sporgerebbe come una brutta verruca. Se una ne cambiassi stonerebbe Come un cane che latri in un concerto. Che fare, adesso? Come staccarsene? Ad ogni opera nata muori un poco. Coscienza anche della poesia. E infine, per chiudere, quello che egli pens del proprio tempo, e che voglio ricordare perch anche il nostro tempo pochi anni dopo porta lo stesso segno.
Intitolazione della Sala dei Cento a Primo Levi (Moncalieri, 28 maggio 1999)
235
Dateci Dateci qualche cosa da distruggere, Una corolla, un angolo di silenzio, Un compagno di fede, un magistrato, Una cabina telefonica, Un giornalista, un rinnegato, Un tifoso dellaltra squadra, Un lampione, un tombino, una panchina. Dateci qualche cosa da sfregiare, Un intonaco, la Gioconda, Un parafango, una pietra tombale, Dateci qualche cosa da stuprare, Una ragazza timida, Unaiuola, noi stessi. Non disprezzateci: siamo araldi e profeti. Dateci qualche cosa che bruci, offenda, tagli, sfondi, sporchi, Che ci faccia sentire che esistiamo. Dateci un manganello o una Nagant, Dateci una siringa o una Suzuki. Commiserateci. Non solo memoria quella di Primo Levi, rimane profezia.
Primo Levi testimone del nostro tempo
Alberto Cavaglion (Ricercatore presso lIstituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Societ Contemporanea Giorgio Agosti) Il mio intervento, dopo le bellissime parole del Professor Ossola, mi esime dal ripercorrere litinerario di Levi scrittore. Vorrei esprimere gratitudine e riconoscenza per questa iniziativa. Sono state numerose le iniziative che in questi ultimi anni si sono succedute per ricordare Primo Levi, ma ormai da molto tempo che ci siamo accorti, dal numero di sale a lui dedicate, dal numero di scuole che oggi portano il suo nome, che era molto alto il consenso dei lettori comuni, proporzionalmente inverso al numero di addetti ai lavori. Il lungo silenzio dei grandi critici che avvolse lopera di Primo Levi finch fu in vita abbastanza impressionante, e credo abbia segnato non poco lisolamento di questo scrittore, peraltro riservatissimo, ma certamente abbastanza impressionante notare il divario che separa il silenzio di tanti anni e leccessivo rumore attuale. Un grande critico letterario, Giacomo Debenedetti, che fra laltro autore del solo testo che nella storia di questo secondo dopoguerra forse possa stare alla stessa altezza di Se questo un uomo, e cio 16 ottobre 1943, ebbe a dire che gli ebrei non amano n i periodi delle vacche magre n i periodi delle vacche grasse: auspicano una cosa giusta. Dopo tanti anni di vacche magre, non solo per ci che riguarda Primo Levi, ma in generale per la storia della deportazione, che come sapete ha subto per tanti anni una sorta di inferiorit psicologica e poi di riflesso anche storiografica rispetto al-
236
Capitolo VI
la Resistenza, questo indicativo, ma altrettanto allarmante, e i segnali sono gi stati implicitamente sottolineati dal Professor Ossola con quellahim riferito al film di Rosi tratto da La tregua. Cerco di spiegarmi meglio. diffuso nella societ in cui viviamo il desiderio non di dimenticare, ma di consolare, o di far apparire lesperienza concentrazionaria meno drammatica e meno tragica di quello che sia effettivamente stata. Primo Levi ha combattuto per tutta la vita contro uninterpretazione semplificatrice dellesperienza concentrazionaria, e se noi proviamo a ripercorrere non solo i grandi libri dedicati alla deportazione, ma gli altri racconti, le pagine sparse che sono state pubblicate in questi ultimi tempi, o la raccolta di interviste, ci accorgiamo che, pur avendo percorso una parabola di scrittura che dal 1963 in avanti (cio dopo la pubblicazione de La tregua, fino a I sommersi e i salvati del 1987) apparentemente lallontana dal racconto del Lager, in realt ci accorgiamo che per tutta la vita, anche quando si mette a raccontare di fantascienza, Levi non ha mai smesso di affliggerci, perch la storia della deportazione noi spesso oggi tendiamo a dimenticarlo una storia di afflizione. inutile illuderci, come molti film di questi ultimi tempi cercano di fare, che sia necessario in qualche modo abbellirla, trasformarla liricamente. Non sono storie, quelle che raccontano lesperienza concentrazionaria, che possono in qualche modo essere trasformate e rese pi gradevoli. Con questo, come potete immaginare, non voglio negare che ci si possa esprimere con umorismo o anche ridere su esperienze fortemente tragiche. Stiamo parlando di uno scrittore che aveva un fortissimo senso dellumorismo, forse molto di pi di altri uomini di teatro dei nostri tempi, che hanno insistito sullumorismo ebraico. Levi aveva pi di altri questa idea, che anche dallesperienza pi tragica possa venire unidea di comicit, nutrita naturalmente di grande letteratura. Levi fu per molto tempo un uomo di consiglio, cui si rivolgevano, finch fu vivo, studenti, giovani laureati, giornalisti alle prime armi: non le grandi firme, non i grandi intellettuali, ma si rivolgevano a lui soprattutto quelli provenienti dal mondo del giornalismo, molto spesso ricorrendo a lui come a un personaggio simbolico; di volta in volta poteva essere simbolo dellebraismo diasporico, del rapporto conflittuale con lo Stato dIsraele, con la politica italiana, con le crisi mediorientali; in quelle occasioni le grandi firme del giornalismo italiano sono andate per intervistarlo, ma le pi belle interviste che noi oggi possiamo rileggere nel volume che Belpoliti ha pubblicato sono interviste di giovani, di persone che si affacciavano timidamente al mondo degli studi, e avevano intuito che dietro a Levi si nascondeva appunto luomo di consiglio, di cui parla Benjamin in un saggio molto famoso. Per cui anche molto simpatico che il ricordo di Primo Levi venga proprio dalla societ civile e dal numero di lettori che si rivolgevano a lui epistolarmente o richiedendo la sua testimonianza nelle scuole. Sapete benissimo che non vi scuola della nostra Regione che non abbia avuto un incontro con Primo Levi, finch era in vita; tanto frequenti queste iniziative, quanto timide le sue apparizioni pubbliche; qualcuno in sala ricorder le presentazioni dei suoi libri a Torino, anche in librerie famose; erano abbastanza divertenti per il monosillabico riserbo con cui Levi rispondeva alle domande dei presentatori, o del pubblico che partecipava, ricorrendo molto spesso al testo che aveva pubblicato per essere pi fedele possibile, per non cadere in errori di memoria. Era naturalmente un personaggio che rifuggiva dal palcoscenico e non amava i riflettori n della televisione n dei mezzi di comunicazione di massa, pur essendo stato di gran lunga il pi premiato degli scrittori del secondo dopoguerra. Calvino, Moravia non hanno avuto tanti premi Viareggio, tanti premi Strega, tanti Cam-
Intitolazione della Sala dei Cento a Primo Levi (Moncalieri, 28 maggio 1999)
237
piello, quanti ne ha avuti Levi. Fa piuttosto riflettere questa specie di risarcimento morale che gli veniva dato simbolicamente, parallelamente al silenzio della grande critica. Il successo, Levi lo conobbe oltre oceano, negli ultimi anni della sua vita: Il sistema periodico, pi dei primi libri, fu tradotto negli Stati Uniti e gener uno straordinario successo americano, che di riflesso fu poi acquisito anche dalla cultura italiana ma stiamo parlando degli anni Ottanta. E poi soprattutto dopo la morte, dopo quella morte, latteggiamento della cultura italiana cambiato, anche perch in mezzo ci sono tante altre questioni: londata crescente del revisionismo, un ritorno a questi temi che lo stesso Levi in qualche modo aveva preparato con lultimo suo libro, che come molti di voi ricorderanno deve il suo titolo a un capitolo di Se questo un uomo. I sommersi e i salvati il titolo di un capitolo importantissimo del primo libro, che si stacca dal testo desordio come una costola e dopo quarantanni genera un libro totalmente diverso, animato da ideali e da una concezione stessa della memoria e del rapporto fra memoria-storia molto diverso dal libro di esordio. Vi una visione del mondo ne I sommersi e i salvati fortemente pessimistica rispetto allottimismo, nonostante tutto, di Se questo un uomo. Vittorio Foa ha dato questa bella definizione di Se questo un uomo: un libro ottimista, che segna il trionfo dellumanesimo dantesco contro la barbarie, un inno alla vita nonostante la tragica materia trattata. Prima di concludere vorrei sottolineare due aspetti che mi sembrano molto importanti. Levi sempre stato per me, nonostante tutto, un autore anticonformista. impressionante oggi osservare come al di sotto di questa prosa bellissima, marmorea, come ha detto Cesare Cases (formula che oggi viene talvolta utilizzata un po troppo retoricamente, un po troppo liturgicamente, scusate la franchezza), dentro questa prosa marmorea ci fosse una forza morale che ha saputo andare contro corrente in alcuni momenti fondamentali della storia di questi nostri ultimi tre o quattro decenni. Consentitemi soltanto due esempi che a me paiono clamorosi. Il primo riferito a La chiave a stella, testo gi qui ricordato: linno al lavoro manuale contenuto in quel libro venne intonato in anni in cui la pigrizia era rivendicata come un diritto. Ho grande ammirazione per un giornalista oggi di successo come Enrico Deaglio perch ha fatto una lucidissima autocritica di una recensione che pubblic a La chiave a stella sul Quotidiano dei lavoratori del 1975. Trentanni dopo su un altro giornale ha pubblicato, con molto senso autocritico, una lucida confessione di quello che allora non aveva capito, cio il valore positivo del lavoro manuale, il valore anche liberatorio che ha la manualit. Per il secondo esempio bisogna fare un passo in avanti di sette anni e arrivare al 1982 quando venne pubblicato il romanzo storico, Se non ora, quando?, che esce nellestate della guerra in Libano, una guerra che lo Stato dIsraele compie in aggressione verso un altro popolo, mentre in Israele cera un governo di destra che aveva negato i princpi ispiratori del sionismo socialista. Levi pubblica con Se non ora, quando? una straordinaria apologia del sionismo di sinistra, dove si racconta di un gruppo di partigiani che sopravvivono allo sterminio e immaginano la nascita di uno Stato fondato sugli ideali del socialismo umanitario che, in quel momento, nel momento in cui il libro usciva, erano fatalmente sconfitti dalla realt; di qui il disagio che gener quel libro, almeno in una parte dellopinione pubblica italiana. Vengo rapidamente a una conclusione. Tutto questo discorso ci deve certamente fare riflettere su un problema fondamentale, che quello dello scrivere dopo Auschwitz. Levi ha compiuto dal 1947, data della prima pubblicazione di Se questo un
238
Capitolo VI
uomo, a I sommersi e i salvati un suo personalissimo percorso di scrittura, che lo ha portato a fare le obiezioni ad Adorno che sono gi state ricordate, sul continuare a scrivere le poesie, ma soprattutto ha fatto riflessioni molto importanti sulla possibilit dello scrivere dopo Auschwitz, in una cultura come quella italiana del secondo dopoguerra che per molto tempo lo ha relegato in un angolino delle storie letterarie. Fino a non molti anni fa, quando si dovevano in qualche modo antologizzare i libri di Levi, li si collocava nel genere della memorialistica, al massimo li si metteva allinterno del realismo del dopoguerra senza particolari sottigliezze interpretative. Per molto tempo fu posta a Levi questa specie di ricatto: Se tu vuoi dimostrare di essere un vero scrittore devi misurarti con il romanzo; devi lasciar stare le testimonianze. Dopo il 1963, questa specie di ricatto molto percepibile nelle interviste. Se ripercorriamo tale periodo attraverso le interviste e gli scritti sparsi, ci accorgiamo che a un certo punto, pubblicato il secondo libro, esaurita la sua testimonianza, la societ italiana ha detto a Levi: Bene, hai raccontato tutto quello che hai vissuto; adesso se vuoi dimostrare di fare veramente Letteratura, devi darci il romanzo, devi cambiare, devi dimostrare la tua nobilitate; e se sei un vero autore, misurati con la letteratura; quello che hai fatto fino ad adesso non letteratura. Questo un problema fondamentale, perch in altre realt, soprattutto nel mondo francese, tale dilemma non immaginabile: gi allindomani della fine della guerra, grandi scrittori si sono posti il problema dello scrivere dopo Auschwitz, vi stata una riflessione critica di quegli stessi autori, e in generale del mondo intellettuale francese. Questo spiega anche perch a un certo punto del suo percorso Levi abbia tentato varie strade: la fantascienza, ma anche paradossalmente il romanzo storico. Se non ora, quando? molto meno sperimentale, come struttura, di Se questo un uomo: un romanzo storico ottocentesco, manzoniano nella sua struttura generale, quanto di pi diverso da quello che per esempio in Francia un autore come Georges Perec stava ipotizzando come struttura narrativa alternativa. Chiudo con un invito a non trascurare un tema che a me molto caro: gli aspetti filosofici di Levi, soprattutto del primo libro. Molto spesso, anche nelle antologie, si parla dellimportanza storica dei suoi libri. Certamente cos: sono uno strumento straordinario, ad esempio, per comprendere cosa stata leconomia del Terzo Reich; sono opere di altissima letteratura, vi sono dei capitoli di straordinaria bellezza. Non vorrei per che fosse trascurata la definizione stessa che Levi diede nella premessa di Se questo un uomo, che non una definizione storica, non una definizione letteraria, ma una definizione etico-civile. Se questo un uomo, dice, uno studio pacato di alcuni aspetti dellanimo umano. Sottolineo laggettivo pacato, che la cifra di uno stile. Tutta la prima parte dellopera di Levi, soprattutto Se questo un uomo e La tregua, al di l del contenuto un tentativo di spiegare filosoficamente, come se fosse unoperetta morale, il rapporto fra bene e male, tra felicit e infelicit umana, facendo luce su quegli aspetti della esperienza umana che Auschwitz aveva capovolto, ma che Levi, con lidea della salvazione del capire che qui gi stata ricordata, in qualche modo tent per tutta la vita di decifrare.
239
Capitolo VII - Appendici A. Archivi della memoria
Guida allArchivio Multimediale
Pier Luigi Cavanna, Marcella Pepe A partire dallanno scolastico 2001-2002, e fino al 2003-2004, gli studenti del Laboratorio Multimediale Interscolastico presso lITIS Pininfarina, guidati dai docenti Marcella Pepe, Carla Piana, Agostino Gelfo e dal tecnico Fortunato Mesiano, si sono impegnati a costruire un Archivio multimediale del materiale audiovisivo girato durante i viaggi di studio nei siti della deportazione. La motivazione principale di tale lavoro risiede nella consapevolezza dellimportanza della documentazione raccolta e nella convinzione dellopportunit di metterla a disposizione di ulteriori ricerche ed elaborazioni, intento che presuppone una catalogazione sistematica e ordinata. I filmati del nostro Archivio, infatti, restituiscono una registrazione puntuale delle visite ai Lager fra i pi rilevanti del fenomeno concentrazionario nazifascista compiute in nove anni di viaggi del Progetto Memoria: chiunque dei partecipanti voglia rivivere la sua esperienza di viaggio a distanza di anni, o reperire sequenze di immagini per una ricerca personale, lo pu fare semplicemente visionando il materiale raccolto in videocassetta. Forse i filmati sono poco professionali, talvolta imperfetti dal punto di vista tecnico (del resto solo alcuni studenti hanno seguto un corso specifico per teleoperatori presso il nostro Laboratorio), e sicuramente poco oggettivi, ma in ogni caso risultano interessanti, in quanto propongono i luoghi visti dagli studenti-operatori, filtrati attraverso la loro sensibilit, animati dai compagni a loro volta impegnati ad ascoltare le parole dei testimoni, le spiegazioni dei docenti e delle guide, i discorsi commemorativi delle autorit, a scattare fotografie, a leggere testimonianze scritte Lelemento per che pi dogni altro rende prezioso lArchivio e forse quello ispiratore della sua realizzazione la testimonianza degli ex deportati accompagnatori nei viaggi: Pio Bigo, Natalia Tedeschi, Anna Cherchi, Albino Moret, Natale Pia, Giorgio Ferrero hanno raccontato la loro prigionia sui luoghi stessi in cui lhanno vissuta, e le telecamere hanno registrato sia le loro parole sia lespressione dei loro volti nel pronunciarle. Le testimonianze qui raccolte, essendo documenti significativi e inediti, conferiscono dunque allArchivio un valore documentario anche per lo storico professionista. Il complesso lavoro di schedatura e catalogazione, ancora in fase di completamento, risultato utile e formativo dal punto di vista didattico, in quanto ha permesso agli studenti coinvolti di riflettere a posteriori sullesperienza del proprio viaggio e di conoscere anche luoghi non personalmente visitati o testimoni non conosciuti direttamente.
240
Capitolo VII
Dopo una fase di preparazione costituita da lezioni di inquadramento storico, letture di approfondimento, lezioni teorico-pratiche di videoripresa documentaristica, il lavoro di costruzione dellArchivio nel suo aspetto pragmatico stato cos organizzato: si formato, per ciascun viaggio, un gruppo interclasse di studenti (la cui composizione variata nel corso dei diversi anni scolastici) con un duplice compito: in un primo momento, esaminare il girato, selezionando le immagini buone o almeno accettabili ed eliminando quelle brutte, mosse, sfuocate, insignificanti; in un secondo momento, procedere alla scrittura della sceneggiatura tecnica al computer, numerando le inquadrature e indicandone la tipologia (ad es. campo medio, campo lungo, panoramica, dettaglio, totale, figura intera, mezzo busto, primo piano), il contenuto (ad es. panoramica sulle baracche, dettaglio della lapide, primo piano del testimone), calcolando i tempi di ciascuna inquadratura e precisandone i momenti di inizio e fine, riportando per iscritto i discorsi e, soprattutto, le parole dei testimoni. La sceneggiatura tecnica uno strumento indispensabile per chi vuole consultare il materiale audiovisivo, in quanto consente di ricostruire il contenuto delle videocassette e di ritrovare in esse la collocazione delle immagini che interessano, senza doverle visionare per intero. Ultimo momento del lavoro stato il semplice montaggio delle inquadrature selezionate in videocassette chiamate MASTER per distinguerle da quelle originali, sotto la guida di Fortunato Mesiano (per i viaggi del 1999, 2000, 2002) e di Carla Piana (per il viaggio del 2001). Il risultato del lavoro unarchiviazione completa dei seguenti viaggi: viaggio del 1999 ai Lager di Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz IIIMonowitz e a Cracovia (testimone: Natalia Tedeschi); viaggio del 2000 al Lager di Mauthausen e ai suoi sottocampi (Melk, Gusen, Linz, Hartheim, Ebensee) (testimone: Pio Bigo); viaggio del 2001 a Berlino, Wannsee, Sachsenhausen e Ravensbrck (testimoni: Anna Cherchi, Natalia Tedeschi); viaggio del 2002 ai Lager di Buchenwald e Dora (testimoni: Pio Bigo, Albino Moret). Di ognuno sono disponibili presso lITIS Pininfarina, custodite nella Biblioteca dellistituto: videocassette SVHS originali, contrassegnate dalletichetta con la scritta ORIGINAL; videocassette VHS con il montaggio delle immagini selezionate, contrassegnate dalletichetta con la scritta MASTER; sceneggiatura tecnica sia in forma cartacea sia in forma multimediale (floppy disk e CD-Rom). Per i viaggi successivi al 2002, lArchivio in via di riordino: per ora, esistono soltanto le riprese girate dagli studenti, conservate anchesse in Biblioteca. Non sono stati invece conclusi n il montaggio n la sceneggiatura tecnica, tranne che per le immagini girate a Mauthausen e alla cerimonia di Gusen (2005), dedicata a posare nel Memoriale una installazione commemorativa dei deportati moncalieresi, opera degli studenti del Majorana. I materiali realizzati nel corso degli anni dal Laboratorio Multimediale utilizzando le immagini dellArchivio sono anchessi custoditi nella Biblioteca dellITIS Pininfarina.
Appendici
241
Indici
Si riportano gli indici delle videocassette originali esaminate, con lindicazione essenziale del loro contenuto e con la denominazione delle videocassette MASTER in cui sono state montate le immagini selezionate. I tempi indicati nelle sceneggiature tecniche si riferiscono alle videocassette originali al fine di consentire il reperimento delle immagini per eventuali montaggi successivi. Per i viaggi successivi al 2002 sono indicati soltanto le tappe del percorso e i testimoni presenti, tranne che per la parte riguardante le immagini girate a Mauthausen e a Gusen nel viaggio del 2005, corredate da una sceneggiatura tecnica, cio dalla descrizione dettagliata del contenuto.
ARCHIVIO MULTIMEDIALE DEL VIAGGIO 1999
Cracovia, Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz III-Monowitz (a cura del gruppo di lavoro composto da Davide Brunetti, Michele Cavallaro, Raffaele Elia, Gianni Passini, Marco Pastore, Alessandro Savino, Andrea Elia, Antonino Merlo e coordinato da Marcella Pepe e Fortunato Mesiano) videocassetta riprese del viaggio montaggio MASTER POLONIA 1VHS MASTER POLONIA 1 VHS sceneggiatura tecnica su CD-Rom, floppy, carta su CD-Rom, floppy, carta
SVHS ORIGINAL POL 1 da 0:11:03 a 0:13:37 viaggio e Varsavia SVHS ORIGINAL POL 2 da 0:00:35 a 0:51:26 visita guidata di Cracovia, del Ghetto ebraico, della fabbrica di Schindler (dettagli, inquadrature e discorsi) SVHS ORIGINAL POL 3 da 0:01:10 a 0:45:33 Auschwitz II-Birkenau (visita guidata del Lager, testimonianza di Natalia Tedeschi) da 0:46:16 a 0:57:54 Auschwitz III-Monowitz (inquadrature e discorsi) da 0:58:15 a 1:18:17 percorso della marcia della morte
MASTER POLONIA 1 VHS
su CD-Rom, floppy, carta
MASTER POLONIA 2 VHS MASTER POLONIA 2 VHS
su CD-Rom, floppy, carta su CD-Rom, floppy, carta su CD-Rom, floppy, carta
MASTER SVHS ORIGINAL POL 4 da 0:00:10 a 0:52:32 Auschwitz I POLONIA 2 VHS (cerimonia ufficiale e museo); Auschwitz II- Birkenau (ritorno al campo per momenti di ripresa)
242
Capitolo VII
Attingendo materiali da questo Archivio sono stati realizzati: il video I giovani e la memoria, SVHS, 1999, col., 17, regia di Carla Piana, montaggio di Fortunato Mesiano, produzione del Laboratorio Multimediale ITIS Pininfarina; la prima parte del video Le forme della memoria, SVHS, 2000, col., 20, regia di Carla Piana, montaggio di Fortunato Mesiano, produzione del Laboratorio Multimediale ITIS Pininfarina; parte del video Un giorno: 27 gennaio 1945. Memoria e testimonianze, DVD, 2006, col., 13, regia di Francesco Martino.
ARCHIVIO MULTIMEDIALE DEL VIAGGIO 2000
Melk, Mauthausen, Gusen, Linz III, Hartheim, Ebensee (a cura del gruppo di lavoro composto da Marco Bernazzi, Antonio Ciccia, Davide Di Dato, Walter Falasco, Giuseppe Faraci, Paolo Virgilio, Igor Vitale e coordinato da Agostino Gelfo e Fortunato Mesiano) videocassetta SVHS ORIGINAL V1 riprese del viaggio da 0:00:00 a 0:18:29 Melk (visita dellAbbazia e del forno crematorio, discorsi e letture di studenti) da 0:18:35 a 1:13:08 Mauthausen e Linz III (testimonianza di Pio Bigo, letture di studenti) SVHS ORIGINAL V2 da 0:00:30 a 0:35:52 Mauthausen (dettaglio inquadrature, letture di studenti, testimonianza di Pio Bigo) da 0:35:56 a 0:53:57 Gusen e intervista di Carla Piana a Pio Bigo SVHS ORIGINAL V3 da 0:21:51 a 0:26:58 Ebensee e testimonianza di Pio Bigo montaggio MASTER 2000 (A) VHS sceneggiatura tecnica su CD-Rom, floppy, carta
MASTER 2000 (A) VHS
su CD-Rom, floppy, carta
MASTER 2000 (B) VHS
su CD-Rom, floppy, carta
MASTER 2000 (B) VHS MASTER 2000 (B) VHS
su CD-Rom, floppy, carta su CD-Rom, floppy, carta
Attingendo materiali da questo Archivio sono stati realizzati: la seconda parte del video Le forme della memoria, SVHS, 2000, col., 20, regia di Carla Piana, montaggio di Fortunato Mesiano, produzione del Laboratorio Multimediale ITIS Pininfarina; parte del video Parole e Segni oltre il Tempo. Mauthausen e Gusen DVD, 2006, col., 26 40, regia e montaggio di Carla Piana, produzione del Laboratorio Multimediale ITIS Pininfarina;
Appendici
243
parte del DVD-Video Leco della memoria. Un testimone fra i giovani, 2006, col., 40, regia e montaggio di Carla Piana e Francesco Martino, produzione del Laboratorio Multimediale ITIS Pininfarina; nel 2000, Un viaggio nella memoria, CD-Rom, a cura di Francesco Martino, produzione del Laboratorio Multimediale ITIS Pininfarina, tratto da una conferenza di Pio Bigo al Pininfarina; parte del video Un giorno: 27 gennaio 1945. Memoria e testimonianze, DVD, 2006, col., 13, regia di Francesco Martino.
ARCHIVIO MULTIMEDIALE DEL VIAGGIO 2001
Sachsenhausen, Berlino, Wannsee, Ravensbrck (a cura del gruppo di lavoro composto da Daniele Mirto, Enrico Pocchi, Andrea Rosmino, Marco Tasinato, Veronica Loscalzo, Roberta Mollo, Sonia Muzzolon, Roberto Acinapura, Serena Scalenghe, Sebastiano Varrica e coordinato da Carla Piana) videocassetta SVHS ORIGINAL SACHSENHAUSEN 1 COPIA CANON CARLA PIANA VHS riprese del viaggio Sachsenhausen da 0:00:00 a 0:51:41 inquadrature e discorsi Berlino da 0:00:13 a 0:12:47 immagini del viaggio, riprese della citt, il Muro con murales da 0:12:51 a 0:15:56 Anna Cherchi in pullman verso Sachsenhausen da 0:16:05 a 1:07:09 dettaglio di immagini e discorsi di Anna Cherchi Wannsee da 0:00:00 a 0:09:25 Sala della Conferenza di Wannsee da 0:09:34 a 0:11:06 fotografie con sovrimpressione della data della visita montaggio MASTER ANNA A SACHSENHAUSEN VHS MASTER ANNA A SACHSENHAUSEN VHS sceneggiatura tecnica su CD-Rom, floppy, carta su CD-Rom, floppy, carta
SVHS ORIGINAL SACHSENHAUSEN 2
MASTER ANNA A SACHSENHAUSEN VHS
su CD-Rom, floppy, carta
MASTER ANNA A Sachsenhausen SACHSENHAUSEN da 0:11:32 a 0:19:21 VHS visita di Sachsenhausen, immagini di Natalia Tedeschi in visita solitaria segue
su CD-Rom, floppy, carta
244
Capitolo VII
videocassetta SVHS ORIGINAL SACHSENHAUSEN 2
riprese del viaggio
montaggio
sceneggiatura tecnica
M ASTER A NNA A su CD-Rom, Ravensbrck SACHSENHAUSEN floppy, carta da 0:19:22 a 0:22:46 VHS le prigioni del Lager, il Museo di Ravensbrck da 0:22:53 a 0:24:01 i forni crematori da 0:24:02 a 0:24:21 Natalia Tedeschi al Lago di Ravensbrck da 0:24:22 a 0:29:30 incontro in Biblioteca fra Natalia Tedeschi e Anna Cherchi con studenti da 0:29:31 a 0:56:45 la cerimonia ufficiale (discorsi del Sindaco di Ravensbrck, della responsabile del Museo, di Marcella Pepe e del Sindaco Carlo Novarino Ravensbrck da 0:00:00 a 0:44:35 Anna Cherchi e Natalia Tedeschi nei locali del Museo (non montato) intervista ad Anna Cherchi e Natalia Tedeschi (26 ca.) MASTER RAVENSBRCK 2001 VHS su CD-Rom, floppy, carta
SVHS ORIGINAL RAVENSBRCK
Attingendo materiali da questo Archivio sono stati realizzati: il video Con Anna e Natalia a Ravensbrck, CD-Rom, 2003, col., 11 08, regia e montaggio di Carla Piana, produzione del Laboratorio Multimediale ITIS Pininfarina; il video La necessit di sopravvivere, DVD, 2005, col., 18, regia e montaggio di Carla Piana, produzione del Laboratorio Multimediale ITIS Pininfarina; il CD-Rom Memoria e scritture, 2001, a cura di Francesco Martino, produzione del Laboratorio Multimediale ITIS Pininfarina.
Appendici
245
ARCHIVIO MULTIMEDIALE DEL VIAGGIO 2002
Buchenwald, Dora, Weimar, Erfurt, Ulm (a cura del gruppo di lavoro composto da Andrea Rosmino, Veronica Loscalzo, Andrea Elia, Raffaele Elia, Serena Scalenghe, Roberta Mollo, Sonia Muzzolon, Roberto Acinapura, Cristina Crivello, Daniele Graziani, Sebastiano Varrica e coordinato da Marcella Pepe, Carla Piana e Fortunato Mesiano) videocassetta SVHS ORIGINAL BUDO riprese del viaggio Buchenwald da 0:01:09 a 1:00:58 dettaglio di inquadrature del Lager, spiegazioni della guida da 1:00:58 a 1:11:16 dettaglio di inquadrature, testimonianza di Pio Bigo nel Lager e nel Museo montaggio MASTER BUDO VHS sceneggiatura tecnica su CD-Rom, floppy, carta
MASTER BUDO Dora VHS da 1:13:24 a 1:22:27 testimonianza di Albino Moret in pullman verso Dora da 1:22:27 a 2:13:40 dettaglio di inquadrature del Lager, spiegazioni della guida, cerimonia ufficiale (testimonianza di Albino Moret; discorsi delle autorit non completati nella sceneggiatura tecnica)
su CD-Rom, floppy, carta
Attingendo materiali da questo Archivio sono stati realizzati: il video Ricordo di Albino Moret (dal conferimento della cittadinanza onoraria alle testimonianze a Buchenwald e Dora), DVD, 2002, col., 16 30, regia di Carla Piana, montaggio di Fortunato Mesiano, produzione del Laboratorio Multimediale ITIS Pininfarina; parte del DVD-Video Leco della memoria. Un testimone fra i giovani, 2006, col., 40, regia e montaggio di Carla Piana e Francesco Martino, produzione del Laboratorio Multimediale ITIS Pininfarina.
246
Capitolo VII
ARCHIVI MULTIMEDIALI DEI VIAGGI 2003, 2004, 2005, 2006
viaggio e testimoni
riprese a
riprese di Daniele Mirto Daniele Mirto
cassetta (*) DANI 1 VHS (copia da Mini Dv) DANI 2 VHS (copia da Mini Dv) DANI 3 VHS (copia da Mini Dv) VERONICA VHS (copia da Mini Dv) ANNA VHS (copia da Mini Dv) TASI VHS (copia da Mini Dv) AUGLIBIR 1 VHS (copia da Mini Dv) AUGLIBIR 2 VHS (copia da Mini Dv)
2003 (Giorgio Ferrero Mauthausen e Gusen e Natale Pia) (120) Mauthausen: testimonianze e discorsi delle autorit (120) Ebensee (30) Mauthausen (60) Mauthausen (85)
Daniele Mirto Veronica Loscalzo Annalisa Giavara
Mauthausen Marco Tasinato (immagini di copertura) (90) 2004 (Pio Bigo) Auschwitz, Gliwice, Birkenau con Pio Bigo (120) Auschwitz e Birkenau wiebocki; con H. S Auschwitz I, Birkenau, Gliwice con Pio Bigo (120) Annalisa Giavara
Carla Piana
Birkenau sotto la neve Carla Piana e Buna con Pio Bigo; festa degli studenti a Pio Bigo per i suoi ottantanni; Cracovia, il Ghetto, la Farmacia (120) 2005 (Natale Pia) Nonantola e Fossoli (30) Bolzano e Mauthausen (30) segue Roberta Mollo Roberta Mollo
AUGLIBIR 3 VHS (copia da Mini Dv)
MINI DV NOFO MINI DV BOMAU
Appendici
247
viaggio e testimoni
riprese a
riprese di
cassetta (*) MINI DV MAUGU (nb: di una parte delle riprese di Mauthausen e Gusen esiste una sceneggiatura tecnica a cura di Marcella Pepe)
Roberta Mollo Mauthausen, Gusen, Hartheim, con particolare riferimento a: inquadrature a Mauthausen; spiegazione della fuga dal Blocco 20; testimonianza di Natale Pia; letture di studenti; cerimonia ufficiale a Gusen; inquadrature della installazione realizzata dagli studenti del Majorana a ricordo dei cittadini moncalieresi morti a Gusen (30) Ebensee (30) 2006 (Pio Bigo) Buchenwald e Dora, con particolare riferimento a: inquadrature dei luoghi; spiegazioni di guide e docenti; discorsi ufficiali delle autorit; testimonianze di Pio Bigo; letture di studenti (60) Buchenwald e Dora (60) Roberta Mollo
MINI DV EBE
Marco Allio, MINI DV Federico Lazzaroni, BUCDO 1 Danilo Pautasso e Sara Selva
MINI DV Marco Allio, Federico Lazzaroni, BUCDO 2 Danilo Pautasso e Sara Selva MINI DV Marco Allio, Federico Lazzaroni, BUCDO 3 Danilo Pautasso e Sara Selva MINI DV Marco Allio, Federico Lazzaroni, BUCDO 4 Danilo Pautasso e Sara Selva
Dora e intervista a Pio Bigo in albergo (60) Intervista a Pio Bigo in albergo (60)
(*) Le videocassette dei viaggi 2003-2004-2005-2006 contengono: inquadrature dei luoghi, spiegazioni di guide e di professori, discorsi ufficiali delle autorit, testimonianze degli ex deportati accompagnatori, letture di studenti. Le riprese non sono montate e non c una sceneggiatura tecnica.
248
Capitolo VII
Dagli Archivi del 2003 e del 2005 stato tratto il materiale per la realizzazione di gran parte del video Parole e Segni oltre il Tempo. Mauthausen e Gusen, DVD, 2006, col., 26 40, regia e montaggio di Carla Piana, produzione del Laboratorio Multimediale ITIS Pininfarina. DallArchivio 2006 stato tratto il DVD La memoria condivisa, intervista ai partecipanti dei viaggi della Memoria 2006, col., 16 30, regia e montaggio di Francesco Martino, produzione del Laboratorio Multimediale ITIS Pininfarina.
Filmografia testimoni
Pier Luigi Cavanna PIO BIGO Cassette realizzate dal Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina: SVHS ORIGINAL V1 (viaggio 2000) SVHS ORIGINAL V2 (viaggio 2000) SVHS ORIGINAL V3 (viaggio 2000) SVHS ORIGINAL BUDO (viaggio 2002) VHS AUGLIBIR 1 (viaggio 2004) VHS AUGLIBIR 2 (viaggio 2004) VHS AUGLIBIR 3 (viaggio 2004) MINI DV BUCDO 1 (viaggio 2006) MINI DV BUCDO 2 (viaggio 2006) MINI DV BUCDO 3 (viaggio 2006) MINI DV BUCDO 4 (viaggio 2006) Video prodotti dal Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina Le forme della memoria Parole e Segni oltre il Tempo. Mauthausen e Gusen Leco della memoria. Un testimone fra i giovani La memoria condivisa CD-Rom Un viaggio nella memoria (Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina) Il 900. I giovani e la memoria (classe 5 E Telec. dellITIS Pininfarina) ANNA CHERCHI Cassette realizzate dal Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina: SVHS ORIGINAL SACHSENHAUSEN 1 (viaggio 2001) VHS COPIA CANON CARLA PIANA (viaggio 2001) SVHS ORIGINAL SACHSENHAUSEN 2 (viaggio 2001) SVHS ORIGINAL RAVENSBRCK (viaggio 2001) segue
Appendici
249
Video: Con Anna e Natalia a Ravensbrck (Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina) La necessit di sopravvivere (Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina) 44145 Anna (Liceo Scientifico Majorana) CD-Rom prodotti dal Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina: Memoria e scritture Con Anna e Natalia a Ravensbrck GIORGIO FERRERO Cassette realizzate dal Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina: VHS DANI 1 (viaggio 2003) VHS DANI 2 (viaggio 2003) VHS DANI 3 (viaggio 2003) VHS ANNA (viaggio 2003) VHS TASI (viaggio 2003) Video prodotto dal Laboratorio Multimediale dellITISPininfarina: Parole e Segni oltre il Tempo. Mauthausen e Gusen ALBINO MORET Cassetta realizzata dal Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina: SVHS ORIGINAL BUDO (viaggio 2002) Video: Ricordo di Albino Moret (Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina) Matricola 0155. Un deportato inesistente (Michela Cane) NATALE PIA Cassette realizzate dal Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina: VHS DANI 1 (viaggio 2003) VHS DANI 2 (viaggio 2003) VHS DANI 3 (viaggio 2003) VHS ANNA (viaggio 2003) VHS TASI (viaggio 2003) MINI DV NOFO (viaggio 2005) MINI DV BOMAU (viaggio 2005) MINI DV MAUGU (viaggio 2005) MINI DV EBE (viaggio 2005) Video prodotto dal Laboratorio Multimediale dellITISPininfarina: Parole e Segni oltre il Tempo. Mauthausen e Gusen
250
Capitolo VII
NATALIA TEDESCHI Cassette realizzate dal Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina: SVHS ORIGINAL POL 1 (viaggio 1999) SVHS ORIGINAL POL 2 (viaggio 1999) SVHS ORIGINAL POL 3 (viaggio 1999) SVHS ORIGINAL POL 4 (viaggio 1999) SVHS ORIGINAL SACHSENHAUSEN 1 (viaggio 2001) VHS COPIA CANON CARLA PIANA (viaggio 2001) SVHS ORIGINAL SACHSENHAUSEN 2 (viaggio 2001) SVHS ORIGINAL RAVENSBRCK (viaggio 2001) Video prodotti dal Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina: I giovani e la memoria Con Anna e Natalia a Ravensbrck Le forme della memoria Un giorno: 27 gennaio 1945 CD-Rom: Il 900. I giovani e la memoria (classe 5E Telec. ITIS Pininfarina) Memoria e scritture (Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina) Con Anna e Natalia a Ravensbrck (Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina)
Riprese a Ebensee (marzo 2003)
Appendici
251
B. Immagini della memoria
a cura di Carla Piana
Lavorare sulle testimonianze con le immagini e linformatica
Come si potuto vedere pi sopra, nel resoconto analitico sui nove anni di viaggi, i risultati dei percorsi di studio e di testimonianza sono stati fissati anche attraverso gli strumenti pi tipici del nostro tempo limmagine fotografica, il filmato, lipertesto multimediale seguendo diverse strategie di realizzazione, e quindi con un quadro complessivo di risultati piuttosto variegato. Alcune di queste realizzazioni si trovano nei materiali allegati al presente volume, le altre sono consultabili presso la Biblioteca dellITIS Pininfarina e dellI.I.S. Majorana. Gli istituti nella produzione video hanno lavorato autonomamente nello sforzo comune di valorizzare talenti individuali e capacit di rielaborazione personale di unesperienza che riteniamo importante e significativa, ma tanto pi fertile se diventa capace a sua volta di diffusione sia attraverso la tradizionale parola scritta sia attraverso i linguaggi audiovisuali. Naturalmente il cinema entrato nel lavoro di preparazione come esempio da smontare per comprendere tutte le valenze espressive e comunicative di cui la cinepresa e il lavoro di regia e montaggio sono capaci. Per la nostra produzione tendiamo a usare generalmente la parola video non soltanto per il supporto usato quello magnetico o digitale e non pellicola ma anche per la consapevolezza che parlare di film, ovvero di cinema, richiede una maggiore dimestichezza con strutture narrative pi complesse, frutto di unesperienza pluriennale da parte degli autori e di tutto lo staff di produzione. Riteniamo utile proporre, a ulteriore illustrazione dei criteri didattici seguti, una sintesi relativa allattivit del Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina e le schede su alcuni dei video realizzati nel corso degli anni del Progetto Memoria. Esse valgono come documentazione di un percorso conoscitivo che si esprime, oltrech nella forma filmica, anche con la parola scritta e danno al lettore unidea dei contenuti e dei princpi ispiratori che hanno portato alla loro realizzazione.
Esperienze di un Laboratorio Multimediale
Carla Piana Il Laboratorio Multimediale, proposto come parte integrante del Progetto Memoria del Pininfarina, si dato come finalit alta quella di insegnare da un lato le competenze necessarie alla costruzione di un ipertesto, dallaltro quelle per la realizzazione di un audiovisivo. Proporre la creazione di un video significa sollecitare un gruppo di studenti a cimentarsi con unoperazione volta a documentare le testimonianze raccolte durante
252
Capitolo VII
i viaggi di studio, nella consapevolezza che la loro preziosit devessere valorizzata attraverso una sintesi fra testimonianza individuale, studio del momento storico e potenzialit dei linguaggi audiovisuali. A tali obiettivi progressivamente se ne sono aggiunti altri. Evidenziare quelle parole attraverso cui i testimoni ridavano vita anche ai loro compagni di deportazione che con loro e in quei luoghi hanno sofferto senza riuscire a sopravvivere in condizioni al limite delle possibilit umane; riuscire a cogliere sentimenti ed emozioni che i testimoni si scambiavano tra loro e con i giovani che accompagnavano al fine di mettere a fuoco le motivazioni e le fatiche del loro continuo pellegrinaggio (si rimanda per questo aspetto ai video Anna e Natalia a Ravensbrck e La necessit di sopravvivere). Oppure documentare la modalit dei viaggi di studio, senza rinunciare a esprimere i propri pensieri; sottolineare che la visita ai campi era articolata in pi momenti: uno di carattere collettivo di natura pi ufficiale, segnato dalla presenza attenta e partecipe delle istituzioni a fianco degli studenti; un secondo di rivisitazione personale con i testimoni per momenti di riflessione pi intima (si vedano I giovani e la memoria; Le forme della memoria; Ricordo di Albino Moret; Parole e Segni oltre il Tempo. Mauthausen e Gusen; Leco della memoria. Un testimone fra i giovani). Naturalmente questi obiettivi non possono essere improvvisati, soprattutto se si usa per la prima volta uno strumento di comunicazione che ha una sua grammatica e codici diversi sia da quelli familiari ai ragazzi sia da quelli acquisiti tradizionalmente a scuola. Il lavoro svolto dallinsegnante coordinatore, a partire dalla preparazione di base, stato quello di dare spazio agli studenti ogni volta che era possibile, ma anche di aiutarli materialmente a uscire dalle numerose difficolt incontrate nel gestire tecnologie in trasformazione (il passaggio dallanalogico al digitale) e nel superare gli inconvenienti propri delle tempistiche scolastiche quando ci sono laboratori in continua ristrutturazione. Per tale ragione i video, pensati con gli studenti nella fase dellideazione, nello sviluppo dei soggetti e delle sceneggiature, sono stati montati spesso con laiuto dellinsegnante coordinatore, senza nulla togliere al valore complessivo dellesperienza didattica delluso dei nuovi linguaggi. Sono da aggiungere alcune considerazioni sulla socializzazione dei vari momenti di lavoro per la produzione dei video allinterno del gruppo interscolastico durante i viaggi di studio. Al gruppo video hanno partecipato, con funzioni diverse, studenti delle Scuole Superiori di Moncalieri uniti dalla condivisione della finalit e del metodo di lavoro. Tuttavia, dal momento che le riprese non erano improvvisate ma studiate in precedenza, e che non si lavorava con la logica dellocchio invisibile che registra quanto accade ma si ragionava in termini di inquadrature opportune (campi e controcampi, piani, dettagli e sequenze da alternare in fase di montaggio), di cavalletti per dare fermezza alla telecamera e di microfoni per ottimizzare laudio, spesso il gruppo video si trovato nel ruolo di terzo incomodo fra testimoni e studenti. Ruolo non sempre compreso da chi estraneo alle problematiche legate a una costruzione filmica che vuole essere, come si diceva, documentazione e rielaborazione di unesperienza di studio. Questo fatto talvolta ha suscitato lidea che il gruppo video togliesse libert di espressione ai testimoni, come se la spontaneit di immagini girate senza interazioni tra i soggetti interessati (registi, teleoperatori, testimoni, studenti e insegnanti) consentisse di costruire la migliore comunicazione possibile per documentare lesperienza fatta nel suo insieme.
Appendici
253
A tale proposito sono state fatte ferventi discussioni durante i viaggi di ritorno in pullman che hanno portato a una maggiore consapevolezza di quanto lavoro ancora si debba fare sui nuovi linguaggi che lelettronica ha messo a disposizione: linguaggi immediatamente leggibili in superficie dai fruitori di ogni et, ma non altrettanto conosciuti nei meccanismi della loro complessa elaborazione. La socializzazione successiva che ha portato i video prodotti a essere proiettati in pubblico in diverse circostanze e a partecipare a rassegne qualificate come Anteprima Spazio Torino, Torino Film Festival, Filmare la Storia, SantenaCortoFilmFestival pu attestare il raggiungimento dellobiettivo di una decorosa efficacia comunicativa, con la soddisfazione degli autori e dei testimoni la cui eco ha cos raggiunto un numero imprevisto di spettatori. Materiali prodotti: Video SVHS I giovani e la memoria, 1999, col., 17, realizzazione degli studenti del Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina, coordinati da Fortunato Mesiano e Carla Piana; presentato a Big 2000; Video VHS Compagni di un viaggio, 1999, col., 8, regia di Emanuele Cassaro / Matteo Gai (L.S. Majorana); presentato a Torino Film Festival 1999 (Scuole); Video SVHS Le forme della memoria, 2000, col., 20, realizzato dagli studenti del Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina coordinati da Fortunato Mesiano e Carla Piana; presentato a Sottodiciotto Filmfestival e a Torino Film Festival 2000 (Scuole); Video V HS Frammenti di memorie, 2000, col., 9, regia di Emanuele Cassaro (L.S. Majorana); presentato a Torino Film Festival 2000 (Scuole); Video VHS 44145 Anna, 2001, col., 16, regia di Michela Cane (L.S. Majorana); presentato a Anteprima Spazio Torino X 2001; CD-Rom multimediale Il 900. I giovani e la memoria, 1999, Area di Progetto della classe 5E Telecomunicazioni dell ITIS Pininfarina coordinata da Francesco Martino e Marcella Pepe; CD-Rom multimediale Un viaggio nella memoria, 2000, Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina, a cura di Francesco Martino; CD-Rom multimediale Memoria e scritture, 2001, a cura degli studenti del Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina coordinati da Fortunato Mesiano e Carla Piana; DVD-Video / VHS Ricordo di Albino Moret, 2002, col., 16 30, semplice girato della testimonianza di Albino Moret nel Lager di Dora e al Museo di Buchenwald, a cura del Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina; presentato a Moncalieri in occasione del Giorno della Memoria, 27 gennaio 2003, rielaborato in forma digitale nel 2006; DVD Matricola 0155. Un deportato inesistente, 2003, col., 14 56, regia di Michela Cane, autoprodotto dalla regista; CD-Rom / VHS Con Anna e Natalia a Ravensbrck, 2003, col., 11 08, realizzato dagli studenti del Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina, con regia e montaggio di Carla Piana; presentato a Moncalieri in occasione del Giorno della Memoria, 27 gennaio 2004 e proiettato al concorso Filmare la Storia (2004);
254
Capitolo VII
Video-S VHS Memorie di pietra , 2003, col., 8, regia di Paolo Bommino (I.I.S. Majorana Sezione Scientifica); proiettato al concorso Filmare la Storia del Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, dei Diritti e della Libert di Torino (22-30 giugno 2004); DVD -Video Il Giorno della Memoria, 2004, col., 16, realizzato da Francesco Martino, Fortunato Mesiano e Carla Piana; Video-SVHS Tracce, 2004, col., 3, regia di Lorenzo Anania / Mario Mancuso (I.I.S. Majorana Sezione Scientifica); presentato a Sottodiciotto Filmfestival; DVD-Video La necessit di sopravvivere, 2005, col., 18, realizzato dagli studenti del Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina, con regia e montaggio di Carla Piana; presentato a Moncalieri in occasione del Giorno della Memoria, 27 gennaio 2005, e al concorso Filmare la Storia (2005); DVD-Video Parole e Segni oltre il Tempo. Mauthausen e Gusen, 2005, col., 26 40, realizzato da Carla Piana con immagini tratte dallArchivio Multimediale dellITIS Pininfarina; presentato a Moncalieri in occasione del Giorno della Memoria, 27 gennaio 2006; DVD-Video Un giorno: 27 Gennaio 1945. Memoria e testimonianze, 2006, col., 13, realizzato nel Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina, con la regia di Francesco Martino, con immagini tratte dallArchivio dei viaggi della. s. 19981999 ad Auschwitz e della. s. 1999-2000 a Fossoli-Carpi; presentato a Filmare la Storia (2006); DVD-Video La memoria condivisa, 2006, col., 16 30, intervista ai partecipanti del viaggio 2006 a Dora e Buchenwald, realizzato nel Laboratorio Multimediale dellITIS Pininfarina, con regia di Francesco Martino, con immagini tratte dallArchivio del viaggio della. s. 2005-2006; presentato al SantenaCortoFilmFestival (Sezione Scuola); DVD-Video Leco della memoria. Un testimone fra i giovani, 2006, col., 40, realizzato dagli studenti del Laboratorio Multimediale dell ITIS Pininfarina (2000-2006), con regia e montaggio di Carla Piana e Francesco Martino; DVD-Video KZ solo andata, 2006, col., 4 32, regia di Micol Bonapace (collaborazione di Ian Marc Bonapace).
Appendici
255
Compagni di un viaggio
Emanuele Cassaro e Matteo Gai Il film stato girato il 28 marzo 1999 in Polonia, durante un viaggio effettuato nellambito del Progetto Memoria. Le immagini sono quelle che abbiamo scelto di riprendere allinterno del campo di Auschwitz II-Birkenau, ora diventato luogo della memoria e museo. Abbiamo voluto realizzare non un documentario, consapevoli del fatto che gi molti ne sono stati girati, e da persone pi esperte e pi documentate di noi, ma piuttosto un cortometraggio che fosse in grado di fotografare le emozioni che ha suscitato in noi quella visita. Il nostro intento stato dunque quello di riproporre allo spettatore il percorso compiuto da coloro che erano destinati alla immediata eliminazione nelle camere a gas, in particolare dai bambini, dal loro arrivo sui vagoni piombati al loro ingresso nelle camere e nei forni; i nomi di alcuni di questi bambini, ricavati dal Libro della memoria di Liliana Picciotto Fargion, accompagnano lo spettatore lungo il tragitto verso la loro tragica fine, cercando di creare anche solo per un momento una unione spirituale fra chi adesso vede queste immagini e coloro che le hanno vissute negli anni bui del nazismo e del fascismo. Il film pu essere idealmente diviso in due sezioni: la prima individua il percorso lungo i binari appena arrivati nel campo, la seconda quello compiuto dalle vittime allinterno delledificio del crematorio. Abbiamo scelto, per il secondo aspetto, le rovine del Crematorio II di Birkenau. Luso di dissolvenze a nero ha rappresentato la soluzione pi adeguata per trasmettere e mantenere il ritmo tranquillo ma non malinconico che abbiamo voluto dare al film; in ci siamo stati aiutati anche dalla musica composta in Lager, e adatta, per le sue caratteristiche di durata, allasimmetria delle immagini e della lettura dei nomi, non filtrata dai rumori esterni. La prima sezione si apre con limmagine in soggettiva dei binari tramite i quali si entrava a Birkenau, accompagnata dalla musica di Olivier Messiaen (1908-1992), Quartetto per la fine del tempo (inverno 1940, Stalag di Goerlitz); la musica sfuma dopo qualche secondo per far spazio a un elenco di date e nominativi di bambini deportati dallItalia e uccisi allarrivo al campo, letto da alcuni dei partecipanti alla visita; questo elenco, parte di uno pi lungo che durante la visita era stato letto sulle rovine del Crematorio II, come momento di raccoglimento e riflessione, la vera colonna sonora del film che, alternata a momenti di silenzio, accompagna lo spettatore durante tutto il tragitto percorso dalla telecamera. La sequenza dei binari interrotta dalle immagini in cui, sullo sfondo dellentrata principale, due ragazze leggono alcuni nominativi, facendo s che la voce inizialmente fuori campo entri in campo per diventare quasi una presenza fisica e concreta. Con le due immagini che rompono lo scorrere sui binari vogliamo rendere il reale contrasto fra il ricordo conservato da quei binari e la memoria di noi visitatori, presenza anacronistica ma non immune alle emozioni; proprio per questo i binari tornano in una seconda sequenza a rappresentare il ritorno al passato, da noi lasciato per dare spazio al nostro ricordo. Nella seconda sezione linquadratura mossa e traballante (soggettiva), che rispecchia la nostra stessa vista di fronte a quei luoghi, si spinge fra le rovine delle camere a gas e dei forni crematori. Le sequenze in movimento sono interrotte da tre inquadrature, progressivamente pi lunghe e nitide, di un forno crematorio (il III di Birkenau,
256
Capitolo VII
perfettamente uguale al II: lunica fotografia rimasta delledificio cos comera durante la sua attivit). Le tre immagini rappresentano la progressiva consapevolezza delle giovani vittime che si trovavano improvvisamente di fronte a una fine crudele e inaspettata. Il sospetto, limmagine sfuocata, diventa gradualmente certezza. La soggettiva passa allora dalla zona in cui si trovavano i forni veri e propri, coi resti delle strutture, fino ai resti di una scala, indicando cos il passaggio dalle fiamme alla libert del cielo. Il loro, il nostro viaggio finito e dal cielo si passa alle fiaccole del ricordo, che vanno accese e tenute accese.
Compagni di un viaggio: fra emozioni, conoscenza e ragione. Nota sul percorso didattico
Lucio Monaco Il breve filmato Compagni di un viaggio una delle realizzazioni del Progetto Memoria. stato girato il 28 marzo 1999 allinterno del campo di Birkenau (Auschwitz II), durante il viaggio di studio a Cracovia, Auschwitz, Birkenau, Buna-Monowitz e al tragitto della marcia della morte del gennaio 1945. La visita a Birkenau si era svolta con lintero gruppo di 75 studenti il 27 marzo 1999; il giorno dopo su proposta degli insegnanti coordinatori un gruppo pi ristretto di 12 studenti del Liceo Majorana, insieme a insegnanti e studenti dellITIS Pininfarina, con le cui attrezzature sono state effettuate le riprese, tornato nel Lager con lintento di realizzare non un documentario, ma piuttosto un cortometraggio che fosse in grado di restituire, razio-
Discutendo le riprese di Compagni di un viaggio (Birkenau, marzo 1999)
Appendici
257
nalizzandole, come importante fare, le emozioni del giorno prima (quando, fra laltro, era stata letta, sulle rovine del Crematorio II, una lista di nominativi di bambini ebrei deportati dallItalia). Si pensato di ripercorrere, per poi riproporlo allo spettatore, il tragitto compiuto da coloro che erano destinati alla immediata eliminazione nelle camere a gas, in particolare dai bambini, come si detto. Il ricorso alla ripresa soggettiva apparso il pi indicato, anche perch si riconnette, per allusione, allinizio di Nuit et brouillard di Alain Resnais. Il montaggio delle riprese, che erano state accuratamente annotate, stato effettuato interamente dagli studenti, e ha costituito un ulteriore momento di razionalizzazione, filtrata attraverso il codice filmico. Va notato che la realizzazione tecnica stata eseguita con i soli mezzi a disposizione del Liceo (una centralina rudimentale). La qualit tecnica stata cos sacrificata a favore di un maggiore impegno (si lavorava nella scuola, senza limiti di tempo o economici) dal punto di vista della cura della sceneggiatura e della resa del discorso. Sono emerse alcune idee nuove rispetto al progetto inizialmente abbozzato, come lelemento strutturale delle tre inquadrature fisse, progressivamente pi lunghe e meno sfocate, di una foto storica del Crematorio III (identico, costruttivamente, al II). Anche la musica (di Messiaen) e la lettura dei nomi di bambini deportati sono state concepite per conferire unit strutturale. Lintenzione di fondo, in ogni caso, stata quella di lavorare didatticamente sullintreccio fra dimensione emotiva e razionale: vorrei spendere qualche parola a questo proposito. La Shoah crea inquietudine e angoscia, due sentimenti ingestibili soprattutto da parte di chi privo di autonomia culturale ed emotiva. irriducibile a qualsivoglia condiscendenza. il terrore allo stato puro che si cela dietro i discorsi razionalistici. Queste parole di Claudio Vercelli (Ha Keillah n. 5 / dicembre 2000 [a. XXV-n.128]) si possono applicare alle due forme di esperienza dellevento, quella mediante i racconti o le ricostruzioni documentarie, e quella attuata mediante la visita dei luoghi. Ora, riprendendo e integrando le considerazioni di Vercelli, ci sono due modi di farvi fronte mediante meccanismi di rimozione: la negazione, oppure lesorcizzazione attraverso labbellimento o sublimazione immaginifica (ad esempio il film di Benigni pu essere letto in questa chiave). Entrambi questi meccanismi sono strettamente legati a quel processo che Enzo Traverso, citato da Vercelli, descrive cos: La memoria di Auschwitz si offusca via via che allevento storico viene sostituito un complesso museale e visivo chiamato Olocausto, il quale rimuove ogni sforzo di rimemorazione, di riflessione e di comprensione critica, sostituendovi una crescente condensazione emotiva. Il cuore diventa in questo caso il surrogato di unintrospezione critica del tutto assente. La Shoah va contemporaneamente restituita alle sue cause e al suo tempo (e alle nostre responsabilit), pur sapendo che questo non intacca il contenuto di angoscia e di forte tensione emotiva che la caratterizza. Il filmato Compagni di un viaggio costituisce lesperimento della rappresentazione di una realt oggettiva ma angosciante e di una esperienza emotiva, come quella della visita a Birkenau descritta sopra. Si cercata cos una strada per fare fronte al problema del rapporto fra emozioni, conoscenza e ragione. Il nodo emotivo nato dalla visita a quel settore di Birkenau (culminata come s detto nella lettura della lista di bambini, tenuta da due studentesse, sulle rovine del Crematorio) stato risolto nella pro-
258
Capitolo VII
posta di unazione concreta, la sua ricostruzione a livello visivo (ripercorrendo parte della strada fino al crematorio) e verbale (la lettura dei nomi, scegliendo date e circostanze in modo che per costringesse lascoltatore a riflettere di fronte a dati apparentemente neutri). I problemi tecnici di ripresa hanno costituito un momento di piena estraniazione rispetto allimpatto emotivo, e cos, pi tardi, i problemi di montaggio e di associazione alla musica. Sono entrate in gioco categorie specifiche del linguaggio filmico (storyboard, campo lungo, soggettiva: grazie anche alle competenze di Carla Piana) e del discorso, diciamo cos, estetico (citazione, allusione, elemento strutturale, linguaggio metaforico). In questo senso vanno considerati i riferimenti abbastanza evidenti a Resnais (Nuit et brouillard) e a Lanzmann (Shoah) e luso della musica di Messiaen (elemento rischioso perch Messiaen non era un deportato cosiddetto razziale, n politico, e per di pi visse indisturbato a Parigi nel periodo della guerra. Ma allepoca non vi erano altri testi musicali reperibili che offrissero al tempo stesso un aggancio al mondo concentrazionario e un parallelismo fra testo, ripresa e struttura, le gi citate asimmetrie). Il risultato di questi due momenti successivi (emotivit costruzione razionale) il film, in cui certamente, al di l delle imperfezioni tecniche (si tratta comunque pur sempre di una simulazione didattica), si possono ritrovare esplicitamente dichiarati alcuni elementi che caratterizzano la Shoah: la sua insostenibilit, il fastidio che genera (si veda leccessiva lunghezza della ripresa, e il fatto che il filmato non vuole piacere), e al contempo il suo forte contenuto emotivo. Siamo riapprodati alla dimensione emotiva, ma su un piano pi elevato: questa volta nasce da un processo di consapevolezza e di collocazione in un tempo e in uno spazio storico dati (arrestato da fascisti), e ricarica di significato un luogo di memoria che rischia, attraverso un eccesso di monumentalizzazione, di fuoriuscire dalla storia mitizzandosi. Il disordine delle emozioni si costituisce in patrimonio positivo di esperienza interiore per chi ha lavorato a questo film, e forse anche, con un percorso omologo, per chi lo guarda.
Frammenti di memorie
Emanuele Cassaro Il film nasce dal desiderio di dare unimmagine alle parole e ai racconti di Orfeo Mazzoni (1924-1998), partigiano, deportato e superstite di Mauthausen e Gusen, conservati in un filmato del 1990 (girato in occasione di un incontro con gli studenti del nostro Liceo). Vi abbiamo quindi innestato le immagini raccolte durante un viaggio nei Lager austriaci effettuato nellaprile 2000. Lo scopo del viaggio era cos come quello del film di toccare con mano luoghi che prima non possedevano una dimensione fisica: lobiettivo percorre punti esemplari, assunti simbolicamente ma che coincidono con i luoghi effettivamente vissuti da Orfeo Mazzoni e da lui menzionati durante lintervista (la scala di Mauthausen, il portone di ingresso, il percorso dei nuovi arrivati, ci che resta di Gusen oggi il Memoriale di Belgiojoso , la camera a gas). Le due memorie quella del vissuto di Orfeo e quella del rivissuto del nostro viaggio (da qui il titolo) si affiancano e si alternano nello scorrere del film, o si sovrappongono impiegando il racconto come guida delle immagini. La vita e la sofferenza in Lager sono riassunte e rappresentate dalla soggettiva della scala della morte, che
Appendici
259
conduce alla cava di Mauthausen, accompagnata solo dalla musica di Olivier Messiaen, che diventa essa stessa il racconto universalizzante lesperienza del deportato. Particolare attenzione, nella fase di montaggio, stata posta al problema dei ritmi narrativi. Il testimone procede su un doppio binario: il ritmo dei gesti e quello del racconto; a questa duplicit cerca di rispondere lintero montaggio, che propone parallelismi e simmetrie: talvolta pi evidenti, come nella posizione del muro nelle soggettive in movimento dellingresso a Mauthausen, della scala della morte e del corridoio del Memoriale di Gusen, talvolta pi criptiche e affidate allintuito dello spettatore. Viene cos ottenuta una forte analogia di ritmo fra i due racconti: se video (i gesti, lo sguardo) e audio (le parole) si fronteggiano nel racconto del deportato, lintero filmato acquisisce una sua dimensione video e una sua dimensione audio che si affiancano e si completano. Ultimo luogo simbolico, la camera a gas di Mauthausen, sottolineata dalle parole di Mazzoni che ricordano la fragile precariet dellesistenza in Lager. Locchio della cinepresa viaggia nel locale, in analogia con una celebre sequenza di Alain Resnais, ma con un percorso diverso: parte dal soffitto e dalla luce per misurare langoscia delle pareti che chiudono ancora oggi il visitatore in una morsa, fino a stringere sullunico, fittizio ma inquietante contatto con lesterno: linfame spioncino, oltre il quale si percepisce una presenza ancora viva, quella di un male ancora possibile.
Le forme della memoria
Carla Piana Il video il risultato conclusivo di un corso teorico-pratico sul rapporto fra linguaggio audiovisivo e ricostruzione storica, tenuto da Carla Piana allinterno del Progetto Memoria durante lanno scolastico 1999-2000. Duplice lobiettivo del corso: da una parte quello di approfondire i temi del rapporto fra storia collettiva e memoria degli ex deportati, fra riflessione personale dello studente e le tesi delle varie interpretazioni storiografiche, il diverso impatto emotivo fra la scrittura tradizionale e quella elettronica nella ricostruzione delle memorie degli ex deportati; dallaltra quello di preparare gli studenti a realizzare un proprio filmato al ritorno dal viaggio di studio a Mauthausen e ai suoi sottocampi alla luce della riflessione maturata. Attraverso una serie di esercitazioni pratiche, gli studenti hanno preso confidenza con le apparecchiature e le tecniche di videoripresa, i diversi metodi di realizzazione di una sceneggiatura, e di scrittura di uno storyboard. La complessit dellobiettivo prefissato, soprattutto per studenti abituati a una fruizione passiva dellinformazione audiovisiva, ha richiesto un lungo lavoro di messa a punto attraverso varie ipotesi di montaggio, fino alla realizzazione di quello conclusivo nella piena consapevolezza del ruolo nuovo che le produzioni audiovisive di carattere storico vengono ad assumere quando si rivolgono a un pubblico di studenti. Il video, presentato al Sottodiciotto Filmfestival, ha ottenuto dalla giuria una menzione per la complessit del lavoro di studio e di divulgazione di contenuti e interrogativi storico-morali fortemente motivanti nellambito educativo.
260
Capitolo VII
44145 Anna
Michela Cane Realizzato durante una visita ai campi di concentramento tedeschi di Sachsenhausen e Ravensbrck nellambito del Progetto Memoria, questo video la testimonianza di una torinese, Anna Cherchi Ferrari, ex deportata nel Lager di Ravensbrck, che, ritornata sul posto, ci ha raccontato parte di quello che ha vissuto. Il video raccoglie alcuni suoi pensieri, espressi lasciando trasparire chiaramente le forti emozioni provate, ma con una certa serenit. Oltre ai terribili racconti pi volte sentiti, emerge infatti un messaggio positivo: la bellezza della vita, che merita di essere vissuta in qualunque modo essa si presenti, e la riconoscenza nei confronti di tante compagne che sono morte, ma che le hanno insegnato come si doveva fare per sopravvivere. Bench spesso Anna abbia sottolineato limpossibilit, per chi non lha vissuta, di comprendere fino in fondo lesperienza del Lager nazista, si cercato di dare unidea di ci che si pu ancora conoscere e uno spunto di riflessione sul fatto che coloro che hanno visto e vissuto non potranno mai raccontare tutto. A questa difficolt della memoria di districarsi fra passato, presente e passaggio di generazione vuole alludere la parte finale del tutto inaspettata che ripropone, oltre alle immagini gi viste, rapide sequenze non viste, corrispondenti forse alle parti pi profonde della memoria (di quella di Anna, e della nostra). Io spero che capiate cosa significava, cosa significato il campo di sterminio. (Anna Cherchi)
Anna e Natalia a Ravensbrck
Carla Piana Allinterno del Museo di Ravensbrck Anna Cherchi, ex deportata politica, e Natalia Tedeschi, ex deportata razziale, vengono intervistate nel 2001 da alcuni studenti del Progetto Memoria sul modo con cui hanno affrontato la responsabilit del testimoniare la propria esperienza nei campi di concentramento. Il contesto particolare d al dialogo un tono non tanto di intervista quanto di confidenza intima nel tentativo delle due testimoni di spiegare non solo ai giovani, ma anche luna allaltra, la diversit della loro esperienza concentrazionaria: ambiti in cui va ricercata la diversa fatica a ripercorrere gli eventi per testimoniare, a guerra finita, le tragedie vissute. Semplici inquadrature con campi medi, primi piani alternati a immagini del museo e a quelle degli studenti intenti allascolto consentono allo spettatore di concentrarsi sul dialogo fra le due donne. Per Anna, superate le difficolt iniziali (da principio non volevo mettere in palcoscenico le sofferenze subite), il parlare era diventato un dovere di dare voce a chi non era pi tornato e aveva sacrificato la vita per la libert. Per Natalia il bisogno di silenzio per molto tempo aveva avuto il sopravvento, nella consapevolezza di non poter capire e spiegare il senso della tragedia che aveva colpito tutta la sua famiglia e il suo popolo e nel timore di non essere compresa nel dolore provato. In seguito sulle parole di Natalia scorrono immagini del campo di Auschwitz IIBirkenau, dei forni crematori, del monumento eretto a memoria e dei resti dello
Appendici
261
sterminato numero di baracche presenti in quel Lager, cifra della dimensione del primo campo di sterminio in cui Natalia fu reclusa. La telecamera ritorna su Anna e sulle fotografie presenti nel museo, che lei osserva mentre con voce sicura sostiene la convinzione che la forza del pensiero positivo pu combattere la volont di annientamento del sistema ed stata capace di sconfiggere Hitler, prima che sui campi di battaglia, nei Lager stessi. Limmagine finale di Natalia che contempla pacatamente il Lago di Ravensbrck e una sua riflessione su ci che laveva aiutata a sopravvivere vogliono esprimere la funzione salvifica del pensiero e del ricordo come capacit di rielaborazione individuale che permette di sfuggire non solo alla volont di spersonalizzazione perseguita dagli aguzzini ma anche alla tentazione, comprensibile ma sterile, delloblio da parte dei sopravvissuti.
Ravensbru ck (marzo 2001)
262
Capitolo VII
La necessit di sopravvivere
Carla Piana Il video vuole essere una semplice registrazione dellesperienza di deportazione di Anna Cherchi nel Lager di Sachsenhausen, oggi luogo della memoria e museo. Ripresa mentre entra nella piazza dellappello, racconta di quando, come e perch stata fatta prigioniera, ma quasi subito passato e presente si sovrappongono e il suo sguardo sul campo di oggi diventa spontaneamente quello pi profondo impresso nella sua memoria. Mentre si aggira per il museo, quasi a verificare con attenzione la veridicit delle parole della guida, la rievocazione dei suoi ideali giovanili affidata a un canto partigiano, Oltre il ponte, che indica ai giovani il male da combattere e il bene a cui tenersi stretti. La telecamera segue Anna fino nel Blocco di Patologia dove le sue sensazioni sono descritte attraverso una serie di campi medi, controcampi, primi piani e soggettive che evidenziano quanto i suoi occhi siano, a questo punto consapevolmente, intenti a cercare la corrispondenza tra quello che era e quello che il luogo del patire che sta per testimoniare ai suoi giovani amici. Dopo aver espresso le sue rimostranze alla guida del Lager perch le trasformazioni museali stanno rendendo anonimo il luogo da cui scomparsa persino la scritta Laboratorio di Patologia medica, subito inizia il suo racconto. Serena, determinata, ha la forza di trasformare la negativit del luogo e la drammaticit della sua esperienza in un fiume di energia positiva tesa a sottolineare il valore della solidariet fra le prigioniere e la necessit di sopravvivere per s e per gli altri, perch la vita bella e merita di essere vissuta in qualsiasi circostanza e per non darla vinta a quei mostri. Dopo essere stata circondata da studenti premurosi e attenti, esce dal Lager sottobraccio a uno solo, a simbolo di una solitudine sempre presente, vissuta con orgoglio, ma perennemente rimessa in discussione per la sua instancabile volont di testimonianza. Le note che accompagnano le sue immagini in solitaria, lungo il corso del film, sono quelle di In cerca di cibo, a evocare una sensazione strettamente legata al luogo come lo sono le immagini di un tempo. Come nota a margine, ci fa piacere qui ricordare che linserimento nel video del prototipo dellaereo Messerschmitt, prodotto nella fabbrica dove Anna lavorava, stato il frutto di una laboriosa ricerca giunta a buon fine grazie al contributo del fotografo Roberto Conte.
Leco della memoria. Un testimone fra i giovani
Carla Piana Il video ripercorre alcune tappe dei viaggi fatti con Pio Bigo nel 2000 a Mauthausen e al sottocampo di Linz; nel 2002 e nel 2006 al Lager di Buchenwald; nel 2004 ad Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz III-Buna e Gliwice. Da tempo lidea di documentare il cammino fatto da Pio attraverso sette campi di concentramento stata preparata e discussa dagli studenti del Laboratorio Multimediale attraverso incontri sia ristretti sia assembleari, ma era necessario ripercorrere insieme tutto il suo viaggio di allora per raccogliere le impressioni sulle trasformazioni
Appendici
263
recenti dei luoghi e le diverse modalit con cui la memoria dei fatti accaduti conservata e valorizzata a perenne monito delle generazioni future. Le testimonianze di Pio in parte sono state gi inserite in altri video e CD-Rom prodotti dal Laboratorio Multimediale, segno di come la sua partecipazione e affezione agli studenti abbia una lunga storia. Per questa ragione, e per non lasciare in Archivio molti momenti particolari del prezioso apporto dato da Pio alla crescita di studenti e docenti, gli insegnanti coordinatori del Laboratorio Francesco Martino e Carla Piana hanno realizzato un montaggio che vuole essere fedele ai progetti fatti insieme ai ragazzi presenti nel tempo al suo fianco. Da qui il titolo Leco della memoria. Un testimone fra i giovani, perch al ricordo puntuale e preciso di Pio segue quello rimasto impresso nei suoi ascoltatori, che a loro volta si sono impegnati e si impegneranno a mantenere il ricordo di eventi che hanno drammaticamente segnato la nostra modernit. Le musiche scelte a commento delle immagini sono state composte da Massimo Lajolo, responsabile del Laboratorio musicale dellITIS Pininfarina, dopo unattenta valutazione delle richieste avanzate e dopo il lavoro di premontaggio.
Parole e Segni oltre il Tempo. Mauthausen e Gusen
Carla Piana Il video ripercorre alcune tappe dei viaggi fatti a Mauthausen e Gusen nel 2000, nel 2003 e nel 2005 da insegnanti e studenti del Progetto Memoria con i testimoni Pio Bigo, Giorgio Ferrero e Natale Pia e documenta uno stare insieme per rievocare i vissuti tragici proprio in quei campi di concentramento e sterminio di cui i giovani nei viaggi di studio vengono ad avere unesperienza non soltanto teorica ma anche perso-
Pio Bigo ripreso ad Auschwitz (marzo 2004)
264
Capitolo VII
nale ed emotiva. Le riprese fatte da studenti, di cui solo alcuni preparati alluso del linguaggio delle immagini, hanno alternato momenti di documentazione diretta delle testimonianze e della visita a momenti opportunamente predisposti per dare forma alla struttura narrativa del video in precedenza pensato, studiato e preparato. Questo doppio impegno ha determinato anche le impurit di un audio che nelle riprese in diretta risente inevitabilmente dei rumori dei lavori in corso nei campi durante la visita, oltrech della scarsa familiarit con luso del microfono. Le immagini iniziali propongono un sovrapporsi tra fotografie depoca e panoramiche sullattuale piazzale dingresso per rievocare situazioni, stati danimo, rapporti di forza che hanno visto contrapposti aguzzini e vittime. Nel racconto filmico, allanalisi delle lapidi posate lungo il perimetro del campo e a una panoramica sui monumenti eretti dalle Nazioni, segue la viva testimonianza degli ex deportati che ricostruiscono con precisione gli eventi conseguenti al loro internamento e le condizioni della loro quotidianit. Da qui il titolo Parole e Segni oltre il Tempo sovraimpresso alla enorme grata ferrata, che costituisce il monumento eretto dalla ex DDR, a significare che tanto maggiore stata la determinazione dei regimi nazifascisti nel cancellare una umanit considerata inferiore od oppositrice tanto pi il pensiero e lazione di una umanit capace di resistenza e di eticit vuole stabilire degli argini materiali e simbolici alla violenza delluomo sulluomo, a perenne monito per le giovani generazioni. Particolare attenzione stata posta alle descrizioni del crematorio e della cava di granito di Mauthausen, dove sulle immagini che scorrono vengono fatte risuonare dalla voce di studenti le parole contenute nei libri di memoria, allo scopo di rendere perenne il grido dindignazione di chi in questi luoghi ha saputo mantenere una lucida consapevolezza delle aberrazioni umane e una capacit di compassione per i compagni di sventura. Le musiche scelte a commento delle immagini non sono quelle ascoltate dai prigionieri nei Lager, ma vogliono riproporre suoni, rumori sicuramente presenti ai prigionieri, al fine di rafforzare il contenuto emotivo del racconto. Particolarmente significativo risulta il capitolo dedicato a Gusen, in cui le immagini vogliono evidenziare una precisa volont di dimenticanza, quasi che i luoghi dove la sofferenza umana ha toccato vertici indicibili possano essere superficialmente bonificati da giardini e villette ripopolate da famiglie borghesi. Locchio della telecamera e le voci narranti fuori campo sottolineano i contrasti e le trasformazioni avvenute nel tempo (come la villa risultante dalla ristrutturazione delledificio dingresso al campo), evidenziando come lo stesso Memoriale di Belgiojoso, costruito intorno al forno crematorio, risulti soffocato dalla speculazione edilizia, quasi una presenza scomoda. Le testimonianze di Pio Bigo (avvenuta nel 2000), di Natale Pia e Giorgio Ferrero (avvenute nel 2003) e la commemorazione del 25 aprile (avvenuta nel 2005) con la deposizione di una corona e di uninstallazione, opera degli studenti dellI.I.S. Majorana Sezione Scientifica, sottolineano la volont di perpetuare il ricordo di quello che stato. Confortante per tutti la presenza di insegnanti locali impegnati nella conservazione del Memoriale e nella valorizzazione dei documenti depoca. Il filmato nel suo insieme documenta anche il metodo di lavoro del Progetto Memoria. Le visite ai campi sono preparate con scrupolo e a un primo approccio orientativo e di testimonianze segue una loro rivisitazione pi riflessiva e personale per sentire il respiro delle memorie e della Storia. Lo spazio dato alla presenza delle autorit di Moncalieri e del luogo ospite fra volti di studenti attenti e commossi vuole dimostrare come, lontani da forme retoriche, i giovani possano comprendere il valore di un legame tra scuola, ter-
Appendici
265
ritorio e istituzioni che prende forma concreta in un momento celebrativo volto a valorizzare la memoria come un impegno morale e civile fondamentale nel percorso formativo dei giovani.
Mauthausen: lapide di Vittorio Benzi (marzo 2003)
Il Monumento italiano a Mauthausen (marzo 2003)
266
Capitolo VII
Ricordo di Albino Moret
Carla Piana Il video consiste in una recente revisione digitale di un semplice montaggio delle immagini girate nei Lager di Dora e al Museo di Buchenwald nel 2002. Nella nuova versione DVD si voluto dare risalto ad Albino e alla sua voce: dal conferimento della cittadinanza onoraria da parte della Citt di Moncalieri allultimo viaggio fatto con il Progetto Memoria. La struttura narrativa stata notevolmente arricchita pur mantenendo limpostazione originaria che lo voleva unico protagonista proprio nel momento in cui la sua recente scomparsa rendeva tutti noi, insegnanti e studenti, commossi e nostalgici della sua capacit di testimonianza e della sua sempre giovanile vitalit. La prima versione VHS stata proiettata il 27 gennaio 2003 nellambito delle manifestazioni organizzate dalla Citt di Moncalieri.
Albimo Moret con Pio Bigo a Buchenwald (febbraio 2002)
Matricola 0155. Un deportato inesistente
Michela Cane Io sono Albino Moret, classe 1923. Ero militare nel Terzo Alpini. Io sono uno dei pochi militari finiti nei campi di sterminio. Lidea di realizzare il film nata dopo lincontro con Albino Moret al Liceo Scientifico Ettore Majorana di Moncalieri, nellambito del Progetto Memoria. A questo primo momento di conoscenza della storia della sua deportazione ha poi fatto seguito il viaggio con lui e con Pio Bigo, che nel 2002 ci ha portato a visitare e conoscere le realt dei Lager di Buchenwald e di Mittelbau-Dora. Leccezionale possibilit che c stata offerta di tornare sui luoghi della deportazione con i testimoni dei fatti, e in particolare di recarci in un Lager quasi sconosciuto ai pi con uno dei suoi pochissimi superstiti, mi ha motivato ulteriormente allapprofondimento della materia e al tentativo di tradurre in immagini, suoni e sensazioni la storia di Albino.
Appendici
267
Il video si struttura in due parti distinguibili per tema, ritmo e contenuto. La prima parte quella che pi propriamente si pu definire documentario; costruita sulle parole di Albino e raccoglie i suoi ricordi. Le immagini in bianco e nero e quelle dei luoghi sono state girate durante la visita al Lager; queste supportano il racconto e sono finalizzate a permettere allo spettatore di comprendere meglio gli spazi e lambiente, ad aiutarlo a entrare (per quanto possibile) nellatmosfera lugubre delle gallerie segrete in cui i deportati costruivano le V1 e le V2. Le riprese dellintervista sono successive al viaggio e risalgono a un incontro con Albino avvenuto nella sua casa il 25 giugno 2002. In tale occasione eravamo presenti solo Albino, la telecamera e io. Seduti attorno al tavolo della cucina, in una situazione tranquilla e diretta, Albino ha testimoniato la sua esperienza. Non si trattato di unintervista asettica: stato un dialogo. Linquadratura particolare, e la figura di Albino non in posizione centrale rispetto allo schermo: la telecamera si trovava infatti posizionata leggermente di lato, quasi a non voler materialmente costituire una barriera alla nostra lunga chiacchierata. Per lo stesso motivo non ho usato n treppiede n microfoni; questa scelta, bench comporti alcune imperfezioni tecniche sia nellaudio (si sente chiaramente, ad esempio, la pioggia provenire dalla finestra) sia nellimmagine (che risulta instabile e rumorosa), ha per consentito che le parole e il racconto si colorassero di una sfumatura familiare e concreta, diretta nella sua immediatezza. Linquadratura non centrale non era stata preparata prima delle riprese, ma si creata sul momento, quasi involontaria. Tale inquadratura d la sensazione della necessaria presenza di un controcampo, che per non esiste. Luso di campo e controcampo evoca solitamente una situazione di dialogo. In questo caso specifico lassenza di un naturale controcampo d forse la sensazione allo spettatore di trovarsi immerso nella scena, quindi parte attiva del dialogo. La parte documentaria si chiude con il mio ringraziamento ad Albino, che apre contemporaneamente la seconda parte del video, quasi un videoclip. Sulle note di Nel blu dipinto di blu, sentita e ripresa per caso in una strada di Erfurt, le immagini di Albino compongono come in un puzzle il mio ricordo di lui, dolce e sorridente. Il video stato girato fra marzo e giugno del 2002, ma stato montato, smontato e rimontato diverse volte. In particolare nellestate del 2003, mentre ero nuovamente incollata al computer per rifinire il montaggio, ho saputo della malattia di Albino. Il 16 settembre 2003 ho ricevuto per telefono la notizia della sua scomparsa. Sono stata presente al rosario, al funerale e fin dentro la Sala del Commiato del Tempio crematorio di Torino. Tornata a casa, accendendo lo schermo del computer, mi sono resa conto che non avevo perso Albino, e che in qualche modo era ancora con me. Il suo sguardo sorridente era rimasto, oltrech in me e nelle persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, anche sullo schermo, e sarebbe rimasto sempre; questa consapevolezza mi faceva sentire un po meno sola per la sua mancanza. Ho finito il montaggio in quei giorni, con gli occhi lucidi. Rivedere Albino sullo schermo per me riscoprire e ritrovare le emozioni e laffetto che sentivo per lui, e in questo senso il mio lavoro non vuole essere altro che un omaggio alla persona straordinaria che amo definire il mio terzo nonno.
268
Capitolo VII
Memorie di pietra
Paolo Bommino La realizzazione del film ha affiancato il lavoro principale del Progetto Memoria durante il viaggio del 2003, ovvero il rilievo, lo studio e la mappatura del Monumento italiano a Mauthausen. Nella prima parte (con la ripresa da destra a sinistra in modo da rendere incomprensibile quanto scritto delle parole riportate sulla parte ufficiale del Monumento) si vuole indicare la difficolt a percepire il Monumento come archivio di vite vissute, di percorsi e storie individuali. La visita al Lager, riportata nelle immagini successive e scandita, mediante il montaggio, dallalternanza di immagini di deportati e sequenze sui luoghi del Lager (le docce, il crematorio, le baracche, il piazzale), mette in relazione i nomi e i volti con le loro vicende. Si ricorso anche ai memoriali costituiti dalle bacheche presenti in alcuni ambienti visitati, attigui al crematorio. Il percorso in tali depositi di memorie (con qualche ripetizione, per esempio delle immagini di un padre e di un figlio) rende allora pi comprensibile la scritta sul Monumento (ripresa, questa volta, da sinistra a destra). Memorie di pietra diventano cos non soltanto il Monumento con le lapidi, ma anche lo stesso Lager con le sue mura e i suoi edifici. La seconda parte introduce al tema del passaggio del testimone. Il superstite che accompagna gli studenti nella visita procede alla ripulitura e alla riscrittura della lapide che ricorda la morte del giovane cognato. In questa operazione aiutato da alcuni studenti. Il senso simbolico delle sequenze evidente: la necessit di rimediare al trascorrere del tempo, lo strumento del ricordo che passa da una generazione allaltra. Le scelte musicali sottolineano, in modo molto evidente nella parte finale, i passaggi e il senso di questo processo di riappropriazione del passato.
Riprese ad Auschwitz (marzo 2004)
Appendici
269
Tracce. Unesperienza didattica di uso del Kalendarium di Danuta Czech
Lucio Monaco Il Calendario di Danuta Czech unopera cos complessa, pur nellapparente semplicit della struttura cronachistica, che le applicazioni didattiche possibili risultano moltissime. Fra i tanti esempi che potrei fare, in qualche modo un po irregolari, perch non appartengono al piano della ricerca storica o specialistica cui sembrerebbe essere confinato il ricorso a questo libro, sceglierei il pi recente, quello legato al corto di 3 che abbiamo intitolato Tracce. Tracce un lavoro svolto nel 2004, dopo una visita ad Auschwitz I e Auschwitz IIBirkenau (per la verit fu visitato anche Auschwitz III-Monowitz, ma qui le condizioni del tempo erano assolutamente proibitive e non fu possibile alcuna ripresa). La scelta di un gruppo di studenti (al quarto anno di liceo scientifico) cadde sulla realizzazione di un film cortissimo (fra laltro da presentare a una rassegna di quellanno a Torino, nella sezione intitolata appunto Incomincio da tre, cio da lavori di tre minuti di durata); si trattava di montare una selezione appropriata di un materiale abbastanza consueto, cio le riprese effettuate durante la visita. Scartate le riprese con le testimonianze di un superstite, che furono impiegate per un altro tipo di film, si scelse di collegare sequenze che mostravano i due Lager cos come oggi si presentano allo sguardo del visitatore; con molti momenti, quindi, di ripresa soggettiva. Le sequenze scelte vennero legate in dissolvenza, con richiami analogici, secondo un ritmo che risult particolarmente adatto alla musica (il processo fu, in realt, inverso): una musica insolita, perch del tipo che si definisce comunemente (e banalmente) classico, ma di unautrice contemporanea (Teresa Procaccini, Moonlight per tre chitarre, op. 142, 1997; le ragioni dellassociazione, proposta dagli studenti, sono esposte nella scheda che si riporta pi avanti). In assenza di parlato, si sono quindi introdotti degli squarci, o frammenti, in qualche modo argomentativi, per ricordare che cosa (alcune delle cose) succedeva in Lager, e quando. Gli assi portanti furono limitati a due: levocazione della macchina burocratica e la deportazione, certamente in-sopportabile, di bambini e di donne. Si scelse per di lavorare sugli avvenimenti che erano accaduti ad Auschwitz negli stessi giorni, ma sessantanni prima (quindi nel 1944). Solo il Kalendarium ovviamente permette una simile precisione. Cos, sono state inserite cinque didascalie, a circa mezzo minuto di distanza, che rievocano le immatricolazioni del 24 marzo 1944 (riguardanti alcuni zingari, fra cui tre bambine) e del 25 marzo: queste ultime suddivise in tre momenti, due riguardanti trasporti dallOlanda, con accenni ai temi della Resistenza e della solidariet, e uno relativo alla deportazione degli zingari. Lultima didascalia infine, in una climax raggelante, ricorda la nascita di un bambino, immatricolato Z 10043, il 20 marzo 1944 (e una carrellata soggettiva sulle latrine della quarantena, richiamo quasi istintivo a una sequenza di Nuit et brouillard, fa intuire quante potessero essere le probabilit di sopravvivenza di un neonato a Birkenau). Infine, nella sequenza che chiude il film (una fitta nevicata che vela la vista dellingresso di Birkenau, ripreso dallinterno del campo, come a suggerire limpossibilit di uscirne, oppure la presenza sospesa di migliaia di vittime), compare, a segno dello scarto temporale ma anche del coincidere degli avvenimenti quegli eventi di allora
270
Capitolo VII
e la visita di questi due giorni, la data Auschwitz 24-25 marzo 2006. Va notato che le didascalie sono state riprese testualmente dalla traduzione italiana del Kalendarium, senza commento; in modo da prestarsi, con la loro lapidariet, a una discussione o un approfondimento che le utilizzi come punto di partenza. Faceva parte del lavoro, come di consueto in questo tipo di attivit di laboratorio, la stesura di una scheda, che proponiamo qui di seguito.
Tracce
Lorenzo Anania e Mario Mancuso Come raccontare le centinaia di migliaia di vite intrecciatesi e sovrappostesi, per lunghi mesi o per poche ore, ad Auschwitz? Quanto resta di esse nei pochi segni oggi visibili e visitabili, sia nella forma-museo di Auschwitz I sia nella retorica delle rovine di Birkenau? I tre minuti del film vogliono ripercorrere le tracce di memoria superstiti mostrando allo spettatore i luoghi dello sterminio, dalle latrine alle baracche agli Appelpltze. Lunitariet data dalla compresenza di tre linguaggi differenti che compongono il film. Il primo quello delle immagini, dove la camera sembra seguire un normale percorso di visita effettuato nel complesso di Auschwitz; partendo cos dalla sterminata metropoli del Campo Grande (parole di Primo Levi, nel II capitolo de La tregua), la cui vastit di tipo psicologico, si percorre lallineamento oppressivo di spigoli, muri, reticolati e strade. Il primo sbarramento dato dallo zoom su un cartello di morte: da qui in avanti prende avvio uno dei temi cardine di Tracce, riferito alla parte pi indifesa delle vittime del Lager, i bambini (le fotografie iniziali provengono dal memoriale installato attualmente nella Zentralsauna di Birkenau). Nella seconda parte la camera si sposta a Birkenau. Qui lampiezza dello sterminio suggerita dalle linee di fuga che rievocano linfinito, dai centri di controllo (zoom sulla torretta dingresso, da dove brillano due luci inquietanti), dalloscurit dei giacigli, dove la luce penetra dallesterno, ma attraverso contorni limitati e definiti. Limmagine-icona dellingresso (vista dallinterno non tanto per consuetudine, ma per sottolineare la consapevolezza che luscita non possibile) quindi riproposta in chiusura, ma attraverso una fitta cortina di simbolici fiocchi di neve, che evocano il silenzio delle vittime. Al ritmo e alla sintassi delle immagini, che non sono frutto di scelte casuali ( i tre minuti sono estrapolati da unora e mezzo di riprese), stato affiancato un discorso musicale analogo, nonostante il titolo della composizione principale (Moonlight di Teresa Procaccini) sembri estraneo. Non a caso il ritmo, caratterizzato da continui cambiamenti e oscillazioni, aderisce perfettamente alle sequenze video, e anche la scelta di un brano di una compositrice vuole essere un richiamo alla caratteristica di Auschwitz come Lager a forte presenza femminile. Il terzo linguaggio quello della parola scritta. Brevi e discontinue didascalie propongono registrazioni di fatti avvenuti sessantanni prima delle riprese e, anche se apparentemente slegati fra loro e slegati dalle immagini, vogliono invitare a riflettere. Riflettere sullordinaria, quasi banale routine della storia di Auschwitz, ricuperata dallo straordinario testo di Danuta Czech (Calendario degli avvenimenti nel campo di Auschwitz 1939-1945) alla cui memoria, in qualche modo, questo film vuole rendere omaggio.
Mauthausen (aprile 2005)
Finito di stampare nel mese di gennaio 2007 presso Comunecazione snc Strada San Michele, 83 - Bra (Cn)
Potrebbero piacerti anche
- Progetto Luoghi della memoria a Milano. Bookcity Scuole 2015Da EverandProgetto Luoghi della memoria a Milano. Bookcity Scuole 2015Nessuna valutazione finora
- 904Documento126 pagine904Pietro Orsatti0% (1)
- CS - Memoriae - Evento Lecce-The Monuments People - 26.01.2024Documento1 paginaCS - Memoriae - Evento Lecce-The Monuments People - 26.01.2024niconoveseiottoc4vllNessuna valutazione finora
- Programma Educazione Scuola EmigrazioneDocumento5 pagineProgramma Educazione Scuola EmigrazionePaulaNessuna valutazione finora
- Le Vie Della Libertà - Un Percorso Della Memoria (Brescia, 1938 - 1945)Documento73 pagineLe Vie Della Libertà - Un Percorso Della Memoria (Brescia, 1938 - 1945)Andrea ViganiNessuna valutazione finora
- Una Storia di Tutti - Testimonianze sulle Stragi in ItaliaDa EverandUna Storia di Tutti - Testimonianze sulle Stragi in ItaliaNessuna valutazione finora
- Guida Didattica ShoahDocumento47 pagineGuida Didattica ShoahAlessandro Andretta100% (1)
- Una patria espatriata. Lealtà nazionale e caratteri regionali nell’immigrazione italiana all’estero (secoli XIX e XX)Da EverandUna patria espatriata. Lealtà nazionale e caratteri regionali nell’immigrazione italiana all’estero (secoli XIX e XX)Nessuna valutazione finora
- Manual Id I StoriaDocumento7 pagineManual Id I StoriaGiuseppe ManginoNessuna valutazione finora
- PDFDocumento18 paginePDFGian Vittorio CermelliNessuna valutazione finora
- I Store Colibri Foi BeDocumento1 paginaI Store Colibri Foi BeMassimo BozzoNessuna valutazione finora
- L'altro inside and out: l'Italia e il MediterraneoDa EverandL'altro inside and out: l'Italia e il MediterraneoNessuna valutazione finora
- Portella della Ginestra: alla radice del segreto italianoDa EverandPortella della Ginestra: alla radice del segreto italianoNessuna valutazione finora
- Protagoniste nascoste: Donne cattoliche, società, politica nella prima metà del NovecentoDa EverandProtagoniste nascoste: Donne cattoliche, società, politica nella prima metà del NovecentoNessuna valutazione finora
- MauthausenDocumento66 pagineMauthausenClaudio LobascioNessuna valutazione finora
- Arte Visiva Luogo e Memoria EbookDocumento212 pagineArte Visiva Luogo e Memoria EbookMadredeigracchiNessuna valutazione finora
- Fascismo Foibe Esodo. Le Tragedie Del Confine OrientaleDocumento130 pagineFascismo Foibe Esodo. Le Tragedie Del Confine OrientaleGianni PacellaNessuna valutazione finora
- Non un uomo né un soldo: Obiezione di coscienza e servizio civile a TorinoDa EverandNon un uomo né un soldo: Obiezione di coscienza e servizio civile a TorinoNessuna valutazione finora
- Italia 1940-1945: Le storie di ieri e i ragazzi di oggiDa EverandItalia 1940-1945: Le storie di ieri e i ragazzi di oggiNessuna valutazione finora
- Tabella Tracce Prima Prova Esami Di Stato Dal 1999 Al 2011Documento4 pagineTabella Tracce Prima Prova Esami Di Stato Dal 1999 Al 2011Romitn_TnNessuna valutazione finora
- Luoghi Migranti. Tra clandestinità e spazi pubbliciDa EverandLuoghi Migranti. Tra clandestinità e spazi pubbliciNessuna valutazione finora
- Aggiornamenti Bibliografici Sulla Shoah - 2017Documento7 pagineAggiornamenti Bibliografici Sulla Shoah - 2017bandarsNessuna valutazione finora
- Mussolini e gli Illuminati: Da Piazza San Sepolcro al rito sacrificale di Piazzale LoretoDa EverandMussolini e gli Illuminati: Da Piazza San Sepolcro al rito sacrificale di Piazzale LoretoNessuna valutazione finora
- Simone Duranti Leggi Razziali Fasciste e PDFDocumento30 pagineSimone Duranti Leggi Razziali Fasciste e PDFRoberto Gallo100% (1)
- I Giovani Ricordano La Shoah CatalogoDocumento93 pagineI Giovani Ricordano La Shoah Catalogorsueuropawoolf8793Nessuna valutazione finora
- Our vision touched the sky: Fenomenologia dei Joy DivisionDa EverandOur vision touched the sky: Fenomenologia dei Joy DivisionNessuna valutazione finora
- La nostra Repubblica: Il 2 giugno nella storia e nelle memorie civiliDa EverandLa nostra Repubblica: Il 2 giugno nella storia e nelle memorie civiliNessuna valutazione finora
- Dal Monte Rosa alla Terra dei Faraoni. Giuseppe Botti, una vita per i papiri dell’antico EgittoDa EverandDal Monte Rosa alla Terra dei Faraoni. Giuseppe Botti, una vita per i papiri dell’antico EgittoNessuna valutazione finora
- Psichiatria e NazismoDocumento145 paginePsichiatria e NazismoMr. DSLNessuna valutazione finora
- Traverso - Il Passato Istruzioni Per L'usoDocumento148 pagineTraverso - Il Passato Istruzioni Per L'usoAnonymous b1cS0YG0ZSNessuna valutazione finora
- Il cinquantenario dell’unità d’italia (1911) e l’emigrazioneDa EverandIl cinquantenario dell’unità d’italia (1911) e l’emigrazioneNessuna valutazione finora
- Alias Supplemento Del Manifesto (25 Gennaio 2014)Documento16 pagineAlias Supplemento Del Manifesto (25 Gennaio 2014)harck181100% (1)
- FESTA DELLA RESISTENZA Programma Aggiornato 19aprile Ore 11Documento8 pagineFESTA DELLA RESISTENZA Programma Aggiornato 19aprile Ore 11Mauro Del QuondamNessuna valutazione finora
- 2021 TOMATIS Dischi Del PCIDocumento21 pagine2021 TOMATIS Dischi Del PCIJacopo TomatisNessuna valutazione finora
- Paragrafo 175: La memoria corta del 27 gennaioDa EverandParagrafo 175: La memoria corta del 27 gennaioNessuna valutazione finora
- Il Novecento - Storia (68): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 69Da EverandIl Novecento - Storia (68): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 69Nessuna valutazione finora
- Faeta 1Documento47 pagineFaeta 1Northman57Nessuna valutazione finora
- Rievocare Il Passato Memoria Culturale E Identita No WatermakDocumento329 pagineRievocare Il Passato Memoria Culturale E Identita No WatermakoloccinNessuna valutazione finora
- Il nostro due agosto (nero): 44 racconti sulla strage di Bologna raccolti e curati da Luca MartiniDa EverandIl nostro due agosto (nero): 44 racconti sulla strage di Bologna raccolti e curati da Luca MartiniNessuna valutazione finora
- La scure alla radice: «Studium», la cultura cattolica e la guerra (1939-1945)Da EverandLa scure alla radice: «Studium», la cultura cattolica e la guerra (1939-1945)Nessuna valutazione finora
- L'esagono. Storia e Tradizioni Del Baianese PDFDocumento151 pagineL'esagono. Storia e Tradizioni Del Baianese PDFKUNGALEGPANessuna valutazione finora
- L'Esagono. Storia, Tradizioni e Antichi Mestieri Del Baianese.Documento161 pagineL'Esagono. Storia, Tradizioni e Antichi Mestieri Del Baianese.Pellegrino De RosaNessuna valutazione finora
- La Sindrome Di Bolechow - OdtDocumento5 pagineLa Sindrome Di Bolechow - OdtRiccardo MuccardoNessuna valutazione finora
- La Trasformazione Del Mondo Romano e Le Grandi MigrazioniDocumento360 pagineLa Trasformazione Del Mondo Romano e Le Grandi MigrazionitarnawtNessuna valutazione finora
- Esoterismo e fascismo: Immagini e documenti ineditiDa EverandEsoterismo e fascismo: Immagini e documenti ineditiNessuna valutazione finora
- Materialismo Storico. Rivista Di Filosofia, Storia e Scienze Umane, N. 1-2 2016Documento391 pagineMaterialismo Storico. Rivista Di Filosofia, Storia e Scienze Umane, N. 1-2 2016Stefano G. AzzaràNessuna valutazione finora
- La Memoria Delle Foibe e Dellesodo GiuliDocumento18 pagineLa Memoria Delle Foibe e Dellesodo GiuliMarco MichieliNessuna valutazione finora
- +testi Di e Su Italo ManciniDocumento224 pagine+testi Di e Su Italo ManciniMarisa La BarberaNessuna valutazione finora
- Giordano Bruno Opera Latine Conscripta Vol 1 PT 1 Oratio Acrotismus de ImmensoDocumento464 pagineGiordano Bruno Opera Latine Conscripta Vol 1 PT 1 Oratio Acrotismus de ImmensoCorsaroGialloNessuna valutazione finora
- Daniela Rana - "On N'a Gazé Que Les Poux". Le Radici Culturali e Teorico-Politiche Dei Negazionismi Tra Italia e FranciaDocumento263 pagineDaniela Rana - "On N'a Gazé Que Les Poux". Le Radici Culturali e Teorico-Politiche Dei Negazionismi Tra Italia e FranciaCorsaroGiallo100% (1)
- Giordano Bruno - de Triplici Minimo Et MensuraDocumento270 pagineGiordano Bruno - de Triplici Minimo Et MensuraCorsaroGiallo100% (1)
- Michela Nacci - Recensioni e InterventiDocumento218 pagineMichela Nacci - Recensioni e InterventiCorsaroGialloNessuna valutazione finora
- Saverio Gentile - Le Leggi RazzialiDocumento288 pagineSaverio Gentile - Le Leggi RazzialiCorsaroGialloNessuna valutazione finora
- Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri - Gli Antifascisti, I Partigiani e Le Vittime Del Fascismo Nel Bolognese (1919-1945) - Vol. IV: Dizionario Biografico M-QDocumento478 pagineLuigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri - Gli Antifascisti, I Partigiani e Le Vittime Del Fascismo Nel Bolognese (1919-1945) - Vol. IV: Dizionario Biografico M-QCorsaroGiallo100% (1)
- Alessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri - Gli Antifascisti, I Partigiani e Le Vittime Del Fascismo Nel Bolognese (1919-1945) - Vol. III: Dizionario Biografico D-LDocumento457 pagineAlessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri - Gli Antifascisti, I Partigiani e Le Vittime Del Fascismo Nel Bolognese (1919-1945) - Vol. III: Dizionario Biografico D-LCorsaroGiallo100% (1)
- AAVV - Capire Gli Stermini. Per Una Didattica Della ShoahDocumento201 pagineAAVV - Capire Gli Stermini. Per Una Didattica Della ShoahCorsaroGiallo100% (1)
- Alessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri - Gli Antifascisti, I Partigiani e Le Vittime Del Fascismo Nel Bolognese (1919-1945) - Vol. II: Dizionario Biografico A-CDocumento473 pagineAlessandro Albertazzi, Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri - Gli Antifascisti, I Partigiani e Le Vittime Del Fascismo Nel Bolognese (1919-1945) - Vol. II: Dizionario Biografico A-CCorsaroGialloNessuna valutazione finora
- Luigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri - Gli Antifascisti, I Partigiani e Le Vittime Del Fascismo Nel Bolognese (1919-1945) - Vol. V: Dizionario Biografico A-ZDocumento471 pagineLuigi Arbizzani, Nazario Sauro Onofri - Gli Antifascisti, I Partigiani e Le Vittime Del Fascismo Nel Bolognese (1919-1945) - Vol. V: Dizionario Biografico A-ZCorsaroGialloNessuna valutazione finora
- Claudio Vercelli - Il Negazionismo. BibliografiaDocumento25 pagineClaudio Vercelli - Il Negazionismo. BibliografiaCorsaroGialloNessuna valutazione finora
- David Bidussa - Meno Memoria, Più StoriaDocumento4 pagineDavid Bidussa - Meno Memoria, Più StoriaCorsaroGialloNessuna valutazione finora
- Nazario Sauro Onofri - Gli Antifascisti, I Partigiani e Le Vittime Del Fascismo Nel Bolognese (1919-1945) - AppendiceDocumento49 pagineNazario Sauro Onofri - Gli Antifascisti, I Partigiani e Le Vittime Del Fascismo Nel Bolognese (1919-1945) - AppendiceCorsaroGialloNessuna valutazione finora
- Abusi Di Memoria. Negare, Sacralizzare, Abbandonare La Shoah. Intervista A Valentina Pisanty PDFDocumento5 pagineAbusi Di Memoria. Negare, Sacralizzare, Abbandonare La Shoah. Intervista A Valentina Pisanty PDFCorsaroGialloNessuna valutazione finora
- David Bidussa - Razzismo e Antisemitismo in Italia: Ontologia e Fenomenologia Del "Bravo Italiano"Documento36 pagineDavid Bidussa - Razzismo e Antisemitismo in Italia: Ontologia e Fenomenologia Del "Bravo Italiano"CorsaroGialloNessuna valutazione finora
- Valentina Pisanty - Sul NegazionismoDocumento9 pagineValentina Pisanty - Sul NegazionismoCorsaroGialloNessuna valutazione finora
- Riti Egizi 2 2016 PDFDocumento377 pagineRiti Egizi 2 2016 PDFMauroCerulli100% (1)
- (1822) Saggi Critico Storic e Filosofico Sul Diritto Di Natura e Delle Genti PDFDocumento220 pagine(1822) Saggi Critico Storic e Filosofico Sul Diritto Di Natura e Delle Genti PDFLuis M.R.Nessuna valutazione finora
- SenofonteDocumento3 pagineSenofonteSquaqquero Di LibonisNessuna valutazione finora
- Riassunto Che Cose Il Restauro Come Quando e Perche Conservare Le Opere DarteDocumento8 pagineRiassunto Che Cose Il Restauro Come Quando e Perche Conservare Le Opere DarteANDREA INNOCENTENessuna valutazione finora
- Storia Ed Istituzioni Dei Paesi AfroasiaticiDocumento48 pagineStoria Ed Istituzioni Dei Paesi AfroasiaticiFederico FaleschiniNessuna valutazione finora
- 1994 Parte 1 Pp. 1 267Documento138 pagine1994 Parte 1 Pp. 1 267SildonesNessuna valutazione finora
- Che Cosa E' L'antropologia Filosofica PDFDocumento53 pagineChe Cosa E' L'antropologia Filosofica PDFClaudio GodoyNessuna valutazione finora
- Elementi Di Teologia FondamentaleDocumento83 pagineElementi Di Teologia Fondamentalemauriziolapuca100% (1)
- La Formazione Professionale in Piemonte Dall'Unità D'italia All'UEDocumento286 pagineLa Formazione Professionale in Piemonte Dall'Unità D'italia All'UEgcamarcaNessuna valutazione finora
- Croce Trattati D' Amore Del Cinquecento.Documento17 pagineCroce Trattati D' Amore Del Cinquecento.Manu PapadakiNessuna valutazione finora
- 7 ZlobecDocumento19 pagine7 ZlobecTwister X SanNessuna valutazione finora
- Leopardi e La MatematicaDocumento18 pagineLeopardi e La Matematicaapi-273812422Nessuna valutazione finora
- WWW Alateus ItDocumento316 pagineWWW Alateus ItCresci AlessioNessuna valutazione finora
- RM-Galloni - Lo Zio Materno Nel MedioevoDocumento36 pagineRM-Galloni - Lo Zio Materno Nel MedioevopontexmaximusNessuna valutazione finora
- DiegoFerioli - Considerazioni Sul Fuþark ScandinavoDocumento39 pagineDiegoFerioli - Considerazioni Sul Fuþark ScandinavoDiego FerioliNessuna valutazione finora
- Livio Praefatio LAT - ITADocumento5 pagineLivio Praefatio LAT - ITAZPOLIXNessuna valutazione finora
- FilologiaDocumento21 pagineFilologiaJoseph990Nessuna valutazione finora