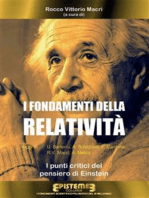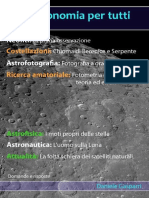Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Atlante Fotografico Luna
Caricato da
Ocram AtirCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Atlante Fotografico Luna
Caricato da
Ocram AtirCopyright:
Formati disponibili
il nuovo
Tutta la superficie visibile della Luna in 44 Tavole fotografiche di grande formato, pi una Tavola per il
lato nascosto.
Le Tavole sono state realizzate grazie alle riprese ad altissima risoluzione effettuate dalla sonda lunare
LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) della NASA.
Le riprese sono state elaborate nei laboratori dellArizona State University, per ottenere unimmagine
completa della Luna come appare vista dalla Terra; ma con uninclinazione dei raggi del Sole simile su
tutta la superficie lunare, per una visone ottimale di tutti i crateri.
Le Tavole sono accompagnate, nelle pagine a fronte, da mappe che mostrano le disposizioni delle
formazioni pi interessanti (crateri, mari, monti, solchi) e dalle descrizioni dettagliate di oltre 330
formazioni, preparate da Walter Ferreri.
Unopera indispensabile per lappassionato osservatore della Luna, per il fotografo esperto di riprese
lunari, per lo studioso, per il semplice curioso del cielo, e per tutti coloro che amano il nostro unico
grande satellite naturale.
Atlante Fotografico
della Luna
ISBN 978-88-95650-364
22,50 euro
il nuovo Atlante
Fotografico della Luna
a cura di Walter Ferreri
a cura di
Walter Ferreri
45 Tavole
da foto originali NASA
GRUPPO
EDITORE
il nuovo
Atlante Fotografico
della Luna
a cura di
Walter Ferreri
45 Tavole
da foto originali NASA
Grafica: Patrizia Andreoni - Grafiche Porpora Srl, Segrate (MI)
Coordinamento editoriale: Piero Stroppa
INTRODUZIONE
Sono ormai trascorsi 20 anni da quando la rivista Nuovo Orione
inizi a pubblicare le schede lunari che avrebbero dato corpo
allAtlante Fotografico della Luna.
Le immagini di tale atlante, basato sulle fotografie realizzare
allOsservatorio del Pic du Midi, nei Pirenei francesi, erano
certamente notevoli per lepoca in cui furono scattate, nel secondo
dopoguerra, e adeguate a molti appassionati che si occupavano di
osservazioni lunari nei primi Anni 90.
Successivamente, gli strumenti a disposizione degli astrofili si
sono molto evoluti, e questo, parallelamente allabbassamento
dei prezzi, consente facilmente di utilizzare telescopi con poteri
risolutivi superiori a quelli mostrati nelle foto del Pic du Midi.
Grazie alle riprese spaziali di LRO
Per adeguarsi alle nuove e accresciute esigenze, il Gruppo B
Editore ha deciso di mettere a disposizione degli appassionati un
nuovo atlante fotografico della Luna, composto da 44 Tavole (pi
una Tavola per il lato nascosto).
Le Tavole sono state realizzate grazie alle riprese ad altissima
risoluzione eseguite recentemente dalla sonda lunare LRO (Lunar
Reconnaissance Orbiter) della NASA, e sono accompagnate da
una descrizione delle formazioni pi caratteristiche, preparata
dallo scrivente.
Le riprese originali di LRO hanno una risoluzione di soli 145 metri
per pixel e sono state realizzate in un periodo di due settimane a
cavallo del mese di dicembre del 2010.
La sonda era equipaggiata con sette strumenti, tra i quali il LROC
(Lunar Reconnaissance Orbiter Camera), composto da due
telecamere, una ad alta risoluzione (NAC, Narrow Angle Camera)
e una a grande campo (WAC, Wide Angle Camera). La prima
arrivava addirittura a una risoluzione di 0,5 metri per pixel; la
seconda a 100 metri per pixel.
La camera ad alta risoluzione era dotata di unottica RitcheyChrtien da 195 mm di diametro a f/3,6, che riprendeva al massimo
porzioni della superficie lunare di 2,5x2,6 km. Laltra, con rapporto
di f/5, riprendeva campi con ampiezze maggiori di 100 km.
Le riprese della sonda sono poi state elaborate nei laboratori
dellArizona State University con appositi software e composte
insieme per ottenere unimmagine completa della Luna come
appare vista dalla Terra; ma con la stessa inclinazione dei raggi del
Sole su tutta la superficie lunare, per consentire la visione ottimale
di tutti i crateri.
Il mosaico lunare che stato generato ha una dimensione di ben 550
Mega: da questa immagine gigante, che disponibile e navigabile
sul sito di LRO (http://wms.lroc.asu.edu/lroc_browse/view/
wac_nearside), sono state ricavate le Tavole presenti in questo
Atlante.
Quattro secoli di atlanti lunari
Di atlanti lunari ne sono stati pubblicati numerosi; gi dopo le prime
osservazioni telescopiche della Luna, si sentita la necessit di
rappresentare la superficie lunare in base a quanto veniva rivelato
dal nuovo strumento.
Per quanto ne sappiamo, la prima mappa a riportare dei nomi delle
formazioni lunari stata quella di Langrenus del 1645. Due anni
dopo, apparve la mappa eseguita da Hevelius, un ricco cittadino
di Danzica, che diede alle catene montagnose i nomi di quelle
terrestri. In realt, la mappa di Hevelius faceva parte del suo lavoro
Selenographia, che conteneva disegni della Luna nelle diverse fasi.
Nel 1651 apparve la mappa di Riccili, con in gran parte la
nomenclatura attualmente in uso. Negli anni seguenti, furono
pubblicate ulteriori mappe, ma nessuna nettamente superiore alle
altre. Tra queste, comunque, doveroso citare quella da 20 cm
di diametro, realizzata da Tobias Mayer di Gottinga, in quanto fu
la prima veramente accurata. Questa mappa venne pubblicata solo
nel 1775, tredici anni dopo la morte del suo autore.
Uno dei maggiori osservatori della Luna fu Johann H. Schrter,
che nel 1791 pubblic unopera dal titolo Selenotopographische
Fragmente; non si trattava di una mappa completa, ma - come
indicato dal titolo - di una serie di porzioni, ognuna delle quali pi
dettagliata di quanto presente nelle mappe complete disponibili al
tempo. Questo lavoro, ampliato, ebbe una successiva edizione nel
1802.
Schrter avrebbe voluto pubblicare in seguito una mappa completa
della Luna, ma poco tempo dopo, durante uninvasione del territorio
tedesco da parte dellesercito napoleonico, il suo osservatorio
venne messo a ferro e fuoco, e il telescopio fu totalmente distrutto.
Per questo, pur avendo dimensioni modeste, la mappa di Mayer
rimase la migliore fino al 1824, quando vennero pubblicate le
prime parti di un notevole lavoro dovuto a un geometra di Dresda:
Wilhelm G. Lohrmann, che osservava con un rifrattore da 108 mm.
Purtroppo, lautore di questo pregevole lavoro ebbe problemi di
vista e non pot completarlo. Solo molto tempo dopo la sua morte,
che avvenne nel 1840, furono realizzate le parti mancanti, e il tutto
fu pubblicato: era il 1878.
Ma la mappa che fece testo nella prima met del XIX secolo
quella di Beer e Mdler. Questi due amici berlinesi, grazie alle loro
osservazioni compiute con un rifrattore da 95 mm, pubblicarono un
pregevole lavoro nel 1837. In questa mappa, da 94 cm di diametro
e completa con un vasto libro di consultazione, erano riportati circa
7000 crateri.
Occorre attendere il 1878 per vedere unopera di impegno ancora
maggiore. Si tratta della mappa da 1,8 metri di Julius Schmidt,
realizzata grazie alle sue osservazioni, compiute principalmente
allOsservatorio di Atene (del quale Schmidt era direttore)
attraverso un rifrattore da 16 cm. Questa mappa riporta ben 33 mila
crateri!
Altre mappe seguirono, e vogliamo ricordare la pi grande realizzata
da un unico osservatore, quella di H. Percy Wilkins, da ben 7,6
metri di diametro (300 pollici), che contiene le immagini di circa
100 mila crateri! La sua prima versione risale al 1946. Negli anni
seguenti, Wilkins present successive edizioni della sua enorme
mappa, ma lepoca dei singoli osservatori stava tramontando e per
questo Wilkins deve ritenersi lultimo grande osservatore visuale
della Luna.
Ormai, la comunit astronomica internazionale, riunita nella
IAU (International Astronomical Union), dava pi credito alle
realizzazioni fotografiche, in quanto i progressi della fotografia
erano stati notevoli nella prima met del XX secolo. Con la
fotografia, si aveva finalmente un documento oggettivo, esaminabile
da pi ricercatori e in qualsiasi momento. Invece, nel disegno ci si
doveva basare su quanto registrato da un solo osservatore e dalla
sua capacit di precisione nel riportare i dettagli.
Il primo atlante fotografico degno di nota fu quello pubblicato
allinizio del XX secolo a Parigi a cura di Loewy e Puiseux. Allo
scopo, era stato progettato un apposito obiettivo acromatico da
60 cm di diametro a f/30, con fuoco coud.
Nel 1935 si ebbe la prima mappa lunare pubblicata dallUnione
Astronomica Internazionale, soprattutto a cura di M. A. Blagg e K.
Mller, che riportava 681 nomi.
Negli Anni 60, il planetologo Gerard Kuiper pubblic un atlante
fotografico molto completo, raccogliendo le migliori immagini
fotografiche provenienti da alcuni tra i maggiori osservatori del
mondo, tra i quali quello francese del Pic du Midi. Qui venne
utilizzato lobiettivo che era servito allatlante fotografico di Parigi,
cio il 60 cm f/30.
Ancora nella seconda met degli Anni 60, presso il Lunar and
Planetary Laboratory dellUniversit dellArizona, utilizzando
un riflettore da 1,5 metri, si ottenne il Consolidated Lunar Atlas:
il migliore atlante fotografico lunare completo, realizzato con un
telescopio dalla superficie terrestre e su pellicola tradizionale.
Nel frattempo, si ebbero molte altre realizzazioni, pi modeste, ma
mirate soprattutto verso gli appassionati di astronomia. Tra queste,
ci piace ricordare la Carta della Luna realizzata dal nostro Guido
Ruggieri nel 1958, con un diametro di 44 cm e pubblicata in sezioni
nel nostro libro La Luna (Milano, Gruppo B editore, 2009).
Note tecniche
Le formazioni di cui sono fornite le caratteristiche in questo Atlante
sono state scelte tra le pi appariscenti o meglio osservabili. Sono
in totale 336 (di cui 21 situate nel lato nascosto) e comprendono
soprattutto crateri. A parit di altri fattori, si data una leggera
prevalenza alle formazioni che hanno nomi di studiosi italiani.
La scala di 2,1 km al millimetro. Questo valore, per, vale solo
per il centro del disco. Man mano che ci si allontana dal centro, la
vera dimensione, lungo un raggio, si ottiene dalla misura diviso il
coseno della distanza angolare.
Per esempio, consideriamo una formazione che nellimmagine sia
lunga 10 mm lungo il raggio:
se si vede a un quarto della distanza tra centro e bordo e quindi a
14,5 dal centro, risulta di dimensioni: 10 mm x 2,1 km/mm / cos
14,5 = 22 km.
se si vede a met distanza tra centro e bordo e quindi a 30 dal centro, risulta di dimensioni: 10 mm x 2,1 km/mm / cos 30 = 24 km.
se si vede a tre quarti della distanza tra centro e bordo e quindi a
48,6 dal centro, risulta di dimensioni: 10 mm x 2,1 km/mm / cos
48,6 = 32 km.
Per evitare di ripeterlo costantemente, abbiamo spesso sottinteso
che la dimensione indicata si riferisce al diametro. Quindi, anzich
scrivere: Un cratere con un diametro di 50 km, ci siamo limitati
a: Un cratere da 50 km, o largo 50 km.
Spesso, anche se non sempre, abbiamo evitato di precisare che le
altezze delle pareti o delle cinte delle varie formazioni sono riferite
al fondo dei crateri. Ovvero, quando si afferma che un cratere ha
sulla cinta un picco che si eleva fino a 2000 m, questa misura si
intende - se non altrimenti indicato - rispetto al suo fondo.
Ricordiamo che la IAU ha deciso di attribuire nomi latini o
latinizzati, oltre che ai crateri, anche alle altre formazioni, elencate
in Tabella 1 con le denominazione latina e italiana a confronto.
Lultima Tavola dellAtlante riporta lemisfero lunare nascosto,
ovvero quello rivolto dalla parte opposta alla Terra e quindi
invisibile, tranne che per le zone molto prossime al bordo, grazie al
fenomeno delle librazioni.
Una prima immagine dellemisfero nascosto, ma di qualit molto
scarsa, si ottenne nel 1959 grazie alla sonda sovietica Lunik 3. In
seguito, se ne ebbero molte altre di qualit via via crescente, sino
a questultima del Lunar Reconnaissance Orbiter, realizzata con
la stessa tecnica a mosaico adottata per la ripresa dellemisfero
visibile.
Il sito di riferimento di questa immagine : http://lroc.sese.asu.
edu/news/index.php?/archives/345-Farside!-And-all-the-wayaround.html
Infine, per un rapido ritrovamento delle formazioni trattate nelle
Tavole, lAtlante completato da un indice analitico.
Ci auguriamo che questo lavoro possa risultare di utilit a chiunque
osservi la Luna e che, soprattutto, stimoli gli osservatori a dedicare
pi tempo al nostro unico grande satellite naturale.
Walter Ferreri
NOMENCLATURA LUNARE
Nome latino
Catena
Dorsa
Dorsum
Lacus
Mare
Mons
Montes
Oceanus
Palus
Promontorium
Rima
Rimae
Rupes
Sinus
Vallis
Tabella 1
Nome italiano
Catena di crateri
Gruppo di creste
Cresta presente in un Mare
Lago (piccola pianura lavica)
Mare (pianura lavica)
Montagna
Catena montagnosa o gruppo di picchi
Oceano (grande pianura lavica)
Palude
Promontorio
Solco
Rete di solchi
Scarpata
Golfo
Valle
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Xe
31
32
33
34
35
36
37
40
41
42
43
an
es
38
l
Vo
39
h
op
44
p
Re
a
lv
ni
so
ta
Markov
ld
SI N U S R O R I S
TAVOLA 1
G
er
ar
Dechen
Dechen. Da Ernst H. Karl von Dechen (18001889), mineralogista e geologo tedesco.
un piccolo cratere, con un diametro di soli 12 km, situato su
una lunga cresta che va da Repsold a Harding. Lo si nota facilmente, in quanto isolato dagli altri crateri.
Galvani. Da Luigi Galvani (17371798), il fisico e anatomista bolognese che viene ricordato per i suoi studi pioneristici
sullelettricit.
un cratere dalle dimensioni di tutto rispetto (80 km di diametro), che sarebbe anche appariscente, se la sua estrema vicinanza al bordo non ne rendesse difficile losservazione.
In pratica, lo si pu osservare solo quando la librazione favorevole.
Gerard. Da Alexander Gerard (17921839), esploratore scozzese noto per le sue esplorazioni sullHimalaya e in Tibet.
Cratere esteso (90 km), ma molto degradato. Al suo interno,
visibile una cresta che corre dal centro alla parete. Allestremit nord di questa cresta, il selenologo tedesco Julius Schmidt
vide un cratere.
Harding. Da Karl Ludwig Harding (17651834), astronomo
tedesco, che nel 1804 scopr lasteroide Giunone.
Un cratere con un diametro di 23 km e pareti dal bordo molto
netto.
Le osservazioni in luce radente mostrano che Harding situato
allinterno di un basso anello appena percettibile.
Markov. Da Andrei A. Markov (18561922), matematico russo specialista nella teoria delle probabilit.
Cratere da 40 km con il bordo delle pareti quasi tagliente che si
trova proprio allimboccatura del Sinus Roris. Vicino a Markov,
Harding
si vedono dei circhi quasi cancellati dalla lava che li ha sommersi.
Repsold. Ricorda Johann G. Repsold (17711830), costruttore
tedesco di strumenti meccanici di precisione e in particolare di
congegni astronomici.
Si tratta di una formazione grande (107 km), ma molto degradata.
Con un riflettore da 32 cm, il selenologo inglese del XX secolo Wilkins trov al suo interno quattro piccoli crateri prossimi
alla parete sud, tre colline vicine alla parete nord e una cresta
centrale.
Volta. il cratere che ricorda il nostro Alessandro Volta
(17451827), al quale si deve la realizzazione della prima pila
elettrica, nel 1800.
Bench molto esteso (113 km), questo cratere si vede solo
quando la librazione favorevole, essendo situato proprio lungo il bordo lunare nord-ovest.
Xenophanes. Da Xenophanes di Colophon, filosofo e poeta
greco (circa 570478 a.C.) che riteneva la Terra piatta.
Un cratere da 120 km che, come Volta, si vede quando la librazione favorevole, bench sia situato un po meno al bordo.
Ci nonostante, la posizione lo rende poco cospicuo.
15
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
14
Desa
22
Pyt
23
24
25
26
27
28
29
30
Babba
ge
hag
ora
32
33
34
35
36
37
40
41
42
43
im
nax
and
pen
ter
er
Horrebow
38
Ha rp alu s
39
Car
son
South
31
J. Herschel
R o b in
rgue
la Condamine
Bouguer
Fo uc au lt
44
Bianchini
Maupertuis
Sharp
TE
TAVOLA 2
JURA
Promontorium
Laplace
SI N U S
IRIDUM
A
Babbage. Questa formazione ricorda Charles Babbage (1792
1871), un matematico inglese inventore di una delle prime
macchine calcolatrici.
un grande (144 km) circo che a unosservazione attenta si
rivela dovuto alla fusione di due grandi formazioni anulari. A
sud del centro della formazione meridionale, si trova un profondo cratere, chiamato A, facilmente visibile con un piccolo
telescopio.
Bianchini. Dallastronomo italiano Francesco Bianchini
(16621729).
Questo cratere ha un diametro di 38 km e si trova quasi nel
mezzo della catena montuosa dei Monti Jura, quella che borda
il Sinus Iridum. Bianchini ha alte pareti dalla forma vagamente
poligonale e una montagna centrale con un cratere a nord e un
altro sulla parete a sud.
Harpalus. Dallastronomo greco Harpalus, vissuto intorno al
460 a.C.
un profondo cratere raggiato con un diametro di 39 km e alte
pareti che si ergono ad almeno 5000 m a ovest. Lo si distingue
facilmente, perch si trova nel bel mezzo del Mare Frigoris.
Sul fondo, si vedono una collina un po a sud del centro e un
piccolo cratere sotto la parete nord.
Iridum, Sinus. Il poetico Golfo della Rugiada, nome dovuto
a Riccioli.
Inizialmente un enorme cratere, con un diametro di ben 260
km, la cui parete sud stata completamente demolita dalla lava,
una volta fluida del Mare Imbrium. una delle regioni pi belle di tutta la Luna ed spettacolare da vedere anche con un
piccolo telescopio. Il bordo nord di questa formazione prende
il nome di Monti Jura; una catena molto aspra che contiene
numerosi picchi, pi alti nella parte centrale. Una grande montagna vicino a Sharp si eleva per almeno 6000 m.
J. Herschel. Ricorda John Herschel (17921871), lastronomo
nato in Inghilterra dal pi famoso padre William (emigrato dalla Germania).
Si tratta di una porzione della superficie lunare, con un diametro di ben 156 km, bordata da una montagna molto alta sul
lato orientale. Il vasto interno contiene numerose colline, crateri e creste, alcune delle quali indicano la presenza di antichi
circhi.
Pythagoras. Da Pitagora (circa 580500 a.C.), il fondatore
della scuola greca di filosofia e scienza, nella quale si pass
dalla concezione della Terra piatta a quella sferica.
un cratere molto evidente con un diametro di 130 km e pareti stupendamente terrazzate, che in alcuni punti raggiungono
i 5000 m rispetto al fondo sottostante. Sul fondo si vede facilmente un gruppo montuoso centrale, sulla cui sommit P.
Moore scopr nel 1952 un piccolo cratere con il rifrattore da 83
cm di Meudon.
Robinson. Da John T. R. Robinson (17921882), astronomo e
fisico irlandese.
Cratere a fondo piatto da 24 km con pareti terrazzate che contengono un craterino sul lato est.
Sharp. Nome dovuto allastronomo inglese Abraham Sharp
(16511742), che fu assistente di Flamsteed a Greenwich.
un profondo cratere con un diametro di 40 km. Sul fondo, si
vedono una piccola montagna centrale, alcuni bastioni e una
cresta a est. Sharp circondato da alte montagne, la pi alta
delle quali raggiunge i 6000 m.
6
Ponce
10
11
12
13
14
A n a x im
Mouchez
le t
enes
Cassini J.J.
Anaxagoras
Goldschmidt
Philolaus
Epigenes
15
16
17
18
19
20
21
22
Birmingham
Fontenelle
23
24
25
26
27
28
29
30
MA RE FRIG ORI S
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
38
TAVOLA 3
Plato
MONTES RECTI
MONTES
MA RE IMBRIUM
Anaxagoras. Filosofo greco vissuto dal 500 al 428 a.C.
Cratere da 51 km con raggiera. Ha pareti terrazzate che si ergono
fino e oltre i 3000 m, rispetto al fondo, dove si trova una brillante
collina centrale, alta circa 350 m.
Anaximenes. Dal nome del filosofo greco di Mileto (585-528
a.C.). Insegnava che il Sole era cos caldo a causa del suo girare
vorticosamente intorno alla Terra. Cratere da 80 km con pareti
che si ergono fino a 2500 m a ovest, ma pi basse nelle altre direzioni. A sud sono ancora visibili le vestigia di un vecchio circo.
Birminghan. Dal selenografo irlandese John Birminghan (18291884). Resti di un cratere da 92 km con un interno molto accidentato per la presenza di molte colline. Pareti molto frammentate.
Cassini J.J. Dal figlio di Gian Domenico, al quale succedette
come direttore allOsservatorio di Parigi (1677-1756).
una regione racchiusa da creste con una parete abbastanza ben
marcata a est. Allinterno sono visibili numerose colline e creste.
Fontenelle. Da Bernard de Fontenelle (1657-1757), astronomo
francese. Cratere da 38 km, con pareti strette ma brillanti a sud,
dove la parete interrotta in due punti. Allinterno, quasi proprio
al centro, si trova un piccolo cratere.
MONTES ALPES
TENERIFFE
Mons Pico
Philolaus. Filosofo greco della fine del V sec. a.C.; sosteneva
che la Terra in movimento e che al centro del cosmo vi fosse
un fuoco centrale.
Cratere da 71 km con pareti terrazzate che si elevano fino a 4000
m dal fondo, sul quale sono presenti molte irregolarit.
Pico, Mons. Montagna battezzata cos da Schroeder, che si riferiva al Pico von Teneriffe.
Montagna isolata alta 2400 m con base di 15x25 km, ben visibile
in ogni periodo in cui illuminata dal Sole.
Plato. Grande filosofo greco (Platone, 427-347 a.C.), allievo di
Socrate. una delle formazioni lunari pi cospicue e pi affascinanti. Si tratta di un circo da circa 100 km, con pareti a spigoli
netti alte mediamente 1 km, con cime che si elevano fino a 2 km.
Il fondo liscio costituito dallo stesso materiale di quello dei
mari, mediamente pi scuro ed costellato da minuscoli crateri.
Poncelet. Dal matematico francese Jean V. Poncelet (17881867). Cratere da 69 km poco appariscente, anche perch visibile molto di scorcio e talvolta invisibile, quando la librazione
sfavorevole.
Goldschmidt. Da Hermann Goldschmidt, astrofilo tedesco
(1802-1866). Pianura con pareti interrotte e un cratere a ovest.
Allinterno, vi un piccolo cratere appena a est del centro.
Recti, Montes. Catena diritta cos chiamata da Birt per il suo
aspetto. Lunghezza di circa 90 km e altezza fino a 1800 m. Il
picco pi brillante situato circa in mezzo, ma non raggiunge la
luminosit di Piton o Pico.
Mouchez. Da Ernest A.B. Mouchez (1821-1892), che fu direttore dellOsservatorio di Parigi.
Resti di un cratere da 82 km prossimo al lembo durante una
librazione media. Il fondo ospita una dozzina di piccoli crateri, alcune creste e un anello dal bordo basso.
Teneriffe, Montes. Nome dato in ricordo dei monti dai quali
Piazzi Smith fece i primi test di osservazioni telescopiche ad alta
quota. una catena montagnosa lunga circa 110 km e con altezze fino a 2400 m. Queste montagne segnano la parete di un
grande antico anello a sud-ovest di Plato.
Main
Challis
de Sitter
Scoresby
Euctemon
Baillaud
Meton
10
11
12
13
14
Barrow
Neison
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
Arnold
W. Bond
C. Mayer
23
Peters
Archytas
Kane
Sheepshanks
O R IS
M A R E F R IG
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
38
Protagoras
Galle
Aristoteles
s
lpe
l i s A Trouvelot
Va l
Mitchell
Egede
TAVOLA 4
Eudoxus
Alpes, Vallis. La celebre fenditura che attraversa la catena
montuosa delle Alpi e per questo chiamata Valle delle Alpi,
lunga 180 km. Visibile con un piccolo telescopio, una delle
formazioni pi interessanti della Luna. In passato si pensava
che fosse stata provocata da un meteorite passato di striscio, ma
oggi sappiamo che dovuta al raggrinzimento della crosta
lunare. Un potente telescopio rivela che il suo interno attraversato da un sottile crepaccio.
Archytas. Filosofo greco (428347 a.C.), uomo di stato e geometra. Un cratere relativamente piccolo ma brillante (32 km
di diametro). Mentre la parete a sud, sul Mare Frigoris, appare
liscia, quella a nord, verso W. Bond, confina con una regione
corrugata. Le pareti si elevano fino a 1500 m dal fondo, nel cui
centro vi una montagna.
Aristoteles. Grande filosofo greco vissuto dal 384 al 322 a.C.
i cui insegnamenti influenzarono profondamente il mondo fino
al Rinascimento.
un cratere con un diametro di 87 km e pareti terrazzate dotate
di picchi che raggiungono i 3600 m. Sul fondo vi sono molte
colline; un gruppo quasi al centro, dove si trovano anche i
resti di un vecchio circo. Dalla parete occidentale un gruppo di
montagne si estende fin quasi a Egede.
Arnold. Da Christoph Arnold (16501695), astronomo dilettante tedesco. Un circo con un diametro di 95 km e pareti molto
basse, quasi assenti a sud. Il fondo scuro e contiene un cratere
a nord-ovest, alcuni minuti craterini e delle colline.
C. Mayer. Astronomo e matematico austriaco (Christian Mayer, 1719-1783).
un cratere prominente con un diametro di 38 km di diametro
e una grande collina centrale. A nord-est una fila di collinette si
estende fin verso Peters.
Eudoxus. Da Eudosso, famoso astronomo greco (400-347 a.C.),
allievo di Platone. Per spiegare il moto dei corpi celesti, concep
un sistema di sfere concentriche, ruotanti intorno alla Terra.
Si tratta di un cratere appariscente, con pareti terrazzate e un
diametro di 67 km. Linterno presenta numerose colline, specialmente a nord-ovest. Nellinterno si vede unalta collina tagliata da un crepaccio, che attraversato da unaltra fessura.
Galle. Dal nome dellastronomo tedesco Johann G. Galle
(18121910), che avvist Nettuno nel 1846 in base alle indicazioni di Le Verrier.
un piccolo ma profondo cratere con un diametro di 21 km,
situato a nord-est di Aristoteles, nel Mare Frigoris. Sul fondo,
a ovest, vi un piccolo cratere, e un altro sulla parete sud.
Meton. Astronomo e matematico greco vissuto intorno al 430
a.C. (italianizzato in Metone).
Bench si tratti di uno dei maggiori circhi presenti sulla Luna
(diametro superiore ai 150 km), la sua posizione prossima al
lembo boreale lo rende poco appariscente. Visto con un piccolo telescopio la superficie interna appare liscia, ma un buon
strumento mostra che in realt il fondo rugoso. Un grande telescopio mostra una fenditura che inizia da un picco a nord-est.
W. Bond. Dal celebre astronomo americano William C. Bond
(17891859).
Si tratta di un circo con un diametro di 158 km, al cui interno
vi un profondo cratere da 11 km. Il vasto spazio interno
attraversato da file di colline, e in generale tutto il fondo appare
piuttosto tormentato.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Cus
anu
Schwabe
Democritus
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Thales
Strabo
de la Rue
Gartner
Endymion
MA RE FRIG ORIS
39
40
41
42
43
44
TAVOLA 5
Baily
Keldysh
Hercules
LACUS
Atlas
Burg
MORTIS
Atlas. Uno dei titani della mitologia greca (in italiano Atlante);
si trovava sullestremit occidentale della Terra e sosteneva il
cielo con le sue spalle.
Da unestremit allaltra misura 87 km e splende di una luce
che ricorda quella della madreperla. Un buon telescopio rivela
al suo interno colline, minuscoli crateri, cavit e crepacci.
Nel centro c una collina non molto alta, e tuttintorno vi sono
enormi massi, come se in quel punto fosse avvenuta unesplosione. Le pareti terrazzate si ergono rispetto al fondo di circa
3000 m.
Baily. Da Francis Baily (17741844), uomo daffari inglese
che dal 1825 si dedic completamente allastronomia. Fu il primo a descrivere il fenomeno dei grani di Baily, che osserv
durante leclisse totale di Sole del 1836.
Cratere con un diametro di 27 km e pareti molto erose, in parte
mancanti a sud, dove visibile un solco che attraversa il cratere
da nord-ovest a sud-est, passando per il suo centro. Sul fondo, a
nord, si vede un craterino.
Brg. Da Johann Tobias Brg (17661834), un astronomo austriaco che elabor una teoria sul moto della Luna.
un cratere con un diametro di 40 km, abbastanza prominente,
in quanto abbastanza isolato nel Lacus Mortis. Ha un fondo
molto concavo, con una doppia montagna centrale, sulla cui
sommit un grande telescopio rivela un minuscolo cratere.
Gran parte del fondo a ovest invaso dal materiale franato dalla parete occidentale.
De la Rue. Dallinglese Warren de la Rue (18151889), che fu
uno dei pionieri dellastrofotografia.
un circo largo 136 km, con le pareti in gran parte rovinate o
ridotte a frammenti, soprattutto nella parte sud-ovest. Nellin-
terno, si vedono molte formazioni e in particolare un profondo
cratere dalle pareti taglienti, situato al centro.
Endymion. Giovane pastore della mitologia greca che, baciato
dalla Luna (Selene), si addorment per sempre.
un cratere molto evidente, con un diametro di 125 km. Il
fondo scuro lo rende riconoscibile sotto ogni angolo di illuminazione. Le pareti sono molto alte, sui 5000 m.
Visto attraverso un piccolo telescopio, il fondo di questo cratere sembra liscio come un tavolo da bigliardo. Ma, con illuminazione radente, un grosso strumento rivela la presenza di
macchie bianche, una striscia di luce e alcuni minuscoli crateri
e colline o coni.
Hercules. Leroe della mitologia greca dotato di una forza straordinaria (in italiano, Ercole). Secondo Riccioli, a far scaturire
il mito di Ercole sarebbe stato un astronomo di questo nome
vissuto intorno al 1560 a.C.
Si tratta di un cratere molto evidente, non solo per le dimensioni (69 km), ma anche perch nel suo interno vi un cratere profondo con le pareti cos sottili che, viste dalla Terra, sembrano
taglienti come una lama.
Strabo. Geografo e storico greco (55 a.C.24 d.C.).
un cratere evidente con un diametro di 55 km; ha pareti terrazzate e linterno piatto uniforme. Perlomeno, questo laspetto che presenta se visto con un piccolo telescopio. Tuttavia,
uno strumento maggiore rivela che il fondo cosparso di minutissimi crateri.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
M
31
32
39
33
40
34
41
35
42
36
43
37
AR
HU
38
BO
LD
TI
AN
UM
44
TAVOLA 6
LACUS
Mercurius
Chevallier. Da Temple Chevallier (17941873), lastronomo
e matematico inglese che divenne direttore dellOsservatorio
di Durham.
Formazione con un diametro di 52 km, della quale rimangono
essenzialmente le rovine della cinta.
Con un piccolo telescopio, si pu vedere allinterno solo un
cratere dal fondo piatto; un telescopio potente invece rivela la
presenza di molti crateri minuti, molti dei quali formano degli
allineamenti.
Humboldtianum, Mare. Dal naturalista ed esploratore tedesco
Alexander von Humboldt (17691859). Nel 1799 osserv un
notevole sciame delle Leonidi dal Sud America.
La visibilit di questo bacino lunare, una pianura lavica circondata da pareti concentriche e con un diametro di circa 170
km, dipende molto dalla librazione lunare. Il suo bordo orientale contiene dei picchi, talvolta visibili di profilo, alti fino a
5000 m.
Mercurius. Da Mercurio, il leggendario messaggero degli dei.
Un bel cratere con un diametro di 68 km e il fondo essenzialmente piatto, al cui centro si trova una bassa collina. Sempre
allinterno, ma in prossimit della parete nord, vi sono due
piccoli crateri, dei quali il pi a nord anche il pi accessibi-
ll ie r
L
F G
Carrington
no
Carrington. Da Richard C. Carrington (18261875), lastronomo inglese che determin il periodo di rotazione del Sole.
Di questo cratere, che ha un diametro di 30 km, i piccoli telescopi mostrano soltanto un fondo uniforme a un livello molto
inferiore a quello del terreno circostante.
Solo strumenti molto potenti rivelano che il suo interno coperto da minutissimi craterini e attraversato da un solco che
passa per il centro.
Cheva
TEMPORIS
Ze
LACUS
SPEI
le. Un altro craterino, ancora pi visibile, situato sul pendio
esterno della parete sud-ovest. I crateri indicati con le lettere F
e G sono alla portata di un rifrattore da 60 mm.
Come in altri casi, i craterini indicati da una lettera che si trovano in prossimit di una formazione maggiore, hanno come
nome completo quello della formazione pi la lettera. Cos, i
craterini F e G si chiamano Mercurius F e Mercurius G. Noi,
per essere pi concisi, li chiamiamo quasi sempre con la sola
lettera.
Tra Mercurius e il lembo lunare, vi sono diverse formazioni,
tutte difficili da esaminare, a causa della loro sfavorevole posizione sul disco.
Spei, Lacus. Lago della Speranza. Denominazione recente.
una pianura lavica estesa per circa 80 km.
Temporis, Lacus. Lago del Tempo. Unaltra denominazione
recente.
una pianura lavica estesa per circa 250 km.
Zeno. Filosofo e astronomo greco-cipriota (336263 a.C.), che
spieg correttamente la ragione delle eclissi solari e lunari.
Cratere da 65 km la cui visibilit pesantemente condizionata
dalla posizione prossima al bordo; ci nonostante, vi si riesce
a scorgere un cratere sulla parete nord e due su quella sud. Le
piccole creste interne sono invece riservate a strumenti potenti,
poich linterno appare piuttosto liscio, se viene osservato con
telescopi medio-piccoli.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
41
42
43
44
ss
40
Ru
39
ell
Briggs
O C E AN U S
ru
ve
Schiaparelli
PR O C E L L AR U M
Ed
din
gt
on
St
TAVOLA 7
Briggs. Dal matematico inglese Henry Briggs (15561630),
che svilupp luso dei logaritmi neperiani.
un cratere con un diametro di 37 km e pareti piuttosto basse.
Il centro e la parte nord dellinterno sono occupati da montagne
e colline.
Uno strumento potente rivela che il fondo attraversato da parecchi solchi, tali da ricordare un piccolo Gassendi.
Eddington. Da Sir Arthur S. Eddington (18821944), grande
astrofisico e matematico inglese, che si occup della struttura
interna delle stelle e della Relativit.
un circo esteso (diametro di 125 km), in precedenza noto
col nome di Reinhold B, con le pareti in gran parte scomparse,
soprattutto verso sud-est.
Con un ingrandimento moderato, si ha limpressione di vedere
allinterno, un po a sud-est rispetto al centro, un cratere largo
7-8 km, ma i forti ingrandimenti dimostrano che si tratta solo di
due creste. Un potente strumento rivela la presenza di crepacci
nella regione interna di Eddington a nord-ovest.
Procellarum, Oceanus. LOceano delle Tempeste il pi
grande Mare lunare, con una superficie di 2,1 milioni di km quadrati (meno del nostro Mediterraneo). Mentre i suoi confini sono
relativamente netti a ovest, nord e sud, a est sono indefiniti.
Russell. Questa formazione ricorda il pittore britannico John
Russell (17451806), che fu anche un appassionato di astronomia e selenografo.
Una formazione estesa (103 km) ma molto degradata, fino al
punto che a sud la parete totalmente scomparsa e con Struve
forma quasi un unico circo con due lobi.
La prima formazione che si nota, quando lo si osserva, un
profondo cratere annidato sulla parete orientale, mentre una-
Seleucus
nalisi pi delicata rivela la presenza di minuscoli craterini sul
fondo.
Schiaparelli. Dal nostro Giovanni V. Schiaparelli (18351910),
scopritore, tra laltro, delle relazioni tra gli sciami meteorici e
le comete.
un cratere di piccole dimensioni (24 km), ma ben distinguibile. Le sue pareti si ergono per circa 1000 m rispetto al fondo, al
cui centro si trova una collina.
Uno strumento potente mostra due craterini sulla parte esterna
della parete nord-est, mentre anche uno strumento pi modesto,
in luce radente, rivela che Schiaparelli si trova al centro di una
cresta che attraversa lOceanus Procellarum.
Seleucus. Astronomo babilonese vissuto intorno al 150 a.C.,
difensore della teoria eliocentrica.
un cratere piuttosto evidente con un diametro di 43 km e pareti terrazzate che si elevano fino a 3000 m rispetto a un fondo
piuttosto infossato.
Una caratteristica di Seleucus quella di presentare una pendenza delle pareti molto dolce allesterno, aspetto che si nota
bene allosservazione telescopica, come anche una collina centrale e un piccolo cratere sulla parete a nord.
Struve. Per ricordare la dinastia degli Struve: Friedrich G.
Wilhelm von Struve, astronomo russo-tedesco (17931864),
Otto von Struve (18191905), direttore dellOsservatorio di
Pulkovo, e Otto Struve (18971963), astrofisico americano
nato in Russia.
Una pianura con un diametro di 170 km, delimitata da una cinta
montuosa bassa, sopra tutto a ovest. Allinterno sono facilmente visibili alcuni crateri dai contorni netti.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Gruithuisen
Wollaston
33
34
35
36
37
38
41
42
43
44
TAVOLA 8
S
llis c
Angstrm
Fedorov
Toscanelli
MONTES
HARBINGER
Artsimovich
Visl
Prinz
t
hr eri
Va
40
Krieger
Mons
Herodotus
Raman
39
NT
ES
CO
LI
32
RI
RU PE S
TO SC AN EL
31
AG
LA
Herodotus
Aristarchus
Brayley
Aristarchus. Dal celebre astronomo greco Aristarco da Samo
(310230 a.C.).
un cratere non molto grande (40 km) ma eccezionalmente
brillante, visibile anche quando illuminato solo dal chiaro
di Terra ed al centro di una raggiera. Per la sua luminosit,
Aristarchus attira subito lattenzione di chi osserva la Luna al
telescopio. William Herschel credeva che fosse un vulcano in
eruzione! Si pensa che abbia avuto origine solo 450 milioni
di anni fa.
Le sue poderose pareti si elevano per ben 3000 m rispetto al
fondo, al cui centro c una collina.
Aristarco il cratere dove sono stati osservati pi fenomeni
lunari transienti; bagliori e colorazioni poi scomparse. Anche
degli astronauti del progetto Apollo sono stati testimoni di tali
eventi.
Gruithuisen. In ricordo delleccentrico astronomo e fisico tedesco Franz von Gruithuisen (17741852), che scrisse un libro
sulla sua scoperta di fortificazioni e edifici lunari.
un cratere con un diametro di 16 km e la cinta alta circa 1800
m rispetto al fondo, molto netta. Circa 20 km a nord c un curioso ammasso di piccoli crateri.
Herodotus. Dallo storico greco Erodoto (484425 a.C.) di Alicarnasso, soprannominato il padre della storia.
un cratere da 35 km, dalle pareti relativamente basse (massima elevazione di 1000 m) e - in contrasto con Aristarchus
- con linterno scuro. Anche un piccolo telescopio mostra un
craterino sulla parete nord-ovest, mentre quelli che tempestano
il fondo di Herodotus sono accessibili solo a strumenti potenti.
Krieger. Un omaggio al selenografo tedesco Johann N. Krieger (18651902), che mor prematuramente per le numerose e
lunghe notti trascorse al telescopio a disegnare in dettaglio, con
una precisione sorprendente, la superficie lunare.
un piccolo circo (da 22 km) con allinterno un curioso terrapieno di forma quadrata e la parete nord rettilinea. A sud la cinta occupata dal piccolo ma profondo cratere Van Biesbroeck
(in precedenza noto come Krieger B), mentre a ovest, dove
pi bassa, arriva un piccolo solco sinuoso.
Prinz. Dal selenologo tedesco Wilhelm Prinz (18571910),
che fece studi comparativi tra la superficie terrestre e quella
lunare.
Sono essenzialmente i resti di un circo invaso dalla lava da 47
km. Linterno disseminato da parecchi craterini e da un accenno di collina centrale.
Un solco proveniente da nord arriva fino alla parete di Prinz,
dove questa pi alta (circa 1000 m rispetto al fondo), terminando sulla sua parte esterna.
Schrteri, Vallis. la maggiore valle sinuosa presente sulla Luna, il cui nome deriva dal selenografo tedesco Johannes
Schrter.
Questa valle inizia 25 km a nord del cratere Erodoto e si allarga
a 10 km per formare quella che lastronomo di Cambridge W.
H. Steavenson chiam Testa di Cobra. Da qui in avanti essa
tende sempre a restringersi.
La parte finale, quella pi a ovest, termina in un minuscolo cratere, ed cos sottile che sia essa che il piccolo cratere si vedono solo con un grande telescopio. La lunghezza totale di 160
km; la profondit massima di 1000 m. Fu il primo solco visto
sulla Luna da questo studioso di Hannover ed visibile anche
con un piccolo telescopio.
il nuovo
Tutta la superficie visibile della Luna in 44 Tavole fotografiche di grande formato, pi una Tavola per il
lato nascosto.
Le Tavole sono state realizzate grazie alle riprese ad altissima risoluzione effettuate dalla sonda lunare
LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) della NASA.
Le riprese sono state elaborate nei laboratori dellArizona State University, per ottenere unimmagine
completa della Luna come appare vista dalla Terra; ma con uninclinazione dei raggi del Sole simile su
tutta la superficie lunare, per una visone ottimale di tutti i crateri.
Le Tavole sono accompagnate, nelle pagine a fronte, da mappe che mostrano le disposizioni delle
formazioni pi interessanti (crateri, mari, monti, solchi) e dalle descrizioni dettagliate di oltre 330
formazioni, preparate da Walter Ferreri.
Unopera indispensabile per lappassionato osservatore della Luna, per il fotografo esperto di riprese
lunari, per lo studioso, per il semplice curioso del cielo, e per tutti coloro che amano il nostro unico
grande satellite naturale.
Atlante Fotografico
della Luna
ISBN 978-88-95650-364
22,50 euro
il nuovo Atlante
Fotografico della Luna
a cura di Walter Ferreri
a cura di
Walter Ferreri
45 Tavole
da foto originali NASA
GRUPPO
EDITORE
Potrebbero piacerti anche
- Atlante StellareDocumento21 pagineAtlante StellareMarchese Di Le Mans100% (1)
- Dizionario Della Nomenclatura LunareDocumento164 pagineDizionario Della Nomenclatura LunareRebecca WebbNessuna valutazione finora
- SONDE SPAZIALI. in Viaggio Tra I Segreti Del Cosmo (Libro / Ebook)Documento115 pagineSONDE SPAZIALI. in Viaggio Tra I Segreti Del Cosmo (Libro / Ebook)Fausto Intilla100% (2)
- Guida Pratica AstronomiaDocumento24 pagineGuida Pratica AstronomiaFrancescaNessuna valutazione finora
- Geologia 2Documento115 pagineGeologia 2Allegra DelmonteNessuna valutazione finora
- Atlante Della Creazione v.1-5 ADocumento400 pagineAtlante Della Creazione v.1-5 AZamir0% (1)
- Space ShuttleDocumento25 pagineSpace ShuttleCarlo Edoardo CapponiNessuna valutazione finora
- Fisica MedicaDocumento222 pagineFisica Medicaeliatan86Nessuna valutazione finora
- Astronomia Pratica Per NeofitiDocumento85 pagineAstronomia Pratica Per Neofitirinco16Nessuna valutazione finora
- I Molluschi Dei Terreni Terziari Del Piemonte e Della Liguria F. Sacco, 1892 - PARTE 11 - Paleontologia Malacologia - Conchiglie Fossili Del Pliocene e PleistoceneDocumento114 pagineI Molluschi Dei Terreni Terziari Del Piemonte e Della Liguria F. Sacco, 1892 - PARTE 11 - Paleontologia Malacologia - Conchiglie Fossili Del Pliocene e Pleistocenezingadula100% (1)
- Elementi Di CosmologiaDocumento135 pagineElementi Di Cosmologiajonathan.gelli5153Nessuna valutazione finora
- Molino Del PianoDocumento12 pagineMolino Del PianoJackson WallNessuna valutazione finora
- Introduzione All'AstrofisicaDocumento229 pagineIntroduzione All'Astrofisicaalterroses100% (1)
- Le Scienze 123 (1978)Documento130 pagineLe Scienze 123 (1978)lilliputNessuna valutazione finora
- Astronomia e Astrofisica: Osservare Il CieloDocumento5 pagineAstronomia e Astrofisica: Osservare Il CieloFederica AngioniNessuna valutazione finora
- Corsi Materiali PDFDocumento136 pagineCorsi Materiali PDFgiulio141091Nessuna valutazione finora
- Razza Di Deficienti - Isac Asimov 1958Documento2 pagineRazza Di Deficienti - Isac Asimov 1958TheOutOfMindNessuna valutazione finora
- Allinemamento PolareDocumento14 pagineAllinemamento Polarejupiter63Nessuna valutazione finora
- I Molluschi Dei Terreni Terziari Del Piemonte e Della Liguria L. Bellardi, 1887 - PARTE 5 - Paleontologia Malacologia - Conchiglie Fossili Del Pliocene e PleistoceneDocumento256 pagineI Molluschi Dei Terreni Terziari Del Piemonte e Della Liguria L. Bellardi, 1887 - PARTE 5 - Paleontologia Malacologia - Conchiglie Fossili Del Pliocene e Pleistocenezingadula100% (1)
- I Molluschi Dei Terreni Terziari Del Piemonte e Della Liguria L. Bellardi, 1872 - PARTE 1 - Paleontologia Malacologia - Conchiglie Fossili Del Pliocene e PleistoceneDocumento330 pagineI Molluschi Dei Terreni Terziari Del Piemonte e Della Liguria L. Bellardi, 1872 - PARTE 1 - Paleontologia Malacologia - Conchiglie Fossili Del Pliocene e Pleistocenezingadula0% (1)
- Appunti Di Astronomia LibroneDocumento380 pagineAppunti Di Astronomia LibroneFel JugNessuna valutazione finora
- Secchi Le StelleDocumento219 pagineSecchi Le StellegorlichNessuna valutazione finora
- Teoria Tettonica Delle PlaccheDocumento40 pagineTeoria Tettonica Delle PlaccheDaniele PulvirentiNessuna valutazione finora
- Astronomia Per Tutti - Volume 3 - Daniele GasparriDocumento134 pagineAstronomia Per Tutti - Volume 3 - Daniele GasparriPeppe PeppeNessuna valutazione finora
- Dispense AstrofisicaDocumento229 pagineDispense AstrofisicaHannaNessuna valutazione finora
- AA - Vv. - Analog Vol 2, Autunno 1994Documento295 pagineAA - Vv. - Analog Vol 2, Autunno 1994Francesco Antonio SpinelliNessuna valutazione finora
- Fabrizio Nicoletti, Percorsi Nella Sicilia Preistorica, Palermo 2003Documento36 pagineFabrizio Nicoletti, Percorsi Nella Sicilia Preistorica, Palermo 2003deuketiosNessuna valutazione finora
- Atlante Della Creazione v.1-5 BDocumento506 pagineAtlante Della Creazione v.1-5 BZamir0% (1)
- Il Monaco Che Inventò La Macchina Del TempoDocumento1 paginaIl Monaco Che Inventò La Macchina Del Tempocarlott6906Nessuna valutazione finora
- Sbob Russo-Calabro 2018-2019 PDFDocumento156 pagineSbob Russo-Calabro 2018-2019 PDFStani SantangeloNessuna valutazione finora
- Telescopi BaseDocumento32 pagineTelescopi BaseDaniele Lipari100% (1)
- Manuale Patologico OPTONDocumento111 pagineManuale Patologico OPTONGerson De Oliveira0% (1)
- L'uomo Che Ha Inventato Il XX Secolo. Nikola Tesla, Il Genio Dimenticato Dell'elettricità by Robert Lomas PDFDocumento183 pagineL'uomo Che Ha Inventato Il XX Secolo. Nikola Tesla, Il Genio Dimenticato Dell'elettricità by Robert Lomas PDFN3ssNessuna valutazione finora
- Dispense Di Astronomia PDFDocumento119 pagineDispense Di Astronomia PDFJan GrisantiNessuna valutazione finora
- I Molluschi Dei Terreni Terziari Del Piemonte e Della Liguria F. Sacco, 1893 - PARTE 14 - Paleontologia Malacologia - Conchiglie Fossili Del Pliocene e PleistoceneDocumento58 pagineI Molluschi Dei Terreni Terziari Del Piemonte e Della Liguria F. Sacco, 1893 - PARTE 14 - Paleontologia Malacologia - Conchiglie Fossili Del Pliocene e PleistocenezingadulaNessuna valutazione finora
- L'Aquila, Genesi Di Un Terremoto Di Luigina MarchesiDocumento8 pagineL'Aquila, Genesi Di Un Terremoto Di Luigina MarchesiFrancesco FurloneNessuna valutazione finora
- Malacofauna Dello Stratotipo Piacenziano, Pliocene Di Castell'Arquato Erminio Caprotti, 1976Documento35 pagineMalacofauna Dello Stratotipo Piacenziano, Pliocene Di Castell'Arquato Erminio Caprotti, 1976zingadula100% (1)
- Astronucleare - CastellaniDocumento294 pagineAstronucleare - CastellaniSam FurNessuna valutazione finora
- PO 85 Trivella Lesioni Palpebrali DEFDocumento9 paginePO 85 Trivella Lesioni Palpebrali DEFeye_fab-oftal2432Nessuna valutazione finora
- Glossario Di FotografiaDocumento8 pagineGlossario Di FotografiaCorrado BaudoNessuna valutazione finora
- Cap. 1 Principi Fisici Dell'EcografiaDocumento52 pagineCap. 1 Principi Fisici Dell'EcografiaValerio MazzeiNessuna valutazione finora
- John G. Fuller - Prigionieri Di Un UFO (1966) (PDF Ufologia Alieni Abduction Malanga Ipnosi)Documento248 pagineJohn G. Fuller - Prigionieri Di Un UFO (1966) (PDF Ufologia Alieni Abduction Malanga Ipnosi)qwertytetteNessuna valutazione finora
- Pietro Caricato - Manuale Di Navigazione A VelaDocumento98 paginePietro Caricato - Manuale Di Navigazione A VelaCarlitos Enrique100% (1)
- Astrofisica ZaninettiDocumento96 pagineAstrofisica Zaninettialterroses100% (1)
- (Med ITA) Anatomia Patologica CompletoDocumento489 pagine(Med ITA) Anatomia Patologica CompletoKranNessuna valutazione finora
- La Linea Meridiana Semita Della Certosa Di San Martino A NapoliDocumento21 pagineLa Linea Meridiana Semita Della Certosa Di San Martino A NapoliNicola SeverinoNessuna valutazione finora
- 26) Astronauti Ed AlieniDocumento7 pagine26) Astronauti Ed AlieniEgidio DBNessuna valutazione finora
- Fisioterapia RespiratoriaDocumento56 pagineFisioterapia RespiratoriaFabrizio PaglierucciNessuna valutazione finora
- Corso Di Astronomia 1 E 2 (Pag 139)Documento139 pagineCorso Di Astronomia 1 E 2 (Pag 139)AlessandroNessuna valutazione finora
- Sopravvivenza in Mare 1Documento103 pagineSopravvivenza in Mare 1puppettaNessuna valutazione finora
- I Celti e I Popoli ItaliciDocumento5 pagineI Celti e I Popoli ItaliciFrancesco BiancuNessuna valutazione finora
- ECG e Pratica Clinica Infermieristica - LEZIONEDocumento119 pagineECG e Pratica Clinica Infermieristica - LEZIONEmiao2011100% (1)
- Esercizi Di Carteggio Della Capitaneria Di SpeziaDocumento81 pagineEsercizi Di Carteggio Della Capitaneria Di SpeziafpttmmNessuna valutazione finora
- Plesso BrachialeDocumento19 paginePlesso Brachialepaolo68audisioNessuna valutazione finora
- Calace Music List PDFDocumento2 pagineCalace Music List PDFgermanlago100% (1)
- Dispositivi Cardiaci ImpiantabiliDocumento101 pagineDispositivi Cardiaci Impiantabilithecorfiot5Nessuna valutazione finora
- Videogiochi 1Documento84 pagineVideogiochi 1Marco MartinelliNessuna valutazione finora
- Boulle Pierre - Il Pianeta Delle ScimmieDocumento74 pagineBoulle Pierre - Il Pianeta Delle Scimmielostrambo100% (1)
- Astronomia Per Tutti Volume 1Documento86 pagineAstronomia Per Tutti Volume 1Marco D'AmicoNessuna valutazione finora
- Parte XV - SIRIODocumento13 pagineParte XV - SIRIOnaike azzenaNessuna valutazione finora
- L' Universo e Il Sistema SolareDocumento15 pagineL' Universo e Il Sistema SolareMELANIA FAZZINONessuna valutazione finora
- Emissione Di Corpo Nero e Applicazioni AstrofisicheDocumento23 pagineEmissione Di Corpo Nero e Applicazioni AstrofisicheDaniela GargiuloNessuna valutazione finora
- Astronomia Per Tutti - Volume 5 - Daniele GasparriDocumento150 pagineAstronomia Per Tutti - Volume 5 - Daniele GasparriPeppe PeppeNessuna valutazione finora
- Il Cielo Nella Navigazione AnticaDocumento32 pagineIl Cielo Nella Navigazione Anticamiriam1skibaNessuna valutazione finora
- Aula 5 Frente 1Documento24 pagineAula 5 Frente 1Henrique Liki SchnitzspahnNessuna valutazione finora
- Formulario Di Astronomia: Cos CosDocumento2 pagineFormulario Di Astronomia: Cos CosArcangelo Di TanoNessuna valutazione finora
- ASTROLOGIA DELLE BORSE - Come PR - GIACOMO ALBANODocumento90 pagineASTROLOGIA DELLE BORSE - Come PR - GIACOMO ALBANOFrancesca CostanteNessuna valutazione finora