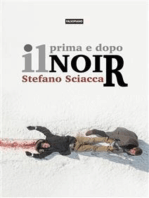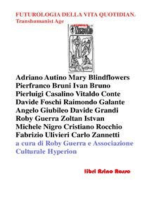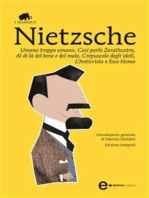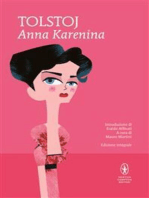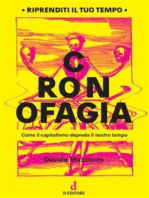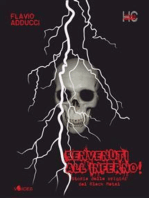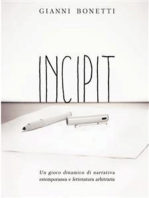Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Il Linguaggio Del Cinema Luca Malavasi
Caricato da
HamzaTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Il Linguaggio Del Cinema Luca Malavasi
Caricato da
HamzaCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|5437225
Il linguaggio del cinema - Luca Malavasi
Storia e critica del cinema (Università degli Studi di Genova)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
Il linguaggio del cinema
La narrazione
Tutti i racconti appaiono regolati da uno schema fondato sulla successione e sulla trasformazione, in cui un
evento o una serie di eventi giungono a compromettere l’equilibrio di una situazione di partenza,
alimentando una situazione di squilibrio che solo un secondo evento permette di superare e risolvere, per
ristabilire una nuova condizione di equilibrio. Altro aspetto essenziale del raccontare storie è quello del
legame causale tra gli eventi, che agiscono come operatori di trasformazioni, causando degli effetti che, a
loro volta, si rivelano la causa di ulteriori trasformazioni, dove vi è una catena dinamica di eventi allacciati in
un rapporto di causa-effetto, non lasciando nulla al caso e riducendo al minimo il ruolo di altri elementi
narrativi, rendendo esplicito un terzo fattore, quello del legame determinante tra personaggi e azioni, e tra
azioni e desideri.
Il termine narrazione possiede 2 significati principali:
Uno di processo, cioè l’azione del narrare
E uno di prodotto, cioè il singolo racconto
Si nota quindi l’idea che la narrazione chiama sempre in causa degli stili narrativi e dei generi narrativi. A
fare ordine in questo vasto campo ci pensa la narratologia, che può essere suddivisa (come dice Gérard
Genette, uno dei padri della disciplina) in:
Narratologia tematica, che si occupa dei contenuti narrativi, della loro grammatica e della loro
logica, puntando l’attenzione sulla narratività. Essa permette di descrivere in modo meno generico
o intuitivo la natura stratificata del racconto, e di identificare con più precisione le logiche profonde
e i fattori strutturali della narrazione. Può quindi anche essere definita come narratologia del
contenuto.
Narratologia modale, che guarda al racconto come processo e azione, puntando l’attenzione sul
modo in cui un determinato linguaggio dà vita e organizza la narrazione. Può anche essere definita
come narratologia dell’espressione. Di questa categoria fa parte l’ambito degli studi
cinematografici.
Entra dunque in campo lo strutturalismo che mira a descrivere le strutture invarianti dei fenomeni culturali,
in rapporto con la linguistica.
Il modello di Greimas
L’attenzione si sposterà quindi dalla narrazione alla narratività (grazie a Greimas), che rappresenta un
tentativo di chiarire che cosa accomuna tutti i tipi di racconto e che cosa permette loro di significare. In
questa teoria, un testo è pensato come una struttura a 4 livelli:
La grammatica fondamentale
La grammatica narrativa: a questo livello l’articolazione semantica del primo, immaginata come una
serie di rapporti tra termini contrari (bianco e nero), si “veste” narrativamente grazie agli attanti, in
tutto 6, raggruppati in 3 coppie:
1. Soggetto e Oggetto di valore. Questa è la coppia più importante, perché tutte le narrazioni
possono essere descritte come il fare di un Soggetto che agisce spinto dal desiderio di
congiungersi con un Oggetto di valore (che può essere sia un oggetto materiale che
immateriale), e che nella sua ricerca non è ostacolato solo da un Opponente, ma anche da
un AntiSoggetto, che proietta un programma narrativo opposto a quello del Soggetto. I
punti essenziali sono quindi 2:
Il legame reciprocamente qualificante tra Soggetto e Oggetto di valore
La natura “polemica” della narrazione: il programma narrativo di un Soggetto che
sviluppa in relazione al programma narrativo di un AntiSoggetto.
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
2. Destinante e Destinatario. Il programma narrativo-tipo prevede che inizialmente, il
Soggetto non sia in congiunzione con l’Oggetto di valore, e che a innescare l’azione
contribuisca il dovere proiettato da un’istanza detta Destinante (che può coincidere con
una figura esterna, ma anche con un imperativo sociale o con un processo psicologico o
morale interiore). Nella prima fase, della manipolazione, il destinante contratta con il
Soggetto spronandolo a intraprendere un programma narrativo per la conquista
dell’Oggetto di valore. La fase successiva è quella della competenza: attraverso la prima
delle tre prove che il Soggetto deve affrontare lungo il suo percorso, detta qualificante, egli
acquisisce il sapere e il potere necessari a congiungersi con l’Oggetto di valore. Segue
quindi la fase detta performanza, in cui il Soggetto agisce per trasformare una serie di stati,
raggiungendo un risultato positivo o negativo attraverso la prova decisiva, che consiste in
una lotta fra Soggetto e AntiSoggetto; insieme, competenza e performanza definiscono la
fase dell’azione. Chiude il percorso narrativo la fase della sanzione, in cui il Desinante
giudica il Soggetto e la sua azione. La sanzione è di 2 tipi:
Pragmatica: il Destinante giudica la performance del Soggetto sulla base della sua
conformità a quando contrattualizzato nella fase di manipolazione
Cognitiva: il Destinante non giudica l’azione ma l’essere del Soggetto. Questo tipo di
giudizio equivale al riconoscimento del suo statuto eroico.
3. Aiutante e Opponente
La struttura discorsiva
La manifestazione testuale
La visione di Gremais ci invita a guardare alla narrazione come a una successione di trasformazioni di stato,
che risulta concentrato sull’avventura di un soggetto che, da una condizione subita, evolve verso
l’acquisizione di un sapere e di un poter fare, grazie ai quali può soddisfare il desiderio di cambiamento che
ha innescato il percorso.
La possibilità di isolare dei modelli più o meno universali di narrazione si deve anche al “raccontare storie”,
che rappresenta un’attività fondamentale dell’essere umano, pratica orientata al problem solving. Da qui
nasce l’idea che le narrazioni ruotino essenzialmente attorno a un’unica struttura basata sul problema, che
conduce a strizzare tutti i racconti in una formula del tipo: Storia=Personaggio+Situazione
difficile/Problema+Tentativo di superamento. Una sequenza che ci ricorda che non esiste racconto senza
qualche tipo di trasformazione e senza la perturbazione di un ordine originario e la creazione di una nuova
situazione; al centro di tutto, un soggetto in divenire.
Il modello di Field
La dimensione delle azioni, seguendo la Poetica di Aristotele, viene divisa in fasi (“atti”), che vengono
ribattezzate Impostazione, Confronto e Risoluzione, e lungo questa ossatura Field colloca i plot point,
ovvero punti di svolta innescati da uno o più eventi, che generano a loro volta una sequenza di avvenimenti
destinati a condurre la storia in direzioni diverse e inattese. In particolare, sempre secondo Field, una
sceneggiatura dovrebbe sempre possedere 2 plot point, uno posizionato grosso modo al termine della fase
Impostazione (circa 30 min. di film) e l’altro alla fine della fase di Confronto (circa 60 min. di film). Nell’atto
di Confronto, si colloca inoltre (dopo circa 45 min. di film) il primo dei due pitch point, che servono a
“pinzare” il racconto:
1. Il primo dovrebbe contribuire a chiarire la posta in gioco e a introdurre ulteriori elementi e
personaggi. Questo pitch point prepara inoltre il cosiddetto midpoint, ovvero il punto di non ritorno
della vicenda.
2. Il secondo svolge la doppia funzione di innescare una nuova serie di eventi e di chiarire la posta in
gioco e i valori del film.
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
Il secondo plot point, destinato a chiudere la fase di Confronto e ad aprire quella della Risoluzione, coincide
con un secondo momento di svolta della vicenda, il più drammatico, in cui il destino dell’eroe appare del
tutto incerto.
Il terzo atto, quello della Risoluzione, conduce alla conclusione della vicenda attraverso un massimo di
azione e di tensione, che prende il nome di climax. Una sequenza action in cui il fattore tempo si fa cruciale,
alimentando una crescente incertezza circa l’esito della vicenda e, dunque, un sentimento di suspense.
Risolti vittoriosamente i problemi che hanno innescato il racconto, la terza fase è suggellata dal ritorno
dell’eroe al mondo di partenza e dalla chiusura di tutte le piste narrative più o meno direttamente connesse
al plot principale.
Il modello di Vogler
Un altro modello di impronta strutturalista è quello di Vogler, centrato essenzialmente sulla descrizione del
“viaggio dell’eroe”, vale a dire sulle trasformazioni soggettive che definiscono le diverse fasi della sintassi
narrativa. Egli pone al centro del suo modello il percorso del soggetto protagonista, l’eroe, mantenendo per
il resto inalterata sia la centralità semantica del “problema” sia un andamento sintattico tripartito.
Primo atto: fase di presentazione e di innesco della vicenda. Una situazione ordinaria viene
danneggiata, generando una forma di mancanza e, di conseguenza, un richiamo all’avventura nei
confronti dell’eroe. Non viene introdotto solo l’eroe ma anche i valori in gioco. La presa di coscienza
da parte dell’eroe della necessità di muovere all’azione può dipendere da 5 meccanismi:
1. Un’urgenza interiore
2. Una notizia condotta da un messaggero
3. Un evento tragico
4. Il ripetersi di una situazione esasperante
5. Un sogno o una visione
Ma il passaggio all’azione conosce generalmente un’ulteriore complicazione: il primo richiamo
viene infatti rifiutato dall’eroe. È dunque necessario un secondo accadimento che contribuisca a
motivare definitivamente l’eroe ponga con più evidenza la questione della scelta, che si carica di un
ulteriore valore di tipo soggettivo e personale. Questa fase preparatoria non è completa senza la
presenza di un Mentore: spesso un ex-eroe, una figura chiave per come prefigura l’avventura e
consegna all’eroe un sapere e un potere. Quindi le 4 fasi che compongono il primo atto e occupano
circa i primi 30 min. del film sono: Mondo ordinario, Richiamo all’avventura, Rifiuto dell’avventura e
Mentore.
Secondo atto: si concentra l’azione successiva alla decisione di lasciare il mondo ordinario e di
varcare la soglia verso il mondo straordinario dell’avventura. Qui si colloca una delle tante prove
che l’eroe dovrà affrontare: una specie di “test” che avvia la descrizione del mondo straordinario e
che presenta le trasformazioni interiori alle quali l’eroe andrà incontro, prima tra tutte il confronto
con le proprie paure. Nel suo percorso l’eroe è aiutato da uno o più alleati, ma anche intralciato o
combattuto da uno o più opponenti. La continuazione del viaggio è caratterizzata da 3 elementi:
1. La presenza di prove sempre più dure
2. Il superamento di una seconda soglia
3. L’individuazione del luogo in cui si trova l’oggetto con cui risolvere il problema
Varcata la seconda soglia si colloca la prova suprema, segnata da una crisi in cui l’eroe sembra
soccombere. Il superamento della prova suprema equivale a un cambiamento profondo dell’eroe,
che vince le proprie paure, sconfigge l’antisoggetto e rimuove la mancanza. Segue una fase di
ricompensa, una pausa destinata al festeggiamento e alla sanzione dell’azione dell’eroe. Il secondo
atto, che occupa circa 60 min. del film, si conclude con il ritorno dell’eroe verso il mondo ordinario.
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
Quindi le fasi del secondo atto sono 5: Prove, nemici, alleati, Avvicinamento, Prova suprema,
Ricompensa, La via del ritorno.
Terzo atto: la strada del ritorno è caratterizzata da una seconda e ultima prova suprema. È il
momento del climax, e, questa nuova prova, collocata nel mondo ordinario, mira a verificare le
capacità dell’eroe di mettere in pratica quanto ha appreso durante la sua avventura nel mondo
straordinario. Il climax si basa su una scelta, grazie alla quale l’eroe dimostra al mentore di essere
cambiato. Ne derivano una seconda morte e una seconda rinascita metaforiche, seguite da
un’ultima fase, quella del Ritorno con l’elisir: è il momento in cui l’intreccio si scioglie
definitivamente, l’eroe viene premiato e l’anti-eroe punito. Per quanto riguarda le modalità di
chiusura del racconto, Vogler ne distingue 2 tipi:
1. Tutti i problemi trovano una soluzione e la storia si chiude
2. Non tutti i nodi risultano sciolti, e il finale appare aperto
L’ultimo atto, che si sviluppa negli ultimi 30 min. di film, è composto da 2 fasi: Resurrezione e
Ritorno con l’elisir.
Questo modello si basa su una doppia articolazione: da un lato la narrazione viene segmentata in fasi di
tensione e fasi di distensione; dall’altro, sviluppa un disegno graduato e ritmato della trasformazione
dell’eroe, che si tende tra un’iniziale “consapevolezza limitata” e una finale “padronanza del problema”.
Questi modelli definiscono un regime narrativo, cioè un sistema coerente di scelte attorno alle quali si
aggregano i modi di interpretare e far interagire gli elementi base della narrazione.
Tipi di narrazione
Il regime di narrazione forte nasce negli anni 10 del 900 con il cinema classico, ma rimane il riferimento
essenziale per il film di finzione narrativa. Si basa su una concatenazione stringete dell’azione e su
un’assiologia trasparente. La spina dorsale del racconto è rappresentata dal percorso di crescita di un
protagonista principale, le cui azioni dettano l’avanzamento della narrazione, conducendo alla risoluzione
del problema che ha innescato la vicenda.
All’opposto vi è il regime dell’anti-narrazione, basata una perdita di centralità dell’azione, su
un’opacizzazione del rapporto tra ambienti e personaggi, su una frammentazione della struttura narrativa,
che smarrisce la propria coerenza e saldezza. I valori in gioco anziché opporsi si contaminano, quando non
si eclissano del tutto. Sovrapposto almeno in parte vi è il concetto di disnarrazione, che lavora a scardinare
tutte le illusioni caratteristiche del romanzo o del film realista e, in particolare, quelle su cui si regge il
paradigma della narrazione forte.
Esiste anche la narrazione debole, regime caratteristico di molto cinema d’autore, che preferisce lavorare
sull’accadere delle cose piuttosto che sul loro intreccio causale, lasciando ampio spazio ai percorsi
psicologici ed emotivi dei personaggi, e all’esplorazione interrogativa delle loro interazioni con l’ambiente
che li circonda.
Racconto e narratore sono le parole chiave della narratologia modale, attorno ai quali si è sviluppata una
narratologia filmica indipendente da quella del testo letterario.
Le caratteristiche linguistiche del cinema sembrerebbero collocare i film in un territorio comunicativo misto
tra romanzo e rappresentazione teatrale. Dal punto di vista narrativo la rappresentazione cinematografica è
un accadere “presente” di una serie di azioni e di eventi su una scena mutevole ma, al tempo stesso, giunge
allo spettatore come già avvenuta, collocata in uno spazio e in un tempo precedenti rispetto a quelli della
proiezione. In questo senso un film può esistere solo per mezzo di un’istanza mediatrice. Un altro elemento
caratteristico della rappresentazione cinematografica è la presenza di un orientamento dello sguardo: la
macchina da presa perlustra la “scena”, modificandone la percezione e guidando, nel tempo e nello spazio,
lo sguardo dello spettatore. La narrazione cinematografica è in definitiva una mescolanza tra mimesis
(l’imitazione dell’azione, tipica del teatro) e diegesis (racconto di un narratore, tipico della letteratura), di
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
azioni al presente e di manipolazione narrativa da parte di un’istanza che, attraverso le risorse offerte dal
linguaggio cinematografico, dà forma e comunica un racconto. Dunque, il racconto cinematografico è l’esito
di un duplice processo di mediazione e di articolazione: da un lato, l’azione di un mostrare filmico che si
manifesta essenzialmente nell’incontro tra una scena e lo sguardo dinamico della macchina da presa;
dall’altro lato, l’azione di un narratore filmico, che articola l’insieme delle immagini. Ma il ruolo
specificamente narrativo del montaggio si manifesta anche attraverso l’eventuale introduzione di tutta una
serie di elementi esterni, tipo l’aggiunta di musiche di accompagnamento o di elementi scritti e gli
interventi in computer grafica. Il racconto cinematografico è una <<sequenza due volte temporale: c’è il
tempo della cosa-raccontata e il tempo del racconto>>, e il secondo è sempre una “distorsione” del primo.
È in questo senso che il cinema si oppone alla realtà. Il racconto è quindi un discorso chiuso che viene a
irrealizzare una sequenza temporale di avvenimenti.
Modificazione della durata
Il caso più comune di manipolazione della durata reale degli eventi è l’ellissi: serve a eliminare alcune
porzioni di storia, considerate non necessarie ai fini del racconto. Al contrario, il sommario costituisce una
figura di sintesi temporale, nella quale una serie di azioni e di eventi, sono presenti in rapida successione.
Con il termine scena si definisce il caso in cui il tempo del racconto equivale al tempo della storia.
All’opposto del sommario funziona la dilatazione, in cui il tempo del racconto si “allarga” rispetto a quello
della storia. Una sospensione caratterizza la pausa: in questo caso il tempo del racconto sembra rallentare
fino a fermarsi, perdendo il proprio aggancio con l’azione; all’interno del racconto cinematografico la pausa
coincide il più delle volte con una descrizione. Un altro tipo di sospensione è il fermo immagine, o frame-
stop, dove il fluire degli eventi si congela, lasciando sullo schermo un fotogramma fisso. In virtù del modo in
cui interviene a manipolare la durata, il fermo immagine merita di essere considerato a parte o affiancato
all’accelerato e al ralenti, che contribuiscono a imprimere un’accelerazione e un rallentamento al flusso
degli eventi. In tutti e tre i casi, la narrazione afferma una specie di totale autonomia temporale.
Altro ricorso è il flashback, che subisce un’ulteriore distinzione in basa alla sua posizione: essendo sempre
un “racconto secondario” può posizionarsi sia all’interno che all’esterno del “racconto primo”. Ma vi è
ancora un’altra suddivisione in: oggettivi, cioè trasmessi dal narratore, e soggettivi, cioè condotti da un
personaggio e dunque dipendenti dalla sua esperienza. I primi svolgono normalmente un ruolo di
arricchimento o completamento del racconto, i secondi possono anche compromettere una simile funzione
per accentuare la loro dipendenza dal lavorio memoriale del personaggio, assumendo la forma di
frammenti intimi, o introducendo nella vicenda un’anacronia destinata a rivelarsi parziale o erronea.
Nel cinema moderno e postmoderno, viene usata una figura concettualmente diversa da quella del
flashback, cioè il flashforward, cioè un “salto in avanti” del tempo del racconto, in cui un frammento di
futuro si incassa nel presente, anticipando qualcosa che accadrà in un momento cronologico successivo.
Altri ricorsi ancora sono i casi di frequenza ripetitiva, in cui un evento accaduto una sola volta nella storia
viene mostrato più volte nel racconto, contraddicendo la condizione più comune di corrispondenza
puntuale, uno a uno, tra un evento singolo e la sua rappresentazione cinematografica (frequenza
singolativa). Spesso la ripetizione non appare del tutto identica. Ultima categoria è quella della frequenza
iterativa, in cui una singola rappresentazione discorsiva si incarica di raccontare un fatto accaduto più volte
nella storia.
Racconto e narratore
L’analisi dei rapporti tra racconto e narrazione si occupa di descrivere le modalità di regolazione
dell’informazione narrativa e la prospettiva che filtra la rappresentazione del mondo diegetico. Sulla base di
come un film amministra le informazioni e, in particolare, i rapporti di sapere tra narratore, personaggi e
spettatore, si definisce la modalità della sua consegna. Un caso emblematico del rilievo narrativo è
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
rappresentato dalla suspense, un “effetto” che si produce a partire da una divaricazione tra il sapere dello
spettatore (di natura onnisciente) e il sapere di un personaggio (limitato alla sua prospettiva).
La questione dell’identità dell’istanza narrante e delle sue eventuali personificazioni all’interno del racconto
è un aspetto che sposta l’asse dell’analisi dal modo in cui un racconto filtra le informazioni in merito al
mondo diegetico al tema della voce. La focalizzazione, che riguarda il racconto in sé, è la collocazione del
focolaio di percezione, esprimendo un aspetto per certi versi neutro. Anche per quanto riguarda la
focalizzazione, vi sono varie suddivisioni:
- racconto non focalizzato o a focalizzazione zero, che fornisce allo spettatore un’informazione
completa ed esauriente, rendendolo onnisciente
- focalizzazione interna: il punto focale coincide con un personaggio, che diventa il soggetto fittizio di
tutte le percezioni. In questo caso lo spettatore partecipa agli eventi allineato al sapere di un
singolo personaggio, posizionamento che può restare immutato per tutta la durata del racconto
(focalizzazione interna fissa) oppure cambiare, spostandosi verso un altro personaggio
(focalizzazione interna variabile)
- focalizzazione esterna: il fuoco si trova in un punto dell’universo diegetico scelto dal narratore al di
fuori di qualsiasi personaggio. Lo spettatore appare come collocato al di fuori del racconto.
Il posizionamento del fuoco percettivo è determinato: tanto la focalizzazione interna come in quella esterna
rappresentano una restrizione di campo, che possono anche riguardare singole porzioni di un racconto per
il resto a focalizzazione zero.
Nel cinema, espressioni come punto di vista, fuoco e sguardo perdono qualsiasi valore simbolico. Al
contrario, il cinema dispone di una figura, la soggettiva, in cui l’idea di un allineamento percettivo dello
spettatore al sapere di un personaggio si può tradurre in un vedere del primo dalla posizione ottica del
secondo. Nel caso del cinema i rapporti tra il sapere e il vedere si possono articolare in forme più
complesse, quindi, alla nozione di focalizzazione va affiancata quella di ocularizzazione, ovvero che lo
spettatore può accedere al mondo del racconto anche attraverso la mediazione di uno sguardo vivo. Più
precisamente si può parlare di:
- ocularizzazione interna, quindi soggettiva, quando un’inquadratura appare riconducibile al
guardare di qualcuno. Questa identifica tutti quei casi in cui un’inquadratura si manifesta
esplicitamente come l’azione di un occhio e questo sguardo non deve necessariamente
appartenere a un personaggio. Viene quindi proposta un’ulteriore suddivisione:
o ocularizzazione interna primaria, quando la visioni di qualcuno resta “senza volto”. Questo
tipo di ocularizzazione, oltre che a rimandare a un narratore, può anche rimandare a un
personaggio del racconto
o ocularizzazione interna secondaria, a questo tipo corrisponde la soggettiva: grazie al
raccordo di sguardo, un’immagine viene identificata come la visione di qualcuno che è stato
precedentemente inquadrati mentre osserva qualcosa
- ocularizzazione zero (più comune), dove un’inquadratura non rinvia ad alcun tipo di sguardo;
coincide anche con un’inquadratura oggettiva, che presenta le cose senza alcuna mediazione.
È così più chiara come l’idea di ocularizzazione si affianchi a quella di focalizzazione: essa consente di dare
conto del fatto che al cinema il sapere spettatoriale può anche passare attraverso un “vedere con”
installato in uno sguardo, riferibile ora a un personaggio, ora all’istanza narrante, ora, più genericamente a
un “occhio”. Senza per questo confondere i due piani: l’ocularizzazione esalta il momento del vedere,
mentre la focalizzazione studia la regolazione complessiva delle informazioni, cui possono partecipare
diverse configurazioni scopiche.
In un film, il narratore rappresenta il primo e unico responsabile della narrazione. Per capire “chi parla”,
bisogna fare riferimento alla teoria dell’enunciazione, secondo la quale, il soggetto responsabile di un testo
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
coincide con un aggregato di operazioni attraverso le quali un enunciatore attualizza un insieme di virtualità
in un testo indirizzato a un enunciatario. Di conseguenza, la teoria dell’enunciazione cinematografica ha
condotto essenzialmente a svincolare l’idea di soggettività da quella di soggetto. Da qui la distinzione tra:
- enunciazione storica: caratterizzata dall’uso del passato remoto e della terza persona
- enunciazione discorsiva: caratterizzata dall’uso del presente e della prima o seconda persona
L’enunciazione cinematografica è quindi un’enunciazione impersonale. Dunque, l’enunciazione filmica si
incarna nel disegno stesso che organizza gli enunciati, e la sua manifestazione testuale coincide
inevitabilmente col “farsi” del film e col suo “darsi” a un enunciatario.
Il secondo tempo della ricerca sull’enunciazione filmica ha avuto di mira l’analisi delle strategie attraverso le
quali l’enunciazione cinematografica si dà a vedere, esponendo l’”effetto finzione” e affermando la natura
discorsiva del film, ovvero in tutti i casi in cui un film sembra funzionare in modo “eccentrico”, marcando, la
propria natura discorsiva, alle quali bisognerebbe aggiungere molte altre occorrenze, a partire dagli
interventi sull’ordine del racconto.
La divaricazione tra un narratore interno al testo e un’istanza narrante che lo racconta raccontare è
semplice: mentre il narratore primo e il narratore secondo di un’opera letteraria condividono lo stesso
strumento d’espressione (la parola), nel caso del cinema abbiamo a che fare con due diversi veicoli
semiotici, le parole e le immagini. In rapporto all’analisi dei processi di figurativizzazione dell’istanza
narrante, vi si può estendere la distinzione tra narratori intradiegetici ed extradiegetici, e tra narratori
eterodiegetici e omodiegetici. Come un romanzo, un film può essere raccontato da un narratore estraneo,
che dà vita a un racconto di primo livello, oppure da un narratore interno, il cui racconto si incassa in quello
originario.
A determinare la natura di un enunciato può contribuire anche il contesto complessivo di un film, come nel
caso dell’interpellazione, in cui un personaggio guarda e parla rivolgendosi direttamente verso la macchina
da presa e, quindi, verso lo spettatore.
Un quarto regime, diverso da quello della narrazione forte, della narrazione debole e dell’anti-narrazione, è
il metanarrativo, che fa di sé l’oggetto specifico e il terreno elettivo del proprio comunicare, e lo fa
praticando continue interferenze e contaminazioni con i modelli precedenti.
Nel caso del cinema moderno, l’analisi della narrazione sembra portare a un regime specifico, quello della
disnarrazione. Più che una contaminazione di regimi, come nel caso della metanarrazione, la disnarrazione
mette in gioco un’anti-narrazione “critica”, in cui il lavoro dell’enunciatore si fa centrale all’interno di
un’operazione di contestazione del racconto attraverso sé stesso, con la conseguenza di “inceppare” del
tutto il funzionamento della narrazione. La disnarrazione rappresenta una consapevole opposizione alla
logica realista del racconto classico. Metanarrazione e disnarrazione, più che affiancarsi alle nozioni di
narrazione forte, narrazione debole e anti-narrazione, vi si intrecciano.
La sceneggiatura
La base di partenza, detta sceneggiatura, contiene la descrizione dei luoghi in cui si svolge il racconto, degli
eventi, dei personaggi, delle loro azioni e delle loro battute. Un modello di riferimento per la sceneggiatura
per la produzione mainstream e televisiva è la versione più tecnica detta “di ferro”. Al polo opposto vi è
quella detta “canovaccio”, che contiene una suddivisione del film in scene, ma, di fatto, rimanda la
“scrittura” del film alla fase delle riprese, aprendosi all’improvvisazione e all’imprevisto; modello
particolarmente usato nel cinema moderno.
La sceneggiatura
La sceneggiatura rappresenta il punto d’arrivo di un percorso di scrittura, dove nel primo stadio di sviluppo
coincide con la stesura del soggetto, che può essere originale o non originale, e rappresenta il “documento”
con cui un regista o un produttore va alla ricerca di finanziamenti. È quindi fondamentale che il soggetto sia
breve ma capace di evidenziare il tema e i punti di forza del film, presentando in modo chiaro i protagonisti,
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
lo spazio e il tempo del racconto e l’articolazione degli avvenimenti. Questa fase preliminare deve essere
adeguata alla scrittura del linguaggio cinematografico: il soggetto deve già rispettare alcune convenzioni
caratteristiche della scrittura filmica, prima tra tutte un “pensiero” per immagini.
La fase di sviluppo del soggetto si definisce trattamento, e consiste in un racconto dettagliato e
“romanzato” della trama. Scritto al presente e in terza persona, il trattamento non costituisce un passaggio
obbligatorio, anche se spesso risulta utile perché consente di approfondire la storia abbozzata nel soggetto.
In alternativa al trattamento possono essere redatti dei “diari” con alcuni dati sui personaggi.
Si passa poi alla scaletta, la traccia fondamentale per la scrittura della sceneggiatura vera e propria. La
scaletta è la presentazione dell’intreccio del film, suddivisa in scene. Non ci sono regole particolari per il
componimento della scaletta.
La sceneggiatura vera e propria rielabora la scaletta scena per scena e contiene le informazioni necessarie
all’avvio della fase di produzione. Esistono tre diverse forme di sceneggiatura, accomunate da una
descrizione separata della colonna visiva e della colonna sonora, oltre che da un numero progressivo, ogni
scena è identificata da un’indicazione del tipo di spazio, da una sintetica descrizione del luogo in cui si
svolge l’azione, da un’informazione sulle condizioni di luce, e sono:
- “all’italiana”: il foglio di sceneggiatura si presenta diviso a metà: a sinistra la descrizione, a destra i
dialoghi, i rumori e le musiche
- “alla francese”: la descrizione è a tutta pagina, mentre il dettaglio degli elementi sono si trova in
colonna a destra.
- “all’americana”: oggi quella standard, colloca le informazioni relative agli aspetti visivi a tutta
pagina, i dialoghi al centro del foglio.
Un completamento della sceneggiatura piuttosto comune nel caso di formati brevi come i cortometraggi, i
videoclip e gli spot televisivi è rappresentato dallo storyboard, l’illustrazione del film inquadratura per
inquadratura.
Modi di rappresentazione
Per definire il cinema che va dalla sua invenzione all’affermazione (metà anni 10 del 900), la storiografia
utilizza 2 etichette:
- “cinema primitivo”: utilizzato per suggerire una condizione imperfetta in cui il cinema non ha
ancora sviluppato le proprie potenzialità narrative ed espressive. Il cosiddetto Modo di
Rappresentazione Primitivo (MRP), successivamente sostituito dal Modo di Rappresentazione
Istituzionale (MRI), è caratterizzato da una dipendenza del cinema da altri mezzi d’espressione, in
particolare, il teatro. Il racconto primitivo si sviluppa sempre a partire dall’unità del “quadro”: un
campo ripreso da una cinepresa fissa, posta a una certa distanza dagli attori, in posizione frontale,
all’interno del quale si svolge compiutamente una porzione di racconto. L’altro aspetto
caratteristico del modo di rappresentazione primitivo è l’assenza del montaggio narrativo.
- “cinema delle attrazioni”, suddiviso a sua volta in altre 2 categorie:
o Il “cinema delle attrazioni mostrative”: caratterizzato da uno sfruttamento della novità
rappresentata dal cinema stesso: per i primi spettatori vedere la realtà muoversi in modo
verosimile sullo schermo già costituisce uno spettacolo.
o Il “cinema dell’integrazione narrativa”: l’obiettivo è qui raccontare storie di più ampio
respiro. Le riprese iniziano a essere concepite in funzione di un montaggio narrativo, la
rappresentazione dell’azione viene frammentata in più inquadrature e si perfezionano i
raccordi di continuità. Anche il rapporto tra film e spettacolo comincia a cambiare.
L’inquadratura
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
La costruzione di un set rappresenta solo una parte del lavoro di produzione di un film, la fase intermedia,
tra il momento di pre-produzione e quello di post-produzione, che comincia con il montaggio per
concludersi con lo sviluppo e la stampa della pellicola o, oggi, con la creazione del DCP (Digital Cinema
Package).
Tuttavia, girare un film significa tradurre una porzione di realtà in immagine, o meglio, inquadrarla. Dal
punto di vista produttivo, la fase delle riprese consiste nella realizzazione delle inquadrature, che andranno
poi a costruire la “materia prima” del montaggio. Questo porta a una prima definizione tecnica di
inquadratura come unità minima del film, un segmento continuo delimitato da due stacchi di montaggio.
Sia l’estetica del montaggio discontinuo (scuola sovietica del montaggio), sia l’estetica del montaggio
continuo (découpage all’americana), rimandano a un’idea di inquadratura come frammento privo di una
reale autonomia discorsiva. Quanto al cosiddetto “cinema dell’inquadratura”, che rappresenta in molti casi
una diversa elaborazione della logica della continuità, l’inquadratura sembra funzionare come
“contenitore” formale di una pluralità di immagini.
L’analisi dell’inquadratura sembra imporre qualcosa di simile a un “arresto sull’immagine”, necessario per
mettere in luce un primo e fondamentale processo compositivo. Fare un’inquadratura significa trasformare
una realtà in immagine, e anche il gesto di registrazione testimoniale di un’azione o di un paesaggio, non fa
eccezione: da un lato, la realtà diventa un’immagine; dall’altro lato, la realtà diventa una rappresentazione
cinematografica, caratterizzata dalla presenza di un determinato punto di vista e plasmata da una pluralità
di fattori tecnici. Queste due dimensioni sono profondamente intrecciate, ma può essere utile distinguerle
anche per specificare come il momento delle riprese non passi soltanto attraverso un’operazione di messa
in quadro filmica di una realtà concreta, ma anche attraverso decisioni che rimandano più direttamente al
piano dell’immagine. Questo appare tanto più vero oggi con la diffusione del digitale quale tecnologia di
registrazione, che ha contribuito ad ampliare il modo di vedere la realtà. Studiare l’inquadratura significa,
dunque, confrontarsi con una serie di operazioni creative e tecniche che conducono da una realtà effettiva
alla sua rappresentazione cinematografica. Con il termine profilmico si intende tutto ciò che sta davanti alla
camera: qualcosa in attesa di diventare cinema, che esiste per il filmico. Studiare gli elementi profilmici,
significa analizzare le operazioni creative e tecniche che contribuiscono a creare l’evento scenico che si
trasformerà in evento filmico.
Per quanto riguarda il ruolo dell’inquadratura, si è a lungo dibattuto se avesse proprietà di finestra, ovvero
un guardare attraverso qualcosa, o di cornice, ovvero un guardare all’interno di qualcosa. Fra i singoli
elementi che concorrono a definire l’inquadratura cinematografica, occorre precisare che a partire dagli
anni 90, l’avvento e la rapida diffusione delle tecnologie digitali di produzione e il prepotente sviluppo del
settore degli effetti speciali e della CGI (Computer-Generated Imagery) hanno messo radicalmente in crisi
l’idea dell’immagine filmica come incontro tra una realtà effettiva e il dispositivo cinematografico.
Cambiano anche i rapporti tra produzione e post-produzione con un cinema sempre più basato sulla
manipolazione digitale, che conduce a fare della produzione solo la prima fase della post-produzione.
L’immagine digitale è una specie visiva completamente diversa da quella fotografica, suscettibile di essere
generata in assenza di realtà, per poi figurare sullo schermo come se fosse reale. La digitalizzazione
costringe anche a rivedere una nozione specifica come quella di inquadratura: l’idea che essa sia il risultato
della riconfigurazione visiva di qualcosa “che sta davanti alla cinepresa pronto per essere filmato” non è più
sufficiente a dare conto di tutte le possibilità cui il cinema contemporaneo può ricorrere per fare
un’inquadratura. Questa idea, semmai, oggi identifica un certo modo di produzione, trasformando quella
che, fino a pochi anni fa, era una definizione generale, in una strategia specifica di generazione
dell’immagine.
La scenografia
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
La smaterializzazione caratteristica del cinema digitale ha inciso profondamente sulle dinamiche realizzative
e sul momento della produzione: soprattutto nel caso del cinema contemporaneo spettacolare, ad alto
tasso di effetti speciali, esso appare ridotto a una fase di “abbozzo” di elementi che saranno poi realmente
creati solo in post-produzione.
L’esplorazione del set virtuale comincia negli anni 80 con una tecnica chiama chroma key: un ambiente
neutro, illuminato in modo uniforme, in cui gli attori recitano circondati da pareti di colore blu o verde, che
saranno successivamente “bucate” per inserirvi qualsiasi tipo di scena. Ad oggi, la scenografia di un film
contemporaneo è quasi sempre l’esito di un incontro tra scene virtuali e scene tradizionali. Bisogna però
puntualizzare due aspetti:
- il primo riguarda l’evidenza dell’intervento digitale, dove la CGI ha ben presto raggiunto
straordinari livelli di fotorealismo e che oggi viene abitualmente impiegata
- il secondo riguarda la questione del realismo scenografico, che può essere a sua volta affrontato da
due punti di vista:
o un,o relativo alla natura materiale dell’elemento scenografico: la progettazione digitale va
oggi ad aggiungersi a due possibilità che caratterizzano la creazione dello spazio di un film:
da un lato, il ricorso a costruzioni scenografiche
dall’altro, l’utilizzo di ambienti reali
Storicamente, la stragrande maggioranza dei film ha intrecciato le due soluzioni e oggi la
realizzazione di una scenografia si arricchisce delle possibilità offerte dalla computer grafica,
anche se, nel tempo, le due strade sono state avvertire con conflittuali.
o l’altro, relativo al suo utilizzo espressivo e narrativo: al cinema il realismo è un “effetto di
realtà”, cioè, una scenografia originale, allestita all’interno di uno studio cinematografico,
che può apparire altrettanto verosimile a una scenografia naturale.
Il realismo, il simbolismo e l’espressionismo di una scenografia devono essere dunque interpretati come
l’esito di una precisa caratterizzazione dello spazio del film; non basta, dunque, girare “dal vero” per
ottenere una scenografia realista. Il lavoro dello scenografo sarà quindi quello di negoziare tra aderenza alla
realtà e costruzione della realtà.
A partire dagli anni 10 e 20, l’idea di scenografia espressionista si è impostata come un’opzione
genericamente contraria al realismo: essa si basa sull’accentuazione dello “sfondo”, che spesso guadagna il
primo piano.
Negli anni 20 si diffonde internazionalmente, col termine caligarismo, un modo di interpretare il mondo
mediante il ricorso a una stilizzazione espressiva delle scenografie, al quale, per certi versi, si accostano le
scenografie déco, altamente geometriche e giocate su una prevalenza del bianco e della luce diffusa, tipico
dei musical. Questa presenza marcata dell’elemento scenografico va a incidere anche sulla relazione tra
ambiente e personaggio, come è evidente nel cinema espressionista, dove il corpo umano appare
accerchiato da interni inospitali, o riflesso e prolungato nello spazio. Questa accentuazione del ruolo
espressivo dell’elemento scenografico e un suo utilizzo spiccatamente anti-naturalistico rappresentano una
tendenza ben viva anche nel cinema contemporaneo (film di Almodovar).
La luce e il colore
Altri 2 fattori determinanti nella caratterizzazione scenografica sono il colore e gli elementi scenotecnici.
Una grande contribuzione viene data anche dalla componente scenotecnica, cioè quell’insieme
estremamente eterogeneo di elementi che “vestono” una scenografia, la cui individuazione è di
responsabilità dell’arredatore.
Ma analizzare gli elementi scenografici, significa anche riflettere sulle funzioni narrative ed espressive che il
film attribuisce loro. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la scenografia, può:
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
- assolvere compiti caratteristici dell’idea di “scrittura della scena”: oltre a decorare lo spazio, serve a
fornire informazioni e a caratterizzare la storicità del racconto; inoltre, può immergerci
immediatamente in una certa atmosfera di “genere”.
- oppure essere caricata di proprietà e valori ulteriori, cioè assumere un ruolo marcato di tipo
narrativo, simbolico o metaforico.
A partire da una riflessione tra cinema e pittura (Jacques Aumont) individua 3 funzioni principali della luce
all’interno di un film:
- tipo drammatico, legata all’organizzazione dello spazio e alla sua strutturazione come spazio
scenico. La luce assolve una funzione narrativa e comunicativa, portando l’attenzione su alcuni
elementi. Questa funzione è ben rappresentata dall’uso che il cinema classico ha fatto della luce: il
cosiddetto sistema a tre luci, che si tratta di un’illuminazione unidirezionale, orientata a
evidenziare elementi primari e secondati all’interno dell’inquadratura, definendo un percorso di
lettura per lo spettatore. Ma la soluzione opposta, quella di un’illuminazione multidirezionale, si
diffonde in modo uniforme a tutti gli elementi dell’inquadratura, rappresenta un’opzione stilistica
ben precisa, quasi sempre legata alla ricerca di un maggior realismo, ma anche funzionale a un
modo di produzione (caratteristico del cinema moderno) che concede largo spazio
all’improvvisazione. Un’illuminazione diffusa, priva di restringimenti del campo visivo, riprende
l’azione da qualsiasi direzione e in qualsiasi momento, senza dover pianificare con eccessiva cura il
rapporto tra posizione della macchina da presa, movimenti degli attori ed elementi scenografici.
- Luce atmosferica: rimanda alla possibilità di creare particolari connotazioni semantiche,
psicologiche ed emotive. In questo caso la luce caratterizza la scena di significati ulteriori, molto
spesso appoggiandosi a valori tradizionalmente associati a certe tonalità. Non si limita a
caratterizzare l’atmosfera, ma ha anche un orientamento narrativo, cioè i colori, caldi o freddi,
rappresentano diversi tipi di stato d’animo.
- Luce con funzione simbolica, segnata da connotazioni di tipo culturale che vertono sulla luce, cioè
che luce e ombra sono metafore, rispettivamente, di bene e di male. Quest’uso simbolico della luce
sembra richiamare un paradigma visivo, definibile come espressionista, dove l’idea di luce
espressionista identifica un modello visuale più generale, una tendenza idealmente opposta a
impieghi orientati nel senso della verosimiglianza e del realismo, e che del contributo
dell’avanguardia tedesca di inizio ‘900 rappresenta la sintesi, la codificazione e la stilizzazione, in
dialogo con altre esperienze.
Nel quadro dell’industria hollywoodiana classica il “disegno” fotografico espressionista contagia, in
particolare, l’horror e il noir (con estensioni verso il dramma), e proprio il suo impiego all’interno della
produzione di genere conduce rapidamente a disciplinarlo in quanto formula espressiva. Al tempo stesso,
questo paradigma s’impone come riferimento essenziale per un utilizzo dell’illuminazione in chiave
propriamente costruttiva, in ideale opposizione alla tendenza del “trionfo del bianco”, che negli anni 30 e
40 trova la sua più compiuta codificazione in generi come la commedia romantica e il musical. Se la
fotografia di gusto espressionista si regge su contrasti tra zone di luce e zone d’ombre e su una luce di
taglio violenta e fortemente direzionale, la commedia e il musical classici contribuiscono a istituzionalizzare
il controluce e i suoi effetti “angelicanti”. Alla luce, in questo caso, spetta il compito di evocare un
immaginario fatto di lusso, un orizzonte morale privo di ombre, sia reali che metaforiche. Queste tendenze
testimoniano la comune volontà di impiegare gli elementi fotografici in senso propriamente semantico.
Negli anni 30 e 40 l’asse della luce viene spostato verso la plasticità, distillando un’immagine-luce in
equilibrio tra verosimiglianza, astrazione e pittoricità, sineddoche perfetta del glamour immaginifico dello
studio system. In quegli stessi anni, il cinema francese e poi, soprattutto, il Neorealismo, formalizzano una
tendenza idealmente opposta a quella tracciata dalle avanguardie e dal cinema statunitense, che si può
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
genericamente definire realista. In sintesi, un orientamento estetico che valorizza la luce in quanto
presenza concreta, ripudiando gli effetti quasi scultorei della tecnica hollywoodiana. L’opzione della scuola
francese, in cui la luce, quand’anche prodotta con l’ausilio di corpi illuminati, insegue un effetto di
immediatezza e naturalismo, viene sconfitto dal sistema opposto, quello di una luce diffusa e spesso piatta,
ottenuta attraverso piccole lampade, dette photo floods, puntate contro un soffitto bianco, che consente
agli attori e al regista di muoversi liberamente sia in interni sia in esterni (in questo cinema la camera a
mano comincia a diventare una consuetudine), senza correre il rischio di “uscire” dalla luce, e senza il
problema aggiuntivo di dover prestare un’attenzione particolare alla continuità fotografica tra le
inquadrature.
Un approccio in parte diverso si deve segnalare, all’interno della stessa produzione francese, nei confronti
del colore, che, a partire da metà degli anni 60, comincia ad affermarsi come una soluzione sempre più
comune, per poi diventare, col decennio successivo, lo standard sia del cinema d’autore sia della
produzione commerciale. Si parlerà quindi di film colorati, e non film a colori, dove è il colore in sé, in
quanto elemento significante, a subire un trattamento esplicitamente anti-naturalistico. In questi anni, il
colore è avvertito ancora come un’eccezione, ma è negli anni 70, negli Stati Uniti, che si compie il più
significativo processo di normalizzazione del colore, che da elemento spesso spettacolare dell’immagine si
fa sempre più invisibile.
L’identità visuale e il racconto di un film dipendono dal lavoro di illuminazione realizzato sul set, il quale
caratterizza sia dal punto di vista narrativo sia dal punto di vista espressivo e simbolico: il direttore della
fotografia “scrive con la luce”, modellandone in maniera determinante per il significato del film la qualità,
la direzione, la temperatura del colore ecc... In questo senso, la fotografia rappresenta senza subbio la
componente più importante della messa in scena.
Al tempo stesso, la qualità fotografica di un film dipende da operazioni che avvengono prima e dopo il
momento dell’illuminazione del set: in particolare, della scelta del supporto e della tecnologia di ripresa, e
dagli interventi realizzati in fase di post-produzione e di stampa, alcuni di semplice correzione (color
correction), altri di vera e propria alterazione della luce progettata durante le riprese (color grading). Al
contrario, la “storia della luce” (o visual storytelling, come dicono gli americani) di un film è un processo
coerente e unitario, scandito da fasi operative e passaggi tecnici che, in modo diverso, contribuiscono a
modellare la qualità luministica e cromatica del racconto. Di questo processo, il direttore della fotografia,
accanto al regista, è il principale responsabile.
L’attore
Vi è una spaccatura fra personaggio e attore, separando ciò che al cinema si dà sempre come unità, e cioè
l’”essere di carta”, descritto dalla sceneggiatura, e il suo interprete. Questa iniziale dimensione cartacea è
subito superata nel caso di un personaggio originale, mentre le cose si fanno più complicate quando il
personaggio possiede una sua pregressa esistenza immaginaria. Nel caso di un personaggio originale, la
tendenza è di confermare la prima “incarnazione”, con l’effetto di schiacciare il personaggio sull’attore.
Al cinema, la nozione di ruolo può rimandare sia a una figura in particolare, sia a un insieme di tratti
chiaramente codificati in termini di azione, comportamento, abbigliamento, appartenenza a un
determinato universo diegetico. Tra tipo e stereotipo, queste figure emergono con particolare evidenza
all’interno del cinema di genere. Da questo punto di vista, una struttura archetipica come quella del ruolo di
“genere” si rivela particolarmente utile per puntualizzare come l’analisi dell’attore si trovi sempre di fronte
a una specie di bivio metodologico: da un lato, essa può scegliere di privilegiare la questione dell’”individuo
narrativo” cui la performance attoriale attribuisce un corpo; dall’altro lato può scegliere di privilegiare la
questione dell’attore sia dal punto di vista della dimensione corporea, sia dal punto di vista dello statuto
divistico.
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
La natura duplice dell’attore cinematografico si complica ulteriormente proprio in presenza della cosiddetta
“aura divistica”, che sposta l’analisi sul piano dell’acteur-persona, cioè la difficoltà di chi vede di giudicare la
recitazione dell’attore a prescindere da ciò che circonda l’attore (opere e vita). Dal punto di vista storico
(detto con Christine Geraghty), quindi, studiare l’attore significa anche interrogare i fattori che governano la
dialettica tra:
- star as celebrity: rimanda a qualcuno la cui notorietà deriva primariamente da ciò che accade al di
fuori della sfera lavorativa, e cioè in termini di lifestyle, tra cronaca mondana e apparizioni
pubbliche. (es: Sharon Stone)9
- star as performer: identifica un attore o attrice definiti in primo luogo dal proprio lavoro, la cui fama
è alimentata dalle performance recitative. (Meryl Streep
Ma studiare l’attore significa anche valutare il peso e le strategie di costruzione della “notorietà
orizzontale” che contraddistingue in forme sempre più incidenti le personalità del cinema contemporaneo,
come il ruolo che hanno oggi giorno i social media nel creare l’”aura divista” di un attore.
Fra gli intrecci tra personaggio, attore e divo, un modello è quella della meta-recitazione, che si può
definire anche come non-recitazione, in cui l’attore non solo non si immedesima con i personaggi, ma
sembra sempre interpretare una versione ostentata di sé.
Sulla tendenza degli autori della Nouvelle Vague a perseguire un “effetto di verità” anche attraverso una
decostruzione della figura dell’attore e del suo lavoro, agisce senza dubbio l’esempio del Neorealismo e del
suo inedito utilizzo di interpreti professionisti e non. La commistione fluida di queste due categorie appare
come un elemento essenziale della “straordinaria impressione di verità” dei film della scuola italiana; dal
punto di vista di una storia dell’attore, invece, la lezione del Neorealismo rappresenta uno snodo centrale
per comprendere gran parte delle problematiche legate alla recitazione tout court. Gli attori non
professionisti, contrariamente a quelli professionisti, sono entità di passaggio, concetto che torna
ciclicamente nella storia del cinema. E vi ritorna come opzione antitetica al cosiddetto Metodo, elaborato
negli anni 50, secondo cui questa idea antipsicologica dell’interpretazione come “mancata
immedesimazione” contraddice la logica emotiva su cui si basa il Metodo. Storicamente, il Metodo ha avuto
il grande merito di rinnovare lo stile recitativo del cinema statunitense e di promuovere un radicale
ripensamento della figura dell’attore. Il Metodo si basa su un’idea di interpretazione come esperienza
fortemente soggettiva e singolare: l’attore deve lavorare sul concetto di memoria emotiva (affective
memory), mettendo in gioco, nella costruzione della parte, ricordi ed esperienze personali; solo in questo
modo, attraverso un’evocazione amnesica di se stesso, egli può arrivare a una vera e propria reincarnazione
nel personaggio. Ne deriva un rapporto attore-personaggio fortemente interdipendente. Per l’attore,
infatti, “entrare” e “uscire” dal personaggio, mettendo in gioco un’esplorazione profonda della propria
vicenda emotiva e psicologica, può rivelarsi un movimento tutt’altro che semplice, o produrre, nei soggetti
psicologicamente più fragili, conseguenza perfino dannose (es: Marilyn Monroe). Come testimoniano la
meta-recitazione e il Metodo, ripercorrere la storia del cinema attraverso la figura attoriale significa
interrogare anche le diverse modalità con cui le categorie dell’attore, personaggio e divo sono entrare in
relazione: quella tra attore e personaggio non è quasi mai una relazione pacifica ma complessa;
quest’ultima dimensione sembra caratterizzare la strada intrapresa da certo cinema contemporaneo, in
particolare statunitense. Molte star vivono oggi l’actorly transformation, ossia un evidente mutamento
fisico raggiunto perlopiù attraverso l’aumento o la diminuzione del peso corporeo, come una delle vie
privilegiate per “vivere” il personaggio, per raggiungere certi effetti di verità recitativa e, al tempo stesso,
per accrescere il proprio personaggio artistico. (es: Christian Bale in The Machinist/ Matthew McConaughey
in Dallas Buyers Club)
A causa dei progressi compiuti nella CGI, l’attore viene sempre più spesso ridotto a una specie di supporto o
veicolo per la creazione di figure digitali. Al tempo stesso, non mancano, nel cinema contemporaneo, casi in
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
cui vengono impiegate tecnologie digitali per creare “dal nulla” l’attore o per resuscitarlo. (es: Lo
Hobbit/Fast & Furious 7)
La pellicola
Inquadrare significa installare uno sguardo, proiettare uno spazio e circoscrivere un tempo. Un processo di
vera e propria traduzione materiale ed enunciativa che trasforma una realtà tridimensionale in un campo di
visibilità organizzato attorno alla presenza di un punto di vista, fisso o mobile, delimitato da una cornice.
Per definire l’inquadratura cinematografica come immagine, è necessario partire dal supporto, e da una
serie di scelte operate preliminarmente in rapporto ad esso: il bianco e nero o i colori dipendo dal tipo di
pellicola utilizzata e dalla sua emulsione, cioè una gelatina organica, sensibile alla luce, in cui sono sospesi
dei cristalli di alogenuro d’argento: la pellicola in bianco e nero contiene uno strato di emulsione, quella a
colori tre. Le differenze tra una pellicola e l’altra dipendono dalle caratteristiche dell’emulsione, e si
misurano in termini di rapidità o sensibilità, cioè una pellicola “veloce”, quindi più sensibile alla luce, è
composta da cristalli di dimensioni maggiori, e questa grana più grossa può rendersi visibile in fase di
stampa; al contrario, una pellicola “lenta” possiede una grana più fine ma richiede una maggiore quantità di
luce.
La qualità finale dell’immagine dipende anche dal trattamento che la pellicola subisce in post-produzione.
La visual texture può essere modificata sia attraverso particolari interventi durante le fasi di sviluppo e
stampa, sia in montaggio, attraverso operazioni di correzione dei parametri fotografici. Si pensi al
cosiddetto bleach-bypass, dove viene saltata la tradizionale sbiancatura della pellicola, così che le particelle
di alogenuro d’argento restano nella copia positiva. In termini visivi, il risultato è una saturazione ridotta e
un aumento del contrasto e della “grana”.
Per quanto riguarda i processi post-produttivi importante è la centralità dei processi di color correction e
color grading, che servono ad aggiustare, rinforzare e uniformare le differenze tra i diversi tipi di pellicola
eventualmente utilizzati durante le riprese o tra porzioni di film, ma anche a cambiare completamente i
colori, i contrasti e la luminosità.
Dato che ancora oggi, a volte, i film vengono girati in pellicola, in post-produzione si riversa la pellicola in
digitale tramite un digital intermediate, stabilendo uno scarto rispetto all’epoca precedente. Oggi, di fatto,
tutti gli effetti un tempo legati alla “fisicità” della pellicola e al suo trattamento sono filtri facilmente
applicabili in fase di post-produzione. La pellicola stessa diventata così essa stessa un effetto speciale. La
digitalizzazione ha anche portato alla conclusione di una lunga stagione, durante la quale la pellicola ha
rappresentato il formato cinematografico per eccellenza e lo standard dell’immagine cinematografica.
L’aspetto più interessante coincide con un allargamento di campo dell’idea di qualità cinematografica,
differenziandolo da ambiti come quelli del cinema amatoriale e non professionale, composto da immagini
digitali “brutte”, come quelle del movimento danese Dogma 95. Scelta dovuta alla volontà di questo
movimento di mostrare un’estetica anti-cinematografica, contraria all’interpretazione che Hollywood stava
dando dell’immagine cinematografica. L’esperienza del cinema dogmatico, influente a livello
internazionale, contribuisce quindi a due spostamenti fondamentali: da un lato, ha riscattato la versione
povera della tecnologia digitale trasformandola in uno standard cinematografico a tutti gli effetti; dall’altro
lato, coniugando il rifiuto di qualsiasi “bellezza” visiva a un approccio documentaristico. Dai film di questo
movimento, è dunque vincolata una nuova immagine della realtà, connotando il supporto digitale a bassa
risoluzione quale operazione privilegiata di un nuovo realismo.
Ma vi è stato anche l’esplorazione del versante “ricco” della tecnologia digitale, che ha oggi quasi
completamente soppiantato la pellicola e che si basa non sulla registrazione fotochimica ma
sull’acquisizione di dati attraverso un sensore. Importante è come la rapida diffusione delle tecnologie
digitali ha dato vita a una pluralità di forme e linguaggi, incrinando una volta per tutte l’idea di uno standard
visivo specificatamente cinematografico. Un film, oggi, può essere fatto della stessa materia di un video
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
amatoriale, o possedere la definizione vagamente plastica e metallica di un videogioco o, ancora, la texture
di una rappresentazione grafica o pittorica. Una situazione dalle importanti ricadute culturali per l’identità
stessa del cinema ma anche una possibilità di arricchimento e rinnovamento.
Cornice
Un’inquadratura è, prima di tutto, una superficie piatta e bidimensionale, caratterizzata dal fatto di
possedere una cornice (tendenzialmente rettangolare), vale a dire una struttura che impone una forma e
una logica di composizione, e dal fatto di operare un ritaglio all’interno di un orizzonte visivo più ampio.
Durante la visione di un film, rileviamo un mondo tridimensionale analogico, del tutto simile a quello della
nostra esperienza quotidiana: l’illusione del movimento e della profondità, accanto alla costruzione
prospettica, sono i principali responsabili di un simile “effetto”. Ciò non toglie che l’immagine
cinematografica sia sempre <<spaziale e superficiale a un tempo>>, e che questa qualità “intermedia”
possa essere valorizzata in quanto fattore espressivo. Si pensi a effetti come lo split screen che, dividendo
l’inquadratura in due o più porzioni autonome, ne addita inevitabilmente la natura di superficie, o all’uso
dell’immagine come database, “senza spazio”, all’interno della quale articolare complessi montaggi
ipertestuali; oppure, ancora, si pensi allo “schiacciamento” della tridimensionalità prodotto dall’uso di
inquadrature aeree a piombo.
Per quanto riguarda la cornice, il primo dato da prendere in analisi è la natura di struttura-limite, che
determina un certo formato dell’inquadratura. Al di là degli aspetti tecnici, può essere utile sottolineare
come il progressivo allargamento delle opzioni, prima grazie all’avvento del Cinemascope, poi di standard
panoramici, abbia finito per trasformare il formato da dato tecnico invariabile a vero e proprio fattore
estetico. Come tutte le cornici, anche quella cinematografica, nell’imporre una certa forma, stabilisce anche
un ordine e una logica di composizione. In particolare, la cornice stabilisce un orientamento, un centro di
equilibrio geometrico e percettivo, e dei pattern simmetrici. E questo appare tanto più vero nel caso di un
dispositivo come il cinema, che si basa sul principio della prospettiva monoculare, responsabile non
soltanto di un’illusione di profondità, ma anche dell’istituzione di un punto di vista centripeto.
La composizione figurativa dell’inquadratura, dunque, dipende dalla presenza di una certa struttura
geometrica e dalle configurazioni plastiche spaziali a essa associate. Il cinema classico tende a stabilire una
forte continuità tra le predeterminazioni plastiche e formali del rettangolo che incornicia la composizione e
la composizione stessa; il centro geometrico rappresenta il punto dal quale inizia la proiezione, con una
distribuzione “sensata” degli elementi, in modo che sia facilmente leggibile dallo spettatore, finendo così
con alleggerire i bordi dell’immagine e il loro valore di limite formale e di operatore “artificiale” della
composizione.
In modo diverso funzionano i processi di decentratura, in particolare il décadrage caratteristici del cinema
moderno e postmoderno. Questa nozione identifica una strategia compositiva contraria alla logica del
cinema classico: in questa tecnica si ha uno svuotamento del centro, che si oppone allo “stile centralizzato”
del racconto hollywoodiano. In questo senso “ideologico” e oppositivo il décadrage è sempre indice di una
volontà di rottura dell’ordine, di scomposizione di codici visivi e culturali, di messa in crisi dell’idea di
inquadratura come finestra aperta su una visione totale e trasparente. Si può guardare al décadrage come
una particolare strategia stilistica di dialogo tra quadro e composizione, che, nel violare esplicitamente il
principio della centratura, finiscono sia per enfatizzare il carattere attivo del bordo, e quindi la natura di
operatore retorico della cornice, sia per portare in primo piano la natura di struttura formale
dell’inquadratura.
La cornice cinematografica è un elemento di “contenimento”, sempre provvisorio, strumento di un ritaglio
temporaneo di una porzione di visibile appartenente a uno spazio più ampio, il quale può essere
rappresentato in modo esplicito oppure ricostruito implicitamente in termini immaginativi.
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
Sulla dialettica del campo e fuori campo si fonda la logica stessa del dècoupage narrativo, col suo
spezzamento di un’unità originaria in inquadrature parziali e la successiva (ri)costruzione di un “senso” di
unità attraverso un sofisticato sistema di richiami tra visibile e invisibile. All’interno del cinema
hollywoodiano, il fuori campo rappresenta sempre un ideale di prolungamento del campo, e la puntuale
grammaticalizzazione dei rapporti tra le due dimensioni implica una continuità tra ciò che appare sullo
schermo e ciò che resta fuori. In questo senso, il fuori campo è sempre una dimensione in qualche modo
prevista (Bazin). Mentre vi sono altre teorie, secondo cui oltre il margine, c’è sempre qualcosa di
imprevisto, suscettibile di assumere le forme più diverse o di stabilire con il mondo rappresentato dialoghi
più o meno impossibili (Seguin). Ma nel cinema contemporaneo questa specie di intransitività tra campo e
fuori campo, dipende anche da un’idea secondo cui il mondo finisce nel e con il campo e il suo orizzonte di
visibilità, e che l’inquadratura è un’immagine oltre la quale non c’è o non può esserci alcun mondo (Seguin).
Si pensi all’uso eccentrico e intensivo di una figura come la soggettiva, anticipato nel cinema classico, e
largamente sfruttato dal cinema contemporaneo, figura che colloca idealmente il corpo del personaggio nel
fuori campo e al di qua della macchina da presa. Lo spazio fuori campo (seguendo Burch) può essere
suddiviso in sei segmenti: i confini immediati dei primi quattro sono determinati dai margini
dell’inquadratura, uno si trova dietro la scena, l’ultimo dietro la macchina da presa. La soggettiva, nel
mostrare ciò che vede il personaggio, colloca idealmente quest’ultimo in uno spazio “anteriore” rispetto
all’immagine, ma la dialettica vedente-visto su cui essa si regge tende di norma a non sollecitare questo
margine scomodo, in cui la nozione di fuori campo si confonde con quella di fuori quadro, utilizzata per
designare lo spazio di produzione, vale a dire il set. Tutti i casi citati fanno leva sulla sollecitazione del fuori
campo “davanti” e cioè sulla scomparsa del corpo del personaggio, fino a trasformarlo in un elemento
misterioso. Da un lato, dunque, queste operazioni finiscono per rendere il fuori campo uno spazio insieme
presentissimo e negato, mentre costringono lo spettatore a calarsi nello sguardo di un personaggio di cui
non si conosce il volto; dall’altro lato, esse impongono alla dialettica tra campo e fuori campo un
funzionamento anomalo, contraddicendo il principio “realista” della continuità spaziale e facendo della
cornice la soglia di un dialogo imprevedibile tra visibile e invisibile.
Modi di rappresentazione
Il tema della prospettiva monoculare è la principale tecnica di riproduzione illusoria della visione umana in
uno spazio planare. La profondità, tuttavia, non rappresenta semplicemente una proprietà di base della
rappresentazione cinematografica, ma anche un parametro visivo che può essere lavorato in forme molto
diverse a scopi narrativi, espressivi o simbolici. La nozione di profondità di campo rimanda alla dimensione
qualitativa della “tecnica” di profondità: essa indica l’estensione della zona di nitidezza dell’immagine, che
può essere ampia, fino a includere tutti gli elementi presenti della scena, da quelli più vicini a quelli più
lontani; oppure limitata, così che l’inquadratura risulta divisa tra una zona nitida, a fuoco, e una zona fuori
fuoco mano a mano che ci si allontana dalla prima. Scorretto è però associare un’ampia profondità di
campo a una maggiore profondità del campo. All’interno dell’inquadratura la costruzione del senso della
profondità dipende da elementi come l’illuminazione, il colore, la scelta degli obiettivi e la disposizione
delle forme nello spazio. Anzi, un’ampia profondità di campo può anche produrre effetti di riduzione della
percezione della profondità, essendo anche uno schema di rappresentazione e un habitus percettivo. Anzi,
dal punto di vista ottico, una riproduzione completamente nitida appare la più lontana dall’immagine reale,
che è netta soltanto al centro. Ma va analizzata anche come una delle tante variabili che entrano in gioco
nella composizione del mondo diegetico. Da questo punto di vista, la profondità di campo costituisce uno
strumento essenziale nella gerarchizzazione dello spazio, nella selezione delle informazioni e nella
costruzione di percorsi visivi. Viceversa, l’uso della messa a fuoco selettiva tende a indirizzare lo sguardo
verso un piano particolare dell’inquadratura. Nel cinema hollywoodiano, gli ingredienti principali del
racconto appaiono in primo piano, messi a fuoco, e al centro dell’inquadratura, mentre gli altri elementi o
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
personaggi sono “sfocati”, così da darne un senso di “realismo”. Diverso è il caso del cinema
contemporaneo, dove questa modalità appare impiegata per esaltare la natura “costruttiva”.
La realizzazione di inquadrature profonde, quasi sempre in formato panoramico, in cui si trovano riuniti
elementi molto vicini e altri lontanissimi, dando vistosi effetti di distorsione prospettica, sciogliendo la
rappresentazione dello spazio da una restituzione verosimile, assimilabile a quella dell’occhio umano, è
data dall’utilizzo di obiettivi a focale lunga, detti teleobiettivi: una delle caratteristiche di queste ottiche è
quella di “affollare” l’inquadratura di elementi e di comprimere la profondità e di schiacciare
innaturalmente i piani lungo l’asse della macchina da presa. La questione della lunghezza focale, corta nel
caso del grandangolo, normale con ottiche comprese tra i 35mm e i 50mm, e delle eventuali distorsioni che
essa introduce nella restituzione della realtà, ci ricorda, una volta in più, la fragilità dell’idea di inquadratura
come finestre: il cinema si apre sul mondo, ma tra lo sguardo dell’osservatore e la realtà si interpone
sempre una mediazione ottica.
Gli effetti di verosimiglianza, come quelli di primi e primissimi piani, o al contrario di distorsione, prodotti
dagli obiettivi, dipendono dalla distanza tra il soggetto e la macchina da presa: con il grandangolo, che
tende a esasperare la profondità, la deformazione dell’immagine è quasi inevitabile nel caso di
inquadrature strette come il primo piano o il campo medio. Un altro tipo di effetto impiegato è il fish-eye,
un obiettivo grandangolare estremo che consente di cogliere un campo pari o superiore a 180°,
producendo un’immagine simile a una semisfera. Mentre la grandezza scalare dell’inquadratura è un
parametro che esprime due ordini di spazialità: da un lato, la maggiore o minore quantità di campo
rappresenta (ampia, nel caso di un campo lunghissimo; ridotta, nei casi di un primo piano), dall’altro, la
qualità della relazione di distanza tra la macchina da presa e il soggetto. Proprio per il fatto di portare sullo
schermo non soltanto una porzione di spazio ma una relazione spaziale, il parametro della grandezza
scalare è stato spesso piegato a usi marcati che caricano la prossemica tra dispositivo cinematografico e
realtà. Per esempio, nell’ambito del cinema narrativo “medio”, un campo lungo o lunghissimo è
normalmente impiegato per descrivere lo spazio in cui si svolgerà un’azione, mentre inquadrature più
strette come il primo piano o la mezza figura sono di norma associate al racconto dell’azione dei
personaggi; il primo piano, in particolare, ricorre alla rappresentazione dei dialoghi, e appare una scelta
quasi obbligata quando del personaggio si vogliono mostrare pensieri ed emozioni.
Oltre che dalla distanza, <<la posizione della macchina da presa rispetto all’oggetto inquadrato>>, è
determinata da altri 3 fattori:
- l’altezza: riferito alla distanza tra la macchina da presa e il suolo. Le sue variazioni si misurano a
partire da una posizione neutra in cui la macchina da presa è posizionata all’altezza degli occhi del
personaggio
- l’angolazione: l’angolazione può essere dall’alto, che produce uno sguardo “verso il basso”. Le
variazioni dell’angolo di ripresa si misurano a partire da una situazione neutra, detta frontale, in cui
l’asse ottico della macchina è parallelo al suolo. Entro certi limiti, altezza ribassate o rialzate e
angolazione dall’alto o dal basso appaiono riconducibili a un vedere umano.
- l’inclinazione: le inquadrature oblique, cioè “storte”, costituiscono una pura convenzione
rappresentazionale della nostra esperienza reale: quando ci poniamo a testa in giù o giriamo la
testa da un lato, la realtà non cambia. Il cinema esprime in questo caso un’esperienza del corpo
attraverso un espediente linguistico che, per quanto convenzionalmente accettato, rappresenta
uno scarto rispetto alla nostra realtà percettiva.
All’interno dell’inquadratura, altezza, inclinazione e angolazione, assieme alla distanza, definiscono un
punto di vista, la cui idea rimanda alle qualità ottico-visive dell’inquadratura considerata come veduta. Il
maggiore o minore grado di visione simile a quella dell’essere umano hanno contribuito a definire dei
quadri di visibilità avvertiti come più riconducibili alle caratteristiche di un vedere umano. La storia del
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
cinema inizia quindi nel segno di un quadro di visibilità spiccatamente antropomorfo: per tutto il primo
decennio del ‘900, il Modo di Rappresentazione Primitivo impone la regola del punto di vista unico e
centrale, corrispondente grosso modo alla visione totale, e teatrale, di uno spettatore seduto in platea. Lo
stesso di può dire nel cinema classico. Ma è soprattutto nel cinema moderno, e ancora di più nel cinema
postmoderno, che i quadri di visibilità si distaccano da una posizione antropomorfa, progettando
l’inquadratura attorno a uno sguardo “impossibile”.
La dissociazione tra immagini antropomorfiche e immagini tecnomorfiche emerge in modo ancora più
pronunciato guardando ai movimenti della macchina da presa; e della seconda il cinema contemporaneo, in
particolare quello avventuroso, fantasy e d’azione, costituisce un esempio emblematico: parte del suo
fascino deriva proprio da un comportamento spettacolare della cinepresa, che inscrive nel racconto una
corporeità del tutto “smisurata” rispetto ai codici dell’esperienza umana. Lo rivela bene il caso del cinema
hollywoodiano classico: la posizione centrale attribuita al personaggio e alla sua azione subordina il
movimento della macchina a una prassi del tutto antropomorfa, della quale la soggettiva rappresenta
idealmente l’emblema. Del resto, i due movimenti base del cinema (la panoramica e il carrello) rimandano
essenzialmente alle principali modalità attraverso le quali l’essere umano esplora lo spazio; il primo
richiama il movimento rotatorio della testa; il secondo, il movimento del corpo nello spazio e il suo
avanzamento. La vicenda, tipicamente contemporanea, del movimento di macchina quale <<esibizione
della tecnologia>>, ha uno dei suoi punti d’origine proprio nel progressivo divorzio tra strumenti di ripresa e
corpo dell’operatore, come testimonia, la louma, telecomandata a distanza e in grado di compiere
complessi movimenti “tecnologici”. Da questo punto di vista, l’estetica contemporanea dei movimenti di
macchina ci restituisce un quadro segnato da una pronunciata opposizione tra un fare registico che esalta
un’attitudine antropomorfa, e una prassi che enfatizza le facoltà inventive e trasformative dell’apparato
tecnologico. Ad esempio, all’interno di narrazione generalmente orientata da una focalizzazione esterna, la
macchina da presa si “aggrappa” agli attori, spesso pedinandoli, per dare forma a uno sguardo sottomesso
ai limiti dell’esperienza umana, alla misura del corpo e alle leggi fondamentali che ne definiscono il
comportamento. Il cinema contemporaneo hollywoodiano, in particolare blockbuster, invece, è solito
utilizzare inquadrature che esaltano la verticalità, come le plongée o la contre-plongée, che è indice di una
logica del movimento che si allontana dai quadri percettivi dell’esperienza umana, e mira anche a esaltare
la propria libertà di azione, come ben rivela la centralità che la “figura” del volo (quando la macchina da
presa riprende “volando”) assume all’interno di questo cinema. (es: Avatar)
L’intensificazione “ultracorporea” e spettacolare associata alla virtual cinematography, dipende non
soltanto dalla libertà di assumere punti di vista “disumani”, ma anche dalla libertà di creare collage di ritmi,
traiettorie e dinamiche offerti nella forma di un unico, complesso movimento di esplorazione dello spazio.
L’estetica della regia virtuale coincide con un vedere di più, più da vicino, più in profondità e più a lungo. Lo
rivela bene anche la ricorrenza, nel cinema contemporaneo, di movimento endoscopici (“osservazioni da
dentro”) che squarciano la superficie di corpi e oggetti per condurre lo sguardo al loro interno. Per
descrivere questo tipo di estetica è stato introdotto il termine di cinematic cinema, in cui il raddoppiamento
dell’idea di movimento rende bene la propensione a imprimere al racconto un forte dinamismo in cui il
movimento del “corpo” della macchina da presa sembra di fatto automatizzarsi. Questo cinema
“cinematico” si stacca da una logica di immediata funzionalità narrativa (e di economia significante, cara al
cinema hollywoodiano classico ma anche alla “morale” del cinema moderno) per inscrivere nel racconto un
“effetto cinetico” fine a se stesso, orientato a un costante stimolazione percettiva. Ciò si traduce anche in
un’emblematica “incapacità” di arresto del movimento, tratto che appare una delle caratteristiche
distintive del cinematic cinema contemporaneo.
Quest’uso sensibile della tecnologia di ripresa sembra sfuggire alla classica distinzione tra:
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
- movimenti motivati: tipici del cinema classico, che così appaiono se svolgono almeno una delle
funzioni (secondo Edward Branigan) fra:
o definire lo spazio
o segue da vicino, o anticipa, il movimento di un personaggio o di un oggetto dotato di
particolare rilievo narrativo
o continua a mantenere o pone al centro dell’inquadratura un personaggio o un oggetto
dotato di particolare rilievo narrativo
o si allontana, evitando esplicitamente di seguirlo o reinquadrarlo, dal movimento di un
personaggio o di un oggetto per ragione di suspense, mistero, sorpresa, buon gusto o
censura
o segue o rivela uno sguardo
o seleziona o identifica un dettaglio narrativamente significante
o visualizza la soggettività di un personaggio
Inoltre, perché questi movimenti siano realmente giustificati, devono anche rispettare alcuni vincoli
temporali
- movimenti autonomi: tipici del cinema moderno e postmoderno, all’interno dei quali accade
regolarmente che i movimenti di macchina non solo si liberino dalle “ragioni” diegetiche ma che si
impongano anche quale strumento espressivo del tutto autonomo. Dal punto di vista funzionale, un
movimento di macchina autonomo può funzionare come marca stilistica, come strumento di
interpretazione del racconto, inserendo nel film una dimensione “esterna”, che può anche
generare un surplus percettivo e un’intensificazione ritmica. Tra gli aspetti caratteristici di questo
paradigma stilistico vi sono proprio: l’esibizione del momento della scrittura e l’esposizione della
prassi tecnico-linguistica, complice la disponibilità di nuove risorse (la louma e la steadycam) che
contribuiscono sia a fluidificare i movimenti della camera, sia ad articolare più complessi percorsi
per lo sguardo.
Gli effetti speciali
Nei primi anni di vita del cinematografo, il funzionamento della scenografia cinematografica appare del
tutto simile a quello della scenografia teatrale, dove anche le condizioni produttive sono in larga parte
analoghe. Vi è però una distinzione (fatta da Christian Metz) fra:
- Trucchi: si svolgono a livello profilmico. Sono per lo più di natura meccanica e, per quanto riguarda
la scenografia, di derivazione teatrale.
- Effetti speciali: si svolgono in fase di ripresa o di post-produzione. Si ottengono attraverso
particolari strategie di ripresa oppure in fase di post-produzione, intervenendo direttamente
sull'immagine o sulla pellicola.
Non sempre queste due categorie possono essere distinte in modo netto, e in alcuni casi il risultato finale è
dovuto alla somma di trucchi ed effetti speciali. È importante sottolineare che, nonostante il grande
sviluppo dei software per la modellazione grafica, molti registi si rivolgono ancora oggi alla tradizione dei
trucchi scenografici, integrando riprese sul set ed effetti digitali.
Il montaggio
Il montaggio delle immagini e dei suoni rappresenta il momento fondamentale della fase di post-
produzione: consiste in un processo di analisi, selezione e assemblaggio del materiale realizzato durante le
riprese, che rappresenta la terza e ultima fase di scrittura di un film.
Lungo tutta la storia del cinema si possono isolare due tendenze principali di montaggio, basate
rispettivamente su una logica di continuità e una logica di discontinuità: due diverse ideologie che finiscono
per esaltare la capacità di simulare una totalità.
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
La logica della continuità è rappresentata essenzialmente dal cosiddetto découpage classico, sviluppatosi
all’interno del cinema hollywoodiano e fondato sulla cancellazione della natura frammentaria del film e sul
primato della narrazione; la ricerca della discontinuità, guida esperienze eterogenee, dagli azzardi delle
avanguardie di inizio 900 agli “strappi” del cinema moderno; ad accomunarle è la volontà di fare della
differenza il motore della produzione del film. Tuttavia, non si deve pensare ad un’adozione radicale
dell’una o dell’altra possibilità: il cinema di finzione narrativa, infatti, ha saputo accogliere forme di
associazione discontinua tra le inquadrature, così come il cinema sperimentale ha spesso raccontato le
proprie storie “anti-classiche” sullo sfondo dell’impalcatura logica definita dalle regole del découpage. E
una simile coabitazione è tanto più evidente nel cinema contemporaneo, nel quale il montaggio lineare
rinuncia volentieri a un po’ della propria regolarità e trasparenza per imprimere un andamento più
coinvolgente al film. Tanto il cinema della continuità come quello della discontinuità guardano alla fase
della messa in serie delle inquadrature come a un processo determinante, che dà forma e fa funzionare il
film, e che si esercita nella costruzione di relazioni tra elementi precisamente individuati. In particolare, a
partire da metà degli anni 10 del 900 e lungo tutto gli anni 20, cinema hollywoodiano e avanguardie
europee concorrono a stabilire due principi fondamentali del montaggio: il prodotto della correlazione tra
due inquadrature non corrisponde mai alla loro semplice somma, e il significato di una singola inquadratura
dipende da quelle che la precedono e che la seguono. Quindi il “senso” di un film non risiede nelle singole
immagini, ma ha origine dal loro accostamento.
Tra gli anni 20 e 30 del 900, in un dibattito, prevalentemente francese e sovietico, si tentò di rispondere alla
domanda “Che cos’è il cinema?”. Fra le varie risposte che vengono date, se ne possono isolare due, che
sono complementari e contribuiscono a promuovere la consapevolezza del cinema come linguaggio
artistico autonomo, ma anche a sciogliere la nozione di montaggio da una definizione troppo appiattita
sulla sua natura di operazione tecnica:
- l’idea che il montaggio rappresenti l’essenza del cinema. Ad essa ci si riferisce con l’etichetta di
“montaggio sovrano”, interpreta l’operazione di messa in serie delle inquadrature come lo specifico
del cinema. L’idea di base è che l’immagine fotografica rappresentata dalla singola inquadratura
non sia che il punto di partenza di un più complesso e originale processo creativo. In questa
prospettiva, il montaggio è il cinema, facendolo essere un’arte. (Pudovkin e Kulesov)
- l’idea che il montaggio cinematografico rappresenti la realizzazione emblematica del principio
artistico per eccellenza, al punto di fare del cinema il mezzo d’espressione più complesso e
“moderno”. In questa prospettiva, si può dire che il cinema è montaggio. (Ejzenstejn)
In conclusione, bisognerà ampliare l’idea di montaggio cinematografico, slegandola da una definizione che
fa coincidere un principio creativo con un’operazione tecnica di articolazione materiale di una serie di
inquadrature.
Continuità e découpage
La continuità non implica una negazione del montaggio né conduce, come nel caso del cinema del piano
sequenza, a una predilezione per l’esplorazione continua della realtà; piuttosto si fonda su un’idea di
cinema come simulazione di una totalità coerente, e affida al montaggio il compito di creare un insieme
percettivamente fluido, in cui la natura frammentaria del film risulti assorbita all’interno di una
concatenazione causale e lineare delle inquadrature. La continuità è un criterio che informa
complessivamente un certo tipo di cinema e che agisce a tutti i livelli della filiera produttiva, dal momento
della scrittura a quello delle riprese, fino alla fase di post-produzione. Il montaggio continuo si è dunque
sviluppato in rapporto al tentativo di trapiantare al cinema il realismo, la complessità e la ricchezza di
soluzioni tecniche del romanzo ottocentesco. Esso è una risorsa linguistica capace di ricreare sullo schermo
un mondo a immagine e somiglianza di quello in cui viviamo, all’interno del quale raccontare storie in modo
efficace e coinvolgente. Alla base del funzionamento di questo tipo di montaggio, c’è la sublimazione
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
linguistica di due meccanismi logici sui quali si reggono tutte le forme di montaggio (e il cinema tout court):
da un lato, la supposizione che esista un significato ben preciso nella successione delle immagini; dall’altro
lato, l’idea che successione motivata equivalga a “una cosa a causa dell’altra”. Di fatto, il montaggio
narrativo serve a trasformare una successione di elementi in una catena di causa e di effetti, con la
conseguenza di imporre non soltanto un ordine temporale, ma anche una cronologia “logicamente”
irreversibile. È in particolare all’interno del cinema statunitense, a partire dagli anni 10 del 900, che questo
“effetto di continuità” comincia a codificarsi in un vero e proprio sistema di regole. (David W. Griffith, The
Birth of a nation)
Con il termine découpage si identifica una figura di scomposizione analitica, finalizzata a (ri)costruire sullo
schermo uno spazio-tempo continuo, che funzioni secondo leggi e logiche conformi a quelle che regolano la
nostra esperienza della realtà. L’importanza del découpage “all’americana” risiede in questa capacità di
sbriciolare l’unità degli elementi visivi e percettivi senza compromettere un “effetto di realtà” che il cinema,
in virtù della sua base fotografica, possiede in partenza. Ma se il découpage rappresenta ancora oggi lo
standard del cinema di finzione narrativa, è soprattutto perché in esso questa simulazione di un mondo
“abitabile” risulta convertita in un insieme di regole, il cosiddetto continuity system, che del découpage può
esserne considerato la base. Regole su come, quando e dove collocare la giunta tra un’inquadratura e le
altre, che producono, da un lato, una “frammentazione organizzata” in cui la costruzione di una narrazione
coinvolgente, centrata sui personaggi, non entra mai in conflitto con il principio finzionale dell’illusione di
realtà; dall’altro lato, queste stesse regole assicurano un “effetto di continuità” sul piano figurativo e
percettivo, grazie a stacchi che, rendendosi invisibili, fanno procedere la narrazione in modo fluido, con
un’inquadratura che continua morbidamente nella successiva. L’elemento centrale di queste strategie
trasparenti e continue è rappresentato dal sistema dei raccordi. La stragrande maggioranza dei passaggi da
inquadrature più larghe a inquadrature più strette segue la regola del raccordo sull’asse, in cui il
cambiamento scalare rispetta la posizione e l’angolazione della macchina da presa. Una perfetta
applicazione dei raccordi di direzione regola invece le entrate e le uscite dei personaggi. A riaffermare la
contiguità stabilita tra due piani contribuisce il raccordo di direzione di sguardi. In tema di sguardo, ma in
rapporto all’azione più che alla direzione, va sottolineata la presenza di un meccanismo che regola i
rapporti tra vedente e visto: è il raccordo di sguardo.
Alla base del découpage c’è la volontà di porre lo spettatore nella migliore posizione possibile dalla quale
seguire il racconto, che si manifesta come vera e propria “onnipotenza”. Da un punto di vista ideologico, il
costante ricorso a una focalizzazione zero, che elegge il destinatario a vertice indiscusso e “punto di fuga”
unica della narrazione, rappresenta un fattore essenziale del découpage, dando allo spettatore una
posizione tra onniscienza e ubiquità. Il sistema dei raccordi è quindi l’insieme delle regole su cui si fonda il
cinema narrativo “all’americana”, che servono anche a raccordare lo spettatore al film.
La logica della continuità si basa sulla progettazione di uno spazio verosimile, in cui lo spettatore non deve
mai perdere la bussola dell’orientamento: dal punto di vista temporale essa stabilisce un ordine
irreversibile, intimamente legata allo sviluppo causale dell’azione. Grazie a raccordi, che possono essere di
movimento o di direzione, si ammorbidiscono le discontinuità sul piano iconico, e il film si sviluppa come
un flusso percettivamente continuo, in cui un’immagine sembra prolungarsi nella successiva. Il découpage
mira a costruire scene spazialmente verosimili e in “tempo reale”.
Dal punto di vista dell’intreccio complessivo del film, invece, il découpage regola un andamento
caratterizzato normalmente da vistosi salti temporali e da frequenti cambiamenti di luogo. Fra le varie
tecniche possiamo nominare la dissolvenza al nero, grazie alla quale il film marca la fine di una fase del
racconto e l’avvio di un’altra. Come tutte le transizioni elaborate nel quadro del cinema narrativo classico
(come l’iris o la tendina, quasi del tutto scomparse dalla produzione contemporanea), la dissolvenza
rappresenta un’alternativa al semplice stacco. Oppure ci sono le transizioni, cioè figure iconiche del tutto
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
arbitrarie e di natura extradiegetica. O ancora la dissolvenza incrociata, cioè un movimento verso
qualcos’altro. Proprio a quest’ultima, il cinema ha fatto precoce ricorso per esprimere non soltanto il
passaggio da una sequenza all’altra, ma anche il recupero analettico, vale a dire il movimento del racconto
verso un episodio passato, che si materializza sullo schermo. Nel caso del flashback, del resto, la segnaletica
deve sempre apparire marcata e inequivocabile, anche quando a introdurlo, in modo esplicito, è il
personaggio. In fine, il montaggio alternato e il montaggio parallelo rappresentano due figure
emblematiche del potere costruttivo del montaggio: in questi casi, il movimento di avanti e indietro tra due
o più linee narrative consente di stabilire un rapporto di simultaneità tra azioni ambientate in spazi
ravvicinati e tra azioni ambientate in spazi lontani tra di loro.
Quindi, i raccordi intervengono a disciplinare, nel senso della continuità, sia il piano diegetico che quello
iconico, che sono inscindibili e interdipendente, costruendo un flusso narrativo e percettivo.
Il continuity system è un sistema elastico e permeabile, in cui la frammentazione organizzata nel segno della
continuità può tranquillamente accogliere cambiamenti di velocità, strappi o deviazioni. Insomma, il
“sistema” può anche aprirsi e accogliere non soltanto perturbazioni della linearità narrativa, ma anche
discrete rotture di tono.
Nell’alleanza tra continuità diegetica e continuità iconica, si realizza un uso marcato degli elementi
linguistici, il quale introduce una momentanea differenza nel flusso percettivo del film, senza per questo
compromettere la tenuta complessiva. Nonostante nel montaggio continuo trasparenza, linearità e
uniformità, tanto sul piano diegetico quanto sul piano visivo, dettano la regola, la drammaturgia di un film
non può fare a meno di piccoli strappi, la cui forza ed evidenza risultano tanto maggiori quanto più è
rigorosa la disciplina narrativa cui è sottoposta la disparità dei materiali che concorrono a creare un film.
Queste piccole fratture diventano sempre più frequenti a partire dagli anni 60 e 70, e possono essere
interpretate come emblema della duttilità del montaggio continuo, suscettibile, in qualsiasi momento, di
“incrinarsi”, senza per questo compromettere la propria tenuta. Al di fuori di questa consapevolezza
generale, si può rischiare di fraintendere che la stragrande maggioranza dei film di finzione narrativa
funziona, ancora oggi, secondo la logica “realista” della continuità e le convenzioni che la sostengono. Più in
generale, c’è il rischio di pensare alla fortuna del découpage e del continuity system come il semplice
ripetersi di una formula efficace e di successo, da cui si scaturirebbero racconti audiovisivi sostanzialmente
identici, fortemente standardizzati e in definitiva prevedibili. E se ciò è in parte vero nel caso della
produzione televisiva, nel caso del cinema, la logica della continuità non ha mai smesso di evolvere. E l’idea
della “rottura di tono” aiuta a specificare la dinamica fondamentale di questa evoluzione che riguarda il
livello visuale, là dove il montaggio lavora normalmente a mitigare la differenza iconica tra le inquadrature,
rendendo lo scarto e lo stacco il più possibile impercettibili. Questioni di stile, come rivela l’esempio del
campo-controcampo, che nelle mani dei registi contemporanei è andato incontro a utilizzi anomali ma mai
incomprensibili, al punto di decostruire i meccanismi su cui si fonda il raccordo di direzione e di sguardi e il
raccordo sonoro.
Si può descrive l’evoluzione storica del regime della continuità narrativa come l’istituzionalizzazione di una
maggiore libertà nei confronti del principio di trasparenza e dell’invisibilità degli stacchi, o come la
progressiva normalizzazione della logica della rottura iconica, che smette di funzionare nel caso del cinema
d’autore, dove, già a partire dagli anni 70, si manifesta una tendenza generale a lavorare sulle differenze, i
salti e gli strappi sul piano figurativo delle inquadrature, o a dissociare una frammentazione organizzata nel
segno della continuità da un’invisibilità delle procedure di costituzione e di esplorazione del mondo del
film. Il “lavoro della forbici” e l’azione dell’istanza narrante si fanno più marcati, in particolare, nel cinema
postmoderno, caratterizzato da un ritmo di montaggio elevato e talvolta gratuito e da un’ubiquità dello
sguardo particolarmente dinamica e nervosa.
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
In sintesi, si potrebbe parlare, per il cinema contemporaneo, di una continuità intensificata. Il film di
finzione narrativa continuerebbe, ancora oggi, a rappresentare lo spazio, il tempo e l’azione secondo i
principi messi a punto nel quadro del cinema narrativo hollywoodiano, introducendo varianti
“quantitative”, in costante aggiornamento, la cui natura è determinata da un insieme di fattori diversi, tra i
quali lo sviluppo tecnologico, la disponibilità di nuovi mezzi d’espressione, l’influenza esercitata da altri
media o linguaggi. La forza di un modello altamente formalizzato come quello della continuità narrativa,
interprete di un’idea di cinema come simulazione verosimile della realtà, risiede, prima di tutto, nella sua
capacità di attualizzarsi storicamente in forma nuove o aggiornate, reagendo sia a una serie di spinte
interne, sia a una serie di sollecitazione culturali esterne.
Il piano sequenza
Un’altra strategia è quella del piano sequenza, cioè di un singolo piano, fisso o mobile, che in virtù della sua
durata e della sua autonomia narrativa costituisce l’equivalente di una sequenza, e mira generalmente,
attraverso il rifiuto degli stacchi di montaggio, a una restituzione integrale della realtà. Due forme, il
découpage e il piano sequenza, che esprimono una visione opposta dell’interpretazione cinematografica
del bisogno primario dell’uomo di raffigurare il reale come un tutto coerente e omogeneo. In entrambi i
casi si tratta di forme, cioè strategie linguistiche e retoriche: occorre escludere l’idea che in rapporto a quel
bisogno di rappresentazione dell’uomo, il piano sequenza costituisca una risposta “naturale”, per
opposizione all’artificialità del continuity system, un modo di scrittura davvero trasparente e realista, il cui
dispositivo cinematografico, rinunciando al montaggio, aderisce senza ulteriori mediazioni alla complessità
fenomenica del mondo che si apre di fronte alla macchina da presa. Ovvero, la continuità percettiva del
piano sequenza non è il veicolo di un accesso automatico a qualche tipo di “verità”; essa, semmai,
rappresenta un fattore tecnico-espressivo suscettibile di essere piegato a produrre un certo effetto di
realtà. Il piano sequenza non è un elemento linguistico tra gli altri, ma il veicolo privilegiato di un cinema
che, attraverso il rispetto dell’unità spaziotemporale, asseconda fino in fondo la propria natura di
strumento di rivelazione della realtà, formula che, si oppone a quella di rappresentazione, in cui ciò che
conta non è la realtà ma quello che vi aggiunge l’immagine. All’interno di una simile impostazione del
rapporto tra dispositivo cinematografico e realtà, il montaggio finisce assimilato a una specie di trucco e
additato come l’origine di tutti gli artifici di un cinema “di rappresentazione”. Il “cinema del piano
sequenza”, tuttavia, non coincide con un rifiuto del principio di montaggio, ma con una critica al découpage
“all’americana”. Il piano sequenza neorealista (come quelli di Rossellini, che segue l’idea di Bazin, ovvero
che non si riduce all’esaltazione del piano sequenza, ma ne fa di quest’ultimo una specie di “libertà
vigilata”) si rivela, più che una soluzione linguistica frutto di una consapevole opposizione a una regola
alternativa, la “misura” per certi versi naturale di osservazione e di ascolto, prima ancora che di narrazione,
di un cinema che sceglie di legarsi a <<un reale che non è stato previamente decifrato e organizzato, ma
viene offerto nella sua molteplicità>>. E la conseguenza più vistosa di questo atteggiamento “umanistico” è
quella di imprimere alla visione un carattere di partecipazione diretta agli eventi, trasformando l’esperienza
dello spettatore in un movimento incerto nei fatti, che raggiungono lo schermo in tutta la loro evidenza e
materialità, accumulandosi, sommandosi e scontrandosi, anziché dispiegarsi ordinatamente.
L’importanza del piano sequenza è quasi impossibile da riassumere: elevato dal cinema francese degli anni
60 a emblema della ricerca d’autore, esso si divide in numerosi modi di interpretazione e utilizzo,
allontanandosi al tempo stesso, soprattutto nella produzione contemporanea, dalla sua identità di strategia
della continuità opposta al découpage.
In conclusione, dunque, con riferimento al cinema più recente, solo una rapida descrizione di tre tendenze
principali, caratterizzate da una valorizzazione spesso opposta dei coefficienti linguistici del piano sequenza:
- la prima ha origine nel cinema moderno, italiano e francese che interpreta il piano sequenza come
una strategia di rinnovamento del racconto, mantenendo sullo sfondo la questione filosofica, prima
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
ancora che estetica, del rapporto tra realtà e dispositivo. In essa il piano sequenza appare
prevalentemente impiegato quale veicolo di un’esplorazione insieme umanistica e “a misura di
uomo” della realtà, un’esplorazione ruvida, anti-spettacolare, fondata su un contatto problematico
tra cinema e mondo. (es: Rossellini)
- La seconda coincide grosso modo con l’idea di piano sequenza “mentale”, che anziché esaltare il
momento dell’incontro sensibile tra realtà e sguardo, si confronta con il “tempo delle cose” a
partire dagli schemi ideali della visione, facendo della continuità una specie di cassa di risonanza del
valore drammatico degli eventi. Questo tipo di piano sequenza è caratterizzato da forme, spesso
molto articolate, di montaggio interno, ma anche da un’intensificazione spettacolare del
movimento continuo dello sguardo, della “fisicità” di un’esplorazione dinamica e prolungata, al
punto di trasformare il piano sequenza in una specie di “effetto speciale”. Ciò che colpisce, in questi
casi, molto spesso, è il virtuosismo esecutivo. (es: Welles)
- La terza tendenza mette in rilievo la “presa”, integrale e prolungata, di eventi che si dispiegano
nella loro effettiva durata. Lo si potrebbe definire un piano sequenza fenomenologico, che insiste
sull’esperienza stessa del “farsi tempo” degli eventi sullo schermo. Piano sequenza che
marginalizzano una finalità rappresentativa o narrativa a tutto vantaggio di un’amplificazione del
legame sensibile dello spettatore con il puro durare delle azioni, come i piani sequenza fissi, frontali
e ripetitivi.
Discontinuità
La logica della discontinuità cinematografica si regge sulla combinazione esibita delle immagini, e fa dello
stacco il principio guida del montaggio, che si rende così trasparente, ma in un’accezione ben diversa da
quella postulata dal continuity system.
Anche nell’ambito della discontinuità si possono individuare interpretazioni spesso molto diverse di uno
stesso principio generale. Ciò è particolarmente vero nel caso delle avanguardie europee di inizio
Novecento, cui si deve la ricerca più coerente in merito alle potenzialità espressive del montaggio
discontinuo. Le avanguardie condividono sia l’idea di una subordinazione del principio della contiguità
spazio-temporale tra le inquadrature al valore espressivo della loro giustapposizione, sia il riconoscimento,
teorico e poetico, della centralità del montaggio all’interno dell’opera cinematografica, sia, infine,
un’opposizione più o meno apertamente critica nei confronti del “modello americano”. Dall’altro lato,
questi movimenti pensano e praticano la logica della discontinuità in direzioni che non è sempre possibile e
assimilare sotto un’unica insegna. L’accostamento evidente di due inquadrature può infatti reggersi su
giustapposizioni di natura molto diverse, a loro volta dipendenti dal livello su cui insiste la discontinuità. Ma
le differenze all’interno delle ricerche delle avanguardie storiche si colgono in modo ancor più immediato
guardando ad alcune “figure” caratteristiche e distintive, come l’associazione metaforiche o la “sequenza di
montaggio”, nelle quali si coagula una diversa riflessione sul potere costruttivo della discontinuità.
Complessivamente si può pensare al contributo delle avanguardie primonovecentesche come la messa a
punto di modalità di associazione tra le inquadrature alternative alla logica dell’illusionismo realista del
découpage, come strategie di significazione che, in una fase storica di intensa riflessione sull’identità e il
funzionamento del cinema, ne arricchiscono le possibilità espressive, esplorando al tempo stesso il
contributo del montaggio nell’ambito del film non narrativo e non analogico. Modalità di associazione che,
come accade per i fenomeni artistici d’avanguardia, hanno progressivamente perduto il loro originario
coefficiente “resistenziale” e oppositivo, per trasformarsi in risorse stilistiche suscettibili di essere utilizzate
anche all’interno di un cinema narrativo genericamente improntato alle regole della continuità.
Montaggio plastico
Nelle associazioni grafiche il rapporto tra le inquadrature è stabilito dal dialogo tra forme, volumi, superfici,
linee, colori, movimenti ecc. il cinema astratto degli anni 20 offre un esempio emblematico di queste
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
possibilità associative ma si tratta di casi molto particolari di montaggio continuo: i film astratti, sembrano
spesso “raccontare storie” di forma geometriche in movimento, obbligando il montaggio a lavorare sul
livello non figurativo. Ben diverso, e più ricco di conseguenze, è il caso in cui la ricerca di associazioni
formali si manifesta all’interno di film narrativi e figurativi; anche per questo, adottando una terminologia di
ispirazione semiotica, si potrebbe parlare, più correttamente, di montaggio plastico. Il suo utilizzo coincide
con un rovesciamento di prospettiva, tale per cui il livello figurativo dell’immagine appare trascinato da
quello plastico, formale e astratto, con la conseguenza di produrre associazioni talvolta spiazzanti e
rivelatorie. Questo tipo di associazioni ha trovato campo fertile soprattutto nel contesto delle avanguardie,
in particolare, nel surrealismo e nel dadaismo, movimenti che, in tutti gli ambiti della produzione artistica,
ruotano essenzialmente attorno alla costruzione del principio di corrispondenza iconica tra la realtà e la sua
rappresentazione. In termini generali, come accade per i modelli di montaggio alternativi alla continuità,
l’avvento del sonoro tenderà a scoraggiare questo tipo di ricerche interamente centrate sul potere
dell’immagine, accelerando al tempo stesso quel processo di sintesi e codificazione, in virtù della quale
l’avanguardismo stilistico si distilla in una serie di “figure” che vanno ad arricchire il repertorio delle
soluzioni di montaggio. Per quanto riguarda le associazioni plastiche, tale processo conduce a formalizzare
due principali modalità di impiego: in un caso, esse sono utilizzate come strategie di transizione, grazie alle
quali stabilire dei <<rapporti sotterranei tra motivi lontani>>. Nel secondo caso, invece, il ricorso a questo
tipo di associazione può servire a esaltare la dimensione plastica della rappresentazione, con interessanti
effetti di stilizzazione dei dati figurativi. Al di là di questi utilizzi “canonici” del montaggio plastico, dal punto
di vista analitico appare necessario guardare al piano plastico come a un livello immanente suscettibile di
essere richiamato nell’immagine e tra le immagini. Qualcosa che proprio per il fatto di essere parte
integrante della struttura della rappresentazione visiva, può essere valorizzato, all’occorrenza, quale
principio guida del montaggio, senza per forza condurre l’intreccio tra plastico e figurativo a esisti
“sconvolgenti”. Prospettiva che trova spazio nella riflessione di Ejzenstejn, secondo il cui la “drammaturgia
del soggetto cinematografico” è rafforzata da una “drammaturgia della forma cinematografica visiva”; idea
che non rimane relegata alle avanguardie, ma che tocca anche altri campi (Béla Balázs). È seguendo l’idea di
Balázs, in cui gli elementi “decorativi” risultano distaccati dalle immagini, che si può prendere come
esempio le associazioni plastiche che ricorrono nel musical hollywoodiano come una specie di “effetto
speciale” che narcotizza temporaneamente una logica di concatenazione causale tra gli elementi figurativi,
per generare affascinanti effetti di stilizzazione e di rimando formale, ma anche di “declassamento” della
figura umana a forma geometrica in movimento. E un discorso in parte analogo si potrebbe fare a proposito
dei “numeri” di battaglia che affollano molti blockbuster contemporanei. Il fatto che questi valori associativi
si manifestino all’interno di segmenti spettacolari, suggerisce infine come il montaggio plastico rappresenti
oggi una risorsa logico-sintattica prevalentemente associata all’orchestrazione di momenti “attrazionali”, in
cui la dimensione visiva tende a prevale su quella narrativa.
Il ritmo
L’idea di ritmo è inseparabile da quella di montaggio: indipendentemente dal fatto che esso lavori nel senso
della continuità o della discontinuità la sua azione di spezzettamento contribuisce sempre e comunque a
imprimere un certo dinamismo al film, in un accordo complesso con i contenuti delle inquadrature e i
parametri della messa in scena, primi tra tutti i movimenti della macchina e la “sensibilizzazione” ritmica
condotta dalla recitazione degli attori. Questione quindi di quantità e di qualità delle variazioni, e seguendo
Ejzenstejn, distinguendo tra:
- una dimensione metrica: dipende dalla lunghezza assoluta dei pezzi o dal ritmo essenzialmente
quantitativo prodotto dal numero di stacchi.
- una dimensione ritmica: si misura in rapporto ai contenuti dell’inquadratura, e rimanda al valore
qualitativo delle variazioni.
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
Si tratta di due aspetti intrecciati e interdipendenti: un alto numero di stacchi non contribuisce
automaticamente a imprimere un maggior dinamismo se, a livello visivo, essi non corrispondono a sensibili
variazioni di contenuto. Ciò che definiamo ritmo di un film corrisponde a un’impressione percettiva, in cui
l’idea di ritmo viene visto come una modulazione del fluire delle forme nel tempo che si lega a quella di
ritmo come processo cognitivo, come andamento dell’interesse e dell’attenzione dello spettatore nei
confronti di ciò che accade sullo schermo. Quindi, ritmo del discorso e della visione.
Alla dimensione della risposta fisica sembra fare appello un tipo di montaggio, elaborato originariamente
nel quadro dell’avanguardia francese, che elegge il potenziale ritmico “assoluto” dell’associazione tra le
inquadrature a suo principio guida, a partire dall’idea generale che il movimento delle forme prodotto
dall’accostamento delle immagini possa generare e modulare in modo diretto e immediato percezioni,
sensazioni ed emozioni ben precise. In questo senso, il montaggio è caratterizzato dal fatto di attribuire una
priorità espressiva a un elemento strutturale del cinema, per trasformarsi nel meccanismo di base
dell’articolazione tra le immagini. In questo caso, l’obiettivo è la valorizzazione del coefficiente musicale
della successione delle inquadrature, per disegnare qualcosa di simile a dei racconti “emotivi”, cosa che
accade soprattutto negli anni 20.
L’ipotesi comune e generale è che il cinema sia “musica per gli occhi”, cioè un linguaggio figurativo, che per
il fatto di svolgersi nel tempo deve mirare anzitutto a costruire delle trame ritmico-musicali. Il valore di
un’opera cinematografica risiede di conseguenza nella sua capacità di suscitare emozioni e di orchestrarle
in una progressione musicale, ed è facile intuire come il montaggio venga considerato uno strumento
“compositivo” fondamentale. In concreto, ciò non equivale a decentrare la narrazione, trasformando il
racconto in una specie di pretesto per valorizzare l’aspetto musicale, e piegando il piano figurativo a
supporto qualitativo dell’emozione; è infatti sulla base di un certo contenuto che la musicalità di un film
può precisare i propri toni e le proprie colorazioni.
In un simile contesto, l’immagine evoca anche il genere della sinfonie urbane, che sull’esplorazione delle
possibilità ritmiche del montaggio fonda di fatto la propria estetica. Il principale obiettivo di queste opere, a
carattere documentario, è quello di tradurre sullo schermo la complessa e mutevole musicalità della città.
Le sinfonie urbane mirano a materializzare sullo schermo la sua essenza ritmica, a far sentire il movimento
della realtà, il suo dinamismo segreto e superficiale. È all’interno di questi film, che vengono ulteriormente
esplorate le potenzialità di una figura caratteristica delle associazioni ritmiche, il cosiddetto montaggio
rapido, in genere associato a un crescendo emotivo. Questo modulo detto “sequenza di montaggio” o, più
spesso, di montage, rappresenta l’emblema delle ricerche dell’avanguardia impressionista. E
dell’impressionismo rappresenta anche il lascito principale, di cui il film narrativo “commerciale” saprà fare
buon uso, impiegando la sequenza di montage soprattutto come risorsa stilistica per rappresentare effetti
dinamici di accelerazione-decelerazione. Lo testimonia, già negli anni 30, molto cinema europeo riferibile al
cosiddetto international style, risultato di una sintesi tra découpage all’americana e innovazioni provenienti
dalla avanguardie del decennio precedente. Di questo stile, il montaggio rapido rappresenta un elemento
imprescindibile. A partire dagli anni 60, si inizia a fare un uso “attrazionale” del montaggio rapido, al quale
fa ricorso soprattutto per imprimere dinamismo alle scene d’azione.
Montaggio intellettuale
Il presupposto discorsivo del montaggio intellettuale coincide con l’idea che il significato emotivo e
razionale di una successione di immagini non risieda nelle inquadrature, ma nella sintesi del loro incontro-
scontro. Dal punto di vista cognitivo, la successione funziona come una sommatoria di sollecitazioni: non
un’immagine accanto all’altra, ma un’immagine sopra l’altra, affidando allo spettatore il compito di lavorare
le sovrapposizioni tra le impressioni che si accumulano nella sua memoria.
Le ricerche della scuola di montaggio russa contribuiscono a formalizzare un modello di associazione tra le
inquadrature e a codificare una serie di figure e stilemi che si staccano ben presto dal territorio dello
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
sperimentalismo d’avanguardia, per sistemarsi stabilmente tra le possibilità espressive del cinema,
compreso quello della continuità “all’americana”. È il caso, in particolare, dell’analogia visiva: essa non
nasce con il cinema sovietico degli anni 20, ma il ricorrente uso da parte di registi russi ne fissa la retorica e
ne normalizza l’uso. È dunque anche grazie a questo processo insieme linguistico e culturale di stilizzazione
se l’analogia può funzionare a pieno regime, fin dagli anni 30, all’interno del cinema classico.
Sgrammaticature
La libertà che caratterizza tutti i film dei registi della Nouvelle Vague e quelli di molti altri autori del cinema
moderno, coincidere con un rifiuto delle regole del découpage e del modello del racconto classico, sostituiti
non soltanto da una narrazione “a mano libera”, ma, più in generale, da un nuovo approccio al linguaggio
cinematografo, in cui all’analogia con la musica, cara alla generazione dei registi francesi dell’avanguardia
impressionista, si sostituisce quella con la scrittura. Importante, al tempo stesso, è l’affermazione di questo
nuovo “modo di scrivere”, che non nasce da una semplice opposizione frontale nei confronti del modello
americano della continuità. Al superamento di un simile modello, i registi della modernità giungono
attraverso un percorso critico rivolto a smascherare la natura ideologica delle forme filmiche e della
trasparenza e dell’illusionismo hollywoodiani, col loro ordinato sistema di regole in cui essi riconoscono il
riflesso di una precisa visione del mondo. È questa visione, e il cinema “normativo” che la diffonde, che essi
respingono: la visione, “occidentale e capitalistica”, di un mondo all’interno del quale l’uomo occupa una
posizione centrale, un mondo logico, unitario, coerente e perciò disponibile e rappresentabile come una
successione lineare di cause e di effetti che si dispiegano in un tempo e in uno spazio dominabili.
L’aggressione che questo cinema esercita nei confronti della geometria perfetta del découpage si rivela una
specie di smontaggio delle sue regole, a partire da quella più importante: la giustificazione narrativa e,
quindi, l’invisibilità percettiva degli stacchi. Nei film della Nouvelle Vague il montaggio non solo non si
adegua alla logica della trasparenza, ma assume molto spesso la forma di un’operazione astratta, di un
gesto linguistico del tutto autonomo rispetto alle “ragioni” proiettate dall’universo diegetico e dalla
progressione narrativa. Tutte le principali strategie di questa radicale discontinuità di basano su una specie
di urto tra il mondo del film e l’azione del cinema, come rivela la più comune di esse, cioè il ricorso allo
stacco brusco, che interviene a concludere un’azione per introdurre rapidamente la successiva, anziché
articolare una successione fluida: chiamati hard cuts, sono particolarmente evidenti nel passaggio tra le
scene, là dove la regola imporrebbe un andamento percettivo insieme morbido e marcato. Una forma di
montaggio che si precisa nel cosiddetto taglio sottrattivo, praticato da tutti i registi della Nouvelle Vague, e
diventato vero e proprio simbolo del cinema moderno e della sua attitudine a tradire la logica della
continuità e dell’invisibilità di ellissi. Questo tipo di stacco si abbatte, come una sorta di interruzione, sul
tempo del film, introducendo una contrazione evidente, dando l’impressione di sottrarre alcune parti
dell’azione, per rivelare al tempo stesso l’essenzialità di quelle selezionate. Anche per questa ragione il
taglio sottrattivo si oppone non soltanto al modello cognitivo del cinema “all’americana”, ma anche allo
<<schema della conseguenza logica basata su una dialettica di associazioni e contrasti>>. Questa logica
della contrazione temporale che finisce per disseminare il film di salti e strappi, imprimendogli un ritmo
spezzato, è anche alla base di un’ultima strategia caratteristica del montaggio moderno, il jump cut, detto
anche “taglio interno” o “taglio in scena”. Si tratta di una specie di scorciatoia, usata soprattutto nell’ambito
dei reportage televisivi, ma che poi verrà usata anche nel cinema narrativo.
Montaggio interno
Lo studio del montaggio cinematografico deve estendersi a contemplare anche tutti quei casi in cui un
principio di scomposizione, selezione e articolazione di elementi opera all’interno della singola
inquadratura, coinvolgendo risorse espressive legate all’organizzazione del visivo. In tal proposito, il piano
sequenza, rappresenta un caso esemplare: una chiara segmentazione dei contenuti iconici e un esplicito
indirizzamento della narrazione possono essere ottenuti anche attraverso i movimenti di macchina e
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
l’orchestrazione degli elementi di profondità di campo. Ma una composizione dinamica può essere
generata anche dalle variazioni della messa a fuoco: una strategia concettualmente opposta alla
costruzione in profondità di campo, che può limitarsi a spostare l’attenzione da un soggetto all’altro,
sostituendosi idealmente al campo-controcampo, oppure dare vita a soluzioni espressive più complesse, in
cui la relazione tra elementi a fuoco ed elementi fuori fuoco si carica di un preciso valore simbolico. E poi,
l’illuminazione e le scenografie, che possono contribuire a segmentare lo spazio dell’inquadratura,
stabilendo dei rapporti marcati, associativi e “sequenziali” tra elementi che smettono di essere
semplicemente compresenti.
Una tecnica di scomposizione è lo split screen, che divide l’inquadratura in due o più porzioni per
presentare simultaneamente azioni collocate in spazi e, talvolta, in tempi diversi. I primi utilizzi dello split
screen risalgono al cinema delle origini. Ci sono 3 modelli principali (Vitella) di utilizzo dello split screen:
- modello narrativo: si sostituisce al montaggio alternato per visualizzare vicende legate da rapporti
di continuità diegetica che si svolgono contemporaneamente. (es: Timecode)
- modello spettacolare: lo spazio dell’inquadratura è frammentato in più sotto inquadrature secondo
una logica iconica che tenta di trasferire al cinema la caratteristica impaginazione dei fumetti: il
primo valore spettacolare attribuito dal film allo split screen risiede proprio in questa strategia di
“ritaglio” ispirata alla libertà di segmentazione e incorniciamento di una tavola disegnata. Ne deriva
un sorprendente dinamismo grafico dell’inquadratura. (es: Hulk)
- modello ipertestuale: caratterizzato dal fatto che <<tra le due o più inquadrature “aperte”
simultaneamente sullo schermo intercorre lo stesso rapporto associativo riscontrabile tra scrittura,
grafica o immagini di un ipertesto, un testo che si propone piuttosto come una rete di materiali
interconnessi>>. (es: L’ultima tempesta)
Oppure ci sono le immagini-collage, in cui l’assemblaggio non lineare di diverse materie dell’espressione
contribuisce a installare più punti di vista e di ascolti simultanei.
Infine, c’è il morphing, cioè un procedimento visivo in cui due immagini vengono legate da una
trasformazione continua l’una nell’altra. Esso nasce negli anni 80 grazie allo sviluppo della computer
grafica, anche se, si può ritrovare nel cinema pre-digitale. Il morphing può collegare due forme diverse
oppure condensare in pochi secondi un cambiamento di stato della medesimo forma. In tutti i casi, si può
intuire la natura antirealistica di questa figura, che rimanda un’immagine della realtà come materia
instabile, intuisce i rapporti di continuità spesso impossibili e viola la freccia del tempo; anche per questo,
esso è utilizzato molto di rado, e prevalentemente nel cinema fantasy e di fantascienza. Al tempo stesso, è
al di fuori di questi generi, in cui funziona perlopiù come effetto speciale di transizione tra forme, che il
morphing manifesta più esplicitamente la propria natura di strategia di montaggio interno e, in particolare,
di connessione temporale. In questo modo, il morphing contribuisce a creare un vero e proprio rapporto di
continuità e di interdipendenza tra situazioni lontane nel tempo, fino ad annullare, a fini simbolici, l’idea
stessa di una reale distanza temporale.
Il lavoro del montatore
Il montaggio è il cuore della fase di post-produzione, momento in cui il film assuma la sua forma definitiva.
Dal punto di vista tecnico si possono distinguere 3 tipologie principali:
- montaggio in pellicola, che consente un montaggio non lineare
- montaggio elettronico, che consente un montaggio lineare
- montaggio digitale, che consente un montaggio non lineare, poiché si lavora sulle immagini e sui
suoni acquisiti e archiviati da un software
Nei primi anni di diffusione del cinematografo, i film sono composti di “quadri” autonomi e l’unica forma di
montaggio consiste nel loro assemblaggio, oppure si tratta di “trucchi” realizzati direttamente in fase di
ripresa. Bisogna dunque aspettare la fine degli anni 10 perché il montaggio cominci a rivelarsi una potente
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
risorsa narrativa. Il rapido sviluppo del montaggio in questi anni conduce all’invenzione delle giuntatrici
(splicer), piccoli strumenti che permettono di tagliare con precisione la pellicola nel punto desiderato e di
allineare e sovrapporre perfettamente i fotogrammi da unire. Questo processo comporta però la perdita di
almeno un fotogramma per ogni giunta. Questo problema sarà risolto solo negli anni 50, grazie alla “pressa
Catozzo”, che rappresenta la prima giuntatrice a nastro, sui quali si applica del nastro adesivo praticando
allo stesso tempo i fori necessari al trascinamento della pellicola. Oggi, per chi ancora lavora con la
pellicola, esistono presse termiche e a ultrasuoni.
All’inizio degli anni 20 il lavoro del montatore si arricchisce grazie alla moviola, che consente una rapida
visione del girato. Questo tavolo di lavoro è composto da un proiettore dotato di un sistema di
trascinamento continuo che permette di far scorrere la pellicola avanti e indietro, a diverse velocità, e di
fermarla nei punti in cui si devono segnare i tagli. Le immagini sono proiettate su un piccolo schermo,
accompagnate dalla riproduzione della pista sonora per mezzo di un lettore magnetico-ottico.
Nel montaggio in pellicola si utilizza la “copia lavoro”, una stampa positiva dal negativo originale. Il
montatore inizia ad assemblare il girato a partire dalla sceneggiatura, dagli appunti di produzione dalle
eventuali note di regia. Si procede quindi a un montaggio preliminare (premontaggio) che viene via via
affinato attraverso ulteriori tagli, raccordi e transizioni, fino a una fase conclusiva detta picture lock, dopo la
quale si sincronizza la traccia audio lavorata in parallelo. Una volta finito il montaggio si procede a
trasferirlo sul negativo. La corrispondenza di tagli e giunte è garantita dalla presenza del keycode, una serie
numerica impressa sui rulli di pellicola ogni 32 fotogrammi e ristampata in tutte le copie positive.
Tra gli anni 50 e 60 fa la sua comparsa la tecnologia video, nella quale la lavorazione avviene su nastro
magnetico. Il montaggio video presenta alcune complicazioni tecniche rispetto al lavoro su pellicola: non
essendo possibile operare tagli e unioni “fisiche”, l’assemblaggio deve seguire fin da subito l’ordine
definitivo delle inquadrature. Inoltre, il montaggio avviene per riversamento dal nastro del girato a quello
del montato, cosi che a ogni copia corrisponde inevitabilmente una perdita di qualità dell’immagine e del
sonoro. Lo strumento essenziale per il montaggio elettronico è la centralina, cui si affiancano generalmente
due videoregistratori (un player e un recorder). La centralina è l’apparecchiatura che permette di leggere il
timecode che la telecamera imprime sul nastro magnetico in fase di ripresa. Una volta scelta l’inquadratura,
identificata da un timing di inizio e di fine, il player legge il materiale che si riversa nel recorder, dando
forma al montaggio definitivo.
Con la rivoluzione digitale degli anni 90 anche il montaggio, come la ripresa e la memorizzazione dei dati
audiovisivi, da analogico si fa “virtuale”: le operazioni di montaggio intervengono su immagini e suoni
acquisiti digitalmente. I molti vantaggi apportati da questa “conversione” hanno condotto alla quasi totale
scomparsa del montaggio in pellicola, più lento, e di quello elettronico, segnato da molti limiti. Accanto alla
smaterializzazione, l’altro aspetto principale che ha contribuito a determinare il successo del montaggio
digitale è rappresentato dalla “leggerezza” della strumentazione, che consiste in un computer dotato di un
programma di montaggio e in alcune periferiche di input/output. Avid, il primo software per il montaggio
digitale, accanto a Premiere, della Adobe, e a Final Cut, della Apple, sono accomunati da un’interfaccia
basata su una timeline, dove appaiono in sequenza tutti gli elementi visivi e sonori. Grazie a marcatori
grafici e a strumenti iconizzati, tutte le operazioni di montaggio diventano facili e sempre reversibili. Nel
montaggio digitale, inoltre, è possibile trattare in modo indipendente le diverse componenti
dell’audiovisivo e visualizzare immediatamente l’efficacia delle soluzioni.
La colonna sonora
Una nuova “cultura del suono” è testimoniata dalla figura del sound designer, che ha il ruolo di disegnare
un ambiente sonoro per lo spettatore e anche di concepire e realizzare uno specifico effetto attorno al
quale ruota tutta l’opera. Un secondo momento di sviluppo, a partire dagli anni 90, avviene grazie alla
rivoluzione digitale, che ha impresso ai processi di registrazione, montaggio e riproduzione una svolta
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
radicale: in particolare, il passaggio della colonna sonora analogica a quella digitale, con la diffusione del
digital surround sound 5.1, a cinque canali, e lo sviluppo dei software di creazione, missaggio ed edizione,
che hanno profondamente modificato la possibilità di produrre e manipolare il suono, fino a farne un
elemento cardine dell’estetica del film contemporaneo. Ma la vera competizione si gioca sul piano della
qualità del surround sound, che può arrivare a gestire fino a 128 canali, propagando il suono attraverso un
massimo di 64 altoparlanti amplificati, alcuni dei quali montati sul soffitto della sala. È proprio l’emissione
verticale a costituire la principale novità di questo sistema, poiché consente di creare un’esperienza più
complessa e realistica. Ma la profondità e la verosimiglianza dipendono anche dal fattore della regolazione
della diffusione da parte di un algoritmo, che gestisce degli “oggetti sonori”.; così, anche il più piccolo suono
viene posizionato nello spazio secondo il disegno stabilito in fase di postproduzione.
Un problema che costituisce la colonna sonora è che non si presenta come un oggetto discontinuo; senza
contare che l’immediatezza percettiva del suono, il suo irriducibile realismo e la sua abituale articolazione
sincronica con il piano visivo tendono a farne un elemento per certi versi “naturale”, da considerare nel suo
impatto sensibile, in quanto udita. Ma il maggior ostacolo allo studio della colonna sonora è rappresentato
dal cinema stesso, che fin dagli anni 30, ha impiegato il suono in termini causali, cioè come “effetto suono”
associato alla realtà rappresentata, rendendolo di fatto “invisibile”. Ha quindi senso contestare l’ipotesi di
un’equivalenza linguistica tra colonna visiva e sonora, e, quindi, una reale autonomia di quest’ultima.
La principale interpretazione che il cinema ha offerto della colonna sonora va in direzione di un
potenziamento del realismo della rappresentazione. La possibilità tecnica di registrare e riprodurre il suono
profilmico si è declinata in un’estetica del sincronismo, codificata e grammaticalizzata nel quadro del
cinema hollywoodiano classico e poi diffusasi rapidamente a livello internazionale.
Il sincronismo
Non diversamente da qualsiasi “effetto di realtà”, il realismo sonoro è una convenzione culturale, quindi,
l’idea di sincronismo sonoro si regge su una duplice logica referenziale: la colonna sonora si sincronizza, da
un lato, alla rappresentazione visiva e, dall’altro, a una certa “immagine sonora” (soundscape) prototipico e
immediatamente identificabile. Sottolineatura che appare tanto più necessaria se si pensa che la colonna
sonora di un film è una mescolanza di presa diretta, doppiaggio, produzione di effetti sonori originali e post-
produzione. Soprattutto nel caso delle grandi produzioni, la presa diretta svolge oggi un ruolo importante,
con la colonna sonora realizzata in studio: se ne occupano il sound designer, responsabile della creazione,
registrazione e campionatura dei suoni, e il sound editor, incaricato di montare i suoni tra di loro e in
rapporto alle immagini. Quanto alla musica, essa rappresenta un comparto creativo e tecnico autonomo,
che contempla numerose figure.
Il sincronismo, quindi, rappresenta un’opzione estetica fondata, da un lato, su un principio di
corrispondenza e di continuità tra elementi visivi ed elementi sonori: la colonna sonora si sincronizza
armoniosamente al contenuto delle inquadrature, ai meccanismi dell’azione, alla psicologia dei personaggi
e alla logica del racconto, contribuendo a rafforzare la progettazione e la rappresentazione di un universo
coerente, omogeneo e “a misura d’uomo”. Dall’altro lato, il sincronismo rappresenta la traduzione di una
sensibilità che rimanda ai processi e ai continui dell’esperienza reale: percezione uniforme e ininterrotta di
immagini e suoni, sincronizzazione fenomenica di occhio, orecchio e cervello, elaborazione di quadri di
sonorità prototipici. Il sincronismo cinematografico è una convezione culturale elaborata anche a partire da
una certa immagine del mondo e da una determinata interpretazione dei processi cognitivi e percettivi
dell’esperienza umana. Il sincronismo ha quindi dato vita a modelli di intreccio e continuità tra immagini e
suoni anche molto diversi tra loro: a distinguerli è proprio il tentativo di riprodurre differenti quadri di
sonorità, avvertiti come più o meno corrispondenti a un sentire umano e incarnato. Ma la questione della
“sonorità del mondo” entra in gioco anche nel caso di un’estetica orientata all’asincronismo e al
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
contrappunto: l’operazione “divisiva” che la sorregge, infatti, mira a veicolare un’esperienza dialettica tra
sguardo e ascolto avvertita come più vicina a quella che caratterizza la nostra vita.
Si possono declinare due principali declinazioni del sincronismo sonoro:
- Un approccio costruttivista, che mira a disciplinare la natura magmatica del suono operando su di
esso un découpage concettualmente analogo a quello del visivo. Codificato nel quadro del cinema
classico americano, è ancora oggi quello dominante: la solidarietà mimetica tra colonna visiva e
colonna sonora su cui si fonda fa di quest’ultima un attributo dell’immagine finalizzato a rafforzare
la coerenza dell’universo diegetico progettato dal découpage narrativo, con un’evidente
subordinazione delle possibilità espressive e dell’autonomia significante dell’elemento acustico
all’illusione referenziale.
- Un approccio fenomenico che mira, al contrario, a restituire l’impasto sonoro della realtà profilmica
in tutta la sua complessa corporeità, fino a generare un’autonomizzazione della dimensione
acustica.
La voce
Nel contesto del film narrativo, la colonna sonora risulta raccordata in termini causali al campo visivo, ma
anche in rapporto alle dinamiche della rappresentazione che la componente sonora articola all’interno
dell’inquadratura, dando origine a un modello definito telefonico, che si basa su un’immediata intelligibilità,
alle spese della materialità specifica dell’ambiente sonoro. Quest’idea suggerisce inoltre che questa
intelligibilità si definisce a partire dalla voce, che diviene centrale nella colonna sonora esattamente come
lo è la figura umana nell’inquadratura. La colonna sonora, quindi, è come un “dare ad ascoltare”
gerarchizzato attorno alla voce e subordinato a un “dare a vedere”. Dal punto di vista percettivo, di
conseguenza, il sono emerge come elemento “naturale”.
Per quanto riguarda il cinema classico, esso rappresenta, ancora oggi, un modello di riferimento anche per
quanto riguarda l’attribuzione di ruoli e funzioni ai singoli elementi che compongono la colonna sonora.
Sincronismo, trasparenza e realismo si traducono in un “far rumore” del mondo diegetico sempre causale,
nella valorizzazione della musica quale fonte di stimolazioni emotive, di accentuazioni ritmico-melodiche e
di orientamenti atmosferici, indirizzati a caratterizzare il ritmo di una scena o di un intero film, a
punteggiare i dialoghi o i confini tra i personaggi, a esprimere l’interiorità di questi ultimi; infine, nella
centralizzazione della voce, attraverso le parole e il dialogo, fino a farne il motore del racconto.
Effetti
Fra gli effetti più comuni di ammorbidimento e discontinuità del cinema classico possiamo ritrovare i
raccordi sonori, cioè “ponti”, come il sound bridge, impiegato abilmente nei dialoghi, che evitano di
marcare la misura della frase, oppure strategie di anticipazione e di accavallamento, come il J-cut e L-cut.
Questi esempi, insieme anche all’overlapping dialogue, ossia il sovrapporsi delle battute di un dialogo caro
alla screwball comedy, contribuiscono alla valorizzazione del loro potere “legante”. Con riferimento al piano
visivo, infatti, una strategia come il sound bridge rappresenta un classico escamotage per fluidificare il
campo-controcampo: la voce è utilizzata per ammorbidire la discontinuità tra le immagini, ancorandosi al
punto di emissione e al punto di ascolto secondo un ritmo diverso da quello del dialogo. Ma si pensi anche
al potere “collante” della musica extradiegetica: oltre a queste funzioni, svolge anche un ruolo di vero e
proprio contenitore atmosferico e percettivo, tanto che non è affatto inusuale, nel cinema classico, trovarla
spalmata per tutta o quasi la durata del racconto.
Si può osservare come fin dagli anni 30 il cinema classico abbia saputo piegare, in direzione di un
rafforzamento della continuità narrativa, la natura immateriale del suono, la sua spazialità “ambientale” e
la permanenza della sua identità anche in assenza di un legame diretto con una fonte di propagazione.
Da un lato, la qualità additiva del suono, col suo impasto multifocale di voci e rumori, finisce per creare un
ambiente acustico frastornante, scarsamente gerarchizzato e aperto, in cui il campo può restare del tutto
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
inesplorato; dall’altro lato, con particolare riferimento alle parole, la natura “polilogo” della scena libera
colonna sonora e colonna visiva da un rapporto di coappartenenza lineare, sottraendo centralità e
leggibilità al dialogo.
Modelli di sincronismo
Per opposizione al modello incarnato dal cinema classico, un simile approccio fenomenico può essere
definito simulazionista: esso assume che il suono e lo spazio siano omogenei, senza gerarchie di
importanza, collocando l’uditore all’interno dello spazio profilmico, e non davanti come nel modello
“telefonico”. Questo modello, per opposizione a quello telefonico, viene rimandato al fonografo.
Questi modelli di sincronismo interpretano ed elaborano in modo assai diverso la natura tridimensionale e
immateriale del suono, che gli consente di sottrarsi a un processo di immediata spazializzazione. Il cinema
classico reagisce riportando il suono al visivo; il cinema della New Hollywood esalta invece il potenziale di
fuga, con la conseguenza supplementare di additare la profonda diversità tra queste due materie
dell’espressione cinematografica. Qualcosa di simile a un vero e proprio effetto di décadrage, esaltando il
suo realismo, in modo da offrire allo spettatore un’esperienza di ascolto percettivamente più simile a quella
quotidiana.
Negli anni 40 nasce l’idea di “montaggio verticale”, che si basa sul dialogo, tra una linea e l’altra (quella
visiva e quella sonora), ma anche nell’incontro tra due diverse operazioni di combinazione, l’una fondata
sulla successione, l’altro sulla sovrapposizione di elementi concomitanti. Il sonoro diventa così un fattore
determinante nell’evoluzione del cinema.
Discontinuità
L’idea di asincronismo viene rideclinata in termini di discontinuità, ed esemplificata attraverso un
“catalogo” piuttosto completo di forme in cui il suono si raccorda al visivo secondo modalità
essenzialmente contrappuntistiche: rumori e voci che penetrano il tessuto narrativo da fonti invisibili; primi
piani sonori su aspetti normalmente ignorati o impercettibili della vita quotidiana; il dialogo interiore,
appartenente a un personaggio ma dissociato dal movimento delle sue labbra; la dissolvenza acustica come
strategia per stabilire similitudini tra le immagini ecc. Senza contare la suggestiva riflessione dedicata al
silenzio.
L’originalità della sincronizzazione godardiana nasce non soltanto dall’articolazione di sorprendenti
dialettiche discontinue tra immagini e suoni, ma anche dalla frequente collocazione di questi ultimi in uno
spazio ambiguo, né completamente dentro né completamento fuori dal racconto, quando in un film, al
contrario, rumori, musiche e parole si lasciano afferrare e comprendere proprio a partire dalla loro
appartenenza allo spazio-tempo della scena, sulla base della loro condizione di “internità” o di “esternità”
rispetto al mondo diegetico, e quindi, in virtù della loro visibilità. Dal punto di vista analitico, l’analisi della
colonna sonora si è precisata in termini di uno studio della “prossemica” tra campo sonoro e campo visivo,
cioè in collaborazione con l’immagine che crea dimensioni reali e immaginarie.
Si può dunque fare (grazie a Michel Chion – 1985) un distinzione tra:
- suoni in, quando la rappresentazione mostra la fonte di emissione (visibilità) contemporaneamente
al suono (caso del sincronismo perfetto: ascoltiamo le parole di un personaggio e lo vediamo
parlare)
- suoni off, la visibilità della fonte non è mostrata
Suoni in e off appartengono al mondo del racconto, e, in relazione ad esso si dicono, intradiegetici
(cioè interni e diegetici).
- Al contrario è la tipologia del suono over, che è di natura extradiegetica: esso emana da una fonte
invisibile situata in un altro tempo e/o in altro spazio rispetto all’azione mostrata dall’immagine.
Esclusivamente come acusmatico, poiché esso non esterno ed estraneo al mondo del racconto.
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
Il campo sonoro possiede una marcata mobilità, come quella interiore: da un lato, appartiene al mondo del
racconto, pur restando esclusivamente acusmatico; dall’altro lato, la sua sonorità è del tutto artificiosa, una
specie di accompagnamento per le orecchie dello spettatore, poiché il monologo interiore è un pensiero
muto. L’effetto finale è quello di una voce che parla con il personaggio e ne commenta l’azione, i pensieri e i
sentimenti più intimi, come se si trattasse di una classica voce over. Ovvero, un suono “di frontiera” che
sembra fermarsi al confine fra off e over. Invece, per quanto riguarda la frontiera tra suoni over e in, essa
viene attraversata tutte le volte che una musica scivola dal mondo del “fuori-tempo e del fuori-luogo” a
quello del qui e ora del racconto (e viceversa), oppure, quando la voce di un narratore esterno si cala in un
personaggio. Anche i rumori possono attraversare questa frontiera.
Auricolarizzazione
La questione della posizione dei suoni deve essere affrontata anche in termini di qualità enunciativa: in
questo caso, si tratta di declinare in rapporto al suono quella domanda narratologica (Chi vede?) da cui ha
avuto origine la riflessione sulla focalizzazione. Una simile ricerca appare del tutto subordinata al visivo,
poiché il campo sonoro non possiede nulla di realmente assimilabile a una prospettiva autonoma.
Il frequente ancoraggio di un suono a un personaggio ha condotto (François Jost) a sviluppare un concetto
per dare conto dei processi di soggettivizzazione percettiva. Si parla dunque di auricolarizzazione,
distinguendo tra:
- una posizione zero: identifica tutti quei casi in cui un suono non appare ancorato a un’istanza
diegetica particolare, e la sua percezione “ambientale” dipende dalla posizione del personaggio
nello spazio e dalla sua distanza dal punto di ascolto collocato idealmente nella macchina da presa.
- una interno primaria: caso in cui un suono rimanda a una percezione soggettiva, marcata, da un
“orecchio interno”, eventualmente riferibile all’istanza narrante, senza ancorarsi a un personaggio.
- una interno secondaria: un suono appare raccordato alla soggettività di qualcuno che dà segno di
udirlo. È in genere sottolineata da segni di ascolto che identificano un personaggio come filtro
percettivo: informazioni provenienti dal mondo del racconto che legano direttamente un suono a
un orecchio interno. A questo regime appartiene anche l’ascolto dall’interno, dove i suoni sono “di
qualcuno” perché risultano filtrati dalla soggettività di un personaggio.
Rumori
I rumori, all’interno di un film, funzionano perlopiù come sfondo e dipendono intimamente dal piano visivo,
essendo, più una caratteristica che un elemento indipendente. Non mancano, comunque, esempi di utilizzo
“marcato” o espressivo del rumore, imponendosi così come elemento simbolico.
Per quanto riguarda l’uso del rumore, si possono distinguere 3 aspetti:
- uso eccentrico del rumore naturale e, in particolare, quello di oggetti e congegni meccanici o
elettrici. (es: Lynch, Twin Peaks)
- creazione di partiture “rumorose” per significare l’invisibile o per caratterizzare in modo inatteso
situazioni, eventi e gesti. (es: Lynch, Twin Peaks)
- presenza di “rumori di accompagnamento”, generalmente bassi, profondi e “neri”, tra la vibrazione
e il rombo, che si sostituiscono al sonoro ambiente creando soundscape martellanti, avvolgenti e
minacciosi, che ritmano intere scene o ampie porzioni di film. Delle specie di sinfonie industriali che
connotano lo spazio, caratterizzano l’azione e, insieme, danno forma all’interiorità dei personaggi,
diffondendo una musicalità atonale “rumorosa” e imponendo un’esperienza di ascolto del tutto
sganciata dalle consuetudini dello spettatore. (es: Lynch, Twin Peaks)
La musica
Anche durante l’epoca del muto, la musica, come i rumori, sono presenti anche in quanto elemento
diegetico. Fin da subito, dunque, l’impiego della musica da parte del cinema sembra svilupparsi in due
direzioni:
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
- Un suo protagonismo narrativo, esemplificato dalle “metafore” musicali del cinema impressionista
e da un genere come il musical, ma anche da tutti quei film in cui una canzone o un brano musicale
si caricano, all’interno del mondo diegetico, di un particolare ruolo semantico. Occorre notare che
la “trama musicale” di un’opera cinematografica può variare sensibilmente: se il classicismo
hollywoodiano ha imposto a livello internazionale il modello del sinfonismo, ossia della musica
originale che si dispiega come “tappetto musicale” per tutta una buona parte del film, a partire
dagli anni 70, tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, il commento comincia a includere e a
rielaborare musica classica e canzoni preesistenti. Oggi, la colonna sonora di un film è una
compilation score, che mescola musica originale e musica non originale.
- L’utilizzo della musica in funzione di accompagnamento: in questo caso, essa si “sposta” al di fuori
della diegesi, udita più che ascoltata, trasparente e, di norma, di sostegno alle immagini, cui si
sottomette in termini logici e percettivi (fino alla sincronizzazione perfetta cara al cinema di
animazione, detta mickey mousing).
A proposito del rapporto tra film e canzoni, a partire dagli anni 80, l’intreccio sempre più sinergico tra
industrie dell’intrattenimento ha contribuito a fare della colonna sonora un fondamentale territorio di
dialogo e scambio.
Per quanto riguarda i rapporti tra campo visivo e campo sonoro musicale, si può precisare che l’autonomia
linguistica della musica le consente una maggiore libertà di movimento e un più fluido attraversamento
delle frontiere tra visibile e invisibile, prima tra tutte quella tra over e in. Al tempo stesso, la musica
diegetica, proveniente da una fonte interna al mondo del racconto, è stata largamente impiegata, anche
come vero e proprio motore narrativo, fino ad assumere, in alcuni casi, un rilievo pari a quello di un
“personaggio”.
L’analisi dei rapporti tra visivo e sonoro pone un’ultima questione, quella delle modalità di apparizione della
musica. A partire da una rilettura dei concetti di parallelismo e di contrappunto, possiamo osservare come
l’ingresso e lo sviluppo del “racconto” musicale in rapporto al visivo si distendano idealmente tra due poli
opposti, tra i quali si contano numerose configurazioni intermedie: da una parte, un insinuarsi e un
diffondersi discreti, che mirano di fatto a cancellare la presenza della musica quale elemento autonomo per
trasformala in un sostegno alle immagini (logica dello sneaking e della trasparenza codificata dal classicismo
hollywoodiano); dall’altra parte, un’affermazione più o meno brutale, che contribuisce a rendere la musica
un elemento “visivamente” presente in quanto tale. Questioni, quindi, di montaggio e di “attacco”.
Il terzo ed ultimo aspetto da considerare è quello delle funzioni della musica. Nel quadro del cinema
narrativo la principale funzione della musica è quella di caratterizzare in senso emotivo il film e di attivare
contestualmente le emozioni dello spettatore, sincronizzando l’audience agli stati psicologici al centro della
narrazione. Si parla in tal proposito (Chion) di:
- funzione empatica della musica: la musica partecipa in modo chiaro e diretto al sentimentalismo
evocato dalle immagini, e tra visivo e sonoro si instaura una vera e propria consonanza che
concorre a dare corpo alle emozioni e a veicolare senza ambiguità allo spettatore. La musica
empatica sincronizzata al racconto mira a precisare e a potenziare il contenuto drammatico del
film, amplificando gesti, pensieri, azioni che nascono dalle storie, dai personaggi e dalle situazioni
rappresentate
- Funzione anempatica. La musica anempatica è indifferente e dissonante, introduce una condizione
di inconciliabilità, scavando una distanza tra visivo e sonoro. L’idea di anempatia implica una
complicazione dell’allineamento empatico tra musica e immagini, e tra film e spettatore.
La distinzione tra funzione empatica e anempatica ha posto l’accento sulla caratterizzazione emotiva del
racconto, intendendo il termine “emozione” in senso molto ampio, che si rivela spesso essenziale, poiché
consegna alle immagini un “valoro aggiunto” insostituibile; allo stesso modo la musica può anche
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
contribuire a orientare le attese dello spettatore e a conferire al racconto un carattere immediatamente
riconoscibile. Ciò è particolarmente evidente nel cinema di genere.
Un’altra funzione caratteristica dell’impiego della musica nel cinema è la costruzione del leitmotiv: un
“motivo conduttore” che, associato a un personaggio o a una situazione, ma anche a un ricordo, a un
oggetto o a un luogo, punteggia il film, non di rado ripresentandosi in varianti ritmiche o melodiche che
marcano qualche tipo di cambiamento.
Un’ultima funzione della musica filmica è definita (Claudia Gorbaman) narrative cueing (“indicazione
narrativa”). La musica serve in questo caso a marcare una tappa del racconto, a enfatizzare un’azione, a
sottolineare un momento, ad attirare l’attenzione dello spettatore su un aspetto particolare. Questa
funzione può avere sia un carattere denotativo, quando la musica contribuisce a evidenziare un elemento
narrativo, sia un carattere connotativo, quando si rapporta alle diegesi in forma di commento o
interpretazione.
Al di fuori del paradigma classico, il potere commentativo dell’elemento musicale può anche affiancarsi con
modalità enunciative ben più esplicite e spesso concettuali. Si parla dunque di contrappunto didattico, cioè
l’indifferenza della musica alla situazione che accompagna corrisponde piuttosto alla volontà di esprimere
un concetto. La musica può anche contribuire a definire l’identità e lo stile di un film: anche quando
concepita e utilizzata come background, essa rappresenta un elemento decisivo, che contrassegna
l’elaborazione emotiva e memoriale del film da parte dello spettatore.
La voce
L’avvento del sonoro sincrono ristabilisce un legame percettivo spezzato, riconsegnando al cinema la
possibilità di ascoltare le parole, presentissime nel cinema muto anche attraverso l’uso delle didascalie, che
si rendono necessarie per chiarire i dettagli del racconto. Il cinema sonoro non è semplicemente
vococentrico, ma interpreta e utilizza fin da subito la voce come veicolo della parola e del dialogo. Il film
sonoro, inteso come possibile alternativa al film parlato è, di fatto, un’opzione del tutto marginale e
comunque avvertita come centrale, e già dal 1929, all’interno del cinema statunitense, il destino sembra
segnato dallo straordinario successo riscosso dai primi film 100% talkies, una dicitura con cui le major si
affrettano a pubblicizzare il nuovo “genere”. Fin dagli anni 30, è quindi il cinema narrativo americano, anche
grazie a generi parlatissimi come la sophisticated comedy, che contribuisce a decretare la vittoria del film
parlato e il dominio della voce. Più esattamente, esso sancisce una volta per tutte una sincronizzazione
antropomorfa tra corpo e suono, allineando in senso realistico parlante, voce e parola, e definendo quella
voce over del narratore extradiegetico e “senza volto”. Sia da un punto di vista tecnico che teorico, non va
dimenticato che la voce è un attributo mobile e malleabile, e la sua identificazione corporea, frutto di
accoppiamento tra contenuto visivo e un contenuto acustico, è suscettibile di essere problematizzato in
senso estetico, come accade nel cinema moderno e postmoderno. Lo rivelano bene i processi di post-
sincronizzazione e di doppiaggio, che possono sostituire, modificare, riassemblare a piacimento la voce, sia
per ottenere una maggior pulizia rispetto alla registrazione in presa diretta, sia per introdurre degli effetti,
sia, infine, per sostituire la voce originale con una ritenuta più adatta o espressiva. A quest’ultimo
proposito, questo tipo di post-produzione, non va confuso con la pratica del doppiaggio delle versioni
originali: essa è parte integrante delle scelte espressive che presiedono alla realizzazione di un film, a
differenza della seconda, che tradisce l’integrità dell’opera, affermando al tempo stesso un pregiudizio
estetico secondo il quale un film sarebbe fatto solo, o soprattutto, di immagini. Da un lato, dunque, come
tutti gli elementi che compongono una colonna sonora, la voce prende forma staccandosi dal corpo che l’ha
originata, e iscrivendosi tecnicamente come pura materia acustica; dall’altro lato, la mobilità che questa
condizione le consentirebbe appare limitata da un inevitabile ritorno al corpo.
All’interno di un film, possono anche esserci voci “invisibili”, definite o presenze acusmatiche o acousmetre,
ed entrambe sottolineano la presenza di voci senza un referente corporeo. L’idea di acousmetre, si applica
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
lOMoARcPSD|5437225
a quelle voce momentaneamente sprovviste di un corpo, che insistono sulla frontiere tra in e off.
L’acousmetre, mette dunque in scena una separazione e un nascondimento dalle motivazioni e dal
significato assai variabili.
Anche la voce del narratore esterno, nella sua versione “neutra”, funziona come commento onnisciente, in
cui la voce indica il mondo della terza persona, distanziandosene in modo più o meno netto: narratori
extradiegetici che guidano il racconto, dispensando informazioni e dirigendo cambiamenti di spazio e di
tempo, ma anche la sua interpretazione e l’analisi dei sentimenti e dei pensieri dei protagonisti.
L’attitudine a lavorare sulla voce del narratore extradiegetico per decostruire l’impermeabilità della finzione
caratterizza il suo utilizzo all’interno del cinema moderno. Altrettanto complesso e sfaccettato è l’utilizzo
della voce over in prima persona, in cui la focalizzazione tendenzialmente onnisciente del narratore esterno
si chiude sulla prospettiva del personaggio. Questo escamotage serve per dare voce ai pensieri dei
personaggi, sovrapponendosi e intrecciandosi alle loro azioni in forme e per scopi assai mutevoli. Al
contrario, quando la voce si stacca dal soggetto per narrare dall’esterno una storia che lo vede
protagonista, l’intreccio tra piano sonoro e piano visivo assume la forma di una corrispondenza puntuale; il
primo produce il secondo. La produzione contemporanea si riempie di parole allo scopo di banalizzarle e
distruggerle. Ben più riconoscibile è la soluzione del cinema afasico, nel quale l’(auto)distruzione della
parola passa più esplicitamente attraverso la sua negazione. Non sono quindi film muti, ma film che
lavorano esplicitamente sull’assenza di parola. Ma una tendenza afasica sembra caratterizzare, più in
generale, quel cinema realista che lavora sulla “fatica quotidiana” o sulla banalità dell’esistenza, nonché
quella produzione d’autore più direttamente interessante allo studio del comportamento, dello spazio e
della dialettica tra personaggio e ambiente, e che rifiuta apertamente il modello del cinema narrativo di
parola. Il cinema afasico non va dunque confuso con quelle operazioni apertamente cinefile che
recuperano, nel contemporaneo, il paradigma del cinema muto.
Dal grammofono al digitale
Fin dalle origini, le proiezioni sono accompagnate dalla musica riprodotta attraverso un grammofono. Ciò
che manca, dunque, assieme al suono delle parole pronunciate dagli attori all’interno del film, è una
colonna sonora “stabile”. A partire dal 1927, con il film Il cantante di Jazz, si ha un incremento dei film
parlati. Inoltre, il rapido abbandono dei dischi (sound-on-disc) in favore della registrazione della colonna
sonora su pellicola (sound-on-film) obbliga le sale a dotarsi di altoparlanti. Per quanto riguarda la
produzione, in questa prima fase, per l’isolamento acustico, le macchine da presa venivano chiuse dentro
scatole insonorizzate, dotate di un foro per l’obiettivo e poggiate su un cavalletto. Quanto ai microfoni, a
causa della loro scarsa potenza devono essere posizionati molto vicini alla fonte di emissione, con
conseguenti problemi di direzionalità.
Questi e altri problemi vengono risolti con lo sviluppo di tecnologie di ripresa audio e di montaggio.
Nascono quindi nuove figure professionali, come i rumoristi (foley artist) e i doppiatori. I rumoristi oggi
giorno sono quasi completamente stati soppiantati dalla figura del sound designer, che per la produzione di
suoni e rumori digitali, e per la loro rielaborazione, si affida alle tecnologie digitali e a software dedicati.
Tuttavia, nonostante la centralità assunta dalla fase di post-produzione a partire dai secondi anni 90, il
sonoro in presa diretta continua a essere ampiamente utilizzato, soprattutto in opere di stampo
documentaristico o in film che inseguono un certo “effetto di realtà”.
Negli anni 60, la registrazione ottica introdotta dall’avvento del sonoro viene sostituita da quella magnetica,
che assicura una maggiore fedeltà e pulizia, due condizioni necessarie per poter sviluppare un suono
multicanale destinano a una riproduzione stereofonica. A partire dagli anni 90, la rivoluzione digitale ha
ulteriormente modificato i processi di registrazione e di missaggio della pista sonora, nonché quelli di
creazione e scrittura, grazie allo sviluppo di software di composizione musicale.
Scaricato da Hamza Lambarraa (bachirlambarraa@live.it)
Potrebbero piacerti anche
- L'immaginario polimorfico fra letteratura, teatro e cinemaDa EverandL'immaginario polimorfico fra letteratura, teatro e cinemaNessuna valutazione finora
- Manuale di semiotica della traduzione: Osnovy obŝego i mašinnogo perevodaDa EverandManuale di semiotica della traduzione: Osnovy obŝego i mašinnogo perevodaNessuna valutazione finora
- True Detective. Viaggi al termine della notteDa EverandTrue Detective. Viaggi al termine della notteValutazione: 3 su 5 stelle3/5 (1)
- Visto in sala. Storytelling attraverso il cinema.: Lezioni di Storytelling attraverso il cinemaDa EverandVisto in sala. Storytelling attraverso il cinema.: Lezioni di Storytelling attraverso il cinemaNessuna valutazione finora
- Cinema, Pensiero, Vita. Conversazioni con fata morganaDa EverandCinema, Pensiero, Vita. Conversazioni con fata morganaNessuna valutazione finora
- Pasolini sconosciuto. Interviste, scritti, testimonianzeDa EverandPasolini sconosciuto. Interviste, scritti, testimonianzeNessuna valutazione finora
- C'eravamo tanto amati. I capolavori e i protagonisti del cinema italianoDa EverandC'eravamo tanto amati. I capolavori e i protagonisti del cinema italianoNessuna valutazione finora
- Manuale Del Montaggio Diego CassaniDocumento19 pagineManuale Del Montaggio Diego CassaniFilippo Salaris IolaoNessuna valutazione finora
- Futurologia della Vita Quotidiana. Transhumanist Age: libri Asino RossoDa EverandFuturologia della Vita Quotidiana. Transhumanist Age: libri Asino RossoNessuna valutazione finora
- Umano troppo umano, Così parlò Zarathustra, Al di là del bene e del male, Crepuscolo degli idoli, L’Anticristo e Ecce HomoDa EverandUmano troppo umano, Così parlò Zarathustra, Al di là del bene e del male, Crepuscolo degli idoli, L’Anticristo e Ecce HomoNessuna valutazione finora
- Cronofagia: Come il capitalismo depreda il nostro tempoDa EverandCronofagia: Come il capitalismo depreda il nostro tempoNessuna valutazione finora
- Immagini della Modernità: Il cinema europeo nell'epoca della secolarizzazione (1943-1975)Da EverandImmagini della Modernità: Il cinema europeo nell'epoca della secolarizzazione (1943-1975)Nessuna valutazione finora
- Manuale Audio per il Podcast: Impara le Basi dell’Audio Digitale e Migliora il Suono dei tuoi Podcast. Microfoni, Cuffie, Registrazione, Editing, Mix, Sound Design e tanto altro: Stefano Tumiati, #3Da EverandManuale Audio per il Podcast: Impara le Basi dell’Audio Digitale e Migliora il Suono dei tuoi Podcast. Microfoni, Cuffie, Registrazione, Editing, Mix, Sound Design e tanto altro: Stefano Tumiati, #3Nessuna valutazione finora
- La tomba e altri racconti dell'incuboDa EverandLa tomba e altri racconti dell'incuboValutazione: 3.5 su 5 stelle3.5/5 (215)
- Di un tono apocalittico adottato di recente in filosofiaDa EverandDi un tono apocalittico adottato di recente in filosofiaNessuna valutazione finora
- LINGUAGGIO E TECNICHE ESPRESSIVE Del Cinema 2015 PDFDocumento186 pagineLINGUAGGIO E TECNICHE ESPRESSIVE Del Cinema 2015 PDFAlbiHellsing100% (1)
- Nel cuore oscuro del sogno hippie: Spie, assassini e rockstar nella Hollywood degli anni '60Da EverandNel cuore oscuro del sogno hippie: Spie, assassini e rockstar nella Hollywood degli anni '60Nessuna valutazione finora
- Bertetto - Teoria e Analisi Del FilmDocumento8 pagineBertetto - Teoria e Analisi Del FilmGianfranco Tinelli100% (1)
- Benvenuti all'inferno! Storia delle origini del Black MetalDa EverandBenvenuti all'inferno! Storia delle origini del Black MetalNessuna valutazione finora
- I dolori del giovane WertherDa EverandI dolori del giovane WertherValutazione: 3.5 su 5 stelle3.5/5 (1620)
- Riassunto Del Manuale Del Film Linguaggio, Racconto, Analisi RondolinoDocumento14 pagineRiassunto Del Manuale Del Film Linguaggio, Racconto, Analisi Rondolinobellux100% (1)
- Scrivere narrativa 2 - Il punto di vista: Scrivere narrativa 2Da EverandScrivere narrativa 2 - Il punto di vista: Scrivere narrativa 2Nessuna valutazione finora
- Antichità - La civiltà romana - Musica: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 18Da EverandAntichità - La civiltà romana - Musica: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 18Nessuna valutazione finora
- Incipit - Un gioco dinamico di narrativa estemporanea e letteratura arbitrariaDa EverandIncipit - Un gioco dinamico di narrativa estemporanea e letteratura arbitrariaNessuna valutazione finora
- Com'è facile diventare un eroe. Prontuario di scrittura del personaggioDa EverandCom'è facile diventare un eroe. Prontuario di scrittura del personaggioNessuna valutazione finora
- La Musica Nel Cinema. Da Presenza Sonora PDFDocumento17 pagineLa Musica Nel Cinema. Da Presenza Sonora PDFFabio Luigi RuggieroNessuna valutazione finora
- Taxi Driver - Analisi Del FilmDocumento50 pagineTaxi Driver - Analisi Del FilmMartina Menegon50% (2)
- Il richiamo della foresta, Zanna bianca e altre storie di caniDa EverandIl richiamo della foresta, Zanna bianca e altre storie di caniValutazione: 1 su 5 stelle1/5 (1)
- Beverini Paolo - Il Videoclip. Strategie e Figure Di Una Forma Breve-Meltemi (2004)Documento182 pagineBeverini Paolo - Il Videoclip. Strategie e Figure Di Una Forma Breve-Meltemi (2004)senhalNessuna valutazione finora
- Dario Tomasi - Lezioni Di RegiaDocumento45 pagineDario Tomasi - Lezioni Di RegiaAnnamaria ImprotaNessuna valutazione finora
- Arte Postale Mail ArtDocumento75 pagineArte Postale Mail ArtVittorio BaccelliNessuna valutazione finora
- Aria FeR PDFDocumento13 pagineAria FeR PDFFrancesco SpinaNessuna valutazione finora
- Surrealismo - Pop Art - Arte InformaleDocumento4 pagineSurrealismo - Pop Art - Arte InformaleAlice RotundoNessuna valutazione finora
- Catalogo Generale Espressioni Ragno 2009Documento372 pagineCatalogo Generale Espressioni Ragno 2009Marazzi Group100% (1)
- Claudio Monteverdi e La Musicalita Del DDocumento16 pagineClaudio Monteverdi e La Musicalita Del DMónica Canales Marquez100% (1)
- Caillois - L'Uomo e Il Sacro (Parziale)Documento6 pagineCaillois - L'Uomo e Il Sacro (Parziale)Mauro OrtisNessuna valutazione finora
- Planos E1027Documento8 paginePlanos E1027alba_1Nessuna valutazione finora
- Futurismo - WikipediaDocumento20 pagineFuturismo - WikipediafabromNessuna valutazione finora
- Lettura Di Un'Opera D'arteDocumento9 pagineLettura Di Un'Opera D'arteDestinyNessuna valutazione finora
- Lombardo Catálogo Architectural 2019Documento449 pagineLombardo Catálogo Architectural 2019VEMATELNessuna valutazione finora
- E Stato Il Figlio. L Influenza Di Monice PDFDocumento6 pagineE Stato Il Figlio. L Influenza Di Monice PDFgiovanna balconiNessuna valutazione finora
- Storia Dell'arteDocumento26 pagineStoria Dell'artekaramrhamNessuna valutazione finora
- Documento PDF 2Documento7 pagineDocumento PDF 2Salvatore SalemmeNessuna valutazione finora
- 1987, Domus (Periodico) 688Documento1 pagina1987, Domus (Periodico) 688Max PigaNessuna valutazione finora
- Mercantia 2011 - Certaldo - Programma Di Sabato 16 LuglioDocumento15 pagineMercantia 2011 - Certaldo - Programma Di Sabato 16 LuglioThe tourist guide to TuscanyNessuna valutazione finora
- Mimmo Jodice Una Storia Di LontananzaDocumento28 pagineMimmo Jodice Una Storia Di LontananzaAlessandro SpanuNessuna valutazione finora
- PDF Catalogo 2011Documento95 paginePDF Catalogo 2011Diego Alex LucettiNessuna valutazione finora
- Caartamodelli 2Documento11 pagineCaartamodelli 2ljl100% (1)
- IlluminoDocumento12 pagineIlluminoRaffaele GalazzoNessuna valutazione finora
- Guida ModenaDocumento22 pagineGuida ModenadantespoNessuna valutazione finora
- Programmma Di Sala PDFDocumento60 pagineProgrammma Di Sala PDFMarcoNessuna valutazione finora
- Guida Rapida 09Documento26 pagineGuida Rapida 09jesus salazarNessuna valutazione finora
- Ignazio Gardella, Torre Di Piazza DuomoDocumento8 pagineIgnazio Gardella, Torre Di Piazza DuomoLuca LuiniNessuna valutazione finora