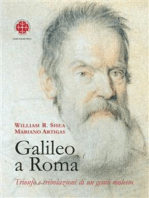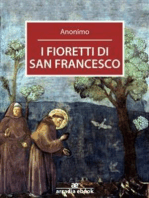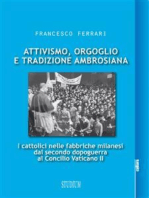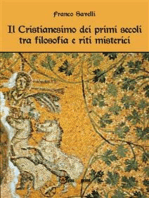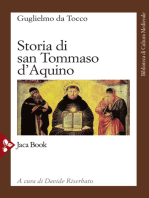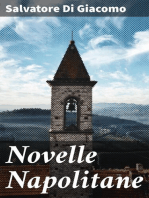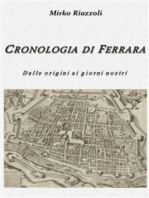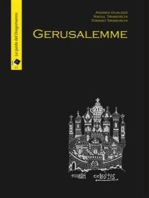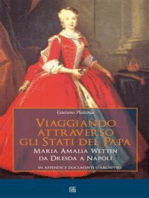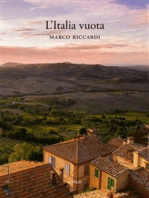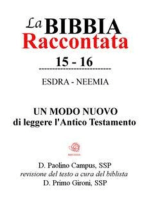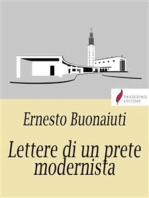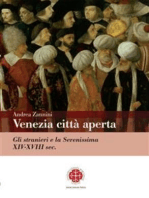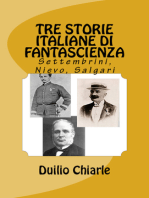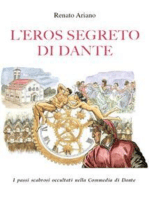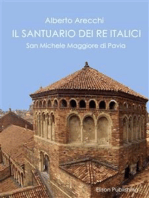Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Chastel, Il Sacco Di Roma, 1527 PDF
Caricato da
Claudio CastellettiTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Chastel, Il Sacco Di Roma, 1527 PDF
Caricato da
Claudio CastellettiCopyright:
Formati disponibili
Il sacco di Roma.
1527
di André Chastel
Storia dell’arte Einaudi 1
Edizione di riferimento:
André Chastel, Il sacco di Roma. 1527, trad. it. di
Marisa Zini, Einaudi, Torino 1983
Titolo originale:
The Sack of Rome, 1527
Princeton University Press
© 1983 Trustees of the National Gallery of Art,
Washington (D.C.)
Storia dell’arte Einaudi 2
Indice
Presentazione 5
I. «Misera caput mundi» 34
La marcia su Roma 37
Le difese di Roma 41
Il sacco 44
II Pageant del 4 agosto 49
Imago Urbis 55
II. Roma-Babilonia 72
La Sala di Costantino 73
Il papa-Anticristo 84
L’Anticristo e i pronostici 91
III. «Urbis direptio» 110
Opere d’arte 118
Reliquie 123
Il prestigio dei soldati mercenari 134
IV. Polemiche: italiani e barbari 146
L’esoterismo ghibellino 147
La fine dell’Italia 150
La disperazione dei letterati 157
L’intervento di Erasmo 163
Adriano VI 172
Archeologia e paganizzazione 176
Storia dell’arte Einaudi 3
Indice
V. Lo stile clementino 192
Il cambio della guardia 199
L’incisione 204
Il Cristo morto del Rosso 208
La Madonna del Parmigianino 210
Le sciagure 213
Il rifugio veneziano 221
VI. Riparazione pontificia, trionfo imperiale 230
La barba del Pontefice 236
Medaglie e monete 242
Il ciclo di san Michele 244
Il Giudizio universale 253
L’imperatore a Roma 263
Epilogo 285
Bibliografia 310
Storia dell’arte Einaudi 4
Presentazione
Tiziano, al suo arrivo a Roma sul finire del 1545, fu
abbagliato dalla città e ne fece parte all’Aretino. In
risposta ne ricevette una celebre lettera, ironica e insie-
me amichevole, dove si legge: «Voi oggi rimpiangete che
la voglia di andare a Roma or che vi dolga il gricciolo,
venutosi adesso di trasferirvi a Roma, non vi venne
venti anni fa, molto ben ve lo credo. Ma, se ve ne stu-
pite nel modo che la trovate adesso, che areste voi fatto
vedendola ne la maniera che la lasciai io?»1.
Se questa città, che affascina il Cadorino sotto Paolo
III, l’avesse conosciuta sotto Clemente VII! L’Aretino
aveva lasciato Roma nel 1525; gli ultimi mesi del suo
soggiorno erano stati abbastanza agitati, con la vicenda
dei Sonetti lussuriosi2, il conflitto con il datario Giberti,
la rissa che, per poco, gli era costata la vita. L’Aretino
serbava tuttavia della Roma «clementina», scomparsa
nella primavera del 1527, un ricordo indimenticabile e
profondo. Stabilitosi per sempre a Venezia, soddisfatto
e attivo per quanto fosse possibile, il «flagello dei prin-
cipi» sapeva che già era caduta nell’oblio la Roma mera-
vigliosa della sua giovinezza.
La catastrofe del 1527 aveva colpito una città dove
gli artisti fiorivano, dove le opere d’arte pullulavano.
Poco tempo dopo quella data fatidica, Vasari ebbe occa-
sione di menzionare spesso nelle sue biografie le conse-
guenze del sacco sulla carriera degli artisti. Prima di
Storia dell’arte Einaudi 5
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
tutto ci colpisce il modo con cui presenta le cose, per
esempio nella vita di Perino del Vaga: «l’anno 1527
venne la rovina di Roma, fu messa quella città a sacco,
e spento molti artefici, e distrutto e portato via molte
opere»3. Le indicazioni dello storico basterebbero a
ricordare che gli avvenimenti politici e militari del mag-
gio 1527 determinarono una dispersione, che è stata
giustamente definita una «diaspora», dei piú grandi arti-
sti del momento. Bisognerà insistervi, perché il feno-
meno è stato esaminato seriamente soltanto di recente4.
La sua importanza dipende dal fatto che a Roma, intor-
no al 1525, si erano verificati numerosi sviluppi nuovi:
per limitarsi alla pittura, era incominciato ad emergere
uno stile originale, tutto abilità, grazia e raffinatezza, di
cui l’Aretino, come molti altri, aveva serbato il ricordo.
Occorre forse esaminare con maggiore attenzione quel-
lo che è andato perso a causa dell’evento storico.
Su un piano piú generale, Jacob Burckhardt si è reso
conto, con la sua solita lucidità, della forza di rottura
dell’avvenimento. Ne coglie le conseguenze a lungo ter-
mine: «Un fatto considerevole, – egli scrisse piú di un
secolo fa, – verrà fuori dalla devastazione di Roma, e
cioè un rinnovamento spirituale e temporale»5. Lo choc
del 1527 aveva sconvolto una tale quantità di cose che
si poteva sperare di ricostruire soltanto con prospettive
nuove. Rendendo necessario il Concilio (proclamato fin
dal 1536, riunito a Trento dopo il 1545) e il movimen-
to di Riforma cattolica, il sacco aveva dato luogo al pro-
cesso mediante il quale, in definitiva, la Chiesa e l’Ita-
lia passarono dall’alto Rinascimento al barocco. Questo
punto di vista non è sbagliato, anche se omette troppi
fattori; ma non è esattamente il nostro. Esso salta una
tappa: quella delle circostanze e dell’eco immediata della
caduta di Roma, da cui abbiamo molto da imparare. Il
problema infatti non è quello del barocco, ma del manie-
rismo, come ha bene compreso fin dal 1945 Giuliano
Storia dell’arte Einaudi 6
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Briganti6. La cultura romana aveva assunto intorno al
1525 un tono nuovo; il sacco provocò il disseminarsi di
uno stile che «smette di essere l’appannaggio esclusivo
delle città di Firenze, Siena o Roma». Si tratta niente
meno che di artisti quali Parmigianino, Rosso, Polido-
ro, Peruzzi, Perino del Vaga. I mutamenti precipitosi
provocati dagli avvenimenti del maggio 1527 portarono
all’«europeizzazione» del manierismo7, che era già in via
di sviluppo. La catastrofe non fece che accelerarla. Già
l’abate Lanzi aveva notato qualcosa del genere8.
Il clima intellettuale della Roma del 1525 doveva il
suo splendore a una convergenza eccezionale di talenti,
a un entusiasmo reso piú intenso dall’incontro delle per-
sone e delle ambizioni, al fervore di una cultura adesso
sicura di se stessa, a una inconsueta libertà di costumi e
di parola – basta rileggere i capitoli relativi di Cellini9.
Ma proprio questo disgustava certamente tanti osserva-
tori, visitatori e residenti stranieri, chierici o laici. Cle-
mente VII fu forse un pontefice di grande dignità, ma
proprio sotto il suo regno le critiche contro la corruzio-
ne romana giunsero a un livello insostenibile. Risaliva-
no da molto lontano, e potevano anche essere conside-
rate tradizionali all’interno del mondo cristiano10. L’am-
ministrazione della monarchia centralizzata della Chie-
sa rischiava sempre di deludere, di irritare, di scanda-
lizzare, quando si aveva a che fare con l’enorme mac-
china della Curia. Molti consideravano pericolosi e
assurdi i recenti sviluppi della politica territoriale e mili-
tare del papato. Leone X e Clemente VII avevano ere-
ditato quella situazione pericolosa e preoccupante crea-
ta da Giulio II. Al rispetto dovuto al pontefice si mesco-
lava inevitabilmente l’ammirazione o il sospetto che
ispirava il suo comportamento come capo dello Stato
romano. Erasmo, di ritorno dall’Italia, scrisse, ironico
e inquieto, l’Elogio della pazzia (1511): se il mondo è
insensato, certo una grande responsabilità ne ha la Chie-
Storia dell’arte Einaudi 7
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
sa. Senza dubbio, l’aspetto generale della città gli pia-
ceva e ne parlerà piú tardi con un certo affetto, ma con
tono ben diverso dall’Aretino. Già allora alla base del
suo pensiero, espresso piú tardi nel Ciceronianus del
1528, era che Roma, con le sue manie di stile elegante
e di pompa antica, alla fin fine era soltanto un covo di
paganesimo11.
Si diffondeva sempre piú l’idea che per essere buon
cristiano fosse meglio non andare a Roma. In quale
misura il breve soggiorno di Martin Lutero presso gli
Agostiniani di Santa Maria del Popolo nel 1511 fece
nascere in lui la volontà di ribellarsi che scoppiò nel
1517, e i cui terribili contraccolpi furono risentiti duran-
te tutto il pontificato di Clemente VII?12. In ogni caso,
nessuno al di là delle Alpi parlò mai con maggior odio e
disprezzo della Città Santa. Certo, né Lutero né Erasmo
poterono vedere e capire tutto quanto stava accadendo.
Ma ne videro e capirono abbastanza per dissociarsi per
sempre dalla vita romana, non solo per come venivano
gestiti gli affari della cristianità, ma, assai piú radical-
mente, per la mescolanza costante, e odiosa ai loro
occhi, di profano e di sacro, di modelli antichi e di usan-
ze cristiane.
A Roma stessa si assisteva a una specie di autocriti-
ca permanente con le Pasquinate13 popolari e i libelli
velenosi, spesso emanazioni di personalità vicine al pote-
re, come i capitoli del Berni, segretario dal 1524 al 1532
del datario Giberti14. L’Aretino ha imparato molto da
questa letteratura. Il tono della satira, nel Rinascimen-
to, era di una violenza estrema e divenne spesso feroce,
come al tempo di Adriano VI15. Tali eccessi verbali erano
dunque parte integrante delle usanze romane, ma inco-
raggiavano l’impressione che la Città Santa fosse il luogo
di lotte locali poco edificanti. Roma, veduta o immagi-
nata di lontano, era sempre piú oggetto di una denun-
cia globale, senza sfumature, amplificata da una pro-
Storia dell’arte Einaudi 8
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
spettiva escatologica, e una parte della cristianità la
incolpava adesso della crisi europea, dei turbamenti della
Chiesa. Contavano sempre meno gli sforzi tentati rego-
larmente per lottare contro gli abusi dei costumi dottri-
nali o morali, contro il rilassarsi dei costumi del clero,
ecc. Il Concilio Laterano del 1513, ad esempio, aveva
preso in tal senso numerose iniziative16. A torto o a
ragione, si aveva la sensazione che sarebbero rimaste
tutte lettera morta o che, in ogni modo, sarebbero state
insufficienti. Roma era il centro di un mondo straordi-
nariamente cosmopolita. L’amministrazione ecclesiasti-
ca presupponeva una quantità enorme di personale; ora
piú che mai i problemi internazionali, che dalla calata
dei francesi nel 1494 passavano praticamente sempre per
l’Italia, si negoziavano a Roma17. Inoltre, in periodi
favorevoli come i pontificati di Giulio II, di Leone X,
di Clemente VII, i movimenti culturali assumevano una
tale importanza che tutti gli sguardi del mondo erano
rivolti verso Roma. Questa stretta associazione e, se
vogliamo, questa commistione tra politica, religione e
cultura, erano sempre state caratteristiche della città.
Per il mondo cristiano, e persino per l’impero pagano,
in questo consisteva, era sempre consistito e consiste
ancora il fascino e la singolarità di Roma. Questo sim-
bolo di una pienezza senza confronti è ciò che permet-
te a Dante di aspirare a essere «...sanza fine cive | di
quella Roma onde Cristo è romano»18. Giustamente si è
insistito sulla severità con la quale Egidio da Viterbo, ai
tempi di Giulio II, si rivolgeva alla Curia. Questo vica-
rio generale degli Agostiniani sembra talvolta raggiun-
gere il tono aspro di quell’altro monaco agostiniano che
aveva forse incontrato a Roma... Ma Egidio non vede-
va alcuna contraddizione fra la critica dei costumi roma-
ni e l’esigenza di una sempre maggiore autorità della
Santa Sede, tra il sogno di un ritorno alla semplicità e
il dovere di magnificenza. Egli incoraggia Leone X a
Storia dell’arte Einaudi 9
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
proseguire l’opera gigantesca del nuovo San Pietro, il
che, fra l’altro, significa la sua approvazione per la ven-
dita delle indulgenze allo scopo di raccogliere fondi,
senza supporre la catastrofe che questo avrebbe provo-
cato19. Un certo fasto liturgico e lo splendore monu-
mentale erano una vocazione inevitabile della Roma
pontificia.
Dal solo esame delle guide, non tardiamo ad accor-
gerci che, già allora, il turismo pio associava inestrica-
bilmente le mirabilia del cristianesimo e dell’antichità
in un’unica celebrazione di Roma come superiore a
tutte le città20. Questo amalgama costante, queste sto-
rie intrecciate, dotavano Roma di un’attrattiva quasi
magnetica per gli intellettuali, i poeti e gli artisti, come
per la folla di pellegrini e di fedeli. Per la coscienza
comune, la capitale della cristianità beneficiava certa-
mente di un’immunità divina, che era perfino procla-
mata con certezza – lo vedremo – nelle piú famose
decorazioni di Roma21. La nozione di «italianità» ricor-
reva sovente nei periodi di difficoltà e di guerre; ma
veniva dimenticata altrettanto rapidamente nelle riva-
lità che scoppiavano tra gli stati piccoli e grandi della
penisola. Essa però non poteva essere dissociata dalla
nozione di «romanità» che, allora, assumeva una colo-
razione intensamente affettiva. Come ha bene osserva-
to F. Chabod, la lingua in piena fioritura «letteraria»,
la cultura in piena espansione, le arti in piena afferma-
zione, vi rappresentavano una parte importante e anche
insolita, che sopravviveva alle delusioni politiche senza
potere, beninteso, supplirvi22. Sotto questo aspetto nes-
suna «nazione» è stata piú di Roma cosciente della pro-
pria capacità, della propria impotenza e delle proprie
sciagure.
Accade forse alla storia come alla geologia: le strati-
ficazioni e le configurazioni profonde non sono facil-
mente visibili. Tuttavia, «lo studio dei terremoti o dei
Storia dell’arte Einaudi 10
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
sismi è il mezzo piú efficiente di cui disponiamo per
conoscere l’interno del nostro pianeta, nel quale essi si
verificano»23. L’esame di talune catastrofi gravissime è
forse, per analogia, un mezzo potente per svelare, nello
sconquasso generale di una società, le forze che un
tempo ne assicuravano la relativa coesione e per rico-
noscere attraverso le reazioni istintive del terrore, della
desolazione e della vergogna certi impulsi percepibili di
rado. L’opposizione delle categorie sociali e la fame di
possesso proprie a qualsiasi collettività mostrano allora
la loro dura realtà; sarebbe ingenuo credere, tuttavia,
che questi soli dati rendano conto di tutto. Prima,
durante, dopo una grande tragedia collettiva, si spri-
gionano, come ondate di calore soffocante in un incen-
dio, folate irreprimibili di fantasia che, nelle scosse di
crudeltà e di terrore24, appaiono in tutta la loro poten-
za e nella loro capacità di sviluppo. In tal senso il sacco
di Roma è stato rivelatore.
Gli avvenimenti del 1527, le circostanze e lo svolgersi
del sacco, hanno formato oggetto di un numero immen-
so di pubblicazioni, di cui l’essenziale è stato raccolto
nella vecchia e stimolante cronaca di Gregorovius (1859-
72), completata dall’enorme racconto documentario di
L. von Pastor (1866-1907) e dal repertorio di H. Schultz
(1894). Da allora in poi non uscirono altro che aggiun-
te e particolari, per lo meno fino a talune opere recenti
alle quali conviene accennare25. J. Hook (1972) ha volu-
to recare alla narrazione storica maggiore chiarezza e
precisione; le fila dei molteplici intrighi diplomatici,
militari, religiosi, vi sono svolte con pazienza26. Abbia-
mo tenuto conto di questa attenta restituzione degli
andirivieni, degli incidenti, dei probabili dati statistici,
del ruolo dei vari personaggi. Ma abbiamo dovuto risa-
lire costantemente alle prime fonti d’informazione per-
ché le ricerche di Hook non coincidevano con le nostre;
il susseguirsi stesso degli eventi concorda solo inciden-
Storia dell’arte Einaudi 11
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
talmente con le nostre preoccupazioni. La nostra inda-
gine segue una linea diversa. La crediamo giustificata dal
fatto che la concatenazione dei fattori è in gran parte
oscura ed enigmatica. In questo susseguirsi poco comu-
ne di divergenze, di panico, di cedimenti, di sommosse
e di disordini inauditi, l’irrazionale e il fortuito ci sem-
brano avere una parte troppo eminente per essere tra-
scurati. È proprio questo che incuriosisce. Non è un
bello spettacolo, ma è talvolta necessario scrutare i sot-
terfugi della violenza e il comportamento incerto delle
vittime. Circostanze come quelle del 1527 pongono l’in-
dividuo in stretta dipendenza dalla «psicologia colletti-
va». Una congiuntura eccezionale ci mette di fronte a
quest’insieme di riflessi, di pregiudizi, di blocchi men-
tali, di pii desideri che oggi noi riuniamo nel termine di
«mentalità». Bisognava tentare di scoprire che cosa ci
fosse alla base di una spaventosa tragedia, che conta
molti mascalzoni e pochissimi eroi. Prima di procedere
oltre, occorreva accostarsi a questa torbida fase del Rina-
scimento con l’aiuto delle nozioni e dei termini che
furono quelli dell’epoca. Abbiamo tentato di ritrovarne
il linguaggio. Non senza una soddisfazione crescente ci
siamo resi conto che le nostre ricerche in aspetti speci-
fici dell’avvenimento mettevano in luce altrettanti lati
poco noti della storia dell’arte. Prima di tutto il ruolo e,
per cosí dire, il peso specifico delle immagini nella pro-
paganda bellica che precedette la calata del connestabi-
le Carlo di Borbone e dei suoi lanzichenecchi; in secon-
do luogo, l’importanza di quegli oggetti preziosi, reli-
quiari, opere d’arte in genere, tanto apprezzati come
bottino di guerra; infine il comportamento e la sorte,
molto mutevoli, delle personalità degli artisti travolti
dalla tormenta. A questo proposito ci sembra pertanto
che la narrazione tradizionale vada integrata con una
quantità di materiale che ne colmi le lacune.
In un’opera piú recente e di agevole lettura sulla
Storia dell’arte Einaudi 12
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Roma del secolo xvi, è esposta l’attitudine della società
cosmopolita e caotica, raggruppata intorno alla Curia, a
sormontarne le molteplici contraddizioni o, almeno, a
convivere con queste27. Abbiamo trovato in questo sag-
gio disegnato con vivezza – ma non interpretato – il
panorama urbano e sociale che avevamo dovuto ricosti-
tuire per situare l’analisi del fatale 1527. La tesi corri-
sponde a ciò che generalmente è ammesso. Quando si
consideri il comportamento anarchico del popolo roma-
no, le discordie e l’instabilità della Curia, il contrasto
costante fra il prestigio e la realtà, ci si meraviglia meno
del crollo e degli orrori del sacco28. Il disastro sembra
rientrare nella continuità della storia, e pertanto non
occorre esaminare piú a fondo questa vicenda. Essa creò
per qualche tempo un vuoto incontestabile, ma non
parve avere segnato una rottura profonda con il passa-
to. Nei manuali, la data 1527 è diventata un comodo
riferimento per scandire i periodi della storia, nulla piú29.
Noi crediamo di dovere piuttosto condividere il pare-
re espresso circa un secolo fa da un grande erudito di
cose romane: «Questo evento funesto ha spaccato per
cosí dire in due il corso della vita romana, spezzando tra-
dizioni e costumi, mentre la lotta contro la Riforma tra-
sformava profondamente gli spiriti»30. Per questo moti-
vo Gnoli, forse esagerando tale aspetto particolare, rite-
neva che alle Pasquinate «letterarie» di prima succedes-
se un altro atteggiamento, un’altra consuetudine di tono
piú aspro e piú pesante31. Piú in generale, si possono
osservare in tutti i campi, diplomatico, religioso, politi-
co, culturale, civile, artistico, una o piú conseguenze
gravi degli avvenimenti del 1527 e degli anni seguenti.
In un’umiliazione senza precedenti della Città, del papa-
to, dell’«italianità», la sciagura ha fatto scoppiare in
piena luce, in faccia agli italiani e al mondo, non solo le
tensioni di questa società contraddittoria e, in un certo
senso, artificiosa costituita dalla città pontificia, ma
Storia dell’arte Einaudi 13
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
anche quella mancanza quasi assoluta di sentimento
nazionale nella penisola, che sovente ha stimolato la
curiosità degli studiosi di storia italiana. Sforzandoci di
isolare l’uno dopo l’altro gli elementi di cristallizzazio-
ne abbiamo veduto abbozzarsi una linea di spaccatura
troppo ampia e troppo marcata per non meritare di esse-
re interpretata come un’articolazione forte, un periodo
cruciale per Roma e per tutto quanto il mondo italiano.
Questo libro è nato dall’esigenza di rispondere agli
interrogativi posti da tale problema. Ci si è chiesti,
insomma, se non fosse il caso di estendere alla Città stes-
sa la frase sensazionale di Sebastiano del Piombo il
quale, anni dopo, esitando a ritornare a lavorare per Cle-
mente, scrive a Michelangelo: «Ancora non mi par esse-
re quello Bastiano che io era inanti el Sacco»32. Ma
come spiegare un simile sconvolgimento?
Nell’ambito delle semplificazioni inerenti al metodo
«sociologico» o globale, che è un modo per chiarire le
cose, il fatto storico non viene tenuto sufficientemente
in conto. L’atto o l’evento «fortuito», come il concetto
di fatalità, non si impongono allo storico fino a quando
non sono espressi e ampliati dalla coscienza collettiva.
Ed è il caso del sacco di Roma. Lo slittamento, che nel
giro di qualche anno ha gettato la capitale della cristia-
nità nell’abisso, è dovuto a un accumularsi di circostan-
ze, di cui i particolari aspetti erano imprevedibili; si pos-
sono tuttavia osservare chiaramente le conseguenze irre-
parabili delle minime colpe.
Il cardinale Giulio de’ Medici, un prelato di inecce-
pibile dignità, era stato eletto papa a fatica il 19 novem-
bre 1523. Per reazione al breve pontificato dell’olande-
se Adriano VI (gennaio 1522 - settembre 1523), la cui
volontà di riforma e lo spirito di austerità si erano sal-
dati con un’impopolarità generale, occorreva un diplo-
matico, un principe illuminato, e lo si era trovato con il
nipote di Lorenzo il Magnifico; ma l’elezione avvenne
Storia dell’arte Einaudi 14
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
a spese del cardinale Farnese, un romano, del quale è
lecito pensare che avrebbe affrontato meglio del bril-
lante Clemente gli incombenti pericoli. Sarà lui a esse-
re chiamato, nel 1534, per riparare la catastrofe. Dieci
anni prima, avrebbe probabilmente evitato i tranelli in
cui era incappata l’astuzia fiorentina.
Sotto Leone X erano avvenuti parecchi fatti nuovi,
che esigevano molta abilità nel potere pontificio; l’in-
vasione dei servizi, dei commerci, delle banche destina-
ti a diventare feudi dei Medici, fenomeno che si
amplierà sotto Clemente33; l’avvento in Francia di Fran-
cesco d’Angoulême, nei Paesi Bassi e in Spagna di Carlo
d’Asburgo, principi giovanissimi, incredibilmente ambi-
ziosi, che, in concorrenza con il non meno giovane e irre-
quieto Enrico VIII d’Inghilterra, visibilmente stavano
per prendere iniziative temibili, la manifestazione bru-
talmente contestatrice, il 31 ottobre 1517, di un mona-
co agostiniano, Martin Lutero, che, a proposito della
vendita d’indulgenze, denunziava apertamente la crisi
dei costumi e gli abusi di Roma.
Sotto Clemente la situazione peggiorò ovunque: a
Roma, le fazioni si agitavano a tal punto che nel set-
tembre 1526 i Colonna, in collisione con gli agenti impe-
riali, giungono perfino ad attaccare e devastare il Vati-
cano; i romani tradirono il loro pontefice34. Per una
assurda disavventura, Francesco I si lascia vincere e cat-
turare a Pavia all’inizio del 1525, cosí la via dell’Italia
è aperta per Carlo V; ma questi, lontano, lento, nego-
zia: il papa e l’imperatore si scambiano numerose lette-
re. Frattanto Francesco persuadeva Clemente a unirsi
alla Lega di Cognac nel maggio 1526, che rinnova il ten-
tativo della «Lega santa» antifrancese del 1512. Ciò
provoca una rottura le cui conseguenze, mal calcolate da
ambo le parti, saranno una forte armata messa insieme
a casaccio, a nord della penisola, nel 1526 e la sua lenta
calata attraverso l’Italia. Questa armata comprendeva –
Storia dell’arte Einaudi 15
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
cosa sorprendente – mercenari luterani. Perché, in meno
di dieci anni, il movimento antiromano aveva trasfor-
mato il clima della Germania e raggiunto un grado di
violenza passionale che a molti umanisti e cristiani sem-
brava una rinascita. Roma era davvero quel paese del-
l’Anticristo che, con un’immagine piú vecchia della cri-
stianità, veniva designato sotto il nome di Babilonia, la
capitale del male? Nel primo terzo del secolo xvi nasce-
vano movimenti religiosi e di rinnovamento della fede
che non vanno trascurati35. Soltanto una visione ristret-
ta dell’azione del «mondano» Leone X e del «politico»
Clemente VII impedisce di cogliere il ruolo esatto dei
due pontefici in quel che potremmo chiamare la «pre-
Riforma cattolica», se si elimina da tale definizione
qualsiasi concetto di una parentela iniziale con la rivol-
ta luterana36. Taluni gruppi ferventi contribuivano con
la loro critica alla Curia e al clero ad appesantire il clima
di Roma, il che alla lunga fece sí che la gente prestasse
orecchio alle profezie allarmistiche. Ma i moventi di
questi gruppi erano evidentemente soltanto devoziona-
li. I Nuovi Osservanti, ad esempio, che aspiravano a
ripristinare la semplicità francescana, vestiti di sai con
cappuccio e forniti di una lunga barba, avevano l’ap-
poggio della duchessa di Camerino, nipote di Clemente
VII. Costei aveva favorito gli incontri di Matteo da
Bascio, un giovane prete di Montefalcone, con il papa,
durante l’anno giubilare del 1525. Nel luglio 1528, la
bolla Religionis zelus accorderà al nuovo gruppo l’auto-
rizzazione di condurre vita monastica e un capitolo gene-
rale convaliderà queste iniziative nel 152937.
Non meno tipico della nuova spiritualità è la tra-
sformazione dell’Oratorio dell’amor divino in una con-
gregazione di cui erano leader il vescovo di Chieti, Gian
Pietro Carafa, e Gaetano da Thiene. Non si deforma l’o-
rientamento del gruppo affermando che era innanzitut-
to imperniato sulla dignità e la sacralità del clero38. La
Storia dell’arte Einaudi 16
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
loro devozione a san Gerolamo è interessante perché si
imperniava soprattutto su Gerolamo l’asceta, il peni-
tente indefesso, e anche sul Gerolamo grande interpre-
te della Scrittura. L’accento è posto sulla vita interiore
e sulla soavità dell’amore metafisico, in un culto tutto
affettivo e fervente dell’Eucaristia (culto che sfocerà
nell’istituzione dell’«adorazione delle quaranta ore»)39.
Alcuni membri del gruppo erano parenti di Clemente e
del suo datario Giberti. Gli incoraggiamenti dati a que-
sti giovani preti, che, in un clima esaltato di speranza e
di pietà, indifferenti ai torbidi dell’ora li giudicavano
anzi salutari, erano tali che uno di loro scrisse nel gen-
naio 1527: «Il Cristo è adesso piú temuto e riverito che
mai a Roma: gli orgogliosi si umiliano e i buoni lodano
Dio»40. Parole che avrebbero sconvolto Erasmo e Lute-
ro. Questo ottimismo religioso fu completamente
distrutto quattro mesi piú tardi dall’esercito imperiale
con i suoi lanzichenecchi sacrileghi41. Tutto questo fer-
vore religioso non annulla evidentemente le testimo-
nianze scabrose dell’Aretino o de La lozana andaluza,
opera di Delicado, sulla «dolce vita» di Roma in quel
periodo; ma la fin troppo nota opposizione fra la «cor-
ruzione romana» e la purezza dei riformatori non-ita-
liani è una delle semplificazioni a cui sarebbe bene
rinunciare.
Taluni rigoristi potevano scandalizzarsi dei nuovi svi-
luppi della pittura e della scultura, dell’importanza che
a Roma veniva loro data, della parte che vi si attribui-
va ai modelli antichi, alle favole pagane. Ma la reazio-
ne degli artisti, che sempre piú numerosi scendevano dai
paesi del Nord, era tutt’altra: Roma li affascinava; nelle
opere commissionate dai principi della Chiesa trovava-
no un equilibrio tra il profano e il sacro che non poteva
non apparire loro straordinariamente stimolante. Sotto
questo aspetto le ultime opere di Raffaello erano molto
significative. Nell’appartamento del cardinal Bibbiena,
Storia dell’arte Einaudi 17
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
l’Urbinate aveva dato nel 1516 la piú archeologica delle
versioni – ossia la piú fedele al modello antico – delle
decorazioni a grottesche, senza il minimo spazio per il
pensiero cristiano: la Stufetta, ciclo di Venere, e la Log-
getta, ciclo di Apollo. Ma l’anno seguente, nella decora-
zione delle logge pontificie, il maestro cambia ottica e
progetta una Bibbia conservando lo stesso sistema orna-
mentale. I motivi figurati delle tredici campate sono
tutti tratti dall’Antico Testamento, in mezzo a una stu-
pefacente varietà di forme decorative e in uno stile inte-
ramente ispirato dall’antico. Fu quello un grande avve-
nimento, di successo considerevole; questa nuova Bib-
bia «è servita di riferimento costante fino alla fine del
secolo xix» e, come anche è stato detto, questo sforzo
rispondeva «al rifiorire degli studi cristiani favoriti da
Leone X alla fine del suo pontificato42. Non vi è qui
alcun dubbio, si contava sulla «Bibbia di Raffaello»,
come sui poemi religiosi di Sannazaro43 per difendere la
fede cristiana; vi si scorgeva uno dei mezzi di azione nor-
mali e necessari della Chiesa.
Oggi siamo inclini a stupirci che, nell’atmosfera tur-
bolenta e instabile dell’Italia dopo il 1494, la cultura
potesse mantenere un tale ruolo e l’arte beneficiare di
tante occasioni favorevoli. Nessuna analisi sociologica o
d’altro tipo è stata fin qui in grado di rendere conto di
tale situazione, tranne forse quella di Jacob Burckhardt,
i cui concetti rimangono, a dire il vero, cosí generici che
si tratta piuttosto di una descrizione intelligente che di
un’analisi44. Considerando «lo stato come un’opera d’ar-
te», Burckhardt ha voluto spiegare il carattere «forma-
lizzato» delle istituzioni nel Rinascimento, che soprav-
vivevano per cosí dire grazie al modo in cui ognuno se
le raffigurava: la loro immagine per la coscienza collet-
tiva contava piú della loro funzione. Ne è prova l’evi-
dente facilità con cui si verificavano rivoluzioni e depo-
sizioni. Pompeo Colonna crede di poter rovesciare Cle-
Storia dell’arte Einaudi 18
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
mente e farsi eleggere papa: la politica di Carlo V tende
a dimostrare che l’Impero, – questa nozione vuota di cui
taluni storici hanno potuto credere, tanto è fittizia,
ch’essa non rappresentava piú una importante parte, –
rispondeva meglio del papato ai disegni della provvi-
denza45. A dispetto di tutti i moti che la agitano, «l’Eu-
ropa del secolo xvi si è semplificata con un ritorno al
modello medievale dell’impero e del papato»46. Se la
diplomazia straordinariamente attiva e contorta dei
sovrani manifesta una specie di slancio ideologico, una
colorazione particolare, talvolta fantasmagorica, duran-
te gli anni che su per giú vanno dal 1520 al 1540-50, dal-
l’elezione al trono imperiale di Carlo di Asburgo alla fine
del suo regno come Carlo V, è in gran parte in ragione
del potente riattivarsi della «finzione imperiale» di fron-
te alla realtà pontificia contestata, scossa, ma tenace. Un
mondo politico in effervescenza dominato dalla concor-
renza fra «impero e papato», due forme del potere che
gli storici troppo preoccupati della modernità del seco-
lo xiv hanno avuto tendenza a sottovalutare, non è forse
per noi facile da afferrare. Siamo in presenza di conce-
zioni complesse e la loro complessità non concorda sem-
pre con le esigenze dell’azione.
Lo scarto fra quel che esprimono queste «forme sim-
boliche» associate all’autorità, e la realtà del potere, era
tale che, per i partecipanti del gioco diplomatico e anche
militare, erano possibili mortali illusioni: comportamenti
che, in una distribuzione diversa delle parti potevano
riuscire, si rivelano catastrofici. C’era rovina, morte,
disonore, insuccesso, guazzabuglio e impotenza, tanto
dalla parte dei vincitori che dei vinti. Tutti gli attori
responsabili sapevano a qual punto la situazione, che si
era aggrovigliata intorno a Roma, fosse pericolosa?
Pochi esempi nella storia pongono meglio in evidenza il
modo con cui i protagonisti della politica riescono a far
precipitare i mali o gli eventi da loro piú temuti, e la loro
Storia dell’arte Einaudi 19
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
capacità di travestire e di annullare gli effetti disastro-
si della loro condotta, una volta fuori dalla difficoltà.
Non sono tanto le atrocità e le infamie a colpirci quan-
to i pietosi rigiri o le false illusioni. Nessuno ha credu-
to di poter mettere Clemente VII fuori causa o di per-
donargli il suo scacco: «noi ruinammo tutti vituperosa-
mente d’una ruina poco men che prevista», scrive fred-
damente Paolo Giovio47. E dalla storia intera dell’epo-
ca, riferita da uno dei piú ardenti difensori di Clemen-
te, Guicciardini, sgorga un’inconsolabile amarezza48.
Quanto a Carlo V, ci vollero tutte le sinuosità di una
politica tessuta di silenzio, di astuzia e di forza, per rag-
giungere la sua meta meno di dieci anni dopo il dram-
ma dell’entrata in Roma. Il crollo morale è indubbio.
L’arte del tempo ce ne consegna il riflesso? Domanda
inevitabile e, certo, delicata.
Si è tentato qui di seguire nell’indagine due linee prin-
cipali. Prima di tutto il concatenarsi del fortuito, che non
può non incitare a una riflessione piú generale sulla sto-
ria. La straordinaria abbondanza dei documenti, delle
memorie rivela il susseguirsi di avvenimenti che compor-
tavano un cosí gran numero di accidenti e di colpe che,
anche oggi quando l’angoscia delle notizie del 1527 non
ci prende piú alla gola, è difficile sfuggire alla sensazione
che un cumulo cosí imponente di disavventure sia qual-
cosa di diverso dalla fatalità. Una specie di determinismo
latente sembra dominare questo susseguirsi di casi. Per-
ciò abbiamo creduto doveroso insistere sulle ossessioni
rivelatrici che, attraverso i sistemi astrologici o profetici,
costituiscono fattori non trascurabili di blocchi mentali e
di falsi movimenti. Si dànno casi in cui i modi dell’im-
maginario costituiscono momenti della storia.
Lo stesso succedersi degli avvenimenti – incontri di
persone, movimenti militari, ecc. – finisce per conver-
gere su una stessa via disseminata di catastrofi, e lo sto-
rico prova qualche difficoltà a collocare nella loro giu-
Storia dell’arte Einaudi 20
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
sta prospettiva le esitazioni e le incertezze, che erano
proprio il segno della situazione. A sua insaputa, egli
rimane prevenuto dalla versione «fatalista» di questa
fase troppo spettacolare del Rinascimento. Parlando di
un moto irresistibile, si eliminano le alternative e si per-
dono di vista i momenti di difficoltà, le occasioni per-
dute, i movimenti inversi che potevano sorgere. Per-
tanto abbiamo dato tutta l’attenzione al dedalo di con-
traddizioni e di ambiguità, dove, per fortuna, un gran-
de storico, Guicciardini, ci serve magistralmente da
guida. Abbiamo dunque dovuto studiare questa realtà
un po’ misconosciuta dagli storici: un momento prolun-
gato di confusione. Tuttavia è notevole che in aprile, nel
momento in cui si moltiplicano annunzi e presagi, Cle-
mente, confidando nella parola del viceré Lannoy, smo-
biliti le milizie pontificie, l’unica sua difesa efficace. Si
può parlare di aberrazione e di calcolo sbagliato, di cat-
tiva informazione49. Si può anche pensare alla reazione
di fuga che precipita la vittima verso quello che inten-
de evitare.
Certo, noi non ne trarremo alcuna conclusione, per
mancanza sia di competenza, sia d’informazione. Ci
basta ricondurre l’indagine storica ai suoi punti di mag-
giore ambiguità. All’uopo non abbiamo trascurato nulla
per raccogliere e raffrontare fra loro i documenti ico-
nografici o letterari importanti e secondari: stampe,
decorazioni particolari che evidenziano la situazione
attraverso immagini e simboli. Vi furono scarse rappre-
sentazioni dei fatti ma, viceversa, parecchi buoni esem-
pi delle conseguenze dei fatti stessi. Non vorremmo
essere fraintesi. Nell’intendimento nostro questo lavo-
ro è destinato a servire la storia dell’arte, come lo fu il
bel saggio del nostro rimpianto amico Millard Meiss50.
Ma la storia dell’arte concepita in modo ch’essa non
lascia intatta la storia pura e semplice. Vorremmo distur-
bare un tantino la sicurezza delle «sintesi». L’episodio
Storia dell’arte Einaudi 21
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
scelto non sembra un caso molto favorevole, poiché il
suo unico pregio pittorico è lo scatenarsi della forza
bruta. Ma proprio l’evento che ha straziato e smembra-
to una città come Roma e un’istituzione come la Chie-
sa cattolica, rivela molto bene la stranezza profonda del
sociale: è insufficiente attenersi all’analisi politica delle
intenzioni; lo studio socioeconomico della congiuntura,
dei bisogni e dei vari ambienti non può condurre ad
altro che a vedere nel sacco un episodio secondario; ma
non è cosí se seguiamo la strada tracciata dalle manife-
stazioni della fantasia popolare, dalle risonanze della
cultura, dalle forme e dai simboli.
L’indagine in questa direzione sembrava feconda per
via dell’abbondanza e dell’atteggiamento della lettera-
tura suscitata dall’avvenimento. A dire il vero, si ha
l’impressione di assistere qui alla nascita del giornalismo
con l’esplosione delle «notizie» (storie), delle pagine
scandalistiche, e dei commenti piú o meno fantastici. Il
«giudizio» era un breve rapporto sull’avvenimento, che
subito veniva stampato e venduto in fogli sulle piazze.
Intorno al 1527 quei giornali improvvisati avevano un
successo sicuro. Il rapporto di un ambasciatore ne men-
ziona la vendita sul Rialto nel 152851. Talune lettere del-
l’Aretino, stampate su fogli volanti per assicurarne la
rapida diffusione, erano dei «giudizi», ossia articoli di
quotidiani ante litteram. Il periodo del sacco vide fiori-
re un po’ dovunque queste «edizioni speciali», e fu allo-
ra che il mastro giornalista scoprí, di fatto, la sua voca-
zione: gli venivano richiesti in alto loco i propri «giudi-
zi» e «pronostici» che erano semplicemente annunci
buffoneschi, parodie dichiarate di pronosticationes astro-
logiche, con un commento facilmente comprensibile
della situazione presente. Il tutto sotto il patronato di
Pasquino, la cui licenziosità e violenza di tono, consa-
crate dall’antica tradizione romana, autorizzano l’a-
sprezza del libellista52.
Storia dell’arte Einaudi 22
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Per l’Aretino, come per il signor Pasquino, non ci
sono che pazzi come quelli che credono agli astrologi, o
manigoldi come coloro la cui menzogna piú innocua è
stata l’annunzio del diluvio53. Cosí l’Aretino pronosti-
cava sul finire del 1526 per l’anno seguente, in base alla
posizione del cielo e del sole: «l’aria sarà pronta a cor-
rompersi per l’infezione dei piedi e del fiato degli Ala-
manni ubriachi di vino italiano». Alcuni anni piú tardi,
nella Cortegiana, l’Aretino, ridendo di tutti quei ricor-
di, introduce il cantastorie, che propone i «grossi tito-
li» del momento: «Le belle storie, storie, storie: la guer-
ra dei Turchi in Ungheria, i sermoni di frate Martino,
il Concilio, storie, storie, gli avvenimenti d’Inghilterra,
il corteo del papa e dell’imperatore, la circoncisione dei
Voivodi54, il sacco di Roma, l’assedio di Firenze, l’in-
contro di Marsiglia e la sua conclusione, storie, sto-
rie»55. Nel bel mezzo di queste informazioni, non tutte
ugualmente sensazionali, dobbiamo quindi collocare l’e-
pisodio del 1527. Il fatto che coincida con le prime
manifestazioni di quel che si può già chiamare la stam-
pa, è una ragione in piú per studiare le reazioni che ven-
gono espresse attraverso varie forme di letteratura a
partire dal sacco56.
Il sacco di Roma non fu il primo esempio di atrocità
commesse in una città illustre: la storia ne conosce un
buon numero e si citava costantemente la presa di Geru-
salemme per opera dei romani e l’ingresso dei goti di Ala-
rico nella stessa Roma57. Alcuni episodi delle guerre recen-
ti non erano stati dimenticati: il saccheggio di Vicenza da
parte dei mercenari tedeschi al momento della Lega di
Cambrai (1509), il sacco di Brescia da parte dei franco-
tedeschi (1512), quello di Prato da parte degli spagnoli
(1513)58. Ma l’entrata dell’esercito imperiale nella capitale
della cristianità alla fine di una calata interminabile lungo
la penisola, in un turbamento profondo degli spiriti ango-
sciati da annunzi terribili, false notizie e presentimenti
Storia dell’arte Einaudi 23
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
di ogni specie, fu ben altra cosa che un episodio militare
particolarmente spiacevole. Pertanto abbiamo creduto
utile esplorare l’antefatto di un attentato sacrilego, dove
non sono mancate né le reazioni popolari, né quelle degli
intellettuali, sondare insomma nella misura del possibile
la profondità di un trauma su cui i documenti raccolti get-
tano nuova luce, che illumina tanto i privati quanto i
gruppi. Uno dei nostri rari predecessori, il professore
Friedrich Hartt, ne ha riconosciuto la gravità commen-
tando la tensione che queste situazioni drammatiche
fanno nascere fra gli organi del potere e l’individuo59. Le
nostre conclusioni sono abbastanza diverse, ma il pro-
blema è pressappoco il medesimo.
Questo studio non ha probabilmente raggiunto,
nonostante i nostri sforzi, il grado di precisione e di rigo-
re che desideravamo. Ogni capitolo cerca di aprire una
prospettiva utile. Il nostro proposito è stato di illumi-
nare «al tempo stesso» la parte dell’accidentale e la
forza dei simboli; ossia da un lato gli slittamenti, l’in-
stabilità, lo stato d’incertezza, di rischio, in cui l’azio-
ne umana è tanto piú vulnerabile via via che si fa piú
audace, e dall’altro l’effetto reciproco tra le raffigura-
zioni di tale azione prima, durante e dopo i momenti di
crisi. Speriamo di avere dimostrato che questi due fat-
tori sono connessi, poiché le raffigurazioni s’inserisco-
no di continuo nell’azione, l’evento si proietta di conti-
nuo nell’immaginario.
La narrazione storica può e deve essere migliorata
continuamente; il nostro intento non è stato di accu-
mulare particolari fini a se stessi, e neppure di dise-
gnarne meglio gli episodi, ma piuttosto di segnalare le
stranezze e le manchevolezze del «discorso storico».
L’incertezza perpetua del vissuto, la pressione costante
dei simboli sono tratti fondamentali dell’esperienza sto-
rica che si coglie in pieno soltanto nei momenti di effer-
vescenza e di disordine.
Storia dell’arte Einaudi 24
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Il nostro tentativo è nato perciò da una sfida o, se
vogliamo, dalla tentazione d’invadere il territorio dello
storico con armi inconsuete, forse insufficienti, ma simi-
li a razzi illuminanti. Abbiamo quasi unicamente affron-
tato quello di cui in genere non si tiene conto. Perché
la storia dell’arte non può riferirsi unicamente alla rico-
stituzione dei soli «avvenimenti» artistici; questi costi-
tuiscono e rivelano ad un tempo, mediante la loro con-
catenazione, l’involucro fatto di narrazioni e di reazio-
ni emotive in cui è contenuta tutta l’esperienza umana,
la vita intera. Abbiamo tentato di esporlo altrove60, solo
l’analisi delle opere e delle forme permette una esplora-
zione completa di quel che chiamiamo l’immaginario
individuale e collettivo, il regno dei simboli.
Questo lavoro, pertanto, mira a mettere in relazione
fatti, fenomeni e opere d’arte che di solito non vengo-
no collegati. Sarà forse il suo unico merito. Tale orien-
tamento ha portato a giustapporre parti narrative –
molto sommarie – e la presentazione di disegni, stam-
pe, dipinti la cui analisi non poteva essere completa. Ne
risulta nel ritmo stesso dei capitoli qualcosa di discorsi-
vo e, sotto molti aspetti, troppo rapido. C’è rischio di
non soddisfare nessuno, ma, almeno, avremo tentato di
far luce sulle passioni e i loro sviluppi specifici, che sono
la trama del vissuto.
Le questioni qui trattate furono oggetto di un corso
al Collège de France nel 1971-72. I principali risultati
furono presentati in una conferenza a Roma il 13 apri-
le 1973 durante un congresso dell’Associazione Guil-
laume Budé.
Quando mi fecero l’onore di invitarmi a tenere le
Andrew Mellon Lectures al Museo Nazionale di Washing-
ton nella primavera del 1977, vidi in questo l’occasione
di uno studio piú ambizioso, che fu abbondantemente
sviluppato per la pubblicazione. Altre ricerche erano
Storia dell’arte Einaudi 25
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
state condotte indipendentemente da Armand Brulhart
(Ginevra). Consistevano di un «notiziario», un elenco
quanto piú possibile completo sui documenti, le fonti e
gli studi concernenti il sacco di Roma, che l’autore ha
gentilmente messo a mia disposizione. Dapprima avevo
sperato di poter pubblicare in appendice quella biblio-
grafia critica. Sono debitore a Brulhart di un numero
apprezzabile di riferimenti.
Dopo la redazione finale di questo testo sono appar-
si due studi storici sull’avvenimento: uno, M. L. Lenzi,
Il Sacco di Roma del 1527, Roma 1978, raccolta di docu-
menti commentati, l’altro: E. A. Chamberlain, The Sack
of Rome, Londra 1979, che riprende la narrazione dei
fatti militari e politici. Vorrei esprimere la mia gratitu-
dine a tutti coloro che mi hanno indicato opere o ricer-
che in corso, che cortesemente hanno risposto ai miei
quesiti, ricercato o verificato documenti, procurato libri
o articoli, fornito fotografie. I miei ringraziamenti
vanno particolarmente: a Roma, a Redig de Campos, a
W. Lotz, a Olivier Michel; a Firenze, a Elio Gabbug-
giani, ex sindaco di Firenze, che ha concesso di foto-
grafare la Sala di Clemente VII a Palazzo Vecchio e al
prof. P. Galluzzi; a Parigi, a Mme Bauermeister
(Bibliothèque Nationale, sezione periodici) e a M.
Destombes; a Ginevra, a Alain Dufour e p. Fraenkel.
La bibliografia e l’indice sono stati compilati dalla
mia assistente A.-M. Lecoq, che, inoltre, ha curato la
stesura definitiva del manoscritto e controllato le cor-
rezioni, cosa di cui le sono gratissimo.
Avvertenza dell’editore. Le note poste tra parentesi quadre sono di
Beth Archer, traduttrice dell’edizione americana del libro.
1
Lettere sull’arte di Pietro Aretino, a cura di F. Pertile ed E. Came-
sasca, 4 voll., Milano 1957 (vol. II, n. cclxiv, p. 106).
Storia dell’arte Einaudi 26
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
2
[I Sonetti lussuriosi, una raccolta di poesie erotiche dell’Aretino,
erano stati illustrati da Giulio Romano in maniera sconveniente. Cfr.
cap. v, p. 147].
3
g. vasari, Vita di Perino del Vaga, in Le vite de’ piú eccellenti pit-
tori, scultori ed architettori, a cura di G. Milanesi, Firenze 1878-85, vol.
V, p. 611.
4
Sviluppando le osservazioni convergenti di g. briganti, Il Manie-
rismo italiano, Roma 1945; e di s. j. freedberg, Painting in Italy. 1500-
1600, Harmondsworth 1971, proporremo piú avanti la nozione di
«stile clementino».
5
j. burckhardt, Die Kultur der Renaissance, 1860 [trad. it. La
civiltà del Rinascimento in Italia, Firenze 1968]; m. creighton, History
of the Papacy, vol. VI, London, 1884, conclude il suo lungo studio con
la rievocazione del sacco del 1527, che segna per lui la fine di un’epo-
ca e l’inizio della Controriforma.
6
briganti, Il Manierismo italiano cit.
7
freedberg, Painting in Italy cit., p. 165.
8
L’abate Lanzi, nella sua Storia pittorica dell’Italia, Bassano 1789,
pp. 243-44, ha soprattutto osservato la dispersione della scuola di Raf-
faello: «Felici le arti se Clemente com’ebbe il genio, cosí avesse avuto
i bei giorni di Leone. Ma le guerre, le pestilenze, e ogni genere di avver-
sità afflisse in quel tempo il Dominio ecclesiastico; e l’anno piú fune-
sto fu il 1527, in cui Roma fu messa a sacco. La scuola di Raffaello si
dissipò, e si disperse, gli eredi delle sue massime o morirono, o si sta-
bilirono altrove; e sotto il pontificato di Paolo III, il solo Perino del
Vaga sosteneva il credito della scuola».
9
b. cellini, La vita da lui medesimo scritta (c. 1559-62), a cura di G.
Davico Bonino, Torino 1973, ad esempio libro I, cap. 30; cfr. cap. v.
10
La critica della Curia e le polemiche antiromane sono caratteri-
stiche della fine del medioevo e del Rinascimento: il movimento ussi-
ta continuò a esprimerle in Europa centrale, il movimento piagnone le
cristallizzò in Italia.
Sulla libertà dei costumi e la corruzione nella Roma del Rinascimen-
to cfr. l. von pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelal-
ters, Freiburg im Breisgau 1886-1907 [trad. it. Storia dei papi dalla fine del
medioevo, Trento-Roma 1944-64, vol. III, libro I, pp. 305 sgg.].
11
a. renaudet, Erasme et l’Italie, Genève 1954. Cfr. cap. iv. Sulle
osservazioni satiriche di Erasmo circa il clima guerriero della capitale,
che lo inorridí, cfr. r. p. adams, The Better Part of Valor: More, Era-
smus, Coht and Vives on Humanism, War and Peace. 1496-1535, Seat-
tle 1962, pp. 37 sg.: «Maledette siano queste guerre che m’impediscono
di godere di una contrada d’Italia che mi piace ogni giorno di piú», let-
tera a Aldo, 1508.
Giulio II era entrato a Roma la domenica degli ulivi del 1507 con
Storia dell’arte Einaudi 27
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
un «trionfo» militare senza precedenti. Ulrich von Hutten scrisse in
questa occasione il suo feroce In tempore Julii, cfr. Opera Hutteni, Mün-
chen 1859, vol. I, p. 267, citato da h. hilman, Savonarola, Erasmus and
other Essays, London 1870, pp. 98 sgg., al quale farà eco nel 1513 il
Julius exclusus, che è piuttosto l’opera di un cardinale erasmiano che di
Erasmo stesso, secondo renaudet, Erasme cit., p. 112.
12
Lutero a Roma, cfr. o. walz, Zur Kritik der Lutherlegende: Luthers
Romreise, in «Zeitschrift für Kirchengeschichte», 2 (1877-78), pp.
611 sgg.; h. boehmer, Luthers Romfahrt, Berlin 1914. Abbiamo tro-
vato questa utile informazione in g. k. brown, Italy and the Reforma-
tion to 1550, Oxford 1933.
13
[Le Pasquinate erano scritti satirici, chiamati cosí perché veniva-
no tradizionalmente attaccati alla statua di un gladiatore soprannomi-
nato per scherzo dagli abitanti del luogo Pasquino, il 25 aprile. L’A-
retino e altri celebri scrittori del Cinquecento parteciparono alle Pasqui-
nate, che divennero la satira politica e curiale di Roma].
14
e. chiorboli, Francesco Berni. Poesie e prose, Firenze 1934.
15
Cfr. cap. iv.
16
a. fliche e v. martin (a cura di), Histoire de l’Eglise, vol. XV: r.
aubecas e r. ricard, L’Eglise de la Renaissance (1449-1517), s.l. 1951,
p. 187 [trad. it. a. fliche e v. martin (a cura di), Storia della Chiesa
dalle origini ai giorni nostri, vol. XV: r. aubenas e r. richard, La Chie-
sa e il Rinascimento (1449-1517) Torino 1972]: misure per rafforzare
gli studi teologici (1513), frenare il lusso dei cardinali (Bolla supernae
dispositionis arbitrio, 1514), impedire alla predicazione di dare troppo
spazio ai pronostici e alle profezie apocalittiche, ecc...
17
Su Roma e la politica «internazionale», cfr. j. fraikin, Noncia-
tures de France. Nonciatures de Clément VII, 2 voll., Paris 1906, Intro-
duzione, pp. xxxv sgg.: La politique de Clément VII et les nonces.
18
Purgatorio XXXII 101-2. Cfr. p. arcari, La Roma di Dante, in
Studi su Dante, vol. VII, Roma 1944, pp. 169 sgg. Sulla forza di attra-
zione di Roma, m. r. scherer, Marvels of Ancient Rome, New York
1955, rimane una buona introduzione.
19
e. massa, Egidio da Viterbo, Machiavelli, Lutero e il pessimismo cri-
stiano, in Umanesimo e machiavellismo, Padova 1949, pp. 75 sgg.; j. w.
o’malley, Giles of Viterbo on Church and Reform. A Study in Renais-
sance Thought, Leiden 1968, cap. v. Il breve di Leone X, che autoriz-
zava le questue nella cristianità, cfr. Breve Leonis X Papae quo indul-
gentiam plenariam concedit elemosynas praebentibus, è stato pubblicato
in «Analecta Augustiniana», 6 (1921-22), pp. 26-28.
20
Sulle guide e la nozione di mirabilia, cfr. o. pollack e l. schudt,
Le guide di Roma, Roma 1930, ristampato 1971; f. morgan-nichols,
The Marvels of Rome, London 1889; a. graf, Roma nella memoria e
nelle immaginazioni del medioevo, Torino 1915, rimane l’opera fonda-
Storia dell’arte Einaudi 28
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
mentale. Sul posto particolare di Roma nel «mito» del Rinascimento,
ci permettiamo di rimandare alle nostre osservazioni in Le mythe de la
Renaissance, Genève 1969, pp. 216 sgg.
21
Cfr. sulla Sala di Costantino il cap. ii.
22
f. chabod, Il Rinascimento, in Problemi storici e orientamenti sto-
riografici, Como 1942; id., Questioni di storia moderna, Milano 1948;
cfr. d. cantimori, Chabod storico della vita religiosa italiana del Cin-
quecento, in «Rivista Storica Italiana», 72 (1960), pp. 687-711, ristam-
pato in Storici e storia, Torino 1971, pp. 315 sgg.
23
j. coulomb, L’Étude de la terre par les ondes séismiques, in La
Terre, Paris 1959, p. 101.
24
Questo aspetto è stato ampiamente trattato, in particolare nell’o-
pera di von pastor, Storia dei papi cit., vol. IV, libro III, parte II, p. 253.
D. Cantimori nell’introduzione alla trad. it. di l. ranke, Die Päpste
[Firenze 1959, ristampata in Storici e storia cit., pp. 172 sgg.] ha ben
dimostrato come l’opera di Pastor sia stata la risposta dell’erudizione
cattolica alla storia protestante di Ranke. Le conclusioni degli storici
sulla esatta natura delle estorsioni e dei sacrilegi sono state spesso
distorte da preoccupazioni confessionali Ranke si è fatto un dovere di
minimizzare sistematicamente gli eccessi delle truppe tedesche. A que-
sto proposito, Pastor (Storia dei papi cit.), ha scritto: «Ranke vede in
questi eccessi dei lanzichenecchi semplici scherzi in cui si rasserenava
il loro spirito evangelico».
25
Non abbiamo potuto consultare s. maurano, Il Sacco di Roma,
Milano 1967.
26
j. hook, The Sack of Rome, 1527, London 1972. Al quale si
aggiungerà un eccellente articolo dello stesso autore, The Destruction
of the New Italia. Venice and Papacy in Collision, in «Italian Studies»,
28 (1973), pp. 10 sgg.
27
p. partner, Renaissance Rome. 1500-1559. A Portrait of a Society,
Berkeley 1976, p. 33: «non sembra esserci nessuna buona ragione per ope-
rare una netta rottura nella storia del sedicesimo secolo, a Roma, a causa
del sacco del 1527». Cfr. la nostra recensione nel «Journal of the Society
of Architectural Historians», 37 (1978). Il punto di vista della «storia
sociale», che è quello della continuità materiale e demografica, appare qui
limitato; la popolazione di Roma ha subito uno sconvolgimento piú
profondo di quanto non lo indichi l’autore, secondo j. delumeau, Vie éco-
nomique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVIe siècle, Paris 1959.
Certamente le istituzioni ecclesiastiche si sono ricostituite, ma il pontifi-
cato di Paolo III ebbe uno «stile» completamente diverso da quello di Cle-
mente VII, come abbiamo cercato di esporre nel capitolo sui Farnese nel
volume collettivo sul Palazzo Farnese, Roma 1981.
28
Sull’incredibile instabilità del governo di Roma, le testimonian-
ze sono innumerevoli. La sua debolezza interna stupiva e preoccupava
Storia dell’arte Einaudi 29
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
particolarmente i Veneziani. burckhardt, La civiltà del Rinascimento
cit., ha citato Girolamo Negro di Venezia, che annunciava catastrofi:
«L’esistenza di questo stato è apparsa a un filo. Dio voglia che non
siamo ben presto obbligati a fuggire ad Avignone ...» (12 marzo 1523).
29
La tendenza a cancellare la rottura del 1527 fondendola in una
prospettiva continua di sviluppo è abbastanza generale, cfr. p. pecchiai,
Roma nel Cinquecento, Bologna 1949; j. delumeau, Rome au XVIe siè-
cle, Paris 1975, p. 227: «È vero ch’essa conobbe gli orrori del sacco,
ma il progresso della città non ne fu che momentaneamente fermato».
p. portoghesi, Roma del Rinascimento, Roma s.d., considera –
non senza ragione, ma in modo un po’ troppo rapido – la cesura del
1527 come parte della storia architettonica e urbanistica della città.
30
v. cian, La coscienza politica nazionale nel Rinascimento, in Scrit-
ti minori, Torino 1934, vol. II, pp. 143 sgg. Cfr. anche cap. iv.
31
d. gnoli, Le origini di Maestro Pasquino, in «Nuova Antologia»,
25 (1890), n. 7, pp. 51 sgg.; f. e r. silenzi, Pasquino. Quattro secoli di
satira romana, Firenze 1968.
32
g. milanesi, Les Correspondants de Michel-Ange, vol. I Sebastiano
del Piombo, Paris 1890, lettera del 24 febbraio 1531. Cfr. cap. v.
33
Cfr. von pastor, Storia dei papi cit., vol. IV, parte I, p. 17, sulla
gioia dei mercanti fiorentini di Roma alla notizia dell’elezione di Leone
X. Sul gruppo di artisti fiorentini e il ruolo degli scrittori toscani sotto
Clemente VII, cfr. anche cap. v.
Al che si aggiungerà l’arrivo dei soldati di Giovanni dalle Bande
Nere, inviati in rinforzo a Clemente contro i Colonna. Sul loro com-
portamento, cfr. cellini, La vita cit., XXXIV: «Era di tutto il mondo
in arme. Avendo papa Clemente mandato a chiedere al signor Giovanni
de’ Medici certe bande di soldati, i quali vennono, questi facevano
tante gran cose in Roma, che gli era male stare alle botteghe pubbli-
che: fu causa che io mi ritirai in una buona casotta drieto a Banchi...»
34
Sullo stato d’animo dei romani prima del sacco, cfr. f. vettori,
in Il sacco di Roma del 1527, a cura di G. Milanesi, Firenze 1867, p.
435: «E li romani erano tanto insolenti e bestiali che persuadevano chi
per un mezzo e chi per un altro salvarsi e che l’imperatore avessi a
pigliare Roma e farvi la sua residenzia e dovere avere quelle medesime
comodità, onori e utili che avevano dal dominio de’ preti».
35
Il resoconto migliore della questione ci pare si trovi nel volume
II della The New Cambridge Modern History: The Reformation. 1520-59,
a cura di G. R. Elton, Cambridge 1958, ristampato nel 1975, cap. viii:
d. cantimori, Italy and the Papacy; cap. ix: h. o. evennett, The New
Orders.
36
È difficile sapere se vi fu un’accoglienza favorevole alle idee pro-
priamente luterane a Roma prima del 1527. brown, Italy and the Refor-
mation cit., p. 205, segnala il caso del domenicano Anghelart, che
Storia dell’arte Einaudi 30
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
abbandonò gli ordini nel 1525, e cita la lettera di un ambasciatore di
Venezia nel 1530: «Vi sono molti eretici a Roma e voi non fate nulla
contro di loro» (sanuto, Diarii, a cura di F. Stefani, G. Berchet e N.
Barozzi, Venezia 1897, vol. LIV, col. 284). Sui libri eretici in Italia,
cfr. d. cantimori, Eretici italiani del Cinquecento, Firenze 1939.
37
Di fatto, l’appoggio pontificio si ritirava non appena questi pre-
dicatori erranti provocavano difficoltà. E Clemente VII ebbe l’occa-
sione di bandirli da Roma nel 1534. Ma sotto Paolo III i Cappuccini
furono protetti dalla stessa Vittoria Colonna. Essi ebbero un immen-
so prestigio con la predicazione folgorante di Bernardino Ochino dopo
il 1536 e una scandalosa notorietà con la fuga a Ginevra e l’apostasia
clamorosa di costui nell’agosto 1542. Cfr. evennett, The New Orders
cit., pp. 280 sgg.
38
È merito di von pastor, Storia dei papi cit. (vol. IV, parte II, libro
III, p. 551), aver indicato la comparsa di questa corrente riformatrice;
alla chiusura del concilio Laterano nel marzo 1517 la congregazione era
stata fondata sotto la denominazione esatta di «compagnia ovvero ora-
torio del divino amore». Questi rigoristi presero il nome di Chietini,
essendo Carafa vescovo di Chieti, poi di Teatini.
39
Gaetano sarebbe all’origine della pratica dell’adorazione perpe-
tua e la preghiera delle quaranta ore (quelle che il Cristo passò nel sepol-
cro). Sulla devozione all’Eucaristia, cfr. Acta Sanctorum Augusti, 2,
Antwerpen, agosto 1735, p. 267. Cfr. f. hartt, Power and the Indivi-
dual in Mannerist Art, in «Studies in Western Art», New York 1963,
vol. III, pp. 227 sgg.
40
Copia de una lettera da Roma, di S. Zener. 1526, in sanuto, Dia-
rii cit., XLIII, coll. 609-12.
41
Sulle disgrazie di Gaetano da Thiene si soffermano tutti i croni-
sti ecclesiastici. Cfr. Acta Sanctorum Augusti, 2, alla data del 7 agosto;
o. raynal, Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII, vol. XX, Roma 1663.
Carafa fu maltrattato, fuggí a Venezia, dove il movimento trovò asilo
prima di impiantarsi a Napoli, donde ritornò a Roma. Cfr. p. paschi-
ni, S. Gaetano, G. P. Carafa, e le origini dei Teatini, Roma 1926. Piú
tardi, diventato papa Paolo IV, Carafa non dimenticò mai il sacco di
Roma (cfr. Conclusione).
42
n. dacos, Les Loges de Raphaël, in Classical Influences, Cambrid-
ge 1976, cap. xxv; Le Logge di Raffaello. Maestro e bottega di fronte
all’antico, Roma 1977.
43
Sugli attacchi di Erasmo al riguardo, cfr. cap. iv.
44
burckhardt, La civiltà del Rinascimento cit., parte I.
45
Il manuale del nostro collega j. delumeau, La civilisation de la
Renaissance, Paris 1967, cosí prezioso sugli aspetti economici, sociali e
religiosi dell’epoca, non sembra tenere sufficientemente in considera-
zione le «categorie» che per la loro importanza hanno trattenuto la
Storia dell’arte Einaudi 31
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
nostra attenzione. Non ci accontentiamo di questo apprezzamento:
«Certamente, il mito imperiale ebbe vita tenace e continuò a osses-
sionare le menti» (p. 41).
Lo studio di f. chabod, Del «Principe» di Niccolò Machiavelli, 1925,
ristampato in Scritti su Machiavelli, Torino 1964, ha vigorosamente messo
l’accento sul carattere personale del potere nel Rinascimento.
Oltre al classico f. kampers, Vom Verdegang der abendländischen
Kaisermystik, Leipzig 1924, cfr. f. yates, Charles-Quint et l’idée d’Em-
pire, in aa.vv., Fêtes et cérémonies au temps de Charles-Quint, a cura di
J. Jacquot, Paris 1960, pp. 57 sgg.; l. diez del corral, La monarquia
hispanica en el pensamiento politico europeo, de Maquiavelo a Humboldt,
Madrid 1975.
46
yates, Charles-Quint cit., p. 57.
47
Historiae sui temporis, citato da f. chabod, in Paolo Giovio, 1954,
ristampato in Scritti sul Rinascimento, Torino 1967, p. 257, nota 3.
48
f. guicciardini, Storia d’Italia, Venezia 1580, ristampato da C.
Panigada, Bari 1929, Vol. V.
49
Fra le Lettere scritte al signor Pietro Aretino, Venezia 1551, si tro-
vano due lettere di Sebastiano (Luciani) del Piombo, dove questi rife-
risce che Clemente avrebbe dichiarato il 15 maggio 1527: «Se Pietro
Aretino ci fusse stato appresso, noi forse non saremmo qui pressoché
prigioni, però che ci avrebbe detto liberamente ciò che si diceva in Roma
de l’accordo cesareo...» (citato da a. luzio, Pietro Aretino nei primi suoi
anni a Venezia e la Corte dei Gonzaga, Torino 1888, p. 16 nota 1).
50
m. meiss, Painting in Florence and Siena after the Black Death. The
Arts, Religion and Society in the Mid-Fourteenth Century, Princeton 1951
[trad. it. Pittura a Firenze e Siena dopo la Morte Nera, Torino 1982].
51
«Un povero homo che va vendendo li giuditij per Rialto...»,
pronto, sembra, a farsi tagliare la testa se le prime lettere non annun-
ziano che i francesi di Lautrec hanno battuto gli spagnoli. Rapporto di
Jacopo Malatesta, ambasciatore di Mantova, citato da luzio, Pietro Are-
tino cit., p. 8.
52
Nell’abbondante letteratura su quest’usanza romana, si può cita-
re silenzi, Pasquino cit. Cfr. anche cap. iv, nota 82.
53
«Li sopradetti manigoldi che la minore e di meno importanza e
menzogna che habino detto è stato il diluvio...» (allusione al pronostico
del 1524, di cui si parlerà oltre, cap. ii). Citato da luzio, Pietro Areti-
no cit., pp. 8 sgg.
54
[Alti ufficiali in Polonia e nei Balcani].
55
La Cortegiana, atto I, scena iv, citata da luzio, Pietro Aretino
cit., pp. 7 sg. Si ricorderà che l’Aretino aveva dedicato il 7 luglio 1527
una canzone al marchese di Mantova sulla sciagura di Roma (ibid.,
pp. 64 sgg.).
56
L’importanza di questo aspetto giornalistico rende il presente stu-
dio molto piú complesso di quello che ha potuto essere condotto in
Storia dell’arte Einaudi 32
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
modo esemplare da A. Pertusi sulla presa di Costantinopoli da parte
dei turchi nel maggio 1453, La caduta di Costantinopoli, vol. I: Le testi-
monianze dei contemporanei e vol. II: L’eco nel mondo, Milano 1976.
Ci si può d’altronde stupire che l’accostamento con questa cata-
strofe non sia mai stato fatto esplicitamente, benché gli spagnoli e i
tedeschi dell’annata imperiale siano stati spesso trattati da turchi, ossia
da nemici della Chiesa cristiana. La caduta della capitale della Chiesa
d’Oriente era stata annunziata, come lo era stata quella di Roma;
aveva riempito di spavento una cristianità incapace di riprendersi;
suscitò «lamenti» greci, italiani, tedeschi, francesi, e «mottetti» (come
quello di Guillaume Dufay; cfr. pertusi, La caduta cit., II, pp. 316 sgg.,
molto piú commoventi della famosa Déclaration en vers de la Sainte Egli-
se al Banchetto del Fagiano dato dal duca di Borgogna il 17 febbraio
1454). Inoltre, tutti i resoconti, contemporanei o successivi, insistono
sugli stessi attentati disonorevoli per la cristianità: stupro di religiose,
di donne e di ragazzi di nobile origine; Enea Silvio: «Aiunt […] Tur-
chorum ducem [...] apud summam aram Sanctae Sophiae propalam
videntibus omnibus nobilissimam virginem ac fratrem eius adolescen-
tem regalis sanguinis constuprasse ac deinde necari jussisse» (pertusi,
La caduta cit., p. 451 nota 21); profanazione e dispersione di reliquie,
cfr. f. babinger, Reliquienschacher am Osmanenhof im xv. Jahrhundert,
in «Sitzungsb. der bayer. Akademie der Wissenschaften, Philos.-Flist.
Kl.», 2, München 1956, pp. 1-47.
57
Una lettera anonima di un segretario di ambasciata veneziano,
datata da Civitavecchia il 20 maggio 1527, è stata pubblicata (Vene-
zia 1527?) con il titolo Copia de una lettera del successo et gran crudel-
tade fatta dreto di Roma che non fu in Hierusalem o in Troia cosí grande
(British Museum). Cfr. anche j. godard, Petit Traicté, Paris 1528.
58
Questa azione fu deplorata in un poemetto di Stefano Guizza-
lotti: «Non tanta crudeltà Turchi infedeli | Usaron mai cotanto alli
Christiani | Quanto ch’a Prato gli Spagnoli crudeli». Cfr. «Archivio
Storico Italiano», 1 (1842), p. 263.
Durante questo saccheggio, uno dei capitelli del pergamo esterno
di Prato (1438) fu portato via dagli spagnoli, secondo l’affermazione
esplicita di Vasari: «l’altro dagli spagnuoli che quella terra misero a
sacco, fu portato via» (vasari, Le vite cit., II, p. 314).
59
Cfr. f. gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter vom
XV. bis zum XVII. Jahrhundert, 8 voll., Stuttgart 1859-724 [trad. it. Sto-
ria della città di Roma nel Medioevo, 3 voll., Torino 1973]; von pastor,
Storia dei Papi cit., vol. IV, parte II; e sul medesimo filone, hartt,
Power and the Individual cit. Comunque, presenteremo nel cap. iv
un’interpretazione un po’ diversa del celebre discorso del vescovo Sta-
fileo al tribunale della Rota nel marzo 1528.
60
Introduzione a Fables, Formes, Figures, 2 voll., Paris 1978.
Storia dell’arte Einaudi 33
Capitolo primo
«Misera caput mundi»
Triste estaba el Padre santo
Lleno de angustia y de pena
En sant’Angel, su castillo
De pechos sobre una almena,
La cabeza sin tiara,
De sudor y polvo Ilena
Viendo a la reina del mundo
En poder de gente ajena*.
Questo è l’inizio di un romance spagnolo, che si can-
tava per le strade di Valladolid e di Valenza dopo la
presa di Roma1. Più irrispettose ancora erano le strofe
in cui ci si burlava della navicula di San Pietro che fa
acqua. Durante i mesi estivi dell’«anno terribile» e anco-
ra negli anni seguenti, la cristianità ha echeggiato di
ritornelli del genere2. Non tutti avevano evidentemen-
te l’insolenza di tono gradita ai seguaci di Carlo V. In
Italia si conosce, in una buona mezza dozzina di esem-
plari, un tipo di lamento detto lamento di Roma, tutto
grida di angoscia, imprecazioni contro la sorte, appelli
a Romolo e alla gloria del mondo antico:
Mi chiamo Roma capomondi
Misera, che del tutto fui signora3.
Misera Italia, a che condotta sei
Suggetta al nome che più fiate hai vinto;
Storia dell’arte Einaudi 34
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
La gloria, el pregio e quel vigore è estinto
Che già dato ti fu da’ sommi Dei4.
Un breve poema anonimo in latino evoca, in un segui-
to di rapide repliche trasposte dal Vangelo, la «passio-
ne» di Clemente, ricalcata su quella del Signore, pare,
senza intenzione ironica5. Si conosce di Costanzo Festa,
membro della cappella papale fin dal 1517, un mottet-
to che, di fatto, e la messa in musica del Salmo 79 sulla
rovina di Gerusalemme, Deus, venerunt gentes in heredi-
tatem tuam: «0 Dio, le nazioni sono venute nella tua ere-
dità, hanno contaminato il tuo santo tempio, hanno
ridotta Gerusalemme in cumuli di rovine».
La distruzione, i cadaveri, il sangue, erano evocati nel
poema biblico con una forza che poteva applicarsi diret-
tamente agli orrori del 1527. La ripresa dell’antifona
Adjuva nos, deus salutaris noster, vi aggiungeva l’accento
dell’implorazione6. Nelle descrizioni del sacco da parte
dei testimoni, gli stessi termini biblici sono stati ripre-
si inconsciamente, sottolineando la temerarietà senza
precedenti di un simile sacrilegio.
Più inatteso, ma rivelatore proprio per il suo stile, un
madrigale pubblicato in una raccolta del 1530, Madrigali
di diversi musici, svolge, su una musica celebre di Phi-
lippe Verdelot, una specie di idillio pastorale conven-
zionale:
Trist’Amarilli mia: donq’è pur vero
Che di Titiro tuo sì stranamente
Vada la gregge errante e lui dolente
Lassi ’l bel Tevere e Vaticano altiero7.
Bisogna intendere: la Chiesa abbandonata si lamen-
ta, il papa ha lasciato Roma. Siamo dunque nell’inver-
no 1527-28, quando Clemente VII, essendo «evaso» da
Castel Sant’Angelo, risiedeva a Orvieto in attesa del-
Storia dell’arte Einaudi 35
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
l’evacuazione definitiva della città, dove non rientrò
che in ottobre.
Su richiesta dell’arcivescovo Cornaro, l’Aretino scris-
se una canzone, Roma coda mundi8 per gratia de li Spa-
gnoli et dei Tedeschi, che emana indignazione o almeno
ne ha tutte le apparenze:
Il dí sexto di Maggio, ohimè l’orrendo
Giorno infelice, paventoso e crudo
Che fa scrivendo sbigotir gl’inchiostri.
In mezzo al fuoco e drento al ferro nudo,
In preda al temerario ardir tremendo
D’Alemagna e di Spagna, a gli occhi nostri
In man di cani e di spietati mostri
De l’universo la diletta donna
Trovasi inerme di consigli e d’armi9.
La raccolta di questi «lamenti» è abbondante; il loro
tono piuttosto monotono esprime un sentimento popo-
lare. Quest’accento accusatore per protestare contro
una sorte odiosa si ritroverà in poeti come l’Ariosto10.
Siamo un po’ meno bene informati sui canti trionfali
delle truppe tedesche e delle popolazioni guadagnate
alle idee luterane. Ne sono giunti a noi pochi brani; su
un foglio del maggio 1527 stampato a Venezia in tede-
sco, Neu Zeitünge von Rome, si legge ad esempio un
peana che evoca l’orribile donna dell’Apocalisse, la Pro-
stituta di Babilonia:
Sie ist gefallen, gefallen die grosse Stadt
Darin[ne] die rote Hure lang gesessen hat
Mit ihren Kelch der Gräulickeit**11.
Gli avvenimenti famosi hanno sempre avuto il loro
accompagnamento popolare. Ma con la presa e il sacco
di Roma nel maggio 1527, si possono seguire da vicino,
attraverso la stampa, le reazioni dell’opinione pubblica
Storia dell’arte Einaudi 36
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
all’interno del mondo cristiano. Da una trentina d’anni
e più, le guerre d’Italia avevano veduto diffondersi fogli
volanti con canards, cioè dicerie sensazionali general-
mente false, chiamati Flugblätter, che avevano un ruolo
del tutto nuovo nella vita pubblica12. Uno dei primissi-
mi benefici della stampa fu infatti la diffusione più rapi-
da e più ampia delle notizie, grazie al moltiplicarsi dei
bollettini d’informazione. Le statistiche sono eloquen-
ti; se ci fu a quel tempo un avvenimento sensazionale,
il gran numero dei pamphlets e fogli volanti, seguiti da
brevi relazioni, stampate in gran fretta, in numerose lin-
gue, dimostra chiaramente che fu quello del maggio
1527, che vide Roma, caput mundi, cadere nelle mani
degli imperiali. I particolari orribili e sbalorditivi del
sacco ne facevano naturalmente una eccellente materia
per questi primi prodotti della stampa che vuole far sen-
sazione.
La marcia su Roma.
In quella primavera del 1527, i protagonisti della
politica europea erano prigionieri di una situazione biz-
zarra e confusa. L’exercitus caesareus, l’armata imperia-
le, era stata posta sotto il comando di Carlo di Borbo-
ne, il peggior nemico di Francesco I; ma la sua marcia
attraverso l’Italia centrale non aveva più nulla a che
vedere con la guerra. Il colpo di audacia che sarebbe
stato la marcia su Roma non era ancora ineluttabile. La
nuova contesa fra il sacerdozio e l’Impero non implica-
va necessariamente tale azione, e neanche l’escludeva:
le disposizioni ufficiali non lo proibivano. Fu piuttosto
per una specie di accelerazione interna e di slittamento
aleatorio che le circostanze stesse del conflitto fra Cle-
mente VII e Carlo V volsero la questione in catastrofe14.
Era difficile immaginare situazione più cupa, più
Storia dell’arte Einaudi 37
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
bloccata. La brutale sconfitta dei francesi a Pavia il 24
febbraio 1525 aveva aperto un periodo d’incertezza e di
angoscia, dove tutto si svolgeva in un clima di minacce
eccessive, di annunzi e di profezie terribili. Dall’inter-
no della sua corte spagnola l’imperatore sembrava tene-
re in pugno tutta la situazione. Non sarebbe stato sag-
gio riconoscerlo a Roma mediante quell’accordo che il
clan «imperialista» della Curia sollecitava? Ma i due
poteri si trovarono presto in opposizione. Il conflitto
divenne manifesto per una questione di principio, con
la promulgazione del breve del 23 giugno 1526, che
ribadiva i diritti imprescrittibili del pontefice, e la rela-
tiva risposta, detta la «memoria di Granata», del 17 set-
tembre 1526. Vi è detto che il linguaggio del papa non
è cristiano e dovrà essere corretto dall’imperatore e
riformato dal Concilio. Il che era una minaccia quanto
mai grave. Questo pamphlet che dava il tono della poli-
tica imperiale fu stampato la primavera seguente ad
Alcalá, è ristampato in estate a Magonza e ad Anversa
sotto il titolo – e se ne capisce la ragione – Pro divo Caro-
lo apologetici libri duo15.
Non rimaneva quindi che manovrare per organizza-
re una guerra di liberazione contro il dominio spagnolo
e tedesco, paragonabile a quella che Giulio II aveva
condotto a buon fine quindici anni prima contro i bar-
bari di allora, ossia i francesi di Luigi XII. Quella che
fu chiamata la Lega di Cognac, per via del luogo in cui
fu firmato l’accordo, il 22 maggio 1526, da Clemente e
Francesco I, appena rientrato dalla prigionia, consolidò
questa volontà. L’avvenimento fu debitamente celebra-
to in Italia16. Avevano luogo movimenti di truppe, in
condizioni difficili, attraverso l’Italia del Nord; gli eser-
citi di entrambi gli avversari stentavano a saldarsi, tanto
erano eterocliti. L’exercitus caesareus si adunava lenta-
mente sotto la direzione di Carlo di Borbone; l’armata
della Lega raggruppava contingenti veneziani, che con-
Storia dell’arte Einaudi 38
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
tavano di essere rinforzati da soccorsi francesi; ma Lau-
trec, che avrebbe potuto, navigato com’era sulle cose
d’Italia, essere l’uomo della situazione, valicò il passo di
Susa soltanto all’inizio del mese d’agosto 152717.
L’unico generale capace di condurre quelle forze era
un Medici, cugino di Clemente, Giovanni dalle Bande
Nere. Fu ferito mortalmente nel novembre 1526, duran-
te un combattimento destinato a ostacolare il congiun-
gersi dei lanzichenecchi di Frundsberg, che scendevano
dai passi delle Alpi e Brescia verso la zona di Mantova,
con Carlo di Borbone che arrivava da Milano18. La
scomparsa del Gran Diavolo fu il primo colpo della
sorte. Quale sarebbe stato l’esito di una campagna che
avesse posto di fronte Borbone e Giovanni, i lanziche-
necchi e le «Bande nere»?
Questo fatale incidente lasciò all’exercitus caesareus la
facoltà di riunirsi, non senza fatica, d’altronde, in ragio-
ne delle difficoltà di approvvigionamento e del cattivo
tempo. La collaborazione di Alfonso d’Este, con il quale
il Borbone era in ottimi termini, gli fu utile, special-
mente grazie al ponte di barche19 preparato dai ferrare-
si per consentire il passaggio del Panaro e l’ingresso
negli stati pontifici20.
L’Italia imparava a conoscere un nuovo tipo di sol-
datesche: i lanzichenecchi, con i loro costumi a sbuffo,
le lance e i pennacchi simili a quelli della Guardia sviz-
zera. La loro brutalità in guerra superava perfino quel-
la dei francesi. L’armata imperiale si componeva di tre
gruppi principali che si urtavano di continuo: il primo,
una schiera di diecimila lanzichenecchi, guidati da un
Frundsberg, gigantesco e minaccioso, tutti luterani:
erano venuti dalla Germania per abolire il potere pon-
tificio sia spirituale sia temporale. Un bel capitano di
venticinque anni, il principe d’Orange, comandava la
cavalleria. Il secondo gruppo, un contingente spagnolo
di tercieros, arrivato passando da Genova, era nuovo
Storia dell’arte Einaudi 39
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
per l’Italia: forte di cinque-seimila uomini, veniva a
umiliare il principe della Chiesa che aveva osato resistere
a Carlo. Dal saccheggio di Prato nel 1513 se ne cono-
sceva l’arroganza e la spietatezza. Vi erano infine irre-
golari italiani di ogni risma, contingenti condotti da
capitani di ventura come Fabrizio Maramaldo, ma anche
da gentiluomini d’alto rango come Marco Antonio
Colonna e soprattutto Ferrante Gonzaga, figlio di Isa-
bella d’Este. Queste truppe vivevano esclusivamente di
saccheggi e estorsioni. Il Borbone non aveva abbastan-
za fondi per distribuire le paghe promesse21.
Come conseguenza di un concatenarsi incredibile di
illusioni, di lentezze, di tradimenti, dovuto al fatto che
ognuno degli alleati calcolava i propri interessi prima di
partecipare alla strategia comune, avvenne che al prin-
cipio del 1527 la strada di Roma fosse pressoché aperta
per quella massa turbolenta ed eteroclita. Negoziava,
manovrava, mentre continuava a slittare verso il Sud.
Dalle città che venivano risparmiate erano state otte-
nute condizioni sostanziali; così per Firenze e Bologna.
Ma, come dimostra chiaramente il movimento delle
truppe, Borbone non poteva tenere a freno lanziche-
necchi e spagnoli se non promettendo il bottino di
Roma; il saccheggio, normale obiettivo per i mercena-
ri, qui assumeva un’attrattiva fantastica. Il Borbone era
un giocatore formidabile – non disponendo ne d’am-
ministrazione organizzata ne d’artiglieria, sapeva che il
suo esercito non poteva condurre un assedio in piena
regola.
A Roma, Clemente, appena rimessosi dopo essere
sfuggito dalle mani dei Colonna, cercava l’accordo con
il viceré, Lannoy, che venne a Roma sotto una pioggia
torrenziale, che da tutti fu giudicata di malaugurio, il 25
marzo22; fiducioso o fingendo di esserlo, il papa firmò la
convenzione che, al prezzo di un enorme contributo,
doveva allontanare l’esercito. Borbone ne fu informato.
Storia dell’arte Einaudi 40
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
L’oro stava per scacciare la guerra. Clemente licenziò i
suoi mercenari, che pure alcune settimane prima aveva-
no difeso brillantemente Frosinone – a meno di cento
chilometri da Roma – contro gli spagnoli del viceré23. Il
Borbone, naturalmente, non rispettò l’accordo. Taglian-
do attraverso la Romagna, attraversò gli Appennini; a
fine aprile avanzava lungo il Tevere verso il caput mundi.
L’esercito della Lega seguiva a distanza, senza interve-
nire, l’esercito imperiale, di cui la marcia si fece repen-
tinamente rapidissima. Il 5 maggio, una domenica, gli
imperiali, arrivando dalla riva destra del Tevere, com-
paiono a nord e a ovest della città. Prendono posizione
intorno al Borgo. Il lunedì 6, prestissimo, all’alba, nella
fitta nebbia del mattino, fu dato l’assalto.
Le difese di Roma.
Roma era rimasta, come nel medioevo, una città
cosmopolita. Abbiamo la fortuna di possedere il censi-
mento generale che ebbe luogo durante l’inverno
1526-27 e che consegna il quadro quanto mai preciso
della popolazione romana alla vigilia della sciagura che
stava per sconvolgere ogni cosa24. Essa contava poco più
di 53 000 abitanti fissi; ammassati nei «rioni» del cen-
tro, il che da secoli provocava la emarginazione delle
comunità collinari e della zona periferica, rinserrata
dalle vecchie mura aureliane, ancora oggi in buono
stato25. Ma la popolazione non era preparata a reagire
energicamente. Circa un quarto di essa non era neppu-
re italiana e appena un sesto era di ceppo romano. «I
Romani formano una minoranza nella città; questa è il
rifugio di tutte le nazioni e un domicilio comune al
mondo intero», si legge in certe memorie che interessa-
no l’anno terribile26. Era vero, e le notizie così vaghe, i
pronostici così conturbanti degli ultimi mesi non pote-
Storia dell’arte Einaudi 41
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
vano che esasperare la disunione e lo smarrimento di
questa massa composita di chierici e di affaristi.
Molti romani, inoltre, desideravano più o meno aper-
tamente la venuta dell’esercito imperiale. Gli uni per
ostilità al pontefice, diventato impopolare a causa delle
tasse e della propaganda avversa, gli altri perché legati
ai Colonna, che avevano trasformato in una piazzafor-
te il Palazzo dei Santi Apostoli e le terme di Dioclezia-
no, dove avevano il loro quartier generale. I loro mes-
saggi si facevano insistenti. Scriverà più tardi Alberini,
«pareva a Borbone l’impresa difficile, la quale li Colon-
nesi li demostravano per molte ragioni più facile e riu-
scibile com’era»27.
Era il 4 maggio; il capitano francese si trovava allo-
ra a Ronciglione. Affrettò il passo. A Roma, all’ultimo
momento, si armava, nello smarrimento e nella confu-
sione, una milizia che fu affidata a Guido Rangoni. Poi-
ché gli imperiali comparivano ad ovest, la difesa si portò
alle mura del Borgo; si fece appena appena in tempo a
predisporre Castel Sant’Angelo, che avrebbe svolto un
ruolo d’eccezione durante tutto il dramma. Cellini, a
credergli, se ne incaricò28.
La fisionomia stessa della città non era ancora cam-
biata. Non esisteva nessuna delle grandi strade moder-
ne. La Via Giulia era soltanto un tracciato, poiché il
palazzo dei Tribunali, progettato da Bramante, e il
palazzo della Cancelleria Apostolica, che dovevano defi-
nirne la funzione e segnarne l’importanza, erano stati
definitivamente abbandonati sotto Leone X. Gli unici
itinerari praticabili da est a ovest attraversavano da un
lato Campo dei Fiori, intorno al quale erano sorti in gran
numero i palazzi connessi con la Cancelleria, e dall’al-
tro Piazza Navona, vicina alla zona di sviluppo favori-
ta dai fiorentini nel quartiere «Ponte» e più a nord. I
Medici erano insediati nella zona di Sant’Eustachio.
Giuliano da Sangallo, su richiesta di Leone, aveva con-
Storia dell’arte Einaudi 42
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
cepito il piano di un grande palazzo che dava su Piazza
Navona attraverso un portico. Ma Clemente non aveva
dato seguito al progetto di suo cugino. E non ebbe il
tempo di apportare mutamenti importanti alla situazio-
ne urbana.
Il sistema difensivo di Roma risaliva ad Aureliano
che, verso il 270, articolò il muro di cinta sul mausoleo
di Adriano, e al papa Leone IV che, verso l’850, aveva
circondato San Pietro e il Vaticano di fortificazioni che
portano il suo nome. Nella cronaca della processione di
consacrazione di quel Borgo leonino, si trova per la prima
volta il nome di Castel Sant’Angelo; il nome ricordava
l’apparizione dell’arcangelo Michele a Gregorio I nel
590, e uno dei miracoli a favore della città di San Pie-
tro di cui abbondano gli annali di Roma29. Il mausoleo,
divenuto la fortezza chiave del sistema difensivo roma-
no, assunse importanza ancora maggiore dopo i lavori
del secolo xv: vennero rialzate le mura sotto Nicola V
e rinforzata la cittadella sotto Alessandro VI. Il Borgo,
che era la città pontificia, fu collegato con la città anti-
ca attraverso il passaggio del Ponte Sant’Angelo, sorve-
gliato dall’enorme fortezza.
La città era quindi ragionevolmente difendibile. Il
Borgo si trovava dominato da Castel Sant’Angelo, dove
non mancava l’artiglieria. In ogni modo, il Tevere costi-
tuiva un fossato non facilmente valicabile. E se anche
fossero avvenute incursioni, la città stessa, molto aggro-
vigliata con passaggi stretti e viuzze tortuose, era piú che
adatta ai combattimenti di strada; questo almeno secon-
do le conversazioni tenute cinquant’anni prima dal re
Ferrante a Sisto IV e riferite da Infessura30. La popola-
zione si sentiva assolutamente sicura. Tutti dicevano:
due o tre giorni di uno scalpicciare inconcludente, l’ar-
tiglieria di Castel Sant’Angelo che tiene gli assalitori a
buona distanza, l’arrivo dell’esercito della Lega che i
cavalieri di Guido Rangoni lasciano intravedere piutto-
Storia dell’arte Einaudi 43
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
sto vicino..., e l’exercitus caesareus in stato di disorga-
nizzazione latente verosimilmente sarebbe insorto, poi
disperso saccheggiando la campagna, lasciando qualche
gruppo ostinato31. La sua riuscita ha segnato lo scacco
definitivo e spettacolare della tattica italiana, fondata da
piú di un secolo sulla manovra e sul temporeggiare.
Francesco Maria Della Rovere, fedele alla tradizione,
l’applicò. E questa fallì. Il 6 maggio il grosso delle trup-
pe della Lega era ancora a Cortona. Giunsero nei pres-
si di Roma soltanto il 21 maggio. Clemente negoziava
per guadagnare tempo. Bisognava accerchiare la città,
chiudere gli imperiali con le loro vittime? Nessuno ci
pensò, a quanto pare. Come neanche di entrare in
Roma. Il 2 giugno ci fu il ripiegamento generale. Guic-
ciardini poté dichiarare che questa lamentevole condot-
ta era avvenuta «per tradimento e per paura»32.
Il sacco.
Il colpo di fortuna che favorì ancora una volta gli
imperiali, il dono del cielo, furono le nebbie mattutine
che, parecchio dopo l’alba, ricopersero la zona di
Sant’Onofrio e di Santo Spirito dove si sferrava l’at-
tacco33. L’artiglieria di Castel Sant’Angelo, impotente,
rimase muta. Gli spagnoli tentarono la scalata verso la
Porta Torrione, i lanzichenecchi al bastione di Santo
Spirito. Ed è un punto dibattuto fra gli storici34 quale
contingente mise piede in Roma per primo. Quasi ad
accentuare il carattere fatidico, del tutto particolare,
dell’azione, il suo iniziatore, il grande capitano che
aveva condotto a marce forzate l’esercito imperiale sulla
Città Santa, fu ferito mortalmente nei pressi della Porta
Torrione nel momento in cui trascinava una seconda
ondata d’assalto, dopo l’insuccesso della prima35. Una
tradizione, che trae argomento dai rapporti accertati
Storia dell’arte Einaudi 44
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
fra Borbone e l’umanista Cornelio Agrippa, vuole che
costui abbia predetto al duca che «le mura di Roma
sarebbero cadute al primo assalto», omettendo di
aggiungere che anch’egli sarebbe caduto con esse36. Que-
sto personaggio poco comune ebbe perciò un inizio da
leggenda, la quale non poté svilupparsi, certo in ragio-
ne della trista rinomanza del sacco di Roma. Il Borbo-
ne ne avrebbe forse orientato diversamente il corso,
mediante qualche impresa personale mirabolante. A
Roma, nel secolo scorso, il babau «Barbone» spaventa-
va ancora i bambini37.
Pioveva. Gli spagnoli si accaniscono e finiscono per
scalare il muro all’angolo della Porta Torrione, i lanzi-
chenecchi a Santo Spirito. Continua la nebbia che pre-
clude la vista ai cannonieri. Al Borgo si impegnano duri
combattimenti. La Guardia svizzera resistette vicino
all’obelisco, e la palla porta ancora le tracce degli spari38
L’iscrizione lapidaria in Via dei Penitenzieri rievoca
il ricordo dell’orafo Bernardino Passeri che cadde dopo
avere strappato uno stendardo agli assalitori39. Erano
ormai giunti alle porte di San Pietro. Il papa pregava
nella sua cappella, «non possendo credere che coloro
entrassino», ha scritto Cellini. Fu una fuga precipitosa.
Il papa aveva appena abbandonato il luogo con quat-
tordici cardinali che già gli imperiali entravano nel Vati-
cano. Mancò poco – possiamo immaginarlo – ch’egli
non fosse catturato, perfino ucciso. Clemente si infilò
nel lungo corridoio alla sommità del muro di cinta; Paolo
Giovio ha raccontato che egli ricoprí il pontefice del suo
manto violetto da vescovo per evitare che fosse tradito
dalla veste bianca40. A Castel Sant’Angelo affluivano i
cardinali, gli ambasciatori, i funzionari della Curia.
Quando si abbassarono le saracinesche, c’erano nella
fortezza circa tremila persone. Sulla piattaforma supe-
riore stavano i due scultori responsabili dell’artiglieria:
«eravamo là, – ha scritto Raffaello da Montelupo nelle
Storia dell’arte Einaudi 45
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
sue memorie, – e guardavamo tutto ciò come se assi-
stessimo ad una festa»41. Poiché la nebbia si era final-
mente alzata, le colubrine potevano sparare, ma il Borgo
era già preso. Le truppe non potevano resistere sotto il
fuoco delle artiglierie; ma già avevano fatto manovra
verso Trastevere, che fu occupato senza difficoltà in
giornata.
Allora gli imperiali si spostarono e fecero pressione
sul Ponte San Sisto, che – lo si constata con stupore –
non era stato in precedenza né distrutto né fortificato42.
Un gruppo di cavalieri si sforzò di fermare l’attacco. Ma
invano. Non c’era più modo di ostacolare l’invasore. Il
panico era totale: non vi fu nessun combattimento di
strada. I luoghi di sosta erano così distribuiti: gli spa-
gnoli occupavano Piazza Navona, i lanzichenecchi
Campo dei Fiori, e il distaccamento italiano di Ferran-
te Gonzaga era schierato davanti a Castel Sant’Angelo43.
Già era stato dato il segnale del saccheggio. Dall’alto
della fortezza pontificia Cellini guardava: «Venuta la
notte e i nemici entrati in Roma, noi che eravamo nel
Castello, massimamente io, che sempre mi son diletta-
to vedere cose nuove, istavo considerando questa ine-
stimabile novità...»44. Così terminava questa giornata
vertiginosa con Castel Sant’Angelo di fronte a una città
abbandonata alla piú folle violenza.
L’armata imperiale aveva così ripetuto, trentatré anni
piú tardi, la «calata» dei francesi nel 1494. Ma la venu-
ta di Carlo VIII e del suo formidabile esercito era stata
solo una parata. Quando erano apparsi a Roma, Ales-
sandro VI aveva fatto un balzo in Castel Sant’Angelo e
se l’era cavata con la paura45. I francesi puntavano su
Napoli, non sullo stato romano. Questa volta l’armata
dell’imperatore lontano, che non era al comando e che
spesso piombava in strani silenzi, si buttò sulla città
dopo un concatenarsi quasi troppo favorevole di circo-
stanze, che non consente di stabilire le intenzioni e le
Storia dell’arte Einaudi 46
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
responsabilità. Questa conquista, molti politici poteva-
no desiderarla senza crederla attuabile; l’«aura», il pre-
stigio religioso della città, sembrava a tutti, tranne che
a dei luterani, proteggerla da una devastazione. Tutti si
trovavano trascinati ben oltre le normali aspettative.
La città non aveva dovuto sopportare un assedio, ma fu
oggetto di un saccheggio atroce, interminabile, comple-
to e insieme disordinato per l’assenza di un comando
forte46. Filiberto di Châlon, principe di Orange, era suc-
ceduto a Borbone, ma la sua autorità era continuamen-
te intaccata47. Infatti i contingenti non avevano all’ini-
zio lo stesso comportamento e capitò che, rivaleggiando
tra loro, rapinassero chi era già stato derubato. Ritorne-
remo piú avanti su aspetti particolari di tali aggressioni.
Le taglie furono così sistematiche che ne risultò un tra-
sferimento d’oro e di ricchezze piuttosto eccezionale.
Nessun assalto era concepibile contro Castel Sant’An-
gelo. Filiberto fece scavare trincee a nord della fortez-
za, per prevenire l’eventuale arrivo delle truppe della
Lega. Dentro le mura del castello i rifugiati erano trop-
po numerosi, ma non mancavano né le vettovaglie né le
munizioni. Il morale, tuttavia, era basso. Le discussio-
ni fra i principi della Chiesa continuavano, i negoziati
pure. L’imperatore, reagendo tardivamente alla notizia,
vide in questa vittoria inattesa la mano di Dio48. Ma non
era chiaro quale seguito politico darle. La lunga esita-
zione di Carlo fu fatale alla città. La situazione assurda
di un papa, accerchiato dalle milizie nemiche in quel
blocco fortificato, famoso in tutto l’universo cristiano,
si prolungava nell’incertezza. I lanzichenecchi luterani
si battevano per deporlo49. Fra tutte le possibilità che si
offrivano all’imperatore, la più semplice era convocare
un Concilio, seguendo il consiglio di Mercurino Gatti-
nara: «tamquam in pseudopontificem, scandalosum,
incorrigibilem ac universum christianae religionis per-
turbantem concilium», il che significava deporre il
Storia dell’arte Einaudi 47
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
papa50. Non si osò. Il temperamento di Carlo non era
all’altezza di quello di Borbone e delle truppe. E poi, era
difficile dichiarare che il papa, vinto e umiliato, turba-
va l’ordine della cristianità.
Prima conseguenza della notizia fu una rivoluzione a
Firenze. Si trattava di un violento ritorno antimediceo.
Nel momento in cui Roma, soggiogata, abbandonata,
ben presto esangue, avrebbe testimoniato per lungo
tempo il trionfo della potenza imperiale e la inettitudi-
ne della resistenza militare italiana, Firenze, con una sol-
levazione impressionante e decisamente disperata,
respingeva – il che era facile – l’autorità dei Medici, ma
al tempo stesso – il che era audace – veniva a sfidare la
potenza imperiale51. Questa nuova situazione, alla lunga,
non poteva far altro che costringere Clemente, in quan-
to Medici, a cercare presto o tardi l’appoggio dell’im-
peratore, che lo stava invece sfidando a Roma.
Se Firenze ritrovava il clima repubblicano, che le
valeva l’aiuto entusiasta di Michelangelo, Roma vedeva,
di disastro in disastro, andare in rovina la sua popola-
zione, il suo patrimonio, il suo prestigio. Si tenevano
conciliaboli per uscire da una situazione sconfortante e
vergognosa. Il 5 giugno fu stipulata una convenzione tra
Clemente e i capi dell’armata imperiale. Il papa e tredi-
ci cardinali restavano a Castel Sant’Angelo, dove sareb-
be stazionata una guarnigione imperiale, fino a che le
piazzeforti dello Stato pontificio fossero state tutte con-
segnate e versate le riparazioni di guerra.
I mesi estivi trascorsero fra i movimenti incontrolla-
ti delle truppe, perseguitate dalla carestia e dall’epide-
mia. Pompeo Colonna era rientrato a Roma, aveva vedu-
to quel «cadavere di città» e si era riconciliato piangente
con Clemente52. Il 28 novembre gli ostaggi lasciati in
custodia degli spagnoli evasero in circostanze abbastan-
za pittoresche: si arrampicarono su per i camini, si tra-
vestirono, ecc... Il cardinale Giovanni Del Monte, il
Storia dell’arte Einaudi 48
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
futuro Giulio III, era tra questi53. Finalmente, al prin-
cipio di dicembre, Clemente poté fuggire a Orvieto e
ritrovare in quella cittadella papale una parvenza di
autorità. Soltanto nel febbraio 1528 ebbe luogo l’eva-
cuazione definitiva di Roma. Gli imperiali, carichi d’oro
e di bottino, scesero su Napoli. Roma, in cui infieriva
oltre la malaria endemica, una specie di «peste»54, fu sol-
tanto a poco a poco rioccupata dagli abitanti dopo un
anno di disordini e di saccheggi. Clemente vi ritornò sol-
tanto in ottobre.
Nonostante l’immensa risonanza nella cristianità,
nonostante il suo eterno valore di simbolo, la presa di
Roma non aveva risolto niente sul piano militare. Nel
1528 la situazione era così mediocre per gl’imperiali che
questi erano tornati all’idea di tenere, in mancanza di
meglio, due solidi punti d’appoggio: Milano e Napoli.
Un esercito supplementare, comandato da Brunswick e
deciso a consolidare il centro di Lombardia, incontrò
una seria resistenza a Lodi, difesa da Gian Paolo Sfor-
za, e rientrò in Germania55. Finalmente i francesi si
misero in moto: l’esercito di Lautrec, cui si erano uniti
contingenti italiani delle «Bande Nere» guidate da Ora-
zio Baglioni, giunse davanti a Napoli; l’impressione che
l’ora della rivincita, per la Lega, fosse sul punto di scoc-
care, era tanto più verosimile in quanto la flotta di Doria
bloccava il porto56. L’abile resistenza spagnola, l’epide-
mia devastatrice, l’improvvisa defezione dell’ammira-
glio, e il ripiegare degli assediati su Aversa, capovolse-
ro definitivamente la situazione a favore degli imperia-
li, a cui non restava altro se non occuparsi di Firenze.
Il «Pageant» del 4 agosto.
Nell’enorme mole di relazioni storiche e opuscoli,
due formule si oppongono in modo del tutto evidente.
Storia dell’arte Einaudi 49
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Da parte imperiale, si hanno i Flugblätter del tipo della
Warhafftige und Kurtze Berichtung del 21 giugno, dove si
menzionano la morte di Borbone, la punizione del papa,
il fatto che i lanzichenecchi hanno gridato: «vivat
Luther Papa»; la versione in latino Direptio expugnatae
urbis Romae ab exercitu Caroli Quinti 1527, sarà pub-
blicata solo molto piú tardi, ma continuerà ad essere
letta ancora avanti nel xvii secolo57. Questa Direptio, che
insiste sulla meritata punizione della città pontificia, fu
pubblicata nel 1623 di seguito a uno dei pungenti dia-
loghi fra cortigiane dell’Aretino: tale associazione può
sembrare strana, ma conferma il carattere scandalistico
che fatalmente presero, in seguito, le rievocazioni degli
orrori del 1527: aneddoti su prostitute, orge e stupri, di
cui s’impadronirono allegramente autori licenziosi come
Brantôme58. In questo campo nessuno ha superato l’au-
tore della Lozana andaluza (la Bella Andalusa), che con-
clude la descrizione della dissolutezza romana con una
lettera in cui, «dopo avere veduto la distruzione di
Roma e la grande peste che seguí, ringrazia Dio di aver-
gli permesso di vedere il castigo da Lui inflitto, a buon
diritto, a un così grande popolo»59.
D’altro lato, il documento piú tipico e senza dubbio
il pamphlet intitolato In urbis Romae excidia deploratio
(Parigi 1528) dedicato a Luisa di Savoia, e datato ex
urbis cadavere tertio cal. Decembris, che e una requisito-
ria storica contro gli abomini del sacco. L’exercitus cae-
sareus ha sorpassato quanto si e visto di piú orribile in
tutti i paesi e in tutti i secoli, in «avidità, sfrontatez-
za, perfidia, lubricità e crudeltà». «L’obbrobrio per le
reliquie, la fiamma per le chiese, l’incesto per le reli-
giose, lo stupro per le matrone, la schiavitú per i gio-
vani» ecco quello che subirono i Romani60. Questo atto
d’accusa sarà ripreso dai francesi in piú d’una occasio-
ne. Un altro di quegli opuscoli, Historia expugnatae et
direptae urbis Romae per exercitum Caroli V Imp. di
Storia dell’arte Einaudi 50
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
César Grolier, fu pubblicato soltanto nel 1637. Natu-
ralmente, in seguito, apparvero numerose memorie e
racconti per confermare e completare quei testi scritti
da testimoni oculari e, in tal senso, sempre rivelatori,
se non veritieri61.
L’irrompere delle notizie da Roma incontrò dappri-
ma, negli ambienti ufficiali di Spagna, un silenzio che
possiamo definire imbarazzato. Ma misuriamo lo choc
psicologico attraverso due scritti, di tono aspro e appas-
sionato, che, databili alla fine del 1527 e all’inizio del
1528, diedero il tono all’inevitabile dibattito sulla giu-
stificazione del sacco. Carlo non si era pronunciato. I
suoi consiglieri presero pertanto l’iniziativa di parlare in
suo nome. Alfonso de Valdés, il segretario privato del-
l’imperatore, redasse il Dialogo de las cosas ocurridas en
Roma che giustifica il sacco di Roma come intervento
«provvidenziale»: tutta la responsabilità ricade sul pon-
tefice, che ha agito da capo di stato imprudente invece
di incarnare lo spirito evangelico. Per quanto terribili
siano gli orrori riferiti, bastano appena a cancellare gli
abomini della città corrotta: «ognuno degli orrori del
sacco e il castigo preciso, necessario, provvidenziale, di
una delle vergogne che insozzavano Roma». Interpre-
tazione da cui non si allontanerà, tranne qualche sfu-
matura, il partito imperiale62.
Ma il Dialogo di Valdés non fu diffuso immediata-
mente, perché non tutti l’approvavano. L’imperatore
stesso era esitante, in ragione della violenta protesta
sollevata dal nunzio apostolico, che Carlo rispettava
molto e che altri non era se non Baldassarre Castiglio-
ne, l’autore del Cortegiano63. La confutazione del Casti-
glione è un’aspra accusa, piena di nobile indignazione.
Egli vede nelle spiegazioni tendenziose del Dialogo un
affronto intellettuale e morale che viene a completare
l’umiliazione sanguinosa del sacco. Nessuna delle debo-
lezze, delle corruzioni, perfino delle sozzure della Roma
Storia dell’arte Einaudi 51
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
moderna è negata: Castiglione risponde soltanto che la
degradazione del Seggio Romano non può giustificare un
attentato senza precedenti, scusare un simile sacrilegio.
Egli attribuisce al dramma un significato che va ben al
di là di quello puramente politico; accetterebbe la
denuncia globale di una società indegna, ma colloca l’i-
stituzione, i simboli, la tradizione al di sopra dei loro
miserabili servitori; restituisce a Roma il suo significa-
to unico, al quale non deve attentare nessuna nazione
cristiana; ricorda che Roma, consacrata dalla Chiesa e
dalla storia, non può in nessun caso subire abomini inno-
minabili, sotto il pretesto di rigenerarla. È facile pensa-
re che un discorso talmente grave, proveniente da un
personaggio, un caballero, che Carlo stimava, non faces-
se che accrescere la perplessità del monarca.
Egli si dimostrò, in seguito, desideroso di cancellare
il ricordo del sacco.
La presa di Roma aveva avuto una ripercussione sini-
stra in Inghilterra. Un po’ sul medesimo tono del Casti-
glione, Thomas More in A dialogue concernynge Here-
syes, del 1528, introdusse un lungo ragionamento sugli
orrori i cui responsabili erano «those uplandish Luthe-
rans»64. Le vicende del paese sembravano essere domi-
nate dal problema del divorzio di Enrico VIII, oppure,
in altre parole, dalla sua passione per Anna Bolena. Il
che, fra l’altro, portava il cardinale Wolsey a favorire
un’alleanza contro l’imperatore e a ricercare l’appoggio
del papa. Il crollo di Roma e la prigionia di Clemente fu
perciò un serio contrattempo, ma le circostanze per-
mettevano, almeno, al cardinale di proporsi come vica-
rio-generale e di risuscitare vecchie ambizioni che risa-
livano al conclave del 152365.
Per tutte queste ragioni l’Inghilterra lanciò minacce,
reclami, richieste per la liberazione del pontefice; fu
perfino messa in ridicolo l’armata imperiale: durante un
banchetto Wolsey fece recitare a questo scopo il Phor-
Storia dell’arte Einaudi 52
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
mio di Terenzio66. Il cardinale fu inviato in Francia per
firmare trattati di alleanza contro l’imperatore; tale ceri-
monia ebbe luogo il 18 agosto ad Amiens. Wolsey era
venuto in gran pompa; fu ricevuto con magnificenza. Fu
allora che il problema del momento venne reso pubbli-
co in Francia, e in modi propri al Rinascimento: con una
serie di quadri viventi, trasposizione simbolica e mima-
ta dell’avvenimento. Questo pageant o, come è stato
chiamato, «a sort of display piece» – una specie di sag-
gio dimostrativo – ebbe luogo meno di tre mesi dopo il
sacco. Il cardinale Jean de Lorraine aspettava Wolsey a
Calais. Il 22 luglio il legato fece il suo ingresso a Bou-
logne. Ne esiste un resoconto, dovuto al contemporaneo
viaggiatore britannico Edward Hall:
At the gate was made a pageant in which was a nun cal-
led Holy Church and three Spaniards and three Almaynes
had her violated and a Cardinal her rescued and set her up
of new again.
Another pageant was a Cardinal giving a pax to the king
of England and the French king in token of peace.
Another pageant was the Pope lying under and the
Emperor sitting in his majesty and a Cardinal poulled down
the Emperor and set up the Pope67.
L’itinerario era dunque accompagnato da quadri
viventi, non difficili da interpretare: per tre volte un car-
dinale – riconosciuto da tutti – salvava la monaca chia-
mata Santa Chiesa, riavvicinava Francia e Inghilterra e
rovesciava l’imperatore, che stava calpestando il papa.
Come succedeva per questo genere di spettacoli, il
pageant conteneva un programma che aveva la funzione
di richiamare l’illustre ospite al suo ruolo. C’è però da
credere che il cardinale non fosse molto attento, perché,
come scrisse al suo re, il suo mulo «era tanto spaventa-
to dal rumore degli spari» che l’unica cosa che egli poté
Storia dell’arte Einaudi 53
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
fare fu di stare a cavalcioni. Ma ne colse il significato
generale: tutto trattava della «pace universale e della
restituzione del papa e della Santa Sede apostolica alla
loro dignità primitiva»68.
Analoghi festeggiamenti ebbero luogo ad Abbeville.
Ma lo sfoggio maggiore fu ad Amiens, dove il 4 agosto
il re in persona aspettava il cardinale. Si ebbero cinque
«teatri», ossia quadri viventi, che costituivano un’ana-
lisi politica e una dimostrazione per simboli. Non è stato
trovato neppure un disegno o incisione dell’evento, ma
ne esiste una descrizione dell’epoca, completata dai ver-
bali del consiglio della città che aveva sostenuto le spese
dello spettacolo.
Il primo quadro raffigurava un tempio i cui due muri,
Francia e Inghilterra, avevano bisogno di una pietra,
lapis angularis, per congiungersi. È facile indovinare chi
reggeva questa pietra. Nel secondo pageant si vedeva l’i-
dolo di Nabuchodonosor schiacciato da una pietra mira-
colosa che poneva fine alla guerra. Questa pietra era
ancora Wolsey. Il terzo era la navicula Petri che sobbal-
zava sulle onde69; San Pietro invocava aiuto. Due per-
sonaggi, l’uno con l’arme di Francia, l’altro con l’arme
di Inghilterra, alzavano la spada. Dietro tutto questo, lo
scenario di una città: Roma o Gerusalemme, dice curio-
samente il testo. E un’iscrizione che minaccia della col-
lera divina i principi che attaccano la dimora di Cristo,
Christiferam domum70. Nel quarto quadro, due allegorie:
la Santa Chiesa e la Pace riconciliate da un angelo rosso:
Wolsey. Infine uno strano spettacolo in cui Pallade,
grazie a Wolsey, guida il mondo ai saturnia regna, all’età
dell’oro. Sydney Anglo, che ha attratto l’attenzione su
questa serie di quadri viventi, cita la conclusione ironi-
ca di Edward Hall: «Quando i saggi videro quel pageant
sorrisero e dissero: “Il re di Francia può ben sentirsi
lusingato, perché fu difficile, per un solo cardinale, scon-
figgere colui che abbatte il capo di tutti i cardinali”».
Storia dell’arte Einaudi 54
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Noi sentiamo, come quel signore, quanto avevano di
artificioso questi spettacoli. Ma siamo colpiti nel vede-
re come gli avvenimenti di Roma, grazie alla diffusione
rapida dei pamphlets, si traducessero alla fine in imma-
gini simboliche. Niente è più familiare della navicula
Petri, questo mosaico che Giotto aveva collocato sulla
facciata di San Pietro, citato da tutti quanti e fatto
conoscere attraverso innumerevoli dipinti e disegni. Il
dramma del 1527, riecheggiato da tutto quel che pos-
siamo chiamare la stampa, è stato anche tradotto in
immagini viventi quasi subito, e queste immagini erano
figure allegoriche.
«Imago Urbis».
Se non fosse per quella specie di censura, consapevole
o inconsapevole, che si è esercitata, a nostro avviso, nei
riguardi del sacco e del suo responsabile, Carlo di Bor-
bone, non si capirebbe perché nessuna incisione o dipin-
to contemporaneo all’avvenimento ci siano noti. Sareb-
be stato facile trar partito, ad esempio, dalla battaglia
di animali allegorici descritta piú tardi da Maurice Sceve
in un endecasillabo bello ma oscuro:
Il cervo volante alle strida dello struzzo
Fuori della sua tana smarrito volò via;
Sul sommo dell’Europa si appollaia,
credendo là trovare sicurezza e riposo,
Luogo sacro e santo, da lui violato,
con mano a tutti profanamente notoria...71.
La stampa di Schön, datata al 1528, che in un lungo
fregio evoca la lotta tra papisti e riformati sotto forma
di una battaglia fra due eserciti schierati, è molto vero-
similmente una eco delle vicissitudini romane. Il tema
Storia dell’arte Einaudi 55
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
di un antagonismo, che si esprime con la lotta di due
principî opposti, dominò l’enorme sviluppo della stam-
pa popolare durante la Riforma. Nella stampa di Schön
il soggetto è militare; i lanzichenecchi sono in eviden-
za72, l’accento è posto sulla battaglia. Tuttavia, nulla
indica che si tratti dell’esercito di Borbone. Su una
stampa dello stesso autore, datata anch’essa 1528, e di
cui tratteremo piú avanti, un soldataccio si prepara a col-
pire un papa. Ma nulla permette di identificare né l’uno
né l’altro.
Per quanto ne sappiamo, non esiste alcuna rappre-
sentazione contemporanea al sacco di Roma, e non ve
ne furono se non molto tempo dopo73. È stato segnala-
to un pannello in una collezione privata, recante la firma
fittizia di Brueghel, che mostra un panorama di Roma,
in cui il riferimento a Borbo e caput mundi permette di
identificare la scena. La veduta è presa da est; la topo-
grafia urbana è precisata con l’aiuto di piccole iscrizio-
ni più o meno errate; minuscole scene di violenza e alcu-
ne installazioni militari sono state inserite per evocare
il sacco del 152774.
Tuttavia, si tratta soltanto di un piccolo rimaneggia-
mento di modelli apparsi alla fine del secolo xv, di cui
il più celebre fu quello del Supplementum chronicarum
orbis di fra Jacopo Filippo Foresti da Bergamo75. Su que-
ste vedute di Roma – che, in parte a causa degli avve-
nimenti del 1527, non sono state sostituite prima del
1550 – si può nettamente distinguere, a destra, il quar-
tiere del Borgo nuovo con la massiccia fortificazione di
Castel Sant’Angelo, la piramide detta tomba di Romo-
lo, la piazza e la scala di San Pietro, il Belvedere; nella
zona centrale, la più popolata, i loci christiani si mesco-
lano con i monumenti pagani che costituivano i riferi-
menti tradizionali dell’imago urbis. Queste «vedute»
antiche non portano tracce delle trasformazioni realiz-
zate al tempo di papa Borgia: la merlatura di Castel
Storia dell’arte Einaudi 56
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Sant’Angelo e il lungo corridoio costruito sul muro che
conduce al Vaticano (1492-94), la grossa torre, il Tor-
rione, innalzato davanti al castello per controllare il
ponte (1445); l’angelo che sormontava la fortezza, a
ricordo della visione di Gregorio Magno, era stato
abbattuto dalla folgore nel 1497 e non ancora sostitui-
to. Verso il 1505-1506, Giulio II aveva fatto aggiunge-
re la Loggetta, che corre lungo gli appartamenti costrui-
ti ai piani superiori. La meta Romuli era stata distrutta
nel 1499, e un’aggiunta tipica del paesaggio urbano era
stata, a partire dal 1507, la costruzione degli enormi
pilastri di Bramante al posto del coro del primitivo San
Pietro. Queste varie modificazioni non figurano evi-
dentemente nella pianta del 1490 né nei panorami basa-
ti su di essa76. È questo il caso del piccolo pannello cita-
to sopra. Una veduta di Roma nel corso dei cinque o
dieci anni che seguono il sacco sarebbe preziosa per
localizzare le distruzioni menzionate nei Flugblätter, e in
particolare gli incendi. Invece è come se in Italia ci fosse
stato un rifiuto di rappresentare l’avvenimento, una
sorta di censura istintiva. Quando si rese necessario
celebrare le grandi gesta dell’Impero – l’incoronazione
di Bologna nel 1530, l’ingresso dell’imperatore a Roma
nel 1536, gli accordi pacifici ottenuti dalla diplomazia
di Paolo III – non era più questione di rappresentare la
conquista e il saccheggio della Città Eterna, ma soltan-
to di mettere in evidenza l’incontro del papa e dell’im-
peratore77.
Le cose andavano diversamente nei paesi dell’Impe-
ro. Verso il 1530 erano di moda i quadri di battaglia
tratti dalla storia greca e romana. Siccome le truppe
rappresentate da Burgkmair e Feselein sono vestite ed
equipaggiate alla moderna, dobbiamo forse vedere in
queste composizioni un’allusione indiretta alle campagne
d’Italia78. Ma i riferimenti espliciti sono venuti piú tardi.
Uno dei pittori-storiografi di Carlo V, Jan Cornelius
Storia dell’arte Einaudi 57
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Vermeyen, disegnò il ciclo di Tunisi che, tradotto in
arazzo, divenne presto celebre79. Una serie di quadri,
probabilmente cartoni per arazzo, furono segnalati alla
fine del secolo scorso, ma e stato impossibile ritrovarne
la traccia80. Questa serie pare comprendesse: Pavia,
«captio Regis Fra.», 1525; il sacco: «Roma capta»,
1527; La Goletta81: «Tannetum expugnatum», 1535.
Immaginiamo abbastanza bene quel che dovettero esse-
re quelle composizioni brulicanti di particolari militari,
sparpagliati su uno sfondo topografico. Il repertorio
delle battaglie imperiali si è arricchito considerevol-
mente intorno al 1540; ma la grande Battaglia dello
Schiavone e la facciata dipinta da Girolamo da Carpi
riguardano sempre Tunisi82.
Direi che quasi tardivamente, al momento del melan-
conico declino dell’imperatore, vi fu una grande serie di
incisioni pubblicate dall’editore Hieronymus Cock su
disegni di Heemskerck. Apparve nel 1555 sotto il tito-
lo generale Divi Caroli V Imp. opt. max. victoriae83. Dodi-
ci tavole illustrano le vittorie dell’imperatore sulla Fran-
cia, sui principi tedeschi, sui turchi, e il conseguente
dominio su tutti i continenti. La più sorprendente
mostra l’imperatore padrone dei re. Due tavole sono
consacrate alle vicende del 1527: la morte di Borbone,
ossia la vittoria militare, e l’assedio di Castel Sant’An-
gelo, ossia, attraverso il sequestro e poi la capitolazione
di Clemente, la vittoria politica. Queste tavole ci
mostrano come trent’anni dopo, in un momento in cui
il dominio imperiale era diventato irremovibile, l’episo-
dio piuttosto imbarazzante del 1527 venisse finalmen-
te rappresentato. Sono stampe molto ben fatte, esegui-
te da qualcuno che conosceva bene la città di Roma.
Heemskerck vi aveva soggiornato e lavorato dal 1532 al
1535, forse anzi fino al 153684.
La prima stampa porta la dicitura «Borbone occiso,
Romana in moenia miles Caesareus ruit, et miserandam
Storia dell’arte Einaudi 58
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
diripit urbem»85, che si riferisce al tempo stesso all’as-
salto e alla morte dell’eroe. Però, per avere una vedu-
ta corretta, il foglio deve essere rovesciato. Difatti la
veduta nello sfondo dovrebbe mostrare San Pietro a
sinistra – dove il timpano della nuova basilica è chia-
ramente indicato – e a destra l’ansa del Tevere, e Castel
Sant’Angelo. Su uno sfondo realistico c’è una raffigu-
razione simbolica: l’eroe è vestito da dux antico: era
perito nell’assalto della Porta Torrione, indicata da
un’enorme torre fortificata posta in evidenza nel dise-
gno. La propaganda imperiale restava fedele alla memo-
ria di Borbone.
Dell’altra stampa, che porta la didascalia «capta urbe,
Adriani praecelsa in mole tenetur obsessus Clemens,
multo tandem aere redemptus»86, esiste un disegno ad
Amburgo. Questa volta, il disegno è capovolto e la stam-
pa e esatta87. Dal lato della statua di San Pietro, a sini-
stra, c’è la basilica vaticana con il campanile, le Logge
vaticane e anche la galleria del Belvedere; l’enorme for-
tezza di fronte, e la grossa torre di Alessandro VI che
blocca il ponte. Il muro è siglato con l’arme di Clemen-
te VII: le palle medicee. Il papa appare alla loggia. Si
pensa alla canzone spagnola:
Triste era il Santo Padre
Nel suo Castel Sant’Angelo.
Le truppe sorvegliano l’ingresso dal lato della città,
mentre cannoni e archibugi sono puntati sulla fortezza,
e due lanzichenecchi giganti, con la loro pesante spada,
ricordano a destra il vigoroso Frundsberg e i suoi mer-
cenari. Un particolare, tuttavia, trattiene l’attenzione: le
due statue gigantesche di San Pietro e di San Paolo da
cui Heemskerck ha saputo trarre mirabilmente partito.
Di fatto, come possiamo facilmente accertare sulle
vedute di Roma del 1490, all’imbocco orientale del
Storia dell’arte Einaudi 59
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Ponte Sant’Angelo c’erano due cappellette, costruite in
seguito a una di quelle disgrazie che talvolta mettevano
a lutto i pellegrini: il crollo del ponte nel 1450. Le trup-
pe di Ferrante Gonzaga, che tenevano quel settore nel
maggio 1527, avevano utilizzato le due cappelle come
riparo. Al ritorno del papa a Roma, furono distrutte e
sostituite dalle due statue, si vedrà più avanti con quale
intenzione88. Venuto a Roma nel 1532, Heemskerck le
aveva vedute al loro posto. Ne ha tratto partito per
introdurre una dimensione simbolica in una scena che
rischiava di sembrare bizzarra e penosa. Mentre un aral-
do avanza per portare un messaggio a Clemente, San
Pietro, stringendo quasi con rabbia le sue grosse chiavi,
volge il capo verso l’immane lanzichenecco porta-sten-
dardo, che, in realtà, sembra interpellarlo con insolen-
za. L’incredibile situazione del giugno 1527 e così rias-
sunta nei due dialoghi muti che s’incrociano: quello del-
l’araldo con il papa, quello del lanzichenecco con San
Pietro. Il papa sembra invulnerabile, Pietro e corruc-
ciato. Attraverso il dramma, traspare l’ordine delle
cose89.
* [«Triste era il Santo Padre | Pieno di angoscia e di pena | Nel
suo castel Sant’Angelo | In cima a una torretta | La testa senza tiara
| Sudata e sporca di polvere, |Vedeva la regina del mondo | In mani
straniere»].
1
Romance del Saco de Roma, por las tropas del condestable de Bor-
bon, a cura di A. Duran, in Biblioteca de autores espanoles, XVI: Roman-
cero general, vol. II, Madrid 1861, n. 1155, p. 162, Cf. «Triste estaba
el Padre Santo | Lleno de angustia y de pena | En Sant’Angel, su castil-
lo, | De pechos sobre una almena, | La cabeza sin tiara, | De sudor y
polvo Ilena, | Viendo a la reina del mundo | En poder de gente ajena.
| Los tan famosos romanos, | Puestos so yugo y melena; | Los cardina-
les atados. | Los obispos en cadena; | Las reliquias de los santos | Sem-
bradas por el arena; | El vestimento de Cristo, | El pié de la Madale-
na, | El prepucio y Vera Cruz | Hallada por Santa Elena, | Las iglesias
violadas, | Sin dejar cruz; ni patena. | El clamor de las matronas | Los
Storia dell’arte Einaudi 60
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
siete montes atruena | Viendo sus hijos vendidos, | Sus hijas en mala
estrena | Consules y senadores | De quejas hacen su cena, | Por faltal-
les un Horacio, | Como en tiempo de Prosena. | La gran soberbia de
Roma | Hora España la refrena: | Por la culpa del pastor | El ganado
se condena. | Agora pagan los triunfos | De Venecia y Cartagena, | Pues
la nave de Sant Pedro | Quebrada Ileva la entena, | El gobernalle qui-
tado, | La aguja se desgobierna: | Gran agua coge la bomba, | Menester
tiene carena, | Por la culpa del piloto | Que la rige y la gobierna. | Oh
Papa, que en los Clementes, | Tienes la silla suprema, | Mira que tu
potestad | Es transitoria y terrena! | Tu mismo fuiste el cuchillo | Para
cortarte tu vena. | Oh fundador de los cielos, | Dadnos paz, pues es tan
buena! | Que si falta a las cristianos, | Huelga la gente agarena, | Y crece
la secta mala | Come abejas en colmena. | La justicia es ya perdida; |
Virtud duerme a la serena; | Quien mas puede come al otro, | Como en
la mar la ballena: | Fuerza reina, fuerza vale, | Dice al fin mi cantile-
na».
2
Per le canzoni in Francia, cfr. e. picot, Chants historiques français
du XVIe siècle: Règnes de Louis XII et François Iee, Paris 1903.
3
a. medin e l. frati, Lamenti storici dei secoli XIV, XV e XVI, vol.
III, Bologna 189o. Un altro lamento pone direttamente in causa Fran-
cesco I, a cui s’ingiunge di riparare i torti causati da Carlo V: «Italia
afflitta, nuda e miseranda | Che or de’ principi suoi stanca si lagna, |
A te, Francesco, questa carta manda» (pp. 405 sgg.).
4
La presa di Roma, a cura di F. Mango, Bologna 1886, citato da d.
hay, Italy and Barbarian Europe, in Italian Renaissance Studies, miscel-
lanee C. Ady, a cura di E. F. Jacob, London 1960.
5
Sonetto anonimo, trascritto da Pandolfo Nassino, «Memorie Mss.
Bresciane», Cod. C.I., 15, Brescia, Bibl. Quiriniana. Pubblicato da g.
milanesi, Il Sacco di Roma del 15-27. Narrazioni di contemporanei,
Firenze 1867, p. lxii: «Passio Domini septimi Clementis | Secundum
Marcum. – Papa dixit: Hebraei, | Quem queritis? – Responderunt ei:
| Papam Clementem cum suis armentis. | – Ego sum: Sinite, sine tor-
mentis. | – Tunc dixerunt: sunt omnes mortis rei. | Et ligaverunt eum
Pharisaci, | Ad Caesarem trahentes caput gentis. | – Dixit Caesar: Tu
es rex dericorum. | – Respondit papa Clemens: Tu dixisti. | – Bla-
sphemavit; et eum percusserunt. | Papa stabat in medio Ispanorum. |
Disse il Colonna: Amice, ad quid venisti? | Et super vestem suam sor-
tem dederunt. | – Sitio, disse; et acetum gustavit. | Consumatum Cle-
mentem expiravit».
6
s. lowinski, A Newly Discovered Sixteenth Century Motet Manu-
script at the Biblioteca Vallicelliana in Rome, in «Journal of American
Musicological Society», 3 (1950).
Questa raccolta contiene un mottetto politico dello stesso Festa, di
sapore «savonaroliano», che deve risalire al periodo in cui Firenze,
Storia dell’arte Einaudi 61
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
sotto Capponi, respinse la «legge dei Medici»; e un altro mottetto che
celebra l’intesa ritrovata fra il papa e l’imperatore alla fine del 1529.
Cfr. cap. vi.
7
a. einstein, The Italian Madrigal, Princeton 1949; d. harsan, The
Sack of Rome Set to Music, in «Renaissance Quarterly», 23 (1970), pp.
412 sgg.
8
[Gioco di parole sull’epiteto tradizionale di Roma, «caput
mundi»].
9
Dal ms della Biblioteca Marciana, pubblicato da luzio, Pietro Are-
tino cit., pp. 64 sgg.
10
Ariosto, strettamente legato alla corte «imperialista» di Ferrara,
aveva introdotto nell’Orlando furioso una profezia rivelatrice (cfr. cap.
ii); aggiunse una deplorazione del sacco nel 1532.
** [«È, caduta, caduta, la grande città dove la rossa Puttana è risie-
duta a lungo con il suo calice di abominio»].
11
h. schulz, Der Sacco di Roma. Karls V. Truppen in Rom.
1527-1528, Halle 1894, p. 36.
12
Sui Flugblätter, oltre le opere antiche di e. weller, Die ersten deut-
schen Zeitungen (1505-1599), Tübingen 1872; e di k. schottenloher,
Flugblatt und Zeitung, Berlin 1922; si veda anche h. washer, Das deut-
sche illustrierte Flugblatt, Dresden 1955; e i. neumeister, Flugblätter der
Reformation und des Bauernkrieges. 50 Blätter aus der Sammlung des Sch-
lossmus., Leipzig 1976. Una Bibliographie der deutschen und lateinischen
Flugschriften des frühen 16. Jahrhunderts, su microfilm, è in corso di pub-
blicazione all’Università di Tubinga sotto la direzione di H-J. Köhler,
H. Hebenstreit-Wilfert e C. Weismann.
Gli avvisi del mondo, fogli d’informazione preziosi per la seconda
metà del secolo (cfr. r. ancel, Etude critique sur quelques recueils
d’«avvisi», in «Mélanges d’Archéologie et d’Histoire», 1908), non
contano per gli anni 1520 sgg., tranne, naturalmente, le relazioni incor-
porate nel Diario di Sanuto.
13
Il foglio piú diffuso fu la Warhafftige eine kurtze Berichtung inn
der Summa, redatta dopo il 22 giugno e diffusa durante l’estate o l’au-
tunno. Cfr. schulz, Der Sacco cit., pp. 44 sgg., e cap. iii.
14
La migliore narrazione rimane quella di Gregorovius, seguito da
Pastor; c. ravioli, La guerra di sette anni sotto Clemente VII... dall’an-
no MDXXIII al MDXXXI, sui documenti ufficiali, in «Archivio della Reale
Società Romana di storia Patria», 6 (1883), pp. 303 sgg. Recentemente,
cfr. hook, The Sack of Rome cit. Non abbiamo potuto consultare u.
boncompagni ludovisi, Il Sacco di Roma, Albano 1929.
15
Analisi in von pastor, Storia dei papi cit., vol. iv, parte Il, libro
III, p. 205 e p. 229 Sgg. Il testo era dovuto ad Alfonso de Valdés, che
sarà l’autore del Dialogo sugli avvenimenti di Roma post factum, cfr.
infra.
Storia dell’arte Einaudi 62
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
16
La conclusione ufficiale della Lega Santa del 1526 fu accompa-
gnata da cerimonie che ebbero a Venezia un andamento sontuoso:
processioni con costumi, figure allegoriche, carri di «quadri viventi»,
ecc. Cfr. sanuto, Diarii cit., XLIII, coll. 42 sgg. per l’8 luglio 1526,
e Calendar of State Papers, Venice, vol. III: 1520-26, London 1869, n.
1343, p. 579.
Si noterà nella tribuna dei confratelli di Santo Stefano, «una dami-
gella in piedi, con in mano un globo, una ruota nell’altra»: Fortuna (la
sorte), e sul palco della Scuola di San Marco, una nave allegorica da
accostare a uno dei simboli analoghi studiati nel cap. ii, e nel pageant
di Amiens.
17
hook, The Sack of Rome cit., p. 228.
18
Su Giovanni dalle Bande Nere, esiste un capitolo di g. g. rossi,
Vita di Giovanni de’ Medici, nella raccolta Vite dei Sforzeschi, Milano
1853, pp. 195-245, e una narrazione di p. gauthiez, Jean des Bandes
Noires, Paris 1901. Sui movimenti di massa e la guerra per scaramuc-
ce proprie del periodo, cfr. p. pieri, Il Rinascimento e la crisi militare
italiana, Torino 1952, pp. 550 sgg e 574 sgg. Quest’autore non sem-
bra considerare Giovanni uno stratega molto originale, ma gli attri-
buisce una decisa attitudine al comando. Sulle circostanze e le conse-
guenze della ferita mortale di Giovanni, cfr. p. gauthiez, Nuovi docu-
menti intorno a Giovanni de’ Medici detto delle Bande Nere, in «Archi-
vio Storico Italiano», 1902-903. Sulla statua in onore del condottiero
eretta in piazza San Lorenzo, cfr. Epilogo.
19
È difficile mettere in relazione a questi avvenimenti il ritratto del
seguace di Bacco (coll. priv.) che è apparso con un’attribuzione discu-
tibile a Dosso all’esposizione di pittura ferrarese Esposizione della pit-
tura ferrarese del Rinascimento, Ferrara 1933, n. 201. Un’iscrizione sul-
l’alto del quadro porta: «Alfonso Duca Terzo con il fiasco e il bicchiere
conservò il ducato di Ferrara e ricuperò quello di Modena e Reggio
qua[n]do alli [=al dí] vi di marzo s’aboccò con Borbone nel Finale». Vi
fu infatti un accordo fra il Duca e Borbone nel momento in cui questi
ebbe bisogno di passare i fiumi, e Modena e Reggio erano l’oggetto di
una vecchia contestazione fra Roma e Ferrara (cfr. gregorovius, Sto-
ria della città di Roma cit., e von pastor, Storia dei papi cit., vol. IV,
parte II, libro III, pp. 234-35). Ma le ragioni per le quali quest’ope-
razione, che fu di grande aiuto all’armata di Carlo V, è stata evocata
al di sopra di un ritratto «bacchico» di Alfonso d’Este, non sono per
noi cosí chiare come sembrano esserlo per e. wind, Bellini’s «Feast of
the Gods». A study in Venetian Humanism, Cambridge (Mass.) 1948,
p. 40. Per di piú, l’identificazione del ritratto è sicura? L’iscrizione è
originale?
20
hook, The Sack ol Rome cit., pp. 127 sgg.
21
pieri, Il Rinascimento cit. cfr. cap. iv.
Storia dell’arte Einaudi 63
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
22
A proposito della visita di Lannoy a Roma il 25 marzo 1527, Mar-
cello Alberini scrive: «e fu ben quel di presago delle future calamitati
nostre, che me ricordo vederlo venire a Santo Apostolo, che era il
tempo serenissimo et in un punto cader tanta e cosí subita pioggia che
in la via Lata i cavalli nuotavano nell’acqua fino alli petti». Cfr. d.
orano, I ricordi di Marcello Alberini, vol. I (l’unico uscito), in Il Sacco
di Roma del 1527, Roma 1901, p. 230.
23
Paolo Giovio descrisse questo fatto d’armi con entusiasmo in una
lettera del 14 febbraio a D. Contarini, ricopiata da sanuto, Diarii cit.,
XLIV, 1896, col. 99. cfr. anche g. g. ferrero, Politica e vita morale
del Cinquecento nelle lettere di Paolo Giovio, Torino 1940, p. 68.
24
d. gnoli, «Descriptio Urbis», o censimento della popolazione di
Roma avanti il sacco borbonico, in «Archivio, della Reale Società Roma-
na di Storia Patria», A (1894), pp. 375 sgg.; delumeau, La vie éco-
nomique cit., Paris 1957, vol. I.
25
Sulle fortificazioni di Roma, cfr. l. cassanelli, g. delfini e d.
fonti, Le mura di Roma. L’architettura militare nella storia urbana,
Roma 1974.
26
marcello alberini, Ricordi cit., p. 238.
27
Ibid., p. 229.
28
cellini, La vita cit., p. 78.
29
Su Castel Sant’Angelo e il miracolo dell’angelo cfr. e. rodoca-
nachi, Le Château Saint-Ange, Paris 1909; m. borgatti, Castel Sant’An-
gelo in Roma, Roma 1931; cassanelli, delfini e fonti, Le mura di
Roma cit., pp. 63 sgg. e nota 14, p. 77 (bibliografia).
30
Tali sono i discorsi di Ferrante a Sisto IV nel 1475: «Voi non siete
signore di Roma e non potete regnarvi in ragione delle gallerie, strade
strette e terrazze. Se dovete farvi passare delle truppe, le donne sca-
gliando pietre dalle terrazze le metteranno in fuga e si stenterà a costrui-
re barricate». Ferrante gli consigliò di abbattere terrazze e porticati e di
allargare le strade. Il papa seguí il consiglio e da allora in poi le terrazze
e i porticati vennero abbattuti nella misura del possibile e le strade allar-
gate sotto il pretesto di rifare la pavimentazione e di dare piú luce.
Da s. infessura, Diario della città di Roma, a cura di O. Tomasini,
Roma 1890, p. 79, citato da delumeau, La vie économique cit., p. 289.
31
pieri, Il Rinascimento cit., p. 580.
32
guicciardini, Storia d’Italia cit., nell’ed. del 1929, V, pp. 142-46;
gregorovius, Storia della città di Roma cit.
33
Secondo F. Vettori nel suo dialogo sul sacco (circa il 1530), l’at-
tacco fu lanciato dietro la dimora del cardinale Cesi, dove da un lato
c’è la vigna di Santo Spirito, dall’altro quella di maestro Bartolomeo
da Bagnacavallo; cfr. Viaggio in Alemagna di F. Vettori... aggiuntavi…
il Sacco di Roma del 1527, dello stesso..., a cura di C. Salvi, Firenze e
Paris 1837.
Storia dell’arte Einaudi 64
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
34
von pastor, Storia dei papi cit., vol. IV, parte II, libro III, p. 256,
n.1; pieri, Il Rinascimento cit., p. 581, nota 1.
35
Cellini, come si sa, si dice l’autore di questa prodezza nella Vita.
Sulle controversie concernenti la morte di Borbone, cfr. von pastor,
Storia dei papi cit., vol. IV, parte II, libro III, p. 255, n. 3.
36
a. prost, Les sciences et les arts occultes au XVIe siècle. Corneille
Agrippa, sa vie et ses œuvres, 2 voll., Paris 1882, app. xxv; f. cancel-
lieri, Il Mercato, il lago dell’Acqua Vergine, il Palazzo Panfiliano nel
Circo Agonale, Roma 1811, pp. 242-243. Cfr. hook, The Sack of Rome
cit., p. 162.
Secondo m. guazzo, Le historie di tutti i fatti degni di memoria nel
mondo successi, Venezia 1546, p. 66, citato da hook, The Sack of Rome
cit., p. 164, un vecchio aveva predetto che Borbone avrebbe trovato
la morte prendendo una grande città.
37
«Fatta la ninna e passa via Barbone» si cantava in Trastevere,
secondo cancellieri, Il mercato cit., p. 242.
38
Sul coraggio della guardia svizzera, cfr. r. durrer, Die Schwei-
zergarde in Rom und die Schweizer in päpstlichen Diensten, Luzern 1927,
vol. I, pp. 397 sgg.
Sulla sfera radiata, cfr. c. maes, La sfera radiata di bronzo dorato già
infissa al vertice dell’obelisco vaticano riconosciuta ora ed autenticata con
iscrizione nel museo Capitolino, in «Il Cracas», 4, 1894, pp. 371 sgg.
39
Iscrizione antica: «D.O.M. | Bernardino Passerio Juli II Leone
X et Clementis VII Ponttt.maxxx aurifici ac gemmario praestantiss. |
qui cum in sacro bello pro | patria in prox. lanic. parte | hostium plu-
reis pugnans occidisset | atque adverso militi vexilium abstulisset | for-
titer occubuit pr.n. mai mdxxvii | V.A. xxx. viim.vi.d.xi | Iacobus et
Octavianus Passerii | fratres patri amantiss. Posuere».
Iscrizione moderna: «Il 6 Maggio 1527 | ravvolto nella bandiera |
di sua mano strappata | alle irrompenti orde borboniche | qui presso
cadde a difesa della patria nel proprio e nel nemico sangue | Bernardi-
no Passeri Romano | orefice | padre di famiglia. | Perché tanto esem-
pio frutti insegnamento ed emulazione ai posteri, la società degli orafi
di Roma al loro fratello d’arte e di cuore nuovo ricordo consagrano |
25 Ottobre 1885».
Cfr. ravioli, La guerra di sette anni cit., p. 374 nota 1.
Si legge un’altra iscrizione all’interno di Sant’Eligio degli Orafi, via
Giulia.
40
Si è obbligati a tenere conto della testimonianza di Paolo Giovio
(1483-1552), ma con qualche prudenza. La sua credibilità di storico è
stata messa in dubbio da F. Chabod nel saggio Paolo Giovio del 1954,
ripreso in Scritti sul Rinascimento cit., pp. 243 sgg.
Stretto alleato dei Medici, dopo la sua venuta nel 1513 al servizio
di Leone X, non lasciò Clemente, e, nel maggio 1527, corse con lui fino
Storia dell’arte Einaudi 65
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
a Castel Sant’Angelo, secondo il suo famoso racconto: «Clementi
autem plenis passibus evadenti proximus erat Paulus Jovius qui haec
conscripsit, sustuleratque ei ab tergo talaris togae sinus ut expeditius
iter conficeret, suumque item violaceo colorem. pallium et pileum capi-
ti atque humens iniecerat ne pontifex a candore vestis agnitus, dum
aperto demum et ligneo ponte in arcem transint a Barbaris accuratio-
re forte glandis ictu sterneretur» (p. giovio, Vita di Pompeo Colonna,
Firenze 1549).
La sua grande opera Historiarum sui temporis ab anno 1494 ad
annum 1547 libri XLV, Firenze 1550-52, sarebbe andata in parte per-
duta (libri V-X) nel sacco del 1527; l’autore affronta non senza ripul-
sione il racconto degli anni penosi del pontificato di Clemente. Negli
Elogia virorum illustrium, Firenze 1549 e Basilea 1577, ha riferito i suoi
ricordi nella Vita di Pompeo Colonna, il nemico giurato di Clemente;
egli coglie l’occasione per mostrare l’emozione del cardinale Colonna
quando giunge l’8 giugno nella città devastata, e la riconciliazione a
Castel Sant’Angelo.
41
Raffaello da Montelupo: frammenti delle sue memorie in g. gaye,
Carteggio inedito di artisti dei secoli XV, XVI e XVII, Firenze 1840, vol. III,
pp. 581-94.
42
Il La lettera del cardinale Guillaume du Bellay all’ammiraglio
Chabot dell’8 luglio, conservata alla Bibl. Naz. di Parigi e pubblicata
da l. dorez, Le Sac de Rome (1527). Relation inédite de Jean Cave, orléa-
nais, in «Mélanges d’Archéologie et d’Histoire», xvi (1896), pp. 410
sgg., dà un’idea dell’incapacità di Renzo da Ceri, della confusione e
della pusillanimità dei romani che non tagliarono i ponti e non chiu-
sero le porte, nell’attesa delle truppe di Colonna, e infine dell’incredi-
bile mancanza di carattere di Clemente, che «parlava di arrendersi» fin
dal 6 maggio e «incominciò pratiche di trattativa a dispetto di tutti»
fin dal 7.
43
Cfr. hook, The Sack of Rome cit., pp. 165 e 167.
44
cellini, La vita cit., cap. xxxiv.
45
La superba narrazione di michelet, La Renaissance, Paris 1855,
vol. I, cap. 1, non dispensa evidentemente di ricorrere a von pastor,
Storia dei papi cit., vol. III, libro Il, pp. 394 sgg. Alessandro VI portò
con sé numerose reliquie, fra cui la Veronica (cap. iii).
46
Sui comandi, cfr. ravioli, La guerra di sette anni cit., pp. 362 sgg.,
con il catalogo dei capitani, pp. 342-44.
47
Su questo curioso personaggio, si è informati grazie al diario tenu-
to da un segretario. Cfr. a. d. pierrugues, Giornale del principe d’O-
range nelle guerre d’Italia dal 1526 al 1530…, Firenze 1897. Filiberto
fu ferito durante un’ispezione nei pressi del castello da Cellini, se c’è
da credere al racconto di questi, Vita, cap. xxxviii: Filiberto conduce-
va una vita elegante e raffinata al Palazzo di San Marco, da cui fu slog-
Storia dell’arte Einaudi 66
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
giato in seguito a una delle innumerevoli sommosse dei lanzichenecchi,
che saccheggiarono il palazzo al principio di luglio.
48
Cfr. cap. iv.
49
Cfr. cap. iii.
50
Historia vitae et gentorum per dominum magnum Cancellarium, a
cura di C. Bornate, Torino 1915.
51
Sull’assedio di Firenze, cfr. hook, The Sack of Rome cit., pp.
200 sgg.
52
Ibid., p. 209.
53
È in memoria di questo episodio che, una volta diventato pon-
tefice, avrebbe fatto innalzare dal Vignola la cappella-memoriale di
Sant’Andrea in Via Flaminia (1554), vicino alla villa che porta il suo
nome: secondo g. moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica,
Venezia (a partire dal 1840), vol. III, p. 193.
54
Sulla fuga a Orvieto, cfr. hook, The Sack of Rome cit., capp. xiv
e xv. Sulla «peste», o epidemia che porta questo nome generico, cfr.
a. corradi, Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie
fino al 1850, Bologna 1863, vol. 1.
55
Sull’affare di Lodi, cfr. guicciardini, Storia cit., XIX, 4; pieri,
Il Rinascimento cit., p. 583. Sull’esaltazione dell’eroismo italiano e l’I-
talus Bellax, cfr. cap. iv.
56
Su Napoli, cfr. hook, The Sack of Rome cit., pp. 233 sgg.
57
schulz, Der Sacco cit., pp. 47-48 (cfr. note 10 e 11). Direptio
expugnatae urbis Romae.... ed. al seguito di p. aretino, Pornodidascalus
seu muliebre, Frankfurt 1623.
58
brantôme, Les grands capitaines, vol. I: Les grands capitaines étran-
gers, Paris 1864.
schulz, Der Sacco cit., p. 73, non ha torto a scrivere che Brantô-
me non aveva fatto altro che condire con «eine pikante Sauce für den
französischen Geschmack» i dati forniti sui grandi capitani da p. de
valles, Historia del fortissimo... capitán Don Hernando de Avalos, mar-
qués de Pescara, con los hechos memorables de otros siete excelentissimos
capitanes del Emperador Don Carlos V, rey de España, Anversa 1562.
59
f. delicado, La lozana andaluza, Venezia 1527. L’epistola finale
alle «amiche e sorelle in amore» aggiunge alcune precisazioni sui «14 000
teutoni barbari, 7000 spagnoli senza armi e senza calzature, ma con fame
e sete ...» che avrebbero tutto distrutto a Roma senza il rifugio che il
«devoto sesso femminile» offrí a quei «pellegrini» di nuovo genere.
60
p. corsi, Ad humani generis servatorem in urbis Romae excidia p.
Cursii civis rom. deploratio, Paris 1528: «Constat eandem Urbem a
Visigotis direptam, ab Herulis occupatam, ab Ostrogotis possessam, a
Vandalis deformatam, a Langobardis vexatam, a Graecis spoliatam, a
Germanis oppugnatam, a Sarracenis ferro ignique vastatam. Sed nunc
a Cesariano exercitu ita omni calamitatum genere afflicta est omnium
Storia dell’arte Einaudi 67
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
simul nationum omniumque seculorum avaritiam, audaciam, perfi-
diam, libidinem, crudelitatem superavit».
61
schulz, Der Sacco cit., pp. 52-53 sgg.
62
alfonso de valdés, Dialogo en que particularmente se tratan de las
cosas ocurridas en Roma el año de MDXXVII, s.l. [1529], edizione a cura
di J. F. Montesinos, Madrid 1928; [trad. it. a cura di G. de Gennaro,
Napoli 1968].
Precisazioni sull’autore sono state portate da m. bataillon, Alfon-
so de Valdés, auteur du «Dialogo de Mercurio y Caron», in Homenaje a
Menendez Pidal, Madrid 1926, pp. 403 sgg., e sulle circostanze della
redazione in Erasme et l’Espagne, Paris 1937, cap. viii. È difatti lecito
considerare quest’opera vivamente antiromana, come tipica della rea-
zione degli erasmiani all’avvenimento. Cfr. cap. iv.
Dalla parte degli imperiali, il rapporto ufficiale piú degno di atten-
zione è la lettera dell’abate Najera, ambasciatore di Spagna presso la
Santa Sede, all’imperatore, in data 27 maggio, pubblicata in a. rodrí-
guez-villa, Memorias para la historia del asalto y saco de Roma en
1527…, Madrid 1875, pp. 135-36. Traduzione inglese abbreviata anno-
tata e rettificata in p. de gayangos, Calendar of Letters. Despatches and
State Papers relating to the negotiations between England and Spain preser-
ved in the Archives at Salamanca, London 1877, vol. III, pp. 211-19.
63
La lettera di Valdés e la risposta del nunzio sono riprodotte nel-
l’edizione di G. Prezzolini del Cortegiano, Milano e Roma, 1937, pp.
841 sgg. cfr. j. cartwright, The Perfect Courtier: Baldassarre Castiglio-
ne, his Life and Letters. 1478-1529, New York 1972, vol. II, Cap. liii.
Il nunzio credeva nella buona volontà del principe e aveva spesso
espresso il suo augurio di una riconciliazione, il che gli valse una let-
tera di rimprovero di Clemente in data 20 agosto per non averlo avver-
tito dei pericoli. Castiglione credette necessario fornire al riguardo lun-
ghe spiegazioni, in data 10 settembre, cfr. Lettere del conte Baldassarre
Castiglione, a cura di P. A. Serassi, Padova 1791, vol. II, pp. 147 sgg.
64
thomas more, A Dialogue Concerning Heresyes (1528), in Engli-
sh Works, London 1557, pp. 258-59.
65
Sulle ambizioni di Wolsey, cfr. a. f. pollard, Wolsey, London
1953, in particolare pp. 121-27; d. s. chambers, Cardinal Wolsey and
the Papal Tiara, in «Bulletin of the Institute of Historical Research»,
38 (1965), pp. 20-30.
66
r. brown, Calendar of State Papers and Manuscripts. Venice
1527-1533, Vol. IV, London 1871, Introduzione.
67
edward hall, The Union of the Two Noble and Illustre Families
of Lancaster and Yorke, 1527, a cura di H. Ellis, London 1809, p. 729;
s. anglo, Spectacle Pageantry and Early Tudor Policy, Oxford 1969.
68
Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII,
IV, ii, 3289; citata da s. anglo, Spectacle, p. 227.
Storia dell’arte Einaudi 68
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
69
Sulla navicula Petri, cfr. h. rahner, «Navicula Petri». Zur Sym-
bolgeschichte des römischen Primats, in «Zeitschrift für katholische
Theologie», 69 (1947), pp. I sgg. La fonte: Luca, 5, 3.
Nel Venerabile beda, Exposito in Joannem, a cura di J. P. Migne,
Patres Latini, vol. 92, Paris 1850, col. 709 d: laborat nec mergitur.
Una moneta di Nicola V porta la navis con Ecclesia. Cfr. Lexicon
für Theologie und Kirche, 7 (1955), p. 588.
70
«Al terzo palco era raffigurata “Navicula Petri”, intendendo la
nostra madre santa Chiesa che era al momento fra le onde. Flutti e
procelle (tempeste) marine nella quale molto agitata e turbata dal
vento erano alcuni personaggi naviganti come san Pietro che tende
le mani a un altro di fuori come sulla riva. Ed era scritto “Domine
salva nos perimus”. E il detto personaggio di fuori teneva un rotolo
nella mano, sul quale rotolo era scritto “Modice fidei quare dubita-
sti”. E ai lati del detto palco erano due corpi adorni portanti ciascu-
no le loro armi, ossia Francia e Inghilterra, e la spada in mano che
facevano roteare come pronti a proteggere, difendere e risollevare
quella navicella. E lungo la parete in alto vi era una città che rap-
presentava Roma o Gerusalemme, dove era scritto “Et iustitia cor-
rectio sedes ejus”».
E sul frontone in alto i quattro versi seguenti: «Destruet ira truces
magni Jovis alta nocentes. | Innyxos propria pellerent sede matrem. Sic
| innicta premet magna tum dextera reges. Ausos | christiferam tange-
re marte domum».
Ballata: «Santa Chiesa dalle onde gravata | E gli sconfitti Gesú vuol
sollevare | Al fine ch’ella sia preservata | Ecco il mezzo per lei risolle-
vare | Il fior di giglio e la vermiglia rosa | Con il loro valore coloro faran-
no sprofondare | Che la Santa Chiesa vollero schiacciare, | Se uniti sono
come lo si suppone». Les spectacles populaires à l’entrée du Légat d'An-
gleterre à Amiens (4 Août 1527), in L’entrée du Légat dedans Ville
D’Amyans avecq le triumphe de la Ville..., a cura di V. Jourdain,
Cayeux-sur-Mer 1910, pp. 13-16.
71
maurice scève, Délie, Lyon 1544, decina xxi. La composizione
della raccolta può essere anteriore al 1540. Le decine xix, xx e xxi con-
cernono il conestabile fellone. Il cervo-volante, emblema di Carlo VI,
era stato adottato dal conestabile con l’impresa: «Cursum intendimus
alis». Cfr. p. giovio, Dialogo dell’imprese militari et amorose, Lyon
1574, p. 12; e g. de tervarent, Attributs et symboles dans l’art profa-
ne, Genève 1958, 1, p. 67.
L’autruche (struzzo) = l’Autriche (Austria), come nella decina lv,
che descrive con ironia la trasformazione dell’aquila in struzzo.
72
Fra le altre vive reazioni nel campo imperiale contro le violenze
dell’esercito, bisogna notare quella del generale dei Francescani, Quiño-
nes, che voleva soprannominare i capitani imperiali «capitani di Lute-
Storia dell’arte Einaudi 69
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
ro» – da una lettera di Navagero del 27 luglio, in brown, Calendar of
State Papers cit., iv, n. 117.
73
Un opuscolo contiene un poema di vasco díaz de frexenal,
Triumpho pugnico lamentable sopra la profana entrada y saco del’alma ciu-
dad de Roma, s.l. [1528], preceduto da una xilografia che rappresenta
una città presa d’assalto. Pubblicato da a. rodríguez-villa, Italia desde
la batalla de Pavia hasta el saco de Roma, Madrid 1885, pp. 223 sgg.
74
Pannello 0,29 x 0,64 m. cfr. m. destombes, A Panorama of the
Sack of Rome by Pieter Bruegel the Elder, in «Imago Mundi», 14 (1959),
pp. 64 sgg.; riproduzione in a. p. frutaz, Le piante di Roma, Roma
1962, p. 171.
Altra versione di dimensioni doppie: 0,50 x 1,37 m è conservata
nei Musei del Belgio; cfr. c. terlinden, Un panorama de Rome à la fin
du XVIe siècle, in «Annuaire des Musées Royaux de Belgique», 3
(1940-42), pp. 29-40.
75
frutaz, Piante cit., n. xcv, tav. 165.
76
Sono quelli di hartmann schedel, Liber chronicarum, Nürnberg
1493 (frutaz, Piante cit., n. xcvi, tav. 116) e di sebastian monster,
Cosmographiae universalis, Lib. VI, Basel 1550 (ibid., n. xcviii, tav. 170).
77
Per esempio alla Villa Imperiale di Pesaro: la decorazione, a glo-
ria di Francesco Maria Della Rovere, porta in un medaglione l’Incoro-
nazione di Bologna. Su questo tema, cfr. cap. vi. Cfr. b. patzak, Die
Villa Imperiale in Pesaro, Leipzig: 1908, pp. 309 sgg.; g. martini, La
Villa Imperiale di Pesaro, Pesaro s.d.
78
Melchior Feselein (attivo 1531-38), Assedio di Roma da parte di
Porsenna, München 1529. Si troveranno in g. m. richter, Melcher Fese-
lein, ein Beitrag zur Geschichte der oberdeutschen Kunst im XVI. Jh., in
«Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte», 54 (1944),
pp. 189 sgg., le indicazioni sui due cicli di battaglia ordinati per una
sala del palazzo da Guglielmo IV di Baviera.
79
I cartoni sono conservati al Kunsthistorisches Muscum di Vien-
na. Cfr. h. göbel, Wandteppiche, I: Die Niederlände, Leipzig 1923, pp.
144-45, 311, 419-20.
80
e. jacobsen, Niederländische Kunst in den Galerien Mansi zu Lucca,
in «Oud Holland», 14 (1896), p. 95.
n. lieb, Die Fugger und die Kunst, vol. II, München 1958, p. 122,
segnala in un inventario dei beni della famiglia Fugger del 1546, che
riproduce probabilmente un’informazione del 1536 e del 1539. «drei
grosse Quadre nemlich die Belagerung Wien, der Sacko zu Rom und
die Schlacht vor Pavia».
81
[Porto sul canale che congiunge Tunisi al mare].
82
a. chastel, Les entrées de Charles Quint en Italie, in Fêtes et céré-
monies au temps de Charles Quint cit., p. 204.
83
f. w. hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engravings, and
Storia dell’arte Einaudi 70
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Woodcuts, vol. VIII, Amsterdam 1954, nn. 167-78. vasari, Le Vite
cit., v, p. 220, cita la serie come se H. Cock ne fosse l’incisore. Cfr.
l. preibisz, Martin van Heemskerck, Leipzig 1911, pp. 86 sgg.
84
Cfr. cap. vi.
85
[Dopo che il Borbone fu ucciso, l’esercito imperiale prese d’as-
salto i bastioni e saccheggiò la misera città].
86
[Dopo l’occupazione della città, Clemente fu tenuto prigioniero
nella grande fortezza di Adriano e venne poi liberato dietro pagamen-
to di un pesante riscatto].
87
w. stabbe, Hundert Meisterzeichnungen, Hamburg 1967, n. 53;
Bilder nach Bildern. Druckgrafik und die Vermittlung von Kunst, esposi-
zione al Westfälisches Landesmuseum, Münster 1976, n. 38, p. 56.
88
Cfr. cap. vi.
89
Vi sarà un seguito, piú tardi, alla prima incisione di Heemskerck.
È dovuta ad Antonio Tempesta e incisa da C. Boel, in una serie sulla
vita di Carlo V, nel 1614. Raffigura Borbone che lancia i suoi soldati
all’assalto all’alba del 6 maggio. L’iscrizione dice: «Milite Caesareo,
Borbonius occupat Heros | Magnanimus magni Capitolia celsa Quiri-
ni, | At fidens armis, duni moenia scanderet Urbis | Concidit, Heroes
sic sic juvat ire per umbras». | hollstein, Dutch and Flemish Etchings
cit., III, p. 7, nn. 148-51.
Un arazzo, che può datarsi sulla fine del xvi secolo, è comparso sul
mercato parigino ed è stato pubblicato in «Connaissance des Arts»,
dicembre 1969, p. 53. Questo pezzo, tessuto di lana e seta, è intitola-
to L’assedio di Roma da parte delle armate di Carlo Quinto. Può trattar-
si infatti di Roma, vagamente segnalata da un torrione a due piani mer-
lati. Ma l’identificazione rimane dubbia, perché vi è rappresentato un
combattimento di cavalleria davanti alle tende di un campo di tipo anti-
co senza nessun’altra indicazione esplicita. E le insegne lasciano piut-
tosto supporre che la parte di assediati sia, anzi, qui assegnata alle legio-
ni romane.
Storia dell’arte Einaudi 71
Capitolo secondo
Roma-Babilonia
Nelle guide di Roma a stampa che si moltiplicano a
partire dalla fine del secolo xv si trova, a uso dei pelle-
grini, la lista delle «stazioni» o santuari la cui visita pro-
cura delle indulgenze, come pure certi luoghi memora-
bili per la storia cristiana, dove le reliquie commemora-
no gli eroi della fede; vi si fa anche menzione di mira-
bilia profane, come il cavaliere del Laterano, le statue
dei domatori di cavalli al Quirinale, l’obelisco di Cesa-
re nel Vaticano1.
Su un incunabolo xilografico diffuso per il Giubileo
del 1475, sotto il pontificato di papa Sisto IV, il suo
stemma compare nell’ultima pagina con lo stemma di
Roma, entrambi sovrastati dal lino miracoloso chiamato
la Veronica2. Sorretta dagli angeli, questa reliquia – che
risale alla leggenda della salita al Calvario, ma in modo
esplicito segnalata a Roma soltanto dal secolo xii – era
diventata uno degli scopi della visita alla città santa.
Arrecava ai pellegrini la conferma delle indulgenze che
si erano guadagnati con il loro viaggio meritorio. La sua
ostensione solenne simboleggiava dunque il compimen-
to del pellegrinaggio. Questa immagine infinitamente
diffusa nei secoli xv e xvi, ed essa stessa apportatrice di
indulgenze, era diventata l’espressione comune della
Roma christiana. Ma nell’incunabolo in questione, l’im-
magine della Veronica e seguita da un’evocazione delle
origini di Roma: la madre di Romolo in preghiera e i
Storia dell’arte Einaudi 72
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
gemelli nutriti dalla Lupa. Un po’ più discosto, in una
iniziale ornata, si vede San Silvestro, il papa che bat-
tezzò Costantino, primo imperatore cristiano. La storia
del mondo era cosí condensata in alcune immagini atte
a impressionare. Di una guida di questo tipo dovette ser-
virsi il monaco agostiniano Lutero nella sua visita del
15113, e forse anche Erasmo nel suo soggiorno del 1506,
dal quale doveva riportare l’Elogio della pazzia e ch’egli
ricordò nel Ciceronianus4. I due temi della religione e
della politica riassumevano, il duplice prestigio di Roma.
Nelle polemiche del secolo xvi, furono sempre piú vio-
lentemente denunziati come la superstizione delle reli-
quie e l’illegittimità del potere temporale dei papi.
La Sala di Costantino.
Verso la fine del 1523 o agli inizi del 1524, uno dei
primi atti ufficiali del pontificato di Clemente VII era
stato quello di ordinare il compimento della Sala di
Costantino, allora chiamata dei Pontefici per via delle
otto teste di papi che dovevano inquadrare le «storie».
Era l’ultima e la piú vasta delle quattro «Stanze» inco-
minciate sotto Giulio II: la «Segnatura» del 1508;
«Eliodoro», iniziata nel 1512 e continuata sotto Leone
X: l’«Incendio» del 1514; e infine «Costantino», a par-
tire dal 15175. Questa serie di decorazioni terminava
nella Stanza contigua alla Stanza di Costantino, con la
quale aveva in comune una storia analoga6. Come è stato
notato da lungo tempo, ognuna di queste decorazioni
contiene allusioni all’attualità attraverso i ritratti dei
papi. La storia contemporanea è resa viva e, nel mede-
simo tempo, è sottolineato il perdurare dell’istituzione7.
Niente è più famoso e, in un certo senso, familiare
di queste stanze, ma vale la pena entrare nei meandri di
una «dottrina» che aveva ritrovato tutta la sua attualità
Storia dell’arte Einaudi 73
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
sotto il pontificato di Clemente. La Stanza di Eliodoro
si articola come un’illustrazione della protezione singo-
lare di cui beneficia la Chiesa di Roma, e al tempo stes-
so, come una vera cronaca delle traversie subite dalla
potenza pontificia nel 1511 e 1512: la pressione delle
truppe di Luigi XII nell’Italia centrale, e il Concilio di
Pisa convocato dal re di Francia sulla fine del 15118. La
decorazione della Stanza mostra, come è stato giusta-
mente fatto notare, la sicurezza della Santa Sede, che ha
reagito a tali minacce con la Lega Santa antifrancese
(1511) e con la convocazione del Concilio Laterano nel
luglio 1511. Le scene della volta ricordano la protezio-
ne del Signore sul popolo eletto9. Le «storie» incomin-
ciano con due episodi mirabilmente scelti per il loro
valore programmatico e di una efficacia perfetta. Elio-
doro espulso dal Tempio mostra la ingegnosa trovata della
prospettiva «drammatica» fortemente arretrata, usata
per presentare il gran sacerdote Onias in preghiera nello
sfondo, Giulio II in trono a sinistra, e a destra il sacri-
lego Eliodoro ricacciato dagli angeli e il cavaliere cele-
ste. I sacri tesori del Tempio non possono essere sac-
cheggiati dagli empi. L’allusione alla minaccia straniera
sul patrimonio romano era, di certo, trasparente, ma
l’importante è qui l’accesa difesa della politica pontifi-
cia in corso.
Molto verosimilmente bisogna interpretare allo stes-
so modo la Messa di Bolsena, dove la decorazione archi-
tettonica «romana» attornia l’evocazione del miracolo
da cui era conseguita l’istituzione della festa del Corpus
Domini. Accostando il papa in persona all’altare in cui
il miracolo ha luogo, la composizione proclama la posi-
zione unica del successore di Pietro in materia di fede;
e con l’attribuirgli la fisionomia di Giulio, sopprime
qualsiasi discussione sull’autorità di questi. La debolez-
za del Concilio scismatico riunito a Pisa è in tal modo
indirettamente ma chiaramente denunziata. Queste due
Storia dell’arte Einaudi 74
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
«storie» che illustrano il «programma» della seconda
Stanza, sembrano, in realtà, essere state completate per
prime; l’aver introdotto il ritratto di Giulio, in piena evi-
denza, in tutt’e due dà loro il valore di un manifesto,
tanto meno contestabile in quanto la fisionomia del
papa e quella del Pontifex barbatus che ha affrontato la
crisi10.
Nelle altre due «storie» Giulio non compare. Esse
sono state terminate sotto Leone X, il che ne spiega la
presenza nell’Espulsione di Attila: il papa, in sella sul
cavallo bianco di rito, procede fra la duplice apparizio-
ne dei santi Pietro e Paolo che atterriscono il barbaro
invasore. Nessuno ha mai dubitato dell’allusione tra-
sparente al ripiegamento delle truppe francesi dopo la
battaglia di Ravenna, alla quale Leone aveva partecipa-
to11. L’idea della scena data, come il programma del-
l’intera Stanza, al Pontificato di Giulio, che però morì
nel febbraio del 1513; conseguentemente la composi-
zione subì importanti modifiche12. Non è sicuro che si
debba dire altrettanto della Liberazione di san Pietro.
L’ammirevole chiaroscuro della scena denota una preoc-
cupazione «luminista» e una assimilazione delle tecni-
che della pittura veneziana che segna una nuova tappa
per Raffaello. La sollecitudine dell’angelo per l’Aposto-
lo non si riferisce a nessun fatto personale della vita di
Giulio o di Leone, ma illustra semplicemente la prote-
zione sovrannaturale, tema della Stanza. Tutti i critici
concordano nell’interpretazione del soggetto. L’affresco
deve ciononostante essere interpretato come un omag-
gio all’opera di colui che fu il titolare di San Pietro in
Vincoli, luogo della sua tomba non finita13. Questa scena
avrebbe avuto grande importanza per il regno di Cle-
mente VII e i simboli di quel regno14.
Quella che si deve chiamare la «dottrina» delle Stan-
ze era stata formulata, sotto Leone, nella Stanza del-
l’Incendio. L’esistenza stessa della Chiesa è rappresen-
Storia dell’arte Einaudi 75
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
tata come un miracolo continuo, ma con conseguenze
precise nell’ordine politico. La nuova Stanza riafferma
il predominio del papato sui principi, ma con minore
invenzione della Stanza di Eliodoro. Qui tutto è accen-
trato intorno all’evocazione degli atti di Leone III (il
giuramento di giustificazione, l’incoronazione di Carlo
Magno), e di Leone IV (la vittoria di Ostia, il miracolo
dell’incendio del Borgo), con il sottinteso che il presti-
gio di quei pontefici dei secoli viii e ix era trasmesso al
loro successore omonimo. Il ritratto di Leone è ripetu-
to ogni volta, ma si è creduto opportuno esplicitare l’ar-
gomento sullo zoccolo della Stanza, dove appaiono
dipinti in falso bronzo dorato, sotto ai sei episodi stori-
ci, sei sovrani «benefattori della Chiesa», secondo le
parole di Vasari: la contessa Matilde, Pipino, Carloma-
gno, Ferdinando di Castiglia, Goffredo di Buglione. Il
sesto è Lotario, identificato dall’iscrizione «Lotharius
imp. Pontificae libertatis assertor».
Questi dati rimanevano evidentemente validi al
tempo di Clemente VII; lo erano anzi più che mai, in
quanto i problemi del pontificato di Clemente tendeva-
no a ripetere quelli della crisi del 1510-14, con poche
differenze: la minaccia di dominazione esterna prove-
niva adesso dall’armata imperiale, l’exercitus caesareus, e
non dai francesi, e la protezione divina non si manife-
stava più con miracoli.
Se i problemi della politica contemporanea si legge-
vano nelle Stanze, per così dire, in trasparenza, la Stan-
za di Costantino pone un problema particolare. La cro-
nologia e la esecuzione delle decorazioni sono state
oggetto di vivaci discussioni15. La concezione di questa
quarta Stanza risale al pontificato di Leone X (morto il
1° dicembre 1521) e il piano generale a Raffaello (morto
nell’aprile del 1520). Giulio Romano prese in mano le
operazioni nell’estate del 152016. Si tratta di sapere se
quei troni pesanti, schiacciati dalle virtù, fossero già
Storia dell’arte Einaudi 76
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
stati previsti per questa stanza. In ogni modo, la loro ese-
cuzione porta il segno dello stile potente, e se possiamo
dire, della brutalità di Giulio, che, in un certo senso, si
accorda benissimo con il tema della «monarchia» ponti-
ficia. La realizzazione ha comportato una battuta d’ar-
resto, precisamente fra la morte di Leone X e l’avvento
di Clemente VII nel novembre 1523, cioè durante il
regno dell’olandese Adriano VI, precettore di Carlo V
quando il giovane principe era andato a studiare a Lova-
nio. Adriano era un pontefice austero, riformatore, che
non nascose la sua antipatia e perfino l’avversione per
quelle decorazioni del Vaticano. I lavori della quarta
Stanza furono sospesi e un grande scompiglio regnò nella
bottega di Raffaello. Questo intermezzo sgradevole durò
soltanto venti mesi. Tra la fine del 1523 e l’autunno del
1524, che vide la partenza di Giulio per Mantova, la
decorazione fu finalmente portata a termine.
Gli emblemi, appropriatamente distribuiti lungo
tutta la decorazione, indicano, in linea di massima, sotto
quale pontificato ogni composizione sia stata dipinta. Lo
spiegamento completo degli emblemi di Leone X si trova
nella Stanza dell’Incendio, con i «motti»: semper, suave,
glovis17 che si ritrovano nella Stanza di Costantino, nei
fregi superiori di due dei finti arazzi: l’Apparizione della
Croce e la Battaglia. Sugli altri appare un emblema lega-
to a Clemente VII, una sfera di cristallo colpita dal sole,
con il motto candor illesus, una mirabile sottigliezza. Vi
sono associate tre penne sopra al Battesimo e si erge sola
sopra la Donazione18. Questa indicazione importante
ècompletata dal motivo delle cariatidi disposte sopra ai
sei pontefici troneggianti nelle nicchie. Su tre delle pare-
ti, queste figure portano il motto iugum suave di Leone
X; sulla quarta, quella dell’ingresso, in cui si vede la
Donazione, le figure sono diventate Apollo e Diana con
la sfera di cristallo e una piccola messa in scena di can-
dor illesus, ripetuta nella strombatura della finestra a
Storia dell’arte Einaudi 77
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
oriente. Secondo queste indicazioni, è sembrato ragio-
nevole concludere che la parete della Donazione data
interamente alla fase di ripresa sotto Clemente, dopo il
completamento del Battesimo, che dev’essere stato con-
temporaneo.
Fra gli otto pontefici inquadrati dalle virtù, quattro
scene evocano con una forza quasi aggressiva episodi sto-
rici raffigurati di rado. Prima di tutto l’azione e il
trionfo di Costantino: l’Allocuzione alle truppe e la Visio-
ne della Croce e la Battaglia del Ponte Milvio. Le altre due
«storie» mettono in evidenza il ruolo del papa Silvestro
I di fronte all’imperatore: il Battesimo di Costantino e la
Donazione della Città di Roma a san Silvestro. Tutto qui
è romano: i paesaggi nelle due prime composizioni; gli
edifici – il Laterano e San Pietro – nelle seconde. Se si
radunano tutti gli elementi di questo riassunto grafico,
vi si trova, dopo la lunga difesa della natura divina del-
l’istituzione e il primato dello spirituale sul temporale,
la più autoritaria delle rivendicazioni che mai sia stata
fatta della legittimità delle pretese pontificie: a) nei
riguardi dell’imperatore, rappresentato qui da Costan-
tino, e b) sulla città di Roma e lo Stato di San Pietro.
Forse non è stato abbastanza sottolineato fin qui, ma
erano precisamente questi i problemi piú scottanti del
momento. L’ammonizione contenuta in questa sala coin-
cide con ciò che e stato cosí violentemente negato nel
152719. Per rendere con forza ancora maggiore la dimo-
strazione e il richiamo a principî basilari, le effigi dei due
papi medicei sono state introdotte in questa sala, che
serviva da anticamera agli appartamenti pontifici. Le
figure sotto il baldacchino hanno certo fatto parte del
programma iniziale e dovevano riassumere la catena dei
papi da san Pietro a san Silvestro, il papa che battezzò
Costantino20. L’identificazione di Leone X è indubbia,
in ragione di un celebre disegno a pastello di Giulio
Romano21; quanto a Clemente egli appare, fatto piutto-
Storia dell’arte Einaudi 78
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
sto eccezionale, in due versioni: imberbe, cosí come era
prima del sacco, e barbuto, come l’ha raffigurato Seba-
stiano del Piombo verso il 1532.
In queste ricostituzioni storiche, l’erudizione archeo-
logica gioca un ruolo considerevole22; ne risulta un effet-
to globale di dispersione e di terribilità che è ben lonta-
no dalla maniera di Raffaello, anche dalla cupa e dram-
matica Trasfigurazione. Gli elementi antichi, tratti dai
rilievi degli archi di trionfo e della colonna traiana, sono
posti in evidenza nelle vedute di Roma: il ponte sul
Tevere con la silhouette delle statue, il mausoleo rico-
stituito, la piramide della tomba di Romolo, nell’Adlo-
cutio; la linea sinuosa del Monte Mario a sinistra del
Ponte Milvio, sul lato destro della Battaglia. Se il nano
che si mette il berretto nell’angolo destro dell’Adlocu-
tio – identificato con il buffone di Ippolito de’ Medici
– stabilisce un legame con lo spettatore, non c’è nulla
di simile nella Battaglia, che, invece, lo tiene a distanza.
Le due scene in interni, ambientate nel Laterano per il
Battesimo e nel vecchio San Pietro per la Donazione,
instaurano un contatto con lo spettatore per mezzo di
numerosi admonitores in abito moderno, perché si capi-
sca bene l’attualità della scena23.
È strano, ma non anormale, che queste strutture
architettoniche familiari a tutti siano state un po’ sem-
plificate per conferire alle due cerimonie una salda
inquadratura di colonne24. Per due volte il vincitore di
Ponte Milvio appare in atteggiamento rispettoso, sia
dinanzi al pontefice che lo battezza che dinanzi al vesco-
vo di Roma che ne accetta la donazione, con l’assenso
manifesto del popolo romano. Non è soltanto interes-
sante, qui, vedere riaffermata la dottrina papale, ma
anche lo stile monumentale della disposizione, con la
scelta premeditata delle figure allegoriche raggruppate a
due a due a destra e a sinistra delle nicchie. È questa una
delle primissime volte in cui compaiono queste personi-
Storia dell’arte Einaudi 79
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
ficazioni che saranno indispensabili all’arte classica: for-
mule retoriche tradotte in immagini allo scopo di met-
tere in mostra la dignità suprema dell’istituzione, che
supera di gran lunga la dignità dei titolari che la incar-
nano; ma al tempo stesso questo corteo straordinario di
Virtù li trasforma in eroi.
I pannelli dello zoccolo sono dipinti a medaglioni,
secondo il sistema già adottato da Raffaello nella Stan-
za della Segnatura, sotto il Parnaso. Sono illustrazioni
poco esplicite, tranne due «quadri» nelle strombature,
che sono stati incisi da Bartoli (s.d.) e Montagnani
(1834). Qualcuno vi ha visto un’evocazione di san Gre-
gorio, che scrive le sue omelie e altre opere edificanti,
altri l’azione violenta di uno scultore che spezza gli idoli
pagani. Se le scene si accordano con il tema dell’instau-
razione pubblica e ufficiale della fede cristiana, ci si
meraviglia un poco della scelta di san Gregorio, vissuto
circa tre secoli dopo il tema storico della Stanza; si deve
quindi intendere che questi pannelli furono attribuiti
all’epoca di Gregorio XIII, il che, a dire il vero, sareb-
be più appropriato25.
La celebrazione della Chiesa romana non poteva
essere più ripetuta e più solenne. Ma quest’insistenza
implica un’intenzione polemica, un rifiuto calcolato dei
temi antipapisti che innalzavano volta a volta l’Impero
o il Concilio al di sopra del papa26. C’è forse anche nella
Stanza di Costantino una punta molto precisa di attua-
lità? Il quesito si pone a partire dal momento in cui si
apprende che il progetto di Leone X non comprendeva
inizialmente le due scene del Battesimo e della Dona-
zione.
Alla morte di Raffaello, nell’aprile 1520, «Sebastia-
no pictore in Roma», il futuro Sebastiano del Piombo,
si sforza di ottenere la commissione della Stanza, riven-
dicata dagli allievi di Raffaello e attribuita invece a Giu-
lio Romano.
Storia dell’arte Einaudi 80
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Avendo bisogno dell’appoggio di Michelangelo, Seba-
stiano insiste perché intervenga in suo favore, presen-
tando, a quanto pare, la situazione sotto una luce un po’
migliore di quanto non fosse. Pertanto, il 6 e il 7 set-
tembre viene invitato a indicare il suo programma per
la futura Stanza, basato su quello che il papa stesso
aveva espressamente detto: l’apparizione della Croce,
una battaglia, poi «una presentazione dei prigionieri»
all’imperatore, e, sull’altra parete, «i preparativi del
fuoco destinato a scaldare il sangue dei fanciulli»27. La
scelta non era molto felice.
L’ultima scena, tratta dalla Leggenda aurea (tradotta
in inglese nel Quattrocento da William Caxton, su una
versione francese contemporanea della duecentesca
opera in latino di Jacopo da Varagine, Vite dei Santi), era
presa dal resoconto del giorno di san Silvestro, il 31
dicembre, in cui si racconta come l’imperatore, colpito
dalla lebbra, doveva essere curato con un bagno di san-
gue, al quale rinunziò per pietà verso le vittime. Tale
autosacrificio gli valse la visione dei santi Pietro e Paolo,
l’incontro con san Silvestro e il battesimo. Le altre due
scene dovevano sottolineare, senza dubbio, la potenza
e la grandezza imperiale. Il tema cambiò completamen-
te quando il programma fu definitivamente rielaborato
sotto Clemente VII.
Il Battesimo, che sostituisce con vantaggio il Bagno di
sangue, dovette essere stato dipinto durante la campagna
del 1520-21, poiché vi si legge a destra l’iscrizione «Cle-
mente VII Pont. max. a Leone coeptum consumavit
mdxxiii», e compaiono gli stemmi di entrambi. Sotto la
Donazione, nulla di simile; il tema sembra emergere solo
all’ultimo momento nella fiera iscrizione sulla colonna
di destra «Ecclesiae dos a Constantino tributa». Perciò
il programma può essere stato modificato in extremis.
Le due scene principali sono state talvolta giudicate così
inopportune che furono considerate una prova sorpren-
Storia dell’arte Einaudi 81
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
dente di mancanza di irrealismo politico28. La mia opi-
nione, invece, e che si tratti di una cosa assolutamente
voluta. Oggi sappiamo che il battesimo impartito da
Silvestro a Costantino e una leggenda che compare sol-
tanto nel v secolo, così come la donazione della città di
Roma non è menzionata prima del periodo di Stefano
II nel secolo viii. Lorenzo Valla, e poi Erasmo, hanno
analizzato i testi e dimostrato il falso29. Tuttavia la cri-
tica radicale della Donazione, redatta verso il 1440 da
Valla nell’opuscolo De falso credita et ementita Constan-
tini donatione, non fu pubblicata nel secolo xv; la sua tesi
era comunque conosciuta e la comparsa nel 1478 e 1480
dei racconti leggendari della vita di Silvestro testimonia
che gli ambienti romani rifiutavano istintivamente que-
sta nuova diminuzione di autorità.
Se l’opuscolo del Valla rispondeva a un atteggiamen-
to critico nei riguardi del potere temporale, non era affat-
to una dichiarazione di guerra da parte dell’autore al
papato30, e non lo fu neppure quando venne pubblicato
nel 1506. Lo divenne improvvisamente nelle mani di
Ulrich von Hutten che lo stampò nel 1518 e 1519. La rie-
dizione del 1520 del testo del 1506, reca una denuncia
decisa dell’autorità politica, destinata a completare quel-
la dell’autorità religiosa fatta da Lutero. Nell’eccitazio-
ne antiromana del terzo decennio, un autore ceco trovò
una prova ulteriore in questo duplice attacco al potere
papale, arrivando al punto di negare la venuta di San Pie-
tro a Roma. Era voler provare troppo e l’opera non fu
accolta con favore neppure dai Luterani31.
L’attacco di Hutten non consentiva più di acconten-
tarsi dell’atto di Costantino. Su questo punto il pro-
gramma antico aveva bisogno di essere reso attuale: nel
1523 si scatena la polemica generale32. Non vi si rispon-
de con discorsi, o per lo meno non ancora, ma con affre-
schi. Secondo il Vaticano, i supposti rapporti tra Costan-
tino e Silvestro sono l’illustrazione simbolica di una isti-
Storia dell’arte Einaudi 82
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
tuzione divina, impossibile a contestarsi, che conferma
il dono di Roma al papa e la superiorità del suo vesco-
vo sull’imperatore. Lo provano le iscrizioni e i molteplici
particolari, che datano dal 1524; ci è voluta una grande
abilità per stabilire inequivocabilmente questi due
punti33. Perché la Stanza, situata, come si ricorderà,
all’ingresso degli appartamenti pontifici, era destinata
alle riunioni ufficiali in cui si trovavano riuniti il Sacro
Collegio dei cardinali e il corpo diplomatico.
Consideriamo, ad esempio, la curiosa inserzione di
due rilievi in stucco sulla parete nord. Uno di essi rap-
presenta l’adventus pontificalis, ossia l’entrata solenne del
papa a Roma su un cavallo bianco: «equo imperiali cappa
purpurea et aliis regalibus insignis ornatus», secondo la
formula che si legge in un testo del secolo xii34. Il rilie-
vo ricorda una scena che si trovava soltanto nella chie-
sa dei Santi Quattro Coronati a Roma e risaliva alla lotta
per le investiture35. Il richiamo storico e indubbio e tutti
capivano il significato di queste rappresentazioni, nel
clima degli anni venti. Era il momento in cui circolava,
tra altre raccolte profetiche, l’opuscolo gioachimita dei
Vaticinia de summis pontificibus36, ristampato nel 1525,
che interpretava i ritratti simbolici dei papi37. Vi com-
pare il papa sul cavallo bianco, che annunzia gravi tur-
bamenti per la Chiesa. Ma il fatto più sorprendente è
che gli stessi temi, le stesse immagini erano parimenti al
centro della denuncia accanita dell’autorità romana da
parte dei Riformatori tedeschi, il cui movimento era
adesso in pieno vigore. La seconda edizione dei Vatici-
nia era stata dedicata a Clemente, ma un’altra edizione
della stessa raccolta, stampata da Hans Sachs nella pri-
mavera del 1527 a Norimberga, fu diffusa da un mini-
stro luterano, Andreas Osiander; il suo commentario
interpreta i simboli nel senso della fine dell’istituzione
papale: vi si vede, ad esempio, un personaggio con la
falce e la rosa. Secondo Osiander, questo simbolo indi-
Storia dell’arte Einaudi 83
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
ca Lutero stesso, il quale approvò caldamente quanto
alla falce, meno quanto alla rosa38.
La dottrina del Vaticano era adesso il bersaglio di un
nuovo genere di polemica. Come è stato spesso notato,
la contestazione antiromana si era espressa con imma-
gini; le caricature e le figure satiriche avevano conqui-
stato la massa del popolo alle idee luterane. Fu il primo
frutto dei nuovi media che consentivano la moltiplica-
zione all’infinito dei testi e delle immagini: la stampa e
l’incisione, che avevano tutt’al più mezzo secolo di esi-
stenza, permisero la trasformazione rapida e decisiva del
pensiero della cristianità settentrionale39. Ma forse non
è stato abbastanza evidenziato in precedenza il fatto che
tutta questa azione ha ripreso esattamente i temi domi-
nanti del pensiero romano, ma capovolti; al dogma della
natura provvidenziale della Città e all’istituzione divi-
na dell’autorità pontificia, si oppone la rappresentazio-
ne implacabile di Roma-Babilonia e del papa-Anticristo.
E questa contestazione radicale dispone ora di mezzi
nuovi.
Il papa-Anticristo.
Intorno al 1520, qualsiasi allusione al papa di Roma,
qualsiasi raffigurazione della sua persona o del suo ruolo,
assumeva al nord delle Alpi una connotazione ostile,
sgradevole e insolente. La simbolica pontificia e il ceri-
moniale romano diventarono sospetti e colpevoli. Alde-
grever incorona la Superbia con una tiara. Baciare il
piede, vecchio rito conosciuto attraverso innumerevoli
rappresentazioni40, fu denunziato da Lutero e raffigura-
to in modo quasi ossessivo nelle stampe. Nella serie dei
«Fanciulli planetari», Georg Pencz, ne ha fatto il cen-
tro della tavola illustrando, sotto il segno di Giove, il
principio del potere terreno; non vi era nulla di simile
Storia dell’arte Einaudi 84
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
nella tavola fiorentina che gli era servita da spunto.
Nelle serie macabre sull’universalità della morte, H.
Holbein e H. Aldegrever scelsero, per la parte riguar-
dante il papa, una scena in cui un principe bacia rispet-
tosamente il piede al pontefice in trono41. Nel Passional
di Cranach, questo tema contrasta deliberatamente con
la evangelica Lavanda dei piedi.
La grande innovazione nel campo dei libelli illustra-
ti doveva essere il Passional Christi und Antichristi, pub-
blicato verso la meta del 1521 dall’editore Grunenberg.
Si suppone che l’opera sia uscita poco dopo la riunione
della Dieta di Worms. Melantone e il giurista Johann
Schwertfeger erano così decisi a trasformare l’opuscolo
in un’arma efficace che ordinarono delle citazioni bibli-
che contro le Decretali. Ne uscì una edizione latina:
Antithesis figurata Vitae Christi et Antichristi. Ma quella
che contò veramente fu l’edizione tedesca destinata alla
massa del pubblico laico. In una seconda edizione, l’in-
cisione II – il Cristo e Pietro nella foresta – fu sostitui-
ta dalla Crocifissione. Delle copie con xilografie furono
inviate a Erfurt e a Strasburgo; la diffusione fu consi-
derevole42. L’incontro di Lutero e di Cranach è, a que-
sto riguardo, un grande avvenimento: l’artista divenne
il ritrattista dei Riformatori. Il Passional fu l’opuscolo
più originale e più efficace mai concepito; secondo Lute-
ro «ein besonders für Leien gutes Buch» *. Col suo sim-
bolismo semplificato divenne il messaggio popolare per
eccellenza, e non c’era possibilità che venisse frainteso.
Il successo fu tale che nel 1536, nella grande sala del
castello di Torgau, Cranach raffigurò l’ascesa al cielo e
la caduta all’inferno, che concludono l’opuscolo43.
Nel 1520 Lutero aveva pubblicato, in risposta alla
scomunica, un commento della «Bolla dell’Anticristo»,
seguito immediatamente da un opuscolo, De captivitate
babilonica Ecclesiae. Il conflitto tra li monaco agostinia-
no e il papa non aveva ancora una grande risonanza al
Storia dell’arte Einaudi 85
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
di fuori degli ambienti clericali. Solo negli anni seguen-
ti desterà un vasto interesse popolare e solleverà una
ribellione dalle conseguenze incalcolabili, in particolare
con il Passional Christi und Antichristi. Questo libello
consisteva in tredici raffigurazioni affrontate del Bene
e del Male, cioè il Cristo dei Vangeli e il papa, sempli-
cemente commentate da un passo della Scrittura, in
tedesco44. Lucas Cranach aveva trovato le illustrazio-
ni-chiave per sostenere la dimostrazione che il papa di
Roma aveva invertito la dottrina evangelica. Egli eser-
cita il potere temporale mentre il Cristo rifiuta la coro-
na; il tempio è un antro di ladri; e, mentre il Figlio di
Dio sale al Cielo, la Bestia e il suo falso pontefice vanno
all’Inferno. Abbiamo qui una confutazione completa e
quasi parola per parola della dottrina delle Stanze del
Vaticano; il papa-Anticristo ha i lineamenti di Leone X
e le allusioni alla corte romana sono precise e ben scel-
te; ad esempio, l’illustrazione del torneo del Belvedere
associa il papa all’aristocrazia guerriera, mentre il Cri-
sto viveva fra gli umili. La rispondenza è così netta che
si può immaginare in Cranach e in Lutero la volontà di
replicare – questa volta a un livello popolare – alla dimo-
strazione data da Raffaello. Durante i venti mesi del
regno di Adriano VI, il Passional non poté essere igno-
rato da Roma. Perciò il compimento della Stanza di
Costantino nel 1524, con la sua affermazione della legit-
timità del potere temporale e la sua trionfale insistenza
sulla Virtù dei pontefici, può e anzi deve essere consi-
derato la risposta dottrinale di Roma.
Tutte le critiche sollevate nel corso dei secoli contro
l’istituzione del papato si trovavano raccolte, messe
insieme, diffuse in un librettino portatile fatto tutto di
illustrazioni. Questo non era che il primo passo di una
campagna che si sarebbe ampliata straordinariamente in
una guerra di immagini. La satira, però, non e tutto:
contemporaneamente alle stampe nate da questa pole-
Storia dell’arte Einaudi 86
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
mica fioriscono i fogli tratti dall’Apocalisse; questi
intrattengono l’idea di una catastrofe mondiale immi-
nente, rivelano quanto gli spiriti siano ossessionati dai
presagi e dalle visioni profetiche di ogni genere. Il clima
si appesantisce sotto questo sbarramento di segni cele-
sti, di annunzi terrificanti; il pensiero escatologico sale
si gonfia, riprende vecchi temi e, apparentemente, turba
tutti45.
Il primo stadio si stabilisce facilmente. Nell’autunno
del 1522 esce la Bibbia tedesca, il September Testament
di Lutero, a Wittenberg46. Solo l’Apocalisse è illustrata
e le 21 tavole, opera di Cranach e della sua bottega, sono
rese tutte attuali: così, a tav. 1, cavalieri e soldati reca-
no allusioni anti-papiste; a tav. 11, il mostro che attac-
ca i due testimoni ha la tiara; a tav. 16, la Bestia sul
trono porta la tiara e, del pari, la Grande Prostituta della
tav. 17. Questi attacchi erano così espliciti che offese-
ro il duca di Sassonia. In dicembre la nuova edizione eli-
minò la triplice corona, inopportuna. Ma l’essenziale era
stato detto in altro modo, sebbene sempre per immagi-
ni: a tav. 14, il crollo di Babilonia e il tema dell’intera
illustrazione, a differenza della corrispondente stampa
di Dürer, dove la distruzione della città maledetta per
mezzo del fuoco celeste non compare che in margine alla
scena. Cranach l’ha staccata, e se ne capisce il perché:
il panorama della città condannata è direttamente tra-
sposto dall’imago Romae di Hartmann Schedel (1493),
che abbiamo già citato47.
Si era così formato il contro-mito di Roma-Babilonia;
e in questa utilizzazione del tutto nuova dei mass-media,
il bersaglio principale era la Roma pontificia, ossia da
una parte l’istituzione e dall’altra la città stessa, l’ima-
go, che ne è il simbolo. I punti della denuncia sono sem-
plici, e ripetuti con una violenza altrettanto terribile
quanto monotona: città della corruzione abitata dal dia-
volo; città della falsa religione governata dall’Anticristo;
Storia dell’arte Einaudi 87
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
in breve, città del male identificata con la città mostruo-
sa dell’Apocalisse e, come questa, destinata a essere
distrutta dall’azione divina perché possa emergere la
vera religione. Non si tratta più dei temi anticlericali
comuni alle polemiche di quei chierici moralizzatori
come Petrarca o Erasmo, o agli attacchi feroci degli ere-
siarchi nordici come Wyclife, ma di una denuncia glo-
bale in cui le critiche tradizionali vengono a fondersi in
un odio in certo qual modo metafisico, un orrore imme-
diato ispirato dall’immagine48.
In questa fase, l’intervento degli artisti è importan-
te, se non fondamentale. Ma il caso di Hans Holbein è
diversissimo da quello di Cranach49. Holbein collaborò
a parecchie pubblicazioni luterane; per l’edizione del-
l’Antico Testamento nella traduzione di Lutero, pub-
blicata da Thomas Wolff a Basilea verso la fine del
1523, eseguì un gruppo di xilografie che riprendono il
modello di Wittenberg. Ma, come è stato chiaramente
dimostrato, questo intervento fu puramente professio-
nale e non comportava affatto un impegno ideologico.
Tuttavia, ci sono due stampe che suggeriscono una par-
tecipazione incontestabile al conflitto antiromano. Nel
Cristo vera luce che appare in un calendario stampato da
Johann Copp a Zurigo per il 1527, l’abisso a destra
aspetta Platone, Aristotele, gli scolastici e il papa, men-
tre i veri credenti si dirigono verso il Signore; la sim-
metria della composizione riporta ogni cosa nello spiri-
to della polemica protestante. L’altra stampa, Il traffico
delle indulgenze, è una caricatura virulenta, che mostra
a sinistra il perdono del Signore e a destra l’indegno
commercio al quale presiede il papa; gli stemmi a rilie-
vo indicati nello sfondo mostrano chiaramente che si
tratta di Clemente VII. Si è supposto che entrambe le
incisioni fossero state fatte in occasione di una Dispu-
tatio, la prima probabilmente per Farel nel marzo 1524.
Sarebbero dunque opere su ordinazione, che ci illumi-
Storia dell’arte Einaudi 88
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
nano sul tono assunto dalla polemica, e non necessaria-
mente sullo stato d’animo di Holbein. La famosa xilo-
grafia colorata dell’Hercules Germanicus, di cui vi è un
solo esemplare, sembra, almeno, una leale testimonian-
za dell’ammirazione dell’artista verso Lutero. Eppure,
forse anche qui non abbiamo che un documento di cir-
costanza; Holbein ha potuto al massimo dare lo schiz-
zo, perché la stampa non è al livello del suo disegno.
Inoltre, sarebbe stata elaborata per certi amici di Era-
smo, non del grande Riformatore, l’immagine di colui
che la folla scambia per un Ercole tedesco – con il papa
appeso al naso50 – raffigurazione alquanto ironica.
La dissacrazione di Roma poteva avvenire solo attra-
verso quel che si potrebbe chiamare una «diabolizza-
zione», ossia una santificazione rovesciata. Tutta la cri-
stianità gravitava intorno a questa città, che era la meta
di tanti pellegrinaggi, grazie ai quali l’imago urbis si era
diffusa in Occidente. Secondo quanto anche il ciclo
monumentale del Vaticano aveva solennemente riaffer-
mato, tutti pensavano che la città beneficiasse di uno
statuto storico privilegiato. Ben lungi dall’affievolirsi,
questo concetto di Roma aeterna era alimentato nel-
l’ambiente pontificio da ogni genere di speculazioni
sapienti51. Negli scritti di Egidio da Viterbo, Roma è la
città santa, dove si compie la storia umana: la morte di
Pietro, la conversione di Costantino, il rinnovamento in
corso ai tempi di Giulio II e di Leone X52. Egidio era un
monaco agostiniano come Lutero. È verosimile che si
siano incontrati durante il soggiorno di Lutero a Roma
nel 1510-11, che lo aveva fortemente disgustato. Lute-
ro si ricordò che Egidio aveva denunziato gli abusi e i
disordini della corte pontificia. È vero; ma Egidio attac-
cava le malefatte dell’ambiente romano e si doleva di
«questa Babilonia», perché aspettava un rinnovamento
spirituale che avrebbe fatto di Roma la nuova Gerusa-
lemme. Per questo teologo, che riassume tutto un aspet-
Storia dell’arte Einaudi 89
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
to del pensiero teologico al tempo di Giulio II e di
Leone X, il cristianesimo raccoglie l’eredità ebraica e
pagana. La Chiesa utilizza il luogo, gli edifici, i simbo-
li stessi da lei sostituiti: Giano, divinità romana, porta
le chiavi come San Pietro. Questa vocazione trae seco
necessariamente lo splendore e la monumentalità. L’i-
stituzione ha bisogno di essere riformata, i costumi
devono essere purificati, ma le esigenze del culto divi-
no, come il prestigio di Roma, richiedono un certo lusso
nella liturgia e splendore di ambiente. Pertanto Egidio
incoraggiava Leone X a proseguire l’opera gigantesca del
nuovo San Pietro. Approvava la campagna delle vendi-
te d’indulgenze per ottenere i fondi tanto necessari,
senza supporre la ribellione che queste stavano per pro-
vocare, o meglio far precipitare in Germania.
Invece di attenuarsi, le cause del conflitto e le incom-
patibilità si moltiplicavano di anno in anno. La poten-
za stessa delle forze che spingevano gli umanisti roma-
ni a celebrare il provvidenzialismo cattolico portò colo-
ro che lo rifiutavano a scandalizzarsi delle esibizioni di
fasto, dell’impegno nel cerimoniale e delle inclinazioni
profane, di cui si aveva quotidianamente spettacolo.
L’antagonismo era così profondo che si manifestava in
due modi di discorsi figurativi totalmente opposti: la tra-
dizione della pittura monumentale mediterranea al cul-
mine dei suoi poteri da un lato, l’arte diretta, popolare,
rapida delle stampe settentrionali dall’altro, che diven-
ta per la prima volta nella storia una forza importante
della vita culturale e religiosa53. Roma non utilizzava le
armi adeguate, i media moderni; non poteva sperare di
vincere. In una lettera ad Alberto di Brandeburgo nel
1525, Lutero dimostra fino a che punto fosse cosciente
del ruolo delle immagini polemiche; scriverà, vent’anni
più tardi, nel suo feroce trattato, Wider der Päpstum zu
Roma vom Teufel bestifft, la celebre frase: «Ho pubbli-
cato queste figure e queste immagini di cui ognuna rap-
Storia dell’arte Einaudi 90
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
presenta tutto un volume, che bisognerebbe ancora scri-
vere, contro il papa e il suo regno. Oh! come la troia si
rivoltolerà nel suo letamaio!»54.
L’Anticristo e i pronostici.
La Riforma, che prendeva rapidamente coscienza
della propria forza nazionale e della propria responsabi-
lità storica, era una somma di aspirazioni e di rivolte di
cui nessuno poteva prevedere il modo di organizzarsi.
Intorno alla formidabile energia polemica di Lutero, tre
gruppi tendevano a formarsi: gli intellettuali, eredi della
critica umanistica delle istituzioni religiose; i germani-
sti antiromani, preoccupati dell’autonomia e della
dignità della nazione tedesca; i predicatori popolari,
interpreti dei malesseri sociali. Appena raggruppatisi,
costoro, già dal 1525, incominciarono a separarsi, a liti-
gare. Ma, fra gli atteggiamenti comuni che potevano riu-
nirli, quello più profondamente condiviso, insieme all’a-
spirazione a uno stato più puro, più «primitivo» della
vita cristiana, era un intenso sentimento drammatico,
l’attesa della catastrofe55.
Nulla di più diffuso, di piú comune – vi partecipano
del pari il popolino e i teologi – che la credenza nella
venuta dell’Anticristo. «In papatu nihil magis celebre ac
tritum est quam futuri Antichristi adventu», dirà Cal-
vino, con il comprensibile disprezzo per la visione fan-
tastica e superstiziosa legata a questo grande mito esca-
tologico56. Nella Germania del secolo xv, ebbe grande
diffusione la favola dell’antimessia grazie a due sistemi
rappresentativi estremamente popolari: il teatro e le
stampe. Facendo leva sull’antisemitismo delle masse,
alcuni misteri, rappresentati in maniera efficace, evoca-
vano una orrenda cospirazione anticristiana che talvol-
ta faceva ridere a spese dell’alto clero, beffeggiato, ma
Storia dell’arte Einaudi 91
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
talvolta si concludeva con l’annunzio meno buffonesco
della venuta di Enoch e di Elia. La satira dei «Pazzi» e
l’irrequietezza religiosa si alternavano; si mescolavano in
miniature e xilografie strane, come quelle della «Nave
dei Pazzi»57.
Alla vigilia del sacco di Roma, non si trovano in Ita-
lia che calcoli superstiziosi e ossessioni. Tutti i fatti un
po’ sorprendenti sono «segni»58. L’interazione della poli-
tica, dei sogni collettivi e della simbolica, è costante. Nel
1496 avevano pescato, a Roma, un bizzarro mostro che
i nemici del papa chiamarono subito «Papstesel» (l’asi-
no del papa); nel 1522, in Sassonia, apparve un altro
mostro, metà vitello - metà monaco. Melantone e Lute-
ro non esitarono a pubblicare un’esegesi di quei feno-
meni straordinari, da cui risultava, evidentemente, che
la fine del papismo e del monachesimo era vicina59. A.
Warburg, F. Saxl e, piú recentemente, J. Baltru∫aitis
hanno mirabilmente dimostrato che nel Rinascimento
c’era stato un improvviso risveglio per la teratologia e
una specie di mania per gli auspici. Quest’attenzione ai
presagi s’intensificava notevolmente intorno al 1525.
«Portenta et omina» ispirano le immagini fantastiche
della raccolta De prodigiis di Polidoro Virgilio del 152660.
Si possono misurare la profondità dell’ansia e lo
smarrimento generale, in una situazione piena di avve-
nimenti mal definibili e di annunzi inquietanti, dal-
l’ampiezza e dalla diversità dei pronostici di qualsiasi
ordine. La brusca crescita dell’escatologia è innegabile61:
non c’era apparentemente altro modo di manifestare
un’angoscia generale. Se vi è un solo elemento caratte-
ristico di quel periodo, è il miscuglio di calcolo e di ras-
segnazione determinato dalla dominante ossessione del-
l’astrologia62. In un succedersi incredibilmente rapido,
ogni anno sono annunziati eventi spaventosi, catastro-
fi o riparazioni che impegnano il destino della cristia-
nità. Non appena un pronostico è superato, un altro ne
Storia dell’arte Einaudi 92
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
sorge con una colorazione politica diversa. La vene-
randa scienza del cielo, con le sue immagini antiche e
le sue formule arabe, tiene vivo un senso di fatalismo
corretto soltanto dall’opportunismo e dalla facilità di
dimenticare. Talune indagini sono potenzialmente peri-
colose. La polemica sulla dottrina delle grandi con-
giunzioni, dovuta ad Abu Masar, è una minaccia alla
solidità della fede perché, tanto per i «congiunzionisti»
come per l’autore della Summa iudicialis de accidentibus
mundi, i cicli astrali, attraverso le grandi rotture,
annunciano i cambiamenti del potere e quelli della reli-
gione63. Un’indagine fondamentale viene quindi intra-
presa dagli studiosi delle scienze fisiche e della storia
naturale in Italia.
I pronostici sono così numerosi, incrociati e con-
traddittori che si deve parlare di uno stato di eccitazio-
ne collettiva dove ciascuno sviluppa una profezia che
dovrebbe battere le altre. Queste profezie si traducono
in pamphlets o in opuscoli, spesso illustrati. E in que-
sto settore se ne trovano tanto in Italia quanto in Ger-
mania, poiché le due culture sono rivali nell’attività
«scientifica».
In un certo numero di casi il pronostico si lega così
da vicino al concatenarsi degli avvenimenti effettiva-
mente realizzati, che si è costretti a interrogarsi sul-
l’autenticità del testo, cioè a chiedersi se la data che
porta non sia falsificata. Un Prognosticon di un astrolo-
go italiano, Torquato, la cui prima edizione compare nel
1534 in latino e nel 1535 in tedesco, viene presentato
come un messaggio rivolto al re d’Ungheria Mattia Cor-
vino, e datato 148o: vi sono previsti lo scisma tedesco,
la disfatta di Pavia e il sacco di Roma; eventi che pre-
parano la purificazione della Chiesa e il trionfo del-
l’Impero sulla Francia e sui turchi. Si può solo suppor-
re che si tratta di un annunzio post eventum64. Tutti i pro-
nostici rivendicavano l’autorevolezza di un testo antico,
Storia dell’arte Einaudi 93
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
di una dottrina dimenticata, di un astrologo del passa-
to. Questa letteratura astrusa avocava a se tutto un pas-
sato di profetismo associato a movimenti mistici, e cer-
cava sostegno nell’autorità di alcune grandi figure una-
nimemente rispettate. Il ritorno d’interesse per Gioac-
chino da Fiore ne è l’espressione più notevole65. Egidio
da Viterbo si appoggia sulle sue prospettive simboliche,
come fanno, dal canto loro, i riformatori.
Aby Warburg ha messo in chiaro, qualche anno fa,
la meravigliosa storia della congiunzione che doveva
accadere nel novembre 1484 fra Giove e Saturno nello
Scorpione, il che doveva significare niente di meno che
un mutamento di religione66. Tutti i dotti italiani e tede-
schi hanno rivolto grande attenzione a questo problema,
prima e soprattutto dopo la data fatidica, in cui non
accadde nulla di speciale. Un astrologo, Lichtenberger,
pubblicò nel 1488 una pronosticatio studiando le conse-
guenze della congiunzione. Essa fu ripubblicata, come
per caso, nel 1526 e nel 1528. Al cap. xxxiii tratta del-
l’apparizione di un falso profeta. Nella cerchia di Lute-
ro, tutti avevano gli occhi fissi sulla data di nascita del
grande Riformatore: 22 ottobre 148467. Va da se che il
suo oroscopo era l’argomento del giorno. Su di un esem-
plare della pronosticatio qualcuno aggiunse un riferi-
mento ad esso. Tutto si trovava spiegato. E al cap.
xxxv, si legge: «L’imperatore entra a Roma, facendo
regnare il terrore: i romani fuggono, chierici o laici, nei
boschi, ma molti sono massacrati».
Gli annunzi catastrofici: inondazioni, piogge di
fuoco, devastazioni capaci di provocare vero panico,
non finivano più. Si sono contati 56 autori e 133 opu-
scoli a base di presagi e di calcoli astrologici per gli anni
1520-30. Le due ossessioni che ricorrono costantemen-
te sono la fine del mondo e la distruzione di Roma e del
papato. Nella Prognosticatio di J. Carion, del 1521, un
disegno esplicito mostra l’imperatore (Sole), il contadi-
Storia dell’arte Einaudi 94
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
no (Saturno), il papa (Giove) e il cavaliere (Marte) che
formano una composizione talmente inquietante che
Warburg l’ha commentata in questi termini: «Senza il
testo si potrebbe credere che il sacco di Roma per opera
dei lanzichenecchi tedeschi fosse già rappresentato»68.
Nella serie dei «Quattro temperamenti» (1528) libera-
mente tratti da un libretto di Hans Sachs, E. Schön ha
curiosamente scelto il pontefice come un improbabile
modello per esporre i diversi effetti del vino. Il tono sati-
rico è evidente; la tavola che illustra il temperamento
malinconico presenta, come il frontespizio di Carion,
l’attentato di un cavaliere contro il papa69. Nulla è più
significativo della violenza antiromana d’ispirazione ger-
manica e insieme luterana, che il frontespizio del Gesprä-
ch Büchlin di Ulrich von Hutten, edito a Strasburgo nel
152170, che rappresenta la collera antipapista con un
assalto di lanzichenecchi contro una folla di cardinali,
teologi e pontefice. Nella fascia in alto, il Signore impu-
gna la freccia della vendetta mentre Davide presenta una
tavoletta con l’iscrizione: «exaltare qui iudicas terram,
redde retribut[um] superbis». Parimenti, in un opusco-
lo anonimo in favore dei contadini apparso a Norim-
berga nel 1525 sotto il titolo An die Versamlung gemay-
ner Bawerschafft, il frontespizio pone in evidenza la
caduta del papa trascinato dalla ruota della Fortuna,
intorno alla quale si affrontano «die Romanisten und
Sophisten», ben presto vinti, e «die Bawerssmann güt
Christen» con le picche71.
Così, mentre la dottrina ostentata dai papi medicei
– che di fatto corrispondeva al pensiero tradizionale
della Chiesa – proclamava l’invulnerabilità della città
pontificia, tutto cospirava per fare dell’umiliazione della
Santa Sede e della distruzione della città eterna una
catastrofe necessaria. Il subcosciente collettivo, in Ita-
lia come in Germania, era scosso dalla credenza popo-
lare nei presagi e nei segni celesti: l’attentato contro
Storia dell’arte Einaudi 95
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Roma era considerato sintomatico della crisi finale del
mondo cristiano. Per i luterani, dal punto di vista reli-
gioso, il saccheggio simbolico della Città diventava un’o-
perazione indispensabile per il rinnovarsi della Fede cri-
stiana.
Questi timori e queste pulsioni oscure trovarono un
punto di cristallizzazione nella tensione che seguì il
1525. La politica imperiale, come quella papale, si infilò
in un processo di sviluppo fatale, dai particolari sor-
prendenti, ma che rispondeva bene alle idee fondamen-
tali dell’ambiente di Carlo: il papa, ministro delle anime,
deve essere subordinato all’Impero, amministratore del
mondo. Riviveva la vecchia idea ghibellina, come ai
tempi di Dante, con una forza straordinaria. I presagi
poetici la celebravano, quando l’Ariosto, ad esempio,
scriveva nel canto XV la famosa profezia di Astolfo:
Del sangue d’Austria e d’Aragona io veggio
nascer sul Reno alla sinistra riva
un principe, al valor del qual pareggio
nessun valor ...72.
Una corrente cavalleresca, aristocratica ed epica, la
cui diffusione è stata aiutata dalla vanagloria militare e
dai simboli tradizionali del potere, s’impadroniva di
tutta una generazione sia in Spagna sia in Francia. Die-
tro questo fervore c’erano immagini chimeriche e ambi-
zioni illimitate. Una di queste era il possesso di Roma.
Non furono però dei cavallereschi paladini, ma una trup-
pa eteroclita di ventura, che, in nome dell’imperatore,
prese Roma nella primavera del 1527, mentre tutti l’an-
nunziavano e i principali interessati rifiutavano di cre-
dervi.
Coloro che conservavano la mente fredda in mezzo
a tanta confusione erano rari. Le decisioni politiche
erano prese tra avversari, collaboratori o alleati le cui
Storia dell’arte Einaudi 96
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
fantasie turbate e conturbanti potevano a ogni momen-
to modificare il corso dell’azione. Guicciardini, che lo
sapeva meglio di ogni altro, non poté trattenersi dal-
l’osservare ironico a questo riguardo: «A troppo dura
condizione sarebbono sottoposti a’ consiglieri de’ prin-
cipi se fussino obbligati a portare in consiglio non solo
discorsi e condizioni umane ma ancora giudicii di astro-
logi o pronostici di spiriti o profezie di frati»73. Ma che
peso ha questa lucida riflessione di qualcuno che ha
veduto fallire tutto, di fronte alle ossessioni e ai presa-
gi che hanno permesso agli storici spagnoli di conclude-
re che il sacco «a causa más que material?»74.
Come prova del sempre maggior numero di espliciti
segni sovrannaturali, un testimone spagnolo anonimo ha
riferito il susseguirsi dei fatti successi ogni giovedì santo
del pontificato dal 1524 in poi; al primo, nulla; al secon-
do, il velo dell’altare bruciò; al terzo, il tabernacolo del
Santo Sacramento cadde durante l’officio; il quarto, un
loco (un pazzo) si alzò in piedi e insultò il papa75. Gran
caso si è fatto delle manifestazioni e delle stravaganze
pubbliche di quel predicatore da strada, soprannomina-
to Brandano («colui che brandisce»), che perseguitava
Clemente. Il giovedì santo 18 aprile 1527, durante la
benedizione pontificia dalla Loggia di San Pietro,
Brandano comparve nudo vicino alla statua di San
Paolo e gridò: «Bastardo sodomita, pei tuoi peccati
Roma sarà distrutta; confessati e convertiti. Se tu non
lo vuoi credere, fra quattordici giorni lo vedrai». Rico-
minciò il giorno di Pasqua a Campo de’ Fiori: «Roma,
fa penitenza. Con te si procederà come con Sodoma e
Gomorra»76. Come tutti i predicatori ambulanti, por-
tava un crocifisso e un teschio. Divenne così importu-
no che fu incarcerato fino all’arrivo degli imperiali, che
lo liberarono.
Incidenti del genere hanno sempre accompagnato le
grandi ansie collettive. Queste esplosioni esprimevano il
Storia dell’arte Einaudi 97
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
medesimo tipo di isterismo che, provocato dal bombar-
damento degli annunzi profetici, era scoppiato in pas-
sato a Firenze. «Si era arrivati – scrive lo storico tosca-
no Varchi – al punto che non solo i monaci sul pulpito,
ma anche dei Romani andavano per le piazze procla-
mando non solo la rovina dell’Italia ma la fine del
mondo, con alte grida minacciose. E non mancavano
persone che, persuase che la situazione presente non
potesse essere peggiore, dicevano che papa Clemente era
l’Anticristo»77. Esempio perfetto di autoesaltazione. In
termini identici, il cardinal Francesco Gonzaga annun-
ziava la notizia nelle sue lettere: «Si po ben hora dire
che N. S. Dio vol dare flagello a la Cristianità...» (da
Roma il 7 maggio); «Se ha da stare in gran.mo suspet-
to che de dì in dì non si scoprano nove angustie et
exterminii et che tutto il mondo habia da andare in fra-
casso et anichilatione: che si po’ fare fermo iudicio che
Dio habia evaginato la spada dela iustitia et revoltato il
vaso del’ira sua sopra la generatione humana» (da Ostia,
il 16 maggio)78. La caduta di Roma significa necessaria-
mente l’inizio dello sconvolgimento totale del mondo.
Alla fine del 1526, l’Aretino aveva pubblicato a Man-
tova un libretto di pronostici per l’anno 1527 che, oltre
a espressioni virulente contro Roma e la corte pontifi-
cia, conteneva, pare, una vera premonizione del sacco
di Roma79. Agli inizi del 1527 comparve a Venezia un
opuscolo intitolato Triompho di Fortuna, libro che per-
metteva di interrogare la sorte mediante dadi e caselle
che rimandavano le une agli altri in modo da comporre,
addizionandoli, una serie di presagi. L’incisione del
frontespizio è attribuita con valide ragioni a B. Peruz-
zi80. Esiste un disegno preparatorio a Oxford con alcu-
ne varianti – il Pantheon e la costruzione chiamata
Horologium di Augusto a San Lorenzo in Lucina – che
consentono di affermare che il disegno è stato legger-
mente modificato per precisare le allusioni alla città di
Storia dell’arte Einaudi 98
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Roma. Il dado e l’astrologia rispondono allo scopo del
libro. Il celebre orologio ricorda gli oroscopi o le date di
nascita. Il globo dell’universo si trova sottoposto alla
spinta di forze avverse, il bene e il male, che, in forma
di un angelo e di un demonio, girano l’enorme manovella
in direzioni opposte. Seduto sulla sommità, il pontefi-
ce romano, senza trono, inquadrato da due figure alle-
goriche, appare in uno strano stato di precarietà. Ven-
gono subito in mente i pontefici dominatori e gloriosi
raffigurati tre anni prima nella Stanza di Costantino,
fra coppie di Virtù, che sembravano al di là di qualsia-
si attacco.
L’intenzione pare esplicita; si è voluto prefigurare in
quell’inizio del 1527 uno dei momenti più difficili. Si
tratta di un pronostico figurato, che riprende e adatta
alla situazione critica del potere pontificio uno dei più
vecchi motivi iconografici dell’Occidente. Non è più
una dea capricciosa a far girare la ruota di Fortuna, e
neppure la mano della Provvidenza. Conformemente a
un’evoluzione generale di questi schemi simbolici, abbia-
mo una drammatizzazione della scena mediante l’azio-
ne contraria di due forze soprannaturali e un’indivi-
duazione della potenza in causa, di cui le due virtù sem-
brano suggerire ch’essa ha ancora qualche mezzo d’in-
tervento sul corso delle cose81; non tutto evidentemen-
te è perduto, l’angelo vincerà forse ancora. La sostitu-
zione del globo terrestre alla ruota di Fortuna si impo-
ne in un trattato astrologico che ha a che fare coi pia-
neti; la fascia dello zodiaco attraversa obliquamente la
sfera82. Quest’equilibrio complesso, o meglio questa con-
fusione tra fatalità astrale, lotta delle forze sovrannatu-
rali e azione umana – preghiera o decisione – descrive
la gravità della situazione di Roma. L’imminenza del
dramma si coglie dalla stranezza dell’immagine.
Storia dell’arte Einaudi 99
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
1
La prima guida di questo genere risale al 1150 circa, l’Opusculum
de mirabilibus novae et veteris urbis Romae del canonico F. Albertini è
datato 1510 (ristampato nel 1515, 1522, 1523). Cfr. scherer, Marvels
of Ancient Rome cit.
2
Si veda la piccola guida tedesca delle Mirabiliae Romae, stampata
circa nel 1475, ristampata in facsimile, Weimar 1904, con introduzio-
ne di R. Ehwald. È tipica delle guide della fine del secolo xv e dell’i-
nizio del xvi, cfr. pollak e schudt, Le guide di Roma cit., p. 23. Dà
quattro illustrazioni: pagina di sguardia: pellegrini e Santo Volto di
Veronica (cappella angolo Nord Est di San Pietro); la leggenda di
Romolo e Remo; Imperium Romae; Santo Volto, con le armi pontificie
dei Della Rovere (Sisto IV).
Sulla Veronica cfr. a. chastel, La Véronique, in «Revue de l’Art»,
n. 40 (giugno 1978), pp. 71-82.
3
Su Lutero a Roma, cfr. introduzione, nota 12.
4
renaudet, Erasme et l’Italie cit.
5
La cronologia e la dottrina delle Stanze sono esposte nell’opera di
d. redig de campos, Le Stanze di Raffaello, Roma 1950.
6
Questa stanza fu incominciata, almeno nella decorazione a grotte-
sche della volta, prima del 1521, poi intrapresa da Perino del Vaga, inter-
rotta nel 1523 e terminata poco prima del 1527. Cfr. m. v. brugnoli,
Gli affreschi di Perin del Vaga nella cappella Pucci, note sulla prima attività
romana del pittore, in «Bollettino d’Arte», 47 (1962), pp. 327 sgg. Vasa-
ri, nella vita di Giovanni da Udine, si riferisce all’epoca di Clemente, in
quella di Perino del Vaga, a quella di Leone X, per il tondo centrale.
7
Come lo ha perfettamente formulato R. Wittkower: «In expres-
sing one event through the other, and meaning both, the painting beco-
mes the symbol of an exalted mystery: the miraculous power of the
Church, which remains the same throughout the ages, whether we are
in the year 452 or 1513» (in Interpretation of Visual Symbols, 1955,
ristampato in Allegory and the Migration of Symbols, London 1977, p.
180).
8
La fusione di questi due registri: teologico e contemporaneo, è
stata analizzata da vicino nell’articolo di m. j. zucker, Raphael and the
Beard of Pope Julius II, in «The Art Bulletin», 59 (1977), p. 524, che
sarà anche utilizzato e completato nel cap. vi.
9
f. hartt, The Stanza d’Eliodoro and the Sistine Ceiling, in «The
Art Bulletin», 30 (1950), pp. 124 sgg. Non seguiamo l’autore nella sua
esegesi della Sistina.
10
zucker, Raphael cit., p. 530.
11
Sulle avventure militari del futuro Leone X, cfr. von pastor, Sto-
ria dei papi cit., vol. III, libro III, p. 816.
12
s. freedberg, Painting of the High Renaissance in Rome and Flo-
rence, Cambridge (Mass.) 1961, p. 152.
Storia dell’arte Einaudi 100
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
13
[Giulio II aveva ideato la tomba più grandiosa che sia mai stata
costruita, ma Michelangelo incontrò talmente tante difficoltà in quella
ordinazione che non fu mai portata a termine. Giulio fu sepolto in San
Pietro, dove giace tuttora senza alcun monumento commemorativo].
14
Cfr. cap. vi.
15
f. hartt, Raphael and Giulio Romano with Notes on the Raphael
School, in «The Art Bulletin», 26 (1944), pp. 67 sgg.; j. hess, On Raphael
and Giulio Romano, in «Gazette des Beaux-Arts», 32 (1947), pp. 86 sgg.,
espone un’opinione completamente diversa. La sua interpretazione ha
suscitato le dure obbiezioni di Hartt, The Chronology of the Sala di Costan-
tino, in «Gazette des Beaux-Arts», 36 (1949), pp. 301 sgg.
Si veda anche j. shearman, The Vatican Stanze Function and Deco-
ration, in «Proceedings of the British Academy», 57 (1971), pp. 3 sgg.
Rolf Quednau, dell’università di Monaco, ha scritto una tesi sul-
l’insieme dei problemi della Stanza di Costantino. Secondo questo
autore la parte decorativa è stata concepita da Raffaello, come pure le
scene storiche; il programma d’insieme è in rapporto con la destina-
zione ufficiale della Stanza. Cfr. Die Sala di Costantino im Vatikan Pala-
st, New York 1979, pp. 448 sgg. Quednau ha concluso ch’esso fu
«attualizzato» nel 1523.
16
Sull’importanza dei progetti di Raffaello cfr. j. sherman,
Raphael’s unexecuted Projects for the Stanze, in Walter Friedländer zum
9o. Geburtstag, Berlin 1965, pp. 177-80; l. dussler, Raphael, München
1966, pp. 96-97.
17
[Glovis è la lettura anagrammata di sivolg o volgersi, rispecchia l’os-
sessione propria dei Medici riguardo alla resurrezione e al rinnovarsi].
18
m. ferry, «Candor illaesus»: The «Impresa» of Clement VII and
other Medici Devices in the Vatican «Stanze», in «The Burlington Maga-
zine», 119 (1977), pp. 676 sgg. Questo studio, di cui seguiamo qui le
conclusioni, ci sembra porre termine alla discussione fra J. Hess e F.
Hartt sull’utilizzazione delle imprese.
Il soffitto, che è stato rialzato alla fine del secolo xvi, era in origi-
ne più basso, dorato, sistemato con «imprese del suave», e disposto in
modo da toccare la cima delle nicchie dei pontefici (shearman, The
Vatican Stanze cit., n. 45).
19
«The association of the history of Constantine with the persons
of the Papacy is of course generally sensible, and in the circumstances
of this moment in the history of the Church it was evidently intended
as a homily on the proper relation of the temporal and especially of the
Imperial, to the papal, spiritual power: this room contains the admo-
nition that was so drastically to be disobeyed in 1527» (freedberg,
Painting of the High Renaissance cit., p. 570).
20
Come ha dimostrato hess, On Raphael and Giulio Romano cit.,
pp. 79 sgg., con l’aiuto delle Vitae Pontificum (1479) del Platina. Non
Storia dell’arte Einaudi 101
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
vi è dubbio che l’ordine primitivo è stato alterato dai ritocchi sopra le
iscrizioni e dalle false identificazioni posteriori, destinate a mettere in
valore il titulus dei papi regnanti.
I due pontefici che inquadrano il Battesimo sarebbero quindi a
destra Clemente I (e non san Leone I) e a sinistra Evaristo (e non Urba-
no I). Il primo, fra Innocentia e Veritas, raffigurerebbe Clemente VII,
come appariva quando era cardinale e nei quattro primi anni del suo
regno (identificazione confermata dalla raffigurazione originale di Can-
dor illesus segnalata sopra, nota 7). La seconda figura, quella dello
Pseudo Urbano I, è stata identificata come quella di Clemente barbu-
to da crowe e cavalcaselle, Raphael, his Life and Works, London
1885, vol. II, p. 535, poi da o. fischel, I ritratti di Clemente VII nella
Sala di Costantino in Vaticano, in «Illustrazione Vaticana», 1937, pp.
923 sgg. Il che è stato contestato da j. hess, On Raphael and Giulio
Romano cit., p. 82, perché il volto è troppo vecchio; l’argomento non
è valido, poiché Clemente era stato invecchiato dalle disgrazie, e, per-
tanto, non si poteva che presentarlo così se si giudicava opportuno
introdurre una seconda volta la sua effigie, adattando la testa del papa
tra Justitia e Veritas – il che non ha nulla d’impossibile. Infatti si trat-
ta di una parte che è stata rifatta a olio, e, dal punto di vista icono-
grafico, il duplice gesto del pontefice che fa appello con l’indice alla
Carità senza rifiutare, d’altra parte, la Giustizia, poteva sembrare adat-
tarsi a un pontificato così tumultuoso e difficile come quello di Cle-
mente. In ogni modo, il suggerimento emesso da hess, On Raphael and
Giulio Romano cit., pp. 84 sgg., che il ritocco riguardasse Sisto V, non
può essere accettato. Torneremo più avanti sui vari problemi legati al
fatto di portare la barba a Roma.
21
Chatsworth, Collezione Devonshire. f. hartt, Giulio Romano,
New Haven 1958, p. 51 e tav. 79.
22
Un insieme di disegni di antichità datati circa il 1515 è stato
messo in rapporto con la Stanza di Costantino, dove hanno potuto esse-
re utilizzati nelle due prime composizioni: ipotesi di e. robert, Über
ein dem Michelangelo zugeschriebenes Skizzenbuch auf Schloss Wolfegg,
in «Römische Mitteilungen», 16 (1901), accompagnata con un’attri-
buzione a Giulio Romano che è stata respinta da H. Wickhoff, 1902,
e hess, On Raphael and Giulio Romano cit.
L’interesse di Giulio per la Colonna Traiana è segnalato da vasa-
ri, Le vite cit., V, p. 530, come pure il progetto di produrre una serie
di incisioni.
23
hess, On Raphael and Giulio Romano cit., p. 90, ha identificato
un certo numero di ritratti: Philippe de Villiers de L’Isle-Adam, Gran
Maestro dei Cavalieri di Rodi; Camillo Caetani, duca di Sermoneta;
«il cavalierino» disegnato da Vasari.
24
Le differenze di stile e di concezione fra i due affreschi militari
Storia dell’arte Einaudi 102
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
e tardo-antichi e le due composizioni paleocristiane sono già state sot-
tolineate da h. dollmayr, Rafaels Werkstätte, in «Jahrbuch der Kun-
sthist. Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses», 12 (1895), pp.
231 sgg.
25
t. buddensieg, Gregory the Great, the Destroyer of Pagan Idols, in
«Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 28 (1965), pp. 53
sgg. ha dato delle ragioni per non seguire l’interpretazione di J. Hess,
che vi vede aggiunte posteriori del tempo di Gregorio XIII e Sisto V,
in concomitanza con la pittura centrale del soffitto del 1585: Il Trionfo
della Croce sugli dei pagani di T. Laurenti. La «caricatura» di Miche-
langelo nel Trionfo di Fortuna del 1527 ripete gli elementi principali del
pannello e perciò lo datano. Ma la relazione può invertirsi e il dipinto
avere sfruttato una vecchia composizione.
26
Qualcosa del genere è stato indicato da hess, On Raphael and
Giulio Romano cit., p. 91: «perhaps the beginning of the controversy
over the Donation of Constantine was one of the reasons for the chan-
ge» (suggerimento di C. Mitchell). Sotto questa forma, l’indicazione
non è esatta: la controversia durava da generazioni: ma il libello di L.
Valla l’aveva resa più stringente e la ribellione luterana implacabile.
27
milanesi, I corrispondenti di Michelangelo cit.; hartt, Giulio
Romano cit., I, p. 43.
28
hartt, Giulio Romano cit., I, p. 45, nota 10.
29
m. petrassi, La leggenda di San Silvestro, in «Capitolium», 45
(1970), pp. 33 sgg.; w. levison, Konstantinische Schenkung und die Sil-
vesterlegende, in Miscellanea F. Ehrli, Roma 1924, vol. II, pp. 159 sgg.
30
w. setz, Lorenzo Vallas Schrift gegen die Konstantinische
Schenkung: «De falso credita et ementita Constantini donatione», «Bibl.
des deutschen historischen Instituts in Roma», 44, Tübingen 1975.
31
a. j. lamping, Ulrichus Velenus and his Treatise against the Papacy,
«Studies in Mediaeval and Reformation Thought», 19, Leiden 1976.
32
Non basta dunque dire con j. hess, in Kunstgeschichtliche Studien
zu Renaissance und Barock, Roma 1967, p. 414: «Das zur Ausführung
gekommene Bildthema ist offenbar in polemischer Absicht als Reak-
tion gegen Valla gewählt worden» (II tema che sviluppava era eviden-
temente stato scelto con intenzione polemica contro Valla). Il pro-
gramma comporta un richiamo calcolato allo statuto di Roma e alla
supremazia dei papa, contestati sia dai luterani sia dagli imperiali.
33
Già Wyclife aveva dichiarato che Costantino era ispirato dal
demonio; era stato condannato dal Concilio di Costanza, sessione
XLV, 33.
Si veda il trattato del cardinale G. Paleotti (1581), Discorso intor-
no alle immagini sacre e profane, in Trattati d’arte del Cinquecento, a cura
di P. Barocchi, vol. II, Bari 1961, p. 277.
La discussione sulla validità della Donazione di Costantino ha
Storia dell’arte Einaudi 103
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
accompagnato nel xi e xii secolo il conflitto tra l’imperatore e il papa,
cfr. m. pacaut, La Théocratie, l’Eglise et le pouvoir au Moyen-Age,
Paris 1957, p. 238.
La diffusione del tema di Costantino cavaliere nella scultura e nel
mosaico romani deve essere messo in relazione con il successo dell’i-
deologia imperiale; il battesimo di Costantino raffigurato verso il 1170
nel portico orientale di San Giovanni in Laterano (incisione in g. ciam-
pini, De sacris aedificiis a Costantino Magno constructis, Roma 1693;
acquarello in s. waetzoldt, Die Kopien des 17. Jahrhunderts nach
Mosaiken und Wandmalereien in Rom, Wien 1962, tav. 84) e nel ciclo
dei Santi Quattro Coronati del 1246, ricorda invece il primato del
sacerdozio. Cfr. h. lavagne, Triomphe et Baptême de Constantin.
Recherche iconographique à propos d’une mosaïque médiévale de Riez, in
«Journal des Savants», luglio-settembre 1977, pp. 164-90.
34
Bisogna riaccostare questa tradizione all’informazione contenu-
ta in una lettera del segretario Pérez all’imperatore, datata da Roma,
il 4 agosto 1527: Lannoy gli aveva scritto che la corte gli ingiungeva
di offrire al papa il tributo e un cavallo bianco. Cfr. de gayngos,
Calendar of Letters cit., n. 145.
35
j. träger, Der reitende Papst, München e Zürich 1970. La caval-
cata del papa e dell’imperatore esprime la concordia dei due poteri (cap.
ii). Così l’ingresso di Sigismondo al Laterano, sulla porta di bronzo dei
Filarete a Roma (1465), e nel 1530 la processione a cavallo di Bologna
debitamente divulgata dall’incisione (cfr. cap.vi). È verosimile che la
coppia dell’imperatore sul cavallo baio e del papa su un cavallo bian-
co, nel Carro di fieno di H. Bosch (Prado), debba essere interpretata
come una derisione del simbolo.
I due rilievi hanno catturato l’attenzione soltanto di J. Hess, ma
i suoi suggerimenti iconografici sono erronei. La conclusione «that
there need not necessarily he any relation between them and the
Popes sitting below», è troppo facile. Non sappiamo se bisogna riag-
ganciarli al progetto iniziale (ipotetico) di Raffaello. L’autore può
essere, come propone J. Hess, Lorenzetto, il collaboratore di Raffael-
lo a Santa Maria del Popolo, al quale, dopo i combattimenti di Castel
Sant’Angelo, Clemente ordinerà la statua di San Pietro all’imbocco del
ponte (cap. vi).
36
[Gioachino da Fiore, monaco cistercense del secolo xii, predica-
va una età di rinnovata spiritualità, che avrebbe reso non più necessa-
ria la gerarchia della Chiesa. Dante lo colloca nel Paradiso].
37
Sui Vaticinia, cfr. r. bainton, Ein wunderliche Weyssagung: Osian-
der, Sachs, Luther, in «Germanic Review», 16 (1946), 3, ristampato in
Studies on the Reformation, Boston 1963, pp. 62 e sgg.; m. reeves, The
Infuence of Prophecy in the Later Middle Ages. A Study in Joachimism,
Oxford 1969.
Storia dell’arte Einaudi 104
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
38
a. osiander e h. sachs, Eyn wunderliche Weyssagung von dem
Babstumb..., Nürnberg 1527. Cfr. a. warburg, Heidnisc-antike Weis-
sagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten, 1920, stampato in Gesam-
melte Schriften, vol. II, Leipzig 1932.
39
Sul ruolo delle stampe cfr. m. geisberg, Die Reformation in den
Kampfbildern der Einblattsholzschnitten, München 1929; a. blum, L’e-
stampe satirique en France pendant les guerres de religion, Paris 1916.
Gli autori del secolo xix hanno tutti messo in rilievo che la Rifor-
ma ha ottenuto la partecipazione delle masse grazie al carattere pole-
mico, diretto, caricaturale e implacabile delle stampe: o. schade, Sati-
ren und Pasquillen aus der Reformationszeit, vol. I, Hannover 1856. e.
fuchs, Die Reformation, in Die Karikatur der europäischen Völker, Ber-
lin 1901, cap. iv, ha ben dimostrato quanto Lutero fosse cosciente di
quest’azione presso le masse.
40
k. a. wirth, «Imperator pedes papae deosculatur». Ein Beitrag zur
Bildkunde des 16. Jahrhunderts, in Festschrift für H. Keller, Darmstadt
1963, pp. 175-221.
41
h. zschelletzschky, Die «drei gottlosen Mayer» von Nürnberg.
Sebald Beham, Barthel Beham und Georg Pencz, Leipzig 1975, pp.
143 sgg.
42
d. koeplin e t. falk, catalogo della mostra Lukas Cranach, vol.
I, Basel e Stuttgart 1974, pp. 330 sgg.
* [«un libro straordinariamente buono per i laici»].
43
f. buchholz, Protestantismus und Kunst im sechzehnten Jahrhun-
dert, Leipzig 1928, pp. 36 sgg.
44
h. grisar e f. heege, Luthers Kampfbilder, vol. I, Freiburg im
Breisgau 1921; a. schramm, Luther und die Bibel, vol. I: Die Illustra-
tionen der Lutherbibel, Leipzig 1923.
45
h. preusz, Die Vorstellungen vom Antichristi im späteren Mittelal-
ter, bei Luther und die konfessionnellen Polemik, Leipzig 1906; p. picca,
Il Sacco di Roma del 1527: profezie, previsioni, prodigi, in «Nuova Anto-
logia», 16 (1929), pp. 120 sgg.
46
Sul September Testament, cfr. f. schmidt, Die Illustration der
Lutherbibel (1522-1700), Basel 1962.
47
Cfr. cap. i. Nelle Conversazioni a tavola di Lutero, si misura la
profondità della rottura con Roma, che riduce gli avvenimenti del
1527 alla sciagura dei cattivi: «Ex Satana enim est Papa» (1531),
Tischreden, n. 210, Weimar 1913, p. 323; (1538), ibid., n. 3717, p. 559.
48
j. janssen, L’Allemagne et la Réforme, trad. franc. Paris 1892, ha
particolarmente insistito sull’aspetto antiromano e antiitaliano della
Riforma, e in particolare sugli scritti estremamente violenti di U. von
Hutten.
49
h. reinhardt, Einige Bemerkungen zum graphischen Werk Hans
Holbein des Jüngeren, in «Zeitschrift für schweizerische Archäologie
Storia dell’arte Einaudi 105
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
und Kunstgeschichte», 34 (1977), pp. 242 sgg.; Catalogo della mostra
Die Malerfamilie Holbein in Basel, Basel 1960, nn. 403, 407 e 408.
50
t. burckhardt-wertheman, Über Zeit und Anlass des Flugblat-
tes: Luther als Hercules germanicus, in «Basler Zeitschrift», 4 (1905), pp.
48 sgg.; citato da reinhardt, Hans Holbein des Jüngeren cit., p. 242.
51
Sulla nozione di Roma aeterna, cfr. k. j. pratt, Rome as Eternal,
in «Journal of the History of Ideas», 25 (1965), pp. 25 sgg.
52
Su Egidio da Viterbo si veda j. w. o’malley, Giles of Viterbo on
Church and Reform. A Study in Renaissance Thought, Leiden 1968; Ful-
fillment of the Christian Golden Age under Pope Julius II: The text of a
Discourse of Giles Viterbo, 1507, in «Traditio», 25 (1969), pp. 265 sgg.;
e le indicazioni date sopra, nella introduzione.
53
blum, L’estampe satyrique cit., t. wright, Histoire de la carica-
ture et du grotesque, trad. franc., Paris 18752 p. 58, cita Eck: «Infi-
nitus iam erat numerus qui victum ex lutheranis libris quaeritantes,
in speciem bibliopolarum Ionge lateque Germaniae provinciae vaga-
bantur».
54
Citato da fuchs, Die Reformation cit., cap. iv.
55
«A heightened sense of eschatology»: r. bainton, The Left Wing of
the Reformation, in «Journal of Religion», 21 (1941), 2; ristampato in
Studies on the Reformation cit., pp. 119 sgg.
56
preusz, Die Vorstellungen cit., pp. 28 sgg.; reeves, Infuence of
Prophecy cit., cap. iii: The Antechrist; a. chastel, L’Antéchrist à la
Renaissance, 1952, ristampato in Fables, Formes, Figures cit., n. 6.
57
In un manoscritto tedesco, l’Anticristo, nella sua sanctitas simu-
lata, porta un enorme reliquiario e si rivolge all’assemblea cristiana, rap-
presentata da un papa e un cardinale, e alla famiglia umana, rappre-
sentata dagli esseri più inverosimili. Cfr. preusz, Die Vorstellungen cit.,
p. 35.
58
Le pietre che cadevano, gli accidenti e le anomalie erano segni.
Essi si moltiplicavano. Un francese ha raccontato nel suo opuscolo sugli
avvenimenti: Bellum romanum, che «il signore del cielo ci manifestò
con segni indubbi la prossima venuta della sciagura» (dorez, Le sac de
Rome cit., pp. 356 sgg.).
59
grisar e heege, Luthers Kampfbilder cit., cap. i; j. céard, La
Nature et les prodiges. L’insolite au XVIe siècle en France, Genève 1977,
pp. 79-83.
60
warburg, Heidnisch-antike Weissagung cit.; f. saxl, Illustrated
Pamphlets and the Reformation, 1948, ristampato in Lectures, London
1957; j. baltru∫aitis, Réveils et prodiges. Le gothique fantastique, Paris
1960, cap. ix.
61
Lo spirito di contrizione che invase numerosi elementi della
Curia dopo il 1527 si tradusse con la medesima formula Roma-Babilo-
nia, e il medesimo riferimento alla profezia di Isaia e all’Apocalisse
Storia dell’arte Einaudi 106
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
rivolte contro Roma stessa. Così nel discorso al Tribunale della Rota
del 15 maggio 1528, Che fu pubblicato a Roma e – e cosa che non stu-
pisce – tradotto in tedesco (cfr. cap. vi).
62
Oltre a warburg, Heidnisch-antike Weissagung cit., si veda l.
thorndike, A History of Magic and Experimental Science, vol. V, New
York 1941, p. 2-33; e. garin, Lo Zodiaco della vita. La polemica sul-
l’astrologia dal Trecento al Cinquecento, Bari 1976.
63
lorenzo bonincontri, De rebus caelestibus, 1472-75, edito a
Venezia da Luca Gaurico nel 1526. Sulla congiunzione di Giove e di
Saturno nell’Ariete, l’autore aveva molto da dire; ne conosceva tre,
coincidenti con il Diluvio, la venuta del Signore Gesù e quella di Mao-
metto; la quarta sembrava corrispondere a una nuova potenza univer-
sale: «Et regem dabit innocuum qui terminet orbem».
Sulla teoria delle grandi congiunzioni, e sulla sua importanza nei
dibattiti sull’astrologia, cfr. garin, Lo Zodiaco cit.
64
Su Torquato, cfr. reeves, Influence of Prophecy cit., p. 364; can-
timori, Eretici cit., pp. 18-20.
65
reeves, Influence of Prophecy cit.
66
warburg, Heidnisch-antike Weissagung cit; garin, Lo Zodiaco cit.
67
L’importanza annessa all’oroscopo di Lutero sussiste nella pole-
mica antiprotestante fino al secolo xvii e oltre; per esempio, f. de rae-
mond, Histoire de la naissance, progrez et décadence de l’hérésie de ce siè-
cle, Rouen 1629, pp. 28 sgg., nota che dopo Jonctin, «Marte e Vene-
re si trovarono nella terza casa della sua natività, il che significa la cadu-
ta della fede».
68
warburg, Heidnisch-antike Weissagung cit. pp. 510-11; saxl,
Illustrated Pamphlets of the Reformation cit., pp. 255 su.: «The books
are only a fraction compared with the pamphlets which were produ-
ced».
Su questa questione, cfr. m. pegg, A Catalogue of German Refor-
mation Pamphlets (1516-46) in Libraries of Great Britain and Ireland, vol.
I, London 1973, vol. II, 1977; r. w. brednick, Die Liedpublizistik in
Flugblatt des 15. bis 17. Jahrhunderts, 2 voll., Baden-Baden 1974 e 1975.
69
Die vier Eigenschaften des Weins. Cfr. catalogo della mostra Von
der Freiheit eines Christenmenschen (Kunstwerke und Dokumente aus
dem Jahrhundert der Reformation), Charlottenburg Schloss, Berlin
1967, pp. 22-23.
70
Catalogo della mostra Hans Baldung Grien, Karlsruhe 1959,
fig. xxxiv.
71
a. wass, Die Bauern im Kampf um Gerechtigkeit 1300-1525, Mün-
chen 1964, p. 223. Altra versione di Glücksrad, obbediente all’azione
energica delle persone abbienti. Cfr. l’Epilogo.
72
[Carlo era nato a Gand, pertanto in territori posti a occidente
(sulla riva sinistra) del Reno].
Storia dell’arte Einaudi 107
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
73
guicciardini, Consolatoria fatta di settembre 1527 a Finocchieto,
tempore pestis, citata nell’edizione, a cura di S. Volpicella, di L. San-
toro, p. 256. È stato osservato non senza meraviglia che lo stesso
Guicciardini ha passato del tempo, pare nel 1528, a compilare una scel-
ta dei testi profetici di Savonarola. Vi si legge, in particolare, il passo:
«O Roma, o prelati di Roma, io vi avviso che voi non avete a guasta-
re questa opera» (25 febbraio 1497). Cfr. palmarocchi, Scritti auto-
biografici e rari di F. Guicciardini cit., p. 313.
74
Il sacco «a causa mas que material» fu la conclusione del conte
de la roca, Epitome de la vida y echos del emperador Carlos, Milano
1646; parimenti antonio canovas del castillo, Del assalto y saco di
Roma por los Españoles, Madrid 1858.
Nella sua Cronaca, il milanese Grumello si adopera a discolpare il
conestabile; a tale scopo, sottolinea il fatto che il saccheggio della città
era un atto voluto dal cielo, l’adempimento della profezia di Samuele:
«Roma declinabit vires et carebit ecclesiastico duce et Rex Romanorum
possedebit eam», e di quelle di santa Brigida di Svezia (Cronaca di
Antonio Grumello pavese [1465-1529], a cura di Muller, Milano 1856).
75
rodríguez-villa, Memorias cit., pp. 140 sgg.
76
von pastor, Storia dei papi cit., vol. IV, parte Il, libro III, cap.
3, p. 247. Il vero nome del personaggio era Bartolomeo Carosi. Esiste
una biografia non pubblicata dovuta a Camillo Turci, cfr. orano, Mar-
cello Alberini cit., p. 246 nota 2; g. b. pecci, La Brandaneide, Lucca
1757; picca, Il Sacco di Roma cit., pp. 235 sgg.
77
b. varchi, Storia fiorentina, Colonia 1721, libro X, cap. 18, cita-
to da picca, Il Sacco di Roma cit., p. 122. Secondo lo stesso autore, una
lettera indirizzata al datario Giberti da Venezia, l’11 dicembre 1526,
annunziava il sacco di Roma.
78
Lettere al marchese di Mantova, pubblicate da a. luzio, Isabel-
la d’Este e il Sacco di Roma, Milano 1908, pp. 121-22 (7 maggio) e
124-26 (16 maggio).
79
luzio, Pietro Aretino nei primi suoi anni cit., pp. 8 e 9, Introdu-
zione.
80
r. eisler, The Frontispiece to Sigismondo Fanti’s «Trionfo di For-
tuna», in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 10
(1947), pp. 155-59.
81
Un’incisione a guisa di fregio, da un arazzo del secolo xv intito-
lato precisamente l’arazzo di Michelfeldt, descrive in cinque scene il
corso immorale del mondo e il regno dell’ingiustizia. Le tre figure del
professore, del prete e della Provvidenza tengono in equilibrio la ruota
della Fortuna, nella quale le condizioni sono raffigurate da uccelli, men-
tre la volpe (Fuchs) si volge in senso contrario al tempo (Zeit). Cfr.
zschelletschky, Die «drei gottlosen Maler» von Nürberg cit. Questo
non è ritenuto (con ragione, a nostro avviso) opera di Dürer da e.
Storia dell’arte Einaudi 108
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
panofsky, Albrecht Dürer, Princeton 1943, n. 391 [trad. it. La vita e
le opere di Albrecht Dürer, Milano 1967].
82
La formulazione di un tema accettabile per il medioevo cristiano
risale alla Consolatio Philosophiae di Boezio (vi secolo). Cfr. p. cour-
celle, La Consolation de Philosophie dans la tradition littéraire, Paris
1967. La più antica rappresentazione della ruota con le quattro posi-
zioni: regnabo (a destra), regno (in alto), regnavi (a sinistra), sum sine
regno (in basso), appare in un manoscritto dell’xi secolo a Monte Cas-
sino, di poco anteriore, sembra, a un pavimento a mosaico in San Sal-
vatore di Torino. Cfr. e. kitzinger, World Map and Fortune’s Wheel:
A Mediaeval Mosaic Floor in Turin, 1973, in The Art of Byzantium and
the Mediaeval West, Selected Studies, a cura di F. Kleinbauer, 13 voll.,
Bloomington e London 1976, p. 345. L’allegoria è di due tipi: la For-
tuna gira il meccanismo ciclico, o è essa stessa all’interno del sistema.
Su una miniatura celebre dell’Hortus deliciarum (xii secolo), la Fortu-
na troneggia sulla terra, azionando la manovella della macchina. Di fac-
cia alla personificazione di Fortuna, potenza cieca e fatale, è regolar-
mente posta quella di Sapientia.
Il motivo illustrava la futilità degli onori e la «vanità delle vanità»;
ha subito trasformazioni notevoli durante il xv e il xvi secolo, cfr. a.
doren, Fortuna im Mittelalter und in Renaissance, in «Vorträge der
Bibl. Warburg», 2 (1922-23). Ne è stato cambiato il carattere, un po’
come quello dell’Ercole al crocicchio delle strade studiato da E. Panof-
sky. Cfr. anche Epilogo, nota 35.
Storia dell’arte Einaudi 109
Capitolo terzo
«Urbis direptio»
«A dí 6 de magio 1527 fo la presa di Roma», questa
iscrizione fu ritrovata sul muro sud del salone della Villa
Lante, ex villa di Baldassarre Turini sul Gianicolo1.
Occupata fin dall’inizio dall’esercito imperiale, è uno dei
punti della collina da dove indubbiamente si poté segui-
re in modo mirabile, dopo che si era diradata la nebbia,
la corsa delle truppe vittoriose attraverso le vie. Altre
iscrizioni fatte con la punta della daga furono ritrovate
in posti non meno significativi. Ma prima di annotarle,
dobbiamo osservare che parecchi capitani dell’esercito
imperiale, hanno lasciato memoriali. Avevano parteci-
pato a fatti troppo straordinari per non essere tentati di
riferirli. Uno di loro ha raccontato in una sola pagina
come fosse avvenuta l’occupazione dei lanzichenecchi
nel 1527.
Il 6 maggio abbiamo preso d’assalto Roma, ucciso sei-
mila uomini, saccheggiato le case, portato via quello che tro-
vavamo nelle chiese e dappertutto, e finalmente incendia-
to una buona parte della città. Strana vita davvero! Abbia-
mo lacerato, distrutto gli atti dei copisti, i registri, le let-
tere, i documenti della Curia. Il papa è fuggito in Castel
Sant’Angelo con la sua guardia del corpo, cardinali, vesco-
vi, abitanti di Roma e membri della Curia sfuggiti al mas-
sacro. L’abbiamo assediato per tre settimane fino a che,
spinto dalla fame, dovette consegnare il castello. Quattro
Storia dell’arte Einaudi 110
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
capitani spagnoli, fra cui un nobile, l’abate de Najera, e un
segretario imperiale, sono stati delegati dal principe d’O-
range per la consegna del castello. Il che fu fatto. Là abbia-
mo trovato il papa Clemente con dodici cardinali in un ripo-
stiglio. Il papa ha dovuto firmare la convenzione di resa che
gli ha letto il segretario. Tutti si lamentavano miseramen-
te; piangevano molto. Siamo tutti ricchi.
Avevamo occupato Roma solo da due mesi che già cinque
mila dei nostri morirono di peste, perché non si seppelliva-
no i cadaveri. In luglio, mezzi morti, lasciammo la città per
le Marche allo scopo di trovare un’altra aria migliore...
In settembre, di ritorno a Roma, saccheggiammo la città
ancora più a fondo e trovammo grandi tesori nascosti. Vi
siamo rimasti alloggiati altri sei mesi2.
Molte cose in poche parole. Veniamo a conoscere le
tre fasi dell’occupazione o del saccheggio. Prima la gran-
de settimana che esordì il 6 maggio e che, veduta retro-
spettivamente, assume un carattere «strano»: case
distrutte, chiese messe a sacco, documenti ecclesiastici
perduti per sempre. Poi il periodo dell’assedio, la resa,
il bottino di guerra, tutto riassunto nelle parole «pian-
gevano molto; siamo tutti ricchi». Quindi, dopo l’on-
data di epidemia che costringe a evacuare la città, il
ritorno in settembre, che significò sei mesi di saccheg-
gio metodico, turbato soltanto da violente liti interne fra
i corpi nazionali e i capitani. Questo calendario spiega
molte cose. In un clima di anarchia totale, l’occupazio-
ne fu interminabile, con gli andirivieni di gruppi rivali,
le diserzioni, i disordini, i traffici, fino alla partenza
delle truppe nel febbraio 15283. A questa data, secondo
Guicciardini, l’exercitus caesareus contava circa cinque-
mila tedeschi, quattromila spagnoli, duemilacinquecen-
to italiani, ossia circa la metà dei suoi effettivi del 1527.
Gli altri? Morti per l’epidemia o partiti alla ventura4.
Il Vaticano fu occupato dai lanzichenecchi luterani di
Storia dell’arte Einaudi 111
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Frundsberg. Lo conferma un insieme di graffiti reperiti
di recente, durante i lavori di restauro, nelle Stanze
decorate da Raffaello5. Nella Disputa si legge verso il
centro, sulla destra, un’iscrizione incisa con la punta
della daga: V. K. Imp.e, quasi cancellato: Martinus
Lutherus. Si è anche notato che nel gruppo delle Decre-
tali, la faccia del cardinale Giulio de’ Medici, poi Cle-
mente VII, ha ricevuto un colpo di lancia sul naso. Ci
furono certamente altri sfregi; sono stati eliminati dai
restauri successivi. Le tracce rimaste bastano a ricordarci
che l’esercito imperiale era animato da uno spirito di
crociata antipapista.
Nella Stanza di Eliodoro, sotto lo zoccolo dipinto, si
legge di nuovo: V. K. Imp.e, chiaramente distinguibile
«Got hab dy sela Borbons»*, seguito da un nome
Dietwart e da una data may. Il che riassume tutto in
poche parole. Non si è trovato nulla, che io sappia, nella
Stanza di Costantino e me ne stupisco. I nemici del
potere temporale dei papi avrebbero trovato lì di che
tenersi occupati. Ma la loro preoccupazione volgeva
altrove, come vedremo. Di recente e venuta alla luce
un’altra testimonianza rivelatrice: durante il restauro
della «Sala della prospettiva» alla Farnesina, sono appar-
se due iscrizioni fatte l’una con la punta di una daga e
l’altra a matita. Entrambe sono in stretto rapporto con
il nostro studio: la prima, che attraversa un campanile
appartenente ad un paesaggio romano sulla parete nord,
dice semplicemente: «Babilonia»; la seconda, sulla pare-
te orientale, sotto la data 1528, consiste in un lungo
testo tedesco in cui si legge: «perché, io che scrivo, non
dovrei ridere: i lanzichenecchi hanno fatto correre il
papa». Una specie di addio a Roma degli occupanti.
Due problemi sussistono a proposito delle Stanze.
Uno è emerso riflettendo sul soggiorno di Tiziano a
Roma nel 1545. Un autore veneziano riferisce nel 1567
il seguente aneddoto:
Storia dell’arte Einaudi 112
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Tiziano mi ha raccontato di recente che, al tempo in cui
Roma fu messa a sacco dai soldati di Borbone, alcuni Tede-
schi che occupavano il palazzo del papa, senza alcun riguar-
do avevano acceso un fuoco in una delle stanze di Raffael-
lo e alcune teste furono rovinate dal fumo, a meno che non
lo siano state dai loro colpi. Il papa ritornato dopo la par-
tenza delle truppe, triste all’idea di lasciare quelle belle
teste rovinate, le fece restaurare da Sebastiano. Durante il
suo soggiorno a Roma, Tiziano andò un giorno in quelle
Stanze insieme a Sebastiano, ben deciso a guardare con la
massima attenzione e a occhi ben aperti quelle pitture di
Raffaello che non aveva mai vedute; e così, dinanzi alla
parete sulla quale Sebastiano aveva fatto i restauri, gli chie-
se chi fosse il presuntuoso ignorante che aveva imbrattato
quei volti. Non sapeva che Sebastiano li avesse restaurati
e non faceva che osservare l’enorme differenza che c’era fra
quelle teste6.
Anche tenendo conto della malizia di Tiziano nei
riguardi di un discepolo di Michelangelo, l’aneddoto
deve essere vero, ma i restauri successivi degli affreschi
rendono difficile accertare la verità. È importante che
vi siano stati guasti per via del fumo, il che suppone un
focolare improvvisato o un camino e del combustibile7.
Questo particolare può chiarire un altro atto più
grave di vandalismo. Si tratta degli armadi intarsiati
disposti intorno alla Segnatura (che doveva – come si sa
– servire inizialmente da biblioteca), opera di fra Gio-
vanni da Verona e di Gian Barili8. Questi sono scom-
parsi. Si è detto spesso che dovevano essere stati dan-
neggiati durante il sacco; cosa che è stata contestata di
recente9, ma la storia precedente la rende verosimile. I
«chiaroscuri» attuali sotto gli affreschi sono opera di
Perin del Vaga; furono dipinti sotto Paolo III, quindi
dopo il 1534, nel momento del trasporto di un caminetto
dalla camera vicina nella «Stanza», e ciò ebbe luogo nel
Storia dell’arte Einaudi 113
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
1541. Ma questa sistemazione si capisce meglio se la
decorazione di tarsia, rovinata più o meno completa-
mente, aveva bisogno di essere rifatta o sostituita: nel
1527 si bruciarono in Roma porte e finestre; plinti di
legno, anche «intarsiati» potevano benissimo alimenta-
re il fuoco durante un inverno di occupazione.
Un’altra vittima, e questa totale, dell’occupazione
militare, furono le vetrate decorate. Il Vaticano, in ispe-
cie al piano delle «Stanze», era appena stato adornato,
sotto Giulio II e Leone X, con finestre eseguite dal
vetraio francese Guillaume de Marcillat10. Tutte le fine-
stre vennero frantumate per ricuperare il piombo utile
per fabbricare palle da archibugio.
Cellini, con i suoi cannoni, proteggeva il castello,
impedendo a chiunque di avvicinarsi. Egli si mostrava
assai orgoglioso di quel che chiamava un «esercizio dia-
bolico». Ma, col passare dei giorni, l’artigliere ridiventò
orafo e coniatore di monete. Clemente era costretto a
versare un’enorme indennità di guerra e si dovettero
fondere i pezzi preziosi del tesoro: «Il Papa e uno dei
suoi servitori, il Cavalierino, mi posero davanti le tiare
con pietre preziose della camera apostolica. Il Papa mi
ordinò di smontarle. Il che io feci. Ogni pietra fu avvi-
luppata in un pezzo di carta e cucita nella fodera delle
vesti del Papa e del Cavalierino. Il restante oro, circa
duecento libre, mi fu lasciato con l’ordine di fonderlo»11.
In tal modo il papa poté versare, dopo l’accordo di
capitolazione del 5 giugno, la somma fantastica di 70000
ducati d’oro. Ma si dovevano coniare sempre un mag-
gior numero di monete d’oro e d’argento per pagare il
tributo colossale necessario per far partire le truppe.
L’estate del 1527 trascorse così in condizioni inverosi-
mili, con la città completamente dissanguata, quasi senza
rifornimenti, con gli abitanti trattenuti di forza e ado-
perati come domestici, con la minaccia di peste incom-
bente perché le fontane erano state distrutte mentre il
Storia dell’arte Einaudi 114
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
papa e gli alti dignitari cercavano disperatamente di
prendere a prestito somme sempre più elevate a Napo-
li o altrove, o battere altra moneta.
Frattanto, ogni casa era stata frugata e saccheggiata;
ogni palazzo perquisito e i suoi abitanti tassati. Vi fu per
alcuni giorni un’eccezione: il Palazzo Colonna, occupa-
to dai nemici personali del papa, dove si era rifugiata
Isabella d’Este. Molti disgraziati vi furono raccolti, ivi
comprese talune personalità note per i loro sentimenti
favorevoli all’imperatore. Ciò nonostante tutti quanti
dovettero pagare ripetute tasse, e, cosa ancora più ter-
ribile, a ogni nuovo contingente.
La cosa importante per i saccheggiatori, infatti, era
estorcere monete o oggetti preziosi, facilmente conver-
tibili in denaro12. L’importanza dell’esercito, l’astuzia
dei capitani sollecitati nei loro appetiti dalla marcia su
Roma, il fatto che la capitale cristiana fosse anche un
centro bancario e commerciale, tutto convergeva per
imprimere allo sfruttamento dei vinti un carattere siste-
matico che sembra del tutto eccezionale. Questo siste-
ma di tassazioni, o «taglie», permetteva di ottenere
sotto le peggiori minacce e, sicuramente, le peggiori vio-
lenze, somme variabili secondo il rango e la fortuna di
ogni membro della curia, di ogni notabile, di ogni cit-
tadino romano. Le cronache hanno fornito alcune infor-
mazioni sulle vittime e, talvolta, sui beneficiati. Così
scopriamo che il cardinale Ponzetti pagò 20 000 scudi
d’oro, il cardinale Enckenvoirt ne versò 40 000 al capi-
tano tedesco Oddone. Il cardinale di Santa Maria in via
Lata, Alessandro Cesarini, s’impegnò a versare 35 000
corone d’oro a nome di circa duecento persone rifugia-
te nel suo palazzo; il documento o instrumentum esiste
con le ricevute, datato 10 maggio. Spesso bisognava
ricorrere a prestiti. Ci si rivolgeva a un cambiavalute o
a un usuraio per fare il versamento di esonero; atti nota-
rili di tal genere ne sono rimasti in gran numero13.
Storia dell’arte Einaudi 115
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Le incarcerazioni e le sevizie avevano per lo più lo
scopo di cavare fuori l’oro, i gioielli, le pietre preziose.
Nella città si ebbero perciò durante tutte quelle setti-
mane soltanto vendite precipitose, traffici, promesse
davanti al notaio, ecc. che fecero del sacco una delle più
grandiose imprese finanziarie mai conosciute, almeno
per il passaggio di mano delle monete e degli oggetti di
valore. Fu un grande salasso di ricchezza. E con quella
emorragia se ne andarono in massa le opere d’arte. Non
mancano le informazioni sullo straordinario mercato che
si organizzò a Campo de’ Fiori, al Borgo e a Ponte
Sisto. Là, secondo un testimone, il notaio Gualderoni-
co: «si vendeva tutto quello che era stato rubato duran-
te il sacco, vestiti ricamati d’oro, sete, velluti, drappo
di lana e di lino, anelli, gioielli, perle; i tedeschi aveva-
no sacchi pieni di oggetti da vendere, e si vendeva di
tutto su una grande piazza del mercato, e poi il sac-
cheggio ricominciava ...»14.
Rodrìguez-Villa ha pubblicato una identica testimo-
nianza oculare, proveniente da un soldato spagnolo:
«...Coloro che le hanno rubate, non essendo intendito-
ri, pellicce e pietre preziose che valgono cento ducati, si
danno per due ducati. Gli arazzi e gli arredi, i bei vesti-
ti, tutto ciò non ha quasi più alcun valore. Ho veduto
vendere dodici arazzi tutti lavorati in oro e una magni-
fica alhombra di seta, il tutto per quattrocentocinquan-
ta ducati»15.
Nel racconto pubblicato dal francese Jean Cave,
abbiamo la descrizione pittoresca della partenza dei lan-
zichenecchi carichi di vestiti e di stoffe, coperti di cate-
ne e di anelli d’oro, con vasi, gioielli, sacchi pieni di
ducati e di cose preziose, che fanno portare dai loro pri-
gionieri: una scena che ricorda quelle riprodotte sulla
Colonna Traiana16. Il 19 febbraio 1528, si viene a sape-
re a Roma che Filippo Doria ha catturato, al largo di
Ostia, dodici imbarcazioni spagnole che portavano a
Storia dell’arte Einaudi 116
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Napoli più di centocinquanta casse di oggetti prove-
nienti dal sacco17.
Due aspetti meritano maggiore attenzione: in questa
gara di rapacità, le opere d’arte furono implicate molto
presto, soprattutto quelle che avevano un evidente valo-
re negoziabile, e, molto presto, nacquero traffici favo-
riti dalla confusione. Sebbene sia possibile delinearne
più o meno le caratteristiche, non si riesce a ricostruire
i particolari di simili traffici.
Questi movimenti interessano naturalmente anche le
biblioteche: talune furono devastate, altre vendute18;
quella del Vaticano, fondata da Sisto IV, fu particolar-
mente colpita: un breve del 1529 ne menziona l’impo-
verimento (diminutionem)19. La perdita delle biblioteche
più di qualsiasi altra cosa affligge gli umanisti; proprio
attraverso la distruzione dei libri la sciagura s’impone
alla loro attenzione; praticamente è il punto essenziale
su cui si soffermano. Così Erasmo, nella lettera a Sado-
leto, dove esprime preoccupazione per la sorte degli stu-
diosi, vede nel saccheggio della biblioteca dell’amico un
atto di barbarie degno degli sciti20. Quanto ai Riforma-
ti, la reazione di Melantone fu identica; la sciagura di
Roma e ricordata soltanto per l’unico disastro che preoc-
cupa gli umanisti: la distruzione delle fonti del sapere21.
È evidentemente in questo evento terribile la ragione di
indignazione degli studiosi che vedevano in Roma il
paradiso dell’erudizione. Erasmo non parla d’altro evo-
cando con nostalgia il suo soggiorno del 1509, nella let-
tera del 1529 a proposito del sacco. Per quanto riguar-
da le opere preziose dei santuari, la razzia sconsiderata
dei vincitori incorse necessariamente – insieme alla vio-
lazione delle reliquie – in ogni sorta di atti sacrileghi,
che, naturalmente, nelle notizie orali e scritte, assunse-
ro un’importanza difficile da minimizzare. Di fatto, il
sacco di Roma, se fu l’occasione di un rastrellamento
metodico dei tesori della città, prese subito un’altra
Storia dell’arte Einaudi 117
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
dimensione, quella di un’immensa profanazione. Quan-
do Guicciardini parla de «la più mesta, la più spaven-
tevole, la più vergognosa tragedia», pensa sia all’umi-
liazione e alla degradazione politiche che alle estorsio-
ni. E ne ha misurato amaramente la portata22. Proprio
la risonanza degli atti empi, più o meno gratuiti, com-
messi durante quelle settimane fece apparire il sacco, a
una gran parte del popolo cristiano, come un attentato
inaudito contro il centro tradizionale della cristianità.
Opere d’arte.
L’evento più memorabile del sacco fu la morte del
connestabile Carlo di Borbone; l’operazione fraudolen-
ta più notevole fu il furto degli arazzi pontifici. Tessu-
ti dieci anni prima sui cartoni di Raffaello, erano desti-
nati alla Cappella Sistina nelle grandi occasioni. Proprio
nella Cappella Sistina, decorata «dei ricchi e bellissimi
arazzi di Sua Santità», furono celebrati i funerali del
connestabile, per citare un rapporto veneziano del giu-
gno 152723. Molto tempo dopo, si e notato con un po’
di sarcasmo che «quella fu probabilmente l’ultima occa-
sione in cui la serie completa fu disposta secondo l’or-
dine voluto da Raffaello»24. Le vicissitudini di quei pezzi
famosi costituiscono un episodio bizzarramente compli-
cato, fra i tanti del periodo.
Isabella d’Este si trovava a Roma quando si verificò
il disastro, e procurò rifugio a molte vittime in Palazzo
Colonna, dove era alloggiata. Suo figlio Ferrante, uno
dei capitani imperiali, aveva lo zampino in ogni genere
di traffici loschi. Siccome gli arazzi erano di enorme
valore, e si sarebbero dispersi, la marchesa mandò cin-
quecento scudi a Ferrante perché li acquistasse al fine –
diceva – di restituirli un giorno al papa, dietro adegua-
to rimborso, naturalmente. Due pezzi, la Conversione di
Storia dell’arte Einaudi 118
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Saul e Paolo di fronte all’Areopago, furono imbarcati su
un battello che conteneva i beni personali di Isabella. Il
carico venne catturato dai pirati. Essendosi sparsa la
voce che si trattava di genovesi, Isabella reclamò i suoi
averi da Andrea Doria, ma non ottenne nulla. Erano
corsi allora sul suo conto apprezzamenti sfavorevoli.
Dovette perciò difendersi dalle accuse di un certo Bene-
detto Centurione, ribadendo che i due arazzi erano stati
acquistati per essere restituiti al papa. In ogni modo, Isa-
bella non li ritrovò mai piú25. Nel 1528 i pezzi sono
segnalati in una collezione veneziana. Venticinque anni
dopo, furono ricomprati a Costantinopoli dal conestabile
Henri de Montmorency e offerti nel 1554 al Vaticano:
il particolare è precisato in una nota d’inventario del-
l’anno seguente26. Altri pezzi ricomparvero a Napoli.
Là infatti si ritrovò un buon numero di opere d’arte e
di reliquie rivendute dai soldati. Nell’autunno del 1532,
si cominciò a trattare per quattro degli arazzi e per un
frammento che erano stati riportati da Napoli. Alcuni
avevano perduto i bordi. Anche quando furono tutti
restituiti, gli arazzi non furono mai ricollocati come
erano prima del 1527, perché sul muro di fondo, dal
1541, il gigantesco affresco di Michelangelo impediva
qualsiasi altra decorazione. Queste vicissitudini illumi-
nano adeguatamente su ciò che poteva capitare, in quel
periodo tormentato, a opere celebri. Ma siamo ancora
lontani dal riuscire a farci un’idea soddisfacente dei
tesori perduti. Si sono ritrovati in Vaticano una trenti-
na di frammenti di arazzo, soprattutto parti dei bordi,
che portano lo stemma di Clemente. I fregi verticali
sono molto interessanti per lo sviluppo delle forme deco-
rative a Roma27. Sono forse residui degli arazzi scom-
parsi, o frammenti di altri pezzi tessuti durante il secon-
do papato mediceo.
In un breve apostolico del 22 luglio 1531, si legge:
Storia dell’arte Einaudi 119
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
a proxima urbis direptione, Joannes Barsena, miles caesa-
rei exercitus, [rubavit] a cubiculo et camera nostra quam-
dam tabulam depictam, pietatis Domini nostri Jesu Christi
et Beatae Mariae Virginis in medio, in portulis vero illam
claudentibus, hinc Beatae Annae Virginem filiam in mani-
bus tenentis, inde autem Beatae Margaritae imagines devo-
te egregieque pictas habentem.
Si trattava di un trittico fiammingo destinato a una
cappella, come se ne conoscono in gran numero; il pan-
nello mediano del tipo di Roger van der Weyden, i por-
telli del tipo di Gérard David28. Opera modesta, che il
cardinale Medici doveva avere acquistato in Fiandra
durante il suo viaggio con il cugino Leone X. L’interes-
sante è nella storia finale del trittico. Il saccheggiatore
aveva portato il bottino in Sardegna, ma finì per con-
segnarlo agli Agostiniani di Cagliari; costoro lo porta-
rono alla cattedrale, dove, dopo l’identificazione, Cle-
mente decise di lasciarlo, con l’obbligo, esplicitamente
stabilito nel breve, di presentarlo ai fedeli ogni anno alla
festa dell’Assunta «honorifice ac devote». Si vedrà più
avanti come la restituzione delle reliquie rubate, in
seguito a un rimorso di coscienza, avvenne spesso dopo
il 1528.
Si parlava molto di atti di vandalismo nei confronti
di pezzi antichi: «ipsa etiam in marmora et antiquas
romanorum statuas sacritum est», dichiara Paolo Gio-
vio29. Corse la voce persino che il Laocoonte fosse stato
rotto. Ma è difficile precisare la parte dell’esagerazione
dovuta allo spavento30. Sappiamo, però, di taluni traffi-
ci di opere. Molti intrighi si allacciavano intorno ai
Gonzaga. Il capitano Fabrizio Maramaldo, con Ferran-
te uno dei capi del corpo italiano, fu un bell’esempio di
militare avventuriero. Questo Maramaldo era in ottimi
rapporti con il marchese di Mantova, che gli scrisse una
lettera divertente e rivelatrice:
Storia dell’arte Einaudi 120
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Ci sono qui due gentiluomini dabbene di cui sono gran-
de amico: Vostra Signoria ne conosce uno personalmente e
l’altro di fama. Entrambi vi considerano generoso e ama-
bile e pronto a soddisfare le persone meritevoli. Entrambi
desiderano una grazia da voi e quindi hanno sollecitato la
mia raccomandazione a voi. Uno è Marmirolo, l’altro Té.
Desiderano possedere alcuni pezzi antichi: teste, gambe,
busti o statue complete, di bronzo o di marmo. Poiché
sanno che tenete Roma alla vostra merce apprezzerebbero
la vostra liberalità riguardo a quelle cose di cui non fanno
caso né voi né i vostri soldati, perché a voi interessa altro
genere di bottino. Perciò, mio caro Fabrizio, non mancate
di soddisfare i miei due amici perché non perdano la buona
opinione che hanno di vostra Signoria. Altrimenti, lo so,
sparlerebbero di Fabrizio Maramaldo peggio di quel che si
sia mai detto dei più grandi pirati del mondo. Fate in modo
che io possa difendere il vostro onore. Sempre vostro
il Marchese di Mantova31
Questa lettera abbastanza fuori del comune è in data
22 maggio. Ferrante Gonzaga chiedeva all’amico avven-
turiero pezzi antichi per le sue collezioni. Marmirolo e
Té erano le sue due ville. Purtroppo non ne sappiamo
di più. Il figlio di Isabella non guardava troppo per il sot-
tile sulla provenienza dei pezzi32. Le sculture antiche,
troppo pesanti, ponevano problemi di trasporto: ma i
frammenti e le teste, i bronzetti e le medaglie, erano
assai più maneggevoli. Bisognerebbe sapere ciò che con-
tenevano le casse evacuate nel febbraio 1528 e cattura-
te dai genovesi davanti a Ostia. Noi sappiamo che i pre-
lati collezionisti avevano motivo di essere inquieti. Una
pagina piuttosto sarcastica di Ciaconius descrive l’an-
goscia di uno dei maggiori collezionisti romani, il car-
dinale Cesi: «Dopo la triste catastrofe della città, quan-
do erano rinchiusi nella fortezza di Adriano, incerti su
quanto stava succedendo, in una situazione personale
Storia dell’arte Einaudi 121
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
disperata, niente gli stava più a cuore che vigilare per-
ché le sue iscrizioni antiche e i suoi quadri non scom-
parissero nelle mani dei soldati che avrebbero potuto
impadronirsene e portarsele via»33.
Due giardini archeologici importanti sono segnalati
sotto Leone X e Clemente VII, quelli del cardinale Cesa-
rini e della famiglia Massimo. Il primo, situato nei pres-
si di San Pietro in Vincoli, esisteva fin dal 1500, se si
presta fede a un epigramma conservato da Schrader e a
un’iscrizione dell’ottavo anno del pontificato di Ales-
sandro VI34. Un certo numero di pezzi – colonne di
cipollino, diciotto teste di filosofi – sono ricordati in vari
testi e, come al solito, nel catalogo di Aldovrandi; ma
questi riferimenti sono troppo tardivi per farsi un’idea
della collezione al momento del sacco o precisare possi-
bili furti. La ricca famiglia dei Massimo fu particolar-
mente colpita. Domenico, il capo famiglia, fu ucciso e
il Palazzo della Via Papalis «presso la valle» distrutto.
La collezione di antichità, conosciuta per una entusia-
stica descrizione del 1512 circa, fu saccheggiata, senza
che ne sappiamo di piú35. In seguito a un accordo con-
cluso fra i tre figli nel 1532, il maggiore, Piero, fece
costruire un nuovo palazzo da Baldassarre Peruzzi. Que-
sta fu l’origine dell’attuale Palazzo alle Colonne, dove
non si ritrovano purtroppo i marmi scomparsi36. Lo stes-
so avvenne per il palazzo del cardinale Del Monte a
Campo de’ Fiori, sebbene fosse un Ghibellino autenti-
co, e parimenti anche per altre personalità, i cardinali
Enckenvoirt e Cesarini, residenti al «rione» Sant’Eu-
stachio. Per alcuni giorni poterono farsi proteggere dai
soldati spagnoli, ma il desiderio di bottino e la minac-
cia dei lanzichenecchi li costrinsero a fuggire, dopo di
che i palazzi furono messi sottosopra37. I cortili erano
depositi di antichità. Queste furono distrutte? portate
via? cedute? oppure, cosa piú probabile, lasciate intat-
te per forza di cose? Non sappiamo.
Storia dell’arte Einaudi 122
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Un epigramma latino conservato in una raccolta vati-
cana costringe a interrogarsi sulle statue del cardinale
Della Valle:
Perché stupirti, visitatore, che queste mute divinità
Trattengono il loro respiro in questi luoghi, sotto la pietra?
Al giungere del nemico, la paura le ha pietrificate;
e nonostante la protezione del Val, i marmi tremano ancora38.
Questo giardino archeologico si trovava al «rione»
Sant’Eustachio; e noto grazie a un’incisione di Hie-
ronymus Cock, molto verosimilmente tratta da un dise-
gno di Heemskerck39. Il cardinale morì nel 1534; la siste-
mazione della collezione alla sua morte era ben lungi dal-
l’essere completa. Fu suo nipote Camillo Capranica che
finí di installare la collezione, resa famosa dal catalogo
di Aldovrandi. È perciò difficile dire se l’edificio e le
antichità abbiano sofferto dell’occupazione imperiale. Il
«cortile», in ogni caso, era ben provvisto di frammen-
ti, che talvolta e stato possibile identificare nella stam-
pa fiamminga, e se questa risale a uno schizzo del 1533
o ’34, parrebbe che i guasti non siano stati gravi.
Reliquie.
Secondo i termini dell’atto di capitolazione del 5 giu-
gno, che prevedeva un risarcimento di quattrocentomi-
la ducati, una clausola indicava che il pontefice avreb-
be tolto «ogni censura, scomunica, pena, interdetto, in
cui [capitani e soldati] fossero incorsi per atti commes-
si anteriormente contro Sua Santità e il Seggio aposto-
lico». Il che significava un’assoluzione in piena regola
per le azioni perpetrate durante il sacco. Poiché le cose
si trascinarono tutta l’estate, una bolla, preparata, pare,
al principio di settembre e conosciuta in un solo esem-
Storia dell’arte Einaudi 123
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
plare, confermava che il papa perdonava ai vincitori40.
Una lettera del segretario imperiale Pérez segnala infat-
ti il 2 settembre la buona notizia all’imperatore. Si capi-
sce questa preoccupazione nei capi dell’esercito impe-
riale. Ma i gesti di conciliazione annunciati, poi dichia-
rati, da Clemente, lasciarono le cose com’erano e
sprofondarono nell’immensa confusione della fine del-
l’anno.
La lista delle chiese saccheggiate e profanate è lunga
quanto imprecisa. Resta molto da fare per controllare e
completare le informazioni episodiche e frammentarie.
È certo però che tutto quanto poteva avere un qualche
rapporto con gli avversari dell’imperatore, con il parti-
to francese, ad esempio, fu trattato con particolare cru-
deltà. Per quanto male informati si sia sulla prima chie-
sa di San Luigi dei Francesi, il tempio tondo con i gran-
di medaglioni scolpiti nel travertino ammirati da Vasa-
ri fu interrotto nel 1527, data in cui scompariva il suo
autore, Jean de Chennevières41. Si sa anche che contro
Trinità dei Monti, centro di propaganda francese, vi fu
una vera spedizione punitiva, a causa dei legami del
convento con il partito francese42. Fu una brutta vicen-
da, di cui dovremo riparlare.
Il disastro fu irreparabile per le oreficerie sacre:
oggetti liturgici, reliquari preziosi e simili, di cui le chie-
se erano ricchissime:
Si sono ricercate le bolle papali, le lettere e i registri nei
monasteri e nei conventi per bruciarli e strapparli: i loro
brandelli sono serviti al posto della paglia nelle case e nelle
scuderie per gli asini e i cavalli.
In tutte le chiese, San Pietro, San Paolo, San Lorenzo
e anche in quelle piccole, calici, pianete, ostensori e orna-
menti sono stati sottratti e i saccheggiatori non trovando
la Veronica hanno preso altre reliquie.
Storia dell’arte Einaudi 124
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
È ciò che si legge nell’opuscoletto tedesco Die
Warhafftige und Kurtze Berichtung: «[Veritiera e breve
relazione], scritta da un soldato di Frundsberg, forse
tirolese, e pubblicato nell’estate o nell’autunno del 1527,
probabilmente per informare della vittoria dei contadi-
ni diventati lanzichenecchi»43. Due indicazioni sono
importantissime: l’assalto alla città del papa era stato,
per una buona metà dell’esercito imperiale, una specie
di pellegrinaggio alla rovescia, o, se si vuole, un atto di
profanazione calcolata, che aderiva alle linee tradizionali
della devozione che attirava a Roma migliaia di fedeli.
La legittimità dell’autorità pontificia si esprimeva con le
bolle sigillate; le somme ricevute in pagamento delle
indulgenze erano scritte sui registri. Pertanto ciò che
venne buttato nel letamaio, calpestato e disperso, furo-
no i conti dell’obolo di San Pietro e gli archivi delle ren-
dite delle regalie. Gli invasori presero di mira anche i
ricordi storici, come la croce d’oro di Costantino e la
tiara di Nicola V, di cui non si trovò più traccia44. Gli
oggetti liturgici – calici, patene ecc. – scomparvero dalle
sacrestie con le reliquie, ossia quegli oggetti di venera-
zione familiari a tutti i pellegrini, nelle loro preziose
custodie45.
L’apice del sacco di Roma fu quest’accanimento con-
tro gli oggetti sacri e gli oggetti tradizionalmente legati
nella mentalità popolare alla devozione. Tutte le rela-
zioni insistono con orrore su questo punto. In una si
legge che «gli imperiali hanno preso le teste di San Gio-
vanni, di San Pietro e di San Paolo; hanno rubato l’in-
volucro d’oro e d’argento e hanno buttato le teste nelle
vie per giocare alla palla; di tutte le reliquie di Santi che
hanno trovato, hanno fatto oggetto di divertimento»46.
Le teste degli Apostoli evidentemente erano venera-
te in modo particolare: quella di San Giovanni nella
chiesa di San Silvestro, quelle di Pietro e Paolo nel
Laterano, quella di Sant’Andrea in San Pietro, dove
Storia dell’arte Einaudi 125
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
era stata collocata in un reliquiario di marmo al tempo
di Pio II. Vanno ancora ricordati molti frammenti della
Vera Croce, il ferro della Lancia consegnata solenne-
mente a Innocenzo VIII dal sultano Bajazet, e, natural-
mente, il Sudario, la Veronica. Ve n’erano altre centi-
naia47. Tutta la cristianità che credeva all’importanza
religiosa di tali reliquie tremava per la Veronica. Que-
sta, l’abbiamo già ricordato, era la reliquia per eccel-
lenza; la sua popolarità presso i pellegrini ne aveva fatto
il vero palladium della Città Santa48. Quando Carlo VIII
era arrivato a Roma nel 1494, il papa, incerto sulle
intenzioni del re, si era rifugiato in Castel Sant’Angelo
portando con sé la Veronica e le reliquie dei santi Pie-
tro e Paolo49.
Nel 1527, Clemente VII non ebbe il tempo di met-
terle in salvo. Ben presto si sparsero le notizie più apo-
calittiche a proposito di questi oggetti, e le relazioni
diplomatiche ne parlarono. È una questione dibattuta se
la tomba di San Pietro sia stata violata o meno.
Una lettera indirizzata da uno «scriptor brevium»
apostolico, un canonico di Spira, in data 17 giugno,
menziona «la profanazione di tutte le chiese, l’esecu-
zione di parecchie persone sull’altare di San Pietro, l’ef-
frazione dell’urna o tomba che racchiudeva i resti dei
santi Pietro e Paolo e anche la profanazione delle reli-
quie». Non è sicuro che questo sacrilegio totale abbia
avuto luogo; ma la voce è corsa con insistenza50.
La Cappella Sancta Sanctorum, al Laterano, meta di
un pellegrinaggio particolarmente solenne, racchiudeva
un tesoro celebre, gelosamente custodito51. Si trattava di
una reliquia dal duplice significato: le teste di Pietro e
Paolo erano state deposte sull’altare maggiore della basi-
lica vicina da Urbano VI, al ritorno da Avignone. Altri
oggetti erano ancora stati mostrati alle folle di fedeli
sotto Leone X. Un rapporto ufficiale inviato all’impe-
ratore segnalava che il santuario «oggetto della massima
Storia dell’arte Einaudi 126
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
venerazione più di qualsiasi altro» era stato saccheggia-
to. Si era pensato che la cavità sotto l’altare fosse stata
risparmiata, grazie al sistema complicato di chiusura a
chiavi multiple. I reliquiari murali e quelli che si trova-
vano sopra l’altare furono spezzati e vuotati. Il reli-
quiario contenente la Santa Croce, dell’epoca di Paolo
II, veniva collocato nei giorni festivi sull’altare della
Cappella Sistina. Scomparve in maggio e anch’esso fu
ritrovato in seguito. Clemente fece disporre il legno in
una croce di cristallo conservata nella sacrestia52. Pan-
vinio, che ha citato una specie d’inventario redatto sotto
Leone X, spiega come sia difficile recensire le perdite,
perché i pezzi erano tutti confusi insieme: «arca cum
multis reliquiis, multae sine nomine reliquiae, capsulae,
arculae et pyxides»53.
Tutto quel che manca è stato rapinato durante il
sacco, o distrutto dal tempo, a meno che non siano stati
fatti prelievi dalla stessa amministrazione pontificia per
cavarne oro.
Nei casi in cui i reliquiari furono asportati, gli ogget-
ti che contenevano poterono essere ritrovati anche lon-
tano da Roma. Per esempio, una grande croce d’argen-
to cesellata, di un modello del xv secolo piuttosto cor-
rente, è stata ritrovata, secondo la tradizione, ed è oggi
conservata a Poggio Mirteto54. La reliquia detta della
Circoncisione, rubata da un lanzichenecco nella Cap-
pella Sancta Sanctorum del Laterano, ricomparve a Cal-
cata nel Lazio; ricollocata, in circostanze impossibili a
stabilirsi, in un elegante reliquiaria, valse alla piccola col-
legiata un’indulgenza plenaria durante la visita del papa
Sisto V nel 1585. L’oreficeria originale è evidentemen-
te scomparsa, ma è possibile che il tipo del nuovo reli-
quiario, con i suoi due angeli d’argento che reggono il
ricettacolo, ne riprendano lo stile55. Una recente esposi-
zione ha permesso di constatare quanto poco rimanga:
praticamente il sacco di Roma ha annullato la maggior
Storia dell’arte Einaudi 127
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
parte dell’oreficeria di Chiesa e a questa causa va attri-
buita la nostra scarsa informazione su questo genere di
arte nell’Italia centrale.
Molto presto, a quanto pare, corsero voci su inter-
venti miracolosi destinati a impedire sacrilegi, e, in ogni
caso, la letteratura posteriore ne ha spesso fatto men-
zione56. Si dice che talune immagini sacre manifestasse-
ro il loro dolore57. La storia delle reliquie non può infat-
ti essere cosa comune. Il ricupero delle preziose vestigia
di cui Clemente si preoccupava fin dall’ottobre 1527
avvenne in un tempo record58. Quando l’esercito impe-
riale ebbe definitivamente evacuato Roma, nel 1528,
alcuni ufficiali spagnoli, per scrupolo di coscienza o
obbedendo a ordini superiori, si diedero a raccogliere le
reliquie e a restituirle a Roma. Il capitano Giuliano de
Castillo è ricordato a questo titolo in un documento
degli archivi vaticani Instrumentum relationis reliquia-
rum a militibus Borboni ab urbe extractis [sic], ossia: con-
statazione del ritorno delle reliquie portate via dalle
truppe di Borbone59. I pezzi ricuperati a Roma e all’e-
stero furono portati in San Marco e il 26 novembre 1528
una processione solenne li trasportò in Vaticano. L’im-
portanza di questa azione riparatrice è stata così ricor-
data: «Molte sacre reliquie rubate nelle chiese di Roma
essendo state portate nel reame di Napoli da quell’eser-
cito feroce, ne fu ricuperato un gran numero e furono
riportate a Roma»60.
Il documento, detto Instrumentum, è dei più scon-
certanti. Contiene centinaia di riferimenti per cui ci si
chiede come e da chi gli oggetti possano essere stati iden-
tificati. Le menzioni sono una più inverosimile dell’al-
tra: una stoffa dove si vede la traccia di una goccia del
latte della Vergine, ossa di martiri e così via61. Tutto
dimostra che durante quei mesi vi fu uno sforzo cre-
scente per ritrovare a qualunque costo le vestigia, in un
ritorno di attività superstiziosa, che rivela un attacca-
Storia dell’arte Einaudi 128
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
mento più forte che mai anche ai tratti più banali della
devozione.
In pari tempo cominciava a diffondersi la notizia che
le grandi reliquie erano state miracolosamente preser-
vate. I primi rapporti avevano potuto esagerare nella
precisazione di particolari sensazionali. In una lettera
del 21 maggio rivolta da un «messere Urbano» alla
duchessa di Urbino e ricopiata in Sanuto si legge: «Le
sacre reliquie sono state disperse. La Veronica è stata
rubata; la si è passata di mano in mano e in tutte le
taverne di Roma, senza che nessuno se ne indignasse;
un Tedesco ha piantato il ferro della lancia che ha col-
pito il Cristo su di una picca ed è corso attraverso il
Borgo per scherno»62.
Questo forse è giornalismo «a sensazione». Provocò
commenti vivaci di tono ma un po’ imbarazzati di
Valdés e le proteste indignate di Castiglione. Ma a poco
a poco le indicazioni mutarono di segno, e uno dei testi-
moni oculari del sacco, sopravvissuto alle tragiche setti-
mane, Alberini, scrisse, nelle sue memorie (redatte, e
vero, molto più tardi): «La Veronica, la testa di
Sant’Andrea in San Pietro, quelle dei Santi Apostoli
Pietro e Paolo in San Giovanni in Laterano, e l’effigie
miracolosa del Salvatore nel Sancta Sanctorum... non
hanno potuto essere profanate da quelle mani infami».
Si raccontò come i soldatacci sacrileghi che demoli-
rono il tabernacolo delle reliquie al Laterano, fossero
atterriti da rumori insoliti e fuggissero63.
Tutte queste tradizioni furono raccolte in documen-
ti manoscritti utilizzati dall’archivista – archeologo di
San Pietro, Jacopo Grimaldi, nell’opera da lui pubblicata
nel 1621, che segna il punto finale di questa curiosa fac-
cenda. Era il momento in cui il nuovo San Pietro era
appena terminato. Non dobbiamo dimenticare che la
basilica-madre della cristianità era rimasta incompiuta e,
per così dire, sventrata per un buon mezzo secolo. All’e-
Storia dell’arte Einaudi 129
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
poca del sacco, i continui lavori di ricostruzione aveva-
no creato un tremendo disordine nelle cappelle, tombe
e reliquiari. E non c’è quindi da stupirsi che si creasse
confusione nei saccheggi come nelle riparazioni. Dopo
il compimento della cupola di Michelangelo, poi della
navata e della facciata del Maderno, ebbe luogo un
solenne trasporto delle opere e in ispecie delle reliquie
ricuperate da circa un secolo, che aspettavano una siste-
mazione definitiva. L’opera di Grimaldi Instrumenta
autentica translationum sanctorum corporum et sacrarum
reliquiarum e veteri in novam basilicam, apparve come il
«dossier» finale sulle grandi reliquie. Annunciava la
prodigiosa sistemazione realizzata dal Bernini alcuni
anni dopo delle quattro maggiori reliquie, ognuna raffi-
gurata da una statua spettacolare: San Longino del Ber-
nini per la Lancia, Sant’Andrea di Duquesnoy per il suo
capo (reliquia che nel 1964 fu riportata a Patrasso,
donde era venuta nel secolo xv, in omaggio alla chiesa
greca ortodossa), Santa Veronica di Francesco Mochi per
il Sudario, Sant’Elena di Andrea Bolgi per il Legno della
Vera Croce.
Da molto tempo era stato diffuso il Trattato delle reli-
quie di Calvino e si era compiuta la rottura fra la cri-
stianità riformata del Nord e il mondo cattolico. Con il
nuovo San Pietro, Roma cercava di riparare una delle
profanazioni risentite più fortemente nel 1527. Era un
modo di riparazione magnifico, ma non aboliva il sacri-
legio. C’era stata una specie di ondata enorme contro le
reliquie e le immagini, non solo nella Sassonia di Lute-
ro, nella Svizzera di Calvino, ma anche nell’Inghilterra
di Enrico VIII e di Elisabetta. Erasmo e Thomas More
avevano messo in guardia contro la «ciarlataneria di
una certa fede nelle ossa e nei santi». Ma nel novembre
1538, dieci anni dopo la processione riparatrice sotto
Clemente VII, quando Enrico VIII fece cancellare Tho-
mas Beckett dal calendario, e distruggere la teca di Can-
Storia dell’arte Einaudi 130
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
terbury, l’importanza del mutamento di atteggiamento
saltò agli occhi di tutti. Il sacco di Roma divenne per
tutti gli iconoclasti della cristianità occidentale una
prova che la protezione divina non riguardava le imma-
gini, e ciò tanto più chiaramente in quanto si trattava
delle reliquie più venerate della cristianità, delle reliquie-
tipo64. Una grande parte dell’arte antica era destinata a
scomparire per sempre perché l’oro e le gemme dei reli-
quiari, se venivano profanati, diventavano di proprietà
pubblica. Non solo si ebbe un vasto rimodellamento di
oggetti preziosi, dei quali si perse in tal modo il signifi-
cato religioso, ma l’arte stessa cambiò di significato e di
contenuto, e questo può essere una conseguenza del
sacco di Roma.
L’avvenimento fu visto in tutta la cristianità come
una gigantesca profanazione. In una lettera inviata da
Portofino il 27 giugno al nunzio d’Inghilterra, Sanga
scrisse:
Quali Goti, quali Vandali, quali Turchi, sono mai stati
pari a questa armata imperiale negli atti sacrileghi com-
messi? Occorrerebbero volumi per descrivere uno solo dei
loro delitti. Hanno buttato a terra il sacro corpo del Cri-
sto, rubato il calice, calpestato le reliquie dei santi per rovi-
narne gli ornamenti. Né chiesa, né convento sono stati
risparmiati. Hanno violentato le monache tra le urla delle
loro madri, bruciato gli edifici più splendidi, trasformato le
chiese in stalle, usato i crocifissi e le immagini come bersa-
glio per gli archibugi. Non è più Roma, ma la tomba di
Roma. Hanno vestito da lanzichenecco il vecchio crocifis-
so di legno venerato da tutti i popoli che si trovava su uno
dei sette altari di San Pietro. I santi Pietro e Paolo che da
così lungo tempo erano sepolti sotto l’altare di San Pietro,
non hanno mai sofferto nulla di così indegno, perfino da chi
li aveva martirizzati65.
Storia dell’arte Einaudi 131
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Una lettera di Vincenzo da Treviso, datata 15 giugno
afferma: «Non c’è Christo per le chiese che non habia
cento et duxento costelade»66.
Ci furono anche altri episodi. Si sapeva che periodi-
camente, all’ingresso del ponte, la dove Heemskerck
aveva collocato i suoi portastendardi, si levavano scher-
ni e grida ingiuriose. L’Historia direptionis riferisce quel-
la che possiamo definire la massima parodia: «Uno di
quelli, che si distingueva un poco per la maestà del por-
tamento e per la statura, rivestì l’abito pontificio, si mise
sul capo la triplice corona, si avvolse delle bende e delle
vesti più preziose e si fece portare con tutta la pompa
di una processione papale su un magnifico cavallo.
Parecchi altri avevano vesti vescovili, taluni mitrie e
mantelli di porpora».
Come non ricordare a proposito di questa maschera-
ta l’ingresso solenne del papa su un cavallo bianco, sul
bassorilievo della Stanza di Costantino? Il vero e pro-
prio simbolo del potere pontificio è distrutto da questa
parodia. La processione di scherno si fermò davanti a
Castel Sant’Angelo, proclamò fedeltà a Cesare reclamò
l’abolizione del fasto pontificio, e richiese che Clemen-
te cedesse a Lutero vele e remi della «Navicella». Allo-
ra la massa gridò: «Vivat Lutherus pontifex!»67; e tutto
ciò, sottolinea l’Historia, si svolgeva sotto gli occhi di
Clemente VII. In tal modo tutto il cerimoniale esterio-
re del papato, e con questo la dignità stessa della litur-
gia, erano degradati e dissacrati. La crisi del rituale, già
seria in tutta la cristianità, non poteva che risultar aggra-
vata da queste pantomime.
Il capitano Schertlin von Burtenbach non poté tratte-
nere il suo turbamento e scrisse nel suo diario: «Signore!
A che punto è la Chiesa e la religione cristiana, se ha potu-
to verificarsi una così terribile vittoria, sì che noi, cristiani,
abbiamo devastato la capitale della nostra religione! Come
si saranno rallegrati i turchi, i pagani, i giudei!»68.
Storia dell’arte Einaudi 132
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Molto tempo dopo, il figlio del Bernini, Domenico
Bernini, ritornò sull’argomento nella sua opera in quat-
tro volumi Historia di tutte l’Heresie, apparsa a Roma
all’inizio del xviii secolo. Secondo lui, gli avvenimenti
del 1527 fanno parte di una grande ribellione antiro-
mana: «Queste nostre perdite in Italia furono i maggiori
fattori del trionfo degli eretici in Germania». Domeni-
co ha attinto da «diarii» allora ancora inediti, come
quello di Armellini, e al tempo stesso da fonti di storia
ecclesiastica già pubblicate. Egli riassumeva il pensiero
di autori precedenti.
In linea generale, preti e prelati furono maltrattati;
quanto più li si poteva supporre di grado elevato nella
gerarchia, tanto più venivano tassati e, per costringerli
a pagare, la soldataglia rivaleggiava in invenzioni sini-
stre. Queste sono state riferite da tutti gli storici, senza
che vi sia modo di distinguere il vero dal falso. Il cardi-
nale Caetano per esempio, avversario di Lutero, fu mal-
menato, beffeggiato, e portato in giro per le strade con
le mani legate, come Ponzetti, che però era un vecchio
imperiale, «ottantenne e più morto che vivo». Al car-
dinale Numalio, generale dei Francescani, toccò una
parodia di sepoltura e fu portato in una bara fino all’A-
racoeli69. Vi fu la festa dell’asino, addobbato con orna-
menti sacerdotali, al quale un povero prete rifiutò a
costo della vita di dare la comunione70. Tutto questo
avveniva precedentemente alla prima – e falsa – par-
tenza dell’estate.
Ostili o no al Santo Padre, alla Curia romana, agli ita-
liani, gli autori di relazioni sul sacco hanno spesso sot-
tolineato, come nel caso di un rapporto spagnolo, lo
strano vuoto creatosi improvvisamente nella capitale
della cristianità: «non si odono più campane, nessuna
chiesa è aperta, non si celebra più la messa... Non si sa
che dire o a che cosa paragonare tutto ciò, se non alla
distruzione di Gerusalemme. Non credo che vi sia mai
Storia dell’arte Einaudi 133
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
stato qualcosa di simile»71. Ma – aggiunge il medesimo
testo – questo evento inaudito, scandaloso racchiude
una grande lezione. La città di Roma era la dimora di
tutti i vizi. «Tutto questo non è avvenuto per caso, ma
per effetto della giustizia divina. Se ne erano avuti,
infatti, ben più che numerosi presagi». L’annuncio della
catastrofe significava ch’essa era un castigo del cielo. Il
silenzio terribile della città morta sul finire del 1527 e
nel 1528 è quindi denso di significato.
Il prestigio dei soldati mercenari.
Una cosa che non si era ancora mai veduta, era quel
miscuglio internazionale, quell’assalto violento di spa-
gnoli e di tedeschi, quella lunga agonia degli abitanti di
Roma – loro stessi di così varia origine – in una città
disorganizzata, in mano a soldati di ventura, diversissi-
mi per costume, linguaggio, comportamento. Ne risultò
un odio duraturo tra spagnoli e tedeschi72, ma con curio-
se sfumature: «Mali fuere Germani, pejores Itali, Hispa-
ni vero pessimi», scrisse il priore dei canonici di Sant’A-
gostino, Kilian Leib73. Questo apprezzamento è sfuma-
to nell’Historia direptionis: «La rabbia degli Spagnoli fu
più viva e più atroce mentre quella dei Tedeschi più
ignobile nei tormenti inflitti ai preti74. È certo in ragio-
ne di questa voce insistente, e molto verosimilmente,
ben fondata, che il generale dei Francescani, Francisco
Quiñones, parlava dei «capitani di Lutero» e ingiunge-
va all’imperatore, a quanto riferisce Navagero, di disar-
mare le sue truppe per non meritare egli stesso questo
appellativo75. Si riversava perciò sui lanzichenecchi ere-
tici tutto l’obbrobrio del saccheggio e dei sacrilegi. Ma,
per quanto ne conosciamo, nessuna immagine ci è giun-
ta che ne illustri le gesta.
Gli italiani avevano periodicamente esaltato i loro
Storia dell’arte Einaudi 134
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
comandanti militari; i grandi «condottieri» hanno for-
nito un magnifico tema a pittori e scultori, come, del
resto, ai poeti. Nella confusione del 1527, le uniche
grandi figure che emersero, furono Giovanni dalle
Bande Nere – che fu onorato a Firenze dopo il 1540
dalle statue del Bandinelli76 – e Carlo di Borbone – la cui
tomba conobbe varie vicissitudini77. Il carattere alquan-
to eccezionale del periodo dipende dal fatto che, dal
punto di vista militare, tutto è dominato dagli andiri-
vieni della temuta truppa dei lanzichenecchi.
Ogni età possiede un tipo particolare di furfante,
avventuriero, buonanulla, dotato di uno strano e discu-
tibile prestigio. Questo personaggio, dopo il 1525 era il
lanzichenecco, Landsknecht, miles provincialis, rivale
degli svizzeri sul mercato dei mercenari. Questo inte-
resse per i soldatacci terribili si nota chiaramente nei
disegni dei pittori svizzeri, prima di tutto Nicolas
Manuel, e Urs Graf78. Su uno schizzo di quest’ultimo,
apparentemente tratto dal vero, un ufficiale reclutatore
francese si sforza di attirare uno svizzero accanto al
quale e seduto a un tavolo un lanzichenecco; a sinistra
la morte, a destra la follia incorniciano la scena. Non esi-
steva nulla di paragonabile in Italia e ancor meno a
Roma. Le splendide xilografie di Weiditz, il «Maestro
del Petrarca», anteriori di poco agli avvenimenti, prefi-
guravano in modo notevole le scene di violenza, di sac-
cheggio, e i gesti sacrileghi79.
Poiché in Italia non usavano incisioni illustrative di
scene di genere e le stampe di avvenimenti d’attualità
quasi non esistevano, è difficile immaginare chi avreb-
be potuto fare cose di questa specie. Comunque sia, c’è
forse un’allusione contemporanea in certi quadri d’alta-
re, per esempio nella Deposizione dovuta a un pittore
marchigiano, Vincenzo Pagani80. La composizione, priva
di finezza e di originalità, è dominata dal Calvario. Al
piede delle croci si collocavano tradizionalmente solda-
Storia dell’arte Einaudi 135
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
ti romani e orientali con il turbante, ad indicare coloro
che, storicamente o simbolicamente, avevano crocifisso
e continuavano a crocifiggere il Cristo. Si vedeva negli
ottomani, gli infedeli, l’incarnazione del male. I soldati
romani spesso venivano identificati con i guerrieri con-
temporanei. Nell’opera del Pagani si riconosce un distac-
camento di lanzichenecchi nella truppa, che, bandiera in
testa, marcia verso la città di Gerusalemme ai piedi
della collina.
Il sacco di Roma avrebbe potuto essere evocato indi-
rettamente raffigurando le truppe in carattere moderno,
o con qualche cenno aneddotico. I soldati di Frundsberg
avrebbero potuto essere riconoscibili dall’abbigliamen-
to. Ma testimonianze del genere sono eccezionali. Que-
st’assenza stessa è interessante in quanto ci ricorda che
le arti, a differenza della fotografia, non avevano lo
scopo di registrare l’attualità. Quando ne trattengono
una figura o un episodio, si opera una trasposizione
all’interno delle strutture abituali. Oppure, come vedre-
mo con le reazioni di Clemente, avviene su un piano del
tutto inatteso di proiezione religiosa80.
Naturalmente e impossibile ricostruire la sorte di
molti soldati dell’exercitus caesareus, ma si può suppor-
re che un certo numero di loro conobbero, se non il
rimorso, per lo meno le ingiunzioni di confessori che li
predisposero alla contrizione. L’abbiamo veduto con la
storia del trittico di Clemente VII in Sardegna e con il
caso del capitano spagnolo Giuliano de Castillo, che si
adoperò per ricuperare le reliquie rubate. Tutti sapeva-
no che molto oro era stato estorto e molte opere porta-
te via in segno di disprezzo. Gli scrupoli degli spagnoli
riguardo ai reliquiari e alle reliquie consentirono la pro-
cessione riparatrice del dicembre 1528. Ma le fortune
nate dal sacco hanno anche creato ai loro beneficiari
talune difficoltà. A questo proposito quel capitano
Maramaldo, che aveva trafficato così bene coi pezzi
Storia dell’arte Einaudi 136
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
antichi, non lasciò questo mondo con tutti gli onori:
«Un colonnello della fanteria di Borbone, Fabrizio
Maramaldo di Napoli, volle lasciare alla sua morte una
certa somma di danaro alla casa di San Paolo di Napo-
li. Il pio padre Giovanni Marionò non lo accettò, temen-
do che si trattasse di danaro rubato durante il sacco della
santa città di Roma»82.
1
c. prandi, Villa Lante, Roma 1955. p. 4) fig. 2. Dei graffiti del
1527 sono forse esistiti anche negli appartamenti Borgia. r. lanciani,
The Destruction of Ancient Rome, London 1901, cap. XVIII, pp.
222-23, ha segnalato che vi erano «names scratched with a pointed
instrument on the lower surface of the wall... but whether they are the
names of the mercenaries of Charles Vth or of more penciful visitors
of later times I cannot say».
2
Questo testo si trova in g. kirchmair, Denkwürdigkeiten seiner Zeit
(1519-1553). Fontes rerum austriacarum, sez. 7, vol. I, Wien 355, pp. 7
e 8. Un testo analogo è parzialmente citato come proveniente da Seba-
stian Schertlin von Burtenbach, uno dei capitani dei lanzichenecchi, di
janssen, L’Allemagne et la Réforme cit., III, p. 140; e von pastor, Sto-
ria dei papi cit., vol. IV, parte 11, libro II, p. 113. Sulle condizioni del-
l’accordo del 5 giugno, cfr. hook, Sack of Rome cit., pp. 209-10.
3
von pastor, Storia dei papi cit., vol. IV, parte II, libro III, pp.
311-12; hook, The Sack of Rome cit., pp. 226-28.
4
guicciardini, Storia d’Italia cit., XVII (V, pp. 189-90).
5
d. redig de campos, Il nome di Martin Lutero graffito sulla «Dispu-
ta del Sacramento», in «Ecclesia», 6 (1947), pp. 648-49; Un altro graf-
fito del Sacco nelle Stanze di Raffaello, in «Ecclesia», 19 (1960), pp. 552
sgg.; Raffaello nelle Stanze, Milano 1965, pp. 20 sgg.
André Malraux ha sviluppato curiosamente questi temi in un finto
colloquio con Picasso: «Quando il conestabile di Borbone ha preso
Roma, i suoi arcieri hanno scelto come bersaglio la Scuola di Atene.
– Non amavano Raffaello? Già cubisti?
– Per mesi, tutti i personaggi: Platone che era Leonardo da Vinci,
e non so più quale che era Michelangelo, e tutti gli altri, hanno avuto
frecce conficcate negli occhi... Bella scena per un film» (andré mal-
raux, La corde et la souris, Paris 1976, pp. 410-11).
Il graffito sulla parete nord della «Sala della prospettiva» è stato
riprodotto in: La Sala della prospettiva. Storia e restauro, catalogo della
mostra organizzata a Roma, alla Farnesina, nel giugno-luglio 1981, a
Storia dell’arte Einaudi 137
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
cura dell’Istituto Centrale del Restauro. Ringrazio la dott.ssa Rosalia
Varoli-Piazza per avermi procurato la fotografia.
6
l. dolce, L’Aretino, 1567, in Trattati d’arte del Cinquecento, a
cura di p. Barocchi, I, Bari 1960, pp. 151-52; r. pallucchini, Seba-
stian Viniziano, Milano 1944, p. 123; l. düssler, Sebastiano del Piom-
bo, Basel 1942, pp. 112 e 213.
* [«Dio abbia l’anima di Borbone»].
7
Non vediamo su che cosa si fondi hess, On Raphael and Giulio
Romano cit., p. 72, per applicare alla Stanza di Costantino l’informa-
zione data da Dolce: «il fuoco... in una delle camere dipinte da Raf-
faello». Secondo j. d. pas savant, Rafael von Urbino und sein Vater Gio-
vanni Santi, vol. I, Leipzig 1839, p. 264, deve trattarsi della Stanza del-
l’Incendio, il che è assai improbabile, poiché vi si trova un caminetto.
Ciò non cambia nulla al ragionamento a proposito dei rivestimenti in
legno della Segnatura. Sui restauri delle Stanze, cfr. b. biagetti, Monu-
menti, Musei e Gallerie Pontificie nel quadriennio 1930-1934, relazione
in «Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia»,
10 (1935), p. 91.
8
Gli autori sono indicati da vasari, Le vite cit., IV, p. 363. Cfr.
p. lugano, Fra Giovanni da Verona e i suoi lavori alla Camera della Segna-
tura, Roma 1908.
9
Secondo j. klacko, Jules II, Paris 1898, p. 75 nota 218, le tarsie
sono scomparse al tempo del sacco. shearman, The Vatican Stanze cit.,
p. 414 nota 96, pensa piuttosto che «almost certainly they survived
until the insertion of the fireplace». La probabilità ci sembra andare
nell’altra direzione. Il fatto che la stanza continuò a chiamarsi «came-
ra della Tarsia» non è una prova.
Un piccolo particolare che forse non è trascurabile, la mancanza
di legna nella città alla fine dell’estate: «ed è l’ultima ruina di questa
città». Lettera di S. Fanzino del 23 ottobre 1527, citata da sanuto,
Diarii cit., coli. 294 sgg.
10
Vasari riferisce nella vita di Guillaurne de Marcillat che i vetrai
francesi «ne fecero per le camere papali infinite», tutte distrutte nel
1527 tranne una ch’egli segnala nella Camera del fuoco (la Stanza del-
l’Incendio). Cfr. redig de campos, Raffaello nelle Stanze cit., p. 19.
11
cellini, La vita cit., cap. xxxviii.
12
Questo è stato bene indicato da e. rodocanachi, in Rome au
temps de Jules II et de Léon X, Paris 1912, che contiene un lungo espo-
sto sul sacco di Roma.
13
Documenti di questo tipo, del 9 maggio, del 21 luglio, del 13
agosto, del 6 ottobre, sono stati pubblicati da p. marzio, Della guerra
fra Clemente VII e gli imperiali, e documenti inediti in proposito, nel gior-
nale romano «Il Saggiatore», 1844, n. 10, pp. 305 sgg., e n. II, pp. 337
sgg.; g. cavalettialondini, Nuovi documenti sul sacco di Roma del
Storia dell’arte Einaudi 138
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
MDXXVII, in «Studi e Documenti di Storia e Diritto», 5 (1884), pp. 221
sgg., ha dato un certo numero di documenti sulle «taglie» e le loro vit-
time, i debiti, depositi, prestiti, ecc.
14
m. armellini, Gli orrori del saccheggio di Roma l’anno 1527
descritti da un cittadino romano di quel tempo, in «Cronachetta Mensuale
di Scienze Naturali e d’Archeologia», 20 (1886), p. 93.
15
rodríguez-villa, Memorias cit., p. 139.
16
dorez, Le Sac de Rome cit., p. 400.
17
h. omont, Les suites du sac de Rome par les Impériaux et la cam-
pagne de Lautrec en Italie, in «Mélanges d’Archéologie et d’Histoire»,
16 (1896), p. 52.
18
Per i furti e distruzioni delle biblioteche, non possiamo che
rimandare allo studio di L. Dorez (cfr. nota 16), che ha tratto notevo-
le partito dalla testimonianza di César Grolier, che fu presente al
sacco, pubblicata nel 1637.
19
g. müntz, La bibliothèque du Vatican au XVIe siècle, Paris 1887,
con le osservazioni di v. cian, in «Giornale Storico della Letteratura
Italiana», 9 (1887), pp. 454 sgg. Sulla visita dell’ottobre 1529 fatta dal
cardinale A. Del Monte, cfr. g. mercati, Cenni di A. del Monte e G.
Lascaris sulle perdite della Biblioteca Vaticana nel 1527, 1910, ristampato
in Opere minori, vol. III, Città del Vaticano 1937, pp. 130 sgg.
20
erasmo, Letters, a cura di p. S. Allen, 12 voll., Oxford 1966-68,
VII, n. 2059.
21
p. melantone, Oratio de capta et direpta urbe Roma, pubblicata
in latino da s. schard, Historicum opus, Basel 1574, vol. II, pp.
1860-65. Ne parla per sentito dire: «Hacc monumenta, cum aeterna
esse debuerint, tamen furore militum aliqua ex parte corrupta dicun-
tur. Et haud scio an impia flamma per urbem vagata, bibliothecas
etiam attigerit» (p. 1863). A questo proposito, cfr. cap. vi.
22
Cfr. cap. iv.
23
Lettera di G. Barozzi al fratello, 12 maggio 1527, in sanuto,
Diarii cit., XLV, col. 418.
24
j. shearman e i. white, Raphael’s Tapestries and their Cartoons,
in «Art Bulletin», 45 (1958), pp. 193-221.
25
Nella corrispondenza dei Gonzaga si parla sempre del recupero
di questi arazzi «ricomprati ai soldati». In una lettera di Ferrante alla
madre Isabella del 15 dicembre 1529, pubblicata da Gaye, Carteggio
cit., vol. II, p. 222, si accenna al recupero della Conversione di San Paolo
e di Paolo predica ad Atene. Cfr. luzio, Isabella d’Este e il Sacco di Roma
cit., pp. 234 sgg. Una lettera a Felice Della Rovere del 22 maggio 1528
informa che, da una nave presa dai Mori, il capitano Cazadiavolo ha
riportato «la bella tapezzaria del papa».
Le attività di Isabella in favore delle sue collezioni sono state esa-
minate da e. malcolm-brown, «Lo insaciabile desiderio nostro di cose
Storia dell’arte Einaudi 139
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
antique». New Documents on Isabella d’Este’s Collections of Antiquities,
in Cultural Aspects of the Renaissance, a cura di Cecil H. Clough, Man-
chester 1976, n. 18, pp. 32 sgg. Numerosi acquisti, negoziati, ecc. ven-
gono segnalati, pp. 335 sgg., per il periodo 1527-29.
26
shearman e white, Raphael’s Tapestries cit., pp. 215-16.
27
von pastor, Storia dei papi cit., vol. IV, parte I, libro 1, p. 474.
b. biagetti, Relazione III: monumenti, musei e gallerie pontificie nel
quadriennio 1930-34, in «Rendiconti della Pontificia Accademia Roma-
na di Archeologia», 9 (1933), p. 138, ill. 60-61.
28
154 x 57 cm. Cattedrale di Cagliari. c. aru, Il trittico di Clemente
VII nel Tesoro del Duomo di Cagliari, in Mélanges Hulin de Loo, Bruxel-
les e Paris 1931, pp. 16 sgg.
29
Citato da dorez, Le Sac de Rome cit., p. 369.
30
gregorovius, Storia della città di Roma cit., ha probabilmente
avuto ragione di affermare che i vincitori non si sono preoccupati delle
antichità; lanciani, The Destruction of Ancient Rome cit., pp. 237 sgg.,
ha ripreso questo punto di vista, che bisogna tuttavia sfumare in ragio-
ne dei rapporti d’affari di Maramaldo e di altri con collezionisti prin-
cipeschi.
31
a. luzio, Fabrizio Maramaldo. Nuovi documenti, Ancona 1883,
p. 26.
32
Alfonso d’Este cercava, come il marchese di Mantova, di fare
provvista di opere d’arte: lettera di Girolamo Naselli al duca di Fer-
rara, datata 25 giugno (Archivio di Stato di Modena), pubblicata da g.
salviolo, Nuovi studi sulla politica e le vicende dell’esercito imperiale in
Italia nel 1526-27, e sul Sacco di Roma, in «Archivio Veneto», A (1878),
pp. 27-33.
In una lettera del 5 giugno 1527, di un certo Sigismondo Fanzi-
no della Torre a Federico (?), si parla di «cinque teste e una gran figu-
ra» (luzio, Fabrizio Maramaldo cit., pp. 27 sgg.).
Secondo e. verheyen, The Palazzo del Tè in Mantua: Images of
Love and Politics, Baltimore 1977, gli oggetti promessi da Maramaldo
arrivarono effettivamente a Mantova nonostante le prevedibili diffi-
coltà di trasporto. Clifford M. Brown, nella recensione uscita in «The
Art Bulletin» del marzo 1980, p. 164, nota che la lettera del Della
Torre del giugno 1534 esclude tale possibilità perché fa riferimento a
«lo inganno dei Signor Fabritio [sic] e la disgratia de la peste». Mara-
maldo aveva ricevuto cento corone da Chigi per risparmiare la sua col-
lezione; era infatti capace di fare il doppio gioco.
33
Paolo Cesi (1481-1537) cardinale nel 1517. a. chacón [ciaco-
nius], Vitae et resgestae Pontificum romanorum, vol. III, Roma 1677, p.
414: «Post urbis miseram cladem cum adhuc in Hadriani arce custo-
diretur, cum suae res aliae omnes in incerto essent, cum de salute despe-
raret, nihil antiquius habuit quam curare ne antiquae inscriptiones aut
Storia dell’arte Einaudi 140
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
tabulae a militibus perderentur, auferrentur, alienarentur». Citato da
c. hulsen, Römische Antikengärten des XVI. Jahrhunderts, in «Abhand-
lungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften», 4, 1917, 1,
n. 4. Cfr. anche d. gnoli, Il giardino e l’antiquario del cardinale Cesi,
Roma 1905.
34
lanciani, Storia degli scavi cit., vol. I, pp. 153 sgg.
35
La collezione di antichità riunita «in aedibus Maximorum
Rome» è ricordata nella raccolta di Claude Belièvre, c. 1512. Ma biso-
gna tenere conto dell’esistenza di numerose case e «vigne» ugualmen-
te piene di frammenti antichi, possedute da quella ricca famiglia. fr.
ibid., vol. I, pp. 172-74- e. müntz, Le Musée du Capitole et les autres
collections romaines, in «Revue Archéologique», 43 (1882).
36
L’estinzione della famiglia Massimo e la distruzione del loro
palazzo è segnalata in una lettera di Sigismondo Fanzino, rappresentante
del marchese di Mantova. Cfr. sanuto, Diarii cit., XLV, COI. 294.
Sui palazzi della famiglia Massimo, cfr. c. l. frommel, Der römi-
sche Palastbau der Hochrenaissance, Tübingen 1973, vol. II, nota 20.
37
gregorovius, Storia della città di Roma cit.; von pastor, Storia
dei papi cit., vol. IV, parte II, libro III, p. 266.
38
«Quid mirari hospes tot numina muta, et anhelo | Sedibus his
aram ducer[e] sub lapidi? | Ho[s]tes adest, vertere metu se i[n] saxa
licet[que] | Tuta tegat vallis marmora, adhuc trepida[n]t». Cod. Vat.
lat . 7 182, f. 1051. Citato da h. brummer, The Statue Court in the Vati-
can Belvedere, Stockholm 1970, p. 119 nota 76. Olivier Michel ha gen-
tilmente controllato la lezione del testo.
39
a. michaelis, Römische Skizzenbücher Marten Van Heemskercks
und anderer nordischer Künstler des XVI. Jahrhunderts, in «Jahrbuch des
Kaiserlich deutschen archäologischen Instituts», 6 (1891), p. 226; c.
hülsen e h. egger, Drei römischen Skizzenbücher von Martin Van Heem-
skerck, 2 voll., Berlin 1913 e 1916; ried. 1975, tav. 128, pp. 56 sgg.
40
Testo pubblicato da c. scaccia scarafoni, Un documento stori-
camente e bibliograficamente ignoto relativo al Sacco di Roma, in «La
Bibliofilia», 40 (1938), pp. 46-53. Per la lettera di Perezoft, cfr. rodrí-
guez-villa, Memorias cit., p. 275.
41
vasari, Della scultura, § 13, in g. baldwin brown, Vasari on
Technique, London 1907, p. 130. Si veda j. lesellier, Jean de Chen-
nevières, sculpteur et architecte de l’église Saint-Louis-des-Français à Rome,
in «Mélange d’Archéologie et d’Histoire. Ecole française de Rome»,
45 (1931), pp. 239 sgg.
42
Mgr. f. bonnard, Histoire du couvent royal de la Trinité du Mont
Pincio à Rome, Paris 1933, pp. 82 sgg.
43
Cfr. cap. i.
44
von pastor, Storia dei papi cit., vol. IV, parte II, libro III,
p. 270.
Storia dell’arte Einaudi 141
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
45
Scherdin von Burtenbach, capitano dei lanzichenecchi, si vanta
di avere portato via vesti lussuose e 15000 fiorini d’oro puro, e in più
la corda di Giuda. Riguardo a questa «reliquia», cfr. le Mirabilia Romae
cit., p. 129: «vicino all’altare di San Pietro, dove il papa ha consacra-
to l’imperatore, è sospesa la corda di Giuda».
46
g. a. saluzzo di castellar, Memoriale (1482-1528), a cura di
V. Promis, Torino 1869.
47
e. müntz e a. l. frotingham, Il Tesoro della Basilica di San Pie-
tro in Vaticano dal XIII al XV secolo, con una scelta di inventari inediti, in
«Archivio della Reale Società Romana di Storia Patria», 6 (1883), pp.
1-138 (pp. 82 sgg., Inventarium, 1454-55; pp. 99 sgg., Inventarium
sacristie, 1489). x. barbier de montault, Les souterrains et le trésor de
Saint-Pierre à Rome, Roma 1866, dà un’idea delle perdite. Queste sono
commentate da f. m. torriglio, Le sacre grotte vaticane, Roma 16392,
p. 265. Cfr. e. müntz, Ricerche intorno ai lavori archeologici di G. Gri-
maldi, Firenze 1881, p. 445.
48
chastel, La Véronique cit., pp. 71 sgg.
49
rodocanachi, Rome au temps de Jules II cit., p. 98.
50
Lettera di Theodorus Vafer alias Gesscheid, pubblicata da i.
mayerhofer, Zwei Briefe aus Rom aus dem Jahre 1527, in «Historisches
Jahrbuch», 36 (1891), pp. 747 sgg.; h. grisar, Le tombe apostoliche di
Roma, in «Studi e Documenti di Storia e Diritto», 13 (1897), p. 345
nota 40, ha creduto di poter sostenere che la tomba dell’Apostolo non
era stata violata, nonostante la testimonianza citata. j. ruysschaert,
Le Sac de Rome de 1527 et la tombe de Saint Pierre d’après deux notai-
res contemporains, in «Römische Quartalschrift», 58 (1963), pp. 133
sgg. è meno sicuro sulla base di testimonianze complementari.
51
h. grisar, Die römische Kapelle Sancta Sanctorum und ihr Schatz,
Freiburg im Breisgau 1908, p. 24.
52
a. rocca, De particula ex pretioso et vivifico ligno Sacratissimae
Crucis. Roma 1609, citato in f. steinmann, Die Sixtinische Kapelle, Ber-
lin 1921, vol. I, p. 582.
53
panvinius, De praecipuis urbis Romae sanctioribusque basilicis...
Liber cit., p. 192. Sul catalogo delle reliquie dell’oratorio compilato nel
1624 da Lorenzo Bonincontri, segretario della confraternita, cfr. gri-
sar, Die römische Kapelle cit., p. 62.
54
Cfr. il catalogo della mostra Tesori d’arte sacra di Roma e del Lazio
dal Medioevo all’Ottocento, Roma 1975, nota 86.
55
Ibid., n. 100. P. de Sandoval nel 1604 ha segnalato la scoper-
ta di questa reliquia nel villaggio che chiama Calcata nel 1557. Cfr.
Epilogo.
56
o. panciroli, Tesori nascosti dell’alma città di Roma, Roma 1625,
p. 195, ha riferito che il crocifisso dipinto della chiesa di Santo Spiri-
to a Roma (Rione Monti) aveva versato lacrime durante il sacco; inol-
Storia dell’arte Einaudi 142
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
tre, la sacra immagine avrebbe protetto le monache del monastero
facendole apparire agli occhi dei soldatacci imperiali come vecchie e
brutte, mentre erano giovani e belle: «incontrandosi i soldati in una di
quelle monache, tanto brutta gli parve (ancorché fosse delle più visto-
se) che venutagli a schifo, voltarono le spalle a tutte. Del che ne fa fede
una di 90, che entrando in questo monasterio, quand’era fanciulla, l’in-
tese dall’altre, che presenti vi furono, essendo occorso il sacco l’anno
1527. E tanta gratia la riconoscono dalla detta imagine del Salvatore...»
Questo delizioso aneddoto è citato da picca, Il Sacco di Roma del 1527
cit., p. 122.
57
Una lettera d’un ecclesiastico, Baldassarre da Pescia, a un mona-
co di Santa Giustina da Padova, del 15 febbraio 1528 (sanuto, Diarii
cit., XLV, coll. 87-88) riferisce un fatto portato a conoscenza di chi
scrive dal cardinale Campeggio: una Madonna vicina al Pantheon,
mutilata da uno spagnolo, si mise a piangere; il soldato fu catturato e
strangolato dai compagni. Questo miracolo avvenne il 10 o l’11 feb-
braio 1528.
A quest’episodio molto celebre fa probabilmente allusione G. B.
Giraldi nella prima novella degli Hecatommithi, Monte Regale 1565,
dove si trova una lunga descrizione del sacco (cfr. Epilogo).
58
Un breve del 26 ottobre 1527, concernente le reliquie rubate «in
tam detestabili et abominabili almae urbis nostrae direptione», che si
dovevano ritrovare e riportare a Roma, è stato pubblicato da b. fon-
tana, Renata di Francia duchessa di Ferrara, in Sui documenti dell’archi-
vio estense, del mediceo, del Gonzaga e dell’archivio segreto vaticano
(1510-1536), Roma 1889, vol. I, appendice X, p. 430.
59
Secondo un documento degli Archivi Vaticani, Don Giuliano de
Castillo, toccato dalla grazia, abbandonò il servizio per consacrarsi al
salvataggio delle reliquie. La riconsegna solenne, che ebbe luogo il 26
novembre 1528, secondo la sua dichiarazione, riguardava le reliquie di
san Biagio, un piede di santa Maria Maddalena, la mano destra di santa
Barbara, un frammento della mangiatoia, un frammento della tavola
della Cena, due pannicelli volgarmente chiamati bavaglini di Nostro
Signore Gesù con una macchia di latte. m. armellini, Un documento
del Sacco di Roma del 1527, in «Cronachetta Mensuale di Scienze
Naturali e d’Archeologia», n. 24 (dicembre 1890), pp. 179 sgg.
60
torrigio, Le sacre grotte vaticane cit., p. 264.
61
Secondo un documento di «Maestro Giovanni Antonio» (Archi-
vio Segreto), citato da p. balan, Clemente VII e l’Italia dei suoi tempi,
Milano 1887, pp. 62 sgg. sono stati rubati: «Unus pes beatae Mariae
Magdalenae | Duo panniculi vulgari sermone dicti bavaroli ı sanctissi-
mi domini nostri Jesu Christi cum macula | lactis et una parva macula
pannilini».
62
sanuto, Diarii cit., XLV, col. 122.
Storia dell’arte Einaudi 143
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
63
Quando chiese ai canonici di San Giovanni in Laterano come
avessero potuto salvare le reliquie degli Apostoli, Leonardo Santoro
ottenne come risposta: «Divinamente i barbari spaventati mentre si
apparecchiavano di abbattere il ciborio, fuggirono via» (santoro, Dei
successi del Sacco di Roma cit., p. 14).
64
Cfr. per l’Inghilterra, j. phillips, The Reformation of Images:
Destruction of Art in England (1535-1660), Berkeley 1973; e per i Paesi
Bassi, d. freedberg, The Problem of Images in Northern Europe and its
Repercussions in the Netherlands, in Hafnia, K°benhavn 1977, pp. 25-45
(con bibliografia sull’iconoclastia nordica).
65
27 giugno 1527, in Letters and Papers Foreign and Domestic of the
Reign of Henry VIII, a cura di J. S. Brewer, London 1872, VOI. IV,
parte II.
66
sanuto, Diarii cit., XLV, col. 436.
67
Questo episodio è ricordato come tipico del comportamento lute-
rano da un polemista antiprotestante, de reamond, Histoire de la nais-
sance... de l’hérésie cit., p. 280: «Dopo che ebbero fatto una stalla per
i cavalli della cappella papale, i luterani rivestiti degli ornamenti eccle-
siastici, scelsero fra loro un lanzichenecco, che tenendo il posto di Lute-
ro fu creato Papa, mentre tutti i soldati alzando la mano gridavano:
Lutero Papa, Lutero Papa».
68
Lebensbeschreibung des berühmten Ritters Sebastian Schertlin von
Burtenbach, a cura di C. S. von Holzschuher, 2 voll., Nürnberg
1777-82.
69
Tutto questo in gregorovius, Storia della città di Roma cit., ed
è essenzialmente tratto dalle narrazioni raccolte da G. Milanesi ne Il
Sacco di Roma del MDXXVII cit.
70
Da un manoscritto della Biblioteca Angelica; schulz, Der Sacco
cit., p. 71.
71
Pubblicato da rodríguez-villa, Memorias cit., pp. 134 sgg. Tra-
duzione parziale in von pastor, Storia dei papi cit., vol. IV, parte II,
libro III, pp. 277-78.
72
Secondo canovas del castillo, Del asalto y saqueo de Roma...
cit., l’odio che ne è risultato durò fino al secolo xvii.
73
La frase proviene dal giurista Fabius Arcas de Narnia, citato da
Kilian Leib nella sua cronaca pubblicata da j. döllinger, Beiträge zur
Politischen, Kirchlichen und Kulturgeschichte der letzten sechs Jahrhun-
derte, Regensburg 1862, vol. II, p. 512.
74
Direptio expugnatae urbis Romae... cit., p. 108.
75
Secondo una lettera del 27 luglio indirizzata da Navagero al doge
di Venezia (brown, Calendar of State Papers cit., vol. IV, pp. 76-78), ci
si è talvolta interrogati su una collusione possibile fra il conestabile di
Borbone e Zwingli: f. de boni, Gli eserciti stranieri in Roma nell’anno
1527, in «Il Politecnico» serie II, vol. 47 (1860), pp. 405 sgg.
Storia dell’arte Einaudi 144
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
76
Cfr. a. venturi, Storia dell’arte italiana, X: La scultura del Cin-
quecento, parte II, Milano 1936, pp. 207 sgg.
77
Carlo V aveva chiesto a Filiberto di Chalon, principe di Oran-
ge, di curarsi di fare erigere per il conestabile una tomba «trionfale» a
Milano o a Napoli (lettera da Valladolid, 30 giugno 1527, pubblicata
da r. ulysse, Philibert de Chalon, prince d’Orange (1502-1530). Lettres
et documents, in «Boletin de la Real Academia de la Historia», 39
[1901], n. 71). Si era dapprima pensato a Milano: cfr. il rapporto (cita-
to) dall’abate di Naiera, il 27 maggio 1527 (rodríguez-villa, Memo-
rias cit., p. 139), ma finalmente l’esercito imperiale, lasciando Roma,
portò i resti del conestabile a Gaeta. Cfr. a. lebey, Le Connétable de
Bourbon (1490-1527), Paris 1904, pp. 442 sgg. Questi riposò dappri-
ma sotto un mausoleo innalzato nella cappella del castello. Nel 1562,
essendo stato scomunicato il conestabile, il Concilio di Trento ne
ordinò l’esumazione e il corpo fu collocato all’esterno della cappella,
dove parecchi viaggiatori poterono vederlo nel corso dei secoli xvi, xvii
e xviii. Il castello di Gaeta fu distrutto nel 1860.
78
Si veda la serie dei disegni e incisioni di Urs Graf in h. koegler,
Urs Graf, Basel 1947; e. major e e. gradman, Urs Graf, Basel s.d. Su Nico-
las Manuel, c. a. beerli, Le peintre poète Nicolas Manuel et l’évolution socia-
le de son temps, Genève 1953, cap. v: Le guerrier, mythe et réalité.
Il lanzichenecco tedesco, copiato dal fantaccino svizzero, appare
nel Corteo trionfale di Massimiliano (H. Burgkmair, Dürer e altri, verso
il 6-18, pubblicato nel 1526), dove guida e accompagna i carri. Nel
1520, Barthel Beham incise una serie di lanzichenecchi in maniera
comica; Cfr. zschelletschky, Die «drei Gottlosen Maler» von Nürn-
berg cit., p. 315.
La migliore raffigurazione dei lanzichenecchi è senza dubbio il pic-
colo pannello in grisaglia firmato Bruegel, datato 1568 (?), se si fosse
certi della sua origine e del suo autore. Probabilmente è un frammen-
to ritagliato da, o uno dei pezzi di, un insieme che fisserebbe un signi-
ficato complessivo a questo gruppo del porta-stendardo, tamburino e
pifferaio, tutti e tre in azione, nel costume tipico dei mercenari, molto
simile all’incisione di Barthel Beham (1525): Coli. Frick, New York,
pannello di quercia: cm 20,3 x 17,8, firmato e datato in basso a sini-
stra. Nella data manca la L che s’impone. L’opera è segnalata nella col-
lezione di Carlo I nel 1639. Cfr. il catalogo della Frick Collection, New
York 1968, vol. I, pp. 142 sgg.
79
w. scheidig, Holzschnitte des Petrarca-Meisters, Berlin 1955, p. 72.
80
w. berenson, Italian Pictures of the Renaissance. Central and
North-Italian Schools, London 1968, tav. 994.
81
Cfr. cap. vi.
82
torrigio, Le sacre grotte vaticane cit., p. 262. L’autore rimanda
a Giovanni Battista del Tuso nella Historia dei chierici regulari, cap. 18.
Storia dell’arte Einaudi 145
Capitolo quarto
Polemiche: italiani e barbari
A colpire ancora più profondamente l’immaginazio-
ne popolare, il sacco di Roma, già annunciato in molti
modi1, ebbe ulteriore conferma dalle «profezie retro-
spettive». Si trattava di un avvenimento di tale impor-
tanza che non poteva non essere esplicitamente segna-
to negli annali della storia celeste e rivelato attraverso
prodigia di un titolo più classico di quelli del 1526. Tra
la fine del 1527 e il corso del ’28, numerosi opuscoli par-
lavano di una cometa comparsa nell’ottobre 15272, che
altro significato non aveva se non quello della sciagura
abbattutasi sul mondo cristiano. Gli opuscoli recavano
un’illustrazione, con una mano in cielo che stringe un
pugnale, sopra o nel mezzo di una pioggia di armi e di
teste mozze. Il prototipo di questa figurazione va ricer-
cato in Plinio e nella sua spada – cometa, detta ’Eigàai3.
L’attuale vignetta ricordava un’immagine della propa-
ganda «piagnona»4 diffusa intorno al 1495: il pugnale in
cielo, in forma di cometa, indica la minaccia legata
all’apparizione del corpo celeste5. In un opuscolo fran-
cese le asce e le picche stanno ad indicare i tedeschi, le
spade corte gli spagnoli e le teste mozze le loro vittime
– gli italiani. Due decenni più tardi, nelle raccolte di
«prodigi»6, si ritrova la medesima cometa in forma di
spada come annuncio della distruzione di Gerusalemme
nel 72, del sacco di Roma dei goti di Alarico nel 413, e
degli avvenimenti del 1527, per i quali il segno celeste
Storia dell’arte Einaudi 146
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
corrisponde a due immani sciagure: l’invasione turca
dei territori del Danubio e il saccheggio di Roma «ab
exercitu caesariano duce Borbonio». Anche nelle rac-
colte del xviii secolo si associa la cometa con il sacco7.
L’esoterismo ghibellino.
I pronostici che comportavano annunzi troppo pre-
cisi, come il diluvio pronosticato per il 1524, erano stati
smentiti. Ma quelle anticipazioni illusorie erano dimen-
ticate di fronte al successo che ebbero gli annunzi cata-
strofici su Roma. Dopo quel che era capitato, qualsiasi
cosa poteva accadere. I libretti profetici si moltiplica-
rono di nuovo dopo il 1528-30, spesso re-interpretando
testi più antichi, o fingendo di essere stati pubblicati in
data più antica. Tuttavia il loro colore politico e il loro
tenore generale aveva subito un mutamento. Il nuovo
tono è esemplificato da un opuscolo piuttosto notevole
intitolato De eversione Europae pronosticon, che com-
parve al più tardi nel 1534, forse già nel 15328; descri-
ve la futura cristianità dopo mezzo secolo di tormenti e
afferma che la comunità delle nazioni non ha altra scel-
ta che quella di rivolgersi all’autorità riconosciuta del-
l’imperatore per impedire ai turchi di invadere l’Euro-
pa. Il dramma del 1527 è solo un momento di una crisi
assai più vasta, che richiederà l’aiuto dell’imperatore. Il
tema delle crociate ricompariva periodicamente come la
persistente coscienza di un’ansietà che urge tanto
profondamente quanto non trova sbocco. L’astrologia
era diventata ghibellina dopo il 15279.
Fra i prodigia che contarono davvero e non furono
dovuti a pure allucinazioni, ci fu l’inondazione dell’8
ottobre 1530, una delle più gravi del secolo10, che portò
l’altezza delle acque a 13 palmi11. Un tedesco scrisse, in
un resoconto del disastro in tre fogli, che le acque erano
Storia dell’arte Einaudi 147
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
salite fino a San Marco e ai Santi Apostoli, ricoprendo
il Campo dei Fiori e la Piazza Navona. Egli concludeva
che dal punto di vista dei danni alle case provocati dal-
l’acqua: «si ebbero rovine ancora maggiori che durante
il sacco, quando Roma fu depredata»12. Il nuovo cata-
clisma apparve ai romani e alla Curia quasi un supple-
mento al sacco voluto dalla Provvidenza, una minaccia
di rovina fisica totale che si aggiungeva a quella della
rovina morale. Che è l’idea che esprime il poema di
Luigi Alamanni Il diluvio romano13.
Questa terribile disgrazia, che tutti si affrettarono a
commentare, sovreccitò tanto più gli animi in quanto
seguiva l’incoronazione di Bologna e la conclusione di
una pace auspicata ma umiliante. Ancora una volta
Roma era sommersa dall’orrore, dalla miseria e dalla
morte; simili orrori non mostrano nulla di naturale. Ne
è una prova lo strano e prolisso trattato intitolato Sce-
china (dal nome del decimo tra i Safiroth o attributi di
Dio, secondo la Cabala)14. Nel luglio 1530 Clemente
aveva inviato una lettera urgente al cardinale Egidio da
Viterbo, invitandolo ad abbandonare il suo riserbo dot-
trinale e a rivolgersi ai grandi testi esoterici ebraici per
essere illuminato nella interpretazione della Sacra Scrit-
tura15. È una richiesta che rivela un pensiero inquieto,
che cerca nuovi lumi. Egidio, generale degli Agostinia-
ni, sotto Giulio II e al momento del concilio laterano,
aveva avuto un ruolo importante nel definire la plenitu-
do temporum; la sua autorità di teologo incuteva grande
rispetto16. Incoraggiandolo a ricorrere alle esegesi non
tradizionali, il papa pensava forse al tentativo di Pico
della Mirandola, interrotto nel 1492. L’occultismo scrit-
turale è un rimedio spirituale per i tempi torbidi.
Il trattato della Scechina (o «Presenza di Dio») è rima-
sto incompiuto. La personificazione dell’attributo divi-
no si rivolge all’imperatore con un lungo ragionamento
sulla simbolica dei numeri, delle lettere e dei nomi,
Storia dell’arte Einaudi 148
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
mescolando costantemente allusioni agli eventi contem-
poranei, e più precisamente a due fatti di alto significa-
to: il sacco di Roma, largamente profetizzato, e l’inon-
dazione del 1530. La concatenazione dei due eventi e
spiegata in una pagina sorprendente che merita di esse-
re conosciuta perché proviene da un letterato vicino a
Clemente, e da conto del nuovo corso del profetismo
dopo quei tragici anni. È la «Presenza di Dio» che parla:
Avevo fatto di Roma la capitale; dimenticando la mia
bontà, essa si è abbandonata più di ogni altra al peccato. Io
l’ho protetta finché fu possibile: spesso l’ho spaventata con
voci profetiche, minacciandole il saccheggio; l’ho esortata
alla riforma morale, alla resipiscenza, al ritorno a modi
salutari. i fatti sono seguiti alle minacce; ho fatto interve-
nire la tua mano con il Borbone; ho preso la città, l’ho sac-
cheggiata, l’ho riempita di assassinio, di sangue, d’incendio.
Tutte queste torture, tutte queste afflizioni, tutte queste
calamità, sono stato io a provocarle, ma benché ne fossi
l’autore, avevo orrore di uno spettacolo così crudele. Mossa
a pietà davanti a questo cumulo di dolori, ti invitavo – tu
lo sai – a risparmiare la città, a liberare i prigionieri, a
richiamare l’esercito, a ristabilire posti di guardia e citta-
della, a recarti in Italia, a fare la pace con i nemici, a ren-
dere ai miei sacerdoti un omaggio quale non avevano rice-
vuto prima. Tornando alla città, mi aspettavo che, avendo
ricevuto prima queste ferite, poi questi onori, capisse l’a-
zione delle due mani di Dio, la sinistra che lacera per mezzo
del Borbone, la destra, che, grazie a te, abbraccia, risolle-
va, restituisce a Bologna. E io vedo che niente è stato com-
piuto; non solo il rimedio non ha guarito, ma ha provoca-
to maggiore licenza colpevole, insolenza audace, avidità,
lussuria e rabbia. Ho voluto dare un nuovo avvertimento:
dopo l’aggressione di Borbone a ferro e fuoco, provocai
quella dell’inondazione facendo salire il Tevere a un’altez-
za eccezionale, per cui invase tutto quanto, trascinò via la
Storia dell’arte Einaudi 149
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
riserva di grano, distrusse le case e provoco guasti a tal
punto che il Tevere toscano parve a tutti – o quasi – un
nemico più crudele del barbaro straniero Borbone. Ma tutto
ciò non è servito a nulla. È certo che non risparmierò più
una corruzione che resiste alla mano del medico17 ; la
taglierò con la falce di nemici atroci, rovescerò il vecchio
ordine e ne stabilirò uno nuovo»18.
Secondo questo discorso, tutto si lega, dunque, nel
susseguirsi degli avvenimenti: le minacce profetiche, la
catastrofe del 1527, l’intervento dell’imperatore e la
pace di Bologna nel 1530. La collera e il perdono divi-
ni si sono alternati. Tutto ciò annunzia che la collera
provocherà nuove e terribili sciagure. Siamo al primo
stadio; altre prove si devono temere, poiché non vi e
alcun indizio di pentimento o di riforma morale. Orbe-
ne, Scechina Provvidenza ha scelto come interlocutore,
per il suo severo discorso, l’imperatore Carlo V:
«manum tuam adduxi cum Borbonio»*. La salvezza
verrà da lui: se porta il numero cinque nel suo nome, e
perché questo numero e legato alla liberazione dal male,
come si può vedere – scrive Egidio – nelle cinque feri-
te del Messia Gesù19. La confusione mentale del teolo-
go era completa e la sua conversione alla causa di Cesa-
re senza riserve. Non sembra che il suo trattato sia stato
diffuso. Non se ne conosce alcuna risonanza, alcuna
illustrazione. Ma esso illumina di una luce obliqua il
clima di angosciosa inquietudine dell’inverno 1530-31,
e dei tre ultimi anni del pontificato di Clemente.
La fine dell’Italia.
È impossibile districare da tanti scritti e dichiarazioni
veementi ciò che era razionale da ciò che fatti senza pre-
cedenti avevano suscitato nell’immaginazione. Emerge
Storia dell’arte Einaudi 150
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
un senso, che non trova attenuazione nella coscienza di
trovarsi in un momento eccezionale. Si distinguono due
atteggiamenti contraddittori con una caratteristica oscil-
lazione: ora s’invoca la fatalità, il che generalmente si
accompagna al sentimento di un’orribile ingiustizia, ora
l’azione provvidenziale interpretata come invito alla
penitenza dopo il castigo. La prima è, più che altrove,
presente tra i lamenti e le imprecazioni che si possono
qualificare popolari, la seconda appare più diffusa tra i
chierici, con una differenza importante, a seconda se essi
continuano a credere oppure hanno perso la fede nella
vocazione essenziale di Roma. Spesso sono guidati da
preoccupazioni politiche. Il poema Canzone dove si narra
la strage e il sacco di Roma, di Girolamo Casio de’ Medi-
ci, si presenta come una deplorazione, ma di fatto ètut-
to orientato a dimostrare che l’imperatore e la sua poli-
tica vanno «nel senso della storia»: la sciagura di Roma
non è quella di Troia o di Cartagine20.
Abbiamo la fortuna che quel periodo convulso abbia
avuto uno dei testimoni più lucidi e meno disposti a
lasciarsi ingannare, Francesco Guicciardini. Nelle suc-
cessive discussioni riguardo alle responsabilità delle varie
parti, nell’apprezzamento dei ruoli svolti e dell’attitu-
dine dei protagonisti a svolgerli, dal secolo xvi in poi,
niente è stato prospettato che già non fosse stato enun-
ciato nella Storia d’Italia21. Questo capolavoro della let-
teratura storica fu redatto da Francesco Guicciardini a
cominciare dal momento in cui, con la morte di Cle-
mente, fu chiaro che la sua carriera politica era finita.
Nel 1534, egli lasciò pertanto il posto di vicelegato a
Bologna, dove il papa l’aveva destinato tre anni prima,
tornò a Firenze e si ritirò ben presto nelle sue pro-
prietà22. Fu allora che Giuliano Bugiardini dipinse il
ritratto ricordato da Vasari23.
Guicciardini, consigliere di Clemente, e fautore con
Giberti di una politica decisamente antiimperiale, che
Storia dell’arte Einaudi 151
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
solo poteva, ai suoi occhi, salvare la libertà d’Italia, aveva
sperimentato tutto e aveva veduto fallire tutto. Il ritiro
in cui lo relegò l’avvento di Paolo III fece di lui il più
grande storico del suo secolo. Forse ebbe la speranza,
come è stato notato24, di ottenere come storico la gloria
negatagli come politico. Scrittore magistrale, per sciol-
tezza, vigore e sottigliezza degni di un grande roman-
ziere moderno, seppe analizzare in profondità la tre-
menda degradazione dell’Italia, a cominciare dalle guer-
re della fine del Quattrocento. Perché questa fu la sua
motivazione e il suo tema. Smontando pezzo per pezzo
il meccanismo implacabile dei fatti provocati dagli erro-
ri e dalle illusioni italiane, egli trasformò a poco a poco
la cronaca delle guerre europee condotte nella penisola
in una grandiosa tragedia, ch’egli vedeva guidata più dal
caso che dal destino. Il suo disincanto ha imprestato per
la prima volta alla «fortuna», al moto fortuito e all’in-
stabilità delle forze, un valore di principio che illumina
tutto25. E quindi il più elevato dei discorsi storici si col-
loca accanto al Trionfo di fortuna, di cui abbiamo rico-
nosciuto l’idea basilare nelle stampe popolari, che tra-
duce in un’immagine di grande plasticità un senso gene-
rale di incertezza. E, al tempo stesso, il ragionamento
del più grande storico dell’epoca non può alla fine che
rinviare alla nozione, appoggiata sullo schema general-
mente diffuso del Trionfo, di un principio quasi demo-
niaco di alternanza e di mutamento.
Guicciardini si trovava a Città della Pieve quando
seppe della presa del Borgo. Credette ancora alla resi-
stenza di Trastevere. Il 10 maggio conobbe «la crude-
lissima nuova di Roma»26. Come per convincerci che la
sua cupa intuizione era veramente nata dalla sconfitta
totale, irrimediabile, della politica di Clemente, come
per invitarci a misurare completamente il suo tormen-
to, Guicciardini ha scritto, ancora sotto l’impressione
della prova, una specie di meditazione sul modello di
Storia dell’arte Einaudi 152
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Seneca e di Boezio, dove il dramma del sacco è analiz-
zato nelle sue conseguenze personali e illustrato da un
monologo interiore. Quest’opera è la Consolatoria27.
Scosse dal disastro di Roma tutte le sue convinzioni, lo
storico s’interroga pertanto dolorosamente. Come
Petrarca nel Secretum, Guicciardini dialoga con se stes-
so. «Sono concorsi in un tempo medesimo troppi acci-
denti perturbanti; né è solo la roba in che tu patisci, ma
di più la grandezza, la dignità, e quello che io credo che
ti pesi sopra tutte le cose, l’onore»28.
Guicciardini muore di vergogna. Vorrebbe pur supe-
rare la sua bruciante angoscia con una elevazione mora-
le o religiosa che lo distaccherebbe da queste miserie; ma
non può e neanche tenta di farlo, osservando che biso-
gnerebbe essersi spogliato della debolezza umana, il che
non è possibile: «Come io desidero che tu sia in questa
perfezione, così confesso io di essere alieno». Il suo
nome, la sua posizione sociale, avrebbero dovuto met-
terlo in grado di porsi a una buona distanza dal passa-
to, dal presente e dalle vicissitudini attraversate. Ma
questo non può essere, ed egli decide di intrattenersi
«più bassamente» con se stesso su tutto ciò che gli è
capitato. Vi è qui una sorprendente e, secondo noi,
ammirevole riflessione su una vocazione che si decide
sotto lo choc e vuole costringersi ad affrontare il reale
nell’amarezza.
Nessun altro potrebbe, senza dubbio, abbandonarsi
a un simile esame di coscienza; il documento che ne
risulta è per noi fondamentale, perché fornisce la chia-
ve dell’analisi storica alla quale abbiamo creduto neces-
sario agganciarsi. Intendiamo dire che il sacco di Roma
ha preso le proporzioni di un disastro che rimette tutto
in causa. Qualunque cosa l’avvenire riservasse, qualco-
sa di irrimediabile era accaduto. Le conseguenze appa-
riranno a poco a poco in tutti i campi, ma l’importante
è sapere perché nulla sarà più come prima. Questo sen-
Storia dell’arte Einaudi 153
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
timento di lacerazione così profonda da raggiungere l’i-
dentità stessa, ci pare che l’abbia conosciuto e medita-
to Guicciardini, il quale seppe trarne una sintesi degli
eventi. Il suo resoconto poggia sulla storia politica, ma
è troppo penetrante per non indurci a esaminare alla luce
delle sue analisi gli altri aspetti della storia di Roma e
del Rinascimento.
Machiavelli era morto in Toscana nel giugno del
1527, vecchio, in disparte, ma ancora vagamente temu-
to. Che cosa si riteneva della sua opera? L’idea che solo
un principe, un politico intrepido, potesse assicurare
l’unità dell’Italia. Oltre le riserve morali che sempre
ispirava, in Spagna come a Roma, la teoria della «poli-
tica pura», questa posizione non coincideva più con il
problema posto dal conflitto dei due poteri dominanti.
Non conveniva né alla monarchia spagnola né alla poli-
tica del partito romano orientato da Giberti e Guic-
ciardini29. Ma quello che non si dimenticava del Princi-
pe era la celebrazione minuziosa della grandezza della
Roma antica, esemplare nell’arte della guerra, quanto in
quella del governo; ed era l’affermazione delle possibi-
lità proprie all’energia umana, la «virtù».
Guicciardini non credeva più senza riserva né all’u-
na né all’altra. «Quale errore citare a ogni proposito i
vecchi Romani»: scrive testualmente per sbarazzarsi di
un modello smentito dal corso delle cose30. Le Conside-
razioni intorno ai Discorsi del Machiavelli, che distruggo-
no metodicamente il vecchio modello, datano, sembra,
dal 1528. Per quanto riguarda la «virtù», questa svani-
sce nell’impotenza e nella confusione che nasce dall’i-
nestricabile groviglio delle circostanze. Si direbbe che il
crollo del 1527 debba una volta per sempre aprire gli
occhi sul vacuo turbinare dell’attività umana. È stato
scritto molto a proposito: «L’impressione più forte, la
più costante che da la Storia d’Italia è quella della debo-
lezza e dell’impotenza umane di fronte al destino»31.
Storia dell’arte Einaudi 154
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Nulla è più impressionante che la famosa e malinco-
nica conclusione dei Ricordi: «Quando io considero a
quanti accidenti e pericoli di infirmità, di caso, di vio-
lenza e in modi infiniti, è sottoposta la vita dell’uomo,
quante cose bisogna concorrino nello anno a volere che
la ricolta sia buona, non è cosa di che io mi meravigli più
che vedere uno uomo vecchio, uno anno fertile»32.
Quello che Guicciardini ha vissuto, quello che ha
sperato di impedire ad ogni costo, quello che ha tenta-
to di rendere intelligibile risalendo al punto di parten-
za del 1494, seguendo passo passo illusioni e errori, è la
sconfitta dell’italianità. Spinto dal dolore di questo
smacco, egli si accinse a cogliere, nei quarant’anni di sto-
ria durante i quali tutto è messo in movimento ed è
scomparso l’equilibrio del Quattrocento, la genesi, l’e-
videnza e lo sfacelo della politica razionale. La parola
d’ordine «libertà d’Italia» copriva al tempo stesso l’in-
dipendenza degli stati della penisola e l’autonomia della
Chiesa. Perciò taluni storici recenti hanno ritenuto che
salvando l’unità religiosa dell’Italia, la politica antiim-
periale preservava l’unica forma di unità esistente33. Ma
questa posizione stessa non mette in evidenza il fatto
che l’«italianità» non era solamente, né veramente, un
fattore politico? In un mondo vieppiù dominato dalla
politica separatista, questa ne era la debolezza essen-
ziale. Il solo momento in cui, come bene ha notato F.
Chabod, si delineò una specie di «sentimento naziona-
le», quando l’unione degli stati della penisola, e in par-
ticolare della cooperazione politica e militare di Vene-
zia e dello Stato pontificio si realizzarono sotto il segno
dell’«italianità», si ebbe nel breve periodo fra la scon-
fitta di Pavia (febbraio 1525) e l’incontro di Bologna
(autunno 1529), ossia durante gli anni in cui la minac-
cia di predominio spagnolo si precisa, si rafforza e cul-
mina in maniera clamorosa con il sacco di Roma34. L’u-
nico modo in cui la «barbara servitù» poteva essere evi-
Storia dell’arte Einaudi 155
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
tata, al momento della Lega di Cognac, e ancora dopo
l’odioso sacco, si sarebbe potuto avere se gli stati aves-
sero saputo rinunciare alle loro piccole ambizioni e si
fossero uniti con il pungolo di un’azione francese più
decisa. Per due volte, la ruota ha girato nel senso sba-
gliato e ha collocato al posto buono la potenza imperia-
le, il che significava la schiavitù politica e morale.
Con un senso del dramma che richiama Shakespea-
re, Guicciardini constata che, se gli eventi di rado obbe-
discono alle intenzioni degli uomini, le motivazioni psi-
cologiche, i moti e le passioni intervengono costante-
mente nell’oscillare tra menzogna e verità, tra azione e
inazione; soltanto la fortuna è fattore decisivo, e nes-
suno la controlla a lungo.
Possiamo chiederci se quella specie di tetraggine, il
disfattismo, il senso di un’irrimediabile debolezza poli-
tica, che hanno tanto dominato il pensiero italiano fino
al Risorgimento, non siano state per le generazioni
seguenti al sacco il prolungamento naturale della delu-
sione subita nel secondo quarto del secolo xvi, e del crol-
lo del mito dell’Italia, che Guicciardini, disperato e luci-
do, si è adoperato a definire e a registrare. Analizzando
il proprio caso personale, lo storico osserva che dovreb-
be prendere le distanze dagli avvenimenti; ma non può.
Preoccupato di cogliere il moto della storia, rifiuta l’in-
terpretazione teologica e propriamente religiosa, che
forse s’impone e che tanti altri scrutavano non lontani
da lui, rifiuta la finalità per ricercare l’intelligibilità
complessa e contraddittoria del comportamento umano.
Egli applica magistralmente, in un testo celebre, questo
stesso teorema alla condizione della Santa Sede: la cui
vocazione è «la cura spirituale» senza il temporale, ma
essa andrà incontro all’annientamento se si limita a que-
sto35. Il pensatore più rigoroso del Rinascimento è dun-
que costretto a enucleare le situazioni contraddittorie
che gli stanno intorno, trovando l’origine, ma non la
Storia dell’arte Einaudi 156
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
causa ultima, della sconfitta in quella complessità natu-
rale. Lo stesso tipo di analisi dovrebbe valere per i campi
da Guicciardini non affrontati, come da nessun altro sto-
rico del suo tempo, che si possono, grosso modo, chia-
mare la «cultura», di cui nessuno allora si proponeva la
formulazione precisa, perché rientrava genericamente
nel concetto di «italianità». Questo, appunto, emerge da
una serie di polemiche che documentano un improvvi-
so mutamento in materia di costumi, di modo di vive-
re, d’interessi profondi dopo il sacco di Roma.
La disperazione dei letterati.
Le disgrazie degli intellettuali romani sono più cono-
sciute di quelle degli artisti, che non furono minori. Ma
la terribile condizione degli scrittori fu oggetto di un’o-
pera vendicatrice di Pierio Valeriano, apparsa agli inizi
del 1529, con il titolo De litteratorum infelicitate libri
duo36 . Questo trattatello è uno dei quadri più cupi che
mai siano stati tracciati sulla condizione degli scrittori
laici. Uno degli interlocutori esclama:
Tutti gli uomini di lettere sono votati, soprattutto al
tempo nostro, ai tormenti e alle sciagure. Tutti quelli che
avrei voluto vedere sono stati in gran numero, a loro per-
dita, sottomessi ai più atroci rigori della sorte, colpiti dalle
più indegne vicissitudini, talvolta morti di peste, talvolta
gettati in esilio e lasciati nel bisogno, chi ucciso di spada,
chi assalito da tormenti quotidiani, altri ridotti, il che è il
peggiore degli infortuni, al suicidio.
Valeriano parla come un intellettuale che non si è ras-
segnato agli orrori della guerra e della brutalità. Anco-
ra in preda allo spavento generalizza indubbiamente una
situazione che ha conosciuto troppo da vicino37.
Storia dell’arte Einaudi 157
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
È vero che l’ambiente romano era stato colpito molto
duramente. Fra gli archeologi più noti, Andrea Fulvio
era stato ucciso in maggio, Fabio Calvo morì entro l’an-
no. Paolo Giovio, che era fuggito in Castel Sant’Ange-
lo accompagnando e, stando a lui, proteggendo Cle-
mente, aveva perduto libri e carte. Del pari Tebaldeo,
che non perdonò mai al potere imperiale quell’abomi-
nevole entrata in Roma nel mese di maggio38. Giraldi,
abbandonando ogni cosa, era fuggito a Bologna, dove
manifestò la sua desolazione in un lungo dramma dedi-
cato a Tebaldeo, per dimostrare in forma di catalogo l’ir-
reparabile dispersione dei letterati. Per quanto il testo
sia ampolloso, rivela l’autentico dolore per la perdita di
quel porto di salvezza per gli intellettuali che Roma
offriva. Lo spirito non ha più una dimora: «nunc quo me
vertam?»39. Questo smarrimento rivela, ove ve ne fosse
bisogno, il valore insostituibile della Città nel mondo let-
terario italiano. L’Oratio di Melantone conferma la
preoccupazione degli scrittori di fronte al saccheggio
delle biblioteche romane, le più ricche del mondo, e la
scomparsa di autori ammirevoli, concludendo: «in que-
sta sciagura, la cultura letteraria stessa e in pericolo»40.
Il giudizio complessivo dato da Valeriano sulla vita
intellettuale non si discosta dal giudizio dato da Guic-
ciardini sulla vita politica: nulla è durevole e i letterati
non hanno una base salda nella società. Essi dipendono
dal potere dominante; tentano di conciliarsi i principi e
i pontefici, ma, per ragioni non meno accidentali, sia
sotto il favore di Clemente che sotto il pontificato antiu-
manista di Adriano VI, sono alla mercé della sorte. Se
i padroni mutano o sono loro stessi colpiti, se scompa-
re il clima favorevole, i letterati sono le vittime prede-
stinate dell’infortunio. Non contano più. Lo choc del
sacco porta senza dubbio Valeriano a drammatizzare
all’eccesso. La sua natura emotiva gli suggerì un po’ più
tardi un curioso opuscolo sulla responsabilità di coloro
Storia dell’arte Einaudi 158
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
che rifiutano ai preti il diritto di portare la barba41. Ma
la disorganizzazione totale dell’ambiente romano lo
obbligò a osservare un fatto capitale: i letterati non
hanno alcun peso «effettivo» nella società e la loro con-
dizione è di totale dipendenza.
Questa condizione era dovuta prima di tutto all’e-
quilibrio instabile che si era di colpo stabilito fra i laici
e i chierici. A Roma era meno possibile che altrove
distinguere le funzioni dello Stato da quelle della Chie-
sa. Si è giustamente osservato42 il potere di attrazione
esercitato a questo riguardo da Roma e la confusione che
ne risultava. Per un Guicciardini che si vanta di avere
rifiutato la condizione sacerdotale, e la cui ostilità al pre-
dominio del clero sarà costante, quanti intellettuali e
specialmente umanisti, scelgono alla fine la carriera dove
il cardinalato può seguire l’episcopato, come Giovio,
Bembo e altri? Questo era successo nel 1521 a Casti-
glione: tanto come nunzio a Valladolid, quanto come let-
terato, egli intervenne nel 1528 a difendere l’onore di
Roma.
Nessuno poteva prevedere se il clima favorevole
sarebbe mai rinato. Si cominciava a capire l’immensa
perdita di prestigio che avrebbe colpito quegli scrittori
e letterati romani. Anch’essi, avevano potuto pensare
che, come la Curia, avrebbero beneficiato di una specie
di privilegio, d’immunità durante i torbidi politici, nella
misura stessa in cui potevano considerarsi indispensabi-
li al mondo. Questa idea era fondata su due elementi:
chierici o no, detenevano, con le humaniores litterae, il
tesoro della nuova cultura, quella di cui i principi abbi-
sognavano, soprattutto nei paesi del Nord, come gli
uomini d’arme, per accedere alla civiltà, ossia a costu-
mi meno feroci e più raffinati. D’altra parte, la forma-
zione morale completa inizia con la conoscenza del
mondo antico: la favola e la poesia che quella alimenta
sono gli strumenti pacifici del sapere. Nello stesso
Storia dell’arte Einaudi 159
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
tempo, l’accesso alla cultura supponeva anche il rinno-
vamento del gusto di cui l’arte romana moderna, ispirata
dai modelli antichi, si riteneva avesse dato l’esempio.
Roma, ora sede del papato, è stata un tempo il centro
di un grande impero. In ragione di questa duplice col-
locazione storica, essa è anche la scuola dell’universo, il
centro da cui irradia una pedagogia per l’uomo moder-
no, riconoscibile da una qualità particolare «umanistica»
e suscettibile di essere estesa a tutta l’aristocrazia euro-
pea. «Artibus emineat semper studiisque Minervae |
Italia et gentes doceat pulcherrima Roma», scriveva
Vida nella sua raccolta poetica del 152543.
Tale era allora il pensiero comune del gruppo roma-
no che si era formato sotto Leone X e che, dopo un
periodo di allarme e di demoralizzazione sotto Adriano
VI, godeva di nuovo favore presso Clemente VII. Si tro-
verebbe lo stesso atteggiamento complessivo in Pietro
Bembo, che era appena rientrato a Venezia nel 1525,
dopo avere pubblicato le Prose della volgar lingua, dedi-
cate a Clemente VII. E non si potrebbe imprestare una
opinione diversa a Castiglione, rispettato in tutta Euro-
pa come autore del Cortegiano, che propone a tutte le
corti il modello di cultura e di vita nobile italiana.
Già da lungo tempo la sicumera e la superiorità degli
intellettuali italiani, e specialmente dei romani, non
erano soltanto oggetto di ammirazione. La caduta del
prestigio della loro Città non poteva non liberare ani-
mosità latenti. Sotto questo aspetto il sacco fu una rive-
lazione. L’amor proprio italiano fu messo a dura prova
in due vivaci polemiche, condotte da Erasmo. Il maestro
incontestato dell’umanesimo settentrionale pare avesse
deciso da alcuni anni di non lasciar passare più niente
delle pretese dell’ambiente romano; non lo distolsero da
tale decisione i lacrimevoli avvenimenti del 1527.
Ci si poteva aspettare una polemica concernente il
coraggio militare degli italiani. «Questi barbari tratta-
Storia dell’arte Einaudi 160
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
no li italiani per poltroni e manigoldi», scrive un italia-
no il 6 agosto ’2744. Le deplorevoli avanzate e ritirate
dell’esercito della Lega, la debole resistenza dei cittadi-
ni di Roma agli imperiali, sembravano avere dimostra-
to che la virtù guerriera aveva disertato i figli della
Lupa.
Nelle sue Historie, Paolo Giovio scriverà più tardi,
dopo le battaglie perdute dall’inizio del secolo, «abbia-
mo cominciato a essere disprezzati dalle nazioni stranie-
re, che avevamo fin allora impaurite»45. Uno dei fuggia-
schi del sacco, collega e amico di Valeriano, Pietro Corsi,
aveva raccontato in De romanae urbis direptione gli orro-
ri del maggio 1527, per suscitare nell’opinione interna-
zionale simpatie per i miseri romani. A questo seguiro-
no il riaccostamento del papa e dell’imperatore, la ribel-
lione di Firenze, le ultime scaramucce della guerra. Un
amico di Pietro Corsi gli segnalò che nella sua famosa rac-
colta di Adagia, Erasmo aveva inserito nell’edizione del
1520, e riproposta nell’edizione del 1533, una formula
ingiuriosa per l’Italia46. Commentando l’adagio Myconii
calvi («dei calvi a Micene»), che indica qualcosa di estre-
mamente eccezionale, Erasmo aveva citato divertito que-
ste altre rarità: «uno scita colto, un italiano guerriero (Ita-
lum bellacem), un negoziante integro, un soldato pio, un
cartaginese leale». In risposta a queste parole insolenti,
Corsi redasse una vibrante protesta, una Defensio pro Ita-
lia, dove traspariva una fondamentale opposizione a Era-
smo, suscitata da innumerevoli allusioni e critiche. Il
tema, esiguo all’inizio, si allarga in due direzioni: 1) Era-
smo disprezza gli italiani; 2) ha torto. Il suo scherno
mira evidentemente all’Italia odierna, ed è un’indegnità
perché si potrebbe enumerare più di un atto di coraggio
e di competenza nelle guerre del nostro tempo. Tutto è
stato perduto a causa delle rivalità politiche, dell’inca-
pacità di unirsi. Niente altro. Questa constatazione con-
tinuerà a riapparire in tutta la storia italiana. Alcune
Storia dell’arte Einaudi 161
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
gesta di rilievo potevano certo essere evocate, come la
difesa di Frosinone contro gli imperiali nel marzo 152747,
e Corsi non mancò di farlo.
Possiamo domandarci se talune abitudini romane
recenti non aggiungessero una nota involontariamente
ironica a questa polemica senza sbocco. Da un quarto di
secolo le decorazioni di facciata a graffiti si erano diffu-
se nella città. Quando le truppe imperiali si sparsero in
Roma, poterono vedere, come l’avevano visto le folle di
pellegrini nel 1525, un numero già notevole di palazzi
che esibivano, in bianco e nero o in chiaroscuro, fasce
istoriate che illustravano talvolta allegorie o più spesso
scene eroiche: Orazio Coclite e Muzio Scevola che sal-
vano Roma con il loro coraggio, Perseo che impietrisce
i nemici. Al Palazzo Milesi, poche settimane prima del
sacco, Polidoro e Maturino avevano dipinto, sulla fac-
ciata, gruppi trionfanti e figure potenti, come quella di
Ercole48.
Questa commemorazione degli eroi e dei fatti roma-
ni, già ampiamente praticata fin dal tempo di Nicola V
e di Sisto IV, sembra avesse preso maggiormente piede
nel periodo di crisi che metteva in causa la Chiesa come
Stato. Dobbiamo dare un valore «apotropaico» a que-
ste raffigurazioni? Esse apparivano come la conseguen-
za naturale della familiarità che esisteva a Roma con le
particolarità dell’arte antica, dove abbondavano, soprat-
tutto nella scultura, i trionfi e le immagini guerresche.
Si pensava quindi di dare un colore antico alle dimore
romane con queste decorazioni di facciata, che d’al-
tronde corrispondevano a una moda generale dell’Occi-
dente. Nel momento del disastro, i simboli dell’eroismo
erano visibili ovunque in Roma, ma, salvo nelle prime
ore del 6 maggio nel Borgo, essi non furono che i testi-
moni derisori di una sconfitta.
In tal modo appariva evidente agli occhi di tutti quale
abisso ci fosse fra la storia antica e la debolezza del Pre-
Storia dell’arte Einaudi 162
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
sente, l’inutile retorica di un’arte celebrativa che altro
non era se non una decorazione impotente. Questo con-
trasto convalidava il rifiuto di Guicciardini, di ricono-
scere la minima coincidenza fra la storia antica e il pre-
sente. Ma la tradizione profondamente radicata dell’ar-
te monumentale ebbe la meglio. Ecco un caso in cui la
nostalgia di un passato concluso e la negazione di un pre-
sente miserabile crearono le condizioni per una retorica
figurativa. Dopo la metà del secolo, l’Italus bellax riap-
parve. A Palazzo Spada le nicchie non sono più finte; le
abitano vere statue; i bassorilievi in chiaroscuro sono
sostituiti da iscrizioni49. Si tratta di una specie di esor-
tazione. Ma capitava anche che alcune facciate fossero
decorate con scene in stucco illustranti il prestigio della
Santa Sede romana50.
L’intervento di Erasmo.
Il primato politico e religioso era stato rimesso in
causa. Ma il primato culturale, altrettanto incontestabi-
le agli occhi dei romani quanto gli altri due, non lo era
stato anch’esso? Il terribile verdetto di Alfonso de
Valdés, che poteva passare per l’espressione ufficiale
del pensiero imperialista, sottolineava l’impotenza e la
corruzione di Roma e ne rendeva responsabile la «paga-
nizzazione», trasformandola nell’accusa centrale. Su
questo tema si sarebbe d’un tratto concentrato lo sfor-
zo per svalutare la cultura romana. Il colpo finale fu
inferto da uno dei dialoghi più brillanti e feroci di Era-
smo, il Dialogus Ciceronianus. Redatto proprio nel 1527
e pubblicato nel marzo 1528, lanciava un attacco in
piena regola contro l’umanesimo romano.
Erasmo era da parecchi anni irritato dalle critiche
che, a Roma, ponevano in dubbio la sua buona fede nelle
discussioni con i luterani51. A dire il vero, la posizione
Storia dell’arte Einaudi 163
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
dell’umanista era estremamente ambigua. Tutti a Roma
sapevano come si utilizzassero negli ambienti prote-
stanti i suoi libelli e le sue reprimende. Anche in questo
caso la stampa aveva parlato; un foglio popolare, il
«mulino di Dio» («Die göttliche Mühle») aveva divul-
gato l’idea che la critica di Roma condotta da Erasmo
servisse direttamente l’aspirazione verso una nuova
devozione, più vicina al Cristo52. Inoltre i testi sulla vita
religiosa di Lutero apparivano spesso in Italia sotto il
nome di Erasmo53.
Erasmo aveva sempre detestato la Roma pontificia.
Il militarismo di Giulio II l’aveva spaventato: l’esteti-
smo raffinato di Leone X non lo affascinava. Le sue rea-
zioni al momento del sacco non hanno niente di para-
gonabile alle esclamazioni di dolore e di scandalo dei
confratelli romani, come ha osservato Augustin Renau-
det54. Era difficile per i filosofi cristiani considerare tale
avvenimento null’altro che la salutare umiliazione del
papa. Perfino vicino all’imperatore, ci si rattristava, ci
si velava il volto per la vergogna. La reazione di Erasmo
è stata molto più complessa.
Parecchi tra i suoi amici aspettavano, data la sua auto-
rità morale, una pubblica condanna non dell’atto di guer-
ra, ma del sacrilegio. Tuttavia gli erasmiani erano divi-
si. Vives, il 13 giugno 1527, prese l’iniziativa. A suo avvi-
so, la vittoria dell’imperatore e la prigionia del papa
davano una nuova occasione alla cristianità di rinnovar-
si55 e avrebbero ridotto la superbia dei monaci, che odia-
vano l’autore di quei «Colloqui» tanto irritanti. Uno dei
prelati romani legati a Erasmo, Jacopo Sadoleto, che nel
1526 aveva assunto il seggio episcopale di Carpentras,
inviò al suo maestro una lettera rivelatrice: «Ritengo
che la deplorazione delle sciagure di Roma non possa
essere fatta degnamente da nessun altro all’infuori di
voi». E il prelato umanista, che non aveva provato imba-
razzo nel criticare, da buon erasmiano, i costumi e il com-
Storia dell’arte Einaudi 164
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
portamento della Curia, aggiungeva un commento elo-
quente, e quasi minaccioso: «È incredibile, tutta la tra-
gedia e il danno che la rovina di questa città arreca al
genere umano. Nonostante i suoi vizi, è la virtù a occu-
parvi il più gran posto. Un asilo di umanità, di ospitalità,
di saggezza e quello che Roma è sempre stata: se taluni
si sono rallegrati, a quanto voi mi scrivete, di quel sacco,
non sono uomini ma bestie orribili...»56.
Questa deploratio di stile elevato, Erasmo non la
scrisse. Egli non ha provato nulla di paragonabile all’in-
dignazione di Castiglione di fronte alla gioia degli impe-
rialisti e degli avversari della Curia. Il suo contributo fu
il Ciceronianus57, che pertanto va considerata come la sua
risposta all’avvenimento. Se scrisse a Clemente nell’a-
prile 1528, fu per denunciare vivacemente le critiche di
Aleandro e di Alberto Pio da Carpi, e chiedere che il
papa vi ponesse fine58. La lettera ritornava sul dramma
del maggio 1527 soltanto in termini convenzionali:
«Non sviluppando, per essere breve, la deplorazione
della sciagura di Roma, che non poté non essere crude-
lissima per qualsiasi uomo dotato di pietà...» Quando
rispose a Sadoleto, nell’ottobre 1528, Erasmo scrisse
solo luoghi comuni e dichiarò in tutta semplicità: «In
quel momento tumultuoso eravamo pieni di timore per
Bembo e per voi; e soprattutto e forse quasi unicamen-
te in voi che mi sembra sopravviva nella sua integrità
l’antica purezza e la dotta pietà». Soltanto due giusti in
tutto il Vaticano! Gli altri non contavano.
Erasmo non voleva tornare sulla critica distruttrice
dell’«intelligencija» romana da lui pubblicata nel 1528.
L’autore del Ciceronianus dichiarò con freddezza: «Il
mio Ciceronianus ha ferito numerosi Italiani; come pen-
savo veramente accadesse»59.
Sarebbe stato sorprendente il contrario, perché l’o-
pera è una satira dei vizi letterari dell’ambiente roma-
no, abilmente presentati come la copertura di qualcosa
Storia dell’arte Einaudi 165
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
di più grave. I romani si erano mostrati ridicoli nell’in-
coronare un francese per il suo stile anticheggiante e per
la sua eloquenza alla maniera di Cicerone. La retorica
ufficiale di quelli che furono chiamati per semplificare
«ciceroniani», si compiaceva degli effetti di stile ricer-
cati. Giunse a un punto in cui l’affettazione dell’antico,
con il suo perpetuo travestimento del linguaggio, cor-
ruppe il latino e, oltre il latino, il pensiero stesso. Era-
smo riprende qui un vecchio tema di discussione tra gli
umanisti: quali erano i pericoli o i meriti di una stretta
imitazione dei modelli? Ne avevano dibattuto quindici
anni prima Bembo e Giovanni Pico. Ma Erasmo svi-
luppò la discussione fino a rimettere in causa tutto il
sistema: prima di tutto, qualsiasi cosa si affermi, esso
non detiene il monopolio del purismo e della qualità let-
teraria; in secondo luogo, i «ciceroniani» vivono in un
sogno pagano che suscita soltanto orrore in un cristiano
degno di questo nome. Il primo argomento risponde a
una irritazione personale, provocata da tante critiche
noiose e pretenziose sul suo stile; il secondo vuole anda-
re a fondo della cosa, e mettere a nudo un fatto grave,
l’accusa principale che ora non si esita più a formulare,
e che era già stata enunciata due anni prima: le buone
lettere... devono «far risonare il nome del Cristo; con
gli Italiani, voi non lo ignorate, queste fanno soltanto
risuonare il paganesimo»: «Quam apud Italos hactenus
nihil aliud quam paganesimum crepent ipse non igno-
ras»60. La diatriba di Erasmo vuole, come indica il tito-
lo, rivolgere agli umanisti romani la rimostranza che san
Girolamo aveva rivolto a se stesso nell’Epistola a Eusta-
chio: il Cristo, apparso in sogno, gli avrebbe detto: «non
christianus es sed ciceronianus» per invitarlo a liberar-
si degli inutili legami con la letteratura e le bellurie dello
stile61. Ma la polemica si spingeva ancora più lontano.
Durante quegli anni 1527-30, la comunità intellet-
tuale appariva intorpidita. Il futuro dell’Italia pesava
Storia dell’arte Einaudi 166
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
greve su di lei, come un gran silenzio inquieto, turbato
solo dai lamenti degli intellettuali rovinati, dai pianti dei
poeti. Proprio allora Erasmo ebbe l’idea crudele e genia-
le di produrre il suo pamphlet sferzante contro il neo-
paganesimo della Roma medicea62. La mascherata per-
manente di questi «ciceroniani» con il loro linguaggio
pomposo preso a prestito dagli antichi autori, apparve
assurda. Credere, o fingere di credere, che si viva come
gli antichi romani, parlare di Giove e dei consoli, è
mania ridicola. Perché «Roma non esiste più, non è
altro che rovine e macerie, tracce e vestigia della sua
antica sventura». La Roma attuale, quella della Curia,
non ha nulla in comune con il mondo antico. Che tipo
di persone sono «queste che ancora sognano della Roma
signora del mondo con i suoi cittadini in toga?» Questi
sciagurati ignorano che la faccia del mondo è mutata e
che un cittadino di Roma conta meno in Europa di un
bottegaio di Basilea63. E soprattutto ignorano che que-
sta sedicente scuola del mondo non è più che un cena-
colo di gente «con più lettere che religione».
Erasmo si sente costretto ad analizzare lo stile stes-
so del Rinascimento romano. Gli pare che nel mondo
cristiano non ci si renda conto a sufficienza delle aber-
razioni di questa gente. Per esempio, il discorso «cice-
roniano» pronunciato da Fedra Inghirami il giovedì
santo del 1509 davanti a Giulio II, con le sue formule
pagane malamente adattate, le sue allusioni a eroi quali
Decio, Curzio e al sacrificio di Ifigenia, il suo sforzo di
fondere in un unico stile romano il cerimoniale antico e
la commemorazione cristiana64, finisce con l’essere una
mostruosità, una follia vergognosa. Né i pontefici suoi
successori hanno tentato in alcun modo di cambiare le
cose. Il male è inerente alla vita, alla cultura, alla reli-
gione di Roma. Questa Roma dei moderni è invasa da
immagini pagane. Qui il discorso di Erasmo si fa più
duro:
Storia dell’arte Einaudi 167
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Nei quadri, i nostri sguardi sono più spesso attratti da
Giove che scivola dal tetto tra le braccia di Danae, che da
Gabriele annunziante alla Santa Vergine la concezione divi-
na; il ratto di Ganimede ci seduce più dell’ascensione del
Cristo; i nostri occhi si attardano con maggior diletto sulla
rappresentazione dei Baccanali o delle feste del dio Termi-
ne, piene di turpitudini e di oscenità, piuttosto che su quel-
la della resurrezione di Lazzaro o del Battesimo del Cristo
per opera di Giovanni.
La pittura mitologica è sconveniente e pericolosa; la
moda romana è sospetta. Fin allora, ci si era acconten-
tati di sorridere. Nel 1528, Erasmo non è più disposto
ad accordare all’arte troppe libertà in un clima spiritua-
le così corrotto.
L’adattamento dei modelli antichi all’arte religiosa
non è desiderabile. Ganimede non deve fornire il pro-
filo dell’angelo Gabriele65. Bisognerebbe denunciare
come pratica immorale il travestimento mitologico dei
fatti umani, e peggio ancora, la mescolanza indecente,
ma così frequente a Roma, della favola pagana con la
verità cristiana. Ovidio occupa un posto eccessivo nella
poesia moderna. Ancora una volta, Erasmo condanna
quello che fu il rinnovamento della poesia cristiana. la
poesia di Pontano e di Sannazaro, uno dei grandi
momenti dei pontificati di Leone X e di Clemente. Nel
1526 era stato edito il De partu Virginis di Sannazaro66.
Per l’ambiente romano quel capolavoro rappresentava il
ritorno alla grande poesia cristiana. Il movimento si era
iniziato sotto Leone X, con artisti minori come Vida e
Giano Vitale. Nessuno aveva dimenticato le dichiara-
zioni di Leone X. In un breve del 21 agosto 1521, aveva
messo bene in evidenza che questo movimento lettera-
rio era destinato a controbilanciare gli attacchi di quan-
ti «per sembrare più dotti attaccano la Chiese con penna
malevole», evidente allusione a Lutero e ai suoi. Il papa
Storia dell’arte Einaudi 168
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
concludeva con la speranza di trovare «fra le minacce di
Golia e le armi di Saul in delirio, il soccorso di Davide
capace di respingere l’impudenza del primo con la sua
fionda, e la follia del secondo con la lira»67.
Questo programma espresso in termini biblici abil-
mente scelti, poteva adattarsi a qualsiasi celebrazione
della dottrina cristiana nel contesto di una politica
moderna. È, in fondo, il pensiero delle «Stanze», ivi
compresa quella di Costantino. Leone X indubbiamen-
te sottovalutava la situazione se contava sull’arma della
poesia per combattere i libelli antiromani. Per Erasmo
sono condannabili e lo stile di queste opere e la stessa
intenzione dotta. Non si deve trattare un argomento cri-
stiano in stile profano, zeppo di immagini e di formule
pagane68. «A che serve invocare così spesso le Muse e
Febo?» Il portavoce di Erasmo nel Ciceronianus prefe-
risce l’inno di Prudenzio al poema di Sannazaro, «del
tutto incapace di abbattere il Golia che minaccia la
Chiesa con la fionda e di domare la follia di Saul»69.
Secondo Erasmo c’è incompatibilità fra quel tipo di let-
teratura e l’ispirazione evangelica. Dimentica che egli
stesso è nutrito di immagini e di formule classiche, che
deve la propria eloquenza agli autori pagani; non tiene
conto di Dante e dei bisogni poetici del tempo. Diven-
ta deliberatamente reazionario.
Per la prima volta si giunge a una rottura fra l’uma-
nesimo cristiano e la cultura moderna. L’ostilità di Era-
smo ha trovato nella situazione del 1527 un’occasione
di manifestarsi più apertamente di quanto fosse acca-
duto prima. Il Ciceronianus mirava a dissipare una vec-
chia illusione, una menzogna. Il mondo degli intellettuali
romani, che si credeva alla testa della cultura universa-
le, non era cristiano se non di nome; lo spirito che lo ani-
mava era decisamente impuro e perfino empio. Mai Era-
smo si era spinto così lontano n’è aveva conglobato
tante attività letterarie e artistiche in una unica ripro-
Storia dell’arte Einaudi 169
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
vazione senza sfumature. È giunto il tempo di respingere
e, se possibile, di porre un termine a un’intossicazione
talmente profonda di favole pagane e di colore antico
che tutto quanto proviene da quell’ambiente romano
«sprizza paganesimo». Già da tempo Erasmo ironizza-
va sulla superbia degli italiani che «si vantano di essere
i soli a essere usciti dalla barbarie», ed esasperano il
resto d’Europa con la loro pretesa a una naturale supe-
riorità70.
Erasmo non era disposto a tollerare alcun rimprove-
ro da parte di questi retori, soprattutto quando venne
a sapere da uno dei suoi corrispondenti spagnoli, Pedro
Juan Olivar, che Castiglione, Navagero e Andrea da
Napoli, tutti e tre ambasciatori in Spagna, si erano per-
messi di burlarsi di lui, con sarcasmo e pubblicamente.
A queste ferite di amor proprio si aggiungeva l’irrita-
zione di vedere contestata la sua posizione religiosa
dagli pseudoteologi di Roma. Il Ciceronianus si dispo-
neva a squalificare una buona volta tutto quell’am-
biente. Era l’offensiva finale. In settembre, scrivendo
a Vergara, Erasmo non poteva che denunziare quel
male irrimediabile: «Paganesimus est, mi crede»71. Che
cos’è in fin dei conti, questo paganesimo nefasto? La
polemica di Erasmo non punta, come tante altre, sulla
scarsa spiritualità e la rilassatezza dei costumi della
Curia; e neppure punta sul commercio delle cose sacre
e sulle superstizioni, di cui Erasmo ha trattato altrove.
E nemmeno punta sulle ingenue affettazioni dello stile
ciceroniano. Si occupa invece del culto dell’antichità;
della nostalgia per un ordine non cristiano che traspa-
re sotto l’amore incondizionato dell’antichità e sotto
l’attrattiva che esercitano le sue vestigia. Erasmo invei-
sce contro la passione intellettuale per la storia, l’arte,
il pensiero del mondo antico, che la coscienza cristiana
non può controllare. L’archeologia, l’accumularsi delle
sculture nei palazzi, la riesumazione dei modelli roma-
Storia dell’arte Einaudi 170
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
ni, non sono più manie anodine e ausiliari legittimi del
sapere, se portano un sentimento di superiorità inam-
missibile, di attaccamento totale e di sensibilità forma-
le; pertanto sono pericolosi72.
Se non c’inganniamo, il Ciceronianus rivela il ripie-
garsi del pensiero di Erasmo verso un nuovo rigorismo,
una più rigida concezione della cultura. Ma, fatto più
importante, è la prima volta, nella storia del Rinasci-
mento, che una critica profonda del «culto dell’antico»
non proviene da un uomo di convento limitato o da un
teologo diffidente, ma da un umanista, formatosi alle
discipline classiche, l’autore degli Adagia. Era un vero
avvenimento; lo si può spiegare con il sommovimento
generale di quegli anni difficili, con la pressione del-
l’evangelismo dei Riformati, con la logica stessa delle
posizioni erasmiane. Il trattato ci costringe a ricono-
scere l’ampiezza della «paganizzazione» che si poteva
osservare non soltanto, ovviamente, nell’eloquenza,
ma in tutta la cultura e la vita romana. Il che apre una
questione di interesse innegabile e più importante di
quanto non si abbia l’abitudine di ammettere per l’in-
terpretazione dello sviluppo artistico della Roma medi-
cea. Si vede chiaramente quanto sia grande l’indiffe-
renza di Erasmo e dei suoi amici verso l’aspetto pro-
priamente artistico del Rinascimento. Il problema del
rapporto di Erasmo con le arti73 è forse un falso pro-
blema.
La passione italiana per le forme gli sfugge e lo scan-
dalizza. L’arte appartiene all’esteriorità e manca del-
l’essenziale; la formula di Bulephoros è precisa: «quae
sunt hominis praecipua, pictori sunt inimitabilia»74. Era-
smo era così consapevole che l’atteggiamento romano
nei confronti dell’arte non era un concetto isolato, ma
formava un tutto, che introdusse una digressione criti-
ca contro la pittura, prendendosela con quel che può
sembrare moralmente inoffensivo: l’arte del ritratto. La
Storia dell’arte Einaudi 171
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
pittura non raggiunge che un aspetto dell’uomo e pre-
cisamente quello che è inferiore. L’attenzione di un pit-
tore al particolare è ridicola. «Se avesse saputo espri-
mere la forma veramente profonda dell’uomo, non si
sarebbe rifugiato in questi parerga»75.
Il Ciceronianus ha solo aggravato la rottura. Non ci
fu discussione di fondo del problema. Già esposto ai
sospetti dei colleghi italiani, Erasmo fu metodicamente
confutato, punto per punto, da Alberto Pio da Carpi.
Questo principe letterato76 aveva già risposto nel mag-
gio 1526 all’accusa di «paganizzazione». Trovandosi a
Roma nel maggio 1527, era riuscito a fuggire in Fran-
cia e a Parigi preparò durante l’inverno 1528 la Respon-
sio accurata et paraenatica, che Erasmo avrebbe pur volu-
to un po’ più mitigata. Era troppo tardi. L’Apologia di
Erasmo non impedì la pubblicazione a Parigi nel 1531,
poco dopo la morte del principe, di un enorme trattato
in ventun libri, In locos lucubrationum variarum D. Era-
smi Roterodami, che conteneva molte cose imbarazzan-
ti per l’accusato e osservazioni importanti su culti, riti,
procedure della religione romana. Anche così l’animo-
sità e il sospetto restavano elevati. I conventuali, più
limitati, semplificavano decisamente le cose; il france-
scano Luìs de Carvajal giunse perfino a rendere Erasmo
responsabile del sacco77.
Adriano VI.
Una delle ragioni per cui gli erasmiani giudicavano
così severamente l’ambiente romano e lo stimavano inca-
pace di dirigere la Chiesa, può essere stato semplice-
mente il fallimento del pontificato di Adriano VI. Il suo
regno, per quanto breve, era stato eccezionale in tutti i
sensi. Era stato eletto inaspettatamente, nel disperato
tentativo di sbloccare un conclave giunto a un punto
Storia dell’arte Einaudi 172
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
morto. Benché fosse stato precettore dell’imperatore, si
rivelò fin dall’inizio poco incline a piegarsi alle esigen-
ze della politica imperiale, sentendosi innalzato a una
carica suprema che sta al di sopra dell’arrendevolezza.
Sbarcando a Genova il 17 agosto 1522, dopo il sacco
della città da parte degli imperiali, Adriano VI rifiutò
di concedere il perdono ai responsabili con il celebre:
«non posso, non devo, non voglio»78. A Roma la pom-
posità dei cardinali lo urta; la richiesta di aumento di
rendite da parte dei membri della Curia lo scandalizza:
«me gusta la pobreza». Il pontefice assume una posi-
zione contraria a tutte le pratiche romane; dà l’esempio
di un sacerdozio umile e pio, che non sembra risponde-
re alla dignità della sua posizione. Egli rappresenta una
critica di fatto agli usi e al cerimoniale romani, l’at-
tuarsi improvviso di quella riforma della Curia di cui si
parlava da decenni.
Il risultato di questo ammirevole e pio tentativo fu
catastrofico. Gli umanisti del Nord e, in primo luogo,
Erasmo, che conosceva il prelato batavo da più di
trent’anni, erano fiduciosi. Nel settembre 1522, Cam-
peggi scriveva a Wolsey che Adriano «con il suo lin-
guaggio e i suoi modi», sarebbe stato un papa eccellen-
te. Adriano però, nei due grandi eventi del momento,
non riuscì ad assicurarsi la collaborazione necessaria.
Erasmo rifiutò di impegnarsi e non offrì il proprio aiuto
a Roma per risolvere la questione di Lutero. L’avanza-
ta dell’Impero Ottomano si accentuava con la caduta di
Rodi; Carlo V promise di agire «au plus tôt que faire se
pourra», ma senza fare una sola mossa.
Il lato più disastroso e, dal nostro punto di vista, il
più significativo, fu l’impopolarità immediata e irrime-
diabile del papa «barbaro» presso i romani. La critica
sgarbata dei suoi atti più semplici assunse fin dall’inizio
proporzioni incredibili. In una lettera del luglio 1522,
fatta passare come di Pasquino, l’Aretino, rifugiato con
Storia dell’arte Einaudi 173
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
il cardinale Medici a Firenze, arriva a mettere in cari-
catura le processioni di reliquie guidate dal nuovo Papa,
in termini buffoneschi e irrispettosi degni di un Rabe-
lais79. Non si perdonava ad Adriano la mancanza di
decoro, l’indifferenza alle tradizioni locali e alla gran-
dezza capitolina. Non basta essere un prete onesto e pio
per comportarsi da sovrano degli Stati della Chiesa. Mai
la contraddizione fra i due aspetti del pontificato era
apparsa così chiara. «Non attribuì il minimo pregio alle
grandi pitture e alle statue antiche; Vianese, legato a
Bologna faceva un giorno l’elogio del Laocoonte che
Giulio II aveva comprato a gran prezzo e fatto colloca-
re nel giardino del Belvedere per abbellire il luogo.
Adriano volse subito lo sguardo e si mise a imprecare
contro quelle statue di un popolo empio»80. Queste
manifestazioni sistematiche di ostilità contro l’arte degli
antichi si estesero, tra lo scandalo generale, ai capolavori
moderni, e prima di tutto al soffitto della Sistina. Vasa-
ri lo ha riferito accuratamente.
... nel pontificato del quale [Adriano VI] furono talmente
tutte l’arti e tutte le virtù battute, che se il governo della
Sede apostolica fusse lungamente durato nelle sue mani,
interveniva a Roma nel suo pontificato quello che inter-
venne altra volta, quando tutte le statue avanzate alle rovi-
ne de’ Gotti (così le buone come le ree) furono condanna-
te al fuoco. E già aveva cominciato Adriano... a ragionare
di volere gettare per terra la cappella del divino Michela-
gnolo, dicendo ch’ella era una stufa d’ignudi; e sprezzando
tutte le buone pitture e le statue, le chiamava lascivie del
mondo e cose obbrobriose ed abominevoli81.
Questo atteggiamento non dipendeva da un gusto
personale, ma da una convinzione. Adriano intendeva
riformare tanto la vita romana quanto le pratiche della
Curia. Non si poteva restaurare la dignità della Chiesa
Storia dell’arte Einaudi 174
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
senza sacrificare le piacevolezze di qualsiasi genere che
Adriano, anticipando di cinque anni il Ciceronianus,
denunziava come l’infezione del paganesimo. Le sue
frasi sprezzanti nei confronti dei capolavori non sono
soltanto sentite come un insulto ai suoi predecessori e
agli artisti, ma come un’offesa alla «romanità», all’«ita-
lianità» della Chiesa.
Nella storiografia italiana, il pontificato di Adriano
VI apparve come l’intrusione violenta dell’incultura e
dell’errore nel mondo romano. Naturalmente non furo-
no recepite le mirabili intenzioni di un sant’uomo, che
desiderava sinceramente una riforma; ma unicamente il
comportamento di un «barbaro». Berni, che apparte-
neva alla cerchia dei Bibiena e scriveva «capitoli satiri-
ci», tipici dello humour italiano, riversò contro Adria-
no ingiurie di grossolanità folle:
O furfante, ubbriaco, contadino
Nato alla stufa, or ecco chi presume
Signoreggiar il bel nome latino82.
Vasari usò sistematicamente la «controleggenda» di
Adriano per esaltare il mecenatismo glorioso del secon-
do papa mediceo, che, con sollievo di tutti, gli successe:
Fu l’anno 1523 creato papa Clemente VII che fu gran-
dissimo refrigerio all’arte della pittura e della scultura...83.
In un epigramma dal finale minaccioso: «Heu, heu,
quam tibi, Christe, jam cavendum est», un poeta espri-
meva il proprio disappunto per il Pontificato di Adria-
no VI e i timori ispirati dalla conquista turca di Rodi nel
152284. Roma è il Cristo; e lui che viene oltraggiato non
proteggendo la sua città. Secondo la critica evangelisti-
ca – e riformata – bisogna, per ritrovare il Cristo, spo-
gliare quel che Roma rappresenta. Usando le stesse paro-
Storia dell’arte Einaudi 175
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
le, gli italiani e i loro avversari non parlavano però della
medesima cosa.
La tomba di Adriano non poteva essere collocata che
nella chiesa dei settentrionali di lingua tedesca, Santa
Maria dell’Anima. Il cardinale Enckenvoirt chiese al
Peruzzi di disegnarla. Peruzzi, a detta del Vasari, affidò
l’esecuzione a un certo Michelangelo da Siena, e ne
sarebbe l’opera migliore, tanto per le combinazioni dei
marmi colorati, quanto per la qualità delle statue85. Le
quattro virtù cardinali circondano la figura giacente; al
di sotto di questa, unico elemento storico della tomba,
è un bassorilievo dove si vede «il suo ingresso in Roma
con la folla romana che gli muove incontro per vene-
rarlo». Non sapendo come illustrare il regno così breve
del pontefice olandese, Peruzzi ricorse al tema sempre
valido dell’adventus, tema che era stato trattato nella
Stanza di Costantino; ma come presentare lo scenario
romano, senza profilare, dietro la folla dei fedeli un
colosseo e una piramide di Sestio? Furono così colloca-
te davanti ad Adriano quelle antiche rovine di cui non
aveva mai smesso di pensare che facevano troppa con-
correnza all’eredità cristiana.
Archeologia e paganizzazione.
Erasmo era disposto a tenere conto del fascino di
Roma, soggiorno ideale dell’umanesimo e paradiso dei
dotti; ma la sua concezione erudita era esclusivamente
letteraria, libresca. Come non lo interessavano le opere
d’arte, così non lo interessavano l’archeologia e gli scavi;
niente era più lontano dalla sua mentalità. Invece pro-
prio l’archeologia era entrata da quindici anni in una
fase nuova e notevole, sotto l’impulso di Raffaello e dei
suoi amici. Certamente, si poteva dire che questa nuova
moda artistica era ispirata dalla nostalgia della Roma
Storia dell’arte Einaudi 176
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
repubblicana e imperiale. I pezzi più svariati, i fram-
menti, le tabulae si accumulavano nei cortili dei prelati:
questa mania irresistibile, che tutta Europa ammirava e
imitava, può essere vista come il supporto del «ritorno
al paganesimo».
Se comprendiamo bene Vasari, è allora, sotto Cle-
mente, che fu inventato da Lorenzetto un modo di pre-
sentare pezzi antichi destinato ad avere un immenso
successo. Proprio nel giardino del cardinale Della Valle
lo scultore avrebbe avuto l’idea di raggruppare i fram-
menti e completare i pezzi. Rimettendo insieme colon-
ne e capitelli, li forniva di uno zoccolo costituito da ele-
menti coperti di rilievi; al di sopra componeva un fre-
gio di frammenti a forma di nicchia e coronava il tutto
con statue «le quali sebbene non erano intere per esse-
re quali senza testa, quali senza braccia ed alcune senza
gambe, ed insomma ciascuna con qualche cosa in meno,
l’accomodò nondimeno benissimo avendo fatto rifare a
buoni scultori tutto quello che mancava: la quale cosa fu
cagione che altri signori hanno poi fatto il medesimo, e
restaurato molte cose antiche, come il cardinale, come i
cardinali Cesi, Ferrara, Farnese, e per dirlo in una paro-
la tutta Roma. E nel vero hanno molto più grazia que-
ste anticaglie in questa maniera restaurate, che non
hanno que’ tronchi imperfetti, e le membra senza capo,
o in altro modo difettose e monche»86. Vasari colloca
dopo la sepoltura di Raffaello nel 1520 la comparsa di
questo «nuovo tipo di decorazione archeologica» che si
impose dovunque; cita due delle collezioni che furono
«visitate» nel 1527 dagli occupanti87. In quanto al «fre-
gio di scene antiche in semirilievo bellissime e rarissime»
che portò all’apice la gloria di Lorenzetto, si tratta pro-
babilmente di una mescolanza di elementi antichi e di
ricostituzioni. Appunto questa modernizzazione delle
antichità affascinava.
Storia dell’arte Einaudi 177
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
C’era di più. Era a Roma che le vaste collezioni dei
modelli antichi, disponibili e certe, venivano ora studia-
te con cura per decorare all’antica e quindi in stile paga-
no le dimore, tanto sulle facciate che all’interno. La reto-
rica «ciceroniana», con le sue formule imitate, i suoi dei
e i suoi templi, era nulla a confronto di quell’invasione
delle forme e dei tipi. Erasmo, che non era tornato a
Roma da vent’anni, ne era a conoscenza abbastanza per
protestare contro quei quadri indecenti che piacevano ai
prelati della Curia88. La nuova generazione gli avrebbe
fornito cento ragioni supplementari per indignarsi e per
denunziare come una licenza il comportamento degli
amatori d’arte. Alla fine ebbe luogo una spaccatura fra
due mondi spirituali: il senso della purezza evangelica
mancherà per sempre a quei retori, così come i monaci e
gli sciagurati che hanno soffocato la religione sotto i riti
non capiranno mai le superstizioni e le immagini. Erasmo
nutriva soltanto diffidenza per quei prelati troppo nume-
rosi, e non soltanto in Italia, che si mostravano talmen-
te attaccati alle lettere e alle arti della Rinascita.
Quando, nella Battaglia di Costantino, Giulio Roma-
no aveva voluto rappresentare i dintorni della città,
aveva introdotto nel paesaggio una villa «all’antica»; era
la villa innalzata a cominciare dal 1517 sul monte Mario,
ma non ancora ultimata, del cardinale Giulio de’ Medi-
ci, prima ricostruzione moderna di una villa suburbana.
In quell’edificio spazioso e incantevole, destinato a
dominare tutto un paesaggio di terrazze digradanti verso
il Tevere, c’era una decorazione di stucchi e di affreschi,
i cui motivi tratti da Ovidio erano stati approvati dal
futuro Clemente VII. Egli non faceva che seguire una
moda «ovidiana» di cui la «stufetta» di lusso era il più
piacevole, ma, per un chierico aggrondato, il più abo-
minevole esempio. La stanza da bagno neopagana di
Castel Sant’Angelo, di cui il pontefice ebbe ben soven-
te l’occasione di servirsi, avrebbe ispirato a Erasmo e ai
Storia dell’arte Einaudi 178
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
suoi amici, a maggiore ragione che non qualche sermo-
ne ampolloso, un’indignazione atta soltanto a dimo-
strare la loro ignoranza delle usanze d’Italia.
Queste innovazioni artistiche andavano di pari passo
con lo sviluppo del sapere sotto i papi medicei. Una delle
ultime preoccupazioni di Raffaello, morto nella prima-
vera del 1520, era stato di proteggere quanto rimaneva
delle rovine dell’antica Roma89. Questo non poteva con-
cepirsi senza rilevamenti archeologici, senza una pianta
della città antica. L’intellettualità della Roma rinasci-
mentale contava molto su queste iniziative. In un poema
in memoria del giovane artista. Castiglione aveva scrit-
to: «Tu quoque dum toto laniatam corpore Romani
componis»*.
Negli anni seguenti, sotto Clemente, questi progetti
avevano cominciato a prendere corpo. La passione
archeologica aveva saldato un gruppetto di eruditi. Nello
stesso 1527, alla fine dell’inverno, uscirono due libri ela-
borati da quegli umanisti archeologi. Uno, Antiquitates
di Andrea Fulvio, è una rarità bibliografica90. Attraver-
so descrizioni ed evocazioni abbastanza precise, e gra-
zie alle citazioni, il volume finisce per essere un elogio
sconfinato della Roma antica, la città più bella, più nobi-
le, più felice. L’autore conclude che Roma ha sempre
trionfato dei barbari.
L’altra pubblicazione è la notevole pianta archeolo-
gica di Fabio Calvo, Antiquae Urbis Romae cum regioni-
bus simulacrum, dedicata a Clemente. Si tratta di un’a-
nalisi sistematica dei «rioni» e della collocazione degli
antichi resti91. L’autore non può trattenersi dal deplorare
quel che il tempo e la malvagità umana hanno fatto
delle meraviglie del passato. Il povero Calvo, già vec-
chio, uomo di storica probità, dicono i contemporanei,
«fu portato fuori di Roma dalle bande mercenarie, per-
ché non aveva denaro sufficiente per pagare la taglia;
finì miserevolmente in un ospedale»92.
Storia dell’arte Einaudi 179
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
La prefazione di Fulvio è un documento notevole:
riferendosi al libro molto precedente di Flavio Biondo,
Italia illustrata, l’autore si pone nella tradizione dell’u-
manesimo romano; sottolineando il ruolo di Raffaello e
dei suoi rilevamenti delle rovine, precisa l’orientamen-
to propriamente archeologico del suo lavoro. E cele-
brando la grandezza passata e presente di Roma in una
forma ardente e appassionata, colloca la «Città Eterna»
al centro di ogni civiltà, attribuendole un valore ideale
e insieme concreto. Vediamo qui il culto di Roma svi-
luppato in mito di Roma. L’opera, ovviamente, era dedi-
cata a Clemente.
Il contenuto è un po’ deludente, dato che si tratta di
una compilazione piuttosto sommaria; ma c’è tuttavia un
progresso in confronto alle descrizioni e localizzazioni
di Biondo. Soprattutto, Andrea Fulvio mostra diligen-
temente come la città antica continui a vivere nella città
moderna. Nel 1525, componendo un poemetto in onore
del giubileo tradizionale, aveva redatto un esposto cro-
nologico dell’istituzione e non aveva esitato a risalire ai
ludi saeculares degli antichi romani. Nella sua raccolta
delle Antiquitates, fa dell’archeologia nascente la chiave
dell’interpretazione storica del fenomeno romano. Ma
queste affermazioni sulla grandezza del mondo pagano,
sulla continuità dei suoi usi e pratiche all’interno del
mondo cristiano, e l’esaltazione della Roma moderna che
era riuscita a conciliarli, erano proprio quelle che urta-
vano di più gli erasmiani. L’elogio di Fulvio mescola con
la massima naturalezza l’antico e il cristiano:
Retinet adhuc Roma quandam priscae maiestatis
umbram ut gentes ex toto orbe tamque membra ad caput
recuprant.
Nusquam tanta aedificiorum laxitas, tanta rerum pompa,
tot loca sacra, tam solida peccatorum venia et tot (ut plebis
vocabulis utar) indulgentiae, tot martyrum triumphi quorum
Storia dell’arte Einaudi 180
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
cruore aspersa, consecrata omnia habentur. Sub Christo
principe totus mundus patefactus est (fol. xvi).
Un po’ più avanti, si trova un lungo passo sulle vicis-
situdini di Roma, «de inclinatione et mutatione Impe-
rii et Urbis excidio», con il lungo elenco degli attentati
barbarici e la conclusione che voleva essere patetica:
«Roma ludibrio fuit barbaris. Sed ipsa demum victrix»
(fol. cii).
Più che l’eloquenza ciceroniana, è quest’ordine di
preoccupazioni che caratterizza la Roma di Clemente
VII e, più generalmente, la cultura che era maturata
sotto i due papi medicei. A quale punto Roma fosse col-
pita dalla sciagura del 1527, la lentezza della ripresa
basta a dimostrarlo. Il simulacrum fu ristampato nell’a-
prile 1532, ma senza suscitare l’entusiasmo che merita-
va. I lavori sulla topografia romana subirono un arresto
deciso. Si dovette aspettare la metà del secolo perché
uscissero nuove piante di Roma e avesse luogo la gran-
de restituzione della città antica per opera di Pirro Ligo-
rio nel 1552.
1
Cfr. cap. ii.
2
La fonte è un opuscolo tedesco, Auslegung Peter Creutzers... über
den erschröcklichen Cometen..., s.l.s.d.; combinato con un opuscolo
francese, La terrible et espouventable comete laquelle apparut le XI. Doc-
tobre Lan MCCCCC XX VII en Vuestrie region Dalemaigne..., s.l.s.d. (indi-
cazioni fornite da Anne-Marie Lecoq).
3
plinio, Nat. hist., I. xxii. warburg, Heidnisch-antike Weissagung
cit., p. 533, ha notato che Melantone si spaventò nel 1531 per l’appa-
rizione «in occasu solstitiali» di una cometa di questo tipo.
4
[«Piagnoni» erano chiamati i seguaci del Savonarola, che piange-
vano la condizione della Chiesa].
5
Cfr. r. ridolfi, Vita di Girolamo Savonarola, Roma 1952, vol. I,
pp. 73-75; d. weinstein, Savonarola and Florence. Prophecy and Patrio-
tism in the Renaissance, Princeton 1970, capp. iii-iv. Sulla medaglia di
Savonarola con la mano del Signore che brandisce la spada, cfr. g. f.
Storia dell’arte Einaudi 181
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
hill, A Corpus of Italian Medals of the Renaissance before Cellini, Lon-
don 1930, nota 1080.
6
Per esempio c. lycosthenes, Prodigiorum ac ostentorum chronicon,
Basel 1557, p. 273. In un manoscritto astrologico intitolato Des comet-
tes et de leurs signifiances..., redatto nel 1587 (Bibl. Warburg, Londra: cfr.
j. m. massing, A Sixteenth-Century Illustrated Treatise on Comets, in «Jour-
nal of the Warburg and Courtauld Institutes», [1977], pp. 33 sgg.) sono
menzionate le comete storiche: Scutella alla morte di Costantino, Veru
alla distruzione di Gerusalemme e al sacco di Roma del 1527.
7
m. pingré, Cométographie ou traité historique et théorique des comè-
tes, Paris 1783, vol. I, p. 485.
8
Sulla pseudo-profezia di Torquato, cfr. cap. ii.
9
Cfr. reeves, Influence ol Prophecy cit., cap. vi.
10
Se n’era già avuta una nel gennaio 1526, e vi sarà di peggio nel
1557 e nel 1598 Cfr. lanciani, The Destruction of Ancient Rome cit.,
p. 94. Vasari ricorda i guasti subiti da un’opera di Perino del Vaga, cfr.
j. shearman, An Episode in the History of Conservation: the Fragments
of Perino’s Altarpiece from S. Maria sopra Minerva, in Scritti di storia del-
l’arte in onore di Ugo Procacci, Milano 1977, vol. II, pp. 356 sgg.
11
[Unità di misura pari alla larghezza (7-8 cm) o alla lunghezza (14-
15 cm) della mano, tuttora usata per misurare i cavalli].
12
Neue Zeytung auss Rom, wie das grausam und erschröcklich gross
wasser der Tyber schaden than hat, s.l. 1530 (The Folger Shakespeare
Library, Washington).
13
L. Alamanni, nato a Firenze nel 1495, avversario dei Medici,
aveva fatto parte di un complotto contro il cardinale Giulio de’ Medi-
ci; condannato a morte, si era rifugiato a Venezia poi a Lione, e si pose
quindi al servizio di Francesco I. Alla notizia della cacciata dei Medi-
ci, rientrò in Italia, dove svolse un’intensa attività diplomatica. Nel
1530 dovette rifugiarsi di nuovo in Francia. L’edizione delle Opere
toscane, di cui il vol. I (Lione 1532, pp. 316–42) contiene Il Diluvio
Romano, è dedicata a Francesco I, presentato come la speranza dell’I-
talia. Cfr. Dizionario biografico degli Italiani, Roma 1960, vol. I. Non
abbiamo potuto trovare l’opuscolo di ludovico gomez, De prodigiosis
Tiberis inondationibus, Roma 1531.
14
egidio da viterbo, Scechina e Libellus de litteris hebraicis, a cura
di F. Secret, Roma 1959.
15
Testo completo in j. f. ossinger, Biblioteca Augustiniana, Ingol-
stadt 1768, s.v. «Casinius», pp. 191-93. Devo questo riferimento alla
cortesia di F. Secret.
16
Cfr. o’malley, Giles of Viterbo on Church and Reform cit.
17
Secondo un vecchio gioco di parole emblematico, i Medici diven-
tavano facilmente i medici inviati dal cielo, e la loro azione era medi-
cina Dei. Cfr. j. shearman, Raphael’s Tapestries, London 1976.
Storia dell’arte Einaudi 182
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
18
«Urbem Romam caput feceram: quae beneficii oblita nulli pec-
cando cedit: ego quoad licuit defendi: per multorum voces territavi: exci-
dium minata: mutare mores: resipiscere: ad sanitatem redire: hortata
sum. Quia minas facta secuta sunt: manum adduxi tuam cum Borbonio:
Urbem expugnavi diripui: caede sanguine incendiis complevi. Tot sup-
plicia: tot plagas tantum calamitatum invexi: ut quamquam ipsa facerem:
ipsa a tam crudeli spectaculo abborream Tantum miseriarum cumulum
miserata: iussi, ut scis, te Urbi parcere: clausos liberare: revocare exer-
citum: praesidia arcesque restituere: Italiam petere: hostibus pacem dare:
meis sacerdotibus tantum honorum tribuere: quantum nunquam fuerat
antea tributum. Reduco in Urbem expecto ob suscepta illinc vulnera:
hinc honores: utramque agnovisse manum dei laevam cum Borbonio dila-
cerantem, destram per te Bo(r)boniae complexantem: sublevantem: resti-
tuentem. Video actum nihil: medicinam non modo non sanasse: sed ad
maiorem peccandi licentiam: audendi petulantiam: habendi cupidita-
tem: famem rabiem irritasse: volui iterato commonefacere: feci impetum
prius ferro atque igne per Borbonium: nunc illuvie: aquisque per Tybe-
rum qui insolito incremento omnia complevit annonam rapuit: domos
evertit: atque adeo afflixit: ut plerique iudicaverunt barbaro externo Bor-
bonio Thuscum Tyberim fuisse crudeliorem: At nec sic quidem quicquam
profeci. Nunc certum est ultra non parcere: morbum medici manum refu-
gientem: immanium hostium falce resecare: antiqua evertere: nova
instaurare» (egidio da viterbo, Scechina cit., p. 105).
19
Ibid., p. 116.
* [«Ho fatto intervenire la tua mano col Borbone»].
20
g. casio de’ medici, Canzon’ove si narra la strage e il sacco di Roma,
diritiva al Catolico Re di Spagna e dei Romani…, [Roma 1529], 21 stro-
fe di 11 versi.
21
Al seguito di v. luciani, Francesco Guicciardini e la fortuna delle
opere sua, Firenze 1944; diez del corral, La monarquia hispanica cit.,
ha sottolineato quanto siamo debitori alla relazione e all’analisi dei fatti
date da Guicciardini.
22
Cfr. r. ridolfi, Vita di Francesco Guicciardini, Roma 1960.
23
vasari, Le vite cit., VI, p. 205: «[fece] a messer Francesco Guic-
ciardini che allora, essendo tornato da Bologna, si stava in villa a Mon-
tici scrivendo la sua storia, il ritratto di lui, che somigliò assai ragio-
nevolmente e piacque molto».
Fondo porpora; blasone dei Guicciardini sul seggiolone, su un libro
in mano allo storico si legge: «Io ho deliberato di scrivere le cose acca-
dute alla | memoria n[ostr]a in Italia». Yale Art Gallery (45 V4 x 33
318). Cfr. c. seymour, The Rabinowitz Collection of European Pain-
tings, New Haven 1961, pp. 30-31.
24
f. gilbert, Machiavelli and Guicciardini, Princeton 1965, cap.
VII, p. 271.
Storia dell’arte Einaudi 183
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
25
r. ramat, Il Guicciardini e la tragedia d’Italia, Firenze 1953; m.
santoro, Fortuna, Ragione e Prudenza nella civiltà letteraria del Cinque-
cento, Napoli 1967, pp. 290 sgg.
26
Ricordi autobiografici e di famiglia, in Opere inedite, a cura di G.
Canestrini, Firenze 1857, vol. X, p. 436.
27
f. guicciardini, Consolatoria, fatta di settembre 1527 a Finocchie-
to, tempore pestis cit., pp. 165 sgg.
28
m. guglielminetti, Memoria e scrittura. L’autobiografia da Dante
a Cellini, Torino 1977, pp. 286 sgg.
29
Cfr. le notevoli analisi di diez del corral, Maquiavelo y Guic-
ciardini, in La monarquia hispanica cit.
30
«Quanto s’ingannano coloro che a ogni parola allegano i Roma-
ni!» Ricordi cit., vol. X, p. 121 nota 110. Vedi anche santoro, Dei
successi del Sacco cit., p. 275 nota 2; d. cantimori, Francesco Guic-
ciardini, in Storia della letteratura italiana, IV: Il Cinquecento, Milano
1966, pp. 102 sgg.
31
gilbert, Machiavelli e Guicciardini cit., p. 288; r. ridolfi, Gene-
si della «Storia d’Italia» guicciardiniana, in «La Bibliofilia», 40 (1938),
pp. 369 sgg., ha potuto stabilire, dall’esame di una prima stesura, che
Guicciardini ha incominciato la sua opera da quello che è diventato il
libro XVI, che tratta della battaglia di Pavia, della formazione della
Lega di Cognac, e del sacco. Egli è andato diritto agli «anni terribili»
che lo esortarono a intraprendere l’opera.
32
Ricordi cit., vol. X, p. 130 nota 161.
33
e. pontieri, Gli ultimi ambiti della indipendenza italiana, in Nei
tempi grigi della storia d’Italia, Napoli 1949, con le note limitative di
cantimori, Italy and the Papacy cit., p. 274.
34
Dopo le considerazioni di f. chabod, Y a-t-il un État de la Renais-
sance?, in «Actes du Colloque sur la Renaissance», Paris 1958, pp.
57–74, seguiamo lo studio di hook, The Destruction ol the New Itatia
cit., pp. 25 sgg.
35
«Io confesso essere proprio ufficio del papa la cura spirituale; e
dico di più, che molto maggiore e più potente farebbe uno pontefice
la autorità spirituale che tutta la temporale che lui potessi avere; e che
il dimettere le cose temporali lo farebbe più grande, più reverendo nel
cospetto di tutta la cristianità. Ma poiché il mondo è pieno di malignità,
chi dubita che se uno pontefice non aiutasse le cose sue con ogni spe-
cie di armi o di potenza, che sarebbe annichilato non manco nello spi-
rituale che nel temporale» (Discorsi politici, I, p. 389, citato da gre-
gorovius, Storia della città di Roma cit.).
36
Ioannis Pierii Valeriani Bellunensis de litteratorum infelicitate libri
duo. Ejusdem Bellunensia. Nunc primum e Bibliotheca Lolliniana in lucem
edita, Venezia 1620, 1. 1, p. 7 (Laurentius Grana): «... sed, bone
Deus, cum primum coepi Philosophos, Oratores, Poetas, Graecarum
Storia dell’arte Einaudi 184
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Latinarumque litterarum professores, quos in Commentario conscrip-
tos habebam, perquirere, quanta, quamque crudelis tragoedia mihi
oblata est, qui litteratos viros, quos me visurum sperabam, tanto nume-
ro comperiebam miserabiliter occubuisse, atrocissimaque fati acerbitate
sublatos, indignissimisque affectos infortuniis, alios peste intereceptos,
alios in exilio, et inopia oppressos, hos ferro trucidatos, illos diuturnis
cruciatibus absumptos; alios, quod erumnarum omnium atrocissimum
arbitror, ultro sibi mortem conscivisse...».
37
c. e. trinkhaus, Adversity’s Noblemen, the Italian Humanists on
Happiness, New York 1940, p. 137.
38
Cfr. cap. vi. Si troveranno elenchi nelle opere solite: von pastor,
Storia dei papi cit., IX, pp. 299 sgg.; gregorovius, Storia della città di
Roma cit.
39
l. gregorii giraldi, Epistola in qua agitur de incommodis quae in
direptione urbana passus est..., in Dialogi duo de poetis nostrorum tempo-
rum, Firenze 1551, pp. 113 sgg.; ristampato in Opera omnia, 1696, vol.
II: Poemata, pp. 913 sgg.
40
«Deinde in hoc misero casu videntur etiam studia literarum in
quoddam discrimen venisse...» (in Historicum opus cit., II, p. 1855).
41
l. dorez, Antonio Tebaldeo, les Sadolet et le Cardinal Jean du Bel-
lay, in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», 26 (1895), p.
384. Cfr. cap. vi.
42
c. dionisotti, Chierici e laici nella letteratura italiana del primo Cin-
quecento, in Problemi di vita religiosa in Italia nel Cinquecento, Padova
1960, ripreso in Geografia e storia della letteratura italiana, Torino 1967,
pp. 55 sgg.
43
Citato da cian, La coscienza politica nazionale nel Rinascimento cit.
44
Citato da salviolo, Nuovi studi cit., 1878, p. 25.
45
giovio, Historiarum sui temporis cit.
46
m. philips, The «Adagia» of Erasmus, Cambridge 1964, pp. 160-
61; r. valentini, Erasmo da Rotterdam e Pietro Corsi, in «Rendiconti
Accademia dei Lincei», serie VI, vol. 12 (1936), pp. 11-12; m. p. gil-
more, Anti-Erasmianism in Itaty: the Dialogue of Ortensio Lando on Era-
smus Funeral, in «The Journal of Medieval and Renaissance Studies»,
4 (1974), p. 9, fig1.
47
Sulla difesa di Frosinone, cfr. cap. i.
48
vasari, Le vite cit., V, pp. 142 sgg. Cfr. a. marabottini, Poli-
doro da Caravaggio, Roma 1969, vol. 1, cap. xi; vol. II, tavv. cxxviii
sgg. (Palazzo Milesi: tavv. cxlvi a cliv). Cfr. cap. v.
49
j. wasserman, Palazzo Spada, in «The Art Bulletin», 43 (1961),
2, pp. 58 sgg.
Il palazzetto di Antonio da Sangallo il Giovane, in via Giulia,
costruito circa il 1535-36, quando fu ereditato da Cosimo I, verso il
156o, venne ornato con una decorazione tutta a gloria dei Medici, con
Storia dell’arte Einaudi 185
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
ritratti di Giuliano, stemma di Clemente. Cfr. l. salerno, l. spezza-
ferro e m. tafuri, Via Giulia, Roma 1973, pp. 272-79.
50
Cfr. cap. vi.
51
renaudet, Erasme et l’Italie cit., III, cap. iii, p. 140; cap. v, pp.
164-65.
52
Su «Die göttliche Mühle», si veda infine, zschelletzschky, Die
«drei gottlosen Maler» von Nürnberg cit., pp. 236 sgg. e fig. 188.
53
La prima traduzione italiana degli scritti di Lutero è notevolmente
precoce, poiché si conosce «uno libretto volgare con la dichiarazione
de li dieci comandamenti, del Credo, del Pater noster...» in una edi-
zione del 1525 di Venezia, che adatta un testo devozionale del 1520
(rist. 1540 e 1543), segnalato come opera anonima da c. ginzburg e a.
prosperi, Giochi di pazienza, Torino 1975, p. 131; studiato da s. sei-
del menchi, Traduzioni italiane di Lutero, in «Rinascimento», 18
(1977), pp. 40 sgg.; (il «libretto» contiene inoltre «una breve annota-
tione del vivere cristiano», di cui non si è identificato l’originale tede-
sco). L’anno seguente, la stessa piccola raccolta appariva, sempre a
Venezia, sotto il nome di Erasmo, cfr. d. cantimori, Erasmo e la vita
religiosa italiana del secolo XVI, in Umanesimo e religione nel Rinasci-
mento, Torino 1975, p. 43. Nel 1525 e 1526, non era già più possibi-
le far circolare senza rischio gli scritti di Lutero, anche quelli solo sulla
religione; ma si trovò l’espediente, in taluni casi, di mettere in coper-
tina il nome di Erasmo, con un interessante adattamento delle ingiun-
zioni cristiane del riformatore per il pubblico italiano.
54
a. renaudet, Etudes érasmiennes (1521-1529), Paris 1939, pp. 98
sgg. A rischio di una totale incomprensione l. halkin, Erasme de Turin
à Rome, in Mélanges d’histoire du XVIe siècle offerts à Henry Meylan,
Genève 1970, p. 16 nota 112, ha affermato: «Erasmo deplorerà il
Sacco di Roma del 1527. Ci si chiede come Renaudet […] abbia potu-
to scrivere il contrario». I due passaggi citati di Erasmo devono esse-
re letti nel contesto che li illumina. Mal informato ancora il 27 mag-
gio, Erasmo esprime soltanto il suo vecchio timore dei disordini: «Mea
senectus in haec tempora satis infeliciter incidit» e «Romae turbatis-
sima sunt omnia nec epistolis patet iter. Putant foedus Caesari cum
Pontifice coiturum». Se si tratta dell’accordo di capitolazione, la for-
mula è esposta in modo curioso (erasmo, Letters cit., VII, n. 1831).
Quando giunsero a Erasmo notizie più precise egli non tradì alcuna
emozione particolare nella lettera a Federico Grau: «De Roma diri
rumores adferuntur: qui sive veri sunt, sive falsi, nullam video spem
pacis inter monarchas» (ibid., n. 1834). Nell’ottobre 1528, la lettera a
Sadoleto commenta più ampiamente i fatti riassumendo, con un’ironia
fredda notata da A. Renaudet, la situazione: «Vidimus Romam cru-
delius captam quam olim fuerit a Gallis aut post a Gottis. Vidimus
Ecclesiae principem Clementem inclementissime tractatum...» (ibid.,
Storia dell’arte Einaudi 186
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
n. 2059). La lettera prosegue estendendosi alla sorte, che sarebbe stata
probabilmente infelice, degli studi umanistici (cfr. cap. iii).
55
Questo punto di vista riflette una lettera di Carlo V a Pierre de
Veyre, inviato presso Lannoy, datata 21 luglio 1527: l’inviato deve far
conoscere al viceré la posizione dell’imperatore: «...sembra che sia per
la mano di Dio e per il suo divino permesso, per giungere e dare avvio
a qualche buona pace nella cristianità per il bene e il riposo di questa,
e per conseguenza ne risulterà un concilio per riforma della Chiesa
tanto desiderata e necessaria che ognuno sa, e anche per estirpare l’er-
ronea setta Luterana. E in tal caso, pensando al successo di così gran-
di benefici abbiamo avuto più piacere che altro di quel che è piaciuto
a Dio di disporre in questa vittoria di Roma» (l. e. halkin e g. dan-
saert, Charles de Lannoy, vice-roi de Naples, Paris 1934, doc. cxxxiii).
56
sadoleto, Epistolarum libri XVI, Lyon 1550, p. 48.
57
Dialogus ciceronianus, sive de optimo genere dicendi, marzo 1528.
[Trad. it. di A. Gambaro, Brescia 1965].
58
Erasmo non aveva mai pensato ad altro. Fin dal 26 giugno 1527,
in una lettera inviata da Roma all’imperatore, il segretario Juan Pérez
segnala di avere chiesto un breve a Clemente VII perché l’arcivescovo
di Siviglia possa imporre silenzio ai contraddittori di Erasmo (de
gayangos, Calendar ol Letters cit., n. 94).
59
erasmo, Letters cit., VII, nn. 1987, 2059; ibid., p. 506: «Cice-
ronianus meus non paucos offendet Italos; quod satis divinabam fore».
60
Ibid., VI, p. 90, n. 1581. Sul Ciceronianus come un’opera cardi-
ne, cfr. g. vallese, L’Umanesimo al primo Cinquecento: da Cristoforo
Longolio al «Ciceronianus» di Erasmo, in Da Dante a Erasmo. Studi di
letteratura umanistica, Napoli 1962, pp. 103-28.
61
girolamo, Epist. XXII 30. Cfr. dom f. cabrol e dom h.
leclercq, Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, Paris 1927,
vol. VII, coll. 2243-44 (con bibliografia); h. hagendahl, Latin Fathers
and the Classics, Göteborg 1958, pp. 91 e 310. L’episodio figura nella
Leggenda aurea.
62
Sull’erasmianismo dei critici italiani dell’umanesimo a partire dal
1530, cfr. p. f. grendler, Critics of the Italian World, Madison (Wisc.)
1969, pp. iii sgg.
63
renaudet, Etudes érasmiennes cit., p. 294. j. w. o’malley, Prea-
ching for the Popes, nella raccolta In Pursuit of Holiness in Late Medie-
val and Renaissance Religion, a cura di Trinkhaus e H. A. Obermann,
Leiden 1974, pp. 08 sgg., ha notevolmente ridotto lo scandalo dei pre-
tesi sermoni «pagani» di cui Erasmo ha fatto la satira attraverso la voce
di Bulephorus, analizzando la vera natura della «teologia retorica»
della corte pontificia, cosa che non hanno avvertito né Burckhardt né
Pastor, né beninteso, l’autore del Ciceronianus.
64
Cfr. renaudet, Erasme et l’Italie cit., p. 96 e nota A, che parla
Storia dell’arte Einaudi 187
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
del giovedì santo; Ciceronianus cit., p. 57; poiché Erasmo non nomina
l’oratore, si suppone che si tratti di Tommaso Fedra Inghirami, di cui
parla altrove come del predicatore «ciceroniano» più in voga a Roma,
insieme a Giulio Camillo.
65
«Si quis argumentum rapti Ganymedis eleganter constructum
opere musaico dissolvat et iisdem tessellis aliter concinnatis exprime-
re conetur Gabrielem coelesteque nuntium adferentem Virgini Naza-
renae, nonne durum parumque felix opus nascetur ex optimis quidem
tessellis sed minus argumento congruentibus» (Ciceronianus cit., p.
409). Questo passo basta a dimostrare che la polemica di Erasmo non
si limita ai testi letterari.
Come lo ha notato bene panofsky, Erasmus and the Visual Arts cit.,
pp. 205 sgg., Erasmo, nella sua preoccupazione di moralista «evange-
lico», attento a quel che succede «magis in moribus quam in parieti-
bus», è ugualmente ostile ai particolari realistici, al lusso delle forme,
ai modelli antichi, in breve a tutto ciò che allora poteva importare agli
artisti.
Sul problema delle tombe, cfr. la risposta di Alberto Pio, citata in
g. scavizzi, La teologia cattolica e le immagini durante il XVI secolo, in
«Storia dell’Arte», 21 (1974), p. 200.
66
De partu Virginis, a cura di A. Altamura, Napoli 1948.
67
«Gratulamur tibi quod tantum unus praestes quantum antea
nemo: Ecclesiae... nostro saeculo... nobis denique ipsis, quibus immi-
nente hinc Goliade armato, hinc Saule a furiis agitato, affuerit pius
David illud funda a temeritate, hunc lyra a furore compescens».
Questo testo è stato pubblicato come premessa all’edizione dei
Poemata di Sannazaro, Roma 1793, pp. xliii-iv. È citato da dacos, Le
loge cit., pp. 69-7o e nota 196.
68
«Io non so se sia più reprensibile, essendo cristiano, trattare in
modo profano soggetti profani non dando a vedere di essere cristiano,
oppure trattare al modo pagano soggetti cristiani» («Haud scio utrum
sit magis reprehendem, si christianus, prophana tractet prophane, chri-
stianum se esse dissimulans, an si materias christianas tractet pagani-
ce») (Ciceronianus, ed. Amsterdarn 1966, vol. I, p. 701).
69
Ciceronianus, ed. Leida, I, col. 1020; citato da renaudet, Etudes
érasmiennes cit., p. 102; dacos, Le loge cit., p. 7o nota 197.
70
Elogio della pazzia, cap. 43. Nel vivo della disputa «ciceroniana»,
Erasmo non esitò a dichiarare che in fatto di «litterae», non doveva
nulla all’Italia, Apologia brevis ad XXIV libros Alberti Pii, in Opera omnia,
Leiden 1706, vol. IX, coll. 1123-96.
71
Lettera del 13 marzo 1527 a erasmo, in Letters cit., VI, pp. 471-
75, n. 1791 (bataillon, Erasme et l’Espagne cit., p. 249, non vi fa che
una breve allusione); n. 1875 «Fervet illic paganesimus quorumdam
quivis nihil placet nisi ciceronianum».
Storia dell’arte Einaudi 188
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
72
Gli storici più antichi si sono molto affannati per fare di Erasmo
un ammiratore dell’arte moderna. j. d. passavant, Rafael von Urbino
und sein Vater Giovanni Santi, Leipzig 1839, ha immaginato ingenua-
mente una visita guidata da Inghirami nella bottega di Raffaello.
Disgraziatamente, tutto ciò che Erasmo ricordava è il sermone di
Inghirami del giovedì santo del 1509. Di fatto, r. giese, in Erasmus and
the Fine Arts, in «The Journal of Modern History», settembre 1935,
p. 273, ha bene osservato che se Erasmo non parla degli edifici, delle
pitture, dei capolavori dell’arte italiana, dipende dal fatto che non l’in-
teressano e che non ha nulla da dirne.
73
Lo studio che E. Panofsky ha fatto dell’elogio di Erasmo a Dürer:
«Nebulae in pariete»; Notes on Erasmus’ Eulogy on Dürer, in «Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes», 14 (1951), pp. 34-41, e del-
l’atteggiamento di Erasmo verso le arti: Erasmus and the Visual Arts cit.,
xxxii (1969), pp. 200 sgg., dimostra finalmente l’importanza seconda-
ria e puramente occasionale delle osservazioni dell’umanista. Se è vero
che egli abbia disegnato e dipinto, come si è supposto, questa espe-
rienza ha solo confermato la sua opinione sull’interesse mediocre delle
arti visive in confronto alle lettere, debitamente presentate, nell’ago-
sto 1518 a Amerbach, come le sole degne di attenzione. La pittura e
l’incisione sono ausiliari poco sicuri del pensiero morale, che solo può
essere espresso con il discorso scritto. Le distruzioni iconoclaste di Basi-
lea nel 1529 lo indignano soltanto per l’orrore della violenza e degli
eccessi (renaudet, Etudes érasmiennes cit., p. 356). È soprattutto per
Erasmo l’occasione di sottolineare che quelle statue di santi e quei cro-
cifissi non sono state in grado di produrre un miracolo.
74
Il pensiero fisso di Erasmo è il valore esclusivo, insostituibile, del-
l’uomo interiore (Enchiridion, 1503, cap. iv: De homine exteriore et inte-
riore). L’uomo interiore non si esprime realmente che con il linguaggio,
che merita tanto più tutta l’attenzione in quanto la verità fu rivelata dalle
Scritture. Il resto non conta. Cfr. d. marsh, Erasmus on Body and Soul,
in «Journal of the History of Ideas», ottobre–dicembre 1976, pp. 976 sgg.
75
Ciceronianus cit., pp. 102 Sgg.: «Istius generis pictor quidam
nuper risui nobis fuit».
76
Alberto, nello spirito del Rinascimento italiano, aveva trasfor-
mato il suo castello, rifatto la cattedrale di Carpi sul modello di San
Pietro, lavorato con i maestri. Cfr. vasari, Le vite cit., IV, 264. m. p.
gilmore, Erasmus and Alberto Pio, Prince of Carpi, in Action and Con-
viction in Early Modern Europe, Princeton 1969, pp. 299-318.
77
Citato da bataillon, Erasme et l’Espagne cit., p. 380.
78
r. carande, El sorprendido y sorprendente Adriano VI, papa, in
Homenaje a Johannes Vincke, Madrid 1963, vol. II, pp. 1 sgg.
79
Su Adriano VI cfr. Adrien VI. Le Ier pape de la Contre-Réforme. Sa
personnalité, sa carrière, son oeuvre, Louvain 1959, con bibliografia.
Storia dell’arte Einaudi 189
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Può sembrare sorprendente che Paolo Giovio abbia consacrato tutta
una biografia a Adriano VI: al suo avvento, il nuovo papa gli tolse tito-
lo e pensione, che gli doveva a Leone X; in compenso gli accordò un
canonicato a Como, a condizione che scrivesse la storia del pontifica-
to di Adriano. Nel suo trattato sui pesci, De Piscibus, scritto nel 1524
e pubblicato a Basilea nel 1531, p. 8, egli si esprime ogni tanto senza
riguardi sulla debole capacità di Adriano, a proposito dei pesci ricer-
cati dall’aristocrazia che sono abbandonati per capriccio e cadono a vile
prezzo: «Uti modo merlucciae plebeio admodum pisci Hadrianus pon-
tifex sicuti in administranda republica habetis ingenii vel depravati
judicii ita in esculentis [= in fatto di tavola] insulsissimi gustus, supra
mediocre pretium, ridente toto foro piscario, jam fecerat».
79
«La scuffia de l’Unico Aretino..., il brachiere di Flischio, la cin-
tura della mamma di Trani…, la statua equestre del Sre Renzo inta-
gliata di pane fresco...» Cfr. Luzio, Pietro Aretino nei primi suoi anni
cit., p. 7 nota 1.
80
p. giovio, De Vita Hadriani VI, in Vitarum illustrium aliquot viro-
rum libri X, Basel 1577, tomo II, p. 128.
81
vasari, Le vite cit., V, p. 456.
82
chiorboli, Francesco Berni, Poesie e prose cit. Cfr. e. bonora,
Francesco Berni e la poesia bernesca, in Storia della letteratura italiana, vol.
VI: Il Cinquecento, Milano 1966, cap. x, p. 290. Berni in seguito
avrebbe dato un giudizio meno volgare ma più duro di Clemente.
Questi pamphlets o «pasquinate» sono notevoli per la loro grosso-
lanità xenofoba Pasquinate di Pietro Aretino ed anonime per il conclave
e l’elezione di Adriano VI, a cura di V. Rossi, Palermo e Torino 1891,
n. XI., p. 55: a proposito del papa «tedesco» sono evocati Alarico e
Genserico, i distruttori di Roma.
83
vasari, Le vite cit., V, p. 352.
84
c. dionisotti, Battista Fiera, in «Italia Medioevale e Umanistica»,
1, 1958, p. 408.
85
vasari, Le vite cit., IV, p. 600 e V, p. 92.
36
Ibid., IV, p. 579.
87
Cfr. cap. iii.
88
La moda era diffusa. Il Palazzo Della Valle è stato descritto nel
1536 da un visitatore: «A destra, si scendeva verso una sala affianca-
ta da un bagno tra i più eleganti e decorato di pitture molto lascive di
giovanette nude alla toeletta, composizione di stile romano più gran-
de e più sontuosa del bagno dei papa a Castel Sant’Angelo». Cfr. hol-
sen e fager, Drei römischen Skizzenbücher cit., p. 56.
89
f. castagnoli, Raffaello e le antichità di Roma, in Raffaello, l’o-
pera le fonti, la fortuna, Novara 1968, vol. II, cap. vi; r. lanciani, La
pianta di Roma antica e i disegni archeologici di Raffaello, in «Rendiconti
della Reale Accademia dei Lincei», V serie, vol. 3 (1894), pp. 797 sgg.
Storia dell’arte Einaudi 190
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
90
r. weiss, Andrea Fulvio antiquario romano, in «Annali Scuola Nor-
male Superiore di Pisa», 18 (1969), pp. 1-2.
* [«Tu restituirai nel suo corpo Roma fatta a brandelli»].
91
Su Marco Fabio Calvo, cfr. lanciani, La pianta di Roma antica
cit., p. 240; a. jammes, Un chef-d’oeuvre méconnu d’Arrighi Vicentino,
in Studia bibliografica in honorem de la Fontaine Verwey, Amsterdam
[19651, pp. 297-316; p. n. pagliara, La Roma antica di Fabio Calvo.
Note sulla cultura antiquaria e architettonica, in «Psicon», 8-9 (1976),
pp. 65-87.
92
valeriano, De litteratorum infelicitate cit., p. 81.
Storia dell’arte Einaudi 191
Capitolo quinto
Lo stile clementino
Il cardinale Giulio de’ Medici si era scelto un emble-
ma personale al tempo di Adriano VI. Nel momento in
cui certi nemici minacciavano la sua vita, egli ci tenne
a mostrare che «la purezza della sua anima non poteva
essere colpita ne dalla malevolenza né dalla violenza»,
secondo quanto ci dice Paolo Giovio1. Al di sopra del
motto candor illesus (candore intatto), erano collocati dei
simboli che ne illustravano l’«impresa» per così dire
«scientifica»: un sole ardente, un fascio di raggi che sfio-
rano una sfera di cristallo, e un albero i cui rami si
incendiano. Giovio precisa che esso fu escogitato dal
tesoriere del cardinale, un fiorentino di nome Domeni-
co Buoninsegni, che aveva il gusto delle speculazioni
fantasiose in fisica: «volentieri ghiribizzava sopra i
secreti della natura». E Giovio fornisce una spiegazio-
ne necessaria, sebbene incompleta, della composizione:
«I raggi del sole, attraversando una sfera di cristallo,
assumono un’unità e un’intensità così grandi che, per un
effetto di propagazione ottica, bruciano tutti gli ogget-
ti tranne ciò che è assolutamente bianco». Questa
impresa, come si è visto, era già apparsa nella Stanza di
Costantino, e quindi è assai anteriore al Sacco; ma fu
facilmente resuscitata per difendere una reputazione
compromessa2.
Il «broncone», o tizzone ardente, era un emblema di
Lorenzo de’ Medici3. L’emblema di Clemente, oltre a
Storia dell’arte Einaudi 192
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
essere una variante del tema della «palla» medicea,
diventava così una versione allargata di una vecchia
«impresa». Ma esso invita inoltre a un accostamento tra
le congetture del Buoninsegni sui segreti della natura e
i raggi luminosi; fa pensare ai diagrammi di Leonardo
sulla rifrazione della luce: furono questi all’origine della
sua idea?4.
La scelta dell’«impresa» da parte del cardinale deno-
ta, o meglio, secondo la regola, ostenta una volontà di
purezza, di trasparenza morale; era una risposta agli
avversari e una sfida alla sorte, una ricerca di giustifi-
cazione un po’ eccessiva. Ma era anche associata ad
un’altra affermazione, che acquistava il suo pieno signi-
ficato dopo l’austero pontificato di Adriano VI, vale a
dire un programma di cultura elevata, un richiamo alle
scienze e alle arti. Difatti, nella Stanza di Costantino,
sopra il vano della finestra ad est, due allegorie alate di
Pittura e Scultura incidono l’emblema sui loro scudi, la
prima con un pennello, la seconda con uno scalpello.
Clemente dichiarava con decisione che il rapporto tra
papato e creazione artistica non doveva essere nuova-
mente rimesso in causa. Tutt’altro.
Non si dovrebbe parlare del mecenatismo nel Rina-
scimento senza tener presente un doppio impulso per-
fettamente esemplificato dal ruolo personale di Cle-
mente VII. Da un lato, i grandi signori del suo tipo ave-
vano sempre invitato, aiutato e favorito molti letterati,
artisti, uomini dotti. Il cardinale Giulio seguiva in que-
sto il modo di vita mediceo. Sotto Leone X si era occu-
pato soprattutto di Firenze, mentre suo cugino atten-
deva a questioni romane. Diventato papa, si verificò un
nuovo fenomeno con l’improvviso moltiplicarsi delle
iniziative, che gli veniva chiesto di patrocinare. L’ap-
poggio del potere supremo galvanizzò immediatamente
le forze intellettuali e artistiche che aspettavano un
momento più favorevole, dopo il gelido intermezzo di
Storia dell’arte Einaudi 193
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Adriano. In quel mondo impaziente e irruente, parve
d’un tratto che tutto diventasse possibile con un secon-
do papa mediceo di un gusto e una raffinatezza incon-
testate5. Il 25 novembre 1523, Michelangelo scriveva a
un collaboratore: «Avrete appreso che un Medici è stato
fatto papa; tutti mi sembrano rallegrarsene. Penso che
per l’arte si faranno laggiù molte cose...»6.
Nel giardino del Belvedere, ornato di piante di aran-
ci e di grandi statue – che divennero celebri in tutto il
mondo –, disposte in nicchie, Clemente recitava al mat-
tino il breviario. La sera, cenava ascoltando l’orchestra
da camera diretta da «Gianicomo piffero da Cesena»7.
Tutto quanto la cultura umanistica aveva prodotto di più
incantevole – di più «pagano» avrebbe detto Erasmo, –
gravitava con naturalezza estrema intorno a Clemente.
Le cose avvennero molto in fretta. Per le lettere come per
l’archeologia, e ben presto per la pittura, una tendenza
interessante cominciò a delinearsi fin dal 1525.
Non abbiamo l’abitudine di pensare alla Curia roma-
na come responsabile di una riforma linguistica o di uno
stile letterario. Ma non vi era altra istituzione al mondo
capace di assicurare un simile magistero e i partigiani
dell’italiano («lingua toscana») sul latino se ne erano
impadroniti. Non è per caso se nel 1525 apparve l’ope-
ra fondamentale di Pietro Bembo: la cosa era matura da
lungo tempo. Nell’ottobre 1524 Pietro Bembo presen-
ta al papa il manoscritto con dedica delle Prose della vol-
gar lingua, dove la finzione di una conversazione situa-
ta nel 1502 consente di mettere in scena Giuliano de’
Medici, cugino del papa. È stato dimostrato che que-
st’opera fece epoca per la definizione del linguaggio let-
terario8. Il flusso di pubblicazioni, le concorrenze e le
polemiche di quegli anni, sono perfettamente rivelatri-
ci. Pierio Valeriano componeva nel 1524 il Dialogo della
volgare lingua, ugualmente orientato verso la giustifica-
zione di un toscano epurato come lingua delle corti d’I-
Storia dell’arte Einaudi 194
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
talia, che gli eventi impedirono di pubblicare. Altra
opera didattica, in cui l’umanista Colocci riferisce una
supposta conversazione in casa dello stesso cardinale
de’ Medici.
Molte questioni culturali sembravano perciò giunge-
re proprio allora a maturazione. C’era un interesse gene-
rale per la lingua pura, per il discorso elegante e lo stile.
La svolta decisiva fu presa dal Bembo, dal Firenzuola e
dal Della Casa, cioè da coloro che domineranno il
mondo letterario alla meta del secolo. Si è giustamente
ricordato che la traduzione dell’Asino d’oro, lo scabro-
so romanzo di Apuleio, per opera di Firenzuola, ha dota-
to la letteratura italiana, verso il 1525-26, di un model-
lo di raffinatezza e di preziosità9. Ma non si dimentichi
che la preziosità petrarchesca e la poesia quintessenzia-
ta incontrerà, in quella stessa Roma di Clemente, l’iro-
nia incisiva di Berni, che rifiuterà di lasciarsi gabbare e
non esiterà a parodiare con insolenza Bembo e le sue
aggraziate formule convenzionali. Il Dialogo contra i
poeti del 1526 adotta il tono terra terra di una critica che
sgonfia le pretese altisonanti10. Se Anfione ha costruito
Tebe, dipende dal fatto che era muratore11, dice Sanga,
interlocutore del Berni. Gli scrittori romani non aveva-
no aspettato Erasmo per canzonare i letterati.
Quest’orientamento dell’ambiente clementino coin-
cide con una specie di «toscanizzazione» dello stile, del
gusto, delle maniere stesse di Roma12. Nella banca e nel
mondo degli affari, i tedeschi, i lombardi, o altri grup-
pi soppiantati non lo sopportavano senza impazienza, e
neppure la maggior parte dei romani. Clemente non fu
mai popolare.
Le memorie di Cellini lasciano intendere a meraviglia
il modo in cui gli artisti vivevano a Roma: il loro lavo-
ro, le loro ordinazioni e i loro piaceri. L’orafo, con la sua
abituale vivacità, ha descritto la vitalità della colonia fio-
rentina: «Essendo una mattina del nostro San Giovan-
Storia dell’arte Einaudi 195
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
ni a desinare insieme con molti della nazione nostra, di
diverse professioni, pittori, scultori, orefici; infra gli
altri notabili uomini ci era uno domandato il Rosso pit-
tore, e Gian Francesco (Penni), discepolo di Raffaello da
Urbino, e molti altri»13.
Un po’ più avanti, Cellini aggiunge che al gruppo, in
prevalenza toscano, si erano recentemente uniti Giulio
Romano e Penni.
Si tratta quindi di un gruppo omogeneo di amici che
formano una scuola. La presenza di Rosso è fondamen-
tale, giacché ci consente di pensare che il proto-manieri-
smo incominciasse a subentrare al raffaellismo romano.
La partenza di Giulio, alla fine del 1524, una volta ter-
minata la Stanza di Costantino, avrebbe accelerato l’al-
lontanamento dallo stile romano. Giulio portava con sé
a Mantova, dove si sarebbe svolta la sua carriera accan-
to a Federico Gonzaga, il suo soprannome di «Romano».
Ci si ricordava ch’egli aveva decorato per il cardinale
Giulio, prima del 1520, le grandi volte della villa di
Monte Mario. Di fatto, egli avrebbe «romanizzato» l’ar-
te di Mantova, mentre a Roma l’eredità di Raffaello
avrebbe, in un certo senso, perso terreno e sarebbe cam-
biata di mano. Durante il 1523, Perino del Vaga lasciò
Roma per Firenze. Secondo Vasari, a causa della peste.
Si può anche pensare che la scoraggiante situazione degli
artisti sotto Adriano VI abbia contribuito alla sua par-
tenza. A Firenze, gli capitò qualcosa di strano:
Avvenne che trovandosi un giorno seco per fargli onore
molti artefici, pittori, scultori, orefici ed intagliatori di
marmi e di legnami, che secondo il costume antico si erano
ragunati insieme, chi per vedere ed accompagnare Perino,
ed udire quel che ei diceva, e molti per vedere che diffe-
renza fusse fra gli artefici di Roma e quelli di Fiorenza nella
pratica, ed i più v’erano per udire i biasimi e le lode che
sogliono spesso dire gli artefici l’un dell’altro...
Storia dell’arte Einaudi 196
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Una discussione ebbe luogo davanti agli affreschi di
Masaccio in Santa Maria del Carmine, insuperabili a
detta dei fiorentini. Perino ne condivideva l’ammira-
zione, ma pensava che vi fossero nei moderni cose altret-
tanto belle, se non di più. Gli proposero di darne una
dimostrazione perché, precisa Vasari, «avevano caro
veder questa maniera di Roma». Perino schizza un
Sant’Andrea che, se fosse stato dipinto, avrebbe potu-
to reggere il confronto con il San Pietro di Masolino e
il San Paolo di Masaccio14.
L’interessante è qui il fatto che ci si aspettava, dal
giovane artista, delle informazioni su ciò che andava suc-
cedendo a Roma. L’andare e venire degli artisti aveva
creato, fra le due «scuole», uno spirito competitivo e
allo stesso tempo, un vincolo di solidarietà, che sarà fon-
damentale in seguito. Gli artisti fiorentini sentivano
che dopo la morte di Raffaello stava succedendo qual-
cosa d’importante a Roma: in un primo tempo, fu pro-
babilmente la nuova maniera di Giulio Romano che fece
parlare di sé. Perino, collaboratore di Raffaello alle
Logge, incaricato della «Stanza dei Pontefici», godeva
della stima di Giulio e di Penni. Era quindi in ottima
posizione per mostrare ai fiorentini la robustezza e la
forza dello stile romano.
Viceversa, quei pochi mesi del 1523 trascorsi a
Firenze in un clima di interesse e di simpatia piutto-
sto eccezionale, gli avevano assicurato un contatto frut-
tuoso con i rappresentanti più attivi della maniera
toscana, e innanzi tutto con il Rosso. Questo risulta da
un’ipotesi ingegnosa, secondo la quale, confrontando
il cartone preparatorio della pala per Santa Maria sopra
Minerva, eseguito da Perino prima della partenza, con
quel che si può ricostituire del quadro finalmente ese-
guito dopo il ritorno a Roma, si scorgono nettamente
delle affinità con il Rosso. Disgraziatamente non è più
possibile esaminare quest’opera; essa fu danneggiata
Storia dell’arte Einaudi 197
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
durante l’inondazione dell’autunno 1530, tagliata e
dispersa15.
Il Rosso doveva essere arrivato a Firenze poco dopo
Perino, più giovane di lui di sei anni. Secondo Vasari,
lo si aspettava con molto interesse, perché la qualità
eccezionale dei suoi disegni era già conosciuta. Questa
indicazione, per quanto sia difficile controllarla, merita
di essere presa in considerazione. Incominciavano a sta-
bilirsi legami privilegiati tra Firenze e Roma, preparan-
do la «toscanizzazione» che sarebbe stata uno dei fatti
dominanti dei due anni precedenti il sacco.
Al pari di Leone X, Clemente non aveva creduto
necessario attirare Michelangelo a Roma. Aveva, qual-
che tempo prima, negoziato con lo scultore i progetti
per la facciata di San Lorenzo (1518), poi della Cappella
Medici (1520). Progetti più o meno importanti gli furo-
no sottoposti: la Biblioteca Laurenziana (gennaio 1524),
il Colosso davanti al Palazzo (ottobre) e il ciborio di San
Lorenzo16. Ma soprattutto contavano le tombe dei
Medici. Forse la presenza stessa di Michelangelo a
Firenze può essere stata sufficiente per influenzare la
situazione. Quindici o vent’anni prima, l’attrazione di
Roma tendeva a vuotare la Toscana. Questa aveva ades-
so una linea più decisa, lasciando all’ambiente romano,
dominato da Raffaello e da Giulio Romano, la cura di
mantenere un certo «classicismo»17. Dal 1520, gli allie-
vi di Andrea del Sarto avevano preso un orientamento
sempre più immaginoso e stilizzato. Era stato il Pon-
tormo a compiere il passo decisivo, e il suo stile ele-
gante, chiaro e infinitamente sottile, si accordava con
gli interessi di Michelangelo. Il termine di proto-manie-
rismo è quello che meglio lo descrive. Pertanto una
polarità degna d’attenzione cominciava a delinearsi fra
i due centri.
Storia dell’arte Einaudi 198
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Il cambio della guardia.
Il segretario del papa, Paolo Valdambrini, di passag-
gio ad Arezzo, condusse con sé a Roma un giovane arti-
sta di nome Giovanni Antonio Lappoli. E questi, per
citare Vasari: «andato dunque con esso m. Paolo a
Roma, vi trovò Perino [del Vaga], il Rosso, ed altri
amici suoi, ed oltre ciò gli venne fatto per mezzo di m.
Paolo di conoscere Giulio Romano, Bastiano Viniziano,
e Francesco Mazzuoli da Parma, che in quei giorni
capitò a Roma»18. Uno storico può difficilmente imma-
ginarsi un’indicazione più preziosa, tanto più ch’essa si
completa con un’informazione non meno importante
sulla venuta del Parmigianino a Roma a metà del 1524:
«Il Datario [Giberti] veduti i quadri e stimatigli quello
che erano, furono subito il giovane ed il zio introdotti
a Papa Clemente, il quale vedute le opere, e Francesco
così giovane, resto stupefatto, e con esso tutta la
corte»19.
Il giovane Parmigianino, nella freschezza dei suoi
ventun anni, fu, insomma, scoperto dal papa, per l’ap-
prezzamento favorevole di Giberti. Si formava così, sul
finire del 1524, un nuovo gruppo20, favorito dai colla-
boratori più intimi di Clemente. E non è forse eccessi-
vo parlare di una specie di cenacolo artistico: Paolo Val-
dambrini si adoperava ad attirare a Roma persone di
merito, e le metteva in contatto le une con le altre. Il
giovane artista aretino Giovanni Antonio Lappoli pare
che abbia anche assicurato un legame fra gli artisti.
Attorniato da intellettuali ed egli stesso musicista e pit-
tore, era, se comprendiamo bene Vasari, non tanto un
artista notevole quanto una figura sociale importante21.
In ogni caso è chiaro che le nuove stelle, Rosso, Parmi-
gianino e i loro amici, avevano gli stessi ammiratori e gli
stessi mecenati. Per quanto difficile sia seguire l’evolu-
zione individuale di quegli artisti ombrosi e sensibili,
Storia dell’arte Einaudi 199
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
non si possono trascurare le loro numerose esperienze
comuni durante quella breve felice stagione. Erano reci-
procamente in contatto, le loro ambizioni seguivano
linee parallele. Nella Roma clementina si formò questa
specie di «clima» comune, che facilita come una serra il
dischiudersi dei fiori rari.
Valdambrini, che sembra essere stato così attivo, fu
una delle vittime del maggio 1527.
Se proponiamo qui la nozione di uno stile «clemen-
tino» è per rendere conto di un certo numero di tratti
comuni che si possono osservare intorno al 1525, e di
un particolare orientamento che cercava di tenere lon-
tani gli artisti dell’epoca da una troppo stretta adesione
ai «modi raffaelleschi» e da una sottomissione troppo
forte alla «maniera michelangiolesca».
Sebastiano, richiamato a Roma dal papa nel 1523
quando aveva trentotto anni22, rappresentava il decano.
Doveva il suo prestigio alla forza dei suoi ritratti: dopo
la morte di Raffaello, non aveva rivali in questo campo.
Vasari ha lasciato una descrizione entusiasta delle raffi-
natezze con le quali raffigurò l’Aretino nel 1524:
pittura stupendissima per vedervisi la differenza di cinque
o sei sorte di neri che egli ha addosso, velluto, raso, erme-
sino, damasco e panno, ed una barba nerissima sopra que-
gli neri, sfilata tanto bene che più non può essere il vivo e
naturale. Ha in mano questo ritratto un ramo di lauro ed
una carta, dentrovi scritto il nome di Clemente VII e due
maschere innanzi, una bella per la Virtù e l’altra brutta per
il Vizio23.
Essendo pessimo lo stato attuale di conservazione
del dipinto, è naturalmente impossibile rendere giusti-
zia al brio dell’esecuzione: solamente paragonandolo
con il ritratto del Castiglione, dipinto dieci anni prima
da Raffaello, se ne possono apprezzare le qualità pitto-
Storia dell’arte Einaudi 200
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
riche: il nero sul nero che rivaleggia con il grigio sul gri-
gio dell’opera più antica, la barba di colore nero lucen-
te rispetto all’altra, rada e bionda, lo sguardo sensibile
del teologo e l’occhio sfrontato del libellista che s’im-
poneva a Clemente tanto da provocarne il patronato e
che ostentava la duplice capacita di satirico e di adula-
tore. Su tutti i piani, il ritratto eseguito da Sebastiano
mostra un grado di sofisticazione più alto.
Nella Flagellazione di San Pietro in Montorio (1525),
nella Sacra Famiglia di Burgos (1526-27), la maniera
superaffinata di Sebastiano si appesantisce. Ma se tenia-
mo conto degli antecedenti dei suoi toni cupi, delle esi-
genze monumentali del suo disegno, quello stile appare
allora trattenuto fino all’artificio: nobile, ma un po’
vuoto, già, come si è detto, classicheggiante24, predi-
sposto dalla volontà piú che dalla convinzione. Donde
le grandi riuscite nel ritratto di quello stile interamente
controllato, quando dipinge la distinzione aristocratica
di Clemente o l’autorevolezza dell’ammiraglio Doria.
Nel gruppo di pittori che diventava così solidale
intorno al 1525, Rosso Fiorentino (nato nel 1495) era il
più vecchio, Francesco Mazzola, con i suoi ventidue
anni, il più giovane; gli altri due, Perino e Polidoro,
erano sui venticinque anni. Circostanze di ogni specie
sembravano riunite per ripetere, su un modulo più raf-
finato, più «esteta», quello spirito di rivalità che aveva
stimolato così fortemente a Roma, vent’anni prima, l’ar-
te e la cultura. Quegli artisti non erano modesti artigia-
ni, ma personalità brillanti e colte. Rosso era «dotato di
bellissima presenza: il modo del parlar suo era molto gra-
zioso e grave, era bonissimo musico ed aveva ottimi ter-
mini di filosofia». Quanto a Francesco Mazzola, era la
seduzione stessa con la sua bella fisionomia, e per cita-
re ancora Vasari, «...aveva il volto e l’aspetto grazioso
molto e piuttosto d’angelo che d’uomo...»; rampollo di
una famiglia di elevato grado sociale, fu allevato dagli
Storia dell’arte Einaudi 201
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
zii che gli procurarono, venuto il momento, facile acces-
so presso Clemente. Il famoso autoritratto a forma di
specchio convesso deve essere stato dipinto durante que-
gli anni25. Esso restituisce alla perfezione il fascino, l’in-
telligenza e l’audacia della giovane generazione che, in
quegli anni, era incoraggiata a esprimere la propria ori-
ginalità.
Nessuno fra quelli era propriamente romano, ma l’en-
tusiasmo per le cose antiche, per la Città Eterna, era
diventato per loro una specie di religione artistica ed
erano tutti estremamente sensibili alle nuove tendenze
culturali.
Perino del Vaga, tornato da Firenze, si metteva al
lavoro nella Cappella Pucci di Trinità dei Monti. La
data di ogni affresco non può essere fissata che appros-
simativamente: la Visitazione, così vicina alla scena cor-
rispondente dell’Annunziata a Firenze, sembra collo-
carsi subito dopo il 152326. Interessante è il bisogno di
introdurre la fluidità e il movimento libero dello stile
toscano in una composizione dominata da una piat-
taforma lastricata, ritmata di gradini – un’idea raffael-
lesca. I due profeti all’arco d’ingresso, rievocati a causa
della dedica mariana della cappella, hanno un valore di
citazione allargata: al di là degli evidenti riferimenti a
Raffaello e a Michelangelo, si osserva un’improvvisa
analogia con le lunghe figure dinoccolate del Parmigia-
nino. Gli affreschi di San Marcello al Corso, incomin-
ciati nel 1525 e interrotti dal sacco, furono ripresi dodi-
ci anni più tardi27, dopo il soggiorno di Perino a Geno-
va, con tutt’altro spirito. «Mentre Roma tutta sorri-
dente si abbelliva delle loro opere...», ha scritto Vasa-
ri, parafrasando Dante, a proposito della nuova deco-
razione delle facciate28. Essa era diventata alla moda con
i tentativi del Peruzzi, quindici anni prima, ma trova-
va adesso la sua piena maturità con i lavori «all’antica»
di Polidoro da Caravaggio29. È stato detto molto bene
Storia dell’arte Einaudi 202
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
da Freedberg: «la ricreazione per immagini della storia
romana, dispiegata in vasti fregi panoramici attraverso
le facciate di una dozzina di palazzi romani decorati fra
il 1524 e il 1527, deve essere annoverata fra i più gran-
di splendori di cui si è arricchita la Città nel breve ma
fecondo spazio del regno di Clemente prima del sac-
co»30. L’arte di decorare pannelli, plinti, zoccoli veni-
va in tal modo destinata a impieghi nuovi. Queste com-
posizioni han finito di scomparire soltanto nel secolo
scorso. Forse concepite per perpetuare le decorazioni
effimere delle entrate trionfali, offrono una indubbia
analogia con gli «apparati», i monocromi collocati sugli
archi di trionfo provvisori o le finte facciate. In passa-
to era stata sufficiente una specie di formula artigiana-
le, ma Polidoro, evidentemente, vi vedeva maggiori
possibilità. Le elaborò in veri e propri manifesti a favo-
re di Roma, quel che Lomazzo chiamerà felicemente la
«maniera marziale»31.
Polidoro si era a poco a poco svincolato dall’idea di
Raffaello di uno stile puro. Il suo interesse per l’arte del
Nord si manifestò verso il 1525 in certi disegni di pae-
saggio di una densità e di una forza del tutto nuove nel-
l’esplorare il fogliame, lo spazio rurale, gli sfondi. Ma
staccandosi così dal modello classico, Polidoro si prepa-
rava a dare una nuova prova delle sue ambizioni arti-
stiche: la grande innovazione di quegli anni – la crea-
zione straordinaria che la rottura del 1527 fece dimen-
ticare per più di mezzo secolo – furono i paesaggi
«all’antica» della cappelletta di Fra Mariano in San Sil-
vestro al Quirinale32. Lavorando con Maturino, Polido-
ro dispose la raffigurazione di due sante, la Maddalena
e Caterina da Siena, in paesaggi completi e avvolgenti,
di cui non si aveva ancora nessun esempio. Si tratta di
una stupefacente ricreazione della pittura antica, con
citazioni esplicite di templa, di loci, ripresi dai modelli
che da allora in poi si sarebbero potuti studiare nelle
Storia dell’arte Einaudi 203
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
cosiddette «grotte»33. Ci pare che ciò rappresenti un
risultato «clementino», che per ragioni evidenti non
ebbe un immediato futuro.
L’incisione.
Raggruppando tutte le possibili informazioni e facen-
do un inventario delle opere realizzate o in corso duran-
te il 1526 e i primi mesi del 1527, si ha a poco a poco
l’impressione che un organismo in piena forza sia stato
bruscamente spezzato. Un inventario più completo di
cui non si può ancora disporre e confronti metodici con-
sentirebbero indubbiamente di formarsi un’idea più pre-
cisa dell’originalità di quel gruppo di artisti. I miti anti-
chi, l’arte antica, vi intervenivano come fattori poetici
costanti. Ma non ci si sentiva più legati a un repertorio
troppo pesantemente archeologico, come quello di Giu-
lio Romano. Si tendeva a selezionare il repertorio, a sot-
tili elaborazioni dell’eredità dei maestri, a sfumature
rare e voluttuose. Questo orientamento generale diven-
ta immediatamente evidente all’esame delle incisioni.
Quasi tutti gli artisti dell’epoca erano in relazione con
incisori, e l’affermarsi della scuola d’incisione romana34
rappresenta un punto essenziale di quegli anni. Raffael-
lo aveva già accolto Marcantonio nella propria bottega
e formato Baviera, l’uno per incidere, l’altro per tirare
le stampe, e niente altro era stato di tanto aiuto per la
diffusione del suo stile. Questo metodo di «pubbliciz-
zare» l’arte attraverso le stampe ha cambiato il corso
della storia artistica e, per di più, ha rafforzato il con-
cetto che avevano gli artisti di Roma di trovarsi al cen-
tro della vita artistica.
Marcantonio lavorò anche con Giulio Romano, non
sempre, come si sa, a opere molto raccomandabili. Lo
scandalo dei «modi disonesti»35 scoppiò dopo la parten-
Storia dell’arte Einaudi 204
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
za di Giulio da Roma, ma procuro gravi noie a Mar-
cantonio che fu imprigionato36 su richiesta di Giberti, e
all’Aretino la cui lite con il Datario si concluse con la
partenza per Venezia nel 1525.
Quest’incidente rimane rivelatore dell’accelerazione
nel libertinaggio avvenuta durante quegli anni di «dolce
vita» di cui Cellini, come più tardi l’Aretino, parleran-
no con la nostalgia dei gaudenti. L’episodio dimostra
anche lo sviluppo della stampa, la sua capacità di trova-
re vie nuove. È possibile che l’erotismo infinitamente
più elegante degli Amori degli dei sia stata una risposta
alla pornografia un po’ pesante di Giulio Romano.
Il grande progresso della incisione durante quei due
o tre anni è dovuto in gran parte allo stesso Clemente.
Data la sua indole di gran signore illuminato, curioso e
sensibile, non fa meraviglia constatare ch’egli godesse la
fama di esperto d’arte. Non si ha nessuna ragione di
dubitare dell’autenticità dell’aneddoto riferito al riguar-
do da Vasari:
Marcantonio, uscito di prigione, finì d’intagliare per
esso Baccio Bandinelli una carta grande, che già aveva
cominciata, tutta piena d’ignudi che arrostivano sulla gra-
ticola san Lorenzo; la quale fu tenuta veramente bella ed è
stata intagliata con incredibile diligenza, ancorché il Ban-
dinello, dolendosi col papa a torto di Marcantonio, dices-
se, mentre Marcantonio l’intagliava, che gli faceva molti
errori; ma ne riportò il Bandinello di questa così fatta gra-
titudine quel merito, di che la sua poca cortesia era degna:
perciocché avendo finito Marcantonio la carta, prima che
Baccio lo sapesse, andò, essendo del tutto avvisato, al papa
che infinitamente si dilettava delle cose del disegno, e gli
mostrò l’originale stato disegnato dal Bandinello, e poi la
carta stampata; onde il papa conobbe che Marcantonio con
molto giudizio avea non solo non fatto errori, ma correttone
molti fatti dal Bandinello e di non piccola importanza, e che
Storia dell’arte Einaudi 205
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
più avea saputo ed operato egli con l’intaglio che Baccio col
disegno; e così il papa lo commendò molto, e lo vide poi
sempre volentieri37.
La stampa è nota38. Corrisponde piuttosto alla for-
mula robusta ereditata da Giulio Romano, che alla
maniera elegante del gruppo del 1525.
Questa maniera si espresse a meraviglia in due serie
di incisioni che rendono perfettamente intelligibile l’o-
rientamento di quei giovani artisti, in quanto la stampa
sprigiona sempre l’essenza degli stili. Gian Jacopo Cara-
glio di Verona lavorava soprattutto con Rosso39; questi
forniva i disegni che Baviera tirava dalle incisioni di
Caraglio. Dall’unione del loro lavoro uscì un registro
voluttuoso e graziosamente frivolo, la serie degli Dei
della Mitologia e quella degli Amori degli dei che fu, se
seguiamo Vasari, interrotta nel mese di maggio, poi com-
pletata sotto l’occupazione da Perino del Vaga, su richie-
sta di Baviera, che ne aveva i diritti di vendita. Si trat-
ta di una delle più raffinate raccolte di incisioni mai ese-
guite: nicchie decorative incorniciano le figure che tutte
prendono la forma «serpentinata», il «contrapposto» o
la veduta di schiena, con una scioltezza e una freschez-
za di tono, una movenza voluttuosa, per cui questo lavo-
ro si distingue fra tutti. Ancora più libera e più immagi-
nosa, la serie degli Amori sviluppa abilmente allaccia-
menti reciproci in cui la complicazione manierista si pre-
sta mirabilmente a mettere in evidenza il gioco erotico40.
Il ruolo di questo Baverio de’ Carocci detto Baviera,
secondo tutte le indicazioni di cui disponiamo, è stato
dunque considerevole per lo sviluppo dell’incisione. Non
soltanto si era imposto nell’ambiente di Raffaello con le
sue iniziative editoriali, ma aveva afferrato così bene le
novità dello stile degli anni 1520 che ne sfruttò ardita-
mente le risorse nel registro profano allora di moda. Se
ha potuto, come tutto sembra lasciarlo credere, conti-
Storia dell’arte Einaudi 206
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
nuare la sua produzione dopo il maggio 1527, questo
avvenne perché ha utilizzato le sue lastre di rame per
una clientela di militari. Disgraziatamente, la primave-
ra del 1527 pose termine a quel periodo notevole. Cara-
glio continuò a lavorare, a viaggiare, ma lontano da
Roma. Marcantonio perdette tutto: «i suoi rami, già
consumati per essere stati adoperati troppo, furono
rubati dai soldati tedeschi e da altri durante il sacco di
Roma»41; tornato a Bologna, non se ne ebbero più noti-
zie, e così neppure del suo collega.
Quanto all’ultimo incisore che ha contato in questo
periodo, il vecchio Ugo da Carpi, questi aveva seguito
la sorte del Parmigianino42 con il quale era venuto a
Roma, e con cui, non appena poté, se ne filò a Bologna;
ma anch’egli, come il Parmigianino, non riuscì a conti-
nuare a lungo la sua attività. Specialista in Italia del
«chiaroscuro», la stampa a due toni, si adoperò a divul-
gare le composizioni religiose dell’amico, rendendo con
estrema fedeltà la flessibilità e anche, se così si può
dire, la fluidità delle forme.
Questo convergere di talenti, d’iniziative e di mezzi
è piuttosto sorprendente e dà significato all’esistenza di
questi gruppi, di queste «compagnie» del 1525. Dopo
tutto quanto abbiamo ricordato, compresi gli esempi
libertini, potremmo essere tentati di considerare Roma
– non dal punto di vista della Curia, ma da quello degli
artisti – come un centro vivace ma poco edificante, e di
concordare con il rimprovero di «paganesimo» a rischio
di estendere a tutto quanto lo stile clementino l’accusa
che Erasmo rivolgeva ai ciceroniani: un compiacimento
per le forme vuote, una sensualità priva di contenuto.
Che ne è dunque della pittura religiosa nella Roma del
1525? Come rendere conto dei due capolavori alquan-
to sconcertanti che ne esprimono le caratteristiche essen-
ziali: il Cristo morto del Rosso, e la Visione di san Gero-
lamo del Parmigianino?
Storia dell’arte Einaudi 207
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Il «Cristo morto» del Rosso.
Il Cristo morto era stato dipinto per il vescovo Tor-
nabuoni di Arezzo, un protetto di Clemente, che, anche
lui, conobbe le traversie del sacco. Ignoriamo per chi fu
dipinta, o per quale chiesa, la seconda opera in causa –
la Madonna con san Giovanni e san Gerolamo del Parmi-
gianino, oggi alla National Gallery di Londra. Entram-
be le opere sono ugualmente utili per illustrare «il
manierismo di Rosso e degli altri giovani artisti di quel
gruppo brillante riunito a Roma, in quei pochi anni edo-
nistici che hanno preceduto il Sacco», per riprendere le
parole di John Shearman43.
È stato spesso attribuito un ruolo di primo piano, per
lo meno in passato, alla personalità di Rosso44. Lo Spo-
salizio della Vergine in San Lorenzo a Firenze (1525) pos-
siede una grazia, una distinzione che provengono da
Michelangelo. Rosso era stato, con Pontormo, l’inizia-
tore a Firenze della scuola della composizione «vertica-
le», di cui non bisogna minimizzare le conseguenze.
Una delle prime incisioni in cui appare questa sovrap-
posizione di figure e lo Sposalizio della Vergine di Cara-
glio; deriva dal pannello di Rosso, ma ha subito molte-
plici trasformazioni. Il registro superiore è al tempo
stesso rialzato e allontanato; due figure intermedie sono
state aggiunte al centro; alcune colonne accentuano l’ef-
fetto ascensionale. Il disegno del Parmigianino, che è
stato messo in relazione con questo pannello e questa
stampa, rivela come il giovane maestro abbia corretto
Rosso, con o senza il suo consenso45. Fatto importantis-
simo, dimostra come i due artisti lavorassero fianco a
fianco, in una specie di rivalità continua.
La venuta a Roma provocò in Rosso uno smarrimen-
to in cui Vasari credette di vedere una legge storica: il
Toscano a Roma è turbato e la sua arte diventa confu-
sa46. La Cappella Cesi di Santa Maria della Pace ne è
Storia dell’arte Einaudi 208
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
forse la dimostrazione: la Creazione di Eva comporta
torsioni fittizie che nella Caduta non appaiono più47. Gli
incontri favoriti dalla nuova corte papale, le conversa-
zioni che dobbiamo immaginare in casa di Valdambri-
ni, dove Rosso brillava per la sua cultura e la sua distin-
zione, gli devono essere stati congeniali, poiché il suo
gusto della raffinatezza complessa si accordava perfet-
tamente con l’orientamento dell’ambiente romano48. Il
Cristo morto, che bisogna datare dal 1525-26, rappre-
senta certamente il culmine di quella evoluzione; non si
può affatto renderne conto senza evocare gli scambi fra
i quattro o cinque artisti favoriti di Clemente. Se ci sfor-
ziamo di ricostituire il dosaggio delicato degli influssi e
delle affinità, che l’esistenza stessa di questo gruppo
invita a immaginare, entriamo nell’intimo di quel che
bisogna pur chiamare il «manierismo clementino»49.
Lo stile lineare e dinoccolato del Rosso cede qui a una
fluidità plastica, a un finito sottile, in cui si tradisce l’at-
taccamento a Michelangelo, quello dei prodigiosi ignu-
di della Cappella Sistina e del Cristo nudo di Santa Maria
sopra Minerva, portato da poco a Roma.
Il tema, che procede da un quadro di Andrea del
Sarto da noi conosciuto soltanto attraverso un’incisio-
ne, contiene un duplice messaggio: da un lato la morte
e resurrezione, ossia il mistero stesso del Cristo della
Passione, e dall’altro l’analogia del corpo del Cristo con
l’Eucaristia, chiamata appunto Corpus Domini. La ten-
denza comune a queste Pietà è la rappresentazione misti-
ca del mistero eucaristico e non soltanto l’immagine
della Passione50. La ineffabile dolcezza del volto, che
sembra sorridere nella morte, giustifica l’attenzione
degli angeli portafiaccole. Sydney Freedberg, a com-
mento di questo quadro scrisse: «Vi è qui una dimo-
strazione del miracolo eucaristico della presenza reale
del Cristo. Ma la presenza qui rivelata ai sensi è descrit-
ta con una sensualità che contraddice un valore più
Storia dell’arte Einaudi 209
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
essenzialmente cristiano del dogma stesso, e la sensua-
lità si confonde con un estetismo che sembra più impor-
tante del significato religioso del quadro»51. Aggiunge-
remo soltanto che questa stessa soavità si accorda con
la convinzione che un accesso al divino esiste anche gra-
zie all’impatto della bellezza pura, bellezza dolce e spi-
rituale come quella degli ignudi della Cappella Sistina;
questa è, secondo noi, la loro vera ragion d’essere52. Lo
stesso avviene per la grazia imprestata all’apparenza ter-
rena del Cristo nel quadro del Rosso.
Il periodo clementino non è durato abbastanza a
lungo perché si possa discernere un’evoluzione signifi-
cativa nell’iconografia religiosa. Ma la tendenza che si
abbozzava sembra emergere con sufficiente vivezza in
quest’opera eccezionale. Il Cristo morto, o meglio Cristo
con angeli, a ragione è apparso a storici recenti come un
capolavoro di anticonformismo, ma anche come l’e-
spressione suprema dello stile «clementino», sia perché
rispecchia un certo tipo di spiritualità – la mistica del-
l’amor divino, che aveva la simpatia e gli incoraggia-
menti del datario Giberti –, sia perché rappresenta il cul-
mine di una lunga elaborazione formale.
La «Madonna» del Parmigianino.
Fra i lavori del Parmigianino a Roma, il Matrimonio
mistico di santa Caterina è quello più squisitamente ela-
borato. Tutti i principî di composizione sono stati abil-
mente modificati in modo da produrre un effetto di
distorsione sorprendente: la Madonna è vista di schie-
na con un profilo sfumato nell’ombra perché per con-
trasto spicchi la faccia della santa, dolce, piena, e l’ele-
gante acconciatura; la mano si dispiega al centro della
composizione, come un oggetto fluttuante in uno spazio
indefinibile, nel quale si apre una porta che incornicia
Storia dell’arte Einaudi 210
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
due visitatori, due testimoni. I colori scivolano sulle
forme dalle molteplici curvature; lo sfondo serve a sepa-
rare l’oculus al di sopra, il drappeggio in alto a destra,
la ruota al di sotto, e del profeta o santo nell’angolo in
basso a sinistra lascia soltanto apparire una testa enig-
matica e pensosa. L’eccentricità raggiunge qui un grado
sconcertante e meraviglioso, che però la Visione di san
Gerolamo supera in sofisticazione e in fascino.
È fuori dubbio che questo lungo pannello sia l’opera
a cui lavorava il giovane pittore al momento dell’in-
gresso delle truppe imperiali nella città.
«Una nostra Donna in aria che legge ed ha un fan-
ciullo tra le gambe; ed in terra con straordinaria e bella
attitudine ginocchioni con un piè fece un san Giovan-
ni, che torcendo il torso accenna Cristo Fanciullo, ed in
terra a giacere in iscorto è un san Girolamo in peniten-
za che dorme»53.
Ogni termine di Vasari sottolinea un paradosso della
composizione attirando l’attenzione su tratti singolari,
come l’aerea sospensione della Madonna (la quale non
legge, ma sembra guardare un libro tenuto dal Bambi-
no), la posizione del Bambino, la linea contorta del Bat-
tista, il sonno inspiegabile di san Gerolamo. Queste
lievi anomalie creano una sorpresa intellettuale che con-
tribuisce in un certo modo all’effetto. Le bizzarrie ico-
nografiche invitano a un esame più attento delle forme.
L’opera è stata così sovente e così felicemente com-
mentata che è come avvolta da elaborate definizioni del
manierismo. Il virtuosismo del pittore si prende osten-
sibilmente gioco delle difficoltà attraverso le perfette
combinazioni proposte e soprattutto attraverso la sua
abilità a sposare i contrari. Non c’è più bisogno di par-
lare di fonti quando queste sono elaborate così brillan-
temente: la composizione è, nel complesso, quella della
Madonna di Foligno di Raffaello, ma la Vergine ricorda
Michelangelo, quantunque la Madonna di Bruges da cui
Storia dell’arte Einaudi 211
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
procede abbia sostituito la sua «terribilità» con una
dignità sognante. Il Bambino ricciuto solleva il braccio
destro e la gamba sinistra in un movimento ironico e
scherzoso che può sembrare strano. Il Battista, piegato
obliquamente, il braccio smisurato puntato all’indietro,
forma una base di sostegno. Si tratta del gesto e della
funzione tradizionale del Battista: non manca la croce
di giunco, e tuttavia il movimento si dispiega in uno spa-
zio dove nulla gli risponde; la sua vivace animazione è
come sottolineata dall’inerzia del santo disteso, forse
una sapiente allusione, pare, a qualche episodio che ci
sfugge piuttosto che puro capriccio dell’artista. Tutti
questi particolari hanno dei precedenti nelle opere di
Correggio: la Madonna con san Sebastiano dipinta per
Modena nel 1524 o 1525 presenta già una forte assia-
lità sottolineata dalla figura cardine di san Gimignano,
sotto alla Madonna54.
L’effetto di verticalità, soluzione già sperimentata
dal Rosso, è spinto all’estremo; la divisione dei due regi-
stri, celeste e terrestre, è ancora accentuata dal cerchio
che racchiude l’apparizione celeste. I disegni prelimina-
ri mostrano quanto la composizione sia stata studiata,
motivo per motivo, prima di raggiungere quel movi-
mento ritmico, teso e insieme aggraziato, che la unifi-
ca55. L’artificio stesso della composizione trova forse
una giustificazione supplementare nel fatto che la visio-
ne soprannaturale appare più reale della figura del dor-
miente che la sogna, e anche del nunzio che la indica
senza guardarla. Mai si era dimostrato più chiaramente
che una pala d’altare è uno spazio per la fantasia; mai i
simboli sono stati elaborati con maggiore sottigliezza.
Se raduniamo le informazioni sparse sugli artisti atti-
rati a Roma sotto il pontificato di Clemente e traccia-
mo un elenco delle opere realizzate in quel breve perio-
do, tenendo presente la diversità dei generi e l’inge-
gnosità dei modi di trattarli, non è più possibile, cre-
Storia dell’arte Einaudi 212
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
diamo, non attribuire a quel momento una certa porta-
ta. Fra l’ultima maniera di Raffaello e il ritorno di
Michelangelo a Roma, il vuoto fu colmato da uno svi-
luppo più sofisticato di quanto si fosse mai visto prima
nell’uno o nell’altro, uno sviluppo che ha consentito a
giovani artisti dall’acuta sensibilità di sfruttare grandi
temi. Se è davvero stato così, allora il sacco, di cui ci
rimane ancora da descrivere l’impatto, fu un accidente
storico che colpì l’arte in profondità tanto quanto con-
dizionò la vita politica dell’Italia, e anche di più in ragio-
ne di quanto ha definitivamente interrotto e capovolto.
Le sciagure.
Nel suo studio sulla peste del Trecento, Millard
Meiss ha dimostrato che un’epidemia catastrofica come
quella del 1348 ha necessariamente due e anche tre con-
seguenze interessanti per le arti56. Prima di tutto ci ricor-
da che gli artisti sono uomini mortali come gli altri e sot-
toposti alle vicissitudini comuni. Periscono o sono cac-
ciati, e questa dispersione può cambiare tutto: la morte
di Pietro Lorenzetti ha modificato la storia della pittu-
ra. Queste sciagure collettive indeboliscono e talvolta
distruggono lo spirito di innovazione. Non c’è più lavo-
ro, o, se ce n’è ancora, tende a obbedire a norme nuove
che saranno, ad esempio, il ritorno a modelli giudicati
più devoti, nella misura in cui lo spirito di penitenza
domina la comunità. A questo seguì un graduale oblio,
poi la ripresa dell’attività, con ogni sorta di movimenti
riequilibratori. A noi interessa scoprire in quale misura
il disastro del maggio 1527 abbia potuto avere un effet-
to analogo.
Le pagine truculente di Cellini ci rendono a meravi-
glia l’impressione di seguire dall’interno della fortezza
l’assedio e il saccheggio57. Dall’alto delle mura inespu-
Storia dell’arte Einaudi 213
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
gnabili, si vedono gli avversari, si odono gli spari e si
aspettano, tra l’andirivieni, dei negoziatori. Della colo-
nia di artisti, gli orafi soltanto, adatti a servire ai pezzi
d’artiglieria, trovarono posto dentro Castel Sant’Ange-
lo. Insieme a Cellini, vi fu Raffaello da Montelupo,
anch’egli scultore e orafo, venuto a Roma su invito di
Lorenzetto nel 1524. Aveva trascorso tre anni in lavo-
ri minuti prima di ritrovarsi in Castel Sant’Angelo con
due pezzi di artiglieria, ad aspettare l’esercito della lega
che doveva venire in soccorso del papa. Più tardi egli
stese dei ricordi di cui abbiamo il manoscritto auto-
grafo. Vi riferisce con semplicità che un amico lo esortò
a fuggire quando si seppe dell’arrivo dei lanzichenecchi,
che fu arruolato per puro caso a sei scudi al giorno, che
vide giungere il papa correndo per i corridoi mentre si
stava alzando il ponte levatoio. Tale era la mischia nei
pressi del castello che era impossibile sparare: pertanto
«eravamo lì a guardare come a una festa»58.
Gli altri artisti, pittori e incisori, rimasero nella città,
dove furono colti di sorpresa dall’arrivo dell’esercito
imperiale. Le loro disavventure, talvolta spaventevoli,
sono state riferite con qualche particolare da Vasari,
che raccolse a Roma, verso il 1540, tutti i possibili rac-
conti sul sacco. Poté parlarne, tra gli altri, con Peruzzi,
con il Rosso, con Perino. La sua opera, apparsa nel
1550, è piena di aneddoti che basta raggruppare per
ricostruire le amare vicissitudini di sedici artisti di primo
piano. Un capitolo da romanzo giallo. Vi furono dei
morti, come l’incisore Marco Dente59. Dei due famosi
decoratori di facciate, Maturino e Polidoro, il primo
volle fuggire, ma fu ripreso e morì, dicono, di peste; il
secondo riuscì a svignarsela verso Napoli. Altri furono
arrestati, malmenati, fatti lavorare come facchini, come
schiavi, sottomessi inoltre all’obbligo di pagare una
taglia alle truppe imperiali. Rovinato, umiliato e senza
scampo, il Rosso dovette, scalzo, trasportare pesanti
Storia dell’arte Einaudi 214
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
fardelli e traslocò la bottega di un salumiere60. Talvolta
fu riservata loro una sorte particolare: Peruzzi, con i suoi
quarantasei anni, e un nobile portamento, fu scambiato
per un prelato grazie alla sua aria dignitosa, il che gli
valse mille fastidi; infine, gli fu ordinato di dipingere un
ritratto di Borbone61. Perino del Vaga aveva moglie e
figli; credette di lasciarci la vita con tutti i suoi beni, ma
invece fu costretto a dipingere guazzi e altre opere
secondo il gusto degli spagnoli62.
Il caso del giovane e bel Parmigianino è eccezionale.
Quasi per miracolo rimase a Roma senza essere infasti-
dito, se seguiamo Vasari come sembra ragionevole fare.
Per tutti gli altri, in quel momento, l’unico problema era
infatti quello di fuggire da Roma a qualsiasi costo, anche
straccioni; alla prima occasione, probabilmente durante
l’estate quando l’epidemia disperse i vincitori nei din-
torni, Peruzzi raggiunse Siena, Rosso Borgo San Sepol-
cro donde si recò a Venezia poi in Francia; Giovanni
Lappoli arrivò, tremante di paura, ad Arezzo; Marcan-
tonio, «ridotto in miseria, avendo perduto tutto e per
di più costretto a pagare una forte tassa, lasciò Roma e
non vi ritornò mai più», racconta Vasari63. Di fatto,
non si sa gran cosa dell’attività di Marcantonio dopo il
1527. Iacopo Sansovino ritornò a Venezia, Giovanni da
Udine nel suo Friuli nativo. Quando Perino del Vaga,
che si trovava in città con l’incisore Baviera, ebbe la pos-
sibilità di essere condotto a Genova, evidentemente non
esitò.
Quanto al Parmigianino, il racconto di Vasari è
straordinariamente preciso. È un classico racconto della
«leggenda aurea» della storia dell’arte, che deve essere
riportato per intero:
Ma quest’opera [la Visione di San Gerolamo] non gli
lasciò condurre a perfezione la rovina ed il sacco di Roma
del 1527; la quale non solo fu cagione che all’arti per un
Storia dell’arte Einaudi 215
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
tempo si diede bando, ma ancora che la vita a molti artefi-
ci fu tolta; e mancò poco che Francesco non la perdesse
ancor egli; perciocché in sul principio del sacco era egli si
intento a lavorare, che quando i soldati entravano per le
case, e già nella sua erano alcuni Tedeschi, egli per rumore
che facessero non si moveva dal lavoro: perché sopraggiu-
gnendoli essi, e vedendolo lavorare, restarono in modo stu-
pefatti di quell’opera, che come galantuomini che doveano
essere, lo lasciarono seguitare. E così mentre che l’impiis-
sima crudeltà di quelle genti barbare rovinava la povera
città, e parimente le profane e sacre cose, senza aver rispet-
to né a Dio né agli uomini, egli fu da que’ Tedeschi prov-
veduto e grandemente stimato e da ogni ingiuria difeso.
Quanto disagio ebbe per allora si fu, che essendo un di loro
molto amatore delle cose di pittura, fu forzato a fare un
numero infinito di disegni d’acquerello e di penna, i quali
furono il pagamento della sua taglia. Ma nel mutarsi poi i
soldati, fu Francesco vicino a capitar male; perché andan-
do a cercare d’alcuni amici, fu da altri soldati fatto prigio-
ne, e bisognò che pagasse certi pochi scudi che aveva di
taglia; onde il zio dolendosi di ciò e, della speranza che quel-
la rovina avea tronca a Francesco di acquistarsi scienza,
onore e roba, deliberò, vedendo Roma poco meno che rovi-
nata ed il papa prigione degli Spagnuoli, ricondurlo a
Parma...64.
Questo racconto, che nessuno ha mai trovato ragio-
ne di mettere in dubbio, si accorda benissimo con quel
che sappiamo del comportamento dei contingenti tede-
schi e spagnoli che infierirono, gli uni dopo gli altri, sulle
stesse vittime. Siamo lieti di apprendere che nell’eser-
cito di occupazione vi furono degli ufficiali amatori d’ar-
te e abbastanza intelligenti per estorcere al giovane pit-
tore disegni a penna e ad acquerello. Due cose, tuttavia,
vanno considerate: prima di tutto l’aneddoto dell’arti-
sta indifferente agli avvenimenti, che lavora mentre il
Storia dell’arte Einaudi 216
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
nemico invade la città, è meraviglioso, ma ci ricorda
qualcosa di noto. Il modello, se vogliamo, possiamo tro-
varlo nel libro XXXV di Plinio. Protogene, al momen-
to dell’assedio di Rodi per opera di Demetrio, lavorava
in un giardinetto fuori della città, ossia in mezzo al
campo nemico; e non s’interrompeva, nonostante l’in-
furiare della battaglia. Quando Demetrio se ne stupì,
Protogene gli rispose che sapeva bene che il re faceva
guerra ai Rodii, non all’arte. Da allora, Demetrio andò
regolarmente a vederlo lavorare. Non intendiamo dire
che il racconto di Vasari sia stato copiato da Plinio, ma
che lo storico ha ideato quello svolgimento edificante
come una controparte della antica saga delle arti. Tutto,
qui, è importante: il distacco del pittore dal mondo e
quella incredibile concentrazione che lo salva dalla cata-
strofe che colpirà gli artisti. Il Parmigianino sembra
essere l’unico, di tutti i pittori di Roma, che se la sia
cavata così bene.
La maggior parte dei sopravvissuti si risollevarono,
chi prima chi dopo, ripresero il loro lavoro e ricevette-
ro di nuovo anche commissioni lusinghiere. Ci fu chi, a
Venezia, si rallegrò del sacco di Roma perché fece ritor-
nare il Sansovino65. Altrettanto si poteva dire per Geno-
va o per Fontainebleau. É questo il rovescio positivo
della catastrofe, ma non si dovrà ciò nonostante trascu-
rare l’impatto degli avvenimenti sulle diverse persona-
lità degli artisti. Vi furono pittori il cui comportamen-
to fortemente alterato colpì i contemporanei; quelli che
R. Longhi ha chiamato le vittime «traumatizzate» del
sacco66.
Vasari, a cui piaceva questo genere di analisi, ha pro-
ceduto a un piccolo studio di psicopatologia. A propo-
sito di Vincenzo Tamagni, un toscano di trentacinque
anni, decoratore di facciate «all’antica» e molto vicino
al Ghirlandaio e a Raffaello, ci riferisce:
Storia dell’arte Einaudi 217
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
perché egli oltremodo dolente se ne tornò alla sua patria San
Gimignano. Là dove, fra i disagi patiti e l’amore venutogli
meno delle cose dell’arti, essendo fuor dell’aria che i
begl’ingegni alimentando fa loro operare cose rarissime,
fece alcune cose, le quali io mi tacerò per non coprire con
queste la lode ed il gran nome che s’aveva in Roma onore-
volmente acquistato. Basta che si vede espressamente che
le violenze deviano forte i pellegrini ingegni da quel primo
obietto e li fanno torcere la strada in contrario67.
Anche se stentiamo a indovinare a quali quadri allu-
de lo storico, non abbiamo difficoltà a credere a quel-
l’irrimediabile calo di qualità in seguito al grave choc psi-
cologico.
Ciò è confermato dal caso, assai più notevole, di
Sebastiano Luciani, alias Sebastiano del Piombo. Cle-
mente, l’abbiamo veduto, gli era legatissimo; non appe-
na innalzato al pontificato, lo chiamò a Roma. Seba-
stiano fece il ritratto del papa nel 1526, bell’esempio di
quello stile romano che precedette il sacco68. Quando a
Roma, nel 1531, la vita riprese quasi normale, Clemen-
te richiamò di nuovo Sebastiano e nell’autunno di quel-
l’anno gli fece dare una delle più gradite prebende vati-
cane, l’ufficio del Piombo. L’artista non aveva ancora
cinquant’anni, ma divenne allora, a quanto pare, il cini-
co più pigro che si fosse mai visto69. (Ciò spiega forse le
osservazioni poco lusinghiere di Tiziano, quando visitò
la Stanza della Segnatura, citate in precedenza). Vasari
racconta tutto questo con molta arguzia, ma allegando
come ragione per l’atteggiamento increscioso di Seba-
stiano la concessione di quella rendita generosa, che gli
permetteva di vivere senza fare nulla. Nella fretta di
condannare le dannose conseguenze di simili benefici,
Vasari ha dimenticato di ricordare la presenza di Seba-
stiano vicino a Clemente nei giorni opprimenti di mag-
gio70, la fuga nella sua città natia, il ritorno che fece
Storia dell’arte Einaudi 218
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
seguito al richiamo del papa, e lo stato di depressione da
lui descritto nella famosa e importante lettera del feb-
braio 1531. «Non mi par esser quel Bastiano che era
avanti il sacco; non posso più tornare in cervello anco-
ra»71. Nella stessa lettera, concludeva: «Dopo essere
passato attraverso il fuoco e l’acqua e aver subito prove
inimmaginabili, ringraziamo Dio e passiamo quel poco
di vita che ci resta in tutta la tranquillità possibile». Si
deve quindi indubbiamente far entrare in conto il «trau-
ma» del 1527 in questa disposizione all’inerzia e all’in-
differenza che ha tanto stupito i contemporanei di Seba-
stiano. Egli visse per altri vent’anni circa; dipinse anco-
ra, e specificamente opere cupe, patetiche, dagli effetti
duri – come la Via Crucis, in parecchie versioni – che
pongono più di un problema72.
Un ultimo caso tipico è quello del croato Giulio Clo-
vio. Egli si trovava al servizio di un cardinale romano;
catturato dagli spagnoli, ebbe talmente paura che fece
voto, nel caso in cui se la fosse cavata, di entrare in con-
vento73. Essendo scampato alle disavventure, andò a
cercare la quiete dello spirito nel monastero di San Ruf-
fino vicino a Mantova, dove per svago imparò l’arte di
miniare i manoscritti. Alcuni anni più tardi, dopo che
in seguito a un incidente dovette curarsi una gamba,
passò al servizio del cardinale Alessandro Farnese che ne
apprezzò il talento di miniatore. Insomma, senza il sacco
non ci sarebbe stato quel piccolo capolavoro sofisticato
della tarda miniatura che sono le Ore Farnese, adesso alla
Pierpont Morgan Library.
Questi aneddoti fanno parte della documentazione.
Più difficile è valutare fino a che punto le traversie del-
l’uomo abbiano o meno agito sullo sviluppo dell’artista.
Ci guarderemo da eccessive semplificazioni. È già
importante osservare che certe persone possono non
essere state toccate dagli eventi e averne evitato il trau-
ma, come accadde al Parmigianino certamente; altri, di
Storia dell’arte Einaudi 219
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
temperamento più nervoso, emotivi, se non addirittura
nevrotici, rivelarono nel modo stesso di condurre la loro
arte un’irritabilità e un’instabilità inquiete, come avven-
ne probabilmente per il Rosso.
C’è un contrasto impressionante fra il Cristo morto e
la Deposizione di San Sepolcro, dipinta alcuni mesi dopo.
Il Rosso, esausto, si era precipitato a San Sepolcro dove
il vescovo Leonardo Tornabuoni, il committente del
Cristo e angeli, si era appena rifugiato «anch’egli fug-
gendo il sacco». Là tutti quanti si adoperarono per faci-
litare le cose al Rosso, e Raffaello dal Colle gli cedette
l’esecuzione della pala dei Battuti per la chiesa di Santa
Croce. In questa Deposizione, Vasari ha rilevato la inso-
lita particolarità dell’effetto di tenebre in occasione della
morte del Cristo74. La si può accostare all’accento lugu-
bre delle Pietà dipinte da Sebastiano alcuni anni dopo.
Un simbolismo semplice, quasi elementare, interviene
qui per mescolare un senso di lutto personale, di reale
tristezza, alla rappresentazione tradizionale e devota
della morte. Occorre spingerci più oltre? I quadri dipin-
ti dal Rosso nel 1528 e 1529 sono discordanti e confu-
si tanto che vi si scorge un nervosismo mal controllato,
una strana mancanza di capacità tecnica. Si può fare,
forse, un altro esempio. Polidoro, rifugiato a Napoli,
non sognava che di tornare a Roma75. Si sa che nel 1528
era stato a Messina, dove dipinse una Salita al Calvario
sovraffollata e disordinata che testimonia, nella sua vee-
menza, la condizione del pittore, perché si è lontani
dallo stile controllato di Roma.
La sorte ha voluto che il pittore scoperto da Clemente
VII fosse ancora in rapporto con il papa nell’ultimo
grande atto politico della sua vita. È infatti a Bologna,
ossia là dove si era rifugiato il Parmigianino, che ebbe
luogo l’evento decisivo della venuta di Carlo V in Italia
e la sua incoronazione. Parmigianino eseguì a memoria
il ritratto dell’imperatore, opera di una sconcertante
Storia dell’arte Einaudi 220
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
freddezza (conosciuta per mezzo di un duplicato che in
realtà sembra sia una copia). Per suggerimento del papa,
il quadro fu presentato all’imperatore che l’avrebbe
tenuto se il pittore non se lo fosse riportato via per
aggiungere qualche tocco finale76. Un altro quadro,
dipinto per l’Aretino, fu offerto al papa in occasione
della sua visita. Si tratta di una delle Madonne più sor-
prendenti – e per molti la più scandalosa – che sia mai
stata dipinta77. La sua dignità nell’eleganza, il suo fasci-
no nella mondanità, sono stati commentati ampiamen-
te. Un autore della fine del xviii secolo ha anche diffu-
so la voce che si tratterebbe di una Venere e Cupido fret-
tolosamente trasformata – battezzata, se così possiamo
dire – per essere offerta al papa. Qualcuno l’ha consi-
derata un esempio di prodigiosa disinvoltura, quasi il
pittore non conoscesse la buona educazione. La figura
di Maria è sempre stata lo spunto per un’immagine leg-
giadra; forse non se ne attendeva un profondo senti-
mento religioso, ma piuttosto un omaggio alla bellezza,
confusa qui con un’immagine di eleganza. Qualcosa
quindi sopravviveva dello stile clementino, per lo meno
in Emilia.
Il rifugio veneziano.
Non è senza interesse considerare i confini della «dia-
spora» degli artisti. Gli uni, come Polidoro, hanno colto
l’occasione di raggiungere città «imperiali» come Napo-
li; ma, una volta arrivata fin là la guerra, dovette rag-
giungere la Sicilia. Perino salì a Genova, città alleata dei
francesi, ma il voltafaccia di Doria sul finire del 1529
ne fece una città imperiale, il che non cambiò nulla né
nei lavori né, beninteso, nelle disposizioni dell’artista.
Taluni abbandonarono le proprie case, ma, per ragioni
diverse, non si trattennero lontani a lungo, come Rosso.
Storia dell’arte Einaudi 221
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Il rifugio immediatamente ricercato dagli artisti e
dagli intellettuali più celebri, fu Venezia. Ciò che ha per-
messo a questa città di rappresentare tale ruolo saluta-
re non è affatto oscuro, data l’altalena politica del Cin-
quecento; ma possiamo chiederci che cosa gli emigrati
sperassero di trovarvi. L’Aretino vi si era stabilito nel-
l’inverno 1526-27; Serlio, sopravvissuto al sacco, fu
subito assunto per pubblicare degli inventari di edifici
romani78. Sansovino, quando decise di passare al servi-
zio del re di Francia, venne trattenuto dalla Serenissi-
ma79, mentre non fu così per il Rosso Fiorentino. Se si
aggiunge che nel medesimo anno Adrian Willaert diven-
tava maestro di coro in San Marco, sembra quasi che la
repubblica di Venezia stesse elaborando una «politica
culturale» per trarre beneficio dalle difficoltà che incon-
travano talune personalità di spicco – non i pittori, ma
gli architetti e i musicisti. Grazie a Serlio, che lo ha rin-
graziato nella prefazione al suo Libro IV del 153780,
sappiamo che il responsabile di queste iniziative fu
Andrea Gritti81, il quale manifestò chiaramente la pro-
pria ambizione di fare di Venezia la «nuova Roma». Il
tono degli elogi si sarebbe modificato in questo senso:
l’onore dell’Italia consisteva adesso in Venezia.
1
p. giovio, Ragionamento sopra i moti e disegni d’arme e d’amore...,
Venezia 1556, p. 33. Più recentemente ferry, «Candor illaesus», cit.,
pp. 676 sgg.
2
Tre medaglie, riprodotte in bonannus, Numismata Pontificum
Romanorum, Roma 1960, XII, XIII e XIV, e commentate alle pp.
195 e 196, riproducono questa impresa: su una di queste versioni la
tiara appare al di sopra della pila medicea. Bonannus cita Tipotius:
«Voluit Clemens integritatem suam ab injuriis Fortunae et hominum
vindicare, incendium Urbis quod in arbore apparet, majori vi quam
humanae tribuens et invidia qua illa flagrabat se esse superiorem in
lucida imagine ostendens». Ercole Tasso vi scorse un atto di vanità
orgogliosa.
Storia dell’arte Einaudi 222
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
3
Come ha ricordato w. hecksher, Emblem, Emblembuch, in Real-
lexicon zur deutschen Kunstgeschichte, vol. V (1967), col. 142.
4
Se si fa l’accostamento con i disegni ben noti di Leonardo che obbe-
discono al medesimo schema generale: centro solare, raggi rifratti, ogget-
to incendiato, si discernono tre fenomeni: l’attraversamento a sfera di
cristallo, la concentrazione dei raggi su un punto di combustione, la dif-
frazione dello spettro in colori primari. Candor illesus sottolinea il fatto
che il vetro rimane intatto, mentre i rami s’infiammano e – secondo Gio-
vio – accentua l’immunità del bianco: le cose candidissime. Come al soli-
to si ha a che fare con tutto un prisma di concetti.
5
Sulle grandi speranze fondate sul pontificato di Clemente VII, cfr.
von pastor, Storia dei papi cit., vol. IV, parte Il, libro III, pp. 159-61.
6
Le lettere di Michelangelo Buonarroti, a cura di G. Milanesi, Firen-
ze 1875, p. 123, n. ccclxxx, lettera del novembre 1523.
7
cellini, La vita cit., cap. xxiii. È allora che Benvenuto fu pre-
sentato al papa (verso il 1523-24).
8
p. bembo, Prose della volgar lingua, a cura di C. Dionisotti, in P.
Bembo, Prose e rime, Torino 1971, pp. 39 sgg.; m. vitale, La questio-
ne della lingua, Palermo 1960; f. foffano, Prose filologiche. La questione
della lingua, Firenze 1908; ried. Firenze 1961.
9
j. shearman, Mannerism, Harmondsworth 1967, pp. 38-39.
10
f. berni, Poesie e prose, a cura di E. Chiorboli, Firenze 1934,
p. 283.
11
[Non perché sapesse suonare la lira; secondo la leggenda, il suono
della sua lira teneva insieme le pietre delle mura di Tebe].
12
Cfr. von pastor, Storia dei papi cit., vol. IV, parte II, libro III,
p. 161, che cita la lettera di Albergati, da Roma del 7 dicembre 1523:
«Tutta Firenze concorre qua».
13
La vita cit., cap. 26, dove Cellini fornisce il quadro della «dolce
vita» degli artisti: banchetti, balli mascherati, galanterie...
14
vasari, Le vite, cit., V, pp. 603-4.
15
Ibid., p. 600. Cfr. a. popham, On Some Works by Perino del Vaga,
in «The Burlington Magazine», 86 (1945), pp. 56 sgg.; a. griseri, Peri-
no, Machuca, Campaña, in «Paragone», n. 87 (1957), pp. 13-21; freed-
berg, Painting in Italy cit., pp. 140-41; più recentemente: j. shearman,
An Episode in the History of Conservation: the Fragments of Perino’s
Altarpiece from S. Maria sopra Minerva, in Scritti di storia dell’arte in onore
di Ugo Procacci, Milano 1977, vol. II, pp. 356 sgg.
16
c. de tolnay, The Medici Chapel, Princeton 1948, p. 9.
17
freedberg, Painting in Italy cit., pp. 114-15.
18
vasari, Le vite cit., VI, p. 10. Questo passo ha attirato l’atten-
zione di briganti, Manierismo cit.; e freedberg, Painting in Italy cit.,
p. 319.
19
vasari, Le vite cit., V, p. 222.
Storia dell’arte Einaudi 223
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
20
cellini, La vita cit., cap. xxx: «Di già era quasi cessata la peste,
di modo che quelli che si ritrovavano vivi molto allegramente l’un l’al-
tro si carezzavano. Di questo ne nacque una compagnia di pittori, scul-
tori, orefici, li meglio che fussino in Roma; ed il fondatore di questa
compagnia si fu uno scultore domandato Michelagnolo. Questo Miche-
lagnolo era Sanese...».
21
vasari, Le vite cit., VI, pp. 10 sgg. Lappoli dipinse tuttavia una
Madonna per Clemente, su ordinazione di Valdambrini. Cfr. anche
freedberg, Painting in Italy cit., pp. 64 sgg. e 319-20.
22
«Essendo poi creato pontefice Giulio cardinal de’ Medici che fu
chiamato Clemente settimo, fece intendere a Sebastiano per il vesco-
vo di Vasone [Girolamo da Schio, vescovo di Vaison] ch’era venuto il
tempo di fargli bene e che se n’avederebbe all’occasione» (vasari, Le
vite cit., V, p. 575).
23
Ibid., pp. 575-76. Quanto di questo ritratto rimane è così rovi-
nato che non si può dire se si tratti di una copia o dell’originale (Arez-
zo, Palazzo del Comune). Cfr. pallucchini, Sebastian Viniziano cit.,
p. 65 e tav. 64.
24
pallucchini, Sebastian Viniziano cit., pp. 58 sgg. Sulla qualifica
dello stile: freedberg, Painting in Italy cit., p. 150. In attesa della pub-
blicazione dell’opera su Sebastiano, cfr. gli studi di m. hirst, tra i quali
Sebastiano’s Pietà for the Commendador Mayor, in «The Burlington
Magazine», 114 (1972), pp. 585 sgg.
25
vasari, Le vite cit., V, pp. 155, 218-19, 221-22. Cfr. il catalogo
della mostra Le triomphe du Maniérisme européen, Amsterdam 1955, n.
88 (con bibliografia). Offerto al papa, il ritratto fu da questi donato all’A-
retino e passò poi all’incisore Valerio Belli che lo vendette nel 1560 allo
scultore Vittoria. Nel 1608 costui lo donò all’Imperatore Rodolfo II.
26
Su questo problema cronologico fondamentale, cfr. m. brugno-
li, Gli affreschi di Perino del Vaga nella Cappella Pucci, in «Bollettino
d’Arte», 47 (1962), pp. 327350; b. davidson, Early Drawings by Peri-
no del Vaga, in «Master Drawings», 1 (1963), n. 3, p. 14; freedberg,
Painting in Itaty cit., p. 150 e nota 57, p. 487.
27
vasari, Le vite cit., V, p. 611: «Talmente andò in lungo questa
pratica che l’anno 1527 venne la rovina di Roma che fu messa quella
città a sacco».
28
Ibid., VI, p. 150: «Mentre che Roma ridendo si abbelliva delle
fatiche loro». Questa frase sembra fare eco al passo sulla miniatura,
citato da Vasari stesso nella vita di Giotto.
29
Più di recente marabottini, Polidoro da Caravaggio cit., I, cap.
xi, pp. 102-35, e catalogo pp. 351-76.
30
freedberg, Painting in Italy cit., p. 146.
31
g. p. lomazzo, Idea del Tempio della Pittura (1590), a cura di R.
Klein, Firenze 1974, vol. 1, p. 1131.
Storia dell’arte Einaudi 224
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
32
marabottini, Polidoro da Caravaggio, I, pp. 99, 135-49; r. a. tur-
ner, Two Landscapes in Renaissance Rome, in «The Art Bulletin», 43
(1961), pp. 275-87.
33
[In scavi romani quali ad esempio la Domus Aurea di Nerone,
dove gli allievi di Raffaello andavano a studiare le pitture parietali, note
più tardi con il nome di «grottesche»].
34
Cfr. m. pittaluga, L’incisione italiana del Cinquecento, Milano
[1930].
35
[Marcantonio incise sedici tavole dei disegni pornografici di Giu-
lio Romano sulle posizioni sessuali, destinati a illustrare i Sonetti lus-
suriosi dell’Aretino].
36
vasari, Le vite cit., V, p. 418. Marcantonio fu rapidamente libe-
rato per le istanze del cardinale Ippolito de’ Medici e di Baccio Ban-
dinelli.
37
Ibid.
38
B. 104, Museo di Providence. Il disegno di Bandinelli, al Lou-
vre, Inv. 99. Cfr. b. f. davidson, Marcantonio’s Martyrdom of S. Loren-
zo, in «Bulletin Rhode Island School of Design», 47 (1960-61), pp. 1-6;
m. g. ciardi-dupré, Per la cronologia dei disegni di Baccio Bandinelli fino
al 1540, in «Commentari», 17 (1966), pp. 146 sgg. Vedi anche il cata-
logo Italienische Zeichnungen, München 1977, n. 5.
39
Dal 1524 al 1527 Caraglio lavorò anche per il Parmigianino; cfr.
a. e. popham, Catalogue of Drawings by Parmigianino, New Haven
1971, pp. 11-12. Sulle sue relazioni con Ugo da Carpi, ibid., I, pp.
12-17.
40
Si tratta di mettere d’accordo le due affermazioni di Vasari: 1)
nella Vita di Marcantonio, V, p. 425: «Avendo poi il Baviera fatto dise-
gnare al Rosso per un libro venti Dei posti in certe nicchie con i loro
instrumenti, furono da Gian Jacopo Caraglio intagliati con bella gra-
zia e maniera, e non molto dopo le loro trasformazioni. Ma di queste
non fece il disegno il Rosso se non di due, perché venuto col Baviera
in differenza, esso Baviera ne fece fare dieci a Perino del Vaga; le due
del Rosso furono il ratto di Proserpina e Fillarre trasformato in caval-
lo [in realtà Saturno e Filira]»; 2) nella Vita di Perino, p. 611: «[duran-
te il sacco] fra tanti il Baviera che teneva le stampe di Raffaello, non
aveva perso molto, onde per l’amicizia ch’egli aveva con Perino, per
intrattenerlo gli fece disegnare una parte d’Istorie, quando gli dei si tra-
sformano per conseguire i fini de’ loro amori. I quali furono intagliati
in rame da Jacopo Caraglio eccelente intagliatore di stampe».
La serie degli Dei: B. 24-43, tra cui Saturno, 1526, firmato «Jaco-
bus Caralius Veronensis»; la serie degli Amori degli Dei: B. 9-23. Il dise-
gno di Perino per Vertumno e Pomona è conservato al British Museum.
41
vasari, Le vite cit., V, p. 414.
42 l. servolini, Ugo da Carpi, Firenze 1977, p. 10.
Storia dell’arte Einaudi 225
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
43
Sul Cristo Morto, cfr. j. shearman, The «Dead Christ» by Rosso
Fiorentino, in «Boston Museum Bulletin», 64 (1966), pp. 148-72.
44
w. friedlander, Die Entstehung des antiklassischen Stiles in der ita-
lienischen Malerei um 1520, 1925.
45
È necessario supporre che «Rosso avrebbe dato un disegno del
suo album a Francesco con il permesso di rielaborarlo per Baviera»?
(s. freedberg, Parmigianino, His Works in Painting, Cambridge [Mass.]
1950, p. 65).
46
a. chastel, «L’aria»: théorie du milieu à la Renaissance, 1973,
ristampato in Fables, Formes, Figures cit., p. 395.
47
m. hirst, Rosso, a Document and a Drawing, in «The Burlington
Magazine», 106 (1964), pp. 120 sgg.; freedberg, Painting in Italy cit.,
p. 130.
48
Pertanto è difficile vedere in Eliézer e Rebecca e Le figlie di Jetro,
opere romane, come propone brugnoli, Gli affreschi di Perino del Vaga
cit., e come rifiuta di fare, giudiziosamente a nostro avviso, hirst,
Rosso cit.
49
Non possiamo che riprendere, riassumere e confermare a modo
nostro le indicazioni di j. shearman, «Maniera» as an Aesthetic Ideal,
in «Studies in Western Art. Acts of the XXth International Congress
of the History of Art», 1961, Princeton 1963, pp. 200 sgg., ristam-
pato in Renaissance Art, a cura di C. Gilbert, New York 1970, pp. 182
sgg., in particolare: «If the germ of Mannerism exists in the High
Renaissance and the seeds were sown in the second decade, the vital
place of its growth is in Rome between the death of Raphael and the
Sack» (p. 203).
50
Secondo l’eccellente osservazione di hartt, Power and the Indi-
vidual cit., p. 229.
51
freedberg, Painting in Italy cit., p. 131.
52
a. chastel, Les «ignudi» de Michel-Ange, 1975, in Fables, Formes,
Figures cit., pp. 273 sgg.
53
c. gould, The Sixteenth Century Italian Schools, London 1962, pp.
131 899. Si può ammettere che sia stato l’andamento del suo raccon-
to a indurre Vasari (Le vite cit., V, p. 225) a dichiarare l’opera incom-
piuta. L’edizione del 155o cita Lorenzo Cibo come «committente»;
quella del 1568 rettifica parlando del ritratto di Cibo e dell’ordinazio-
ne della Nostra Donna in aria fatta da Maria Bufolini, il che concorda
con la presenza dell’opera nella famiglia Bufolini nel xviii secolo.
54
Museo di Dresda. L’opera ha molto sofferto. La data general-
mente accettata è il 1525, avendo Anselmi tratto partito dalla compo-
sizione nella cattedrale di Parma nel 1526. Cfr. a. c. quintavalle, L’o-
pera completa del Correggio, Milano 1970.
55
freedberg, Parmigianino cit., p. 74.
56
meiss, Painting in Florence and Siena cit.
Storia dell’arte Einaudi 226
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
57
cellini, La vita cit., 1, capp. xxxiv-xxxviii.
58
raffaello da montelupo, La vita, a cura di G. Gaye, 1840, n.
cccclxiii, pp. 581-598.
59
Nell’orazione funebre di Luca Longhi di Ravenna (1580), V. Car-
rari parla di Marco Dente «intagliatore di meravigliosa, anzi unica
eccellenza…, ammazzato, con gran perdita di quest’arte, nel Sacco di
Roma». Citato da a. petrucci, Una vittima del Sacco di Roma, in «Il
Messaggero», 17 marzo 1959, p. 3.
60
vasari, Le vite cit., V, pp. 150-162. Sul viaggio a Napoli di Poli-
doro, cfr. marabottini, Polidoro da Caravaggio cit., pp. 149-50.
61
Peruzzi era da più di vent’anni a Roma. Aveva ricevuto nel 1520
l’incarico di dirigere i lavori di San Pietro, che procedevano sempre a
rilento. Era stato lui ad organizzare l’apparato dell’incoronazione del
1524. Non se la cavò molto bene, riferisce Vasari (ibid., IV, pp. 601-2):
«Quando sopravvenne l’orrendo sacco di Roma, il povero Balthazar
rimase prigioniero degli spagnoli: non perdette soltanto tutti i suoi beni
ma inoltre subì molti cattivi trattamenti perché, siccome aveva un
aspetto imponente, nobile ed elegante, lo credevano qualche prelato tra-
vestito o un personaggio adatto a pagare una grossissima taglia. Dopo
che quei barbari empi ebbero finalmente scoperto che era soltanto un
pittore, uno di essi, molto legato a Borbone, gli fece fare il ritratto di
quello scellerato capitano, nemico di Dio e degli uomini, sia che gli
abbia fatto vedere il cadavere, sia che glielo abbia descritto con dise-
gni e parole.
«Uscito dalle loro mani, Balthazar [Baldassarre] si imbarcò per
Porto Ercole e per Siena, ma per istrada fu svaligiato e spogliato di
tutto; giunse a Siena in camicia. Accolto con riguardi dai suoi amici,
che lo riequipaggiarono, ricevette ben presto uno stipendio pubblico
per occuparsi delle fortificazioni della città».
62
Ibid., V, p. 61
63
Ibid., p. 419.
64
Ibid., p. 225.
65
«Ecco, dal male del Sacco di Roma è pur uscito il bene, che in
questo luogo di Dio fa la vostra scultura e la vostra architettura», scri-
ve l’Aretino il 20 novembre 1537 (Lettere sull’arte di Pietro Aretino, I,
p. 81).
66
r. longhi, Ricordo dei manieristi, in «Approdo», 1, 1953, pp.
55-59, ripreso in Da Cimabue a Morandi, Milano 1973, p. 731: «Non
vorrei trarre oroscopi artistici, come oggi è di moda, da avvenimenti e
calamità varie del tempo; ma se di più d’uno dei «manieristi» si sa per
certo che a Roma lavorò con lo stocco dei lanzichenecchi alle costole;
di qualche altro che si salvò fuggendo (quando non ci rimise la buccia),
quasi si vorrebbe chiamarli dei “traumatizzati” del sacco di Roma».
67
vasari, Le vite cit., IV, pp. 491-92.
Storia dell’arte Einaudi 227
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
68
Napoli, Capodimonte.
69
vasari, Le vite cit., V, pp. 576 sgg. La rendita era di 8o ducati
all’anno. «Quest’uomo aveva tanto piacere in stare ghiribizzando e
ragionare, che si tratteneva i giorni interi per non lavorare; e quando
pur vi si riduceva, si vedea che pativa dell’animo infinitamente». Vasa-
ri aggiunge che Sebastiano era «tutto faceto e piacevole... e nel vero
non fu mai il miglior compagno di lui».
70
Dei brutti giorni del 1527 si ha una singolare lettera indirizzata
all’Aretino: «Bastiano pittore al divino signor Pietro Aretino. Compa-
re, fratello e padrone, è pur vero che i Pietri Aretini bisogna che ci
naschino; io dico ciò che ha detto il disperato Papa Clemente in Castel
Sant’Angelo. Sua Santità ha fatto imporre a tutti i dotti che faccino una
lettera allo Imperatore, raccomandando alla maestà sua Roma, ogni di
saccheggiata peggio che prima. E il Tebaldeo, insieme con gli altri, ser-
ratisi per tal cosa in gli studi, hanno fatto presentare le lor lettere a
nostro signore, il quale, lettone quattro versi per una, le gettò là, con
dire che da voi solo era materia tal soggetto; in fine egli vi ama, e assai
assai. E un di qualche cosa sarà, al dispetto degl’invidiosi, pur sanità.
Di Roma nel ’27» (g. bottari e s. ticozzi, Raccolta di lettere sulla pit-
tura, scultura ed architettura, Milano 1822-25, p. 188, n. lxxxvi).
71
milanesi, Les Correspondants de Michel-Ange cit., p. 38.
72
Cfr. i. fenyö, Der Kreuztragende Christus Sebastiano del Piombo’s
in Budapest, in «Acta Historiae Artium», i, (Budapest 1953), pp. 151
sgg. Si può trascurare lo studio di e. larsen, A Contribution to Seba-
stiano del Piombos Changing Conception of «Christ carrying the Cross»,
in «L’Arte», 59 (1960), pp. 209 sgg.
73
vasari, Le vite cit., VII, p. 558.
74
Ibid., V, p. 163: «È cosa molto rara e bella, per avere osservato
ne’ colori un certo che tenebroso per l’eclisse che fu nella morte di Cri-
sto...» Sulla Deposizione di Borgo San Sepolcro, cfr. k. kusenberg, Le
Rosso, Paris 1931, pp. 31 sgg.
75
vasari, Le vite cit., V, p. 151. marabottini, Polidoro da Cara-
vaggio cit., cap. xiv.
76
f. bologna, Il Carlo V del Parmigianino, in «Paragone», n. 73
(1956), pp. 3-16.
77
La Madonna dalla rosa, Museo di Dresda. Cfr. freedberg, Par-
migianino cit., pp. 80-81 e 181-82.
78
l. olivato, Per il Serlio a Venezia: documenti nuovi e documenti
rivisti, in «Arte Veneta», 21 (1967), pp. 284 sgg., ha pubblicato il testa-
mento redatto da Serlio il 1° aprile 1528, nel momento in cui, giunto
a Venezia gravemente ammalato, credette opportuno dettare le sue ulti-
me volontà. Dovette ristabilirsi abbastanza presto poiché il 1° set-
tembre dello stesso anno presentava al Senato la domanda di «copyri-
ght» per le sue tavole di architettura, pubblicata da d. howard, Seba-
Storia dell’arte Einaudi 228
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
stiano Serlio’s Venetian Copyright, in «The Burlington Magazine», 115
(1973), pp. 512 sgg.
79
d. howard, Jacopo Sansovino: Architecture and Patronage in Renais-
sance Venice, New Haven 1975.
80
s. serlio, Regole generali di Architettura sopra le cinque maniere
de gli edifici..., Venezia 1537, libro IV, p. 111: «In Venetia ricetto di
tutto il ben humano e divino, il Sereniss. et non mai apieno lodato
Principe, messer Andrea Gritti, ha condotto al servigio de la sua incli-
ta Republica questi singular huomini, che così fanno stupenda questa
città di nobili, et d’artificiosi edifici come la fece Dio mirabile di natu-
ra e di sito...».
81
Per la nozione della nuova Roma, cfr. d. s. chambers, The Impe-
rial Age of Venice. 1380-1580, London 1970, pp. 12-32.
Storia dell’arte Einaudi 229
Capitolo sesto
Riparazione pontificia, trionfo imperiale
Il 6 ottobre 1528, Clemente rientro a Roma con una
scorta di fanteria e di cavalleria1. Per sei mesi la caput
mundi non era stata che un fantasma di città. I Tercie-
ros spagnoli, la fanteria italiana e la cavalleria avevano
lasciato Roma definitivamente la domenica 16 febbraio;
i lanzichenecchi l’indomani. L’esercito imperiale rag-
giungeva Napoli, dove la guerra si sarebbe riaccesa con
l’arrivo dei francesi di Lautrec e il blocco del porto da
parte di Doria. Quest’ultimo episodio, che a un certo
momento sembrò avere esito incerto, confermò, con la
decimazione degli assedianti, la morte di Lautrec e la
defezione dei genovesi, il trionfo degli imperiali.
Il 6 ottobre c’era un temporale sulla città, tutte le
relazioni diplomatiche lo ricordano2. Il primo atto del
pontefice fu di recarsi a San Pietro che aveva lasciato a
precipizio e in mezzo al frastuono delle armi esatta-
mente diciassette mesi prima. Le misure prese per rimet-
tere un po’ d’ordine – quelle che concernevano l’ali-
mentazione e l’igiene – e, specialmente per porre fine
alle rappresaglie contro i sudditi imperiali negli Stati
della Chiesa, sono state ampiamente commentate; dimo-
strano che Clemente poteva essere un principe avvedu-
to e capace.
Meno attentamente è stata esaminata la natura delle
reazioni specifiche del pontefice e dei suoi alla situazione
spirituale e morale del momento. A Roma, «l’autorità e
Storia dell’arte Einaudi 230
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
la dignità di Sua Santità traspaiono meglio che in qual-
siasi altro luogo». I cardinali furono richiamati il 14
ottobre. Tutti, e specialmente gli inviati dell’imperato-
re, osservavano che anche fra quanti in precedenza lo
avevano sostenuto, era sopravvenuto un mutamento.
Evidentemente le milizie imperiali avevano lasciata die-
tro di sé una diffidenza irreparabile, non soltanto a
Roma ma in tutto il Lazio, dove avevano imperversato3.
Intorno alla città, un certo numero di borgate, di chie-
se e di conventi, si rallegrarono di essere sfuggite alla
devastazione da parte dei soldati a cavallo grazie alla
protezione celeste e, quindi, furono fatte offerte di rin-
graziamento, ad esempio alla chiesa di Frascati. Nella
chiesa della Madonna della Quercia vicino a Viterbo, si
trova un dipinto del chiostro dove si vede l’esercito di
Borbone che passa al largo dalla citta4.
La lettera indirizzata da Clemente VII il 24 ottobre
all’imperatore da un quadro esatto della situazione:
Dovremmo rallegrarci dopo un tale naufragio e benché
spoglio di tutto, di essere giunto in porto; ma il nostro dolo-
re per la rovina dell’Italia, visibile a tutti gli sguardi, e
soprattutto per la miseria di questa città, la nostra stessa
sventura, sono stati aumentati dall’aspetto di Roma. Ci
resta l’unica speranza di poter sanare le numerose ferite del-
l’Italia e della Cristianità, con i mezzi che tu ci offri, e di
risuscitare questa città con la nostra presenza e quella della
Curia, perché, figliolo amatissimo, non abbiamo più davan-
ti ai nostri occhi, che un cadavere a brandelli, e niente può
moderare il nostro dolore, niente può risollevare questa
infelice città e la Chiesa, tranne la speranza della pace,
della tranquillità, che dipende unicamente da te5.
L’Italia è un essere ferito, Roma un «cadavere a bran-
delli». Dopo la partenza dei lanzichenecchi e degli spa-
gnoli, la vita non era tornata alla normalità. Il popolo
Storia dell’arte Einaudi 231
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
aspettava un segnale, il ritorno del papa e della Curia,
non solo per riparare i guasti e porre fine ai saccheggi,
ma per ridare ai giorni, alle settimane, il tradizionale
ritmo di attività. Dal 1527 si diceva la messa soltanto
nella chiesa dei Tedeschi, Santa Maria dell’Anima, e in
quella degli Spagnoli, San Pietro in Montorio. La ricom-
parsa di Clemente e la sua volontà di «restaurare» la
città furono decisive. Ma non abbiamo – o non siamo
riusciti a ritrovare – particolari sufficienti sulle azioni
intraprese allora dai romani. La città aveva perduto
almeno la metà dei suoi abitanti. L’epidemia infettiva,
restava, naturalmente, latente, e riprendeva a infuriare
con il ritorno del caldo. Si cominciava appena a respi-
rare quando la terribile e scoraggiante piena del Tevere
dell’autunno 1530 ripiombò i romani nella desolazione:
l’accanimento della sorte, interpretato come un nuovo
avvertimento del cielo, provocò manifestazioni più vio-
lente di disperazione, e insieme, come abbiamo veduto,
lo strano sforzo di Egidio da Viterbo per interrogare la
Cabala6.
È sempre sorprendente e, se vogliamo, rassicurante
osservare l’ostinazione testarda con la quale le società
umane superano i peggiori disastri. Era improbabile non
rimanere colpiti dalla coincidenza di una data ricorren-
te dello stesso giorno del mese: 6 maggio (assalto), 6 giu-
gno (capitolazione), 6 dicembre (evasione del papa), 6
ottobre (1528, suo ritorno a Roma)7. In circostanze tra-
giche, accadimenti e simboli assumono un’importanza
vitale, e ancora di più in una città, che, nota al mondo
come un insieme di grandi nomi e di grandi eventi,
aveva appena conosciuto la più straziante umiliazione
della sua storia. Nel caos di Roma qualsiasi atto del
pontefice diventava significativo. La prima grande ceri-
monia ufficiale fu, nel novembre, la processione per
celebrare il ritorno delle reliquie, di cui si e parlato in
precedenza8. I testimoni essenziali della sacralità di
Storia dell’arte Einaudi 232
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Roma si ritrovavano di nuovo al loro posto, e assume-
vano una maggiore importanza in quanto tutti sapeva-
no a quali sacrilegi fossero stati esposti. Nella basilica di
San Pietro, tuttora incompleta, dove i lavori erano stati
interrotti, e non c’era neppure da discutere di ripren-
derli e, tanto meno, di portarli a termine, – l’ostensio-
ne della Veronica ridiventava possibile, se i pellegrini
fossero tornati9.
Non se ne parlò per lungo tempo. Il lento sfascio del-
l’esercito della Lega e l’installarsi delle forze imperiali
in Lombardia, a Genova, a Napoli, continuavano a tene-
re l’intera penisola in uno stato di confusione e di abbat-
timento a cui esisteva ormai un solo rimedio: la sotto-
missione diretta o indiretta all’autorità imperiale, di cui
i pronostici e le profezie proclamavano con sempre mag-
giore sicurezza il dominio universale10. Un epigramma
sarcastico circolava nel 1528: «Septimus inferior Quin-
to, quis credat? habetque imperium Quintus, Septimus
exilium»*11. Non si trattava di riprendere le strade verso
la Città Eterna finché il nuovo equilibrio dei poteri non
fosse stato chiarito. Ci vollero altri due anni: ma nel frat-
tempo continuarono le sventure.
Innanzi tutto, la malattia del papa. Il 10 gennaio
1529, lo si considerò perduto. In quel «momento della
verità» la gente che l’aveva tanto disprezzato e svilla-
neggiato, sembrava manifestargli il suo favore: si capi-
va bene ch’egli era la sola difesa contro il dominio tota-
le dell’imperatore e dei suoi alleati12. Clemente non cele-
brò la messa di Pasqua, ma, già fuori pericolo, impartì
la benedizione tradizionale urbi et orbi da San Pietro. Gli
avvenimenti si sviluppavano implacabili. A Firenze, che
fin dal maggio 1527 non riconosceva più l’autorità dei
Medici, qualsiasi accordo che significasse una restaura-
zione discreta diventava impossibile con l’eliminazione
di Capponi dal governo repubblicano nell’aprile 152913.
Le misure antimedicee si aggravavano e la pressione
Storia dell’arte Einaudi 233
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
diplomatica non aveva più alcun potere contro un’evo-
luzione che costringeva ineluttabilmente Clemente a
ricercare l’accordo con Carlo V per conservare a Firen-
ze la signoria dei Medici. Il che fu ottenuto con il trat-
tato di Barcellona del giugno 1529.
Nella primavera del 1527, i fiorentini erano riusciti
a stornare l’esercito imperiale, che aveva maggiore inte-
resse a prendere Roma. Ma adesso per loro e, in più di
un significato, per il loro onore, dovevano tentare quel-
la lotta contro il dominio straniero che i romani non ave-
vano saputo condurre. Era anche il momento più para-
dossale di quella lunga battaglia per l’indipendenza ita-
liana: affrontando al tempo stesso l’autorità del papa e
quella dell’imperatore, senza alcuna speranza di un
sostegno da parte di una Lega completamente disorga-
nizzata, la ribellione di Firenze significava piuttosto,
come giustamente la considerava il Guicciardini, un sus-
sulto di disperazione che non un tentativo di rimetter-
si in piedi con una minima prospettiva di riuscita14. In
agosto, il re di Francia aveva concluso a Cambrai la
pace con Carlo V, abbandonando Napoli, Milano e
Genova, lasciando costernati i suoi ex alleati italiani.
Il mutamento dei fattori politici in Italia e nel resto
d’Europa provocò una ridistribuzione dei poteri nel-
l’entourage dell’imperatore. L’Inghilterra di Enrico
VIII, ampiamente coinvolta negli avvenimenti interna-
zionali nel 1527, attraversava adesso un periodo diffi-
cile che non le permetteva di occupare un posto impor-
tante nella politica europea. Clemente non badò molto
all’inviato di Enrico15. E in una situazione di distrazio-
ne generale si compì lo scisma e ancor più il passaggio
di un grande paese alla Riforma. Nessuno pensava più
alla «libertà dell’Italia», tranne Venezia e, ancora per
qualche tempo, Firenze allora assediata. La sua caduta
avvenne soltanto nell’autunno del 1530, dopo la serie
abituale delle illusioni, degli eroismi e dei tradimenti. Se
Storia dell’arte Einaudi 234
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
ne ha traccia in alcune composizioni musicali e in qual-
che particolarità dell’iconografia religiosa16. Ma neppu-
re questa resistenza alle due potenze adesso unite poté
ritardare il giorno della resa dei conti della storia.
Sul finire del 1529, Carlo V riuniva a Bologna i prin-
cipi italiani e si faceva incoronare solennemente da Cle-
mente VII nella navata di San Petronio il 24 febbraio
1530, anniversario della sua nascita e della vittoria di
Pavia. La coincidenza delle date aggiunge sempre qual-
cosa all’importanza degli avvenimenti. Ne sono ben noti
i particolari17. Tutto fu disposto con l’arte che gli italiani
sanno mettere in queste faccende: a Bologna e, in spe-
cial modo, a San Petronio si ebbe uno splendore che per-
metteva il paragone con Roma e San Pietro18. Era indi-
spensabile. Quando Clemente entrò in città il 24 otto-
bre 1529, passò sotto tre archi successivi, con fregi che
raffiguravano scene bibliche, con fregi guarniti di statue;
un dipinto che rappresentava Assuero ed Ester illustra-
va l’unificazione dei due poteri. Per l’ingresso di Carlo,
il «messaggio» degli archi non era meno esplicito: sul
fregio del primo, era evocata la vita di Costantino, il cui
battesimo dato da papa Silvestro con l’omaggio dello
scettro e della corona era un richiamo alla dottrina della
Stanza di Costantino19.
Il rituale dell’incoronazione era evidenziato con gran-
de cura dai responsabili e dai gerarchi; ogni insegna era
esposta e ben sottolineata: la spada, lo scettro, il globo
e il diadema. Si capisce l’interesse immenso che ebbero
quelle giornate per i pittori preoccupati di fissare l’ico-
nografia ufficiale, giornate che facevano misurare l’im-
menso cammino percorso dall’erede di Massimiliano
dalla modesta incoronazione a Aquisgrana dieci anni
prima. La processione finale, che fu accuratamente com-
memorata dalle due straordinarie serie di incisioni di N.
Hogenberg e di R. Péril20, portava allo stesso livello di
sacralità il papa e l’imperatore, con i loro emblemi;
Storia dell’arte Einaudi 235
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
distribuiva intorno a loro i membri dell’autorità religiosa
e le figure del potere politico, ciascuna con il posto, la
collocazione, il costume e gli attributi appropriati. Si è
potuto riaccostare questo corteo «in fregi» al Trionfo
antico del Mantegna, al Trionfo della Chiesa di Tiziano21.
Aggiungeva ancora dell’altro, che le stampe hanno colto
perfettamente: la valorizzazione delle gerarchie e dei
simboli, il riordinamento di una società e di un mondo
che usciva da una confusione destabilizzante. I simboli
universali avevano ripreso corso. Ma qualcosa mancava
ancora: Roma. Gli avvenimenti troppo scottanti, trop-
po vicini, dei 1527, avevano costretto ad accontentarsi
di una specie di copia della Città Santa. Lo spettacolo
di Bologna non fu che la prova generale del grande atto
che restava da rappresentare proprio a Roma, nessuno
sapeva quando.
Nel frattempo, a nord delle Alpi, la polemica delle
immagini continuava più di prima. In Germania gli
avversari cattolici di Lutero incominciavano ad attac-
carlo con le sue stesse armi. Su una stampa di Cochlaens,
pubblicata a Lipsia nel 1529, il septiceps Lutherus appa-
re come la Bestia dell’Apocalisse attualizzata. L’anno
seguente a Norimberga la stessa figura mostruosa a sette
teste è riferita da Georg Pencz al papato diabolico,
accompagnata dalle insegne medicee. Il testo è di Hans
Sachs: «Guardate questa bestia a sette teste simile per
la forma e i modi alla bestia che san Giovanni ha vedu-
to in riva al mare»22.
La barba del pontefice.
Durante quegli anni difficili, in cui in tutti i campi
si facevano sentire le conseguenze della catastrofe del
1527, l’ambiente pontificio usciva lentamente dall’at-
mosfera di lutto e di dolore di cui non sono la sola testi-
Storia dell’arte Einaudi 236
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
monianza «i lamenti» e i pianti dei chierici. Il diploma-
tico veneziano Sanuto scrivendo nell’aprile 1528 da
Orvieto, dove continuava a trovarsi la Curia, riferiva
che: «La domenica degli Ulivi il papa ha esortato i car-
dinali e i prelati a cambiare vita, a fare penitenza per i
loro peccati, perché questi avevano provocato il flagel-
lo abbattutosi su Roma»23. Un anno dopo il dramma, il
15 maggio 1528, il vescovo Giovanni Stafileo al Consi-
glio della Sacra Rota24 tenne un discorso sulle cause del
sacco di Roma, Oratio ad Rotae auditores excidii urbis
Romae sub annum Christi mille quingenta viginti septem
causas continens25. Testo spesso citato, ma che è indi-
spensabile scorrere per intero, perché in certo qual modo
vi si trova l’esposto ufficiale dell’avvenimento dal punto
di vista teologico.
Il prelato ricorda innanzitutto la distruzione per
opera di scellerati, o meglio di belve crudeli, del seggio
e del santuario stesso della giustizia, la profanazione dei
libri che racchiudono le leggi divine e umane in uso in
tutto l’universo. A ciò si aggiungono le sciagure degli
abitanti della città, la morte dei sacerdoti, la miseria di
tutti. E a questo punto cade la celebre esclamazione:
«Perché ci sono accadute così tremende sventure? Per-
ché i peccati della carne avevano corrotto la missione di
Roma; non eravamo più cittadini e abitanti della santa
città di Roma, ma della città meretrice di Babilonia. E
il nostro tempo ha veduto adempiersi la parola del
Signore che si legge in Isaia». Tutta l’orazione mira a
dimostrare che la condanna di Babilonia nelle parole dei
Profeti e dell’Apocalisse non si riferisce a un episodio
della storia biblica, bensì alla Roma moderna. Perciò i
sovvertimenti sacrileghi che hanno avuto luogo vanno
compresi al tempo stesso nell’orrore che suscitano e nel-
l’insegnamento che impartiscono: cardinali condotti
vergognosamente in giro, vescovi prigionieri, preti ucci-
si, pie donne già vecchie violentate sull’altare, scuderie
Storia dell’arte Einaudi 237
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
installate in palazzi apostolici, reliquie di martiri profa-
nate. Tutto ciò significa un tempo da Apocalisse dove
il sacro non può più essere rispettato. Serve però come
immane avvertimento per tutti, e in particolare, per i
responsabili della giustizia, i quali devono dedicarsi sol-
tanto a placare la collera del Signore.
Il grande argomento degli avversari del papato:
Roma-Babilonia, è quindi riaffermato, assimilato e oltre-
passato. L’esortazione alla penitenza è la reazione nor-
male dopo ogni calamita. Ma Stafileo non parla soltan-
to di pregare «ad placandam iram Dei»; l’appello alla
contrizione riceve una dimensione apocalittica; la visio-
ne dell’Apostolo Giovanni «annuncia per questa città
castighi che sono ancor più atroci di quelli già da noi
subiti». La denuncia globale dei costumi e della vita
romana non si capisce se non in rapporto allo scandalo
inaudito che ha disonorato Roma. Non è pertanto esat-
to equiparare le parole del vescovo alle dichiarazioni di
Alfonso de Valdés, ad esempio, il quale, prima di tutto,
intendeva giustificare le azioni dell’esercito imperiale
come effetto del castigo divino. Non una sola voce della
Curia si è elevata a scusare o a giustificare l’orrore del
sacco. Proprio il suo carattere mostruoso, ingiustifica-
bile, richiede un’interpretazione alla luce delle sue estre-
me conseguenze, con riferimento all’Apocalisse. Infat-
ti, dal punto di vista della Chiesa, si tratta di un episo-
dio al di là della storia; inoltre, per il fatto stesso che a
taluni può apparire come una sconfessione dell’istitu-
zione stessa, richiede una prospettiva più elevata, affin-
ché la peggiore prova che il seggio romano abbia mai
conosciuto possa, malgrado tutto, essere considerata
come volta al suo bene.
Quando rientrò a Roma, Clemente aveva mutato
aspetto. Era invecchiato e portava la barba lunga, come
notarono tutti i diplomatici. Così si legge nel Diario di
Sanuto: «Ha una barba longa e canuta»26. Questo segno
Storia dell’arte Einaudi 238
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
tradizionale di lutto assumeva in un pontefice una gran-
de importanza. Molti membri del clero lo imitarono a
perpetuare il ricordo e il dolore delle sventure comuni.
Clemente conservò la lunga barba del 1528 fino alla
morte. Il ritratto nobile e teso opera di Sebastiano del
Piombo – a cui fecero seguito altri analoghi – è anzi
diventato la rappresentazione-tipo di Clemente: è il
modello che Vasari adotterà nel 1540 per raffigurare il
papa mediceo in veste di san Gregorio a Bologna27.
Se il volto del papa Urbano I nella Stanza di Costan-
tino ricorda un ritratto di Clemente, non è affatto
improbabile che sia stato ritoccato dopo il 152828.
Comunque sia, in ragione delle circostanze, la barba
penitenziale di Clemente sollevò un certo numero di
problemi che costrinsero a ripensare all’effettiva natu-
ra della tradizione e degli usi. Si può dire con certezza
che, se il Quattrocento fu un’età glabra, il secolo seguen-
te favorì i volti barbuti29. Dall’xi e xii secolo in poi, fu
convinzione generale presso i Latini che quell’orna-
mento non convenisse al clero, soprattutto all’alto clero,
e su questo punto il mondo latino era in totale opposi-
zione con il mondo greco, dove prevaleva l’uso contra-
rio, con una evidente volontà di discredito per gli occi-
dentali. Una lunga barba indicava un penitente, un pri-
gioniero, un eremita, o un appartenente alla Chiesa d’O-
riente. Giustamente è stato fatto notare che la decisio-
ne di Giulio II di portare la barba e di farsi ritrarre così
da Raffaello poneva un problema relativamente impor-
tante30: era una decisione simbolica di rimanere barba-
tus fino alla liberazione dell’Italia, decisione presa alla
fine del 1510 e mantenuta fino all’inizio del 1512, quan-
do l’ornamento virile e insolito scomparve di fronte alla
fortunata evoluzione degli eventi presagita dal Concilio
del Laterano e dal rivolgimento delle alleanze. In altre
parole, portare la barba, che non corrisponde all’appa-
renza normale e desiderabile di un ecclesiastico, diven-
Storia dell’arte Einaudi 239
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
ne una manifestazione pubblica in risposta a una vicis-
situdine drammatica, e insieme un impegno personale.
La moda, che esisteva nel clero italiano come altro-
ve, provocò un discusso mutamento nell’aspetto este-
riore dei preti. Molti fra loro avevano imitato Giulio II,
tanto più che la voga della barba aveva incominciato a
diffondersi da quindici o vent’anni negli ambienti cor-
tigiani e principeschi; il ritratto di Castiglione (1515) ne
è una prova sufficiente, come le esitazioni di Bembo a
proposito di quest’ornamento facciale31. Il risultato fina-
le fu un’ordinanza di Adriano VI alla fine del 1523 che
proibiva agli ecclesiastici un’usanza «che li faceva asso-
migliare a soldati piuttosto che a preti»32. All’avvento di
Clemente, sembra che in Curia fosse di nuovo di moda
essere glabri. La comparsa di Clemente «colla barba
longa» nel 1528 non fu forse una sorpresa, ma fu neces-
sariamente notata.
Portare la barba, segno di lutto diventato d’un trat-
to piuttosto diffuso a Roma, tra i sacerdoti, sembra
avere avuto il carattere di protesta contro chi aveva
perpetrato il sacco. Per lo meno, in tal senso parla
l’informazione secondo la quale «con un gesto di per-
dono verso gli imperiali, Clemente emanò un proclama
in cui vietava agli ecclesiastici di uscire per le vie della
città con lunghe barbe»33. E in questa occasione fu pub-
blicato da Giovanni Pierio Valeriano, l’umanista schiac-
ciato dal dolore e autore del De litteratorum infelicitate,
un libello munito dell’approvazione del papa, Pro sacer-
dotum barbis34. L’argomentazione è innanzi tutto antro-
pologica:
La soppressione del pelo in quasi tutti i paesi e in quasi
tutte le epoche ha qualcosa di effeminato. Nell’antichità un
filosofo senza barba difficilmente passava per filosofo. D’al-
tronde il Cristo stesso si presentava diversamente? Se la
barba non fosse un indice di pietà, di moralità di serietà,
Storia dell’arte Einaudi 240
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
di dignità, la si sarebbe portata così spesso? La troverem-
mo sui ritratti ufficiali di Giulio II, o sulle monete coniate
di Clemente?
Fin qui si tratta della ripresa del vecchio dibattito.
Ma il tono cambia quando l’autore risponde a quanti
pretendono dal clero un aspetto sorridente. Come sareb-
be possibile ciò in un’epoca di dolore, dopo la rovina del-
l’intera Italia, dopo il sacco di Roma, vergognoso scon-
volgimento del mondo cristiano? Il segno di una condi-
zione infelice conviene più che mai alla chiesa d’Italia,
della quale i paesi del Nord hanno dimenticato le sacre
istituzioni. «Ma l’Italia intera ha subito niente di più
deplorevole». E si chiederebbe al clero di adottare un
aspetto più femmineo che virile! Perché è proprio su
questo punto, alla fine, che poggia il ragionamento di
Valeriano in favore della barba dei preti. Egli non esita
a sostenere che abitudini effeminate e corrive, come
quella di radersi, abbiano potuto attirare su Roma le
catastrofi che sappiamo. Radersi sarebbe un insulto al
Signore; e questi non può essere placato se non da una
riforma morale, da un ritorno al ritegno, alla decenza,
alla dignità virile, di cui è buon segno che sia ridiven-
tato generale il portare la barba. Questo factum aveva
ricevuto l’autorizzazione del papa.
Si ebbe dunque una piccola disputa a proposito del-
l’uso da raccomandare al clero romano35. Verso il 1530,
lo vediamo, diventava difficile eliminare, fosse anche
per diplomazia, i segni di lutto, che, inoltre, venivano
interpretati come indizi di dignità e, persino, di buon
contegno professionale. Da questi piccoli particolari e da
queste discussioni accidentali si può misurare fino a un
certo punto l’ampiezza dei cambiamenti portati nella
mentalità della Curia dalle sciagure del 1527. Si tende-
va a riesaminare tutto, a sottoporre tutto a un’indagine
severa. Si preparava la Contro-Riforma, con i suoi minu-
Storia dell’arte Einaudi 241
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
ziosi regolamenti. E il Pontefice manteneva, con tutte
le implicazioni connesse, la sua nuova effigie nei ritrat-
ti sulle monete, ai quali affidava un messaggio ancora più
esplicito.
Medaglie e monete.
C’era un urgente bisogno di mettere in circolazione
monete d’oro nella città rovinata. Per un’antica con-
suetudine, il verso delle monete ha sempre svolto la
funzione emblematica e simbolica a commento degli
avvenimenti. Benvenuto Cellini tornò a Roma nell’aprile
1529 e realizzò il suo sogno di lavorare alla Zecca, dove
fu nominato «maestro delle stampe» il 16 aprile. Secon-
do Vasari, «non sono mai state vedute più belle mone-
te di quelle che allora furono stampate in Roma»36.
Un doppio ducato che era stato coniato per l’ascesa
del pontefice mostrava i santi Pietro e Paolo nella
«Navicella»37; conteneva quasi un presentimento dei
futuri guai. Il «doppione largo d’oro», o doppio scudo,
ordinato da Clemente VII in persona all’orafo mostra-
va sulle due facce le preoccupazioni del pontefice.
C’era da una parte «un Cristo nudo, le mani legate,
con la scritta “Ecce homo”, e dall’altra un papa e un
imperatore che raddrizzavano una croce che minaccia di
cadere, con l’iscrizione “Unus spiritus et una fides erat
in eis”». Il che da un lato comportava un apprezza-
mento cristiano delle prove subite a immagine del Sal-
vatore, e dall’altro un voto o un annuncio anticipato
della concordia fra i due poteri. Di fatto, Cellini ha
creato due monete distinte: un doppio ducato che com-
prende l’effigie del papa e l’Uomo dei dolori, e un altro
dove il gruppo del papa e dell’imperatore corrisponde ai
santi Pietro e Paolo38. Un’altra moneta d’argento, del
valore di un doppio carlino, mostra sul verso l’immagi-
Storia dell’arte Einaudi 242
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
ne del Cristo che trattiene san Pietro al di sopra dei flut-
ti con il motto «Quare dubitasti?», che è un commo-
vente richiamo del dramma.
Se si pensa che battere moneta è la prima afferma-
zione dell’autorità politica, non è inutile esaminare
attentamente quanto mostrano i conii di Cellini. Si
esprime a tre livelli, e in tre immagini: l’esitazione del-
l’Apostolo, la Passione del Signore, l’invocazione immu-
tata ai due santi fondatori della Chiesa. É come una nar-
razione compendiata della prova vissuta da Clemente.
La conclusione da trarre è che la Chiesa è sopravvissu-
ta e una nuova politica è ufficialmente proclamata: l’al-
leanza pacifica dei due poteri. Una medaglia, sempre di
Cellini, mostra la Pace che distrugge le armi; in esergo
si legge «Clauduntur belli portae»39. Questa medaglia è
riprodotta, come quella del Giubileo del 1525, nell’o-
pera classica di Bonannus del 169940, che la mette in rap-
porto con i colloqui di Bologna e l’incoronazione del
1530: in mezzo a strumenti bellici giace una figura inca-
tenata, è Marte che morrà dinanzi al tempio di Giano
dalle porte chiuse, come vuole la tradizione antica.
Lo stesso autore stabilisce un nesso tra un’altra
medaglia, che esiste in due versioni, e la fuga da Castel
Sant’Angelo: il pontefice a cavallo in una – e a dorso di
una mula nell’altra – saluta un soldato supplichevole
(due nell’altra); l’iscrizione «Justitia ex Deo» indica
sufficientemente che questo atto di clemenza è stato
compiuto41. Bonannus è stato attratto dalla curiosa me-
daglia, per noi di gran lunga più significativa, coniata a
ricordo della liberazione del 6 dicembre: una larga infer-
riata a sinistra, e su una piattaforma l’angelo che pre-
cede san Pietro; in esergo «Misit D[ominus] Ang(elum)
suum et liberavit me», o nell’altra versione «Mitsit
Dominus angelum, suum. Roma». Il commento indica
appunto che questa frase viene dagli Atti, 12, 11, in cui
Pietro parla della sua liberazione miracolosa dall’Hero-
Storia dell’arte Einaudi 243
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
dianum. Per Clemente «la figura di san Pietro che fugge
dalla prigione, significava la sua evasione da Castel
Sant’Angelo»42.
Questa medaglia merita attenzione per la composi-
zione stessa. L’inferriata ricorda immediatamente il
mirabile affresco della Stanza di Eliodoro, dove l’ange-
lo sveglia san Pietro dormiente. L’episodio vissuto da
Clemente illustra le costanti della storia religiosa, e il
simbolo – san Pietro che tiene la sua enorme chiave e
segue il movimento deciso dell’angelo, reso con molta
evidenza dal medaglista – dà all’avvenimento la sua
dimensione definitiva. L’azione provvidenziale è avve-
nuta con l’aiuto di Castel Sant’Angelo, di dove, al
momento opportuno, fu possibile scappare. La fortezza,
posta sotto la protezione di san Michele, ha salvato in
due occasioni il pontefice, prima riparandolo il 6 mag-
gio, poi permettendone la fuga il 6 dicembre. La coin-
cidenza rende evidente l’intervento divino. Quel che
conta non è più l’atroce sacco della città, ma il fatto che,
grazie all’angelo, o, se vogliamo, grazie ai meandri della
fortezza che ne porta il nome, dove quegli ha vigilato sul
papa, Clemente ha potuto riparare a Orvieto e ripren-
dere in mano il governo della Chiesa43.
Il ciclo di san Michele.
Per Clemente e per i suoi, vi era dunque un risvolto
provvidenziale degli eventi, degno di essere celebrato
persino tra gli orrori della catastrofe. Da ciò che sap-
piamo delle iniziative di Clemente dopo il 1528, fu quel-
lo il filo conduttore della sua azione di restaurazione e
di riparazione. Per accorgersene basta raggruppare un
certo numero di indicazioni fornite da Vasari: concer-
nono tutte Castel Sant’Angelo, e il grande interesse che
Clemente vi portava. Esse provano quanto l’insistenza
Storia dell’arte Einaudi 244
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
sul soccorso dell’Angelo fosse cosa seria, e come se ne
possa scoprire tutta la portata soltanto attraverso i sim-
boli dell’arte.
Rientrando da Bologna, il papa condusse con se Bac-
cio Bandinelli e lo alloggiò al Belvedere.
Dimorando quivi Baccio, pensò Sua Santità di satisfare
a un voto il quale aveva fatto mentre che stette rinchiuso
in Castel Sant’Agnolo. Il voto fu di porre sopra la fine del
torrione tondo di marmo, che è a fronte al ponte di Castel-
lo, sette figure grandi di bronzo di braccia sei l’una, tutte
a giacere in diversi atti come cinte da un angelo, il quale
voleva che posasse nel mezzo di quel torrione sopra una
colonna di mischio, ed egli fusse di bronzo con la spada in
mano. Per questa figura dell’angelo intendeva l’Angelo
Michele custode e guardia del Castello, il quale col suo favo-
re ed aiuto l’aveva liberato e tratto di quella prigione; e per
le sette figure a giacere poste significava i sette peccati
mortali: volendo dire che con l’aiuto dell’angelo vincitore
avea superati e gettati per terra i suoi nemici, uomini scel-
lerati ed empi, i quali si rappresentavano in quelle sette
figure de’ sette peccati mortali. Per questa opera fu fatta
fare da Sua Santità un modello, il quale essendole piaciuto
ordinò che Baccio cominciasse a fare le figure di terra gran-
di, quanto avevano a essere, per gittarle poi di bronzo44.
Si trattava di ricollocare al sommo della fortezza
l’angelo famoso, ricordo del miracolo romano riporta-
to dalla Leggenda aurea: san Michele che rinfodera la
spada per significare a san Gregorio e a chi lo seguiva
in processione che la peste era finita45. La preoccupa-
zione di restituire all’edificio la sua fisionomia storica
e cristiana si accordava con il sentimento di ricono-
scenza concepito da Clemente: il san Michele restaura-
to sarebbe servito da ex voto; al tempo stesso un «con-
cetto» più complesso sarebbe sorto nel cielo di Roma.
Storia dell’arte Einaudi 245
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Ma la collocazione della statua era diversa, poiché Vasa-
ri precisa che si aveva in animo il coronamento del tor-
rione rotondo di faccia al ponte, il che data l’allusione
al 1527. L’arcangelo che schiaccia i sette peccati era una
variante alquanto inaspettata della vittoria dell’angelo
su Lucifero e la sua coorte. Non sappiamo esattamen-
te a che cosa essa rispondesse, al di fuori della preoc-
cupazione di Clemente di stigmatizzare i nemici del
papato e della Chiesa. Ma, per esempio, contava fra
questi Borbone? In ogni caso, un breve del 27 agosto
1528 denunciava come principali responsabili del sacco
gli eretici luterani46.
Conosciamo un disegno di Bandinelli, di fattura un
po’ rozza, che indica un primo stadio del progetto47.
Secondo Vasari Baccio cominciò le sue enormi figure,
ma quell’impresa grandiosa non si concluse mai. Dieci
anni più tardi, sotto Paolo III, che manifestò lo stesso
interesse del suo predecessore alla decorazione al tempo
stesso esterna e interna del castello, Raffaello da Mon-
telupo realizzò una statua di marmo di nove metri, «e
cioè l’angelo di Castello che è in cima del torrion qua-
dro di mezzo, dove sta lo stendardo», a commemora-
zione della visione gregoriana48. Al tempo stesso la for-
tezza ritrovava il suo angelo eponimo, la grande stanza
che si ornava del ciclo di Alessandro in omaggio al papa
regnante e accoglieva la figura sorprendente di Perino
del Vaga. L’arcangelo che balza attraverso la finestra
dimostra nella sua «terribilità» l’autorità del protettore
celeste dei pontefici e della loro fortezza49.
Clemente non aveva soltanto pensato a collocare un
simbolo eloquente di fronte al Ponte Sant’Angelo. Con-
cepì tutta una composizione per riplasmare il castello50.
A Lorenzetto, ossia Lorenzo Lotti di Firenze, fu com-
missionata dal papa, poco dopo il ritorno a Roma. Vasa-
ri è chiarissimo:
Storia dell’arte Einaudi 246
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Perciocché avendo il papa veduto, quando si combatté
Castel Sant’Agnolo, che due cappellette di marmo che
erano all’entrata del ponte51 avevano fatto danno, perché
standovi dentro alcuni soldati archibugieri, ammazzavano
chiunque s’affacciava alle mura, e con troppo danno, stan-
do essi al sicuro, levavano le difese, si risolvé Sua Santità
levare le dette cappelle, e nei luoghi loro mettere sopra due
basamenti due statue di marmo: e così fatto metter su il san
Paolo di Paolo Romano, del quale si è in altro luogo ragio-
nato, fu data a fare l’altra, cioè un san Pietro, a Lorenzet-
to, il quale si portò assai bene, ma non passò già quella di
Paolo Romano; le quali due statue furono poste e si veg-
giono oggi all’entrata del ponte52.
Tutti questi particolari sono interessanti: la distru-
zione delle due cappelle vuole eliminare un doloroso
ricordo; ma la cappella di destra conteneva un affresco
che mostrava il Cristo fra i due fondatori della Chiesa53.
Sostituire le due edicole era un’idea brillante per dare
un’inquadratura monumentale al castello e, con il pro-
getto del san Michele per la torre rotonda, imprimere un
significato nuovo, eloquente e romano, al lato della for-
tezza verso la città. Non meno brillante fu l’idea di ria-
doperare in quell’occasione una statua inutilizzata della
basilica di San Pietro. Questo particolare ha colpito
Vasari, che riferisce come una statua di san Paolo, opera
di Mino e Paolo Romano, rimasta in Vaticano dal 146o
circa, fermò una volta l’attenzione di Clemente: «Per il
che egli deliberò di far fare un san Pietro della grandezza
medesima, ed insieme alla entrata di ponte san’Angelo,
dove erano dedicate a questi apostoli due cappellette di
marmo, levar quelle che impedivano la vista al castello,
e mettervi queste due statue»54.
Il trasporto di una statua e l’approntamento di un’al-
tra dovettero avere luogo poco dopo il 1530, perché Tor-
rigio fornisce una precisazione utile: «Le cappelle gemel-
Storia dell’arte Einaudi 247
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
le, danneggiate dalla guerra, avevano parimenti soffer-
to della piena del 1530. La loro sostituzione con le sta-
tue ebbe per iscopo di conservare a quel luogo il suo
ornamento e il suo carattere religioso»55 La collocazio-
ne delle statue, esattamente sulla soglia del ponte56
sovrastato dalla fortezza, assume il suo pieno significa-
to come richiamo dell’autorità privilegiata dei santi
patroni di Roma, di cui i Riformatori riconoscevano
l’importanza e veneravano l’immagine. Qui ancora, il
monumento corrisponde alla stampa e al libro. Le iscri-
zioni non sono prive di interesse. Quella sul basamento
del San Pietro – ce l’assicura Torrigio – è opera di Pie-
tro Bembo: «Clemens VII p. M. Petro e Paulo Aposto-
lis Urbis Patronis anno salut. humanae mcxxxiv. Hinc
humilibus veniam.». Le iscrizioni, prima collocate di
fronte al castello, sono state poi spostate57.
Il completamento di queste disposizioni, che possia-
mo chiamare riparatrici e si svolgono come un ciclo di
San Michele, si trova alla Trinità dei Monti58. La nostra
informazione proviene sempre da Vasari. Nella Vita di
Michelangelo egli spiega come si giunse a concepire il
Giudizio universale nella Sistina; nel primo progetto
ideato da Michelangelo, si trattava di due grandi «fac-
ciate»: il Giudizio universale sopra all’altare, e, sopra
l’ingresso: ... «quando per la sua superbia Lucifero fu dal
cielo cacciato, e precipitati insieme nel centro dello
inferno tutti quelli angeli che peccarono con lui»59. La
relazione con il ciclo di San Michele sembra evidente –
Michelangelo non realizzò questo affresco, ma le indi-
cazioni che se ne traggono, orientano appunto verso la
Trinità dei Monti. Tutto il passo del Vasari deve esse-
re citato:
elle quali invenzioni molti anni innanzi s’è trovato che
aveva fatto schizzi Michelangelo e varii disegni, uno de’
quali poi fu posto in opera nella chiesa della Trinità di
Storia dell’arte Einaudi 248
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Roma da un pittore ciciliano, il quale stette molti mesi con
Michelangelo a servirlo a macinar colori. Quest’opera è
nella croce della chiesa alla cappella di san Gregorio dipin-
ta a fresco, che ancora che sia mai condotta, si vede un
certo che di terribile e di vario nelle attitudini e gruppi di
quelli ignudi che piovono dal cielo, e de’ cascati nel centro
della terra conversi in diverse forme di diavoli molto spa-
ventate e bizzarre; ed è certo capricciosa fantasia.
Per questa via si è tentato di ritrovare il filo condut-
tore del progetto, certamente imponente, di Michelan-
gelo. Un disegno di casa Buonarroti mostra una cascata
di figure, che forse traspone nel precipitare dei danna-
ti alcuni elementi della caduta degli angeli60. L’affresco
del «garzone» ignoto è pur esistito, le guide ne fanno
menzione, come una specie di modello ridotto di un più
grande progetto61. Esso scomparve nel 1739, quando fu
abbattuto il muro del transetto per edificare l’attuale
cappella terminale. Della primitiva decorazione della
Trinità dei Monti, quando il santuario dei «frati cala-
vresi e franciosi che vestono l’abito de San Francesco di
Paulo», incominciava ad attirare l’attenzione, rimango-
no poche tracce. A quale fase apparteneva la cappella
della Concezione ornata di affreschi da un Calabrese di
cui Vasari non ha ricordato il nome, un compagno di
Marco Calavrese?62. L’unica cosa notevole è che sotto
Leone X numerose cappelle ebbero decorazioni interes-
santi, e spesso per mano di meridionali – il che non deve
stupire. La cappella del transetto, detta Chateauvillain,
dal nome dell’ambasciatore francese sotto Leone X,
dovette parimenti accogliere pitture di cui non si cono-
sce più il tema; sussistono sulle volte quattro sibille e
quattro profeti – raggruppati a due a due – stranamen-
te appollaiati sugli orli degli archi. Sotto Clemente VII,
la Cappella Pucci, che occupava il braccio sinistro del
transetto, fu commissionata a Perino del Vaga: il suo
Storia dell’arte Einaudi 249
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
straordinario brio e messo in evidenza dalle due note-
voli figure dei profeti «mariani» Isaia e Daniele, sopra
all’arco spezzato d’ingresso; ma tutto fu interrotto nel
maggio 152763
Grazie alla sua posizione elevata che lo metteva in
evidenza e ai suoi dichiarati rapporti francesi, il con-
vento dei Minimi era un punto di attrazione inevitabi-
le per l’armata imperiale64. Nella cronaca dell’anno ter-
ribile, fu uno degli episodi più spietati. Questo serve a
spiegare come la Cappella Chateauvillain sia diventata
la Cappella San Gregorio. A nostro giudizio, e dopo il
1530, e a titolo di «riparazione» per il sacrilegio e per
la dissacrazione da parte dei vandali, che fu ideata la
nuova decorazione, imperniata sulla caduta degli ange-
li ribelli. La scelta del tema, presa a prestito dal progetto
iniziale della Sistina, ci porta a datare al 1534 l’opera di
quel Jacopo Siculo, del quale nulla si sa, tranne che si
trattava, ancora una volta, di un meridionale, e che per
la sua composizione si era valso del disegno inutilizzato
di Michelangelo65. Ma è già molto. Perché l’avere svi-
luppato la leggenda di san Michele in tutta una cappel-
la conferma il legame con il ciclo concepito da Clemen-
te VII, e inversamente, questa indicazione ci assicura
che il progetto di Michelangelo rispondeva allo stesso
disegno.
Intorno alla caduta degli angeli precipitati nella
Geenna dall’arcangelo, che costituisce il centro della
scena, si svolgevano gli episodi classici: da una parte il
toro bianco e la freccia di Gargano (da cui la denomi-
nazione del Monte Gargano consacrato a San Michele);
dall’altra l’apparizione dell’angelo al sommo del mauso-
leo di Adriano a significare la fine della peste a Roma66.
Il primo episodio e sdoppiato nelle lunette, il secondo
occupa tutto il resto della parete. A giudicare da queste
scene, Vasari, che ha ricordato soltanto l’affresco
«michelangiolesco» ora scomparso, non ha torto di
Storia dell’arte Einaudi 250
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
affermare che lo stile del pittore sente lo sforzo. Tutta-
via la composizione più originale per le sue dimensioni
e, dal nostro punto di vista, la più conclusiva, è l’affre-
sco che descrive il miracolo di Castel Sant’Angelo.
È cosa eccezionale che questo episodio sia stato este-
so fino a coprire tutta una parete. Infatti, lo si trova di
solito, per lei meno in Italia, in predelle e piccole com-
posizioni. Ad esempio, per rimanere nello stesso perio-
do, fra le «storiette», oggi ben identificate, che accom-
pagnavano il grande pannello di san Michele e gli ange-
li ribelli del Beccafumi67. Ma a Trinità dei Monti si ave-
vano buone ragioni per dare alla scena uno sviluppo
particolare, come dimostrerà l’analisi che segue. L’an-
gelo, simile a una figura di bronzo, si libra sopra la for-
tezza, più di quanto non vi sia appoggiato. La croce di
processione, sorretta dal diacono inginocchiato in primo
piano, sembra rispondergli. È infatti il momento, in
cui, come racconta la Leggenda aurea, l’apparizione del-
l’angelo che rinfodera la spada significa la fine della
peste, essendo esaudite le preghiere e processioni di
Gregorio: sul ponte, colto di sorpresa durante la ceri-
monia propiziatoria, un gruppo di leviti che porta delle
«icone» si ferma, stupito. Gli assistenti formano due
gruppi stranamente separati; un personaggio avvolto in
un drappo, guardando verso lo spettatore, domina il
gruppo a sinistra; a destra, una folla inaspettata di pre-
lati e di chierici – tra i quali, alcuni certamente sono
identificabili – sta dritta dietro al pontefice in preghie-
ra. Questa accolta di personaggi mitrati intorno alla
tiara non appartiene evidentemente alla leggenda, ma
attualizza la scena in un significato che non è difficile,
da indovinare. Un tale raggruppamento di alti dignitari
accanto al papa davanti a Castel Sant’Angelo non pote-
va che ricordare a tutti i presenti tra la folla, o meglio
ai membri della Curia accalcati, un certo giorno di mag-
gio 1527.
Storia dell’arte Einaudi 251
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Il «profilo perduto» non consente di identificare il
papa che impresta i suoi lineamenti a san Gregorio, ma
il cappuccio della cappa pontificia reca un San Michele
che atterra il demonio sopra un blasone mediceo con sei
palle. Lo stesso blasone è scolpito sulla torre rotonda di
Castel Sant’Angelo. La scena deve essere perciò riferi-
ta a un papa della famiglia Medici che non potrebbe
essere altri che Clemente. Lo precisa ancora un ultimo
particolare:
il pittore ha dato una sagoma priva di vigore alla for-
tezza, al fine di magnificare l’angelo. Ma, con una cura
sorprendente, ha dipinto due piccoli edifici collocati
all’ingresso del ponte, uno dei quali porta l’immagine
sacra del Cristo fra Pietro e Paolo, che identifica una
cappella68. Si tratta infatti delle due cappelle di cui si
conosce ora l’importanza negli atti «riparatori» compiuti
da Clemente.
La ricorrenza della processione gregoriana si celebra
il 7 maggio, secondo la Leggenda aurea. Il papa si chiu-
deva nella fortezza la sera del 6 maggio. È difficile che
proprio questo pontefice, così attento alle coincidenze,
non ne fosse a conoscenza quando formulò il voto di cui
l’ordinazione della grande statua a Bandinelli fu la con-
seguenza. In ogni caso, quest’insieme di circostanze
parve abbastanza eloquente perché, in conformità delle
pratiche religiose più costanti, si potesse leggere l’epi-
sodio moderno nell’antica leggenda; si commemorava
con la massima naturalezza l’intervento provvidenziale
dell’angelo nel 1527 celebrando il miracolo del 590. La
devozione all’arcangelo si intensifica sempre quando si
temono scempi dell’Anticristo e dei nemici della chiesa.
La dedica della cappella è ampiamente significativa di
questa preoccupazione. Avere reso attuale la leggenda
gregoriana basta a spiegare l’ampio spazio che le è riser-
vato. Se fossimo in grado di identificare i personaggi lo
si capirebbe ancora meglio. Trinità dei Monti appare
Storia dell’arte Einaudi 252
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
pertanto, sulla fine del pontificato di Clemente VII,
come la chiesa dove l’esecrazione degli orrori del 1527
assunse la forma più spettacolare e più esplicita69.
Il «Giudizio universale».
Cellini era tornato a disegnare monete; anche Ban-
dinelli era ricomparso. Sebastiano non rimase a Vene-
zia, ma lo spettacolo deprimente di Roma provocò in lui
una psicastenia, di cui si lagnò con Michelangelo. Lo
trasse fuori la generosità di Clemente. Senza volere dare
un’interpretazione eccessiva alla depressione del pitto-
re, dobbiamo tuttavia osservare che negli anni successi-
vi egli gettò le basi di un nuovo tipo di arte religiosa,
dove uno stile semplificato, formalmente spoglio, con
zone avvolte nell’oscurità, segna un ripudio dei bei
modellati precedenti. «La prima manifestazione di que-
sto atteggiamento è la Via Crucis»70. Il quadro doveva
ispirarsi al gruppo di Michelangelo, ma tiene anche
conto del Cristo morto del Rosso, di cui Sebastiano
annulla in certo qual modo l’idea centrale. Si tratta ora
di elaborare uno stile severo, che convenga a una devo-
zione dolorosa, l’unica adatta alla situazione. E que-
st’orientamento apparirebbe un fatto importante di per
sé se non ne annunziasse un altro.
L’opera fu ripetuta per lo meno in tre versioni, di cui
è interessante conoscere i destinatari: una per il conte
di Cifuentes, ambasciatore dell’imperatore a Roma (oggi
all’Ermitage); un’altra per Domenico Grimani, patriar-
ca d’Aquileja, versione menzionata da Vasari (probabil-
mente quella al Museo di Budapest)71; una terza è ora al
Prado. Se ci fidiamo del ricorso alle medaglie, possiamo
pensare che il pittore, familiare del papa, abbia com-
memorato nelle sofferenze del Cristo quelle del suo
servo e della sua città; o, almeno, che la prova subita
Storia dell’arte Einaudi 253
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
dalla Chiesa, era servita a porre in evidenza l’atroce e
pietoso Calvario del Signore. La semplicità della com-
posizione ricorda immagini pie; con la trovata del legno
diritto e del Sacro Volto visto di fronte – che a tutti
doveva evocare la Veronica – Sebastiano ha saputo
impiegare in modo nuovo le risorse del suo stile. C’è
quasi l’inversione, l’autonegazione di un’arte72.
E neppure pare esagerato scorgere nella Pietà (oggi a
Ubeda) un richiamo calcolato della angoscia della cri-
stianità. L’opera fu ordinata alla fine del 1533 da Fer-
rante Gonzaga in persona per Francisco de los Cobos,
Commendayor Mayor e consigliere dell’imperatore. La
realizzazione del lavoro durò sei anni, e l’esasperazione
di coloro che erano coinvolti in quell’impresa è diver-
tente da seguire73.
La cosa importante, anzi notevole, è che il papa
avrebbe provocato, in quei pochi anni dedicati a ripa-
rare e a ricominciare da capo, la fine di quello che abbia-
mo chiamato lo stile «clementino» a Roma. La «dia-
spora» era un fatto compiuto: né il Rosso né il Parmi-
giano sarebbero tornati. Peruzzi ricomparve nel 153074.
Il papa si adoperava a richiamare tutti quelli che anco-
ra potevano dare lustro al suo pontificato, e d’altronde
essendo tornata la pace, giovani artisti della Toscana,
delle Fiandre, trovavano la via di Roma: Salviati, Vasa-
ri, Martin van Heemskerck. Ippolito de’ Medici, che
aveva ricevuto il cappello cardinalizio nel 1529, faceva
lavorare i fiorentini, mentre il cardinale Enckenvoirt si
faceva committente di artisti del nord. Clemente dopo
tante umiliazioni invecchiava, ma con dignità; non
avrebbe lasciato che il suo pontificato attraversasse il
peggiore momento della storia della Chiesa senza fare un
ultimo sforzo. Comprendeva che lo stile artistico dove-
va mutare. Sentiva a sua volta il fascino della «terribi-
lità». Non poteva evitare Michelangelo. E così, infine,
lo chiamò a intraprendere nella Cappella Sistina qual-
Storia dell’arte Einaudi 254
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
cosa che segnasse una conclusione – un ciclo escatologi-
co adatto – del ciclo storico di Sisto IV, anteriore di un
mezzo secolo, del ciclo teologico di Giulio II, anteriore
di un quarto di secolo. Per un riflesso tipico, Clemente
desiderava che un’opera d’arte illustrasse proprio la cata-
strofe del suo pontificato. Il sacco di Roma, l’abbiamo
veduto, non è stato raffigurato direttamente; lo è stato
invece, secondo il modo proprio del Rinascimento,
mediante un simbolo, elevato di per sé sufficientemen-
te da essere commisurato all’avvenimento. I concetti, le
sfumature intellettuali o affettive, prospettate dagli sto-
rici per rendere conto della singolarità del Giudizio uni-
versale sono tutti degni di attenzione: secondo L. von
Pastor, l’attesa escatologica è creata dall’ossessione degli
errori del 152775; per C. Lanckoronska, vi domina piut-
tosto un pungente senso di colpa e il richiamo alla con-
trizione76; per D. Redig de Campos, con cui concorda C.
de Tolnay, l’angoscia cristiana è qui espressa dal Dies
irae77. Queste opinioni sembrano davvero far converge-
re l’attenzione sull’effetto di oppressione dolorosa volu-
ta dall’artista per suscitare nell’animo dei fedeli la medi-
tazione sul giudizio finale. Ma l’interpretazione può e
deve essere articolata in nozioni più precise. Non è pro-
prio della composizione figurativa racchiudere tutto il
ventaglio delle «lezioni», fra le quali gli storici, per la
fretta di trarre conclusioni, sono forse troppo inclini a
operare delle scelte? Non è proprio di un’opera che si
svolge tanto ambiziosamente su così ampio spazio il
potere giustapporre forme ricche di suggestioni com-
plementari, perfino contrarie? Il tema è stato adottato
onde permettere un dirompere imprevedibile, incredi-
bile all’interno della composizione, non per tenersi nei
limiti di un unico argomento.
Michelangelo fu l’ultimo degli artisti con il quale
Clemente prese contatto. L’incontro del perdono – indi-
spensabile per via dell’adesione del Buonarroti alla ribel-
Storia dell’arte Einaudi 255
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
lione antimedicea – ebbe luogo il 22 settembre 1533 a
San Miniato al Tedesco. Michelangelo venne a Roma in
novembre, o forse in dicembre. Il progetto, di cui Con-
divi dice che fu elaborato «dopo aver considerato molte
soluzioni», doveva già essere stato oggetto di conversa-
zioni precedenti fra Clemente e Michelangelo e riguar-
dava senza dubbio le due facciate. La lettera di Seba-
stiano del 17 luglio 1533 annunzia alcune novità sensa-
zionali: «tal cosa che non ve lo sogniassi mai»78. Che
cosa di più sorprendente se non manifestare due volte
il potere terribile del cielo, all’origine sugli angeli e alla
fine sui mortali?
Ci volle un anno a Michelangelo per prendere tutte
le disposizioni necessarie al suo definitivo ritorno a
Roma; arrivò il 23 settembre 1534, pochi giorni prima
della morte di Clemente sopravvenuta il 13 ottobre.
Paolo III confermò il progetto del predecessore e con-
vinse non senza fatica Michelangelo a darvi inizio; ma
la preparazione delle pareti non era cosa semplice e
quindi l’esecuzione cominciò solo l’8 novembre 153579.
Frattanto Michelangelo aveva rotto con Sebastiano, che
aveva creduto di potergli essere di aiuto preparando
l’immenso muro per la pittura a olio, come aveva egli
stesso sperimentato con successo a San Pietro in Mon-
torio quindici anni prima80; Michelangelo dichiarò che
«la pittura a olio è un’arte di donne e di ricchi fannul-
loni come fra Bastiano»81. Si decise pertanto per il meto-
do duro, paziente e tradizionale dell’affresco. Il lavoro
durò sei anni. Fu tolto il velo all’affresco la Vigilia di
Ognissanti del 1541, in un mondo che incominciava a
dimenticare il sacco di Roma, ma che non avrebbe mai
dimenticato l’opera di Michelangelo.
A noi pare che si debba annettere alla composizione
vera e propria, alla «storia», un’importanza ancora mag-
giore di quella accordatale da tanti importanti interpre-
ti. Se si tiene conto dello stupore prodotto sui contem-
Storia dell’arte Einaudi 256
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
poranei – effetto ricercato fin dalla concezione dell’af-
fresco nel 1534 – e dell’impressione duratura che, per
la collocazione, il rigore, l’unita di forme e di colore, il
Giudizio provoca tuttora, dobbiamo evitare di identifi-
care l’insieme dell’opera con «un singolo concetto», per
quanto sublime sia, ma piuttosto radunare tutte le idee
che essa suscita come potenzialità attive all’interno di un
sistema formale senza precedenti. In altre parole, lo
scopo dell’esegesi ci sembra non tanto quello di ricollo-
care l’impresa di Michelangelo in una cornice di cultu-
ra teologica o nella prospettiva di un variato dibattito
religioso, ossessionato dal mito della escatologia, quan-
to di situarla nell’ordine della pittura ecclesiastica, a cui
innanzi tutto appartiene. Dalle sue particolarità nasce-
ranno le questioni effettive.
Senza rompere con la formula convenzionale del
Giudizio universale concepito come una facciata a regi-
stri sovrapposti, Michelangelo ha voluto, grazie a un
immenso lavoro di selezione e di semplificazione, dare
piena espressione al suo valore universale. Si può inter-
pretare in questo senso l’effetto rotatorio prodotto dal
contrapporsi di un movimento ascensionale a sinistra e
discensionale a destra, mentre la gigantesca figura del
Cristo serve come centro di questa rotazione. Non è
necessario introdurre la nozione dell’eliocentrismo del
cosmo per rendere conto di una disposizione così poten-
te e così necessaria come questa; ma l’unità formale, la
coerenza del disegno suggeriscono effettivamente l’esi-
stenza di un sistema dietro questa immensa composi-
zione, in cui ogni corpo è soggetto alla forza di gravità
se sta tra i dannati, e si eleva grazie all’attrazione cele-
ste se appartiene alla schiera degli eletti. Vi è un’op-
posizione fondamentale – come ha compreso molto
bene C. de Tolnay82 – fra la tranquilla gravità del Cri-
sto e la confusione generale degli esseri che lo circon-
dano.
Storia dell’arte Einaudi 257
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
L’altro elemento dominante, che non può essere
misconosciuto, è la realtà della Chiesa, presente con
una grande ricchezza di movimenti contrastanti nella
larga fascia del secondo livello. La Madonna, arretrata
dietro il Cristo, ne afferma la grandezza. I santi, ognu-
no portatore del proprio attributo o designati da gesti
tradizionali, sono al loro posto di intercessori. Ma
Michelangelo non era interessato a caratterizzarli con
troppa esattezza. Quel che è poco abituale, è il tumul-
to degli eletti, che paiono perorare una causa, presenta-
re il loro martirio come un pegno; tremano per loro
stessi o per l’umanità peccatrice? Se si identificano le
due figure negli angoli superiori con Adamo ed Eva, si
tratta allora, in realtà, di un riferimento alla intera Chie-
sa trionfante e alla sua partecipazione all’ultimo atto
della Salvezza.
L’umanità, anche salvata, perde la propria sicurezza in
presenza di Dio, nell’avvento prodigioso dell’Ultimo
Giorno. Dobbiamo porre all’origine del tema dell’affre-
sco un pensiero teologico più esplicito, come quello della
giustificazione per la sola grazia83, o quello della negazio-
ne valdese dell’Inferno?84. Noi pensiamo di no. Da un
canto, vi sono esempi di pietà: il rosario appare fra gli
strumenti di salvezza, trattato meravigliosamente come
una catena a cui si aggrappano le anime per salire al cielo.
Gli emblemi dei santi sono evidenti. I culti particolari non
sono rifiutati, sono solamente sottoposti a una grande
semplificazione. Il culto di Maria, quello dei santi, appaio-
no ridotti all’essenziale senza particolari inutili, senza
ristrettezza di vedute. L’effetto è tanto formale quanto
spirituale. D’altro canto, l’Inferno esiste, i diavoli lo occu-
pano, le anime vi precipitano, il peccato c’è.
Non bisogna rimproverare a coloro che hanno scrit-
to ancora sotto choc per la novità del Giudizio univer-
sale, di non avere colto l’essenziale, quando dicevano,
come Condivi: «In quest’opera Michelangelo espresse
Storia dell’arte Einaudi 258
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
tutto quel che d’un corpo humano può far l’arte della
pittura»85, o come Vasari: «l’intenzione di questo uomo
singulare non ha voluto entrare in dipignere altro, che
la perfetta e proporzionatissima composizione del corpo
humano et in diversissime attitudini»86.
Per lo spettatore di oggi, come per quello del Cin-
quecento, l’originalità dell’opera sta nel fatto di avere
abolito cornice, spazio, natura, a beneficio di raggrup-
pamenti ora fitti, ora radi, il cui elemento unico e
costante è il corpo nella sua nudità. Iniziativa possente,
che merita di essere meditata.
All’inizio del Cinquecento, presso i maestri fiorenti-
ni e romani, era diventato abituale comporre una «sto-
ria» religiosa con figure nude, disposte – da Leonardo
o Raffaello, ad esempio – come manichini viventi di cui
si abbozzavano le pose prima di ricoprirli dei drappeg-
gi tradizionali. Michelangelo usava, nei suoi disegni, lo
stesso metodo ed era diventato per lui naturale, quasi
istintivo, comporre iniziando da figure nude, poiché,
come Leonardo e più tardi Vasari, capiva che in esse si
trovano «insieme gli affetti delle passioni e contentez-
ze dell’animo». Il corpo umano esprime ogni cosa: è il
codice universale dell’espressione. La decisione presa
nel 1534 di ricoprire l’immensa «facciata» con una
coreografia di nudi in una luce poco variata e senza
armatura architettonica appariva manifestamente come
un passo indietro rispetto al soffitto della cappella; l’im-
portanza assunta dal Giudizio dopo vent’anni implica un
rifiuto dell’opera giovanile. Nei drappeggi, nei raggrup-
pamenti e soprattutto nei colori chiari, nel leggero rilie-
vo, le preoccupazioni pittoriche sembrano essere state
soppiantate dalle esigenze proprie allo scultore: il corpo
umano è l’oggetto primordiale.
Vi è una specie di rinuncia nel Giudizio universale:
una severità che riflette il cupo stato d’animo dell’arti-
sta, con il suo umore vieppiù turbato e angosciato che
Storia dell’arte Einaudi 259
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
lo riavvicina a Vittoria Colonna87. Proprio durante l’e-
secuzione dell’opera si sviluppano le sue preoccupazio-
ni devozionali e hanno luogo i loro colloqui teologici a
San Silvestro sul Monte Cavallo88 Questo fatto è stato
spesso e opportunamente sottolineato per rendere conto
del tetro colore del mondo terreno, dell’aspetto doloro-
so e teso della Chiesa celeste. Tuttavia, non è da tra-
scurare un tratto singolare che saltò agli occhi della
Curia e dei fedeli nell’autunno del 1541 e fu all’origine
di una delle più violente e rivelatrici polemiche del seco-
lo. «Non mancano persone per condannare l’opera, –
scrisse il cardinale Ercole Gonzaga al suo corrispon-
dente a Roma. – I padri Teatini sono i primi a dire che
le figure nude, mostrando le parti intime, non si addi-
cono a un tale luogo»89.
L’aneddoto famoso e divertente del Maestro di ceri-
monia che viene a vedere l’opera con Paolo III e criti-
ca «come cosa disonestissima in un luogo tanto onora-
to avervi fatto tanti ignudi»90, deve coprire qualcosa di
serio: un tentativo disperato dei teologi e dei prudenti
membri della Curia per cercare di ottenere un minimo
di decenza ed evitare lo scandalo. Perché scandalo vi fu,
come attesta una serie monotona di critiche, dalla let-
tera piuttosto odiosa dell’Aretino nel 1545 al trattato
antimichelangiolesco di Gilio nel 1564.
Quando il Maestro di cerimonia disse incollerito che
questa è «non opera di cappella di papa ma da stufe e
d’osterie», non fece che riprendere le critiche formula-
te da Adriano VI, quindici anni prima, contro la volta
della Sistina. Il papa riformatore detestava l’arte moder-
na e, in particolare, la Cappella Sistina, che per lui non
era che «una stufa di ignudi»91. Per quanto provocante
fosse la loro bellezza, i giovanetti nudi della volta non
erano, in realtà, che una variante originale e poetica
della formula tradizionale dei «putti» portaghirlande,
che l’arte non aveva mai smesso di adoperare92.
Storia dell’arte Einaudi 260
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
La «facciata» del Giudizio estende alla «storia» inte-
ra una concezione che, sebbene accettabile nelle parti
ornamentali, era già stata spinta un po’ troppo oltre
nella volta della Sistina. Se Michelangelo ha segnato
una netta rottura con le ambizioni decorative e lo stile
brillante della sua giovinezza, ha tuttavia conservato, e
anche ampliato al massimo, il ricorso alla nudità. Per
questo ha offeso tutti i critici93. È stato inflessibile e ha
sostenuto che nessun altro genere di figurazione era
possibile per rappresentare la resurrezione dei corpi. La
nudità conferiva ai personaggi sacri un valore primor-
diale, estraneo alla storia in cui domina la bellezza. Non
è necessario sottolineare che questo solo aspetto basta a
tenere l’opera lontana da qualsiasi concezione ristretta
e puritana della penitenza.
Gli ultimi anni trascorsi nell’eseguire l’affresco furo-
no quelli in cui Michelangelo secondo le conversazioni
fedelmente registrate da un ammiratore portoghese94 –
formulò in maniera definitiva i suoi concetti sull’arte e
lo stile. Egli era assai cosciente dei problemi, ma il suo
pensiero ultimo riguardo al corpo umano è esposto, con
maggiore ingegnosità e forza di quanto non lo possa
fare alcun testo, nel poema biblico della Sistina. Nel
registro inferiore, le facce laide e stravolte dei diavoli e
dei dannati mostrano la degenerazione del corpo nella
bruttezza – segno della maledizione. Al di sopra del
grande cerchio della Chiesa trionfante, alcuni angeli
portano, volteggiando, le arma Christi, simboli della Sal-
vezza. Questi angeli, senza ali, rappresentano la perfe-
zione atletica e, per Michelangelo, armoniosa del corpo.
Essi prolungano gli ignudi della volta: introducono il
medesimo sfolgorio di bellezza in una composizione in
cui questa sembrava non trovare posto, ma, questa
volta, con una giustificazione tematica. La bellezza è il
segno acuto e avvincente di una condizione superiore:
«Ne altro saggio abbiam ne altri frutti del cielo in
Storia dell’arte Einaudi 261
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
terra», aveva scritto Michelangelo verso il 1534-3595. È
il momento in cui intraprendeva la «facciata»; ma aveva
appena incontrato Tommaso Cavalieri e celebrava que-
sto amico meraviglioso in poemi ardenti e in disegni
grandiosi.
Il ritorno di Michelangelo nel 1534 e il suo affresco
ambizioso significavano una nuova svolta della vita arti-
stica a Roma. Lo stile della «terribilità» richiedeva il
monocromo azzurro e bruno e le forme pesanti alle quali
si atteneva Sebastiano del Piombo. Ciò era in opposi-
zione totale con la suavitas dello «stile clementino» e a
questo riguardo si potrebbe parlare di una riforma arti-
stica, o di uno stile in armonia con il nuovo tono della
Curia. Ma mantenendo ad ogni costo, come privilegio
dell’artista, come sua quidlibet audendi potestas96, la pre-
minenza assoluta della nudità sacra, Michelangelo soste-
neva qualcosa di essenziale, precisamente la fantasia dei
toscani e le esigenze romane che, a partire dalla volta
della Sistina, avevano nutrito l’arte «clementina».
Senza inquadratura, la «facciata» di Michelangelo
restava incredibilmente sobria quanto a elementi deco-
rativi. È la prima opera importante dell’artista che non
comporti alcun genere d’invenzione ornamentale. Ma
c’è dell’altro.
Aveva scoperto già Michelangelo nella cappella del papa
la facciata del Giudizio, e vi mancava sotto a dipignere il
basamento, dove si aveva ad appiccare una spalliera d’araz-
zi tessuta di seta e d’oro, come i panni che parano la cappella:
onde avendo ordinato il papa che si mandasse a tessere in
Fiandra, col consenso di Michelangelo fecero che Perino
cominciò una tela dipinta della medesima grandezza, den-
trovi femmine e putti e termini che tenevano festoni, molto
vivi, con bizzarrissime fantasie, la quale rimase imperfetta
in alcune stanze di Belvedere dopo la morte sua: opera certo
degna di lui e dell’ornamento di si divina pittura97.
Storia dell’arte Einaudi 262
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Un disegno al British Museum, che fece parte delle
collezioni di Rubens e che l’artista ha ritoccato qua e là,
da un’idea di questo programma98. Questo progetto, che
non si concluse, fornisce almeno qualche nozione dello
stile della «terribilità» nell’ornamento, indispensabile,
a nostro giudizio, per apprezzare la portata dell’opera di
Michelangelo. Era forse l’ultimo tentativo del pontefi-
ce di fare iscrivere il suo stemma nella cappella, perché
Michelangelo non aveva voluto che le armi del Farnese
comparissero in quella composizione, che, tutto som-
mato, non gli doveva nulla, per lo meno quanto alla con-
cezione99. Paolo si sarebbe rifatto con la Cappella Pao-
lina, di cui diede l’ordine all’artista nel 1541.
L’imperatore a Roma.
Gli sforzi di Clemente VII per sfruttare le sciagure
del sacco e il suo ingombrante ricordo al fine di correg-
gerne gli effetti, erano riusciti solo in parte. Aveva nego-
ziato con l’imperatore senza perdere la faccia, ma nes-
suno si faceva illusioni, come prova la relazione del-
l’ambasciatore di Venezia, Antonio Soriano, nel luglio
del 1535100. Clemente è menzionato a proposito della sua
paura del Concilio: «rappresentandosi il Concilio come
pericolosissimo alle cose sue», e del suo pietoso smacco:
«essendo seguito il sacco infelice di Roma, tanto dan-
noso e di tanta vergogna di sua Santità e di quella
sede...»
Segue una tipica digressione sul matrimonio dei
bastardi (la figlia dell’imperatore e Alessandro de’ Medi-
ci), che Clemente (lui stesso sospettato di bastardaggi-
ne), era stato costretto ad accettare nel 1530. Non aveva
compiuto alcun passo avanti dalla parte dei riformato-
ri. La guerra dei libelli e delle stampe era più feroce che
mai. Il problema del Concilio restava irrisolto. Quando
Storia dell’arte Einaudi 263
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
nell’ottobre del 1534 il papa morì, fu sostituito con una
premura e un’unanimità insolite. Il cardinale Farnese,
che aveva sempre appoggiato Clemente e aveva tratto
tutte le lezioni possibili dai drammatici avvenimenti,
appariva come il solo pontefice adatto a rivitalizzare
Roma e la Chiesa101. La sua azione fu precisa e di gran-
de portata sia sul piano locale sia su quello diplomatico.
Non ce ne rendiamo conto se consideriamo Paolo III sol-
tanto come «l’ultimo papa del Rinascimento», un prin-
cipe della Chiesa destinato ad assicurare il trapasso con
l’età del Concilio. La maggior parte delle sue iniziative
furono dettate dagli errori, le sconfitte, le manchevo-
lezze del suo predecessore, ed erano dirette a restituire
al seggio pontificio la dignità e il prestigio perduti102. La
preoccupazione fondamentale di questo pontificato
sarebbe stata, e non poteva essere altrimenti, solo quel-
la di cancellare le ultime tracce e perfino qualsiasi ricor-
do dell’umiliazione del 1527.
Le due idee congiunte della riconciliazione dei prin-
cipi cristiani e della preparazione del Concilio, diedero
al pontificato Farnese una fisionomia assai particolare;
la politica di Paolo III ebbe una duttilità e al tempo stes-
so una coerenza notevoli. Non era più in potere della
Santa Sede trasformare d’un tratto la situazione. Egli
riuscì, per lo meno, a modificarla alquanto grazie a quel-
le operazioni spettacolari – simboli più che portatori di
veri risultati – quali i tempi richiedevano.
La tregua di Nizza del giugno 1538, significava la
pace delle armi, la missione di Caetano in Germania e
la sua disputatio con Lutero volevano ricercare la fine
della guerra di religione a qualsiasi prezzo.
A Roma stessa, si seppe molto presto che ci sarebbe
stata una politica attiva di rinnovamento urbano.
C’erano rovine dappertutto, a cominciare dalle mura
aureliane e dai recinti del Belvedere, attraverso i quali
passavano i lupi103. L’incoronazione di Paolo III ebbe
Storia dell’arte Einaudi 264
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
luogo il 3 novembre 1534 con grande pompa. L’anno
seguente fu rimesso in vigore il carnevale; il tempo del
lutto era terminato. Fin dal novembre 1534 veniva
nominato un commissario alle antichità: suo compito era
proteggere, o per lo meno tentare di sorvegliare le rovi-
ne antiche, frenare gli scavi clandestini e lo sfrutta-
mento incontrollato che avevano trasformato il Colos-
seo e il Foro in cave di pietra. La scelta di Latino Gio-
venale Manetti, segretario particolare del papa, umani-
sta e archeologo, era significativa. Si riesumavano così
tutte le dotte preoccupazioni dell’età clementina. Il
breve di nomina è chiaro: «Non senza un profondo
dolore abbiamo veduto i venerabili monumenti dell’ar-
te dei Romani abbattuti, distrutti, dispersi dai Goti, dai
Vandali e da tutti i Barbari, dai danni del tempo e anche
dalla nostra stessa negligenza e cupidigia»104.
Tutti capivano l’allusione ai saccheggi dei barbari e
alle cattive abitudini dei moderni. La nozione di un
patrimonio romano assumeva d’un tratto un significato
più completo.
Il corso della politica portò tuttavia a una conse-
guenza inattesa: la sistemazione del Foro e la ripresa di
una processione trionfale attraverso la città in onore di
Carlo V. Dopo l’incontro di Bologna e l’incoronazione
dell’imperatore nel febbraio 153o, questa visita era ine-
vitabile. Entrare a Roma ed esservi accolto dal papa era
per Carlo il modo ideale per consumare apertamente la
sua vittoria e, al tempo stesso, sostituire all’invasione
tutto sommato un po’ imbarazzante del 1527 un
«trionfo» in buona e dovuta forma. La campagna di
Tunisi nel 1535 e la vittoria, impossibile a contestarsi,
sugli infedeli, fornivano l’occasione attesa, tanto più
che egli doveva risalire la penisola per ritornare negli
Stati degli Asburgo. Si consolidavano gli anelli della
catena che rinserravano l’Italia invitando ogni città e
ogni principe a manifestare la propria gioia di accoglie-
Storia dell’arte Einaudi 265
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
re l’imperatore. Il dominio spagnolo era adesso così ben
radicato che Carlo raggiunse facilmente il suo scopo105.
A Roma l’operazione era piuttosto delicata. Il ricor-
do del sacco era rimasto così forte, che si credette pru-
dente porre in stato di allarme Castel Sant’Angelo. Una
parte della popolazione si senti assai a disagio da questi
preparativi. Rabelais scrisse, certo mezzo per burla: «il
papa ha fatto apprestare tre mila letti alla romana, ossia
delle materassa, perché la città ne è sprovvista dal sacco
dei lanzichenecchi»106.
I francesi (compreso Rabelais)107 e gli ambasciatori
degli stati antiimperiali abbandonarono la città in segno
di protesta contro le demolizioni abusive alle quali si era
messo mano fin da gennaio per creare una strada di Para-
ta attraverso la zona archeologica. Un elenco degli edifi-
ci e delle chiesette distrutte in quell’occasione, conserva-
to in un manoscritto al Vaticano, giustifica in gran parte
l’indignazione di Rabelais108. Ma più interessanti sono i
particolari: la piccola cappella di San Lorenzo degli Spe-
ziali al Foro fu eliminata «perché si vedessero le colonne
di Antonino e Faustina»; altri edifici subirono la stessa
sorte «per ingrandire la piazza davanti a palazzo Carafa».
Questa operazione del tutto occasionale anticipava di
mezzo secolo i lavori urbanistici eseguiti sotto Sisto V,
che hanno aperto viali e creato pubbliche piazze e usato
i grandi edifici come punti focali di prospettive. Quella
era una vera novità. Un comitato per i festeggiamenti,
presieduto dal Sangallo, regolava i preparativi per il cor-
teo trionfale. Le sue decisioni indicarono una tendenza
che in seguito portò a numerosi abbattimenti metodici
sotto Paolo III, in particolare a quelli che consentirono
di aprire una prospettiva assiale su Palazzo Farnese, incor-
niciato da una piazza regolare109. Il Colle Capitolino era
in abbandono. Fu deciso di trasportarvi la statua di Marco
Aurelio del Laterano per riaffermare in tal modo che era
per tradizione il centro municipale110.
Storia dell’arte Einaudi 266
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Doveva essere stata prevista una sistemazione monu-
mentale, poiché Michelangelo, che per il momento non
voleva sentirne parlare, promise di occuparsene in segui-
to. E questo doveva portare al meraviglioso ordina-
mento che tutti conosciamo111.
L’ingresso dell’imperatore ebbe luogo il 5 aprile
1536. Per il protocollo del cerimoniale, Paolo III si
ispirò al precedente più vicino, l’ingresso dell’impera-
tore Federico III sotto Paolo II (1° gennaio 1469). Se
ne conoscono i particolari attraverso le numerose rela-
zioni diplomatiche, una cronaca, e due libretti – sfor-
tunatamente non illustrati –, pubblicati in francese ad
Anversa e in italiano a Roma112. Una parte delle «sto-
rie» dipinte fu affidata a Salviati, un’altra alla bottega
di un Martino Tedesco, che si è creduto, un tempo, di
poter identificare con Heemskerck113. Si hanno mag-
giori informazioni sulle trovate del programma che sulle
reazioni dei romani, le quali furono, a dir molto, dispa-
rate. Un vecchio poeta, Tebaldeo, che non aveva dimen-
ticato il 1527, chiuse le imposte della sua abitazione,
che si trovava sul passaggio del corteo, e trattò l’impe-
ratore da criminale114. Ma non vi furono, a quanto pare,
manifestazioni ostili. In occasione della venuta del suo
vincitore, Roma ritrovava l’antico splendore ed esibiva
il suo scenario monumentale e le sue antichità. L’itine-
rario comportava dapprima un giro attraverso la città
antica, che, cominciando a Porta Capena (San Seba-
stiano), attraversava tutti gli archi famosi: Costantino,
Tito, Settimio Severo, per terminare, dopo l’attraver-
samento del foro, a Palazzo San Marco. Battista Fran-
co aveva collocato, ai lati della Porta San Sebastiano, le
statue del Cristo e di San Pietro (questa «rassomiglia-
va all’immagine di san Pietro che sta sul ponte») evo-
cando la scena del «quo vadis?»115. Alla sommità della
porta, fra Numa Pompilio e Tullio Ostilio, «Quirinus
pater» teneva nella destra la tiara, al di sopra dello
Storia dell’arte Einaudi 267
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
stemma pontificio, e nella sinistra la corona, al di sopra
dello stemma imperiale.
Già dall’inizio, Roma si presentava contemporanea-
mente come la città del Cristo e di Pietro, e insieme l’e-
rede della Roma antica, regia e imperiale. L’iscrizione:
«Carolo V Rom. Imp. semer Augusto, tertio Africano»
era illustrata nella decorazione delle due torri, in cui si
vedevano i trionfi dei due Scipioni, il vincitore di Anni-
bale e il distruttore di Cartagine116. La vittoria d’Afri-
ca, che faceva di Carlo un altro Scipione, veniva a col-
locarsi nella gloriosa storia di Roma. Per l’occasione, un
quarto arco «quasi abbastanza simile all’arco di trionfo
di Costantino, era stato aggiunto ai tre grandi archi
antichi». Innalzato da Antonio da Sangallo in Piazza
San Marco, era dedicato a «Carolo. V. Augustus a Deo
coronato, magno, pacifico, Romano Imperatori». Sulle
due facciate erano otto riquadri monocromi. Alcuni rap-
presentavano le battaglie di Tunisi e della Goletta e un
combattimento di cavalleria contro i turchi; gli altri
mostravano Carlo che restituisce al re di Tunisi la coro-
na, libera i prigionieri cristiani, e lascia la città con i suoi
prigionieri di guerra turchi. La decorazione era comple-
tata da statue: sopra a ognuna delle quattro coppie di
colonne d’argento con capitelli dorati stavano dei pri-
gionieri incatenati, e fra le colonne gli imperatori Mas-
similiano, Federico, Alberto e Rodolfo. Ma Roma, rap-
presentata come una dea vittoriosa circondata da trofei,
sormontava l’intera costruzione. Lasciata Piazza San
Marco, il corteo doveva imboccare la Via Papalis fino al
Castel Sant’Angelo. Alla vecchia Cancelleria, accanto al
quadro vivente che raffigurava il suicidio di Cleopatra,
ce n’era un altro con il suicidio di Lucrezia Romana –
esempio di virtù romana imitato, dicevano, nel 1527117.
Otto statue (Evangelisti e Dottori) furono allineate
sul Ponte Sant’Angelo da Raffaello di Montelupo die-
tro le effigi di Pietro e di Paolo118. Finalmente, attra-
Storia dell’arte Einaudi 268
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
verso il Borgo «coperto d’arazzeri a guisa del giorno del
Corpus domini», la sfilata giungeva a San Pietro. A par-
tire di lì, l’accento poggiava non più sul trionfo milita-
re, ma su quello della Chiesa e della fede cristiana. La
prima porta era trasformata in arco trionfale con la scrit-
ta: «Carolo. V. Imperatori semper Augusto Christianae
R. P. propagatori». Due quadri viventi vi rappresenta-
vano san Paolo, convertito, che si metteva alla ricerca
di san Pietro, e san Clemente convertito da san Barna-
ba119. Al di sopra del cornicione, san Pietro era in piedi
fra due Vittorie. Finalmente, alla porta del Vaticano
dedicata a «Carolo. V. Augusto mahometanorum Pavo-
ri, pallorique», lo stemma del papa figurava in mezzo
alle quattro Virtù cardinali e la porta era inquadrata
dalle statue di Cesare Augusto e di Costantino.
La retorica umanistica si era così impegnata a fondo
per celebrare l’imperatore. Pallido, lento e avaro di paro-
le, la sua dignità, il suo nobile portamento impressiona-
rono il popolo romano, sempre sensibile alle apparenze.
La grandiosa sfilata, ordinata come una processione, si
concludeva con una parata di truppe destinata a mette-
re bene in vista l’onnipotenza imperiale. Ma tutta la
cerimonia era stata abilmente organizzata in modo che
davanti al Colosseo, ai piedi del Campidoglio, l’erede
degli imperatori capisse che una storia millenaria lo
dominava. A ogni passo Roma si presentava attraverso
i suoi eroi e i suoi simboli come la capitale dei Cesari
latini e la città della Chiesa. Non era più nello stile
ingenuo delle xilografie per pellegrini, ma nel linguag-
gio sofisticato e colto dello scenario trionfale che si cele-
brava la duplice grandezza romana. Il discorso sottile ma
preciso degli umanisti di Paolo III, eredi dei «cicero-
niani» di Leone X, consentiva di insinuare un ammoni-
mento politico nella parata militare.
L’atroce sacco sembrava dimenticato, cancellato. Al
Ponte Sant’Angelo i cannoni tuonarono «come se l’u-
Storia dell’arte Einaudi 269
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
niverso sprofondasse», dice la cronaca. Non avevano
sparato da nove anni, dal giorno in cui il cardinale Ales-
sandro Farnese stava accanto a Clemente in lacrime
sotto la protezione dell’artiglieria di Cellini. Il papa ora
aspettava seduto all’ingresso di San Pietro, vestito del
piviale e della tiara. Carlo, in abito semplice, di un vio-
letto omogeneo che ne accentuava il pallore, si accostò,
si genuflesse una poi due volte, e baciò il piede del pon-
tefice, «etiam aliquantum retrahentis pedem», dice il
cronista romano. Poi il papa gli prese la mano, l’ab-
bracciò e lo introdusse nella basilica.
Veniva ripreso il rito seguito per Costantino da Sil-
vestro. La Curia vi annetteva grandissima importanza
poiché si riaffermava così il primato dell’autorità spiri-
tuale. Si trascorse una settimana in passeggiate archeo-
logiche, colloqui politici, dichiarazioni antifrancesi, atte-
stazioni di fedeltà alla Chiesa. La domenica 16 aprile, il
giorno di Pasqua, l’imperatore ricevette l’incenso, dopo
il papa, all’Offertorio. Terminata la funzione, il papa e
l’imperatore si recarono in uno spazio all’interno della
basilica, sempre chiuso da un coro provvisorio – dove
era stato eretto un baldacchino. La ebbe luogo in loro
onore l’ostensione delle grandi reliquie ritrovate: il ferro
della lancia e il Vultus Sanctus. La visita di Carlo assu-
meva il valore di un pellegrinaggio. Tutto aveva ritro-
vato il proprio posto, in un certo qual modo, e anche la
storia.
Così, attraverso il cerimoniale, le scene simboliche
venivano di nuovo rappresentate. La Chiesa riafferma-
va la propria autorità. Roma riconquistava il proprio pre-
stigio antico e cristiano insieme, culturale e devoziona-
le. La cerimonia, che celebrava la vittoria della Chiesa
sugli infedeli e sugli eretici, discolpava definitivamente
Carlo della responsabilità del sacco e lo collocava nella
linea dei grandi imperatori. L’evento non fu celebrato
da stampe o da poesie di circostanza.
Storia dell’arte Einaudi 270
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Sussisteva un cerio riserbo. Tutto lo sforzo degli arti-
sti era stato concentrato sulle decorazioni e sugli archi.
Come diceva un epigramma: «Omnia nunc merito
cedant miracula Romae: | Qui Paulus priscum, reddidit
omne decus»120.
Quello di cui si intendeva serbare il ricordo fu espres-
so, al modo romano, con una decorazione di facciata. Sul
Palazzo Crivelli, costruito due anni più tardi a Via Giu-
lia con una decorazione sfarzosa a fasce e pannelli, ven-
nero collocati al di sopra di due finestre due bassorilie-
vi, raffiguranti l’uno Carlo V che bacia il piede di Paolo
III, l’altro l’abboccamento di Nizza121. Un pageant fran-
cese in onore di Wolsey, dell’estate 1527, fu la prima
raffigurazione del sacco di Roma. Un altro pageant,
esclusivamente romano, ha concluso nella primavera del
1536 il penoso episodio politico e militare aperto fin dal
tempo di Pavia e della Lega di Cognac – dieci anni di
violenze e di confusione in Italia. All’arrivo delle bande
cenciose e litigiose del conestabile di Borbone si con-
trappose la sfilata impeccabile di quattromila fanti impe-
riali in ranghi di sette, seguiti da cinquecento cavalieri,
dai Grandi di Spagna, dai cardinali e dalla guardia cesa-
rea. Alla figura di Carlo di Borbone morente, ferito da
un colpo di balestra nella grigia alba del 7 maggio 1527,
si contrappose la sottile silhouette dell’imperatore su di
un cavallo bianco. Se possiamo stabilire questa equiva-
lenza, lo dobbiamo al fatto che la storia passa sempre
attraverso rappresentazioni del genere – nel duplice
significato di simbolo e di spettacolo; il loro susseguirsi
ne costituisce appunto l’essenza.
1
Secondo sanuto, Diarii cit., XLVI, p. 645. Citato da hook, The
Sack ol Rome cit., p. 239.
2
sanuto, Diarii cit., XLIX, p. 134. Citato da hook, The Sack of
Rome cit., pp. 241-242.
Storia dell’arte Einaudi 271
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
3
hook, The Sack of Rome cit., p. 245.
4
d . gnoli, Il Sacco di Roma e la peste, in «Nuova Antologia», II
serie, 26 (1880), 15 dicembre, pp. 746 sgg.
5
Citato da von pastor, Storia dei papi cit., vol. IV, parte II, libro
III, p. 323.
6
Cfr. cap. iv.
7
Lettera di Iano Calvo Salimbeni alla Balia di Siena, datata da
Viterbo, il 4 ottobre 1528, a proposito del ritorno di Clemente a
Roma: «... Così intendano V. S. ill.me che a li sei [maggio] fu presa
Roma, a li sei [giugno] si arrese il castello, alli sei [dicembre] si partì
verso Orvieto, et alli sei [ottobre 1528] vol far la tornata. Cosa che mi
è parsa degna di annotazione». Pubblicata da c. p. falletti-fossati,
Clemente VII e l’impresa di Siena, il Sacco di Roma, l’assedio di Napoli,
Siena 1879.
8
Cfr. cap. iii.
9
Il Giornale di Biagio da Cesena (Blasius de Martinellis) menzio-
na l’ostensione del Volto Santo per la settimana santa del 1533. Cfr.
chastel, La Véronique cit., p. 78 e nota 38.
10
Cfr. cap. iv.
11
m. dell’arco, Pasquino e le Pasquinate, Milano 1957, p. 108.
12
hook, The Sack of Rome dt., pp. 245-46.
13
c. roth, The Last Florentine Republic. 1527-1530, London 1925,
p. 133.
14
Dopo la sconfitta di Gavinana (vicino a Pistoia), il 3 agosto
1530, che vide la morte di Ferruccio, il migliore sostegno della causa
fiorentina, e nello stesso tempo quella del principe d’Orange, «i Fio-
rentini – scrisse il Guicciardini – rimanevano senza risorse; la carestia
produceva sofferenze terribili senza speranza di alleviarle, una situa-
zione che, invece di indebolire l’ostinatezza di una parte 1 dei cittadi-
ni, serviva solo a rafforzarla: questa gente disperata sognava unica-
mente di sacrificarsi e far perire con loro la nazione. Non si trattava
più di salvarla al prezzo della loro vita o di quella di altri concittadini,
ma solo di far sì che le sue rovine fossero la loro tomba» [questo passo
corrisponde a L. XX, p. 143, dell’ediz. della Storia d’Italia, Pisa 1824].
g. parenti, Prime ricerche sulla rivoluzione dei prezzi in Firenze, Firen-
ze 1939, ha sottolineato l’effetto che ebbero gli avvenimenti del 1530
sulla vita economica di Firenze.
* [«Il Sette è inferiore al Cinque, chi lo crederebbe? Il Cinque ha
l’impero, il Sette l’esilio»].
15
Questo visitatore, al quale né l’imperatore né soprattutto il papa
annetterono sufficiente importanza, fu il padre di Anna Bolena diven-
tato conte di Wiltshire. Intervenne a nome di Enrico VIII per otte-
nere un accordo politico e il famoso divorzio chiesto dal re. Egli fu con-
gedato. Wolsey doveva morire sul finire del 1530; la mediazione che
Storia dell’arte Einaudi 272
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
aveva sognato durante l’estate del 1527 (cfr. cap. i) non aveva più
senso. La Spagna dominava l’Italia e l’Inghilterra lasciava, con Enrico
VIII, la chiesa romana. Le preoccupazioni di Enrico VIII riguardo
al suo divorzio non smisero di manifestarsi durante tutto il periodo:
s. ehses, Römische Dokumente zur Geschichte der Ehescheidung Hein-
richs VIII. von England. 1327-1534, in Quellen und Forschungen aus dem
Gebiete der Geschichte, Paderborn 1893.
16
Un certo numero di manifestazioni artistiche portano la traccia
di questa «liberazione» di Firenze e del suo ritorno alla «repubblica cri-
stiana». Un mottetto, Florentia tempus est penitentiae, dovuto a C.
Festa, riprende l’appello «piagnone» alla penitenza, concludendo con
una supplica: «Clemens peccavi, miserere mei», che sembra veramen-
te preparare un accordo con il papa. Cfr. «Journal of American Musi-
cological Society», 3 (1950).
Un retroscena politico preciso è stato messo in luce da j. f. o’gor-
man, An Interpretation of Andrea del Sarto’s Borgherini Holy Family, in
«Art Bulletin», 47 (1965), pp. 502-4, nella pala d’altare dipinta per
Giovanni Borgherini, che apparteneva all’opposizione antimedicea e
fece parte con Niccolò Capponi del gruppo di aristocratici che prese-
ro il potere dopo l’espulsione del maggio 1527. Questa notizia è stata
recentemente completata e leggermente sfumata da f. gilbert, Andrea
del Sarto «Heilige Familie Borgherini» und florentinische Politik, in Fest-
schrift für Otto von Simson zum 65. Geburtstag a cura di L. Grisebach e
K. Renger, Frankfurt 1977, pp. 284-88. La composizione è posterio-
re al febbraio 1528, quando il Cristo fu proclamato «Rex populi flo-
rentini» (il che non implica una teocrazia, ma il ritorno alla libertà
repubblicana, sottolineato dal fatto che il globo è sorretto dal Gio-
vannino fiorentino, che lo presenta al Bambino Gesù); essa è anterio-
re all’aprile 1529, che vide l’eliminazione del gonfaloniere Capponi.
17
Sull’ingresso a Bologna e le pubblicazioni che lo illustrano, cfr.
in Fétes et cérémonies au temps de Charles-Quint cit.; v. terlinder, La
politique italienne de Charles-Quint et le «triomphe» de Bologne, pp. 29
sgg.; j. jacquot (a cura di), Panorama des fêtes et cérémonies du règne.
Entrée et couronnement de Bologne... 1 pp. 43 sgg., con bibliografia.
Lo studio di g. giordani, Cronaca della venuta e dimora a Bologna
del Sommo Pontefice Clemente VII per la coronazione di Carlo V impe-
ratore, Bologna 1842, contiene la documentazione completa sui prepa-
rativi della città di Bologna e le modalità dell’incoronazione.
18
GIORDANI, Cronaca cit.: «tutte cose essendo a similitudine
della Basilica Vaticana».
19
Stanza di Costantino. Cfr. cap. ii.
20
N. Hogenberg: 40 tavole, rist. da W. S. Maxwell, Edinburgh
1875. R. Péril: 16 tavole, unico esemplare completo conservato all’Al-
bertina, Vienna. Testo dell’iscrizione nella serie di R. Péril: «Carolus
Storia dell’arte Einaudi 273
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
ille ego sum quintus hoc nomine Caesar. Natus ad Imperium Romana
ut sceptra tenerem. Est animus fessas mutasque reponere leges jura tri-
bunorum fasces priscosque Quirite Patricios revocare reducere pacem
antiquam correcta morum omnia in servato tramite legibus et veterum
jurisque vetusti consiliis armisque meis frenare superbos oppressos
relevare manu primevo Capitolia prisca nitori viros sanctumque sena-
tum reddere».
21
jacquot, Panorama cit., p. 425.
22
geisberg, Die Reformation cit., III (1930), tav. 139; g. stuhb-
fauth, Dreizeitgeschichtlichen Flugblättern des Hans Sachs mit Hand-
schriften des Georg Pencz, in «Zeitschrift für Bücherfreunde», 10
(1918-19), pp. 237 sgg.
23
sanuto, Diarii cit., XLVII, col. 349. Cfr. anche XLV, coll.
488-89; una lettera di Alvise Lippomani al vescovo di Bergamo, data-
ta da Orvieto il 7 gennaio 1528, indica che il tenore di vita della corte
pontificia a Orvieto era simile a quello dei primi tempi della Chiesa.
24
[Uno dei tre tribunali curiali, costituiti da dieci Prelati (audito-
res), che svolgevano le funzioni proprie della corte d’appello].
25
In schard, Historicum opus cit., pp. 1858 sgg.
26
sanuto, Diarii cit., XLVIII (1528), 6 luglio, col. 226. Svetonio
riferisce che Cesare ebbe la stessa reazione dopo il massacro del distac-
camento di Titurio (Cesare, 67). Cfr. r. reynolds, Beards, an Omnium
Gatherum, London 1950, e l’articolo di zucker, Raphael and tbe Beard
of Pope Julius II cit.
27
Nella Cena di San Gregorio destinata a San Michele in Bosco. p.
barocchi, Vasari pittore, Milano 1964, p. 17 e tav. v (pp. 114-15).
28
È stato identificato, nella Stanza di Costantino, il ritratto di Cle-
mente imberbe nell’effigie di San Leone 1 (o Clemente 1) fra Innocentia
e Veritas a destra del Battesimo. A sinistra di questa stessa scena, fra
Pax e Prudentia, quello di Urbano 1 (o Evaristo) sarebbe il ritratto di
Clemente barbuto. Cfr. fischel, I ritratti di Clemente VII nella sala di
Costantino in Vaticano cit., pp. 923 sgg. Se è davvero così, l’inserzio-
ne simmetrica in questa sala, al posto del ritratto precedente, è signi-
ficativa.
29
reynolds, Beards cit.
30
zucker, Raphael and the Beard of Pope Jutius II cit., pp. 524 sgg.
Noi accettiamo la linea generale di questo studio eccellente, di cui il
«Poscritto» nei riguardi di Clemente VII ha soltanto bisogno di esse-
re completato e sfumato.
31
In una lettera del 1518, Bembo scrive: «Ho buon viso et sommi
levato la barba che era assai lunga». Sembra che sia rimasto fino al
1536, quando il suo ritorno alla barba lunga fu notato da B. Cellini in
una lettera citata da Bottari e ticozzi, Raccolta cit., vol. I, p. 14. Fu
il suo aspetto definitivo, ben noto dai ritratti di Tiziano, dal mosaico
Storia dell’arte Einaudi 274
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
degli Zuccati, ecc. Cfr. g. coggiola, Per l’iconografia di Pietro Bembo,
in «Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 74
(1914), pp. 473 sgg.
32
e. rodocanachi, Les Ponfificats d’Adrien VI et de Clément VII,
Paris 1933, p. 57.
33
hook, The Sack of Rome cit., p. 240. In uno dei suoi poemi umo-
ristici, Berni rimpiange che Domenico d’Ancona, il quale ha sacrifica-
to la sua bella barba su richiesta di Giberti, non si sia fatto piuttosto
tagliare la testa per esporla degnamente: «Almen. gli avessi tu tagliato
il collo | più tosto che guastar si bella cosa; | che si saria potuto imbal-
samare, | e fra le cose rare | poner sopra ad un uscio in prospettiva |
per mantener l’imagine sua diva» (berni, Poesie e prose cit).
34
pierio valeriano bolzani, Pro sacerdotum barbis, Roma 1531.
(L’esemplare consultato è stato quello della Biblioteca dei Congresso a
Washington).
35
Da parte dei Riformati, ci furono anche problemi di toeletta del
clero. In Die Gantz Bibel, presso Köppel, Basel 1530, fol. lxiiv, l’in-
cisione, forse dovuta a Vogtherr il vecchio, illustra la tonsura dei preti,
che è da respingere, in contrasto con la raccomandazione del testo bibli-
co in favore della barba: «Er soll auch kein blatten machen auf seinem
Haupt noch seinen Bart abscheren...» (questo riferimento è dovuto alla
cortesia di Jean Wirth).
36
vasari, Le vite cit., VII, p. 44.
37
e. martinori, Annali della Zecca di Roma: Clemente VII
(1523-1534), in «Atti e Memorie dell’Istituto Italiano di Numismati-
ca», vol. 3, Roma 1917.
38
e. camesasca, Tutta l’opera del Cellini, Milano, 1955, n. 2 D; ed
e. e. plon, Benvenuto Cellini, Paris 1883, p. 196 sgg. I due pezzi sono
descritti separatamente nel Trattato d’oreficeria. Gli eserghi del rove-
scio «Pro eo ut me diligerent: Ecce Homo. Roma» (martinori, Anna-
li della Zecca di Roma cit., n. 6); «Ut omnis terra adoret te» (n. 7).
39
camesasca, Tutta l’opera del Cellini cit., n. 2 A e B.
40
bonannus, Numismata Pontificum Romanorum cit., vol. I, pp. 184
sgg., n. xi.
41
Ibid., nn. xvii e xv, testo p. 196.
42
Ibid., n. ix, testo p. 192. Secondo rodocanachi, Le Cháteau
Saint-Ange cit., p. 138, la medaglia sarebbe esistita in tre tipi; il model-
lo riprodotto da Bonannus sarebbe quindi apocrifo.
43
Con lo stesso spirito, l’iniziativa di costruire un pozzo profondo
a doppia rampa (per il passaggio dei cavalli) al fine di assicurare l’ap-
provvigionamento della città di Orvieto nel 1527-28, fu commemora-
ta con la medaglia di Mosè che colpisce la roccia (Esodo 17,6): bonan-
nus, Numismata Pontificum Romanorum cit., n. X, p. 192.
44
vasari, Le vite cit., VI, p. 153.
Storia dell’arte Einaudi 275
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
45
borgatti, Castel Sant’Angelo in Roma cit., pp. 165 sgg. La storia
dell’angelo dell’incoronazione è piuttosto complicata: a ricordo della
processione votiva e del prodigio sopravvenuto al tempo di Gregorio
Magno, Nicola III fece collocare sulla cima un angelo, che da allora si
vede raffigurato sulle miniature e sui quadri; questa figura fu distrut-
ta nel 1379 durante certi torbidi di Roma; Nicola V si adoperò a
restaurare il Castel Sant’Angelo e nel 1453 è terminato «l’Agniolo
nuovo messo in chastello» (secondo il documento del pagamento), di
marmo, o, più probabilmente, di legno con ali di bronzo. Il 29 ottobre
1497, il fulmine provocò l’esplosione di una polveriera che distrusse «la
statua dorata dell’angelo tenente la spada fuori del fodero».
46
b. fontana, Documenti vaticani contro l’eresia luterana in Italia,
in «Archivio della Reale Società Romana di Storia Patria», 15 (392),
pp. 71 sgg.
47
Louvre, Inv. 92.
48
vasari, Le vite cit., IV, p. 226. Sostituita dal bronzo, ancora visi-
bile, di Giardoni.
49
Cfr. j. a. gere, Two Late Fresco Cycles by Perino del Vaga: the Mas-
simi Chapel and the Sala Paolina, in «The Burlington Magazine», 102
(1960), pp. 8-19.
50
Cfr. a. chastel, Two Roman Statues: Saint Peter and Paul, in Col-
laboration in Italian Renaissance Art, a cura di Sheard e Paoletti, New
Haven 1978, pp. 59-63.
51
Un fatto di cronaca drammatico del giubileo del 1450 è, fra gli
altri, riferito da un cronista, Andrea Fulvio: «La grande folla ritorna-
va dall’aver visitato il Sudario, essendosi imbattuta in una mula e non
potendo indietreggiare né dall’una né dall’altra parte per quelli che die-
tro incalzavano, molti furono schiacciati sotto le zampe de’ cavalli e
sotto i piedi della folla stessa, molti altri caduti dai lati annegarono».
In seguito a ciò il pontefice Nicola V fece erigere le due cappellette
all’ingresso orientale del ponte, l’una edificata a Santa Maria Madda-
lena, l’altra ai Santi Innocenti. Cfr. borgatti, Castel Sant’Angelo in
Roma cit., pp. 167 sgg.
52
vasari, Le vite cit., IV, p. 580.
53
e. mâle, Les Apôtres Pierre et Paul, in «Revue des Deux Mondes»,
15 luglio e 1° agosto 1955. Su questa duplice devozione fondamenta-
le: c. pietri, Roma christiana. Recherches sur l’église de Rome, son orga-
nisation, sa politique, son idéologie, de Miltiade à Sixte III (311-440),
Roma 1976, cap. xviii: Iam regnant duo apostolorum principes.
54
vasari, Le vite cit., 11, p. 649- Secondo v. golzio e g. zander,
L’arte in Roma nel secolo XV, Roma 1968, pp. 338 e 435, il San Paolo
di Paolo (Taccone) Romano (1463-64) doveva essere stato collocato in
Cima alla scala della basilica vaticana.
55
torrigio, Le sacre grotte vaticane cit., p. 385. L’autore aggiunge:
Storia dell’arte Einaudi 276
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
«Haec duo sacella visuntur depicta in templo sanctissimae Trinitatis
in Monte Pincio». Tratteremo un po’ più avanti di questo affresco della
Trinità dei Monti.
56
La ricostruzione del ponte che conduce al mausoleo, il futuro
Ponte Sant’Angelo, è degna di attenzione, anticipa le due serie di
quattro statue che verranno innalzate nel 1536 per l’ingresso di Carlo
V, e saranno esse stesse un punto di riferimento per il futuro proget-
to del Bernini (m. s. weil, The History and Decoration of Ponte Sant’An-
gelo, University Park [Pa.] 1974, pp. 90 sgg.).
57
f. spada, Alcune mie congetture intorno ad una iscrizione monu-
mentale di Pietro Bembo quale essa leggesi sotto la statua di San Paolo nella
faccia posteriore del suo piedestallo al Ponte Sant’Angelo in Roma, Roma
1886; cfr. c. d’onofrio, Il Tevere a Roma, Roma 1968.
58
Abbiamo pubblicato una parte di queste osservazioni sotto il tito-
lo La cappella di San Michele alla Trinità dei Monti, negli «Atti» del col-
loquio sulle pie fondazioni francesi, tenuto a Roma nel maggio 1978,
Roma 1981.
59
Questo si spiega chiaramente con ciò che segue. Il testo è un’ag-
giunta del 1568 (VII, p. 204). Cfr. p. barocchi, Giorgio Vasari, in La
vita di Micbelangelo nelle due redazioni del 1550 e del 1568, Milano
1.962, VOI. III, p. II.
60
c. de tolnay, Michelangelo, vol. V: The Final Period, Princeton
1960, p. 103, fig. 133; h. thode, Michelangelo. Kritische Untersuchun-
gen Ɵber seine Werke, vol. II, Berlin 1913, p. 75, ha suggerito che la
straordinaria composizione di Rubens (Monaco) sul tema deve proba-
bilmente qualcosa a Michelangelo.
61
In particolare Gaspare Celio nel 1638, menzionato da de tolnay,
Michelangelo cit., fig. 17; e da f. titi, Descrizione delle pitture, sculture e
architetture di Roma, Roma 1763, p. 377. Sono vivamente grato a Isabella
Balsamo delle indicazioni che mi ha cortesemente fornito al riguardo.
62
vasari, Le vite cit., V, p. 213.
63
Ibid., pp. 601-2. Cfr. lo studio fondamentale di brugnoli, Gli
affrescbi di Perin del Vaga nella Cappella Pucci cit., pp. 327 sgg. (per la
datazione, p. 328).
64
Cfr. cap. iii e lo studio di pecchiai, Roma nel Cinquecento cit.
65
Si noterà il lapsus caratteristico di f. titi, in Nuovo studio di pit-
tura, scultura ed architettura nelle chiese di Roma, Roma 1721, p. 397:
«Nella croce della chiesa vi sono molte pitture nella volta e da per tutto,
e fra l’altro il Giudizio e benche sia mal condotto, vi si vede non so
ché di terribile e vario nell’attitudine e grupi di queli ignudi, il tutto
condotto da un siciliano, che serviva Michel’angelo Buonarota; ed è
uno de’ disegni che fu. fatto per il Giudizio da dipingersi nel Vatica-
no». Non si tratta evidentemente del Giudizio ma della Caduta degli
angeli ribelli, confusi in una stessa definizione della «terribilità».
Storia dell’arte Einaudi 277
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
66
La leggenda di san Michele è riferita con tutti questi episodi nella
Leggenda aurea alla data del 29 settembre. Cfr. o. rojdestvensky, Le
culte de saint Michel et le Moyen-Age latin, Paris 1922.
67
Si tratta della seconda versione del tema, al Carmine di Siena. Si
è d’accordo oggi nel datare la pala del Carmine intorno al 1528, dati i
suoi legami stilistici con la pala Saraceni del 1528 (d. sanminiatelli,
Domenico Beccalumi, Milano 1967, n. 43, pp. 101-2).
Vasari (Le vite cit., V, p. 638) parla di cinque «storiette». L’appa-
rizione di san Michele sul mausoleo di Adriano: disegno agli Uffizi, e dise-
gno acquarellato a Windsor (pubblicato da c. brandi, Disegni inediti di
D. Beccafumi, in «Bollettino d’Arte», serie 28 [1934], pp. 35 sgg. r san-
miniatelli, Domenico Beccafumi cit., pp. 139-40); pannello al Carne-
gie Institute a Pittsburgh: f. zeri, Due storie di san Michele di Dome-
nico Beccafumi, in Diari di lavoro, Bergamo 1971, pp. 79-80. Il mira-
colo di Monte Gargano figura parimente fra gli altri episodi.
68
Il Cfr. cap. 1, e chastel, Two Roman Statues cit.
69
Nel 1575, nella Sala degli Angeli di Caprarola, le medesime scene
furono dipinte all’interno di un ciclo più completo poiché include
Gedeone, Daniele ed episodi biblici che illustrano l’intervento di esse-
ri celesti. L’apparizione sul mausoleo è opera di Giovanni de’ Vecchi,
che manifestamente si è ricordato della composizione sulla Trinità dei
Monti, con la visione delle mitrie episcopali dinanzi all’immagine della
Madonna; soprattutto, le due statue anacronistiche sono in evidenza,
come nella cappella Chateauvillain. L’interpretazione tutta moderna dei
costumi e dei tipi dipende da un principio generale, il riferimento alla
storia recente non è esplicito. Cfr. r. roli, Giovanni de’ Vecchi, in
«Arte Antica e Moderna», 29 (1965), p. 52; f. zeri, Pittura e Contro-
riforma, Torino 1957, p. 109.
70
Cfr. cap. v.
71
fenyö, Der Kreuztragende Christus Sebastiano del Piombos in Buda-
pest cit., pp. 151 sgg.
72
freedberg, Painting in Italy cit., p. 488 nota 72.
73
hirst, Sebastianos Pietà for the Commendayor Mayor cit., pp. 585 sgg.
74
Vasari spiega il perché risalendo agli avvenimenti del 1529:
«Intanto venuto l’esercito del papa all’assedio di Firenze. Sua Santità
mandò Baldassarre in campo a Baccio Valori commissario, acciò si ser-
visse dell’ingegno di lui n’bisogni del campo e nell’espugnazione della
città. Ma Baldassarre amando più la libertà dell’antica patria, che la gra-
zia del papa, senza temer punto l’indignazione di tanto pontefice, non
si volle mai adoperare in cosa alcuna di momento; di che accortosi il
papa, gli portò per un pezzo non piccolo odio. Ma, finita la guerra, desi-
derando Baldassarre di ritornare a Roma, i cardinali Salviati, Trivul-
zio e Cesarino, i quali tutti aveva in molte cose amorevolmente servi-
ti, lo ritornarono in grazia del papa, e ne’ primi maneggi; onde poté
Storia dell’arte Einaudi 278
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
liberamente tornarsene a Roma» (Le vite cit., IV, p. 603). Fu allora che
Peruzzi studiò la costruzione nel nuovo Palazzo Massimo, 1532 sgg.
75
von pastor, Storia dei papi cit., vol. V, pp. 747 sgg.
76
Non riusciamo a scorgere un rapporto interessante fra la lettera
del 27 settembre di Sadoleto spesso – forse troppo spesso – citata, che
commenta di lontano, e in modo religiosamente prudente, gli avveni-
menti di Roma, e il presunto stato d’animo di Clemente e di Miche-
langelo, come lo suggerisce c. lanckoronska, Appunti sulla interpreta-
zione del Giudizio Universale di Michelangelo, in «Annales Instituto-
rum», 1932-33, p. 125.
77
L’umanità perde la sua sicurezza in presenza del Signore. Quel
che Michelangelo manifesta o invita imperiosamente i fedeli a prova-
re dinanzi a questo vasto avvenimento figurato, è il peccato. L’uomo
deve sapere che la sua natura è colpevole nei confronti del Signore, e
gli Eletti stessi sembrano tremare ancora (de tolnay, Michelangelo cit.,
V, p. 40).
78
milanesi, I corrispondenti di Michelangelo cit., p. 106; de tolnay,
Michelangelo cit., V, pp. ig, 98 sgg.
79
Sulle date, barocchi, Giorgio Vasari cit., pp. 1404 sgg.
80
vasari, Le vite cit., V, pp. 579-80. Cfr. m. chiarini, Pittura su
pietra, in «Antichità viva», 9 (1970), fasc. 2, pp. 29-37.
81
Michelangelo a Sebastiano (vasari, Le vite cit., V, p. 584); «la
scarpa di mattoni» (ibid., VI I, pp. 209- 10).
82
Questo concetto di un centro calmo e del tumulto che esso pro-
voca, corrisponde a quello di Leonardo nella Cena di Santa Maria delle
Grazie.
83
lanckoronska, Appunti sulla interpretazione del Giudizio cit. L’ar-
ticolo di m. b. hall, Michelangelo’s «Last Judgment» Resurrection of the
Body and Predestination, in «The Art Bulletin», 58 (1976), pp. 85 sgg.,
ha formulato un punto di vista nuovo, che non riteniamo dover discu-
tere qui.
84
l. steinberg, Michelangelo’s Last Judgement as Merciful Heresy, in
«Art in America», 63 (1975), pp. 48-63: Le idee eretiche di Miche-
langelo (ereditate da Erasmo e soprattutto da Valdés), successivamen-
te ignorate dalla critica e nelle riproduzioni incise eseguite dopo lo sco-
primento dell’opera, consistono nel rifiuto di una dannazione eterna
(Cristo esitante, privo di collera, assenza di iatus fra il cielo e l’infer-
no, piccolo numero di dannati in rapporto agli eletti...)
85
a. condivi, Vita di Michelangelo Buonarroti, Roma 1553, in p.
d’ancona, a. pinna, i. cardellini (a cura di), Michelangelo, Milano,
1964, p. 231.
86
vasari, Le vite cit., VII, p. 210. Le riserve sugli apprezzamenti
di Condivi e Vasari si trovano in de tolnay, Michelangelo cit., p. 122.
87
Probabilmente fin dal 1536, anno in cui la venuta di Carlo V
Storia dell’arte Einaudi 279
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
attirò a Roma la contessa. Cfr. steinmann, Die Sixtinische Kapelle cit.,
II, p. 499.
88
Queste conversazioni del 1538 circa, a cui partecipava Vittoria
Colonna, e in cui Fra Ambrogio Caterino svolgeva le sue esegesi pao-
line, sono riferite da Francisco de Holanda di seguito al Tractato de pin-
tura antiqua (1548), in Dialoghi micbelangioleschi di Francesco d’Olan-
da, a cura di A. Aureli, Roma 1926.
Caterino pronunzierà nel 1555 la condanna degli ignudi della Cap-
pella Sistina: «Commendo artem in facto; at factum ipsum vehemen-
ter vitupero ac detestor» (citato da r. de maio, Riforme e miti nella
Chiesa del Cinquecento, Napoli 1973, p. 98 nota 1).
89
barocchi, Giorgio Vasari cit., p. 126o: lettera di Nino Sernini del
19 novembre 1541.
90
vasari, Le vite cit., VII, p. 211.
91
Ibid., V, p. 456. Cfr. a. chastel, Les «ignudi» de Michel-Ange,
in Fables, Formes, Figures cit., p. 284.
92
Ibid., p. 285.
93
Un documento del 1545, a quanto pare parla dell’«Inventore delle
porcherie» (l. dorez, La Cour du Pape Paul III, Paris 1932, vol. I, p.
154 nota 4).
In una lettera del 15 agosto 1546 di Paolo Giovio al cardinale Ales-
sandro Farnese, si legge: «Qual si è scandalizzato per esser dipinto il
simulacro del Vaticano coi segno di maschio et il Ricciotto pittore se
n’è appellato a Michelangelo in Capella Xysti: pur, per levar il rumore,
gli faccio attaccare un foglio di platano». Cfr. a. ronchini, Giorgio
Vasari alla corte del cardinal Farnese, in «Atti e Memorie delle R. R.
Deputazioni di Storia Patria per le Provincie Modenesi e Parmensi»,
2 (1864), p. 126 nota 1.
94
Francisco de Holanda, citato nota 88. La critica recente propen-
de per l’autenticità dei Dialoghi, cfr. r. j. clements, Michelangelo’s
Theory of Art, London 1961, pp. xxiv sgg.; e i. cardellini, Michelan-
gelo e i contemporanei, in Michelangelo cit., p. 66.
95
Sonetto «Veggio nel tuo bel viso, Signor mio», in Rime, a cura
di E. N. Girardi, Bari 196o, p. 46. c. l. frommel, Michelangelo and
Tommaso dei Cavalieri, Amsterdam 1979, data dall’anno 1533 l’inizio
della passione di Michelangelo per T. Cavalieri; vi vede, come altri, una
delle ragioni della sua venuta definitiva a Roma, e pone il rinnovamento
dell’ispirazione «platonica» dell’artista-poeta, in rapporto con la con-
cezione del Giudizio universale (pp. 93 sgg.).
96
Cfr. a. chastel, Il dictum Horatii quidlibet audendi potestas e gli
artisti (XII-XVI secolo), in «Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
Comptes rendus», gennaio-marzo 1977, pp. 30 sgg., ripreso in Fables,
Formes, Figures cit., I, pp. 363 sgg.
97
g. vasari, Le vite cit., V, pp. 623-24.
Storia dell’arte Einaudi 280
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
98
p. pouncey e j. a. gere, The Drawings of Raphael’s Circle, Lon-
don 1962, n. 194; j. rowlands, Rubens, Drawings and Sketches, Lon-
don 1977, n. 53. Il disegno è stato utilizzato per un fregio di Palazzo
Spada.
99
Cfr. vasari, Le vite cit., VII, p. 209: «Desiderando Sua Santità
che sotto il Iona di Cappella ove era prima l’arbore di Papa Giulio II
mettervi la sua, essendone ricerco, per non fare torto a Giulio e a Cle-
mente non ve la volse porre dicendo non istare bene» (condivi, Vita
di Michelangelo cit., p. 231). «Nella qual opera, per essere stata inven-
zione di Papa Clemente, ed al tempo di lui aver avuto principio, non
pose l’arma di Paolo, contuttoché il Papa ne lo avesse ricercato».
A. Bertini-Calosso ha creduto di poter identificare i ritratti di Cle-
mente VII e di Paolo III in due figure accovacciate l’una dietro san Pie-
tro, l’altra dietro Adamo: Ritratti del Giudizio Universale, in Michelan-
gelo Buonarroti nel IV centenario del Giudizio Universale, 1541-1941,
Firenze 1942, pp. 45 sgg. Le figure inserite in secondo piano negli spazi
come personaggi celebri facilmente riconoscibili sono abbastanza nume-
rose; esse non ci sembrano prestarsi a un’interpretazione così precisa
come è stata proposta.
100
Pubblicata in e. alberi, Le relazioni degli ambasciatori veneti al
Senato durante il secolo decimosesto, Firenze 1855, VOI. III, p. 299.
101
lanciani, The Golden Days of the Renaissance cit., p. 107. Que-
sto punto è stato sviluppato nel nostro capitolo La cour des Farnèse, nel-
l’opera collettiva Le Palais Farnèse, Roma 1981, vol. II.
102
chastel, La cour des Farnèse cit.
103
a. michaelis, Geschichte des Statuenhofes, in «Jahrbuch des deut-
schen Instituts», 5 (189o), p. 32; citato da dorez, La cour de Paul III
cit., p. 214.
104
lanciani, The Golden Days cit., p. 110.
105
Sui «trionfi» italiani di Carlo V nel 1535-36, cfr. chastel, Les
entrées de Charles Quint en Italie cit., pp. 197-206; e jacquot, Panora-
ma de Fétes et cérémonies du règne. Entrées italiennes (1535-1536) cit.,
pp. 427-33. Nel volume a cura di M. Fagiolo, Roma 1979, La città effi-
mera e l’universo artificiale del giardino, c’è alle pp. 63 sgg., un saggio
di m. l. madonna, L’ingresso di Carlo V a Roma, con ricostruzioni pre-
cise degli «apparati».
106
Lettres écrites d’Italie, a cura di V. L. Bourrilly, Paris 1910, p. 38.
107
Lettera del 28 gennaio a geoffroy d’estissac, ibid., p. 56.
108
Giornale di alberini, Ricordi cit. Cfr. lanciani, Storia degli scavi
cit., vol. II, pp. 58 sgg.; e dorez, La Cour de Paul III cit., I, pp.
250-60.
109
Sulla sistemazione urbana intorno a Palazzo Farnese, cfr. p.
murray, Italian Renaissance Architecture, London 1969, pp. 166 sgg.;
e il mio La Cour des Farnèse cit.
Storia dell’arte Einaudi 281
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
110
t. buddensieg, Zum Statuenprogramm in Kapitolplan Pauls III., in
«Zeitschrift für Kunstgeschichte», 39 (1969), pp. 177-228.
111
Cfr. j. s. ackermann, The Architecture of Michelangelo, London
1959 [trad. it. L’architettura di Michelangelo, Torino 1968, pp. 50-66
e 179-981.
112
z. ceffino, La triumphante entrée de l’Empereur nostre Sire Cbar-
les le Cinquiesme toujours auguste faicte en sa très noble cité de Rome,
testo francese, Anversa 1536, versione italiana, Roma 1536; andrea
sala, Ordine, pompe, apparati, et ceremonie della solenne entrata di Carlo
V Imperatore sempre Augusto nella città di Roma, riedito in v. forcella,
Tornei e giostre, ingressi trionfali e feste carnevalesche in Roma sotto Paolo
III, Roma 1885, pp. 39-50; b. podesti, Carlo Quinto a Roma nell’an-
no 1536, in «Archivio della Società romana di Storia Patria», 1 (A78),
pp.-303-44; f. cancellieri, Storia dei solenni possessi de’ sommi ponte-
fici da Leone III a Pio VII, Roma 1803, VII: Dell’ingresso solenne di
Carlo V sotto Paolo III; m. mitchell, The SPQR in two Roman Festi-
vals of the Early and Mid-Cinquecento, in «The xvith Century journal»,
9 (1978), n. 4, pp. 99 sgg. Non abbiamo potuto consultare a. de
santa-cruz, La Cronica del Emperador Carlos V, Madrid 1920-25, vol.
III, pp. 322-53, che contiene una narrazione dell’ingresso e del sog-
giorno di Carlo V a Roma secondo un testimone oculare (informazione
che dobbiamo alla cortesia di Bonner Mitchell); e neppure c. scheurl,
Einrit Keyser Carten in die alten Keyserlichen haubtstatt Rom, den 5. Apri-
lis, 1536.
113
Due problemi interessanti si pongono a proposito delle decora-
zioni per questo ingresso. Innanzitutto, a chi spetta la concezione e
l’organizzazione? Si hanno i nomi di Antonio da Sangallo il Giovane,
e dei suoi collaboratori Battista da Sangallo, Raffaello da Montelupo,
Battista Franco, Francesco Maso, Girolamo Pilotto, Francesco Sal-
viati. Ma si è pensato, sulla base di un taccuino di disegni, al ruolo
possibile di Peruzzi stesso: g. de angelis vossat, Gli archi trionfali
ideati dal Peruzzi per la venuta di Carlo V, in «Capitolium» A (1943),
pp. 287 sgg. Solo che Peruzzi non era più in grado di lavorare (morì
il 6 gennaio 1536) e la critica del Taccuino di Siena ha dimostrato che
questa raccolta non è omogenea: contiene note molto diverse (tra cui
f. 29v: tre archi; f. 4or: un quarto arco, concernente l’ingresso del
1536) e può risalire a quel Jacopo Meleghino da Ferrara, di cui Paolo
III aveva fatto il suo uomo di fiducia e che dovette sorvegliare gli
apparati. Cfr. m. toca, Osservazioni sul cosiddetto «Taccuino senese»
di Baldassarre Peruzzi, in «Annali della Scuola Normale Superiore di
Pisa, Classe di lettere e filosofia», serie III, 1 (1971), pp. 161 sgg. Pos-
siamo quindi attenerci all’indicazione di Vasari, il quale descrive con
precisione l’arco del Palazzo di San Marco e aggiunge: «Non solo que-
sto arco fu da Antonio ordinato, ma tutto l’apparato della festa che
Storia dell’arte Einaudi 282
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
si fece per ricevere un si grande e invittissimo imperatore» (Le vite cit.,
V, pp. 464-465).
Il secondo problema concerne la partecipazione di Martin Heem-
skerck. Avendo Vasari segnalato «un Martino tedesco ed altri giovani
tedeschi, che pur allora erano Venuti a Roma per imparare», ammi-
randone la capacità di lavorare in fretta e bevendo molto (ibid., VI, p.
673), è sembrato semplicissimo riconoscervi Martin Heemskerck, la cui
venuta nel 1532 è stata segnalata da Vasari stesso nella sua autobio-
grafia, e i cui taccuini sono così pieni di vedute di Roma. Tuttavia h.
egger e c. holsen nella loro introduzione ai Römische Skizzenbücher
cit., I, p. ix, hanno sollevato delle obiezioni: Heemskerck non poté
rimanere più dei tre anni indicati da C. Van Mander, poiché il suo pro-
tettore, il cardinale Enckenvoirt, era morto nel luglio 1534; il panora-
ma di Roma vista dal Campidoglio, datato 1536, è di un imitatore.
Bisogna escludere la partecipazione di Heemskerck alle decorazioni del
1536. H. Egger è tornato su questo punto: Zur Dauer von Martens van
Heemskerck Aufenthalt in Rom (1532-1535), in «Mededeelingen van
het Nederlendsch Instituut te Rom», 5 (1925), pp. 119 sgg.
Ma se il disegno della facciata del Vaticano decorata per ricevere
l’imperatore, disegno conservato a Chatsworth, è davvero di Heem-
skerck, allora l’artista deve avere collaborato alla decorazione del 1536,
poiché si vedono sulla facciata gli «addobbi provvisori».
114
p. giovio, Elogia…, Venezia 1546, p. 60 («Antonius Tibal-
deus»): «... Periit in via lata octogenarius senex, firmissimo corpore,
et celsa prosperitate, semper erecto, stranguria cruciatus, adeo gravi-
ter, ut ex atra demum bile se ipso factus amarior saepe, nec insulse deli-
rare videretur, quum iarma, fenestrisque penitus occlusis Carolum
Caesarem ex Africa, relato insigni triumpho, ad eius limen transeun-
tem spectare noluerit, quod eum minime iustum Imperatorem putaret,
qui sub fide publica captae, deletaeque urbis scelus, quo Maiestas ejus
vel extra culpam sugillari potuit; decumatis legionibus minime uindi-
casset, quasi non satis fuerit, in tantae cladis solatio Borbonium, Dor-
binium, Moncatam, et Aurantium, quattor Summos Duces, et patrati
facinoris authores, singulis ictos fulminibus, ultore magno numine
spectavisse».
115
Iscrizioni: sotto la statua del Cristo, «Domine, tu hic eris» (Cef-
fino) [o eras (secondo Sala)]; sotto quella di San Pietro, «Redi, hic
sedem meam constitue».
116
Iscrizioni: per Scipione il Vecchio, «Quintus Fulvius Flaccus
Capena illatus Afros depulit»; per Scipione Emiliano, «Deo pro nobis
stante, Afri repulsi». Un’altra era ripetuta sotto ogni arco trionfale,
«Scipiadis medium Caesar te moenibus infers, Quamlibet a victo ter-
tia palma manet».
Storia dell’arte Einaudi 283
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
117
Sull’atteggiamento e la sorte delle donne romane durante il
sacco, cfr. alberini, Ricordi cit., p. 272 nota 1. F. Guicciardini sug-
gerisce che talune seguirono l’esempio di Lucrezia [Lucrezia era una
matrona romana diventata leggendaria per la sua virtù (cfr. The Rape
of Lucrece di Shakespeare). Violentata dal figlio di Tarquinio il Super-
bo, chiese al marito e ai suoi amici di vendicarla, poi si uccise con un
pugnale. Nella rivolta che seguì i Tarquinii vennero cacciati da Roma].
Cfr. anche la lettera di Niccolò Vitelli a Vitello Vitelli, 11 maggio 1527,
in Lettere di diversi... scritte a Vitello Vitelli, Firenze 1551. Alcuni gen-
tiluomini romani preferirono uccidere la loro moglie piuttosto che
abbandonarla ai nemici, per esempio accadde così a palazzo Cesarini.
118
Un disegno attribuito a Lafréry o a Du Pérac (Berlino Dahlem,
Kupferstichkabinett, verso il 1580. Cfr. weil, History and Decoration
cit., fig. 17) conserva forse il ricordo di questa sistemazione, che, d’al-
tra parte, si presenta come una ricostituzione conforme a ciò che
mostra l’affresco del Labarum nella Stanza di Costantino.
119
Iscrizioni: al di sopra di san Paolo convertito, «Religionis asser-
tori»; al di sopra della conversione di san Clemente, «Presidi securi-
tatis».
120
Biblioteca Vaticana, Cod. Barb. Lat. 1903, f. 38r.
121
venturi, Storia dell’arte italiana cit., XI, 2, p. 992; portoghesi,
Roma del Rinascimento cit., I pp. 172 e 466.
Storia dell’arte Einaudi 284
Epilogo
Gli undici anni del pontificato di Clemente VII
lasciano un’impressione di tensione e di crisi, se para-
gonati con gli otto in cui ha regnato il cugino Leone X.
Descrivendoli come un concatenarsi sinistro di minac-
ce, di disastri e di resipiscenze, parrebbe di cogliere in
profondità quel che successe a Roma; e ci ingannerem-
mo. Perché in quella corre un’altra storia, e abbiamo
tentato di identificarla, di riscoprirne le origini e l’ori-
ginalità. Prima che la sciagura della collettività trascini
con sé la miseria e la spaccatura, il corso della vita arti-
stica è o può apparire come estraneo alla forte spinta
degli avvenimenti. È qui tuttavia (e anche un’analisi
incompleta dei fatti lo dimostra con evidenza), un aspet-
to essenziale della situazione; infatti l’attività artistica
non fiorisce in un centro come Roma senza iniziative e
incoraggiamenti stimolati dall’atteggiamento stesso del
principe. Lo si vide non appena Clemente successe a
Adriano, e di nuovo, in un modo alquanto diverso,
quando Clemente successe a se stesso nel 1528.
Abbiamo ricercato e trovato numerose relazioni pre-
cise fra le passioni politiche e religiose dell’epoca e lo spi-
rito delle opere d’arte dipinte o incise. Prima di tutto,
abbiamo già notato quale contrasto vi sia tra il mezzo
popolare e spesso semplificato della stampa e lo stile
nobile della grande pittura in Italia. Questo segno, que-
sta rigidità relativa del comportamento sociale italiano,
Storia dell’arte Einaudi 285
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
meritano un esame più approfondito. Parlando di «stile
clementino» proponevamo un accostamento abbastanza
arrischiato tra la figura di questo raffinato gentiluomo
diventato papa e l’orientamento artistico. Ciò che è man-
cato al politico – il pensiero rigoroso, il giusto calcolo
delle proprie possibilità, l’esatta valutazione delle forze
– e forse quel che ha permesso al «mecenate» di mante-
nere l’originalità del clima artistico di Roma, grazie alla
sua mente duttile e alle sue molteplici curiosità, alla sua
apertura di principe colto al talento e alla iniziativa1.
Si sconfina quasi sempre negli elogi iperbolici o uffi-
ciali – attribuendo troppe cose alla personalità del prin-
cipe; inversamente si può trascurare un’articolazione
interessante, anzi decisiva, se non si dà sufficiente rilie-
vo al ruolo che ha sostenuto. Il potere richiede alcune
idee precise. A Clemente non e mancato un progetto
complessivo di ciò che il potere papale doveva essere, gli
è venuta meno la strategia per assicurarselo, ed è que-
sto che Guicciardini e Giberti si sforzavano di conqui-
stargli opponendosi a Schömberg e al gruppo «imperia-
lista». Le esitazioni, l’ambiguità che furono fatali al
potere politico, diventano duttilità e seduzione nel
campo in cui poté esercitare la sua duplice vocazione
medicea e pontificia.
In quale modo opere così ricche di sensibilità come
quelle degli artisti del 1525 hanno potuto aver realizza-
zione in una situazione socio-politica così confusa, tra
la pioggia di cattive notizie e di minacce terrificanti?
Domanda non diversa dall’altra, come Raffaello e
Michelangelo abbiano potuto concepire la loro opera
romana sotto Giulio II, nel tumulto di un pontificato
tanto teso quanto quello del 1525 era instabile. L’inte-
ra interpretazione del Rinascimento discende dalle rispo-
ste date a simili questioni.
Clemente aveva un’idea generosa e intelligente dei
doveri culturali del suo pontificato. Competente e aper-
Storia dell’arte Einaudi 286
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
to, ispirava fiducia agli artisti che ricercavano la sua
protezione, soprattutto dopo il rude comportamento di
Adriano VI. Anche se non interveniva personalmente
si sapeva che la sua cerchia favoriva le iniziative abili e
brillanti, che si apprezzavano le opere in cui le favole
antiche, la storia romana, erano trattate in maniera ori-
ginale. Paragonato alle grandi ambizioni dell’età prece-
dente, il tono generale era forse minore, più preoccu-
pato della leggiadria che della grandiosità, come si nota
anche in letteratura. Ma la partenza di Giulio Romano
aveva segnato una svolta; gli artisti in auge dal 1525 al
1527 tendevano – come è normale in una generazione
che segue quella di grandi maestri – a elaborare uno
stile elegante e quintessenziato, «iperclassico» se voglia-
mo. La cultura umanistica vi rappresentò una parte più
particolare e più diffusa che mai in precedenza. Agli
occhi degli osservatori che ignoravano la diversità delle
correnti e delle aspirazioni all’interno della città, Roma
si «paganizzava» irrimediabilmente; i grandi amatori
stranieri, innamorati di modernità, venivano a cercar-
vi quello stimolo intellettuale che proprio agli spiriti più
religiosi appariva rovinoso per la cristianità.
La caduta di Roma, che segnò la fine della libertà d’I-
talia, doveva quindi essere considerata anche nelle sue
ripercussioni morali e culturali. Essa affrettò la sfalda-
tura fra la «via romana» e il rigore dei riformatori. Fece
scoppiare le contraddizioni interne di quel che si chia-
ma il Rinascimento. Clemente fu talvolta compianto,
raramente ammirato. A Roma stessa. dove la sua politi-
ca fiscale e la preferenza data ai toscani avevano sem-
pre danneggiato la sua immagine pubblica, egli dovette
alla solidarietà che nasce dal condividere. le sventure
una specie di consenso forzato. Alla sua morte furono
pubblicati dei libelli2. Ma il giudizio comune si espresse
in due modi. Innanzitutto nel famoso sonetto sarcasti-
co e crudelmente penetrante di Berni:
Storia dell’arte Einaudi 287
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Un papato composto di rispetti,
Di considerazioni e di discorsi;
Di più, di poi, di ma, di se, di forsi,
Di pur assai parole senza effetti.
Questo non è tanto una caricatura quanto un’analisi
senza compiacenze e l’irritazione di un testimonio –
non a caso segretario di Giberti. La conclusione feroce
diceva tutto:
Lo dirò pur, vedrete che pian piano
Farà canonizzar papa Adriano3.
A Firenze, apprezzamenti più sfumati insistevano
sulla dignità di una vita che meritava altra sorte4; ma
sarà soprattutto ricordato il giudizio che Vasari, trat-
tando proprio di Michelangelo, credette alla fine di
dovere dare del pontefice: «Ma morto Adriano, e crea-
to Clemente VII, il quale nelle arti dell’architettura,
della scultura e della pittura fu non meno desideroso di
lasciar fama, che Leone e gli altri suoi predecessori»5.
Una vocazione realizzata soltanto in parte.
Occorrevano a quell’età immagini forti e rappresen-
tazioni simboliche: il Giudizio universale di Michelan-
gelo apparve come la conclusione estrema, la dichiara-
zione sublime e difficile che esprimeva la coscienza del
presente. Visibile al pubblico nel 1541, quest’opera,
che è priva di riferimento attuale, non parve a nessuno
fuor di proposito. Gli altri artisti avevano reagito,
secondo la loro natura, alle delusioni e alle sofferenze
con la fuga, con l’emotività, con il ripiegamento o con
la confusione. Michelangelo manifestò nella composi-
zione eccezionale, grazie allo stile tragico, le esperien-
ze straordinarie vissute: una constatazione personale
straziante della sciagura e della debolezza umana dinan-
zi al Signore.
Storia dell’arte Einaudi 288
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
La rappresentazione di fatti gravi e profondamente
sconcertanti richiedevano il ricorso alla Scrittura. Cle-
mente, che era stato il più manovriero ma il meno for-
tunato dei diplomatici, il capo di stato più furbo e il più
severamente colpito, non poteva «spiegare» il sacco di
Roma con la propria indecisione e i proprii errori. Qual-
siasi ritorno sul passato richiedeva un altro modo di
vedere. La storia della Chiesa si svolge secondo un piano
divino, che bisogna cercare di capire. Se l’esercito impe-
riale avesse aggirato Roma, come aveva fatto a Firenze,
per timore di un assedio lungo e difficile, il papa avreb-
be ricordato San Leone che ferma Attila. Se, in mezzo ai
saccheggi, la città fosse stata attaccata, le forze imperiali
ricacciate, forse annientate dall’esercito della Lega (ciò
sarebbe potuto succedere tra l’8 e il 9 maggio a poche
miglia da Roma), l’episodio biblico di Eliodoro avrebbe
fornito l’indispensabile antefatto registrato dalla sacra
scrittura. Poiché era accaduto il peggio, e il papa ne era
scampato, la Liberazione di san Pietro dava all’episodio
drammatico la sua dimensione sovrannaturale. Era
un’interpretazione perfettamente normale per una cul-
tura satura di riferimenti ai libri sacri. Michelangelo
non procedette in altro modo, nel dispiegare il vasto sim-
bolo che gli avevano affidato: la realtà cupa e pericolo-
sa della vita esposta al giudizio di Dio. Ma egli la descri-
ve nel più potente stile romano.
Lo schema generale delle reazioni di una comunità
cristiana a gravi catastrofi e sempre il medesimo: senti-
menti di abbandono e di disperazione; evocazione del
Giudizio universale, di cui le presenti sventure annun-
ciano il sopraggiungere imminente; appello alla peni-
tenza e alla correzione dei costumi. La ricerca delle
cause naturali immediate e perseguita, certamente, con
l’intenzione di agire su di queste, ma la spiegazione
d’insieme, che ne sta alla base, e di altro ordine. È un
fenomeno comune: lo si nota bene, ad esempio, a Firen-
Storia dell’arte Einaudi 289
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
ze dopo il gran diluvio, l’inondazione catastrofica di
Ognissanti nel 13336. Due secoli dopo, l’Oratio di Sta-
fileo al tribunale della Rota era esattamente dello stes-
so tono; l’esercito era stato mandato per stabilire la
pace, non per commettere misfatti quali «razzie», scon-
volgimento della città imperiale, profanazione dei tem-
pli, saccheggio delle biblioteche, assassinio dei preti,
stupro di vergini e matrone». Questi eccessi, che non si
tratta più di negare o di minimizzare (come faceva ini-
zialmente Valdés) sono da imputarsi per intero alla folle
«avarizia» delle truppe trascinate in una autentica sedi-
tio. Bisogna affidarsi a Cesare per ristabilire l’ordine.
Questo interessante discorso presenta anche un altro
risvolto, perché il suo autore tradisce la propria origine
umanistica nell’insistenza del secondo «sacrilegio»:
insieme al saccheggio delle chiese, quello delle bibliote-
che: «non minus sacrilegium est bibliothecas quam
phana diripere». La ricchezza di quelle romane era stata
opera dei pontefici; contenevano il tesoro stesso dello
spirito umano, gli stati non possono conservarsi «sine
honestarum artium cognitione et sine libris». Questo
lato del ragionamento di Stafileo si ritrova nel somma-
rio «politico» di un oratore noto dalle iniziali «p. M.»,
che non e altri se non Filippo Melantone. Non vi e
alcun dubbio sui sentimenti di Melantone. In una let-
tera scritta a Wilhelm Reiffenstein il giorno stesso in cui
cadde la città, così li espone: «Nulla di nuovo a parte le
voci della presa di Roma. Vorrei che fossero false per
molte ragioni, ma soprattutto per timore per le biblio-
teche, che in nessun luogo della terra sono più ricche.
E tu conosci l’odio dei nostri soldati e di Marte per i
libri, e soprattutto come il nostro secolo, per non so
quale fatalità, sia più crudele verso i libri di qualsiasi
altro»7. La reazione da umanista di Melantone risulta
quanto mai chiara, e quel che l’Oratio di Stafileo può
avere di sorprendente, cioè la sua preoccupazione esclu-
Storia dell’arte Einaudi 290
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
siva per i libri, si spiega benissimo nel prolungarsi di
questa reazione immediata del giugno 1527.
Le distruzioni di cui si è parlato, dice Stafileo, furo-
no un atto di pura follia, inspirato dall’odio per la cul-
tura. Non si è mai veduta una cosa simile: un esercito
senza capi abbandonato per dodici giorni a se stesso in
una città. Orbene, questa città e la patria comune di
tutti gli uomini, e la cultura è tornata a rinascervi: «hic
nuper bonae disciplinae tamquam renatae sunt». Col-
pirla sotto pretesto di alcune debolezze esagerate in
modo eccessivo e un parricidio. Si deve rimetterla in
onore. La gente può ridere delle disgrazie con sarcasmo;
ma i buoni cittadini hanno un altro atteggiamento,
sapendo quanto il mantenimento della cultura importi
alla dignità della città. Restaurare la cultura moderna è
non soltanto possibile ma necessario. L’Oratio enuncia-
va gli orientamenti che, grosso modo, avrebbe seguito
Clemente a partire dal 1529 e che avrebbero caratte-
rizzato gli anni seguenti sotto Clemente e sotto Paolo.
L’imperatore meritava più che mai questo titolo. La
presa di Roma seguita dall’incoronazione e dall’entrata
in Urbem diedero al termine e all’istituzione stessa il
senso che le mancava. Fin dal 1528 si poteva designare
Carlo V «imperatorem caesarem augustum; pium, feli-
cem, victorem Galli, pontificis, patrem patriae»8. Nel
1555, nella prima stampa della serie famosa in gloria del-
l’Imperatore dove si oserà ricordare la morte gloriosa di
Carlo di Borbone, Heemskerck avrebbe mostrato l’a-
quila che tiene incatenate le grandi potenze: il Turco, il
papa, il re di Francia9. Non solo, come disse Frances
Yates, «il sacco di Roma per opera degli eserciti del
nuovo Carlo Magno è stata la risposta terribile della sto-
ria ai sogni degli umanisti italiani»10, ma ha provocato
questo stupefacente slittamento: il mito di Roma – l’i-
dea del grande retaggio antico – sembra adesso essere
passato dalla parte della potenza imperiale, a spese della
Storia dell’arte Einaudi 291
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
realtà italiana. È anzi possibile che la teoria «imperiali-
sta» del potere politico unico, superiore, abbia preparato
la strada alla teoria «assolutistica» del xvii secolo11. Que-
sta non avrebbe assunto l’ampiezza ossessiva che ebbe
sotto Carlo V e Filippo II, senza gli eventi spettacolari
che abbiamo preso in esame.
Alcuni mesi dopo la visita dell’imperatore, fu pub-
blicata, alla fine di maggio 1536, la Bolla che proclamava
il Concilio12. Fin dalle prime riunioni un gran discorso
di Sadoleto aprì il dibattito risalendo a ciò che era avve-
nuto a Roma nove anni prima, naturalmente alla luce dei
sacri testi13. Il vescovo di Carpentras faceva parte dei
«ciceroniani» che Paolo III aveva pensato di invitare per
sottolineare la sua volontà riformatrice e insieme la
preoccupazione di risollevare il prestigio romano. Egli
non era di quelli che, come Erasmo, consideravano il
sacco un castigo meritato; piuttosto lo vedeva come un
avvertimento del Cielo. La nuova Curia, di cui faceva
parte, era meno preoccupata della riparazione richiesta
da una profanazione orribile (ancorché tale preoccupa-
zione potesse manifestarsi di nuovo), o della penitenza
resa necessaria dalla corruzione «babilonese» del caput
mundi, che non della comune restaurazione di Roma e
della Chiesa. La volontà ostinata dei riformatori di dis-
sociare l’una cosa dall’altra non doveva più trovare eco.
Il dinamismo di ciò che si sarebbe concretizzato nella
Riforma cattolica rinsaldava il ruolo della Città Eterna,
riconosciuta nella propria originalità e come centro di
un’istituzione religiosa irremovibilmente salda in una
vasta parte d’Europa.
Quel che conta, ricorda Sadoleto ai suoi ascoltatori,
e il ruolo di consiglio, di equilibrio, di rifugio che, nel
disordine e nella crudeltà delle vicende umane, solo il
sovrano pontefice può assicurare. Egli si impone alle
potenze temporali. Leone, in altri tempi, con la sola
forza della parola, non costrinse Attila ad abbandonare
Storia dell’arte Einaudi 292
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
l’Italia? La dignità, la purezza, il disinteresse del magi-
stero cristiano sono indispensabili all’ordine del mondo.
È spaventoso pensare che simili valori abbiano potuto
per un momento offuscarsi dinanzi ad altre considera-
zioni. È terribile che certe sette, per ripulsione contro
la pratica romana, siano potute giungere a una denun-
cia generale dell’istituzione: «Il Nostro nome è diven-
tato così odioso, si è creata nei nostri riguardi una tale
opinione di perfidia e di avidità, che tutto ciò che e
detto contro di noi da chiunque e subito ritenuto
verità». Pare incredibile che «in questi anni in cui siamo
stati conquistati, saccheggiati, fatti a brandelli, non solo
non abbiamo avuto l’aiuto e il soccorso di chi ci è più
vicino, ma neppure la commiserazione e la pietà degli
altri». Come esitare in tali condizioni a riunire questo
Concilio, che solo può ristabilire l’unita del mondo cri-
stiano? Dalle esperienze dolorose, scoraggianti, del pas-
sato deve nascere una volontà riformatrice in seno alla
Chiesa di Roma. Nello sfondo di tutte le preoccupazio-
ni romane, c’erano adesso le vicende della Germania14.
La vittima più crudelmente colpita e più indifesa
politicamente per lungo tempo fu in definitiva l’Italia.
L’analisi di Guicciardini ci illumina inesorabilmente su
questo punto. Durante il corso del secolo si ebbero mol-
teplici testimonianze del senso di abbandono provato
dagli italiani15. Nascevano nuove società governate con
maggior rigore, come la Toscana del Gran Ducato, con
principi moderni di organizzazione, e con due ordini di
conseguenze: la celebrazione precoce delle glorie locali;
l’esigenza incomprimibile di un risarcimento attraverso
l’arte, di cui ogni provincia, ogni città conosceva da
molto tempo l’esigenza e il prezzo. Il generale ottimismo
del Rinascimento era cosa del passato. Il fallimento di
una egemonia «italiana» ha mantenuto la penisola nella
condizione più favorevole alle celebrazioni immaginarie,
alle vuote parate.
Storia dell’arte Einaudi 293
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
È curioso che non appena tornato a Roma, Bandi-
nelli, al servizio di Clemente, abbia denominato il suo
«studio»: «accademia». L’incisore Agostino Musi, il
compagno di Serlio, tornato fin dal 1530, ci ha lasciato
un documento piuttosto importante incidendo la famo-
sa tavola dello «studio», con l’iscrizione «Academia di
Bacchio Brandin in Roma in luogo detto Belvedere
mdxxxi», seguita dalla sigla «A. V.». Il che ci fornisce
un’informazione sul posto di lavoro dello scultore non
meno interessante dei suoi accessori: le statuette, i luci-
gnoli, gli utensili16. La denominazione stessa di «acade-
mia» e abbastanza pomposa; sembra convenire al carat-
tere orgoglioso di Baccio, a meno che il termine non sia
già stato di uso corrente. In ogni caso, questa incisione,
ripresa poi in una versione poco diversa da Enea Vico
verso il 155017, segna abbastanza bene la posizione di
favore di cui godeva Bandinelli al momento in cui Cle-
mente tentava di riportare l’attività artistica a Roma.
A dispetto delle recriminazioni degli erasmiani, nien-
te poteva alterare l’attrazione profana di Roma per gli
umanisti, gli amatori d’arte, gli artisti. Rabelais vi segue
il cardinale Du Bellay; Heemskerck, protetto del cardi-
nale Enckenvoirt, disegna le collezioni di antichità18.
Nel 1531 un giovane artista, Francesco Salviati, era
giunto a Roma su raccomandazione di Benvenuto Della
Volpaia19; poco dopo, mandato da Tommaso de’ Neri al
cardinale Ippolito de’ Medici, Giorgio Vasari arrivava
a sua volta da Arezzo. I due amici si buttarono con foga
sui palazzi, le collezioni, le rovine, studiando e dise-
gnando tutto ciò che era loro accessibile20. Il loro unico
interesse erano le antichità. La prima opera che a Vasa-
ri capitò di produrre in quella intensa stagione fu una
Venere con le Grazie, a grandezza naturale, di cui il car-
dinale de’ Medici fu così estasiato che raccomandò il gio-
vane pittore a papa Clemente. Dato il momento, non era
un’opera di grande importanza, ma rappresentava il
Storia dell’arte Einaudi 294
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
modo con cui un artista aveva modo di evolvere. I gio-
vani dell’epoca non hanno più la freschezza e la libertà
di invenzione di quelli del 1525; sono più affettati, cor-
tigiani e, se possiamo dirlo, la mentalità «storicistica».
Uno dei più vecchi familiari di Clemente era l’uma-
nista Paolo Giovio, esemplare perfetto del «ciceronia-
no», ossia del letterato imbevuto dell’eleganza latina
nello stile e convinto della superiorità romana nella cul-
tura. Era rispettato come il futuro storiografo del perio-
do. Aveva accompagnato Clemente il mattino del 6 mag-
gio nella fuga precipitosa a Castel Sant’Angelo. Ne uscì
incolume e, avendo protezioni da parte dei Colonna,
poté ritirarsi nel 1528 a Nocera in Campania, dov’era
vescovo. Compose un dialogo alla maniera antica, De
viris illustribus, situandolo nell’isola di Ischia dove allo-
ra si trovava Vittoria Colonna. Dopo i tragici avveni-
menti di Roma la sua reazione, tutto sommato, era di
occuparsi di lettere e di arti, il che può essere conside-
rato una reazione tipica; ma, meglio ancora, ci sono in
questo testo molteplici allusioni ai pittori contempora-
nei per analizzare il problema dell’invecchiamento degli
artisti, come nel caso del Perugino, o quelli dell’imita-
zione, ad esempio tra gli allievi di Leonardo. Paolo Gio-
vio cominciò a redigere biografie dei grandi maestri, con
l’idea di comporre una specie di galleria ideale dell’arte
italiana «da Cimabue al tempo nostro»21. Era la prima
iniziativa del genere, e fu realizzata vent’anni più tardi
da Vasari, d’altronde in pieno accordo con Giovio.
Durante il suo soggiorno giovanile ed entusiasta dal
1531-32, e poi nel 1540, al momento in cui seppe pro-
curarsi le buone grazie della corte Farnese, Vasari, in
contatto con tutte le maggiori personalità, si prefisse, in
particolare, di raccogliere tutto il materiale disponibile
per una storia del sacco e delle sue conseguenze. Dob-
biamo a lui se oggi siamo informati sulla portata di quel-
l’avvenimento. Conformemente al suo metodo. ne
Storia dell’arte Einaudi 295
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
distribuì i particolari all’interno delle varie biografie.
Ciascuna di queste rimanda alle altre, non fosse che per
la ripetizione degli stessi riferimenti. Sommando aned-
doti e notazioni, si hanno tutti gli elementi di una rela-
zione sul «Sacco di Roma e gli artisti», il cui tenore e
quasi esattamente parallelo a quello di Giraldi e Pierio
Valeriano per i letterati22; ma la lettura e meno cupa. Le
doti di storico innate in Vasari lo hanno portato a sce-
gliere proprio i punti che appaiono più interessanti. È
lui ad illuminarci sulla importanza del pontificato di
Adriano VI, sulle speranze all’avvento di Clemente. Dei
lavori, le ambizioni, le amicizie, le sventure degli uni e
degli altri egli sa una quantità di cose, di cui consegna
il particolare con un instancabile brio toscano ma con
un’indignazione piuttosto convenzionale. Una volta sola
cambia tono, nella vita di Jacopo Sansovino, aggiunto
nell’edizione del 1568. Con una certa meraviglia vi si
trova una formula che non aveva mai adoperato: «quan-
do Dio – scrive – per castigo di quella città, e per abbas-
sare la superbia degli abitatori di Roma, permise che
venisse Borbone con l’esercito a’ sei giorni di maggio
1527, e che fu messo a sacco e ferro e fuoco tutta quel-
la città...»23. Castigare questa città orgogliosa? Non si
capisce esattamente ciò che Vasari voglia dire. Egli non
stigmatizza la «corruzione» di Babilonia, ma la super-
bia dei romani. È forse l’eco delle delusioni provate
sotto Giulio III o della decadenza che il predominio
toscano stava allora sperimentando?
Dopo quarant’anni vediamo ancora sussistere due
versioni opposte dell’avvenimento: il sacco come sacri-
legio che squalifica l’autorità imperiale responsabile,
oppure come giusto castigo a dimostrare che questa
autorità e lo strumento privilegiato di Dio. La polemi-
ca poteva accendersi in qualsiasi occasione e, di fatto,
così avvenne periodicamente verso la meta del secolo. La
diffidenza nei confronti del clero romano ispirò la pub-
Storia dell’arte Einaudi 296
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
blicazione a Venezia nel 1545 di un’edizione italiana del
Dialogo di Valdés. Quando sorse un conflitto tra Filip-
po II e Paolo IV, questi affermò che Carlo V era un ere-
tico; e in Spagna venne ristampato Savonarola per dimo-
strare che Borbone aveva attuato la profezia del santo
predicatore che si era scagliato contro papa Alessandro
VI24. Il ricordo del 1527, grazie alla sua inesauribile
forza di simbolo, riviveva in una situazione che poteva
sembrare una ripresa. Il cardinale Gian Pietro Carafa era
stato coinvolto negli orrori del sacco; giurò a se stesso
di non ricadere nella politica debole di Clemente. Dive-
nuto Paolo. IV, la sua reazione autoritaria si manifestò
nel tentativo di estirpare qualsiasi eresia: condannò Era-
smo e gli scritti riformati; promosse processi ingiusti e
impolitici contro il cardinale Pole e i suoi amici. Al
tempo stesso chiedeva a Michelangelo di affrettare i
lavori della cupola e istituiva la festa della «Cattedra di
san Pietro». Il riaffermarsi del primato romano coinci-
deva con una viva tensione fra il papa e l’imperatore25.
«E Roma tutti i giorni aspetta un altro sacco». Nel-
l’inverno 1556-57, i preparativi militari di Paolo IV
creavano uno stato di agitazione che Joachim du Bellay
guardava con ironia26. Nella primavera del 1557, Paolo
IV, ripetendo punto per punto le iniziative di Clemen-
te VII, aveva preso posizione contro gli imperialisti e
aveva attaccato chi ne costituiva il grande sostegno, la
famiglia Colonna. Trovò perfino un’occasione, il 10
maggio, per rimproverare ai cardinali spagnoli il com-
portamento delle truppe di Carlo V ventinove anni
prima27.
Parimenti cercava un appoggio, lento a giungere, in
Francia. La risposta partì finalmente da Napoli in set-
tembre, con l’esercito del duca d’Alba, che, avvicinan-
dosi a Roma, ravvivò i ricordi del 1527 e provocò un
panico. Un giovane artista, Giovanni Armenini, riten-
ne prudente lasciare la città al più presto, come ricordò
Storia dell’arte Einaudi 297
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
egli stesso in un trattato pubblicato trent’anni più
tardi28. Trent’anni dopo, si ripetevano le circostanze
che avevano portato al dramma del 152729: «non si vede-
vano che soldati, insegne, gonfaloni». Rinascevano le
profezie escatologiche, per esempio nei sogni di renova-
tio e nell’annunzio del «papa angelico» formulato da
Guillaume Postel30. In un sonetto piuttosto bizzarro dei
Regrets, Joachim du Bellay riprende tutti i temi che si
erano cristallizzati intorno alla vicenda del 1527: la Babi-
lonia dell’Apocalisse, l’umiliazione di Roma victrix. L’an-
goscia della devastazione possibile, l’idea che la Città
della storia avesse perduto la sua immunità provviden-
ziale, fanno adesso parte, insieme all’intuizione di una
gloria schiacciante, dell’eredità romana.
La storia della tomba di Clemente nella chiesa di
Santa Maria sopra Minerva, progettata da Bandinelli nel
1542, contiene parecchi indizi importanti. La tomba è
accanto a quella di Leone. L’idea di congiungere i due
papi medicei mediante monumenti simmetrici risale al
1525, all’inizio del pontificato di Clemente, all’epoca in
cui Michelangelo lavorava alla Cappella Medici a Firen-
ze. Lo scultore fu invitato a disegnare una tomba dop-
pia per i due cugini mentre sistemava la Sacrestia Nuova
di San Lorenzo. Ma le cose andarono altrimenti31. Quan-
do morì Clemente alla fine del 1534, si parlò di erigere
due tombe in stile trionfale nella chiesa di Santa Maria
Maggiore, su un progetto di Michelangelo che sarebbe
stato eseguito da Alfonso Lombardi. Ma dopo molte
rivalità, Bandinelli si accaparrò l’ordinazione del disegno
e ad Antonio da Sangallo il Giovane fu affidata l’archi-
tettura. Il luogo indicato era ancora Santa Maria Mag-
giore, come si vede da una serie di progetti notevoli per
un monumento a sé stante. Alla fine la scelta cadde su
Santa Maria sopra Minerva, dove venne rifatta l’abside
con una spesa non indifferente per inserirvi le due
tombe.
Storia dell’arte Einaudi 298
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
I disegni di Bandinelli conosciuti sono assai strani
perché non hanno alcun rapporto con il monumento
finito. Tra questi il più bello e più significativo propo-
ne una costruzione a tre piani: l’effige dei morti è posta
tra due figure celesti che reggono le torce, l’anima dei
defunti prega in una mandorla tenuta da cinque angeli
e, sopra un cornicione, Cristo e la Madonna sono cir-
condati da sei santi in atto di intercedere mentre si vol-
gono verso Dio Padre e la colomba dello Spirito Santo.
È stato osservato che composizioni del genere non si
facevano più da due secoli e non hanno riscontro nel
Rinascimento. L’anima e una figura di adolescente che
somiglia al David di Michelangelo. Questa apparizione
celeste e stata messa in relazione con la bolla Apostolici
Regiminis, che ricorda il dogma dell’immortalità del-
l’individuo proclamato dal Concilio Laterano nel dicem-
bre 1513 da Leone e da suo cugino il cardinale Giulio.
Ma tutti i monumenti funerari presuppongono la fede
nella vita ultraterrena e l’ingresso in Paradiso per gra-
zie divina. L’originalità di questo disegno sta nel porre
in risalto l’ascensione dell’anima, rappresentata qui da
una creatura giovane e pura, che molto probabilmente
fa riferimento alla condizione del giusto e all’aspetto fisi-
co dei mortali nel regno dei cieli. Questi sono argo-
menti dottrinali ben noti ai platonisti della cerchia di
Clemente, come ad esempio Egidio da Viterbo, e certa-
mente interessavano il pontefice. Non era appunto il
problema posto da Michelangelo nel Giudizio universa-
le? D’altro canto il progetto mette l’accento sull’inter-
cessione di Maria accanto a quella di Cristo per ricor-
dare il ruolo della Vergine, rifiutato dai Riformatori, ma
sostenuto energicamente dal papa defunto. Questo dise-
gno pertanto parrebbe rappresentare la tomba ispirata
dalla vita di Clemente. Evoca il destino personale e la
speranza di salvezza di un papa che era stato duramen-
te provato.
Storia dell’arte Einaudi 299
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Non si confaceva più al papato di Paolo III, che
cominciava a seguire una politica di restaurazione mili-
tare; e questo spiega il carattere trionfalistico dell’ope-
ra finita, la simmetria dei due monumenti, e l’insisten-
za sui due momenti politici, inseriti con abilità: l’in-
contro di Bologna con Francesco I nel 1515 (tomba di
Leone X) e l’incontro con Carlo V nel 153o nella mede-
sima città papale (tomba di Clemente VII). Gli interes-
si teologici erano stati superati dal fatto che la Santa
Sede aveva riacquistato autorità politica.
Baccio, a quanto ne riferisce Vasari, se la cavò malis-
simo, e trovò il modo di partire per Firenze lasciando
l’opera incompiuta; alla fine si dovette ricorrere a Mon-
telupo per la statua di Leone e a Nanni di Baccio Bigio
per quella di Clemente. Ma l’interessante è il progetto
di Bandinelli e la critica che ne fa Vasari: era una spe-
cie di arco trionfale con nicchie per le statue sedute dei
pontefici accompagnati l’uno dai santi Pietro e Paolo,
l’altro dai due san Giovanni; alcuni bassorilievi illu-
stravano, sotto il cornicione, l’incontro di Bologna fra
Leone e Francesco I e l’incoronazione di Carlo V da
parte di Clemente e altri, collocati più in basso, episodi
della vita dei quattro santi. Concezione indegna, escla-
ma Vasari, che non tralascia nessuna occasione di denun-
ziare la presunzione di Baccio: «Mostrò in questa fab-
brica Baccio o poca religione o troppa adulazione, o
l’uno e l’altro insieme; mentre che gli uomini deificati
ed i primi fondatori della nostra religione dopo Cristo
ed i più grati a Dio, vuole che cedano a’ nostri papi, e
gli pone in luogo a loro indegno, a Leone e Clemente
inferiori...»32
In questa discussione tutto merita attenzione. La
preoccupazione della convenienza devozionale, che si fa
più stringente e impone il rispetto della gerarchia fra
Chiesa trionfante e Chiesa militante; la scelta delle «sto-
rie» destinate a presentare i fatti salienti di ogni ponti-
Storia dell’arte Einaudi 300
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
ficato: nei due casi l’intervento del papa presso i prin-
cipi. Questo riferimento all’autorità era diventato in
certo qual modo obbligatorio. Tanto meglio si osserva
fino a che punto essa sia ora stereotipata, limitata a
scene-modelli fisse, mentre si moltiplicano dovunque i
cicli di glorificazione dinastica.
A Firenze, la storia medicea, poneva nonostante tutto
problemi delicati. Rimane da esaminare il modo con cui
furono risolti nella serie delle sale di Palazzo Vecchio
dove dopo il 1556 fu deciso di illustrare i fasti di tutta
la famiglia. Niente del genere era ancora stato tentato
a Firenze. Per la grande Sala di udienza, che doveva
sostituire il Salone dei Cinquecento del tempo repub-
blicano, Baccio propose una serie di nicchie: su un lato
la statua di Leone X che riportava la pace in Italia, e
quella di Clemente VII che incoronava Carlo V, con sta-
tue più piccole nelle nicchie secondarie: le virtù dei Pon-
tefici33. La ripetizione del Programma sottolinea la
monotonia del «concetto». Sulla grande parete, vi sareb-
bero le statue di Giovanni dalle Bande Nere34, dei duchi
Alessandro e Cosimo.
Negli appartamenti, una sala era consacrata a Cosi-
mo il Vecchio, una a Lorenzo, una a Leone X, una a Cle-
mente VII, una a Giovanni dalle Bande Nere, una al
duca Cosimo35. L’ideatore di questo ciclo non e altri che
Vasari. I lavori durarono dal 1556 al 1562. Il program-
ma è stato commentato nei particolari nei Ragionamen-
ti (redatti a partire dal 1557) che il pittore-storico con-
cepì come una guida per il visitatore36. Il vero scopo era
quello di identificare gli innumerevoli ritratti di cui ha
ornato le composizioni e di spiegare il «concetto» poli-
tico ed elogiativo di ognuna. L’articolazione dei meda-
glioni e il concatenarsi dei grandi pannelli, compongo-
no una specie di romanzo dinastico dove si legano «quei
fatti, le storie che sono stati cagione della grandezza di
casa Medici». È la ricapitolazione di un secolo di vita
Storia dell’arte Einaudi 301
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
fiorentina e italiana, quale il duca regnante desiderava
vederla. Nella Sala di Clemente VI I l’incoronazione di
Carlo V occupa il quadro centrale, formando il noccio-
lo della composizione. Le «storie» scelte hanno soltan-
to interesse dinastico: evocazione del cardinale Ippoli-
to, nipote di Clemente; matrimoni di Caterina con il del-
fino di Francia e di Margherita, figlia di Carlo V, con
Alessandro; investitura e ingresso di questi; e infine
due scene dove Clemente è rievocato per se stesso: l’a-
pertura della Porta Santa a San Pietro per il Giubileo del
1525 e un episodio bizzarro, il ritorno di Clemente VII
a Roma. Sulle pareti, con un’importante soluzione fac-
cia a faccia, Leone e Francesco I, Clemente e Carlo V,
e, in un grande panorama, l’assedio di Firenze.
Il programma adottato per la Sala di Clemente era un
po’ scucito. Non si trattava di introdurvi un medaglione
che ricordasse la sciagura del 1527, di cui Vasari aveva
saputo così bene indicare altrove l’orrore e l’importan-
za. Tuttavia, una certa allusione si insinua nel pannello
dove «vi è il ritorno di papa Clemente a Roma dopo
molte iniziative difficili ma onorevoli». Vasari precisa:
ed ho finto che quattro virtù lo riportino in sedia, cioè la
Quiete, la Vittoria, la Concordia e la Pace, la quale mostra
dopo tanti travagli di abbruciare con una face in mano
molti trofei, sopra i quali ho posto a sedere il Furore ignu-
do, incatenato e legato ad una colonna di pietra; simil-
mente ci ho messo il popolo romano, che li viene incontro;
e, perché si riconosca che ritorna in Roma, ho fatto il Teve-
re ignudo con la lupa che allatta Romulo e Remo (Ragio-
namenti sopra le Pitture di Palazzo Vecchio, VIII)37.
La pia menzogna e la generalizzazione vaga si com-
binano a meraviglia in questo tessuto di allegorie che
nasconde il dramma. Si e pensato, per ritrovarvi un ele-
mento aneddotico, al ritorno di un’ambasceria, ma ciò
Storia dell’arte Einaudi 302
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
non si accorda con un discorso così complesso. È più
logico supporre che Vasari abbia deliberatamente rie-
vocato in quella composizione confusa, che può adattarsi
al ritorno da Bologna nel marzo 1530, le vicissitudini del
pontificato; dopo aver voluto la guerra, Clemente effet-
tivamente si decise per la pace.
Nella Sala vicina, decorata per la gloria di Giovanni
dalle Bande Nere, si trova una filosofia della storia
alquanto diversa. Ai combattimenti contro gli imperia-
li, che lo hanno reso famoso, è aggiunta la rievocazione
del Ponte Sant’Angelo «com’era prima del sacco, dove
il signor Giovanni assalito dagli Orsini alla testa di più
di duecento armati, dimostrò il proprio valore attraver-
sando con soli dieci uomini intrepidi»38. Questo ciclo
richiama, oltre le «virtù» allegoriche che ornano, come
per la Sala di Clemente, gli angoli della sala, il vecchio
simbolo della Fortuna, «con la vela, che calca il mondo».
Il tema di Fortuna appare come un filo scuro attraverso
l’episodio storico di cui qui abbiamo tentato di raduna-
re gli sparsi elementi.
A questa dea capricciosa infatti riconducono sempre
i diversi specchi del pensiero e dell’arte dell’epoca, dove
appaiono a volta a volta l’ondeggiare della sorte, le rap-
presentazioni confuse ma passionali che anticipano l’e-
vento, la fermezza che domina le sventure, la vigliac-
cheria che le amplifica, la debolezza che consente di pro-
durre tutte le conseguenze, che costituiscono il disa-
stro. Tutto il periodo, nel modo di concepire la politica
strana, impulsiva e orgogliosa del tempo, e ossessionato
dalla «Fortuna», dea del destino che offre o che ripren-
de i suoi favori, favori che la virtus saprà afferrare e trat-
tenere. Ma tenendo conto della duplice accezione di
«virtù», che significa tanto l’energia pura «al di là del
bene e del male» quanto la nobiltà dell’azione. La «For-
tuna con la vela, che tiene il mondo sotto i suoi piedi»,
è la variante fiorentina, sempre ricorrente, che si oppo-
Storia dell’arte Einaudi 303
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
ne al fatalismo della ruota e del mutamento39. L’ideolo-
gia del Gran Ducato, fedele in questo a Machiavelli,
rimette in onore la volontà politica.
In un ritratto recentemente riportato alla luce40 di
Giovanni, attribuito a Carlo Portelli e molto probabil-
mente ordinato dal gran duca Cosimo, figlio dello stes-
so Giovanni, una bandierina dietro il casco del «con-
dottiere» reca la figura della «Fortuna»; l’eroe afferra
con gesto deciso il ciuffo di capelli che la dea seduta sulla
ruota, in movimento, gli presenta. La scritta «S.S.R»
deve essere sciolta così: «Sapiens supra Fortunam», il che
aggiunge una dimensione intellettuale e morale, di spi-
rito ficiniano, alla figura del guerriero. Pare che si sia
faticato alquanto per trovare post mortem un emblema
confacente al personaggio. Quarant’anni dopo l’avveni-
mento, bisognava celebrare nell’intelligente capitano
delle Bande Nere virtù presenti nel figlio che era adat-
to più alla politica che alla guerra. L’emblema non fa che
guadagnarci in forza simbolica e commemorativa.
Pressappoco nello stesso momento, la riduzione della
storia a un episodio ben scelto era evidente anche in una
città «imperialista» dichiarata come Verona41. Nel 1564,
fu decorata la Sala d’onore del Palazzo Da Lisca (più
tardi Ridolfi) con un fregio veramente monumentale
che circonda tutta la camera. Domenico Brusasorzi vi
raffigurò con una ricchezza di particolari e un’abbon-
danza di ritratti che eccitano la curiosità, la cavalcata di
Clemente VII e di Carlo V dopo l’incoronazione di
Bologna. Era ispirata, naturalmente, alla serie di inci-
sioni di Hogenberg; tutta l’aristocrazia spagnola e ita-
liana degna di passare ai posteri, e presente in abbiglia-
mento solenne. Si commemorava l’ordine nuovo della
politica; e questo non appare più soltanto, come sul
sepolcro di Clemente, il fatto saliente del suo pontifi-
cato, ma piuttosto come l’avvenimento capitale del seco-
lo42. Il pageant del 1530 permetteva di respingere il ricor-
Storia dell’arte Einaudi 304
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
do della sciagura del 1527. I simboli hanno sempre l’ul-
tima parola.
Nel 1565 usci una raccolta di cento novelle, Heca-
tommithi overo Cento novelle43, dove si ritrova l’antica
tradizione dei novellatori ma senza la grazia di Boccac-
cio. La preoccupazione di moralizzare e posta in evi-
denza dall’introduzione, che dà tono alla raccolta. In
fuga da Roma in preda al dramma del 1527, un gruppo
di giovani, sull’imbarcazione che li porta a Marsiglia, si
raccontano delle storie. Questo artifizio permette all’au-
tore di dare una rievocazione molto particolareggiata del
sacco, in cui si trovano i dettagli più crudi tratti da
informazioni e dalle cronache: «un grandissimo e poten-
tissimo esercito di Alamanni macchiati dell’eresia mor-
tale di Lutero e dei suoi attraversò l’Italia con l’orribi-
le intenzione non solo di distruggere Roma, patria comu-
ne di tutte le nazioni, ma di mettere veramente a morte
il papa».
Questi cavalieri selvaggi volsero la loro rabbia contro
le cose divine: reliquie spezzate, chiese saccheggiate.
Tutto e ricondotto a un’immagine spaventevole, dove la
santità di Roma e inesplicabilmente violata, e le sue ric-
chezze rubate. Quest’opera finge di essere stata conce-
pita nel 1528, dal trauma degli avvenimenti. Ma in
realtà appartiene a un periodo in cui l’accidente del
sacco appare come un attentato doloroso dovuto all’a-
zione diabolica degli avversari di Roma. Visto in questa
luce, l’evento poteva apparire come il punto di parten-
za di un’età nuova, quella della Controriforma44.
1
Si può menzionare il fatto che Clemente non ometteva nulla dei
doveri principeschi. Nel 1533, in occasione del matrimonio di sua
nipote Caterina con Enrico, delfino di Francia, fece montare un corno
di liocorno sontuoso che, secondo Cellini, non valeva meno di 17000
ducati di camera. L’orafo ha raccontato anche come, per montarlo, egli
Storia dell’arte Einaudi 305
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
fu posto in concorrenza con Tobia di Camerino che prevalse (libro 1,
cap. 60). Cfr. g. schönberger, Narwal-Einhorn. Studien über einen sel-
tenen Werkstoff, in «Städel Jahrbuch», 9 (1935-36), pp. 204 sgg.
2
Per esempio quello del notaio Macinocchi, «De Clemente VII.
Pont. Max. Obitu». Cfr. a. bertolotti, Note sincrone sui papi dalla
metà del secolo XV a quella del XVI e sul sacco di Roma del 1527, in
«Archivio Storico, Archeologico e Letterario della Città e Provincia di
Roma», 4 (188 1), pp. 24,-55.
3
Poesie e prose cit., p. 76, n. xx.
4
vettori, Narrazione della presa di Roma per Borbone cit., pp.
423-24, citato da von pastor, Storia dei papi cit., vol. IV, parte II, libro
III, p. 511. «Clemente VII non era né crudele, né orgoglioso, né simo-
niaco, né avaro, né stravagante, ma temperante, semplice, pio, zelan-
te nell’adempimento dei suoi doveri religiosi. Nonostante ciò, sotto di
lui Roma ha conosciuto le più grandi sventure, e gli altri papi, che erano
pieni di vizi, vissero e morirono felicemente, agli occhi del secolo».
5
vasari, Le vite cit., VII, p. 191.
6
a. smart, Taddeo Gaddi, Orcagna and Eclipses, in Studies in Honour
of Millard Meiss, New York 1977, p. 403.
7
«Nihil novi habemus praeter rumores de capta Roma, quos opta-
rim vanos esse cum ob alias multas causas, tum quia metuo bibliothe-
cis, quae nullo in loco totius orbis terrarum lucopletiores sunt quani ibi.
Et tu scis, non modo milites nostros et Martem odisse libros, sed et
hoc totum seculum nescio quo fato literis iniquius esse, quam ullum
unquam fuisse credibile est». La lettera è datata «Die jovis post Exau-
di» (Corpus Reformatorum, Halle 1834, vol. I, col. 869).
8
Lettera di Gerard Geldenhauer («Noviomagus») a Carlo V, in Col-
lectanea, Amsterdam 1901, p. XLII.
9
Divi Caroli V Imp. Opt. Max. Victoriae, 1556; hollstein, Dutch and
Flemish Etchings cit., n. 167. Un medaglione d’argento (Bibl. Vat.) attri-
buito a Leone Leoni riproduce la composizione (e. plon, Benvenuto Cel-
lini, Paris 1883, p. xxxiv). Al contrario di ciò che è detto nella raccolta
Fêtes et cérémonies au temps de Charles-Quint cit., p. 373 e nota 38, rite-
niamo che il rilievo derivi piuttosto dall’incisione, attenuando i suoi ele-
menti polemici contro il re di Francia e il papa, che non viceversa.
10
yates, Charles-Quint cit., p. 79.
11
Ibid., pp. 88 sgg.
12 von pastor, Storia dei papi cit., vol. V, p. 102.
13
Oratio Rmi Sadoleti, in Concilio Tridentinum diarorum, actorum, epi-
stularum, Tractatum nova collectio, pubblicazione della Societas Goer-
resiana, vol. XI, Freiburg im Breisgau 1930 n. 15, pp. 108 sgg.
Questo importante discorso concorda perfettamente con la lettera
spesso citata del 27 settembre 1527, in cui Sadoleto esponeva a Cle-
mente prigioniero la sua reazione alle sciagure di Roma: «...Sempre vidi
Storia dell’arte Einaudi 306
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
e prospettai più chiaramente che si dovesse mutare o l’ordine pubbli-
co o precipitare nell’estrema rovina. Avvenne ciò che non desideravo
affatto... Ma se con i nostri tormenti si è placata l’ira e la verità di Dio
e la durezza della pena dischiude la via a migliori costumi e più sante
leggi, non fu forse per noi il peggiore dei mali» (Anecdota letteraria ex
mss. codicibus, a cura di G. C. Amaduzzi, Roma 1783, vol. IV, p. 335).
14
Pietro Paolo Vergerio scrisse più tardi: «Tutte le facende di Cle-
mente erano rivolte in ogni altro luogo che in Germania, queste di
Paolo sono qui quasi tutta hora» (lettera all’Aretino del 1° luglio 1535,
citata da von pastor, Storia dei papi cit., vol. V, p. 32.
15
Per esempio il sonetto di Nicolò Franco da Benevento, La mise-
ra Italia questi infelici tempi (1548): «Non ti piace, ser Carlo, che i
Romani | oggi posti in un sacco | e scavallata | Fiorenza e tutta Napo-
li spogliata | e postala negl’unghie a’ Catalani?... | Non ti piace egli che
a’ Veneziani | oggi la Lega rotta e mirinolata? | e che ne l’Alemagna
scristianata | sia Fedinando re dei Luterani?» (Rime, Firenze 1916, pp.
53 Sgg.). Cfr. grendler, Critics of the Italian World cit., cap. v.
16
Bartsch, 418. Cfr. n. pevsner, Academies of Art Past and Present,
London 1940 [trad. it. Le accademie d’arte, Torino 1982].
17
Bartsch, 49. Con la menzione «Baccius Bandinellus inv.».
18
egger e hülsen, Drei Römischen Skizzenbücher cit.
19
vasari, Le vite cit., VII, pp. 10-11.
20
Ibid., pp. 653-55. Al punto di cadere malato, riferisce non senza
fierezza lo storico.
Probabilmente nel luglio 1532, egli dovette rientrare a Firenze.
21
j. von schi.osser, La letteratura artistica, Firenze 1964, pp.
196-97.
22
Cfr. cap. iv.
23
vasari, Le vite cit., VII, p. 499.
24
bataillon, Erasme et l’Espagne cit., p. 540.
25
de maio, Riforme e miti nella Chiesa del Cinquecento cit., cap. iv,
pp. 93 sgg.
26
j. du bellay, Les Regrets, 1558, sonetto lxxxiii. g. gadoffre, Du
Bellay et le sacré, Paris 1978, ha collocato il poema «in forma di visio-
ne» intitolato Le Songe nella turbata atmosfera di quel periodo.
27
von pastor, Storia dei papi cit., vol. VI, libro II, p. 402.
28
g. b. armenini, De’ veri precetti della pittura, Ravenna 1586,
parte III.
29
Come indicato nel cap. iii, un reliquiario rubato durante il sacco
in San Giovanni in Laterano fu ritrovato precisamente nel 1557 nella
chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano di Calcata. p. de sandoval, Pri-
mera parte de la vida y hechos del emperador Carlos Quinto (1500-28),
Valladolid 16o4, pp. 470-71, riferisce i miracoli che permisero di iden-
tificare allora «el sancto Prepucio».
Storia dell’arte Einaudi 307
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
30
Su Postel, cfr. j. secret, Les Kabbalistes chrétiens de la Renais-
sance, Paris 1964, pp. 171 sgg.
31
Per particolari sulle tombe medicee cfr. de tolnay, The Medici
Chapel cit., cap. XI; d. heikamp, Die Entwurfszeichungen für die
Grabmäler der Mediceerpäpste Leon X. und Clement VII., in «Alberti-
na-Studien», 4 (1966), pp. 134 sgg.; v. l. goldberg, Leo X, Clement
VII and the Immortality of the Soul, in «Simiolus», 8 (1975-76), pp.
16-25; e m. g. dupré, Per la cronologia dei disegni di Baccio Bandinelli
fino al 1540, in «Commentari», 17 (1966), pp. 146-50.
32
vasari, Le vite cit., VI, p. 165.
33
Ibid., p. 172. Questi gruppi sono sempre sul posto a Palazzo Vec-
chio. Sul Palazzo Caffarelli-Vidoni, i fregi dipinti intorno al 1560-70
nello stile di Perino del Vaga contengono scene «all’antica»: glorifica-
zione, exhortatio, incoronazione, trionfo sul carro, vittoria di Tunisi,
ingresso a Roma, glorificazione da parte delle Virtù, tutte collocate tra
un busto e l’altro degli imperatori. Cfr. fagiolo, La città effimera cit.,
figg. 88-92.
34
È la statua che sarà trasportata in Piazza San Lorenzo nel 1851,
sul basamento – diventato fontana – della tomba di Giovanni dalle
Bande Nere lasciato incompiuto da Baccio.
35
p. bargellini, Scoperta di Palazzo Vecchio, Firenze 1968, figg.
213-19. Il modello del soffitto della Sala di Giovanni dalle Bande Nere
è al Louvre (cfr. barocchi, Vasari pittore cit., fig. 54).
36
vasari, Ragionamenti sopra le pitture di Palazzo Vecchio, in Le
Opere di Giorgio Vasari, 1878-85, vol. VIII (382).
37
Ibid., p. 182.
38
Una serie di ventidue composizioni di Stradano incise sotto la
direzione di Philip Galle celebra le vittorie della casa Medici. Cfr. hol-
lstein, Dutch and Flemish Etchings cit., vol. VII, p. 80: «Mediciae
Familiae rerwn feliciter gestarum o in victoriae et triumphi jobanne
Stradano Flandro... delinuta... Philippo co in aes incisa et edita, 1583».
Vi si trova tra l’altro una sorprendente Uscita delle truppe da Castel
Sant’Angelo al tempo di Giovanni dalle Bande Nere, che capovolge
completamente la situazione dei 1527.
39
Nel secolo xv era apparsa un’immagine di Fortuna del tutto diver-
sa dalla figura allegorica con la ruota, dei medioevo (cfr. cap. ii, nota
81): quella della divinità che regge la vela e il timone, di origine anti-
ca. Alberti ne trasse partito a Palazzo Rucellai e sulla facciata di Santa
Maria Novella (nel fregio decorativo). Verso il 1480, un medaglista fio-
rentino sfruttò il motivo che godeva di un elevato patrocinio della filo-
sofia: Platone (Leggi, IV, 709 A), e Ficino (epistola a Giovanni Rucel-
lai). Cfr. a. warburg, Francesco Sassetis Letzwillige Verfügung (1907),
in Gesammelte Schriften, Leipzig 1932, vol. I, p. 147; a. chastel, Art
et Humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique, Paris 1961,
Storia dell’arte Einaudi 308
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
pp. 205-6 [trad. it. Arte e umanesimo a Firenze al tempo di Lorenzo il
Magnifico, Torino 197-99; e f. wind, Platonic Tyranny and the Renais-
sance «Fortuna», in De artibus opuscula XL. Essays in Honor of Erwin
Panofsky, New York 1960, pp. 492 sgg.
40
e. p. pillsbury, A Medici Portrait by Carlo Portelli, in Essays pre-
sented to Myron p. Gilmore, Firenze 1978, vol. II, pp. 289 sgg.
41
p. brugnoli, Maestri della pittura veronese, Verona 1974, p. 222,
fig. 155; v. filippini, Il Palazzo Ridolfi e l’affresco di Domenico Brusa-
sorzi, prefazione di P. Gazzola, Verona 1953.
42
Il tema fu ripetuto pochi anni più tardi al Palazzo Ridolfi (1582).
Alcuni disegni per questa composizione, ritrovati recentemente, atte-
stano la qualità piuttosto forte dello Stile: r. harpath, Graphische
Sammlung (München), Italienische Zeichnungen, München 1977.
43
g. b. giraldi, Hecatommithi cit.
44
m. righetti, Per la storia della novella italiana al tempo della rea-
zione cattolica, Teramo 1921.
Storia dell’arte Einaudi 309
Bibliografia
1. Fonti anteriori al 1600.
alamanni, l., Il Diluvio Romano, in Opere toscane, vol. i, Lyon
1532.
alberini, m., Ricordi. Cfr. d. orano.
albertini, f., Opusculum de mirabilibus novae et veteris urbis
Romae, Roma 1510; ristampe nel 1515, 1522, 1523.
L’entrée du Légat dedans la Ville d'Amyans avecqz la triumphe
de la Ville..., 1527. Cfr. v. jourdain.
Anonimo spagnolo, frammento di manoscritto sul sacco di Roma,
Madrid, BN, Cc 59. Cfr. a. rodríguez-villa, Memorias.
aretino, pietro, Pasquinate del luglio 1522. Cfr. v. rossi.
– Canzone sul sacco di Roma dedicata al marchese di Man-
tova, 7 luglio 1527. Cfr. a. luzio, Pietro Aretino.
– La Cortigiana, Venezia 1534.
– Lettera del 20 novembre 1537; lettera del 1545 a Tiziano,
in f. pertile e e. camesasca (a cura di), Lettere sull’arte di
Pietro Aretino, Milano 1957.
ariosto, l., Orlando furioso, Venezia 15323.
armenini, g. b., De’ veri precetti della Pittura, Ravenna 1586.
baldassarre da pescia, lettera del 15 febbraio 1528. Cfr. m.
sanuto, Diarii, vol. XLV.
barozzi, g., lettera al fratello, 12 maggio 15 2 7. Cfr. m. sanu-
to, Diarii, vol. XLV.
bembo, p., Prose della volgar lingua (1524), in c. dionisotti (a
cura di), p. bembo, Prose e rime, Torino 1971
Storia dell’arte Einaudi 310
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
berni, f., cfr. e. chiorboli.
boaistuau, p., Histoires prodigieuses, Paris 1560.
bonincontri, l., De rebus caelestibus (c. 1472-75), edito da Luca
Gaurico, Venezia 1526.
calvo, f., Antiquae Urbis Romae cum regionibus simulacrum,
Roma 1527; ristampato nel 1532.
calvo salimbeni, i., lettera del 4 ottobre 1528 alla Balia di
Siena. Cfr. c. p. falletti-fossati.
carlo v, lettera del 30 giugno 1527 al principe di Orange. Cfr.
r. ulysse.
carlo v, Lettera del 21 luglio 1527 a Pierre de.Veyre. Cfr. l.
e. halkin e g. dansaert.
casio de’ medici, g., Canzon’ ove si narra la strage e il sacco di
Roma, diritiva al Catolico Re di Spagna e dei Romani, s.l.n.d.
[Roma -15291.
castiglione, b., Il Cortegiano, a cura di G. Prezzolini, Milano
e Roma 1937.
cave, i., Relation sur le Sac de Rome. Cfr. l. dorez, Le Sac de
Rome.
ceffino, z., La Triumphante entrée de lEmpereur nostre Sire
Charles le Cinquiesme toujours auguste taicte en sa très noble
cité de Rome, testo francese, Anversa 1536; testo italiano,
Roma 1536.
celebrino, e., La presa di Roma (1528). Cfr. f. mango.
cellini, b., La vita da lui medesimo scritta (c. 1559-62), a cura
di G. Davico Bonino, Torino 1973.
chalon, ph. de, principe di Orange, Journal (1526-30). Cfr. a.
d. pierrugues.
clemente vii, breve del 23 giugno 1526, Roma 1526.
– Brevi del A luglio e del 26 ottobre 1527. Cfr. b. fontana,
Renata di Francia.
– Breve del 27 agosto 1528. Cfr. b. fontana, Documenti
vaticani.
– Lettera del 24 ottobre 1528 a Carlo V. Cfr. l. von pastor,
vol. IV.
– Lettera del luglio 1530 a Egidio da Viterbo, in j. f. ossin-
ger, Bibliotheca Augustiniana, Ingolstadt 1768.
Storia dell’arte Einaudi 311
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
– Breve del 22 luglio 1531- Cfr. C. ARU.
– Breve che nomina L. G. Manetti Commissario alle antichità
di Roma, novembre 1534. Cfr. r. lanciani, The Golden Days.
Des comettes et de leurs signifiances... (1587)- Cfr. j. m. massing.
condivi, a., Vita di Michelagnolo Buonarroti, Roma 1553, in p.
d’ancona, a. pinna e i. cardellini (a cura di), Michelange-
lo, Milano 1964.
Copia de una lettera da Roma, di 5 Zener 1526 (5 gennaio 1527).
Cfr. sanuto, Diarii, vol. XLIII.
Copia de una lettera del successo & gran crudeltade latta dreto di
Roma che non fu in Hierusalem o’ in Troia cosí grande,
s.l.n.d. [Venezia 1527?].
corsi, p., Ad humani generis servatorem in urbis Romae excidia
P. Cursii civis romani deploratio, Paris 1528.
– Delensio pro Italia ad Erasmus Roterodanum, Roma 1535.
creutzer, p., Auslegung... uber den erschröcklichen Cometen so
im Westrick und umssligenden grentzen erschinen am XI. tag
Weinmonats des m.d.xxvii. jars..., s.l.n.d.
delicado, f., La lozana andaluza, Venezia 1527.
Descriptio Urbis (1526-27). Cfr. d. gnoli, Descriptio urbis.
diaz de frexenal, v., Triumpho pugnico lamentable sopra la pro-
fana entrada y saco del’alma ciudad de Roma, s.l.n.d. [e.
1528?], Madrid 1885.
Die gantz Bibel, Basel 1530.
Direptio expugnatae urbis Romae ab exercitu Caroli Quinti...
anno mdxxvii, da p. aretino, Pornodidascalus seu muliebre.
Frankfurt: 1623; cfr. h. schulz.
dolce, l., L’Aretino (1567), in Trattati d’arte del Cinquecento,
a cura di P. Barocchi, vol. I, Bari 1960.
du bellay, g., cardinale, lettera dell’8 luglio 1527 all’ammi-
raglio Chabot. Cfr. l. dorez, Le Sac de Rome.
du bellay, j., Les Regrets, Paris 1558.
egidio da viterbo, Scechina e Libellus de litteris hebraicis, a cura
di F. Secret, Roma 1959.
enrico viii, cfr. j. s. brewer.
Storia dell’arte Einaudi 312
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
erasmo, d., Enchiridion militis christiani (1503), Basel 1518,
Paris 1923.
– Eloge de la Folie (Moriae Encomium), Strasbourg 1511,
Basel 1515 [trad. it. Elogio della Pazzia, Torino 19641.
– Myconii calvi, Adagiorum chiliades, Venezia 1520.
– Letters, a cura di P. S. Allen, 12 voll., Oxford 1966-68.
– Dialogus ciceronianus, sive de optimo genere dicendi (marzo
1528), Leiden 1643; Amsterdam 1966. Ed. it. a cura di A.
Gambaro, Brescia 1965-
– Apologia brevis ad viginti quatuor libros Alberti Pii quondam
Carporum comitis, in Opera omnia, vol. IX, Leiden 1706.
fanzino (della torre), S., lettera del 23 ottobre 1527. Cfr.
sanuto, Diarii, vol. XLV.
festa, c., Florentia tempus est penitentiae, mottetto sul salmo
78. Cfr. s. lowinski.
fiera, b., Epigramma contro Adriano VI. Cfr. c. dionisotti,
Battista Fiera.
francisco de holanda, Tractato de pintura antiqua (1548), in
a. aureli, Dialoghi michelangioleschi di Francesco d’Olanda,
Roma 1926.
franco de benevento, N., La misera Italia questi infelici tempi
(1548), in Rime, Firenze 19 16.
fritsche, m., Catalogus prodigiorum atque ostentorum, Nürn-
berg 1555.
fulvio, a., Antiquitates Urbis, Roma 1527.
gattinara, m. a. di, Historia vitae et gestorum per dominum
magnum cancellarium, a cura di C. Bornate, Torino 1915.
geldenhauer, g. («Noviomagus»), lettera a Carlo V, in Col-
lectanea, Amsterdam 1901.
giovio, p., De Piscibus (1524), Basel 1531.
– Lettera del 14 febbraio 1527 a D. Contarini. Cfr. sanuto,
Diarii, vol. XLIV.
– Elogia veris clarorum virorum imaginibus apposita quae in
museo Joviani Comi spectantur. Addita in calce operis Adria-
ni pont. vita, Venezia 1546.
– Lettera del 15 agosto 1546 al cardinale Alessandro Farne-
se. Cfr. a. ronchini.
Storia dell’arte Einaudi 313
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
– Vita di Pompeo Colonna, in Elogia virorum bellica virtute illu-
strium.... Firenze 1549.
– Historiarum sui temporis ab anno 1494 ad annum 1547 libri
XLV, Firenze 1550-52.
giovio, p., Ragionamento sopra i moti e disegni d’arme e damo-
re..., Venezia 1556.
– Dialogo dell’imprese militari et amorose, Lyon 1574.
– De vita Hadriani VI, in Vitarum illustrium aliquot virorum
libri X, Basel 1577.
giraldi, g. b., Hecatommithi, Monte Regale 1565.
giraldii l. g., Epistola in qua agitur de incommodis quae in direp-
tione urbana passus est..., in Dialogi duo de poetis nostrorum
temporum, Firenze 1551.
godard, j., Petit traicté contenant la déploration de toutes les prin-
ses de Romme, depuis la fondation ou constitution d’icelle taic-
te par Romulus, jusques à la dernière prinse des Espagnolz qui
a esté plus cruelle que toutes autres, Paris 1528.
gomez, l., De prodigiosis Tiberis inondationibus, Roma 153 1
(non consultato).
gonzaga, francesco, lettere del 7 e 16 maggio 1527 al mar-
chese di Mantova. Cfr. a. luzio, Isabella d’Este.
gonzaga, federico, lettere del 22 maggio 1527 a Fabrizio
Maramaldo. Cfr. luzio, Fabrizio Maramaldo.
grolier, c., Historia expugnatae et direptae Urbis Romae per
exercitum Caroli V imp. die vi maii MDXXVII, Clemente VII
Pontifice, Parigi 1637. Cfr. h. schulz.
grumello, a., Cronaca di Antonio Grumello pavese, dal MCCC-
CLXVII al MDXXIX, a cura di G. Müller, Milano 1856.
gualderonico, t., Relazione sul sacco di Roma. Cfr. m. armel-
lini, Gli orrori.
guazzo, m., Le Historie di tutti i fatti degni di memoria nel
mondo successi, Venezia 1546.
guicciardini, f., Storia d’Italia, libro XVIII, Venezia 1580;
ristampato da C. Panigada, Bari 1929, vol. V.
– Histoire des guerres d’Italie. Trad. francese, Londra 1738.
– Discorsi politici, in g. canestrini, Opere inedite di France-
sco Guicciardini, Firenze 1857, vol. I.
Storia dell’arte Einaudi 314
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
– Considerazioni intorno ai discorsi del Machiavelli sopra la
prima deca di Tito Livio (1528), a cura di G. Canestrini,
Firenze 1857, VOI. I.
– Ricordi autobiografici e di famiglia, in g. canestrini, Opere
inedite di Francesco Guicciardini, Firenze 1857, vol. X.
– Scelta di testi profetici di Savonarola, in r. palmarocchi,
Scritti autobiografici e vari di Francesco Guicciardini, Bari
1936.
– Consolatoria, fatta di settembre 1527 a Finocchieto, tempore
pestis, in r. palmarocchi, Scritti autobiografici e rari di Fran-
cesco Guicciardini, Bari 1936.
guizzalotti, s., Poema sul sacco di Prato nel 1513, in «Archi-
vio Storico Italiano», I (1842).
hall, e., The Union of the Two Noble and Illustre Families of
Lancaster and Yorke (1527), a cura di H. Ellis, London
1809.
infessura, s., Diario della città di Roma, a cura di O. Toma-
sini, Roma 1890.
Instrumentum relationis reliquarum a militibus borbonii ab Urbe
extractis. Cfr. m. armellini, Un documento del Sacco.
kirchmair, g., Denkwürdigkeiten seiner Zeit (1519-1553), Fon-
tes rerum austriacarum, sezione 7, vol. I, Wien 1855.
Lamenti di Roma. Cfr. a. medin e l. frati.
leib, k., Historiarum sui temporis ab anno 1524 usque ad annum
1528 annales. Cfr. j. döllinger.
Leone X, breve del 21 agosto 1521, in i. sannazaro, Poema-
ta, Roma 1793.
lichtenberger, j., Pronosticatio (1488), edizione tedesca con
prefazione di Martin Lutero, Wittenberg 1527.
lipipomani a., Lettera del 7 gennaio 1528 al vescovo di Ber-
gamo. Cfr. sanuto, Diarii, vol. XLVI.
lomazzo, g. p., Idea del Tempio della Pittura (1590), a cura di
R. Klein, Firenze 1974.
lutero, m., De Captivitate babilonica Ecclesiae, Wittenberg
1520.
– Tischreden (1531, 1538), in Sámtliche Werke, Tischreden II,
Weimar 1913.
Storia dell’arte Einaudi 315
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
– melantone, f., Deuttung der czwo grewlichen Figuren,
Bapstesels au Rom und Munchkalbs au Freyerberg i inn Meys-
szen junden (1523).
lycosthenes, c., Prodigiorum ac ostentorum chronicon, Basel
1557.
melantone, f., lettera del 6 giugno 1527 a Wilhelm Reiffen-
stein, in c. g. bretschneider, Corpus Reformatorum, vol.
I, Halle 1834.
– Oratio de capta et direpta urbe Roma per exercitum caesareum
anno MDXXVII [habita a P.M. professore publico], a cura di
N. Gerbelius, Strasbourg 1541; in s. schard, Historicum
Opus, vol. II, Basel 1574; in c. g. bretschneider, Corpus
Reformatorum, vol. II, Halle 1843; ed. ted. Strasbourg
[1528?].
– schwertfeger, i., Passional Christi und Antichristi, Wit-
tenberg 1521.
michelangelo buonarroti, «Veggio nel tuo bel viso, Signor
mio», in Rime, a cura di E. N. Girardi, Bari 1960.
– Lettera del 25 novembre 1523. Cfr. g. milanesi.
micinocchi, De Clemente VII. Pont. Max. Obitu. Cfr. a. ber-
tolotti.
Mirabilia Romae (c. 1475), a cura di R. Ehwald, Weimar 1904.
more, t., A Dialogue concerning Heresyes (1528), in English
Works, London 1557.
münster, s., Cosmographiae universalis Libri VI, Basel 1559.
najera, Abate di, Rapporto a Carlo V, 25 maggio 1527. Cfr.
p. de gayangos, vol. III.
naselli, g., lettera del 25 giugno 1527 al duca di Ferrara. Cfr.
g. salvioli.
navagero, a., lettera del 27 luglio 1527 al doge di Venezia.
Cfr. r. l. brovn.
Neue Zeytung auss Rom, wie das grausam und erschröcklich gross
wasser der Tyber schaden than hat, marzo 1530.
olivar, p. j., lettera del 13 marzo 1527 a Erasmo. Cfr. era-
smo, Letters.
orange, principe di, cfr. a. d. pierrugues.
Storia dell’arte Einaudi 316
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
osiander, a. e sachs, h., Eyn wunderliche Weyssagung von
dem Babstumb..., Nürnberg 1527.
paleotti, g., Discorso intorno alle imagini sacre e profane, in
Trattati d’arte del Cinquecento, a cura di P. Barocchi, Bari
1961, vol. II.
panvinius, o., De praecipuis urbis Romae sanctioribusque basi-
licis... Liber, Roma 1570.
Passio Domini septimi Clementis, secundum Marcum. Cfr. c.
milanesi, Il Sacco ...
pelegrino de taxis, Neue zeytung von Rom... Venezia [1527].
Cfr. h. schulz.
pérez j., lettere del 25 giugno e 4 agosto 1527 a Carlo V. Cfr.
p. de gayangos.
pio da carpi, a., Ad Erasmi... expostulationem responsio accu-
rata et paraenatica, Paris 1529.
– Tres et vigenti libri in locos lucubrationum variarum. D. Era-
smi Roterodami, Paris 1531.
rabelais, f., Lettres écrites dItalie, a cura di V. Bourriffy, Paris
1910.
raffaello da montelupo, La vita. Cfr. g. gaye.
Romance del Saco de Roma por las tropas del condestable de Bor-
bon, in Biblioteca de Autores Españoles, 16: Romancero gene-
ral, a cura di A. Duran, vol. II, Madrid 1861.
Per i resoconti contemporanei del sacco di Roma, vedere mila-
nesi, Il Sacco; p. picca e h. schulz.
sadoleto, j., lettera del 27 settembre 1527 a Clemente VII,
in g. c. amaduzzi, Anecdota letter an a ex mss. codicibus, voi.
IV, Roma 1783.
– Lettera ad Erasmo, in Epistolarum libri XVI, Lyon 1550.
– Oratio Rmi Sadoleto, in Concilium Tridentinum Diarorum,
Actor an, Epistularum, Tractatum nova collectio, Societas
Goerresiana, vol. XI, Freiburg im Breisgau 1930.
sala, a., Ordine, Pompe, Apparati et Ceremonie della solenne
entrata di Carlo V Imperatore sempre Augusto nella città di
Roma, Roma 1536. Cfr. anche v. forcella.
saluzzo di castellar, g. a., Memoriale (1482-1528), a cura di
V. Promis, Torino 1869.
Storia dell’arte Einaudi 317
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
sandoval, p. de, Primera parte de la vida y hechos del empera-
dor Carlos Quinto (1500-28), Valladolid 1604.
sanga, lettera del 27 giugno 1527 al nunzio in Inghilterra. Cfr.
j. s. brewer.
sannazaro, i., De partu Virginis (1526), a cura di A. Altamu-
ra, Napoli 1948.
santoro, l., Dei successi del Sacco di Roma e guerra del regno
di Napoli sotto Lotrech per L. Santoro da Caserta, a cura di
S. Volpicella, Napoli 1858.
santa-cruz, a. de, La Cronica del Emperador Carlos V, Madrid
1920-25.
sanuto, m., Diarii, a cura di F. Stefani, G. Berchet e N.
Barozzi, voll. XLV e XLVI, Venezia 1896 e 1897.
scève, m., Délie, Lyon 1544.
schard, s., Historicum opus, vol. II: Rerum germanicorum scrip-
tores, Basel 1574.
schedel, h., Liber chronicarum, Nürnberg 1493.
schertlin von burtenbach, s., Lebensbeschreibung des berihm-
ten Ritters Sebastian Scherttin von Burtenbach, a cura di C.
S. von Holzsffiuher, 2 voll., Nürnberg 1777-82.
scheurl, ch., Einrit Keyser Carlen in die alten Keyserlichen
haubtstatt Rom, den 5. Aprilis, 1536 (non consultato).
sebastiano del piombo, lettere del 15 maggio 1527, e altra
senza data, all’Aretino, in Lettere scritte al signor Pietro Are-
tino, Venezia 1551; ripubblicate da T. Landoni, Bologna
1873; lettera del 1527 all’Aretino, in g. bottari e s. ticoz-
zi, vol. III.
– Lettere del 6 e 7 settembre 1520, 24 febbraio 1531 e 17
luglio 1533 a Michelangelo. Cfr. g. milanesi, Les corre-
spondants de Michel-Ange.
serlio, s., Regole generali di architettura sopra le cinque manie-
re de gli edifici, Venezia 1537.
sernini, n., lettera del io novembre 1541 al cardinale Ercole
Gonzaga. Cfr. p. barocchi, Giorgio Vasari.
Sie ist gefallen, gefallen die grosse Stadt... Cfr. h. schulz.
soriano, a., Relazione al Senato di Venezia (luglio 1535). Cfr.
e. alberi.
Storia dell’arte Einaudi 318
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
stafileo, g., Oratio... (15 maggio 1528), s.l.n.d. [Roma 1528].
Ed. ted. s.l.n.d. [Strasbourg 1528?1, riedita da s. schard,
Historicum Opus, vol. II, Basel 1574.
La Terrible et espouventable comete laquelle apparut le XI. Doc-
tobre Lan mcccccxxvii en Vuestrie region Dalemaigne...,
s.l.n.d. [1528].
torquato, g., De eversione Europae Prognosticon (1532 o
1534), Anversa 1544.
Trist’Amarilli mia..., in Madrigali di diversi musici (1530)- Cfr.
d. harsan.
urbano, lettera del 12 maggio 1527 alla duchessa di Urbino.
Cfr. sanuto, Diarii, vol. XLV.
vafer, th., lettera del 17 giugno 1527. Cfr. i. mayerhofer.
valdés, a. de, Pro divo Carolo apologetici libri duo, Alcali,
Mayence, Anversa 1527.
– Dialogo en que particularmente se tratan de las cosas ocurri-
das en Roma el ago de MDXXVII, s.l. [1529?], ed. it. Vene-
zia 1545; edizione a cura di j. F. Montesinos, Madrid 1928
[trad. it. a cura di G. de Gennaro, Napoli 19681.
valeriano, g. pierio, Pro sacerdotum barbis, Roma 1531; ripub-
blicato, Leiden 1639.
– De litteratorum infelicitate libri duo. Ejusdem Bellunensia.
Nunc primum e Bibliotheca Lolliniana in lucem edita, Vene-
zia 1620.
valla, l., De falso credita et ementita Constantini donatione decla-
matio (c. 1440), a cura di U. von Hutten, Mayence 1518.
valles, p. de, Historia del fortissimo capitán Don Hernando de
Avalos, marqués de Pescara, con los hechos memorables de
otros siete excelentissimos capitanes del Emperador Don Car-
los V, rey de España, Anversa 1562.
vasari, g., Le vite de’ piú eccellenti pittori, scultori ed architet-
tori (1568), a cura di G. Milanesi, Firenze 1878-85; ristam-
pato nel 1906.
– Ragionamenti sopra le pitture di Palazzo Vecchio, a cura di
G. Milanesi, Firenze 1885; ristampato 1906.
varchi, b., Storia fiorentina, Colonia 1721.
Storia dell’arte Einaudi 319
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
vergerio, p. p., lettera del 1° luglio 1535 all’Aretino. Cfr.
l. von pastor.
vettori, f., Viaggio in Alemagna di Francesco Vettori... aggiun-
tavi... il Sacco di Roma del 1527, dello stesso, a cura di C.
Salvi, Firenze e Paris 1837.
vida, m. g., Poeticorum libri tres, Roma 1525.
vincenzo da treviso, lettera del 15 giugno 1527. Cfr. sanu-
to, Diarii, vol. XLV.
virgilio, p., De prodigiis (1526), Basel 1531.
vitelli, n., lettera dell’11 maggio 1527, a Vitello Vitelli, in
Lettere di diversi... scritte a... Vitello Vitelli, Firenze 1551.
Warhatttige und kurtze berichtung inn der Summa..., s.l.n.d.
[1527]- Cfr. h. schulz.
wolf, i., Lectionum memorabilium et reconditarum Centenarii
XVI, Lavingae 1600.
wolsey, lettera a Enrico VIII sulla sua entrata a Calais (1527).
Cfr. j. s. brewer.
2. Studi.
ackermann, j. s., The Architecture of Michelangelo, London
1959 [trad. it. L’architettura di Michelangelo, Torino 1968].
adams, r. p., The Better Part of Valor: More, Erasmus, Coht and
Vives on Humanism, War and Peace. 1496-1535, Seattle 1962.
Adrien VI. Le premier pape de la Contre-Réforme. Sa personna-
lité, sa carrière, son oeuvre, Louvain 1959.
alberi, e., Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato duran-
te il secolo decimosesto, vol. III, Firenze 1855.
anglo, s., Spectacle, Pageantry and Early Tudor Policy, Oxford
1969.
arcari, p., La Roma di Dante, in Studi su Dante, vol. VII, Roma
1944.
armellini, m., Gli orrori del saccheggio di Roma l’anno 1527
descritti da un cittadino romano di quel tempo, in «Crona-
chetta Mensuale di Scienze Naturali e d’Archeologia», serie
IV, vol. 20 (1886).
Storia dell’arte Einaudi 320
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
– Un documento del Sacco di Roma del 1527, in «Cronachetta
Mensuale di Scienze Naturali e d’Archeologia», 24 (1890).
aru, c., Il Trittico di Clemente VII nel Tesoro del Duomo di
Cagliari, in Mélanges Hulin de Loo , Bruxelles e Paris 1931.
aubenas, r. e ricard, r., L’Eglise de la Renaissance (1449-1517),
s.l. 1951, in a. fliche e v. martin (a cura di), Histoire de l’E-
glise, vol. XV [trad. it. La Chiesa e il Rinascimento
(1449-1517), Torino 1972, in a. fliche e v. martin (a cura
di), Storia della Chiesa dalle origini ai giorni nostri, vol. XVI.
bainton, r., The Left Wing of the Reformation, in «Journal of
Religion», 2 1 (1941); ristampato in Studies on the Refor-
mation, Boston 1963.
– Ein wunderliche Weyssagung: Osiander, Sachs, Luther, in
«Germanic Review», 16 (1946); ristampato in Studies on the
Reformation, Boston 1963.
balan, p., Clemente VII e l’Italia dei suoi tempi, Milano 1887.
baldwin brown, g., Vasari on Technique, London 1907.
baltrusaitis, j., Réveils et prodiges. Le gothique fantastique,
Paris 1960.
barbier de montault, x., Les souterrains et le trésor de
Saint-Pierre à Rome, Roma 1866.
bargellini, p., Scoperta di Palazzo Vecchio, Firenze 1968.
barocchi, p., Giorgio Vasari, in La vita di Michelangelo nelle due
redazioni del 1550 e del 1568, Milano 1962.
– Vasari pittore, Milano 1964.
bataillon, m., Alfonso de Valdèsl auteur du «Dialogo de Mercu-
rio Y Caron», in Homenaie a Menendez Pidal, Madrid 1926.
– Erasme et l’Espagne, Paris 1937.
berrli, c. a., Le peintre poète Nicolas Manuel et l’évolution
sociale de son temps, Genève 1953.
berenson, b., Italian Pictures of the Renaissance: Central and
North-Italian Schools, London 1968.
bernini, d., Historia di tutte l’heresie, Roma 1746.
bertini-calosso, a., Ritratti del Giudizio Universale, in Miche-
langelo Buonarroti nel IV centenario dei Giudizio Universale.
1541-1941, Firenze 1942.
Storia dell’arte Einaudi 321
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
bertolotti, a., Note sincrone sui papi dalla metà del secolo XV
a quella del XVI e sul sacco di Roma del 1527, in «Archivio
Storico, Archeologico e Letterario della Città e Provincia
di Roma», 4 (1881).
biagetti, b., Relazione III: monumenti, musei et gallerie ponte-
ficie nel quadriennio 1930-1934, in «Rendiconti della Pon-
tificia Accademia Romana di Archeologia», 9 (1933).
– Monumenti, musei e gallerie Pontificie nel quadriennio
1930-1934 relazione, in «Rendiconti della Pontificia Acca-
demia Romana di Archeologia», 10 (1935).
Bilder nach Bildern. Druckgrafik und die Vermittlung von Kunst,
mostra, Westfalisches Landesmuseum, Münster 1976.
blum, a., L’estampe satyrique en France pendant les guerres de
religion, Paris 1916.
boehmer, h., Luthers Romfahrt, Berlin 1914.
bologna, f., Il Carlo V del Parmigianino, in «Paragone», n. 73
(1956).
bonannus, p., Numismata Pontificum Romanorum, Roma 1699.
boncompagni-ludovisi, u., Il Sacco di Roma, Albano 1929
(non consultato).
bonnard, f., Histoire du couvent royal de la Trinité du Mont Pin-
cio à Rome, Paris 1933.
bonora, e., Francesco Berni e la poesia bernesca, in Storia della
letteratura italiana, vol. IV: Il Cinquecento, Milano 1966.
borgatti, m., Castel Sant’Angelo in Roma, Roma 1931.
bottari, g. e ticozzi, s., Raccolta di lettere sulla pittura, scul-
tura ed architettura, 8 voll., Milano 1822-25.
brandi, c., Disegni inediti di D. Beccafumi, in «Bollettino d’Ar-
te», serie 111, 28, 1934.
brantôme, Les grands capitaines, vol. I: Les grands capitaines
étrangers; M. de Bourbon, le colonnel Frunsberg, Paris 1864.
brednick, r. w., Die Liedpublizistik im Flugblatt des 15. bis 17.
Jahrhunderts, 2 voll., Baden-Baden 1974 e 1975.
brewer, j. s., Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the
Reign of Henry VIII, vol. IV, parte II, London 1872.
briganti, g., Il Manierismo italiano, Roma 1945.
Storia dell’arte Einaudi 322
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
brown, g. k., Italy and the Reformation to 1550, Oxford 1933.
brown, r. l., Calendar of State Papers and Manuscripts Relating
to English Affairs Existing in the Archives and Collections of
Venice..., vol. III: 1520-26, London 1869; vol. IV: 1527-33,
London 1871.
brugnoli, m. v., Gli affreschi di Perino del Vaga nella Cappella
Pucci. Note sulla prima attività romana del pittore, in «Bol-
lettino d’Arte», 47 (1962).
brugnoli, p., Maestri della pittura veronese, Verona 1974.
brummer, h., The Statue Court in the Vatican Belvedere,
Stockholm 1970.
buchholz, f., Protestantismus und Kunst im sechzehnten Jahrhun-
dert, Studien über christliche Denkmäler, 17, Leipzig 1928.
buddensieg, t., Gregory the Great, the Destroyer of Pagan Idols,
in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 28
(1965).
– Zum Statuenprogramm in Kapitolplan Pauls III, in «Zeitsch-
rift für Kunstgeschichte», 39 (1969).
burckhardt, j., Die Kultur der Renaissance (1860) [trad. it. La
civiltà del Rinascimento in Italia, Firenze 19681.
burckhardt-wertheman, t., Ober Zeit und Anlass des Flug-
blattes: Luther als Hercules germanicus, in «Basler Zeitsch-
rift», 4 (1905).
cabrol, f. e leclercq, h., Dictionnaire d’archéologie chrétien-
ne et de liturgie, vol. VII, Paris 1927.
camesasca, e., Tutta l’opera del Cellini, Milano 1955.
cancellieri, f., Storia dei solenni possessi de’ sommi pontefici
da Leone III a Pio VII, Roma 1803.
– Il mercato, il lago dell’Acqua Vergine, il Palazzo Panfiliano
nel Circo Agonale, Roma 1811.
canovas del castillo, a., Del assalto y saco de Roma por los
Españoles, Madrid 1858.
cantimori, d., Eretici italiani del Cinquecento, Firenze 1939.
– Italy and the Papacy, in The New Cambridge Modern History:
The Reformation, 1520-1159, a cura di G. R. Elton, Cam-
bridge 1958; ristampato 1975.
Storia dell’arte Einaudi 323
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
– Introduzione a l. ranke, Storia dei Papi, Firenze 1959;
ristampato in Storici e storia, Torino 1971.
– Chabod storico della vita religiosa italiana del Cinquecento, in
«Rivista Storica Italiana», 72 (1960); ristampato in Storici
e storia, Torino 1971.
– Francesco Guicciardini, in Storia della letteratura italiana,
vol. IV: Il Cinquecento, Milano 1966.
– Erasmo e la vita religiosa italiana del secolo xvi, in Umanesi-
mo e religione nel Rinascimento, Torino 1975.
carande, r., El sorprendido y sorprendente Adriano VI, papa, in
Homenaje a Johannes Vincke, Madrid 1963.
cardellini, i., Michelangelo e i contemporanei, in Michelange-
lo, Milano 1964.
cartwright, i., The Perfect Courtier: Baldassarre Castiglione, His
Life and Letters 1478-1529, New York 1972.
cassanelli, l., delfini, g. e fonti, d., Le mura di Roma. Lar-
chitettura militare nella storia urbana, Roma 1974.
castagnoli, f., Raffaello e le antichità di Roma, in Raffaello,
l’opera, le fonti, la fortuna, Novara 1968.
cavaletti-rondini, g., Nuovi documenti sul sacco di Roma del
mdxxvii, in «Studi e Documenti di Storia e Diritto», 5 (1884).
céard, j., La nature et les prodiges. L’insolite au XVIe siècle en
France, Genève 1977.
chabod, f., Del «Principe» di Niccolò Machiavelli, 1925.
– Il Rinascimento, in Problemi storici e orientamenti storiogra-
fici, Como 1942; ristampato in Questioni di storia moderna,
Milano 1948
chabod, f., Paolo Giovio (1954), ristampato in Scritti sul Rina-
scimento, Torino 1967.
– Y a-t-il un Etat de la Renaissance?, in Actes du Colloque sur
la Renaissance, Paris 1958.
chacôn, a., Vitae et res gestae Pontificum romanorum, vol. III,
Roma 1677.
chambers, d. s., Cardinal Wolsey and the Papal Tiara, in «Bul-
letin of the Institute of Historical Research», 38 (1965).
– The Imperial Age of Venice. 1380-1580, London 1970.
Storia dell’arte Einaudi 324
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
chastel, a., L’Antéchrist à la Renaissance (1952), ristampato
in Fables, Formes, Figures, vol. I, Paris 1978.
– Les entrées de Charles-Quint en Italie, in Fêtes et cérémonies
au temps de Charles-Quint, a cura di J. Jacquot, Paris 1960.
– Art et Humanisme à Florence au temps de Laurent le Magni-
fique, Paris 1961 [trad. it. Arte e umanesimo a Firenze al
tempo di Lorenzo il Magnifico, Torino 19791.
– Le mythe de la Renaissance, Genève 1969.
– Le «Dictum Horatii: Quidlibet audendi potestas» et les arti-
stes (XIII-XVIe siècles), in «Académie des Inscriptions et Bel-
les-Lettres. Comptes rendus», (gennaio-marzo 1977).
– L’aria: théorie du milieu à la Renaissance, 1973, in Fables,
Formes, Figures, vol. I, Paris 1978.
– Le «ignudi» de Michel-Ange, 1975, in Fables, Formes, Figu-
res, vol. I, Paris 1978.
– Fables, Formes, Figures, 2 voll., Paris 1978.
– Two Roman Statues: Saints Peter and Paul, in Collaboration
in Renaissance Art, a cura di Stedman Sheard e J. T. Pao-
letti, New Haven 1978.
– La Véronique, in «Revue de l’Art», n. 40 (giugno 1978).
– La Chapelle de Saint-Michel à la Trinité-des-Monts, in Actes
du colloque sur les Pieux Etablissements français, Rome, mai
1978.
– La Cour des Farnèse, in Le Palais Farnèse, Roma 1981.
– partner, p., Renaissance Rome, 1500-1559, in «Journal of
the Society of Architectural Historians», 37 (1978).
chiarini, m., Pittura su pietra, in «Antichità Viva», 9 (1970),
fasc. 2.
chiorboli, f., Francesco Berni. Poesie e prose, Firenze 1934.
ciaconius, Cfr. chacôn.
ciampini, g., De sacris aedificiis a Constantino Magno construc-
tis, Roma 1693.
cian, v., recensione di E. Müntz, La Bibliothèque du Vatican
au XVIe siècle, Paris 1886, in «Giornale storico della Lette-
ratura Italiana», 9 (1887).
– La coscienza politica nazionale nel Rinascimento (1931 e
1935), in Scritti minori, 2 voll., Torino 1936.
Storia dell’arte Einaudi 325
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
ciardi-duprú, m. g., Per la cronologia dei disegni di Baccio Ban-
dinelli fino al 1540, in «Commentari», 17 (1966).
clements, r. j., Michelangelo’s Theory of Art, London 1961.
coggiola, g., Per l’iconografia di Pietro Bembo, in «Atti del
Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 4 (1914).
corradi, a., Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime
memorie fino al 1850, Bologna 363.
courcelle, p., La Consolation de Philosophie dans la tradition
littéraire, Paris 1967.
creighton, m., History of the Papacy, vol. VI, London 1884.
crowe, j. a. e cavalcaselle, g. b., Raphael, His Life and
Works, London 1885.
dacos, n., Les Loges de Raphaël, in Classical Influences, Cam-
bridge 1976.
– Le logge di Raffaello. Maestro e bottega di fronte all’antico,
Roma 1977.
davidson, b. f., Marcantonio’s Martyrdom of S. Lorenzo, in
«Bulletin of Rhode Island School of Design», 47 (1960-61).
– Early Drawings by Perino del Vaga, in «Master Drawings»,
1 (1963).
de angelis d’ossat, f., Gli archi trionfali ideati dal Peruzzi per
la venuta di Carlo V, in «Capitolium», 18 (1943).
de boni, f., Gli eserciti stranieri in Roma nell’anno 1527, in «Il
Politecnico», serie 11, vol. 47 (1860).
dell’arco, m., Pasquino e le Pasquinate, Milano 1957.
delumeau, j., Vie économique et sociale de Rome dans la secon-
de moitié du XVIe siècle, 2 voll., Paris 1957 e 1959; ristam-
pato abbreviato in 1 vol., Rome au xvie siècle, Paris 1975
[trad. it. Vita economica e sociale di Roma nel Cinquecento,
Firenze 19791.
– La civilisation de la Renaissance, Paris 1967.
de maio, r., Riforme e miti nella Chiesa del Cinquecento, Napo-
li 1973.
destombes, m., A Panorama of the Sack of Rome by Pieter Brue-
gel the Elder, in «Imago Mundi», 14 (1959).
diez del corral, l., La monarquia hispanica en el pensamiento
politico europeo, de Maquiavelo a Humboldt, Madrid 1975.
Storia dell’arte Einaudi 326
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
dionisotti, c., Battista Fiera, in «Italia Medioevale e Umani-
stica», 1 (1958).
– Chierici e laici nella letteratura italiana del primo Cinquecen-
to, in Problemi di vita religiosa in Italia dei Cinquecento,
Padova 1960; ristampato in Geografia e storia della lettera-
tura italiana, Torino 1967.
döllinger, i., Beitrage zur Politischen, Kirchlichen und Kulturge-
schichte der letzten sechs Jahrhunderte, vol. II, Regensburg
1862.
dollmayr, h., Rafaels Werkstätte, in «Jahrbuch der Kunsthist.
Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses», 12 (1895).
d’onofrio, c., Il Tevere a Roma, Roma 1968.
doren, a., Fortuna im Mittelalter und in Renaissance, in «Vor-
träger der Bibl. Warburg», 2 (1922-23).
dorez, l., Antonio Tebaldo, les Sadolet et le Cardinal Jean du
Bellay, in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», 26
(1895).
– La Cour du Pape Paul III, 2 vol., Paris 1932.
– Le Sac de Rome (1527). Relation inédite de Jean Cave, orléa-
tiais, in «Mélanges d’Archéologie et d’Histoire. Ecole fran-
gaise de Rome», 16 (1896).
durrer, r., Die Schweizergarde in Rom und die Sckweizer in
pdpstlichen Diensten, Luzern 1927.
dossler, l., Sebastiano del Piombo, Basel 1942.
düssler, l., Raphael, München 1966.
egger, h., Zur Dauer von Martens van Heemskerck Autenthalt
in Rom (1532-1535), in «Mededeelingen van het Neder-
lendsch Instituut to Rom», 5 (1925).
ehses, s., Römische Dokumente zur Geschichte der Ehescheidung
Heinrichs VIII. von England. 1527-1534, in Quellen und For-
schungen aus dem Gebiete der Geschichte, Paderborn 1893.
einstein, a., The Italian Madrigal, Princeton 1949.
eisler, r., The Frontispiece to Sigismondo Fantis «Triompho di
Fortuna», in «Journal of the Warburg and Courtauld Insti-
tutes», 10 (1947).
evennett, h. o., The New Orders, in The New Cambridge
Storia dell’arte Einaudi 327
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
Modern History: The Reformation, 1520-1559, a cura di G.
R. Elfon, Cambridge 1958; ristampato nel 1975.
falletti-fossati, c. p., Clemente VII e l’impresa di Siena, il
Sacco di Roma, l’assedio di Napoli, Siena 1879.
fenyö, i., Der Kreuztragende Christus Sebastiano del Piombos in
Budapest, in «Acta Historiae Artium», 1 (1953).
ferrero, g. g., Politica e vita morale del Cinquecento nelle let-
tere di Paolo Giovio, Torino 1940.
ferry, m., «Candor illaesus»: The «Impresa» of Clement VII and
Other Medici Devices in the Vatican «Stanze», in «The Bur-
lington Magazine», 119 (1977).
filippini, v., Il Palazzo Ridolfi e l’affresco di Domenico Brusa-
sorzi, Verona 1953.
fischel, o., I ritratti di Clemente VII nella sala di Costantino in
Vaticano, in «Illustrazione Vaticana», 1937.
foffano, f., Prose filologiche. La questione della lingua, Firen-
ze 1908; ripubblicato da F. Ageno, Firenze 1961.
fontana, b., Renata di Francia duchessa di Ferrara. Sui docu-
menti dell’archivio Estense, del Mediceo, del Gonzaga, e del-
l’archivio secreto vaticano (1510-36), vol. I, Roma 1889.
– Documenti vaticani contro l’eresia luterana in Italia, in «Archi-
vio della Reale Società Romana di Storia Patria», 15 (1892).
forcella, v., Tornei e giostre, ingressi trionfali e feste carnevale-
sche in Roma sotto Paolo III, Roma 1885.
fraikin, j., Nonciatures de France. Nonciatures de Clément VII,
2 voll., Paris 1906.
freedberg, d., The Problem of Images in Northern Europe and
Its Repercussions in the Netherlands, in Hafnia: Copenhagen
Papers in the History of Art 1976, Kobenhavn 1977.
freedberg, s. j., Parmigianino: His Works in Painting, Cam-
bridge (Mass.) 1950.
– Painting of the High Renaissance in Rome and Florence, Cam-
bridge (Mass.) 1961.
freedberg, s. j., Painting in Italy. 1500-1600, Harmondsworth
1971.
The Frick Collection, catalogo, vol. I, New York 1968.
Storia dell’arte Einaudi 328
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
friedländer, w., Die Entstehung des antiklassischen Stiles in der
italienischen Malerei um 1520, 1925.
frommel, c. l., Der römische Palastbau der Hochrenaissance,
Tübingen 1973.
– Michelangelo and Tommaso dei Cavalieri, Amsterdam 1979.
frutaz, a. p., Le piante di Roma, Roma 1962.
fuchs, e., Die Karikatur der europäischen Völker, Berlin 1901.
gadoffre, g., Du Bellay et le sacré, Paris 1978.
garin, e., Lo Zodiaco della vita. La polemica sull’astrologia dal
Trecento al Cinquecento, Bari 1976.
gauthiez, p., Nuovi documenti intorno a Giovanni de’ Medici
detto delle Bande Nere, in «Archivio Storico Italiano»,
1902-903.
– Jean des Bandes Noires, Paris 1901.
gayangos, p. de, Calendar of Letters. Despatches and State Papers
Relating to the Negotiations between England and Spain Pre-
served in the Archives at Salamanca, London 1877.
gaye, g., Carteggio inedito di artisti dei secoli XV, XVI e XVII,
Firenze 1840.
geisberg, m., Die Reformation in den Kampfbildern der Ein-
blattsholzschnitten, München 1929.
gere, j. a., Two Late Fresco, Cycles by Perino del Vaga: The Mas-
simi Chapel and the Sala Paolina, in «The Burlington Maga-
zine», 102 (1960).
giese, r., Erasmus and the Fine Arts, in «The Journal of Modern
History» (settembre 1935).
gilbert, f., Andrea del Sarto «Heilige Familie Borgherinio und
florentinische Politik, in Festschrift ffir Ottd von Simson zum
65. Geburtstag, a cura di L. Grisebach e K. Renger, Frank-
furt am Main 1977.
– Machiavelli and Guicciardini, Princeton 1965 [trad. it.
Machiavelli e Guicciardini, Torino 19701.
gilmore, m. p., Erasmus and Alberto Pio, Prince of Carpi, in
Action and Conviction in Early Modern Europe: Essays in
Memory of E. H. Harbison, a cura di T. K. Rabb e J. E. Sie-
gel, Princeton 1969.
Storia dell’arte Einaudi 329
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
– Anti-Erasmianism in Italy: The Dialogue of Ortensio Lando
on Erasmus’ Funeral, in «The Journal of Medieval and
Renaissance Studies y», 4 (1974).
ginzburg, c. e prosperi, a., Giochi di pazienza, Torino 1975.
giordani, g., Cronaca della venuta e dimora a Bologna del
Sommo Pontefice Clemente VII per la coronazione di Carlo V
Imperatore, Bologna 1842.
gnoli, d., Il Sacco di Roma e la peste, in «Nuova Antologia»,
serie II, vol. 26 (1880).
– Le origini di Maestro Pasquino, in «Nuova Antologia», 25
(1890), n. 7.
gnoli, d., Descriptio urbis o censimento della popolazione di
Roma avanti il Sacco borbonico, in «Archivio della Reale
Società Romana di Storia Patria», 18 (1894).
– Il giardino e l’antiquario del cardinale Cesi, Roma 1905.
göbel, h., Wandteppiche, vol. I. Die Niederlande, Leipzig 1923.
golzio, v. e zander, g., L’arte in Roma nel secolo XV, Roma
1968.
gould, c., The Sixteenth Century Italian Schools, London 1962.
graf, a., Roma nella memoria e nelle immaginazioni del medioe-
vo, Torino 1915.
gregorovius, f., Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter vom
xv. bis zum XVII. Jahrhundert, Stuttgart 1859-72; 1886-96’
[trad. it. Storia della città di Roma nel Medioevo, 3 voll.,
Torino 1973.
grendler, p. f., Critics of the Italian World, 1530-1560: Anton
Francesco Doni, Nicolo Franco and Ortensio Lando, Madison
(Wisc.) 1969.
grimaldi, j., Instrumenta autentica translationum sanctorum cor-
porum et sacrarum reliquiarum e veteri in novam basilicam,
Roma 162 1.
grisar, h., Le tombe apostoliche di Roma, in «Studi e Docu-
menti di Storia e Diritto», 13 (1897).
– Die rdmische Kapelle Sancta Sanctorum und ihr Schatz, Frei-
burg im. Breisgau 1908.
– e heege, f., Luthers Kampfbilder, vol. I, Freiburg im Brei-
sgau 1921.
Storia dell’arte Einaudi 330
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
griseri, a., Perino, Machuca, Campafia, in «Paragone», n. 87
(1957).
guglielminetti, m., Memoria e scrittura. L’autobiografia da
Dante a Cellini, Torino 1977.
hagendahl, h., Latin Fathers and the Classic, Göteborg 1958.
halkin, l., Erasme de Turin à Rome, in Mélanges d’histoire du
XVIe siècle offerts à Henry Meylan, Genève 1970.
– e dansaert, g., Charles de Lannoy, vice-roi de Naples, Paris
1934.
hall, m. b., Michelangelo’s Last judgment: Resurrection of the
Body and Predestination, in «The Art Bulletin», 58 (1976).
Hans Baldung-Grien, catalogo della mostra, Karlsruhe 1959.
harpath, r., Graphische Sammlung (Miinchen), Italienische Zei-
chnungen, München 1977.
harsan, d., The Sack of Rome Set to Music, in «Renaissance
Quarterly», 23 (1976).
hartt, f., Raphael and Giulio Romano with Notes on the
Raphael School, in «The Art Bulletin», 26 (1944).
– The Chronology of the Sala di Costantino, in «Gazette des
Beaux-Arts», 36 (1949).
– The Stanza d’Eliodoro and the Sixtine Ceiling, in «The Art
Bulletin», 30 (1950).
hartt, f., Giulio Romano, New Haven 1958.
– Power and the Individual in Mannerist Art, in Studies in
Western Art, vol. III, New York 1963.
hay, d., Italy and Barbarian Europe, in Italian Renaissance Stu-
dies, a cura di E. F. Jacob, London 1960.
hecksher, w., Emblem, Emblembuch, in «Reallexikon zur
deutschen Kunstgeschichte», 5 (1967).
hess, j., On Raphael and Giulio Romano, in «Gazette des
Beaux-Arts», 32 (1947).
– Kunstgeschichtliche Studien zu Renaissance und Barock, Roma
1967.
hill, g. f., A Corpus of Italian Medals of the Renaissance befo-
re Cellini, London 1930.
hirst, m., Rosso, a Document and a Drawing, in «The Bur-
lington Magazine», 106 (1964).
Storia dell’arte Einaudi 331
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
– Sebastianos Pietà for the Commendador Mayor, in «The Bur-
lington Magazine», 114 (1972).
hollstein, f. w., Dutch and Flemish Etchings, Engravings and
Woodcuts ca. 1450-1700, Amsterdam 1954.
hook, j., The Sack of Rome, 1527, London 1972.
– The Destruction of the New Italia: Venice and Papacy in Col-
lision, in «Italian Studies», 28 (1973).
howard, d., Sebastiano Serlios Venettan Copyright, in «The
Burlington Magazine», 115 (1973).
– Jacopo Sansovino: Architecture and Patronage in Renaissance
Venice, New Haven 1975.
hülsen, c., Römische Antikengärten des XVI. jahrhunderts, in
«Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften», 4 (1917).
– e egger, h., Drei Rômischen Skizzenbücher von Martin Van
Heemskerck, 2 voll., Berlin 1913 e 1916; ristampato nel 1975.
Italienische Zeichnungen, mostra, München 1977.
jacobsen, e., Niederländische Kunst in den Galerien Mansi zu
Lucca, in «Oud Holland», 14 (1896).
jacquot, j., Panorama des fêtes et cérémonies du règne. Entrées
italiennes (1535-1536), in Fêtes et cérémonies au temps de
Charles-Quint, a cura di J. Jacquot, Paris 1960.
jammes, a., Un chef-d’oeuvre méconnu d’Arrighi Vicentino, in
Studia bibliographica in honorem de La Fontaine Verwey,
Amsterdam [1965].
janssen, j., L’Allemagne et la Réforme, trad. francese Paris 1892.
jourdain, v. (a cura di), Les spectacles populaires à l’entrée du Légat
d’Angleterre à Amiens (4 Août 1527), Cayeux-sur-Mer 1910.
kampers, f., Vom Werdegang der abendländischen Kaisermystik,
Leipzig 1924.
kitzinger, e., World Map and Fortune’s Wheel: A Mediaeval
Mosaic Floor in Turin (1973), in The Art of Byzantium and
the Mediaeval West: Selected Studies, a cura di F. Klein-
bauer, Bloomington e London 1976.
klaczko, j., Iules II, Paris 1898.
koegler, h., Urs Graf, Basel 1947.
Storia dell’arte Einaudi 332
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
koeplin, d. e falk, t., Lukas Cranach, vol. I, Basel e Stuttgart
1974.
kusenberg, k., Le Rosso, Paris 1931.
lamping, a. j., Ulrichus Velenus and His Treatise against the
Papacy, Studies in Mediaeval and Reformation Thought,
19, Leiden 1976.
lanciani, r., La pianta di Roma antica e i disegni archeologici di
Raffaello, in «Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei.
Classe di scienze morali, storiche e filologiche», serie V,
vol. 3 (1894).
– The Destruction of Ancient Rome, London 1901.
– Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni romane
di antichità, 2 voll., Roma 1902 e 1913; ristampato nel 1975.
– The Golden Days of the Renaissance in Rome from the Pon-
tificate ot Julius II to that of Paul III, London 1906.
lanckoronska, c., Appunti sulla interpretazione del Giudizio
Universale di Michelangelo, in «Annales Institutorum»,
1932-33.
lanzi, l., Storia pittorica dell’Italia, Bassano 1789.
la roca, conte de, Epitome de la vida y echos del emperador
Carlos, Milano 1646.
lavagne, h., Triomphe et Baptême de Constantin. Recherche
iconographique à propos d’une mosdique médiévale de Riez,
in «Journal des Savants» (luglio-settembre 1977).
lebey, a., Le Connétable de Bourbon (1490-1527), Paris 1904.
lesellier, j., Jean de Chennevières, sculpteur et architecte de l’é-
glise Saint-Louis-des-Français à Rome, in «Mélanges d’Ar-
chéologie et d’Histoire. Ecole française de Rome», 45 (1931).
levison, w., Konstantinische Schenkung und Silvesterlegende, in
Miscellanea F. Ehrli, vol. II, Roma 1924.
Lexikon für Theologie und Kirche, 7 (1955).
lieb, n., Die Fugger und die Kunst, vol. II, München 1958.
longhi, r., Ricordo dei manieristi, in «Approdo», 1 (1933);
ristampato in Da Cimabue a Morandi, Milano 1973.
lowinski, s., A Newly Discovered Sixteenth Century Motet
Manuscript at the Biblioteca Vallicelliana in Rome, in «Jour-
nal of American Musicological Society», 3 (1950).
Storia dell’arte Einaudi 333
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
luciani, v., Francesco Guicciardini e la fortuna delle opere sue,
Firenze 1944.
lugano, p., Fra Giovanni da Verona e i suoi lavori alla Camera
della Signatura, Roma 1908.
luzio, a., Fabrizio Maramaldo. Nuovi documenti, Ancona 1883.
luzio, a., Pietro Aretino nei suoi primi anni a Venezia e la corte
dei Gonzaga, Torino 1888.
– Isabella d’Este e il Sacco di Roma, Milano 1908.
maes, c., La sfera radiata di bronzo dorata già infissa al vertice
dell’obelisco vaticano riconosciuta ora ed autentificata con
iscrizione nel museo Capitolino, in «Il Cracas», 4 (1894).
major, e. e gradman, f., Urs Graf, Basel s.d.
malcolm-brown, e., «Lo insaciabile desiderio nostro de cose
antique»: New Documents on Isabella d’Este’s Collections of
Antiquities, in Cultural Aspects of the Renaissance. Essays in
Honour of P. O. Kristeller, a cura di Cecil. H. Clough, Man-
chester 1976.
mâle, e., Les Apôtres Pierre et Paul, in «Revue des Deux-Mon-
des», 15 luglio e 1° agosto 1955.
malraux, a., La corde et la souris, Paris 1976.
mango, f., La Guerra di Camollia e la presa di Roma, rime del
secolo XVI, Bologna 1886.
marabottini, a., Polidoro da Caravaggio, 2 voll., Roma 1969.
marsh, d., Erasmus on Body and Soul, in «Journal of the
History of Ideas» (ottobre-dicembre 1976).
martini, g., La Villa Imperiale di Pesaro, Pesaro s.d.
martinori e., Annali della Zecca di Roma: Clemente VII
(1523-34), in «Atti e Memorie dell’Istituto Italiano di
Numismatica», vol. III, Roma 1917.
massa, e., Egidio da Viterbo, Machiavelli, Lutero e il pessimismo
cristiano, in Umanesimo e machiavellismo, Padova 1949.
massing, j. m., A Sixteenth-Century Illustrated Treatise on
Comets, in «Journal of the Warburg and Courtauld Insti-
tutes», 41 (1977).
maurano, s., Il Sacco di Roma, Milano 1967.
mayerhofer, i., Zwei Briefe aus Rom aus dem jahre 1527, in
«Historisches Jahrbuch», 36 (1891).
Storia dell’arte Einaudi 334
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
mazio, p., Della guerra fra Clemente VII e gli imperiali, e docu-
menti inediti in proposito, in «Il Saggiatore», n. 10 (1844).
meder, i., Dürer-Katalog, Wien 1932.
medin, a. e frati, l., Lamenti storici dei secoli XIV, XV e XVI,
vol. III e IV, Bologna 1890 e 1894.
meiss, m., Painting in Florence and Siena alter the Black Death:
The Arts, Religion, and Society in the Mid-Fourteenth Century,
Princeton 1951 [trad. it. Pittura a Firenze e Siena dopo la
Morte Nera, Torino 1982].
mercati, g., Cenni di A. del Monte e G. Lascaris sulle perdite
della Biblioteca Vaticana nel 1527 (1910), ristampato in
Opere minori, vol. III: Il Vaticano, 1937.
michaelis, a., Geschichte des Statuenhofes, in «jahrbuch des
deutschen Instituts», 5 (1980).
michaelis, a., Römische Skizzenbücher Marten Van Heem-
skercks und anderer nordischer Künstler des xvii. Jahrhunderts,
in «Jahrbuch des kaiserlich deutschen archäologischen
Instituts», 6 (1891).
michelet, j., La Renaissance, Paris 1855.
milanesi, g. (a cura di), Le lettere di Michelangelo Buonarroti,
Firenze 1875.
– Il Sacco di Roma del 1527. Narrazioni di contemporanei,
Firenze 1867.
– Les Correspondants de Michel-Ange, vol. I, Sebastiano del
Piombo, Paris 1890.
milman, h., Savonarola, Erasmus and Other Essays, London 1870.
mitchell, b., The SPQR in Two Roman Festivals of the Early
and Mid-Cinquecento, in «The xvith Century Journal», 9,
n. 4 (1978).
morgan-nichols, f., The Marvels of Rome, London 1889.
moroni, g., Dizionario di erudizione storica-ecclesiastica, Vene-
zia 1840 sgg.
müntz, e., Ricerche intorno ai lavori archeologici di G. Grimaldi,
Firenze 1881.
– Le Musée du Capitole et les autres collections romaines à la fin
du XVe siècle et au commencement du XVIe siècle avec un choix
de documents inédits, in «Revue Archéologique», 43 (1882).
Storia dell’arte Einaudi 335
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
– e frotingham, a. l., Il Tesoro della basilica di San Pietro in
Vaticano dal XIII al XV secolo, con una scelta d’inventari ine-
diti, in «Archivio della Reale Società Romana di Storia
Patria», 6 (1883).
müntz, g., La Bibliothèque du Vatican au XVe siècle, Paris 1887.
murray, p., Italian Renaissance Architecture, London ig6g
[trad. it. L’architettura del Rinascimento italiano, Bari 1981].
neumeister, i., Flugblätter der Reformation und des Bauernkrie-
ges. 50 Blätter aus der Sammlung des Schlossmus., Leipzig 1976.
nijhoff-sellwrff, h., Der Triumphzug Karl des Vten zu Bolo-
gna von Robert Peril, Antwerpen 1530, in «Oud Holland»,
48 (1931).
o’gorman, j. f., An Interpretation of Andrea del Sartos Borghe-
rini Holy Family, in «The Art Bulletin», 47 (1965).
olivato, l., Per il Serlio a Venezia: documenti nuovi e documenti
rivisti, in «Arte Veneta», 21 (1967).
o’malley, j. w., Giles of Viterbo on Church and Reform. A
Study in Renaissance Thought, Leiden 1968.
– Fulfillment of the Christian Golden Age under Pope Julius II:
The Text of a Discourse of Giles ot Viterbo, 1507, in «Tra-
ditio», 25 (1969).
omont, h., Les suites du sac de Rome par les Impériaux et la cam-
pagne de Lautrec en Italie, in «Mélanges d’Archéologie et
d’Histoire. Ecole française de Rome», 16 (1896).
orano, d. (a cura di), I ricordi di Marcello Alberini, vol. I: Il
Sacco di Roma del 1527, Roma 1901.
pacaut, m., La Théocratie, l’Eglise et le pouvoir au Moyen-Age,
Paris 1957.
pagliara, p. n., La Roma antica di Fabio Calvo. Note sulla cul-
tura antiquaria e architettonica, in «Psicon», nn. 8-9 (1976).
pallucchini, r., Sebastian Viniziano, Milano 1944.
panciroli, o., Tesori nascosti dell’alma città di Roma, Roma
1625.
panofsky, e., Albrecht Dürer, 2 voll., Princeton 1943 [trad. it.
La vita e le opere di Albrecht Dürer, Milano 19671.
– «Nebulae in pariete»: Notes on Erasmus’ Eulogy on Dürer, in
Storia dell’arte Einaudi 336
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
«Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 14
(1951).
– Erasmus and the Visual Arts, in «Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes», 32 (1969).
partner, p., Renaissance Rome. 1500-1559. A Portrait of a
Society, Berkeley 1976.
paschini, p. s., Gaetano, G. P. Carala, e le origini dei Teatini,
Roma 1926.
passavant, j. d., Rafael von Urbino und sein Vater Giovanni
Santi, vol. I, Leipzig 1839.
pastor, l. von, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mit-
telalters, Freiburg im Breisgau 1886-1907 [trad. it. Storia dei
papi dalla fine del medioevo, Trento-Roma 1944-641.
patzak, b., Die Villa Imperiale in Pesaro, Leipzig 1908.
pecchiai, p., Roma nel Cinquecento, Bologna 1949.
pecci, g. b., La Brandaneide, Lucca 1757.
pegg, m., A Catalogue of German Reformation Pamphlets
(1516-1546) in Libraries of Great Britain and Ireland, vol. I,
London 1973; vol. 11, 1977.
pertusi, a., La caduta di Costantinopoli, vol. I: Le testimonianze
dei contemporanei; vol. II: L’eco nel mondo, Milano 1976.
petrassi, m., La leggenda di San Silvestro, in «Capitolium», 45
(1970).
petrucci, a., Una vittima del Sacco di Roma, in «Il Messagge-
ro», 17 marzo 1959.
pevsner, n., Academies of Art Past and Present, London 1940
[trad. it. Le accademie d’arte, Torino 1982].
philips, m., The «Adagia» of Erasmus, Cambridge 1964.
phillips, j., The Reformation of Images. Destruction of Art in
England (1535-1660), Berkeley 1973.
picca, p., Il Sacco di Roma del 1527: profezie, previsioni, prodi-
gi, in «Nuova Antologia», 64 (1929).
picot, e., Chants historiques français du XVIe siècle: Règnes de
Louis XII et François Ier, Paris 1903.
pieri, p., Il Rinascimento e la crisi militare italiana, Torino
1952.
Storia dell’arte Einaudi 337
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
pierrugues, a. d., Giornale del principe d’Orange nelle guerre
d’Italia dal 1526 al 1530…, Firenze 1897.
pietri, c., Roma christiana. Recherches sur l’église de Rome, son
organisation, sa politique, son idéologie, de Miltiade à Sixte III
(311-440), Rome 1976.
pillsbury, e., A Medici Portrait by Carlo Portelli, in Essays pre-
sented to Myron P. Gilmore, vol. II, Firenze 1978.
pingré, m., Cométographie ou traité historique et théorique des
comètes, Paris 1783.
pittaluga, m., L’incisione italiana del Cinquecento, Milano
[1930].
La pittura ferrarese del Rinascimento, mostra, Ferrara 1933.
plon, e., Benvenuto Cellini, Paris 1883.
podesta, b., Carlo Quinto a Roma nell’anno 1536, in «Archi-
vio della Reale Società Romana di Storia Patria», i (1877).
pollack, o. e schudt, l., Le guide di Roma, Roma 1930.
pollard, a. f., Wolsey, London 1953.
pontieri, e., Gli ultimi ambiti della indipendenza italiana, in Nei
tempi grigi della storia d’Italia, Napoli 1949.
popham, a., Catalogue ot Drawings by Parmigianino, 2 voll.,
New Haven 1971.
– On Some Works by Perino del Vaga, in «The Burlington
Magazine», 86 (1945).
portoghesi, p., Roma dei Rinascimento, Roma s.d.
pouncey, ph. e gere, j. a., The Drawings of Raphael’s Circle,
London 1962.
prandi, c., Villa Lante, Roma 1955.
pratt, k. j., Rome as Eternal, in «Journal of the History of
Ideas», 25 (1965).
preibisz, l., Martin van Heemskerck, Leipzig 1911.
preusz, h., Die Vorstellungen vom Antichristi im späteren Mittelal-
ter, bei Luther und die kontessionnellen Polemik, Leipzig 1906.
prost, a., Les sciences et les arts occultes au xvie siècle. Corneil-
le Agrippa, sa vie et ses oeuvres, 2 volt, Paris 1882.
quednau, r., Die Dekoration der Sala di Costantino. Anmerkun-
gen zum Spätwerk Raphaels, in «Kunstchronik», n. 30
(1977).
Storia dell’arte Einaudi 338
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
quintavalle, a. c. e zerner, h., L’opera completa del Correg-
gio, Milano 1970.
raemond, fl. de, Histoire de la naissance, progrez et décadence
de l’hérésie de ce siècle, Rouen 1629.
rahner, h., Navicula Petri. Zur Symbolgeschichte des römischen
Primats, in «Zeitschrift für katholische Theologie», 69 (1947).
ramat, r., Il Guicciardini e la tragedia d’Italia, Firenze 1953.
ravioli, c., La guerra di sette anni sotto Clemente VII... dall’an-
no MDXXIII al MDXXXI, sui documenti ufficiali, in «Archivio,
della Reale Società Romana di Storia Patria», 6 (1883).
raynal, o., Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII, vol. XX,
Roma 1663.
redig de campos, d., Il nome di Martin Lutero graffito sulla
«Disputa del Sacramento», in «Ecclesia», 6 (1947).
redig de campos, d., Un altro grafflto del Sacco nelle Stanze di
Raffaello, in «Ecclesia», 19 (1960).
– Raffaello nelle Stanze, Milano 1965.
reeves, m., The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages:
A Study in Joachimism, Oxford 1969.
reinhardt, h., Die Malerfamilie Holbein in Basel, mostra, Basel
1960.
– Einige Bemerkungen zum graphischen Werk Hans Holbein des
jüngeren, in «Zeitschrift für schweizerische Archäologie
und Kunstgeschichte», 34 (1977).
renaudet, a., Etudes érasmiennes (1521-1529), Paris 1939.
– Erasme et l’Italie, Genève 1954.
reynolds, r., Beards, an Omnium Gatherum, London 1950.
richter, g. m., Melcher Feselein, ein Beitrag zur Geschichte der
oberdeutschen Kunst im XVI. jahrhundert, in «Oberbayerische
Archiv für vaterländische Geschichte», 54 (1944).
ridolfi, r., Genesi della «Storia d’Italia» guicciardiana, in «La
Bibliofilia», 40 (1938).
– Vita di Girolamo Savonarola, Roma 1952.
– Vita di Francesco Guicciardini, Roma 1960.
righetti, m., Per la storia della novella italiana al tempo della
reazione cattolica, Teramo 1921.
Storia dell’arte Einaudi 339
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
robert, c., Ober ein dem-Michel-Angelo zugeschriebenes Skiz-
zenbuch auf Schloss Wolfegg, in «Römische Mitteilungen»,
16 (1901).
rocca, a., De particula ex pretioso et vivifico ligno Sacratissimae
Crucis..., Roma 1609.
rodocanachi, e., Le Château Saint-Ange, Paris 1909.
– Rome au temps de Jules II et de Léon X, Paris 1912.
– Les Pontificats d’Adrien VI et de Clement VII, Paris 1933.
rodriguez-villa, a., Memorias para la historia del asalto y saco
de Roma en 1527..., Madrid 1875.
– Italia desde la batalla de Pavia hasta el saco de Roma, Madrid
1885.
rojdestvensky, o., Le culte de saint Michel et le Moyen-Age
latin, Paris 1922.
roli, r., Giovanni de Vecchi, in «Arte Antica e Moderna», 2
9 (1965).
ronchini, a., Giorgio Vasari alla corte dei Cardinale Farnese, in
«Atti e Memorie delle R. R. Deputazioni di Storia Patria
per le Provincie Modenesi e Parmensi», 2 (1864).
rossi, g. g., Vita di Giovanni de’ Medici, in Vite dei Sforzeschi,
Milano 1853.
rossi, v., Pasquinate di Pietro Aretino e anonime per il concla-
vo e l’elezione di Adriano VI, Palermo e Torino 1891.
roth, c., The Last Florentine Republic. 1527-1530, London
1925.
rowlands, j., Rubens, Drawings and Sketches, London 1977.
ruysschaert, j., Le Sac de Rome de 1527 et la tombe de Saint
Pierre d’après deux notaires contemporains, in «Römische
Quartalschrift», 58 (1963).
salerno, l., spezzaferro, l. e tafuri, m., Via Giulia, Roma
1973.
salvioli, g., Nuovi studii sulla politica e le vicende dell’esercito
imperiale in Italia nel 1526-27 e sul Sacco di Roma, in
«Archivio Veneto», 15 (1878).
sanminiatelli, d., Domenico Beccafumi, Milano 1967.
santoro, m., Fortuna, Ragione e Prudenza nella civiltà lettera-
ria del Cinquecento, Napoli 1967.
Storia dell’arte Einaudi 340
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
saxl, f., Illustrated Pamphlets and the Reformation (1948),
ristampato in Lectures, London 1957.
scarafoni, c. scaccia, Un documento storicamente e bibliogra-
ficamente ignoto relativo al Sacco di Roma, in «La Bibliofi-
lia», 40 (1938).
scavizzi, g., La teologia cattolica e le immagini durante il xvi
secolo, in «Storia dell’Arte», 21 (1974).
schade, o., Satiren und Pasquillen aus der Reformationszeit, vol.
I, Hannover 1856.
scheidig, w., Holzschnitte des Petrarca-Meisters, Berlin 1955.
scherer, m. r., Marvels of Ancient Rome, New York 1955.
schlosser, j. von, La letteratura artistica, Firenze 1964.
schmidt, f., Die Illustration der Lutherbibel (1522-1700), Basel
1962.
schönberger, g., Narwall-Einhorn. Studien über einen selten
Werkstoff, in «Städel Jahrbuch», 9 (1935-36).
schottenloher, k., Flugblatt und Zeitung, Berlin 1922.
schramm, a., Luther und die Bibel, vol. I: Die Illustrationen der
Lutherbibel, Leipzig 1923.
schulz, h., Der Sacco di Roma. Karls V. Truppen in Rom.
1527-1528, Halle 1894.
secret, j., Les Kabbalistes chrétiens de la Renaissance, Paris 1964.
seidel menchi, s., Traduzioni italiane di Lutero, in «Rinasci-
mento», 18 (1977).
servolini, l., Ugo da Carpi, Firenze 1977.
setz, w., Lorenzo Valla Schrift gegen die Konstantinische
Schenkung: «De falso credita et ementita Constantini dona-
tione», Bibl. des deutschen historischen Instituts in Rom,
44, Tübingen 1975.
seymour, ch. jr., The Rabinowitz Collection of European Pain-
tings, New Haven 1961.
shearman, j., Raphael’s Unexecuted Projects for the Stanze, in
Walter Friedländer zum 90. Geburtstag, Berlin 1965.
– The «Dead Christ» by Rosso Fiorentino, in «Boston Museum
Bulletin», 64 (1966).
– Mannerism, Harmondsworth 1967.
Storia dell’arte Einaudi 341
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
– «Maniera» as an Aesthetic Ideal, in «Studies in Western
Art. Acts of the xxth International Congress of the History
of Art», (1961), Princeton 1963, ristampato in Renaissan-
ce Art, a cura di C. Gilbert, New York 1970.
shearman, j., The Vatican Stanze: Function and Decoration, in
«Proceedings of the British Academy», 57 (1971).
– Raphael’s Tapestries, London -1976.
– An Episode in the History ot Conservation: The Fragments of
Perinos Altarpiece from S. Maria sopra Minerva, in Scritti di sto-
ria dell’arte in onore di Ugo Procacci, vol. II, Milano 1977.
shearman, j. e white, j., Raphael’s Tapestries and Their Car-
toons, in «The Art Bulletin», 40 (1958).
silenzi, f. e r., pasquino. Quattro secoli di satira romana, Firen-
ze 1968.
smart, a., Taddeo Gaddi, Orcagna and Eclipes, in Studies in
Honour of Millard Meiss, New York 1977.
spada, f., Alcune mie congetture intorno ad una iscrizione monu-
mentale di Pietro Bembo quale essa leggesi sotto la statua di
San Paolo nella faccia posteriore del suo piedestallo al Ponte
Sant’Angelo in Roma, Roma 1886.
stabbe, w., Hundert Meisterzeichnungen, Hamburg 1967.
steinberg, l., Michelangelo’s «Last judgment» as Merciful Here-
sy, in «Art in America», 63 (1975).
steinmann, e., Die Sixtinische Kapelle, Berlin 1921.
stuhbfauth, g., Dreizeitgeschichtliche Flugblättern des Hans
Sachs Mit Handschriften des Georg Pencz, in «Zeitschrift für
Bücherfreunde», 10 (1918-19).
terlinden, c., Un panorama de Rome à la fin du xvie siècle, in
«Annuaire des Musées Royaux de Belgique», 3 (1940-42).
terlinden, vte., La politique italienne de Charles-Quint et le
«triomphe» de Bologne, in Fêtes et cérémonies au temps de
Charles-Quint, a cura di J. Jacquot, Paris 1960.
tervarent, g. de, Attributs et symboles dans l’art profane:
1450-1600, Genève 1958.
Tesori d’arte sacra di Roma e del Lazio dal Medioevo all’Otto-
cento, mostra, Roma 1975.
Storia dell’arte Einaudi 342
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
thode, h., Michelangelo. Kritische Untersuchungen über seine
Werke, Berlin 1913.
thorndike l., A History of Magic and Experimental Science,
vol. V, New York 1941.
titi, f., Nuovo studio di pittura, scoltura ed architettura nelle
chiese di Roma, Roma 1721.
– Descrizione delle pitture, sculture e architetture di Roma,
Roma 1763.
toca, m., Osservazioni sul cosiddetto «Tacuino senese» di Baldas-
sarre Peruzzi, in «Annali della Scuola Normale Superiore di
Pisa, Classe di lettere e filosofia», serie III, vol. I (1971).
tolnay, ch. de, The Medici Chapel, Princeton 1948.
– Michelangelo, vol. V: The Final Period, Princeton 1960.
torrigio, f. m., Le sacre grotte vaticane, Roma 16392.
träger, j., Der reitende Papst, München e Zürich 1970.
trinkaus, c. e., Adversity’s Noblemen, the Italian Humanists on
Happiness, New York 1940.
Le triomphe du Maniérisme européen, de Michel-Ange au Greco,
mostra, Amsterdam 1955.
turner, r. a., Two Landscapes in Renaissance Rome, in «The
Art Bulletin», 43 (1961).
ulysse, r., Philibert de Châlon, Prince d’Orange (1502-1530).
Lettres et documents, in «Boletin de la Real Academia de la
Historia», 39 (1901).
valentini, r., Erasmo da Rotterdam e Pietro Corsi, in «Rendi-
conti Accademia dei Lincei», serie VI, vol. 12 (1936).
vallese, g., L’Umanesimo al primo Cinquecento: Da Cristofo-
ro Longolio al «Ciceronianus» di Erasmo, in Da Dante a Era-
smo. Studi di letteratura umanistica, Napoli 1962.
vasoli, c., Alberto III Pio da Carpi, Carpi 1978.
venturi, a., Storia dell’arte italiana, 3 voll., Milano 1938-40.
vitale, m., La questione della lingua, Palermo 1960.
waas, a., Die Bauern im Kampf um Gerechtigkeit 1300-1525,
München 1964.
waetzoldt, s., Die Kopien des 17. Jahrhunderts nach Mosaiken
und Wandmalereien in Rom, Wien 1962.
Storia dell’arte Einaudi 343
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
walz, o., Zur Kritik der Lutherlegende: Luthers Romreise, in
«Zeitschrift für Kirchengeschichte», 2 (1877-78).
warburg, a., Francesco Sassettis Letzwillige Verlägung (1907),
ristampato in Gesammelte Schriften, vol. I, Leipzig 1932.
– Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zei-
ten (1920), ristampato in Gesammelte Schriften, vol. II,
Leipzig 1932.
washer, h., Das deutsche illustrierte Flugblatt, Dresden 1953.
wasserman, j., Palazzo Spada, in «The Art Bulletin», 43
(1961).
weil, m. s., The History and Decoration of Ponte Sant’Angelo,
University Park (Pa.), 1974.
weinstein, d., Savonarola and Florence. Prophecy and Patriotism
in tHe Renaissance, Princeton 1970.
weiss, r., Andrea Fulvio antiquario romano, in «Annali Scuo-
la Normale Superiore di Pisa», A (1969).
weller, e., Die ersten deutschen Zeitungen (1505-1599), Tübin-
gen 1872.
wind, e., Bellini’s «Feast of the Gods». A Study in Venetian
Humanism, Cambridge (Mass.) 1948.
– Platonic Tyranny and the Renaissance «Fortuna», in De arti-
bus Opuscula XL. Essays in Honor ot Erwin Panofsky, New
York 1960.
wirth, k. a., Imperator pedes papae deosculatur. Ein Beitrag zur
Bildkunde des 16. Jahrhunderts, in Festschrift für H. Keller,
Darmstadt 1963.
wittkower, r., Interpretation of Visual Symbols (1955), ristam-
pato in Allegory and the Migration of Symbols, London 1977.
wright, th., Histoire de la caricature et du grotesque. Trad. fran-
cese, Paris 18752.
yates, f., Charles-Quint et l’idée d’Empire, in Fêtes et cérémo-
nies au temps de Charles-Quint, a cura di J. Jacquot, Paris
1960.
zeri, f., Pittura e Controriforma, Torino 1957.
– Due storie di San Michele di Domenico Beccafumi, in Diari
di lavoro, Bergamo 1971.
Storia dell’arte Einaudi 344
André Chastel - Il sacco di Roma. 1527
zschelletzschky, j., Die «drei gottlosen Maler» von Nürnberg.
Sebald Beham, Barthel Beham und Georg Pencz, Leipzig
1975.
zucker, m. j., Raphaël and the Beard of Pope Julius II, in «The
Art Bulletin», 59 (1977).
Storia dell’arte Einaudi 345
Potrebbero piacerti anche
- Oro Di TroiaDocumento197 pagineOro Di TroiauomonuovoNessuna valutazione finora
- Franco Venturi Utopia e Riforma Nell'illuminismoDocumento185 pagineFranco Venturi Utopia e Riforma Nell'illuminismoMartín GonzálezNessuna valutazione finora
- Galileo a Roma: Trionfo e tribolazioni di un genio molestoDa EverandGalileo a Roma: Trionfo e tribolazioni di un genio molestoNessuna valutazione finora
- Il viaggio in età moderna: Studi di Gaetano PlataniaDa EverandIl viaggio in età moderna: Studi di Gaetano PlataniaNessuna valutazione finora
- La verità sull'evoluzione e l'origine dell'uomoDa EverandLa verità sull'evoluzione e l'origine dell'uomoNessuna valutazione finora
- Attivismo, orgoglio e tradizione ambrosiana: I cattolici nelle fabbriche milanesi dal secondo dopoguerra al Concilio Vaticano IIDa EverandAttivismo, orgoglio e tradizione ambrosiana: I cattolici nelle fabbriche milanesi dal secondo dopoguerra al Concilio Vaticano IINessuna valutazione finora
- Ebraismo e antisemitismo nella società italiana: Una storia discontinuaDa EverandEbraismo e antisemitismo nella società italiana: Una storia discontinuaNessuna valutazione finora
- La diplomazia delle due sponde del Tevere: Aggiornamento Conciliare e democrazia nelle transizioni internazionali (1965-1975)Da EverandLa diplomazia delle due sponde del Tevere: Aggiornamento Conciliare e democrazia nelle transizioni internazionali (1965-1975)Nessuna valutazione finora
- Astrattismo e Dadaismo: Poetiche dell'antiliricoDa EverandAstrattismo e Dadaismo: Poetiche dell'antiliricoNessuna valutazione finora
- Il Cristianesimo dei primi secoli tra filosofia e riti mistericiDa EverandIl Cristianesimo dei primi secoli tra filosofia e riti mistericiNessuna valutazione finora
- Le Saint-Siège, les eglises et l'Europe. / La Santa Sede, le chiese e l'europa.: Études en l'honneur de Jean-Dominique Durand / Studi in onore di Jean-Dominique DurandDa EverandLe Saint-Siège, les eglises et l'Europe. / La Santa Sede, le chiese e l'europa.: Études en l'honneur de Jean-Dominique Durand / Studi in onore di Jean-Dominique DurandNessuna valutazione finora
- I Versi livornesi di Giorgio Caproni (sottotitolo Filologia d'autore e critica della varianti)Da EverandI Versi livornesi di Giorgio Caproni (sottotitolo Filologia d'autore e critica della varianti)Nessuna valutazione finora
- Cronologia di Ferrara Dalla fondazione ai giorni nostriDa EverandCronologia di Ferrara Dalla fondazione ai giorni nostriNessuna valutazione finora
- Da Paolo a Paolo: Le immagini nei primi secoli del cristianesimoDa EverandDa Paolo a Paolo: Le immagini nei primi secoli del cristianesimoNessuna valutazione finora
- Il cristianesimo vissuto: Consigli fondamentali dedicati alle animeDa EverandIl cristianesimo vissuto: Consigli fondamentali dedicati alle animeNessuna valutazione finora
- Antichità - La civiltà romana - Storia: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 12Da EverandAntichità - La civiltà romana - Storia: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 12Nessuna valutazione finora
- Viaggiando attraverso gli stati del Papa Maria Amalia Wettin da Dresda a NapoliDa EverandViaggiando attraverso gli stati del Papa Maria Amalia Wettin da Dresda a NapoliNessuna valutazione finora
- Storia della decadenza e rovina dell'Impero Romano, volume settimoDa EverandStoria della decadenza e rovina dell'Impero Romano, volume settimoNessuna valutazione finora
- Lutero e il diritto: Certezza della fede e istituzioni ecclesialiDa EverandLutero e il diritto: Certezza della fede e istituzioni ecclesialiNessuna valutazione finora
- Il Settecento - Arti visive (59): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 60Da EverandIl Settecento - Arti visive (59): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 60Nessuna valutazione finora
- Pienezza di vita: Teologia a partire dai vissuti credentiDa EverandPienezza di vita: Teologia a partire dai vissuti credentiNessuna valutazione finora
- L'ombra sinistra della scuola: Memorie frustrate di un insegnante secondario, dal ’68 ai primi ‘90Da EverandL'ombra sinistra della scuola: Memorie frustrate di un insegnante secondario, dal ’68 ai primi ‘90Nessuna valutazione finora
- La fuoriuscita del Logos modalità ed effetti nei testi patristici dei primi 4 secoliDa EverandLa fuoriuscita del Logos modalità ed effetti nei testi patristici dei primi 4 secoliNessuna valutazione finora
- Filarete e la città ideale: Politica e architettura nel primo RinascimentoDa EverandFilarete e la città ideale: Politica e architettura nel primo RinascimentoNessuna valutazione finora
- Venezia città aperta: Gli stranieri e la Serenissima XIV-XVIII sec.Da EverandVenezia città aperta: Gli stranieri e la Serenissima XIV-XVIII sec.Valutazione: 1 su 5 stelle1/5 (1)
- G. Briganti - Pietro Da Cortona o Della Pittura Barocca (1962)Documento74 pagineG. Briganti - Pietro Da Cortona o Della Pittura Barocca (1962)Romeo Durante100% (1)
- Roma negli scrittori italiani: Da Dante a PalazzeschiDa EverandRoma negli scrittori italiani: Da Dante a PalazzeschiNessuna valutazione finora
- Delle Varie Eresie: Diversarum Hereseon LiberDa EverandDelle Varie Eresie: Diversarum Hereseon LiberNessuna valutazione finora
- Tre storie italiane di fantascienza: Settembrini, Nievo, SalgariDa EverandTre storie italiane di fantascienza: Settembrini, Nievo, SalgariValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Del PoDocumento88 pagineDel PokurospNessuna valutazione finora
- Monachesimo e diaconato femminile: Il caso della diaconessa OlimpiaDa EverandMonachesimo e diaconato femminile: Il caso della diaconessa OlimpiaNessuna valutazione finora
- L'eros segreto di Dante: I passi scabrosi occultati nella Commedia di DanteDa EverandL'eros segreto di Dante: I passi scabrosi occultati nella Commedia di DanteNessuna valutazione finora
- Il santuario dei Re Italici: San Michele Maggiore di PaviaDa EverandIl santuario dei Re Italici: San Michele Maggiore di PaviaNessuna valutazione finora
- I Mozart, come erano - Volume 1: Una famiglia alla conquista dell'EuropaDa EverandI Mozart, come erano - Volume 1: Una famiglia alla conquista dell'EuropaValutazione: 3 su 5 stelle3/5 (1)
- Dal profondo: 1918: la rivoluzione vista dalla RussiaDa EverandDal profondo: 1918: la rivoluzione vista dalla RussiaNessuna valutazione finora
- Profumo Mueller, Le Opere Geometrizzate Di Luca CambiasoDocumento9 pagineProfumo Mueller, Le Opere Geometrizzate Di Luca CambiasoClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Battisti, Mantegna Come ProspetticoDocumento11 pagineBattisti, Mantegna Come ProspetticoClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Profumo Mueller, L'architettura Ficta Negli Affreschi Di Luca CambiasoDocumento26 pagineProfumo Mueller, L'architettura Ficta Negli Affreschi Di Luca CambiasoClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Venezia Venusia Nata Dalle Acque PDFDocumento39 pagineVenezia Venusia Nata Dalle Acque PDFClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Cronologia Del Colosso Di Rodi PDFDocumento12 pagineCronologia Del Colosso Di Rodi PDFClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Convegno - Lucrezia - Borgia - Bologna PDFDocumento3 pagineConvegno - Lucrezia - Borgia - Bologna PDFClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Ungaro, Traiano e La Costruzione Della Sua Immagine Nel ForoDocumento27 pagineUngaro, Traiano e La Costruzione Della Sua Immagine Nel ForoClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- La Cultura Artistica Sotto Ierone II in PDFDocumento3 pagineLa Cultura Artistica Sotto Ierone II in PDFClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Gabriele, Demogorgone PDFDocumento31 pagineGabriele, Demogorgone PDFClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Settis, Citarea 'Su Una Impresa Di Bronconi'Documento47 pagineSettis, Citarea 'Su Una Impresa Di Bronconi'Claudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Centuripe Ellenistica. Il Quadro GeneraleDocumento14 pagineCenturipe Ellenistica. Il Quadro GeneraleClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- L Autoritratto Di Andrea Mantegna Nella PDFDocumento35 pagineL Autoritratto Di Andrea Mantegna Nella PDFClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- CatelliDocumento11 pagineCatelliClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Zappi 1920Documento194 pagineZappi 1920Claudio CastellettiNessuna valutazione finora
- La Citta Delle Vigne Dei Giardini e Dell PDFDocumento63 pagineLa Citta Delle Vigne Dei Giardini e Dell PDFClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Colombo e I Mostri PDFDocumento16 pagineColombo e I Mostri PDFClaudio Castelletti100% (1)
- Il Significato Del Colore Nei Marmi in e PDFDocumento13 pagineIl Significato Del Colore Nei Marmi in e PDFClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Pensabene, Canopo - Di - Villa - Adriana. - Programmi - Temat PDFDocumento45 paginePensabene, Canopo - Di - Villa - Adriana. - Programmi - Temat PDFClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Mossakowski L Estasi Di Santa Cecilia Di Raffaello 2002Documento6 pagineMossakowski L Estasi Di Santa Cecilia Di Raffaello 2002Claudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Massinelli, Osservazioni Sul Rilievo Del Carro Di Nettuno Al Museo Del BargelloDocumento10 pagineMassinelli, Osservazioni Sul Rilievo Del Carro Di Nettuno Al Museo Del BargelloClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Gli Automata. Dal Bello All Utile e Vice PDFDocumento24 pagineGli Automata. Dal Bello All Utile e Vice PDFClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Stefano Riccioni Il Mosaico Absidale Di PDFDocumento149 pagineStefano Riccioni Il Mosaico Absidale Di PDFClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Il Bagno Di Dosso in Castel Sant Angelo PDFDocumento16 pagineIl Bagno Di Dosso in Castel Sant Angelo PDFClaudio CastellettiNessuna valutazione finora
- Horrido - Manuale Luftwaffe (Italiano)Documento14 pagineHorrido - Manuale Luftwaffe (Italiano)Floreia Sile100% (1)
- I Retroscena Occulti Della Casaleggio e Il Loro "Giullare Illuminato"Documento9 pagineI Retroscena Occulti Della Casaleggio e Il Loro "Giullare Illuminato"Domenico Bevilacqua100% (1)
- Universita Ca' Foscari Venezia - Deportate, Esuli, ProfugheDocumento356 pagineUniversita Ca' Foscari Venezia - Deportate, Esuli, ProfughegiovanniNessuna valutazione finora
- Lottomio N665 25 Aprile19 PDFDocumento23 pagineLottomio N665 25 Aprile19 PDFyuormeNessuna valutazione finora
- Castello Di Ternavasso - Poirino 2014 v00Documento1 paginaCastello Di Ternavasso - Poirino 2014 v00api-253973560Nessuna valutazione finora
- GDR Ita 2018 Fantascienza Soli Nel Buio Di Qwein 6.3Documento24 pagineGDR Ita 2018 Fantascienza Soli Nel Buio Di Qwein 6.3Michele Qwein Molinari100% (25)
- Federico II Di SveviaDocumento1 paginaFederico II Di SveviaGiulia TrozziNessuna valutazione finora
- Virgilio BaudelaireDocumento13 pagineVirgilio BaudelaireTeleCisNessuna valutazione finora
- Ildeposito - O Gorizia (Accordi - Mi)Documento1 paginaIldeposito - O Gorizia (Accordi - Mi)Raffaele PozziNessuna valutazione finora
- Schema: Filippo II, Elisabetta I D'inghilterra, Caterina de Medici, Francesco I Di Guisa, Antonio Di BorboneDocumento4 pagineSchema: Filippo II, Elisabetta I D'inghilterra, Caterina de Medici, Francesco I Di Guisa, Antonio Di BorboneDiego Deplano100% (1)
- Curzio MalaparteDocumento3 pagineCurzio MalaparteMichele George ToscaNessuna valutazione finora
- Epigrafia Greca Nell'Italia RomanaDocumento10 pagineEpigrafia Greca Nell'Italia RomanaGiuseppe DelfinoNessuna valutazione finora
- Another Day of Sun PDFDocumento5 pagineAnother Day of Sun PDFRoger YuenNessuna valutazione finora
- Clan BrujahDocumento105 pagineClan BrujahOrazio Conforti50% (2)
- Eneide 12 e Iliade 22253a Duelli FinaliDocumento12 pagineEneide 12 e Iliade 22253a Duelli FinalimicheleNessuna valutazione finora
- La Repubblica 26.08.11Documento60 pagineLa Repubblica 26.08.11NeXr0xNessuna valutazione finora