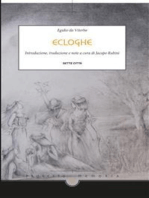Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Come Giambattista Vico Fu Il Filosofo Di Benedetto Croce
Caricato da
Sofia Mazziero0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
0 visualizzazioni6 paginerelazione corso di filosofia e appunti
Titolo originale
COME GIAMBATTISTA VICO FU IL FILOSOFO DI BENEDETTO CROCE
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentorelazione corso di filosofia e appunti
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
0 visualizzazioni6 pagineCome Giambattista Vico Fu Il Filosofo Di Benedetto Croce
Caricato da
Sofia Mazzierorelazione corso di filosofia e appunti
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 6
Mazziero Sofia L-10 m.
92587
COME GIAMBATTISTA VICO FU IL FILOSOFO
DI BENEDETTO CROCE
Era il 1922 quando Benedetto Croce nell’incipit della sua “Filosofia di Giambattista Vico” scriveva
a proposito del sommo filosofo:
“Per quali ragioni a me sia sembrata necessaria una nuova esposizione della filosofia del Vico,
potrà desumersi dai cenni sulla fortuna di questo scrittore, in quanto desideroso di attestare, per
quanto possibile, la reverenza che si deve a tal gran nome” 1
Lo stesso Croce ricordava come le sue molte “fatiche vichiane” avessero due obiettivi: il primo,
principale e sostanziale, di ravvivare il pensiero di Vico mentre il secondo era di natura filologica,
ossia il desiderio di preparare una nuova e compiuta edizione critica degli scritti del filosofo, una
ricca bibliografia ragionata ed una nuova biografia accompagnata da una compiuta illustrazione.
Non è un caso che la Collectio Viciana realizzata dal Croce costituisca la più completa ed
affascinante raccolta libraria riguardante il filosofo della “Scienza nuova”: essa comprende alcuni
esemplari dell’opera di Vico molto rari e pregiati in quanto impreziositi da dediche e correzioni
autografe dell’autore, un volume intitolato “Opere Vichiane” e la monumentale “Bibliografia
Vichiana” del 1904 allestita attraverso l’accurata ricerca di tutta la principale letteratura critica
intorno al filosofo, tra cui spiccano saggi mai dati alle stampe.
Era l’estate del 1910 quando il Croce era immerso nella stesura della sua “Filosofia di Giambattista
Vico”: un’opera con il duplice vantaggio di presentare un Vico divenuto si, chiaro e facilmente
comprensibile, ma che al tempo stesso riusciva a trasmettere al lettore la sua voce possente e
fascinosa. Grande dunque il servigio che quest’opera, tradotta in inglese ed in francese, rese al
sommo filosofo: così grande che dal 1911 in poi la Scienza Nuova, da circa mezzo secolo esclusa
dal mercato librario, vi rifaceva trionfalmente ingresso, continuamente attestato da un succedersi di
riedizioni, ristampe, commenti e traduzioni.
Benedetto Croce ebbe fortuna alterna: agli inizi del ‘900 fu particolarmente noto negli ambienti
filosofici sia in Italia che all’estero ma già a partire dagli anni ‘50 il suo pensiero inizierà a sembrare
attardato e legato al suo tempo, non all’altezza di quello di Gentile e non abbastanza radicale come
quello di Gramsci. Nonostante questo egli si profila a tutti gli effetti come il degno discendente di
Vico – lui stesso amava definirsi “patito di Vico” – al punto da acquistare la sua casa per abitarvi
una volta tornato a Napoli nel 1866. Addirittura Emilio Ciocchetti2 ricorda proprio come “nella
filosofia il Vico ed il Croce non sono due ma uno”, nonostante tra i due sia possibile riscontrare
alcune differenze stilistiche: oscurità, artificiosità, confusionismo geniale ed un tono perennemente
elevato al sublime regnano nella produzione del Vico mentre profondo ordine, mirabile chiarezza ed
uno stile il più possibile discorsivo in quelle di Benedetto Croce, maestro nel saper alleggerire
complesse trattazioni con un aneddoto.
Siamo quindi di fronte a due pensatori tanto distanti nel tempo ed appartenenti a due secoli
culturalmente e mentalmente diversi ma che presentano inaspettatamente innumerevoli
somiglianze: entrambi autodidatti ma con una infanzia difficile, entrambi con un vivo interesse per
la cultura ma costretti l’uno dal padre l’altro dallo zio Silvio Spaventa ad iscriversi alla facoltà di
giurisprudenza, entrambi con un grande amore per la città di Napoli, entrambi in grado di esercitare
la loro maggiore virtù filosofica, l’autocritica. Diversi erano però gli atteggiamenti dei due filosofi:
il Vico perennemente agitato, tormentato, a volte crudele con se stesso mentre la calma e la serenità
erano i sentimenti a cui si ispirava quella del Croce, come del resto si coglie perfettamente con la
1
B. Croce, La Filosofia di Giambattista Vico, Bari Laterza 1922 p.1
2
E. Ciocchetti, Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 20 Giugno 1911, Vol. 3.
lettura del “Contributo alla Critica di Me Stesso”, stilato in pochi giorni nell’aprile del 1915.
Riguardo la tormentata infanzia del suddetto filosofo alla quale ho precedentemente accennato,
proprio in tal opera autobiografica si comprende come una brusca interruzione ed un profondo
sconvolgimento della sua vita fu causato dal terremoto di Casamicciola del 1883 durante il quale
Croce perse a soli 17 anni entrambi i genitori e la sua unica sorella. Lui stesso, rimasto sotto le
macerie per diverse ore, riportò varie fratture e fu costretto ad un lungo periodo di convalescenza.
Una volta guarito ma oramai orfano, si recò a Roma nella casa di suo zio Silvio Spaventa, divenuto
suo nuovo tutore: un uomo autorevolissimo in politica ma molto diverso da suo padre, nonostante il
legame di parentela. Furono quindi anni di cambiamenti radicali perché la vita in quella nuova e
grande città, stravolse totalmente la piccola realtà (egli era infatti originario di Pescasseroli) nella
quale il giovane era abituato a vivere e a studiare. Quei tempi senza amici, durante i quali il giovane
Croce frequentò solamente la facoltà di giurisprudenza alla Sapienza – senza peraltro nutrire una
autentica passione – furono a detta sua “i più dolorosi e cupi”, e lo portarono più volte ad
interrogarsi ed a riflettere sul significato della sua esistenza fino ad indurlo a meditare al suicidio.
Difficile infanzia anche per il nostro Vico come ricorda egli stesso nell’autobiografia intitolata Vita
Scritta da Se Medesimo pubblicata nel 1728: dall’opera si apprende come la sua vita cambiò per
sempre quando a causa della sua vivacità “essendo col capo in giù piombato da alto fuori d'una
scala nel piano” 3, si procurò una spiacevole frattura al cranio, che lo costrinse ad una lunga
convalescenza. A seguito di ciò iniziò a sviluppare una personalità malinconica – come del resto si
coglie in alcuni tratti della sua autocritica – soprattutto perché fu costretto ad un lungo periodo di
convalescenza, interrompendo gli studi per tre anni. Nonostante i medici prospettassero che quella
frattura gli avrebbe procurato seri problemi a livello cognitivo, Vico non abbandonò mai l’idea di
costruirsi un sapere, del resto la sua “Scienza Nuova” ne è la perfetta rappresentazione. Tuttavia per
assecondare il desiderio paterno, il giovane fu in seguito “applicato agli studi legali”: frequentò per
circa due mesi le lezioni private del professor Francesco Verde e successivamente si iscrisse alla
facoltà di giurisprudenza presso l'università di Napoli, senza tuttavia seguirne i corsi, e
comunicando al padre solo in un secondo momento la sua perdita di interesse per lo studio del
diritto che considerava un puro e mero esercizio di memoria, come del resto anche lo stesso Croce.
Quest’ultimo infatti, per accontentare lo zio che voleva far di lui un diplomatico, si iscrisse alla
facoltà di giurisprudenza le cui lezioni, ricche di definizioni da imparare a memoria, mal si
confacevano alla personalità del Croce, che non a caso ebbe diversi scontri verbali con i docenti.
Un raggio di sole in quel cupo triennio romano furono soltanto le lezioni di filosofia morale tenute
dal professor Labriola, grazie alle quali il giovane Croce si appassionò a studi eruditi e filosofici,
trascurando tuttavia il pensiero hegeliano di cui criticava la forma incomprensibile. Non è un caso
che nella sua opera “Estetica come Scienza dell’Espressione e Linguistica Generale” abbia dedicato
un intero capitolo a Vico, definendolo il «primo scopritore della scienza estetica», mentre Hegel, al
quale erano lasciate poche pagine, era trattato insieme ad altri pensatori.
Il lascito vichiano, rimasto quasi completamente sconosciuto al suo secolo e rivalutato solamente
nei primi anni dell’Ottocento, viene perfettamente colto ed elaborato nella produzione crociana
ponendone in rilievo l’originalità. Analizzando anzitutto le riflessioni sull’impegno civile e sulla
dimensione della storia, ci si accorge come esse siano caratteristiche non solo della filosofia latina
rispetto alla contemplativa filosofia greca, di Dante, Botero e la sua “ragion di stato” e di
Machiavelli, ma anche di autori in cui la politica non era un elemento prioritario: Vico prima e
Croce poi ne sono l’emblematica espressione.
Secondo il fondatore della Scienza Nuova, l’uomo poteva conoscere scientificamente solo la storia
perché gli esseri umani, a differenza di Dio che aveva piena conoscenza del mondo naturale in
quanto suo creatore, erano gli artefici e quindi i protagonisti indiscussi della storia.
Il principio vichiano del “verum et factum conventuntur”, il quale attesta come la verità e la
fattualità si compenetrino a vicenda – tra l’altro già espresso all’inizio del ‘500 da Thomas Hobbes
con il suo “scire per causas” – è molto complesso ed evolve con gradualità nella produzione
3
E. Ciocchetti, Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 20 Giugno 1911, Vol. 3.
vichiana: l’uomo è dotato di un livello di produttività definito con il termine greco poiesis, il “fare”,
inteso come forma originaria di canalizzazione del flusso vitale originario ed attraverso il suo
bagaglio di conoscenze produce qualcosa in senso forte da intendere proprio come le leggi e la
storia stessa.
Al mondo della storia possiamo quindi applicare il principio del “verum ipsum factum”, formulato
già nel De Antiquissima Italorum Sapientia del 1710 come criterio di verità alternativo al cogito
cartesiano: per Vico la verità indubitabile è la consapevolezza del concreto operare degli uomini
nella storia. Alla luce di questo, è significativo a mio avviso poter definire Vico il primo grande
“filosofo della storia”, poiché sostiene come l’ordine dell’universo ed i comportamenti
dell’individuo siano condizionati dal flusso della storia stessa. Ad ogni modo, l’uomo può
comunque ricreare quello che è la storia, riattivandola attraverso la “narrazione”, la quale è una
ulteriore forma della poiesis manifestata non dai filosofi, ma dai poeti.
Proprio in difesa della storia, il Vico conduce un’aspra polemica contro gli stoici e gli epicurei in
quanto i primi tendono ad un ripudio dei sensi e delle passioni mentre i secondi fanno del senso una
regola: entrambe sono pertanto definite filosofie monastiche e della solitudine. Esse si
contrappongono alle teorizzazioni del Vico, il quale ricordava già nel primo assioma – quello
dell’antropocentrismo – come non si potesse costruire una filosofia basata su un uomo che fa di sé
regola dell’universo: la possibilità dell’autoinganno è insita nell’animo dell’uomo, il quale quando
immagina può essere illuminato o meno dalla ragione e quindi per via della sua mente tende a
distorcere la realtà, diventando ossessivo.
La storia vichiana dovrà quindi indagare le cause e rinvenire le leggi provvidenziali a cui
obbediscono gli eventi storici. Con le successive letture idealistiche ma soprattutto con la lettura
proposta dal Croce nella sua opera intitolata “Filosofia e Storiografia” emerge una differente
concezione di storia universale: una storia finalistica, naturalistica e deterministica poiché dominata
dalla casualità degli eventi, nonostante si riprenda dalle riflessioni vichiane il fatto che “lo spirito
umano non può conoscere se non ciò che egli stesso ha fatto” – ovvero il principio della
conoscibilità della storia umana – perché fatta dagli stessi uomini.
In questo il Croce è fortemente influenzato dalle teorizzazioni positivistiche ottocentesche, si ricordi
in particolare la visione di Ratzel, il quale fu il primo a comprendere l’importanza della rivoluzione
darwiniana, e la sua opera “Antropogeographie”. Secondo la teorizzazione espressa in quest’ultima,
l’uomo non può che confrontarsi con la superiorità della natura, un sistema ambientale governato da
rigide leggi e nel quale l’importanza del clima (che si associa ad un particolare sviluppo naturale)
consente di leggere la diversa organizzazione territoriale: il clima determina così le caratteristiche
della terra e più in generale quelle dell’essere vivente.
Inoltre, se Vico combatte gli stoici e gli epicurei, anche il Croce è protagonista di una battaglia
contro quelli che definiva “filosofi puri”: secondo quest’ultimo infatti la filosofia non deve essere
considerata singolarmente bensì in stretta connessione con l’arte, con la storia, con la politica in
quanto la storia implica sempre una dimensione filosofica e la storia è anche pensiero. Si veda in
proposito l’opera crociana “La Storia come Pensiero e Azione”, un affresco storico ma anche una
storia dello spirito – laddove con spirito si intende una storia del mondo – mossa da una dimensione
profonda che ha anche uno spessore spirituale in quanto ricca di sentimenti e passioni.
Il secondo motivo della presenza nella riflessione crociana di Vico, è rappresentato dal fatto che egli
fu il primo filosofo ad aver pensato l’autonomia dell’arte (la poiesis, appunto) intesa quale punto di
partenza della storia e della conoscenza storica. Croce adopera nelle sue riflessioni il termine
generico di “arte” quale sinonimo di “facoltà estetica” in quanto secondo lui tutte le arti hanno la
medesima natura poiché prodotti dell’intuizione e viene articolando la propria tesi fondamentale
richiamandosi proprio alla figura di Giambattista Vico, che per primo avrebbe avuto il merito di
proporre nel II libro della “Scienza Nuova” – completamente dedicato alla Sapientia Poetica – una
“Logica poetica” in grado di concepire la poesia, avente come principio la fantasia, una forma
di conoscenza autonoma ed individuale rispetto alla filosofia.
Vico, secondo do un modello secolarizzante, divide la storia in tre differenti: degli dei, degli eroi e
degli uomini. I protagonisti della prima – che si profila come un’età contrassegnata dal prevalere dei
sensi e dalla mancanza di riflessione – sono i cosiddetti “bestioni insensati” i quali affidandosi
esclusivamente agli stimoli dell’istinto felino, ai sensi ed alla fantasia atterrita dallo spavento
iniziale, interpretano il mondo come un gigantesco organismo di forze incommensurabili.
Alla luce di questo, possiamo affermare come l’analisi e la valorizzazione di questa dimensione
fantastico-istintiva strettamente connessa alla ripresa del principio del verum-factum costituiscono i
due aspetti fondamentali della interpretazione crociana di Vico.
Croce come Vico ribadisce l’importanza dell’autonomia dell’arte, definendola una categoria
spirituale autonoma appartenente alla sfera della conoscenza: l’intuizione artistica è la prima forma
di conoscenza dello spirito, slegata dalla logica e dalla pratica.
Il mondo dell’arte è pertanto costituito da intuizioni, le quali non sarebbero altro che delle presenze
nei nostri sensi di un contenuto precedente a qualsiasi organizzazione concettuale e da immagini
pure, svincolate da riferimenti intellettuali e morali in quanto l’arte, a differenza della filosofia, non
distingue il reale dall’irreale, è fantasia. Pertanto “a tal contenuto tal forma”: nella sintesi artistica
intuizione e espressione si identificano. Croce giungeva quindi a interrogarsi sul problema della
personalità dell’opera d’arte, la quale è espressione dello stato d’animo del suo autore e di
conseguenza è qualcosa di conoscibile ma allo stesso tempo singolare.
Da questa deduzione fortemente influenzata dalle teorizzazioni vichiane discende la celeberrima
definizione del carattere «lirico» dell’arte (l’«intuizione lirica») laddove con liricità si intende la
qualità propria, e dunque l’unicità di ogni manifestazione artistica, che è sempre – anche nelle
forme ritenute più impersonali, quali l’epica, tragedia, romanzo – espressione di un mondo
personale di sentimenti, voce di un’anima. Solo successivamente nel saggio “Il carattere di totalità
dell’espressione artistica” del 1918 Croce arricchì la propria estetica con un concetto nuovo, quello
del carattere cosmico o universale dell’arte, laddove il concetto di intuizione lirica non viene
sostituito, bensì integrato da quello di intuizione cosmica.
Il critico infatti nel periodo 1917-1920 si occupò dei più grandi poeti della letteratura occidentale,
quali Ariosto, Goethe, Shakespeare, Corneille e Dante. Il saggio su Dante, sulla cui figura si
interroga anche lo stesso Vico, è molto significativo a questo proposito: il Croce esprimendo un
giudizio sulla Divina Commedia destinato a suscitare notevoli discussioni, individua da una parte la
struttura, ossia il romanzo teologico e dunque una concezione intellettualistica che non ha nulla di
poetico, ricco di costruzioni immaginative di scarsissima importanza e dall’altra l’autentica poesia
dantesca, che va analizzata in singoli episodi e passi che costituiscono delle “liriche in sé”.
Per darne una immagine visiva, secondo Croce il poema si potrebbe raffigurare come una fabbrica
robusta e massiccia sulla quale si estende una rigogliosa vegetazione con rami e fiori che la
rivestono in modo che solamente qua e là si possano notare le mura o gli spigoli.
Anche Vico ha svolto nel corso degli anni delle riflessioni molto originali su Dante Alighieri, poeta
che definisce “Omero Toscano” in quanto almeno in un primo momento gli pareva rappresentare un
modello di creazione poetica e di linguaggio perfettamente corrispondente a quello omerico, per
giungere poi invece a separare con forza due figure e due ruoli storici distinti: Omero, figura mitica
e non individuale e Dante, individualità potente, artefice primo della lingua ed iniziatore di una
teoria linguistica nel suo “De Vulgari Eloquentia”. Infatti secondo Vico è impossibile che uno sia
allo stesso tempo “poeta e metafisico sublime", dato che la poesia guarda al concreto ed al
particolare, mentre la metafisica all'astratto.
Per Vico, Omero – interamente protagonista del III libro della Scienza Nuova – è poeta, non
filosofo e quindi il simbolo della sapienza poetica in quanto i poemi omerici furono l'espressione
immediata di un mondo abitato da uomini dai rozzi costumi e che per la debolezza delle loro menti
erano quasi fanciulli: non a caso, scrive il filosofo, “ l’Odissea è ricca di favole per intrattenere i
fanciulli". Proseguendo nell’analisi della visione della storia vichiana precedentemente accennata, si
può notare come nell’età degli eroi dominata indiscutibilmente dalla fantasia, nacquero il
linguaggio, inteso come espressione spontanea e naturale dell’uomo e della sua esigenza di
comunicare, la poesia, ossia manifestazione dello spavento iniziale e di un uomo che avverte con
animo perturbato, il mito e le favole. Vico, dopo aver accuratamente analizzato discusso tutta una
serie di prove filologiche e filosofiche rispettivamente nei capitoli V e VI del medesimo libro,
sostiene che Omero non debba essere considerato come singolo ma come espressione e
personificazione della creatività popolare dei greci dell'età arcaica. Egli è emblematica
rappresentazione della poesia dell’età eroica della Grecia, cioè di quel tempo in cui l’umanità,
osservando il mondo con stupore e meraviglia, non riesce ancora a rappresentarlo con i concetti –
perché non possiede ancora sviluppata la ragione – ma solamente attraverso un linguaggio misto, in
parte visivo ed in parte verbale e sotto la spinta della fantasia, se lo raffigura con immagini
suggestive, cariche di sentimento e di passione. Il fatto che la tradizione attesti che Omero abbia
composto da giovane l'Iliade e da vecchio l'Odissea sono testimonianza rispettivamente dei costumi
della Grecia giovane e della Grecia matura: basti pensare alle differenze che si notano mettendo a
confronto la lite tra Achille e Agamennone, laddove gli eroi non rivelano alcun equilibrio interiore
ma piuttosto fervore di passioni e di violenze, crudezza di animo, ostinatezza di carattere con la
prudenza e l'astuzia di Ulisse, personificazione di una Grecia che “aveva alquanto raffreddato gli
animi con la riflessione”.
Omero fu così il primo storico della gentilità, in quanto i suoi due poemi debbono essere considerati
tesori dei costumi della Grecia antica e paragonabili per importanza alle leggi delle XII Tavole per
la storia di Roma. Ineguagliabile ed irraggiungibile, egli fu l'ordinatore della civiltà greca, padre di
tutti i poeti e fonte delle filosofie greche, meritando anche il primato dell'inimitabilità assegnatogli
da Aristotele, Orazio e i maestri dell'arte poetica proprio per le proprietà dell'età eroica che sono
espresse nei suoi poemi.
Ebbene, possiamo facilmente intuire che proprio la lettura della Scienza Nuova è alla base del
concetto di intuizione cosmica crociano, laddove “il singolo palpita della vita del tutto, e il tutto è
nella vita del singolo”: ne deriva pertanto come in ogni poesia siano per racchiusi tutti gli umani
destini, tutte le speranze, i desideri, le illusioni, le gioie, le grandezze e le miserie umane.
Tuttavia, se Vico individua l’universalità solo in Omero, Croce riesce a cogliere il concetto di
cosmicità in più autori in un certo periodo della sua attività critica: se l’intuizione lirica era qualcosa
di riscontrabile in qualsiasi autore si era fatto portatore di una propria visione del mondo, la
cosmicità era qualcosa di molto singolare, riscontrabile unicamente all’interno dei grandi capolavori
della letteratura universale.
Pertanto il principio della cosmicità qualora rigorosamente applicato, produrrebbe una selezione
estremamente severa dei valori poetici e dei poeti, nel vero senso della parola.
In un primo momento Croce, proprio basandosi sulla «cosmicità» produce una netta separazione tra
poesia e non-poesia: in questo quadro quindi solo i più grandi capolavori hanno diritto di rientrare
nella categoria della poesia intesa nella sua pienezza più totale, la quale è in grado di suscitare
nell’uomo ricordi, esperienze, pensieri, e sentimenti mentre tutte le altre manifestazioni letterarie
vengono a ricadere nella grande categoria della non-poesia. Infatti il criterio di giudizio
imprescindibile per Croce è la distinzione tra intuizione vera e intuizione falsa, l’immagine
elaborata a fini organici (i soli validi sotto il profilo estetico) e l’altra combinata per fini meccanici.
Invece Vico nel 37° assioma definisce la poesia come quella facoltà che “deve dare senso e
passione alle cose insensate", ossia è quello che fanno i fanciulli quando giocando, si rivolgono agli
oggetti inanimati come fossero vivi. Lo stesso fecero gli uomini del mondo fanciullo, "sublimi poeti
per natura". Pertanto, mito e poesia nascono entrambi dalla fantasia e costituiscono le prime forme
spontanee di comunicazione e conoscenza della realtà che si esprimono prevalentemente attraverso
la gestualità e la corporeità e solo in misura minore con un linguaggio povero di parole.
Invece per Croce la bipartizione tra poesia e non poesia è molto più complessa: dapprima il concetto
di non-poesia viene ad avere una valenza fortemente negativa, in quanto accomuna sotto la
definizione della non arte una serie di opere letterarie anche meritevoli, ma che comunque non
raggiungono il livello della cosmicità. In seguito però Croce avvertì la necessità di rivedere questo
schema troppo netto e meccanico e rendere quindi la valutazione artistica più flessibile e sfumata,
più adeguata alla complessità e alla varietà delle espressioni artistiche. Un primo passo verso il
superamento di tale rigidità lo troviamo nel volume “Poesia Popolare e Poesia d’Arte”, una raccolta
di saggi del 1933 in cui il Croce mette in crisi l’idea romantica – che deriverebbe proprio da Vico –
secondo la quale la poesia popolare era un’espressione collettiva di sentimenti e idee corali,
passionale, spontanea e irriflessa. Secondo Croce infatti la poesia popolare, anche se anonima e
attestata in diverse forme e luoghi con il medesimo tema, avrebbe sempre alla base l’espressione e
l’ideazione di un singolo che si era fatto carico di esprimere la propria singolarità, poi condivisa
dalla collettività. Pertanto l’unica distinzione logica istituitile tra poesia popolare e poesia d’arte
sarebbe da ricercare nella minor complessità della poesia popolare, la quale non sarebbe altro che
una poesia semplice espressa da un singolo che non ha dietro di sé un sentimento di particolare
pregnanza, quindi viene espresso in forme piuttosto semplici.
Nel volume però Croce, insieme alla sostanziale stroncatura della poesia popolare, presenta una
serie di saggi dedicati alla poesia sia latina che italiana del Rinascimento, della quale esalta la
capacità formale, il grande esercizio stilistico e tecnico portato avanti anche grazie all’imitazione
attenta dei modelli antichi. La maggior parte degli autori minori del Rinascimento non raggiungono
un elevato livello di poesia e Croce ne sottolinea la capacità formale grazie all’imitazione dei poeti
del passato.
La sintesi di tali teorizzazioni, nonché l’espressione più matura dell’estetica e della metodologia
critica crociana è rappresentata dal volume “La Poesia” del 1936. Quell’anno è particolarmente
difficile per il filosofo, in quanto è perseguitato dai fascisti che lo hanno sottoposto a libertà vigilata
ed i suoi amici sono stati costretti ad allontanarsi da lui non avendo la possibilità di frequentarlo
liberamente: Croce è preoccupato della situazione politica e personale e un modo per reagire ai suoi
turbamenti è chiudersi in sé stesso riflettendo sulla poesia. Nel suddetto volume, Croce non si
sofferma su nessuna poesia in particolare a livello nazionale, ma investe nella sua riflessione tutta la
poesia mondiale che aveva avuto modo di leggere. Egli inserisce una terza categoria, quella della
letteratura, che integra al suo interno alcune caratteristiche della poesia nella più ampia accezione:
la letteratura viene definita come una delle parti della “civiltà e dell’educazione simile alla cortesia
e al galateo”. La letteratura è intrinseca all’uomo e alla sua società e non ambisce ad arrivare a un
livello di cosmicità, ma allo stesso tempo ha una funzione ben determinata nella società e va ben
studiata e apprezzata. La poesia è un qualcosa di materno, spontaneo, opera di verità e colloquio
con Dio, mentre la letteratura è un’opera di civiltà, costruita ed artificiosa ma non per questo
dispregevole o negabile a livello di studi.
Pertanto, attraverso l’analisi fin qui condotta e soprattutto prendendo in considerazione quest’ultimo
aspetto relativo alla poesia, ci si accorge perfettamente come entrambi i pensatori non smettano mai,
nel corso della loro produzione, di interrogarsi sulla varietà e molteplicità della storia e della
produzione artistica. Non escludendo a priori alcuna interpretazione né riflessione, essi dimostrano
come una mente aperta e curiosa non debba in alcun modo temere il dubbio ma anzi accoglierlo
come stimolo per ulteriori e più profonde riflessioni. E’ singolare notare come, pur partendo da
presupposti diversi e soprattutto pur appartenendo a due secoli diversi, Croce e Vico abbiano in
comune una straordinaria affinità intellettiva, accompagnata da una capacità di andare al di là di
schemi prestabiliti ed universalistici: entrambi sono sempre pronti a cogliere ogni opportunità,
imparando, creando e partecipando attivamente alla storia più che adeguandosi ad essa.
Potrebbero piacerti anche
- Pico Della Mirandola - Conte Di ConcordiaDocumento86 paginePico Della Mirandola - Conte Di Concordiajoeslegar100% (1)
- PACCHI, Arrigo. Introduzione A HobbesDocumento196 paginePACCHI, Arrigo. Introduzione A HobbesRafael Curcio100% (1)
- Federico Chabod - Storia Dell'Idea D'europaDocumento147 pagineFederico Chabod - Storia Dell'Idea D'europaGennaro ScalaNessuna valutazione finora
- Benedetto Croce e La 'Sua' NapoliDocumento94 pagineBenedetto Croce e La 'Sua' Napolidavis2aNessuna valutazione finora
- SolovievDocumento10 pagineSolovievLicia ScarciofaloNessuna valutazione finora
- Wilson, N.G. - Filologi Bizantini (Scan)Documento402 pagineWilson, N.G. - Filologi Bizantini (Scan)Blanca Español50% (2)
- Barzanti - Fausto Sozzini e La Filosofia in Europa (2005)Documento80 pagineBarzanti - Fausto Sozzini e La Filosofia in Europa (2005)universallibraryNessuna valutazione finora
- Appunti Su Due Recenti Volumi Dedicati A Angelo ColocciDocumento32 pagineAppunti Su Due Recenti Volumi Dedicati A Angelo ColocciGerardo LarghiNessuna valutazione finora
- Lodovico Antonio Muratori - Annali D'italia Dal Principio Dell'Era Volgare Sino All'Anno 1750 - 01Documento1.380 pagineLodovico Antonio Muratori - Annali D'italia Dal Principio Dell'Era Volgare Sino All'Anno 1750 - 01Pietro GiocoliNessuna valutazione finora
- Estetica CroceDocumento26 pagineEstetica CrocePaolo EmilioNessuna valutazione finora
- Massimiliano Capati BENEDETTO CROCE E LE METAMORFOSI DEL BAROCCODocumento21 pagineMassimiliano Capati BENEDETTO CROCE E LE METAMORFOSI DEL BAROCCOAndrea PinottiNessuna valutazione finora
- Giordano BrunoDocumento21 pagineGiordano BrunoStefano CiettoNessuna valutazione finora
- Il BaroccoDocumento7 pagineIl Baroccocarmen d’agostinoNessuna valutazione finora
- Massoneria Delle Antiche PietreDocumento7 pagineMassoneria Delle Antiche PietreVincenzo RizzutoNessuna valutazione finora
- Giuseppe PariniDocumento15 pagineGiuseppe Pariniigor7miali7Nessuna valutazione finora
- Lacriticadantesc 00 ZambuoftDocumento124 pagineLacriticadantesc 00 ZambuoftAngelo Di VittoriNessuna valutazione finora
- Annali d'Italia dal principio dell'era volgare sino all'anno 1750 - volume primoDa EverandAnnali d'Italia dal principio dell'era volgare sino all'anno 1750 - volume primoNessuna valutazione finora
- 65 - George BerkeleyDocumento40 pagine65 - George BerkeleyGeorge OcneanuNessuna valutazione finora
- L Ebreo Di Verona CommentoDocumento10 pagineL Ebreo Di Verona CommentoGianandrea de AntonellisNessuna valutazione finora
- 13339-Texto Del Artículo-47101-1-10-20151016Documento9 pagine13339-Texto Del Artículo-47101-1-10-20151016Roberta VinerbaNessuna valutazione finora
- Muratori Annali D Italia 1Documento1.294 pagineMuratori Annali D Italia 1Marco SimoniNessuna valutazione finora
- Alberti, Leone Battista 1843 Opere Volgari, t.1 (Ocr)Documento486 pagineAlberti, Leone Battista 1843 Opere Volgari, t.1 (Ocr)Mitchell JohnsonNessuna valutazione finora
- Il Poeta Eretico: Jacopo Bonfadio libri Asino RossoDa EverandIl Poeta Eretico: Jacopo Bonfadio libri Asino RossoNessuna valutazione finora
- BRUNO, Giordano in Dizionario Biografico - TreccaniDocumento22 pagineBRUNO, Giordano in Dizionario Biografico - Treccanividalin76Nessuna valutazione finora
- Croce - Conversazioni Sulla Filosofia Del JacobiDocumento22 pagineCroce - Conversazioni Sulla Filosofia Del Jacobiguglielmo531Nessuna valutazione finora
- Saggio sopra la necessità di scrivere nella propria linguaDa EverandSaggio sopra la necessità di scrivere nella propria linguaNessuna valutazione finora
- Lelio Basso - Carlo Pisacane Nel Risorgimento Italiano-1932Documento6 pagineLelio Basso - Carlo Pisacane Nel Risorgimento Italiano-1932Massimo CardelliniNessuna valutazione finora
- Tesi A. MelchionnaDocumento292 pagineTesi A. MelchionnabrysonruNessuna valutazione finora
- Benedetto Croce. Teoria Della Laicità "Trascendentale" e Primato Del Pensiero CriticoDocumento11 pagineBenedetto Croce. Teoria Della Laicità "Trascendentale" e Primato Del Pensiero CriticoambientiNessuna valutazione finora
- La Letteratura CineseDocumento46 pagineLa Letteratura CineseCAROLINA MESANessuna valutazione finora
- Filippo Bartolone / Cristianesimo e Filosofia in F.B.Documento4 pagineFilippo Bartolone / Cristianesimo e Filosofia in F.B.Enzo CiceroNessuna valutazione finora
- Concetto Marchesi Fedro E La Favola Latina (Vallecchi)Documento126 pagineConcetto Marchesi Fedro E La Favola Latina (Vallecchi)Francesca DemontisNessuna valutazione finora
- Letteratura 16 PDFDocumento3 pagineLetteratura 16 PDFLuiza ZeferinoNessuna valutazione finora
- Il Dante Di Ozanam e Altri Saggi (Mario Scotti)Documento165 pagineIl Dante Di Ozanam e Altri Saggi (Mario Scotti)Sérgio RenatoNessuna valutazione finora
- Un ebreo nuovo: Alle origini del sionismo (1881-1920)Da EverandUn ebreo nuovo: Alle origini del sionismo (1881-1920)Nessuna valutazione finora
- La Bibbia Nei Primi Trovatori - Silvia Cocco - PHD ThesisDocumento197 pagineLa Bibbia Nei Primi Trovatori - Silvia Cocco - PHD ThesisjoaocadenhoNessuna valutazione finora
- La Civiltà Del Rinascimento in ItaliaDocumento5 pagineLa Civiltà Del Rinascimento in ItaliaCarlo PallardNessuna valutazione finora
- BoccaccioDocumento7 pagineBoccaccioCristian ChirNessuna valutazione finora
- Il Libro Dei Prodigi Di Giulio OssequenteDocumento16 pagineIl Libro Dei Prodigi Di Giulio OssequentevaleNessuna valutazione finora
- Arte RinascimentoDocumento30 pagineArte RinascimentoAltanzulNessuna valutazione finora
- NinusDocumento13 pagineNinusStavros GirgenisNessuna valutazione finora
- Girolamo VitelliDocumento3 pagineGirolamo VitelliBlumenbachNessuna valutazione finora
- La Letteratura Delle OriginiDocumento28 pagineLa Letteratura Delle OriginigaetanoditriaNessuna valutazione finora
- PetrarcaDocumento13 paginePetrarcaAlberto ViglioneNessuna valutazione finora
- La letteratura italiana nel secolo XIX. Volume secondo. La scuola liberale e la scuola democratica.Da EverandLa letteratura italiana nel secolo XIX. Volume secondo. La scuola liberale e la scuola democratica.Nessuna valutazione finora
- Seneca, l'armonia dell'universo e il teatro della vita: Nuova SecondariaDa EverandSeneca, l'armonia dell'universo e il teatro della vita: Nuova SecondariaNessuna valutazione finora
- Caputo GiuseppeDocumento2 pagineCaputo Giusepperinco16Nessuna valutazione finora
- Tesi - Verita e Conoscenza Nel Pensiero Di Nicolo CusanoDocumento244 pagineTesi - Verita e Conoscenza Nel Pensiero Di Nicolo Cusanojoeslegar100% (1)
- Imparare a sparare: Vita di Vladimir Ze'ev JabotinskyDa EverandImparare a sparare: Vita di Vladimir Ze'ev JabotinskyNessuna valutazione finora
- 2011 - Gonfiantini, Il Mito Oltre Le ParoleDocumento9 pagine2011 - Gonfiantini, Il Mito Oltre Le ParoleMercedesNessuna valutazione finora