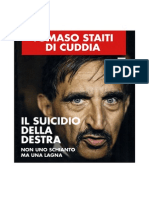Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
L'Italia Della Prima Repubblica e La Ricostruzione Economica
L'Italia Della Prima Repubblica e La Ricostruzione Economica
Caricato da
Ilaria De SanctisCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
L'Italia Della Prima Repubblica e La Ricostruzione Economica
L'Italia Della Prima Repubblica e La Ricostruzione Economica
Caricato da
Ilaria De SanctisCopyright:
Formati disponibili
L'ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA: LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA
Il problema principale del dopoguerra fu quella della ricostruzione e della ripresa
economica. Le maggiori città come Torino, Bologna erano state pesantemente
bombardate e rase al suolo. Le ferrovie riscossero molti danni. I porti erano ridotti a un
cumulo di macerie e la rete stradale erano impraticabile. A sua volta l'agricoltura
mancava di macchine e di opere di irrigazione, ma soprattutto risentiva dei massicci
sequestri di prodotti e bestiame da parte dei tedeschi. Un aiuto concreto per fronteggiara
la situazione venne dagli Stati Uniti, interessati a una rapida ripresa economica
dell'Europa occidentale, anche per la paura che le dure condizioni che doveva subire
potessero favorire un'espansione dei moviementi di ispirazione comunista. A partire dal
1948 iniziarono anche gli interventi consistenti e organici del piano Marshall, che
ammontarono circa a 1500 milioni di dollari in cinque anni. Tali aiuti consentirono di
risanare la bilancia dei pagamenti e accellerarono la ricostruzione e la ripresa industriale.
Fra il 1948 e il 1953 si avviò così il primo rilevante sviluppo industriale del Paese.
La riforma agraria e l'occupazione delle terre: In un paese ancora prevalentemente
agricolo, una delle maggiori emergenze era la riforma agraria. Il quinto governo De
Gasperi cercò di combattere il latifondo improduttivo, cioè i terreni lasciati incolti dai
grandi proprietari, e diminuire la disoccupazione agrigola creando un vasto ceto medio
agrario. Il governo propose così grandi espropri, ma tale iniziativa fu ostacolata dalla
forze conservatrici in parlamento. Ecco perchè tra la fine del 1949 e 1050 i contandini
senza terra, della Calabria e della Puglia, occuparono ampi tratti di terreno incolti o solo
in parte coltivato, costringendo il governo a intervenire. Così nel 1950 furono approvati
alcuni punti della riforma, che riguardavano solamente alcune zone del delta padano, la
Maremma toscana e varie aree dell'Italia meridionale. Un deciso impegno caratterizzò gli
anni del centrismo con l'istituzione della Cassa del mezzogiorno (1950).
Un elemento imporante per la modernizzazione economica del Paese fu il diretto
intervento dello stato. Imprese pubbliche furono istituite soprattutto nel settore
siderurgico, dell'energica elettrica, dei trasporti e delle comunicazioni. Il governo si
impegnò anche nella costruzione e riorganizzazione di diversi enti, tra i quali l'Istituto
per la ricostruzione industriale (Iri), creato nel 1933, che venne ristrutturato su basi
più moderne al fine di potenziare l'industria. In campo petrolifero ed energetico nel 1953
fu fondato l'Ente nazionale idrocarburi (Eni), che iniziò l'estrazione di metano, fonte
strategica per lo sviluppo dell'industria petrolchimica. Per il rilancio dell'edilizia
popolare fu costituito un altro ente, l'Ina-Casa. Il "piano fanfani", se da una parte dette
impulso all'attività edilizia e creò nuova occupazione, non fu però privo di effetti negativi
in quanto esso dette vita, nelle periferie urbane, a enormi ghetti-dormitori privi di servizi
necessari.
L'epoca del centro-sinistra e il miracolo economico: Dal 1947, da quando le
sinistre erano state espulse dall'area governativa, il sistema politico sembrava bloccato:
non c'erano alternative reali ai governi diretti dalla Dc. La Terza legislatura (1958-
1963) si aprì dopo le elezioni del 1958, con la Dc che rimaneva il partito di maggioranza.
Però piano piano emergeva il partito di centro-sinistra in conseguenza dei profondi
mutamenti intervenuti nell'ambito della società italiana. Finiti i tempi duri del dopoguerra,
l'Italia stava vedendo una ripresa economica. Di conseguenza la società cominciava ad
aprirsi al desiderio di una sempre maggiore crescita economica. Di ciò si prese l'incarico il
settore della Dc, la cui amministrazione era stata affidata prima ad Amintore Fanfani
(1954-1959), poi ad Aldo Moro (1959-1964). Nella Dc si stava affermando una linea
politica che, attraverso l'apertura di un dialogo con il Partito socialista, puntava a
formare una nuova maggioranza parlamentare, i cui liberali sarebbero stati sostituiti dai
socialisti. Ciò avveniva mentre nel partito comunista italiano, Palmiro Togliatti iniziava
a ronoscoscere come negativi molti aspetti dell'autoritarismo sovietico e teorizzava una
"via italiana al socialismo": una via che non fosse costruita su un modello sovietico, ma
adattata sulle condizioni economiche, storiche e culturali del Paese. Tuttavia, dopo la
repressione della rivoluzione ungherese del 1956 il Pci scelse di schierarsi a sostegno
dell'Unione Sovietica.
il difficile cammino verso il centro-sinistra:
Ottobre 1959: La Democrazia cristiana, nel suo congresso di Firenze, approva
una linea rinnovatrice: il partito non accetterò più appoggi dalle forze di destra nella
formazione dei nuovi governi.
Marzo 1960: Cade il governo moderato di Antonio Segni. Viene incaricato di
formare un governo di transizione Ferdinando Tambroni, che si mostra disposto ad
accettare i voti dei neofascisti riuniti nel Movimento sociale italiano.
Marzo-maggio 1960: Nel paese si diffonde una protesta estremamente decisa
contro il governo, con scioperi e manifestazioni di piazza. Tambroni e la parte della Dc
che lo sostiene rispondono autorizzando le forze di polizia a condurre una pesante
repressione.
Giugno-luglio 1960: Il governo autorizza il Msi a tenere il proprio congresso a
Genova, città nella quale sono ancora particolarmente cici i ricordi della Resistenza.
Il primo governo di centro-sinistra (1962-1963) realizzò alcune importanti riforme, tra cui
la nazionalizzazione dell'energia elettrica (con la nascita dell'Enel) e l'istituzione della
scuola media dell'obbligo. Durante i governi di centro-sinistra si registrò un
notevole sviluppo ecnomico che determinò anche in Italia la nascita di una società di
massa, caratterizzata dall'aumento dei consumi. Non mancarono però aspetti negativi
dello sviluppo, quali lo spopolamento delle campagne, che provocò una crisi agricola e
pesanti importazioni alimentari dall'estero; l'emigrazione della manodopera dal Sud
verso il Nord, la speculazione edilizia, il degrado urbano e la disomogeneità di sviluppo
del paese.
Verso la fine del 1967 espole, la contestazione studentesca. Manidestazioni spontanee
si diffusero nelle scuole e nelle università; si formarono gruppi extraparlamentari detti
dell "nuova sinistra", i quali rifiutarono il riformismo del Pci in nome di una soluzione
rivoluzionaria. Nel 1968 si aprì una lunga fase di lotte operaie e sindacali ("autunno
caldo"), con lunghi scioperi dei lavoratori che chiedevano miglioramenti salariali e
contrattuali. La forte domanda di rinnovamento si manifestò nelle elezioni politiche del
1968, che sengarono l'avanzamento del Pci e la crisi del centro-sinistra.
Nello stesso periodo iniziò l'offensiva terroristica, che si proponeva di usare la violenza
come arma politica. Sotto la pressione del terrorismo e di una crisi economica, il
centro-sinistra entrò definitivamente in crisi. Per far fronte a questa difficile fase Enrico
Berlinguer, segretario del partito comunista, propose la via del "compromesso
storico", basato su un'alleanza di governo tra Dc e Pci. Questa svolta portò alla
costituzione di un governo con l'appoggio esterno dei comunisti. Il nuovo governo
dovette affrontare la tragica situazione del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro da
parte delle Brigate Rosse (marzo-maggio 1978). Dopo il 1978 nella Dc prevalse una
linea contraria alla prosecuzione dell'intesa con il Pci e propensa invece a un dialogo con i
socialisti (Psi e Psdi). Da questo orientamento ebbe inizio l'età del governo
"pentapartito". Il Psi divenne l'ago della bilancia della politica italiana, grazie anche
all'azione del suo segretario Bettino Craxi, che proponeva l'immagine di un Psi
riformista e filoccidentale. In questi anni si aggravò il problema della spesa pubblica e si
intravidero i germi di una crisi che avrebbe portato di li a poco al crollo del sistema
politico. Tale sistema entrò in crisi in modo irreversibile con la caduta del muro di Berlino
e la fine del comunismo nell'Europa orientale. Agli inizi del 1922 scoppiò lo scandalo di
Tangentopoli, che portò allo scoperto la crisi degenerativa del sistema politico.
Nell'aprile del 1933 un referendum modificò la legge elettorale, sostituendo il sistema
proprozionale con quello maggioritario, novità assoluta nella politica italiana. Intato,
tutti i partiti del dopoguerra si erano dissolti o traformati, mentre ne erano nati nuovi. Le
elezioni del 1994 videro contrapporsi due coalizioni: quella di centro-destra e quella di
centro-sinistra, conferendo al sistema politico italiano il carattere bipolare. L'epoca
delle Prima repubblica era finita.
Potrebbero piacerti anche
- D.D. - Movimenti Collettivi e Sistema Politico in Italia 1960-1995Documento209 pagineD.D. - Movimenti Collettivi e Sistema Politico in Italia 1960-1995IrreperibiliNessuna valutazione finora
- L'interrogatorio Di Claudio Bizzarri Al Processo Per La Strage Di BresciaDocumento55 pagineL'interrogatorio Di Claudio Bizzarri Al Processo Per La Strage Di BresciaUgo Maria TassinariNessuna valutazione finora
- Fisica, Carica e Campo ElettricoDocumento2 pagineFisica, Carica e Campo ElettricoIlaria De SanctisNessuna valutazione finora
- Filippo Tommaso MarinettiDocumento3 pagineFilippo Tommaso MarinettiIlaria De SanctisNessuna valutazione finora
- KierkegaardDocumento6 pagineKierkegaardIlaria De SanctisNessuna valutazione finora
- La Crisi Della Germania Repubblicana e Il NazismoDocumento6 pagineLa Crisi Della Germania Repubblicana e Il NazismoIlaria De SanctisNessuna valutazione finora
- La Sera FiesolanaDocumento1 paginaLa Sera FiesolanaIlaria De SanctisNessuna valutazione finora
- Assolutismo FranceseDocumento1 paginaAssolutismo FranceseIlaria De SanctisNessuna valutazione finora
- La LocandieraDocumento4 pagineLa LocandieraIlaria De SanctisNessuna valutazione finora
- L'Italia Nel Secondo DopoguerraDocumento7 pagineL'Italia Nel Secondo DopoguerraEdoardo PessinaNessuna valutazione finora
- In Italiano Taiata 2Documento470 pagineIn Italiano Taiata 2Vasila Ivan0% (1)
- Staiti - Il Suicidio Della DestraDocumento149 pagineStaiti - Il Suicidio Della DestraFiammuusNessuna valutazione finora
- 1974 e 1976 Bombe A Brescia. La Strage in Piazza Della Loggia e Il Sistema Di Informazione.Documento3 pagine1974 e 1976 Bombe A Brescia. La Strage in Piazza Della Loggia e Il Sistema Di Informazione.mirco dondiNessuna valutazione finora
- Uccisioni Da Parte Forze Dell'OrdineDocumento35 pagineUccisioni Da Parte Forze Dell'OrdineFabio Josh Fortunato0% (1)
- Biografia Di Mussolini - George RouxDocumento318 pagineBiografia Di Mussolini - George RouxMarcèlNessuna valutazione finora
- Hiostorica 51Documento200 pagineHiostorica 51fillNessuna valutazione finora
- Studio Sul Rapimento e Omicidio Moro Di Laura PicchiDocumento50 pagineStudio Sul Rapimento e Omicidio Moro Di Laura PicchiLaura PicchiNessuna valutazione finora
- Fronte Della Gioventù (MSI)Documento6 pagineFronte Della Gioventù (MSI)eckhartTolle3Nessuna valutazione finora
- L'europeismo Di Anfuso Ci Avrebbe SalvatoDocumento1 paginaL'europeismo Di Anfuso Ci Avrebbe SalvatoAlberto SamonàNessuna valutazione finora
- 1970 Divisiopne Fenomeni A ColoriDocumento76 pagine1970 Divisiopne Fenomeni A ColorialessandroNessuna valutazione finora
- F.F (A Cura Di) - La Destra RadicaleDocumento268 pagineF.F (A Cura Di) - La Destra RadicaleIrreperibiliNessuna valutazione finora
- Andrea Re The Black AutonomistsDocumento14 pagineAndrea Re The Black AutonomistsGurgulaz PiangispermaNessuna valutazione finora
- Da Rivolta Contro Il Mondo Moderno A Gli Uomini e Le RovineDocumento11 pagineDa Rivolta Contro Il Mondo Moderno A Gli Uomini e Le RovinePhilip 'Don Brewer' LynottNessuna valutazione finora
- Sfumature Rossobrune PDFDocumento51 pagineSfumature Rossobrune PDFnopenopenope2Nessuna valutazione finora
- L'anima Nera Della RepubblicaDocumento41 pagineL'anima Nera Della RepubblicaGiulia PiccirilloNessuna valutazione finora
- La Strage Di Stato - ControinchiestaDocumento113 pagineLa Strage Di Stato - ControinchiestaAccattoneNessuna valutazione finora
- Fascisti RossiDocumento22 pagineFascisti RossiandybortrexNessuna valutazione finora
- Processo Per Strage Piazza Della Loggia: Lavoro Di Laura PicchiDocumento46 pagineProcesso Per Strage Piazza Della Loggia: Lavoro Di Laura PicchiLaura PicchiNessuna valutazione finora
- Annali Del Liceo Classico Di Tivoli N 23 2010Documento161 pagineAnnali Del Liceo Classico Di Tivoli N 23 2010roberto_borgia1Nessuna valutazione finora
- Riassunto Storia Politica Della Repubblica 1943 2006 - Appunti Di Storia ContemporaneaDocumento50 pagineRiassunto Storia Politica Della Repubblica 1943 2006 - Appunti Di Storia ContemporaneaAle AleNessuna valutazione finora
- Le Stragi Impunite (Tesi)Documento109 pagineLe Stragi Impunite (Tesi)Michele Altomeni100% (1)
- Dossier CasaPound Reggio EmiliaDocumento16 pagineDossier CasaPound Reggio EmiliaLorenzo AstolfiNessuna valutazione finora
- Tracce Della Strategia Della Tensione.Documento46 pagineTracce Della Strategia Della Tensione.Marco BaroneNessuna valutazione finora
- Appunti Storia ContemporaneaDocumento4 pagineAppunti Storia ContemporaneaJulian McGowanNessuna valutazione finora
- Giuseppe Tucci - Onori - e - Nefandezze - Di - Un - Esploratore PDFDocumento86 pagineGiuseppe Tucci - Onori - e - Nefandezze - Di - Un - Esploratore PDFluma100% (1)
- Storia Segreta Della Politica Italiana - Servizi Segreti Massoneria Sisde Sismi Aisi CIA Usa Stragi LicioDocumento67 pagineStoria Segreta Della Politica Italiana - Servizi Segreti Massoneria Sisde Sismi Aisi CIA Usa Stragi Liciocarlo.scognamiglio76Nessuna valutazione finora
- Fallaci Intervista Giulio AndreottiDocumento26 pagineFallaci Intervista Giulio AndreottifabiusdictatorNessuna valutazione finora