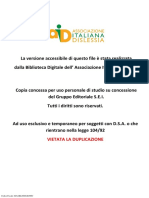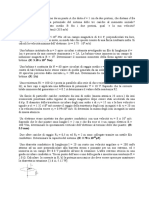Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
2K visualizzazioni11 pagineEsercizi Fisica
Il documento contiene 9 sezioni che trattano argomenti di fisica come cinematica, dinamica, fluidi, onde ed elettromagnetismo. Vengono posti una serie di quesiti e problemi da risolvere su queste tematiche spaziando su grandezze fisiche, equazioni e calcoli.
Caricato da
Luigi ReveruzziCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
2K visualizzazioni11 pagineEsercizi Fisica
Il documento contiene 9 sezioni che trattano argomenti di fisica come cinematica, dinamica, fluidi, onde ed elettromagnetismo. Vengono posti una serie di quesiti e problemi da risolvere su queste tematiche spaziando su grandezze fisiche, equazioni e calcoli.
Caricato da
Luigi ReveruzziCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd