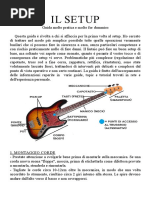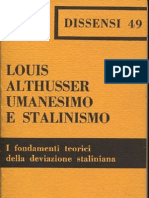Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
1K visualizzazioni8 pagineL'epoca Delle Passioni Tristi
Il documento discute della crisi della società moderna e del malessere diffuso che le persone provano. Viene analizzata la perdita di fiducia nel futuro e l'incertezza creata dai progressi tecnologici. Inoltre si discute della crisi dell'autorità e del prolungamento dell'adolescenza che ne deriva.
Caricato da
Costanza BordigaCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
1K visualizzazioni8 pagineL'epoca Delle Passioni Tristi
Il documento discute della crisi della società moderna e del malessere diffuso che le persone provano. Viene analizzata la perdita di fiducia nel futuro e l'incertezza creata dai progressi tecnologici. Inoltre si discute della crisi dell'autorità e del prolungamento dell'adolescenza che ne deriva.
Caricato da
Costanza BordigaCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd