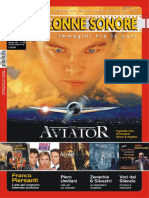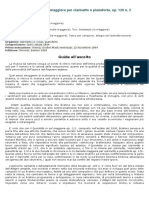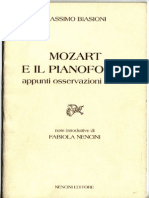Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
L'organetto
Caricato da
Angela CorniaCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
L'organetto
Caricato da
Angela CorniaCopyright:
Formati disponibili
L'ORGANETTO (FISARMONICA DIATONICA)
La fisarmonica diatonica, comunemente nota come ORGANETTO, uno strumento musicale appartenente alla famiglia degli AEROFONI (strumenti il cui suono generato da un flusso d'aria) di tipo MECCANICO (l'aria prodotta da un mantice o soffietto) e provvisto di ANCE LIBERE. L'ancia libera una sottile linguetta di acciaio, fissata ad una estremit su una piastrina di ottone o alluminio forata in modo tale da consentire all'ancia di vibrare liberamente sotto il soffio dell'aria, producendo cos il suono. Ogni ancia intonata su una nota musicale: la lunghezza e la larghezza della linguetta sono proporzionate all'altezza della nota. Pi acuta la nota, pi piccola l'ancia e viceversa. Le ance sono montate su intelaiature di legno (soniere) fissate all'interno di due cassettine, anch'esse di legno, dotate entrambe di tastiera. L'organetto caratterizzato da una tastiera melodica a bottoni, azionata dalla mano destra, estesa per 2 ottave e 1/2, nella quale le note sono ordinate per scale diatoniche (5 toni e 2 semitoni). Ad ogni bottone corrispondono due suoni differenti, secondo che il tasto sia premuto aprendo o chiudendo il mantice (sistema bitonico). Il numero dei tasti della melodia pu variare, secondo il tipo di organetto, da 12 a 33, ordinati in una, due o tre file. Lo strumento possiede una seconda tastiera pi piccola, azionata dalla mano sinistra, che comprende i bassi e gli accordi (da un minimo di 2 a un massimo di 12, ordinati in due file) necessari per l'accompagnamento ritmico. Ogni tastiera aziona una serie di valvole che consentono il passaggio dell'aria attraverso le ance e la produzione del suono. L'afflusso dell'aria alle ance assicurato da un mantice in cartone rivestito di stoffa, che collega le due casse. Tra i vari tipi di organetto, quelli pi utilizzati nella musica tradizionale italiana sono l'organetto a 2 bassi e l'organetto a 8 bassi, pur essendo diffusi anche i tipi a 4 e a 12 bassi.
ORGANETTO DIATONICO: uno strumento ad aria di tipo meccanico (laria prodotta da un mantice o soffietto) e provvisto di ance libere. Ogni ancia intonata su una nota musicale; pi unancia piccola, pi la nota acuta. Le ance sono montate su intelaiature di legno (somiere) fissate allinterno di due cassettine, anchesse di legno, dotate di tastiera. Ad ogni bottone corrispondono due suoni differenti a seconda che il tasto sia premuto aprendo o chiudendo il mantice.
BREVE STORIA DELL'ORGANETTO
Lorganetto, o meglio la fisarmonica diatonica, nasce in Austria nel 1829 ad opera di Cyrill Demian, costruttore di organi e pianoforti a Vienna. Lo strumento originario, denominato "accordion", era dotato di un mantice azionato dalla mano sinistra, di una cassettina contenente le ance libere metalliche, raggruppate in modo tale da produrre accordi completi, e di una tastiera con cinque tasti azionati dalla mano destra, ciascuno dei quali comandava una valvola per consentire il passaggio dellaria attraverso un determinato gruppo di ance. L"accordion" di Demian utilizzava ance di tipo bitonico, cio in grado di produrre determinati suoni solo aprendo il mantice e altri suoni solo chiudendolo; ad uno stesso tasto potevano cos corrispondere due suoni differenti, a seconda della direzione della corrente daria nel mantice, in analogia con larmonica a bocca, inventata pochi anni prima (1821) dal tedesco Buschmann. In tal modo lo strumento poteva produrre 10 accordi completi con soli 5 tasti. Tra il 1830 e il 1840 l "accordion" si diffonde nel Nord Europa (Francia, Germania, Svizzera) e successivamente in Russia, Cecoslovacchia, Polonia, Italia, Gran Bretagna, e Stati Uniti. In questo periodo lo strumento viene continuamente modificato, per migliorarne le potenzialit sonore. Viene ampliata la tastiera di destra (fino a 14 tasti su una sola fila, poi fino a 27 su due file) e si sostituiscono gli accordi completi con singole note per eseguire brani melodici. Viene aggiunta unapposita valvola di presa daria; si aggiunge una cassettina sul lato sinistro con ulteriori ance, e relativi tasti, per produrre sia le note di basso sia gli accordi necessari ad accompagnare le melodie realizzate con la tastiera di destra. Molte di queste innovazioni tecniche sono da attribuire, oltre che allo stesso Demian, a costruttori francesi e tedeschi che, tra laltro, estendono anche la gamma sonora dellaccordion fino a tre ottave, prima nellambito della scala diatonica e poi di quella cromatica.
Altra innovazione significativa riguarda il numero di ance (ugualmente intonate) messe in funzione da uno stesso tasto. Dal sistema di base, che prevedeva per ogni tasto una sola "voce" (ancia) a doppia azione (bitonica), si passa alle due e poi alle tre voci per tasto, intonate sulla stessa nota, anche in ottave diverse (voci bassa, normale e acuta), consentendo cos lintroduzione dei "registri" (variatori di timbro sonoro). Lancia di tipo unitonico (che produce la stessa nota, indipendentemente dal movimento del mantice) viene introdotta, da costruttori italiani, nella tastiera dei bassi/accordi attorno al 1880, dando origine ad un meccanismo basato su un complesso sistema di tiranti e valvole a effetto multiplo, che consente di aumentare il numero di tasti(e di bassi/accordi) dagli originali 2, 4 o 8, fino a 48 e oltre, mantenendo relativamente basso il numero di ance impiegate (una stessa ancia pu intervenire nella formazione di pi accordi e conseguentemente viene messa in funzione da tasti diversi). La nuova meccanica permette di dare ai bassi e agli accordi della tastiera dellaccompagnamento una progressione per quinte e di produrre accordi maggiori, minori e di settima su tutta la scala cromatica, incrementando notevolmente lo possibilit armoniche dello strumento. Nellultimo ventennio del secolo vedono cos la luce gli accordion (diatonici e cromatici) a sistema "misto": bitonico per la melodia e unitonico per laccompagnamento. In questi strumenti le file di tasti melodici vengono portate a tre e poi a quattro (fino a 37 tasti complessivi), per sfruttare al meglio laumentato numero di bassi, che cresce fino a 80. Va sottolineato che per tutta la seconda met dell800 anche gli strumenti cromatici mantengono il sistema bitonico nella tastiera melodica; solo nel 1897, ad opera dellitaliano Paolo Soprani, laccordion cromatico adotta totalmente il sistema unitonico, aprendo la strada alla moderna fisarmonica cromatica. Dai primi del 900 inizia la grandissima espansione della fisarmonica cromatica, che si diffonde in tutta Europa e nel resto del mondo, grazie alla completezza delle sue capacit melodiche e armoniche, ulteriormente migliorate grazie allintroduzione della tastiera melodica tipo pianoforte. Inizia cos il declino della fisarmonica diatonica, che vede dapprima la scomparsa degli strumenti a sistema ?misto?, poi il confinamento degli strumenti interamente diatonici nellambito della musica tradizionale. In Italia la prima fabbrica di "accordion" viene fondata nel 1863 da Paolo Soprani, a Castelfidardo in provincia di Ancona (Marche). Lo strumento, nel nostro Paese viene denominato "armonica" e successivamente "fisarmonica", ma il nome pi comunemente utilizzato quello, dialettale, di "organetto". Questo nome rester poi ad indicare lo strumento diatonico, nelluso tradizionale, fino ai nostri giorni. La costruzione di organetti si espande e ritmo vertiginoso tra il 1870 e il 1900, con la nascita di numerose fabbriche, localizzate in particolare nelle Marche (Castelfidardo, Macerata), in Lombardia (Stradella, Cremona) e in Piemonte (Vercelli, Lein). Con linvenzione della fisarmonica cromatica cresce ulteriormente il numero di costruttori, che realizzano sia fisarmoniche sia organetti. Nel 1924, un primo censimento delle fabbriche di fisarmoniche e organetti ne individua in Italia ben 93 su un totale di 232 in tutta Europa. Oggi il numero dei costruttori italiani si ridotto ad appena una trentina, di cui solo una diecina continua a produrre organetti, in particolare a Recanati e Castelfidardo e nella provincia di Teramo.
Potrebbero piacerti anche
- Organetto Superfacile Vol 1 PDFDocumento85 pagineOrganetto Superfacile Vol 1 PDFantropo200294% (18)
- L'Organetto DiatonicoDocumento100 pagineL'Organetto DiatonicoFenice Serena88% (8)
- Organetto Super Facile Vol 3Documento35 pagineOrganetto Super Facile Vol 3acidexp66Nessuna valutazione finora
- Organetto Superfacile Vol 5.zipDocumento29 pagineOrganetto Superfacile Vol 5.zipVincenzo MellaceNessuna valutazione finora
- METODO PER ORGANETTO DIATONICO + 46 BraniDocumento81 pagineMETODO PER ORGANETTO DIATONICO + 46 Branicristina cassoni25% (4)
- Spartiti Organetto N 2 PDFDocumento16 pagineSpartiti Organetto N 2 PDFPasquale Prencipe67% (3)
- 1) Organetto Superfacile Vol 1 PDFDocumento85 pagine1) Organetto Superfacile Vol 1 PDFGianluca EspositoNessuna valutazione finora
- Polca Del TrilloDocumento2 paginePolca Del TrilloGiustino Justin86% (7)
- Tarantella Dell'Etna For Flute Edited by Fabio FalsiniDocumento1 paginaTarantella Dell'Etna For Flute Edited by Fabio FalsiniFabio Falsini100% (1)
- Cat Edizioni 2020 PDFDocumento97 pagineCat Edizioni 2020 PDFsdagogyNessuna valutazione finora
- Tarantella SalterellaDocumento2 pagineTarantella SalterellaAntonio IannuzziNessuna valutazione finora
- Demo FisarmonicaDocumento3 pagineDemo FisarmonicaFRANCESCO CASELLANessuna valutazione finora
- Analisi Di Cleopatràs Di Giovanni TestoriDocumento7 pagineAnalisi Di Cleopatràs Di Giovanni TestoriRensavoNessuna valutazione finora
- Canzoniere 50° CAIDocumento36 pagineCanzoniere 50° CAImcocce100% (1)
- Il Rock N Roll Musica Cultura e SocietàDocumento4 pagineIl Rock N Roll Musica Cultura e SocietàAlessio MarrucciNessuna valutazione finora
- Stand by Me String QuintetDocumento9 pagineStand by Me String QuintetInmyWorld KwonNessuna valutazione finora
- SAX Il Manuale Delle ImboccatureDocumento6 pagineSAX Il Manuale Delle ImboccaturesertNessuna valutazione finora
- Tecnica Organettistica Vol 2Documento27 pagineTecnica Organettistica Vol 2Vincenzo MellaceNessuna valutazione finora
- Tecnica Organettistica Vol 1Documento27 pagineTecnica Organettistica Vol 1Lucio BianchiNessuna valutazione finora
- Metodo Organetto Part 6Documento1 paginaMetodo Organetto Part 6CarloNessuna valutazione finora
- Brani Di Fisarmonica ClassiciDocumento5 pagineBrani Di Fisarmonica ClassiciFRANCESCO CASELLA0% (1)
- PIZZICA Per Orchestra - L. Petracca - Full ScoreDocumento13 paginePIZZICA Per Orchestra - L. Petracca - Full ScoreLucaNessuna valutazione finora
- Tecnica Organettistica Vol 1Documento27 pagineTecnica Organettistica Vol 1Vincenzo MellaceNessuna valutazione finora
- Raccolta Brani Per Organetto PDFDocumento13 pagineRaccolta Brani Per Organetto PDFJackWasabi50% (2)
- 7 Spartiti Di Musica Popolare LombardaDocumento11 pagine7 Spartiti Di Musica Popolare Lombardaaledagaz100% (2)
- Il Giro ArmonicoDocumento1 paginaIl Giro ArmonicotonymontanaNessuna valutazione finora
- Piccolo Fiore - Valse MusetteDocumento3 paginePiccolo Fiore - Valse MusetteFrancesco MarelliNessuna valutazione finora
- WWW - Parenticomune.it StrinaDocumento2 pagineWWW - Parenticomune.it StrinaCosp Cosp50% (2)
- AlmanaccoDocumento2 pagineAlmanaccosara dieciNessuna valutazione finora
- Guido Deiro PDFDocumento5 pagineGuido Deiro PDFwlh2000Nessuna valutazione finora
- CARLO VENTURI - 24 Composizioni Giovanili (Da Filmer) PDFDocumento32 pagineCARLO VENTURI - 24 Composizioni Giovanili (Da Filmer) PDFcristina cassoniNessuna valutazione finora
- Tesi - La Tarantella Di Montemarano PDFDocumento61 pagineTesi - La Tarantella Di Montemarano PDFFabio SorianoNessuna valutazione finora
- AccordatureDocumento10 pagineAccordaturealbertocalderanoNessuna valutazione finora
- FR-2 Roland PDFDocumento50 pagineFR-2 Roland PDFredpassionNessuna valutazione finora
- Sibelius Manuale in ItaDocumento138 pagineSibelius Manuale in ItaTullio FedericiNessuna valutazione finora
- Il Vero Pianista Sull'oceanoDocumento46 pagineIl Vero Pianista Sull'oceanoDaniele RussoNessuna valutazione finora
- Colonne SonoreDocumento48 pagineColonne SonoresergiomarcellaNessuna valutazione finora
- Tutti Gli Spartiti - Stretta Shop Online Di Spartiti MusicaliDocumento16 pagineTutti Gli Spartiti - Stretta Shop Online Di Spartiti MusicaliRosario GrecoNessuna valutazione finora
- Dragon BolDocumento1 paginaDragon BollopNessuna valutazione finora
- Termini Musicali PDFDocumento12 pagineTermini Musicali PDFPippo BaudoNessuna valutazione finora
- Cantiamo Insieme 2Documento8 pagineCantiamo Insieme 2serenataserenataNessuna valutazione finora
- Demo Musichese Vol1 Defi 2008Documento16 pagineDemo Musichese Vol1 Defi 2008vito pizzolatoNessuna valutazione finora
- Amor Dammi Quel FazzolettinoDocumento1 paginaAmor Dammi Quel FazzolettinoaliceadslNessuna valutazione finora
- LA CURA Franco Battiato Accordi e SpartitiDocumento2 pagineLA CURA Franco Battiato Accordi e SpartitiAndrea FinettoNessuna valutazione finora
- Flauto DolceDocumento5 pagineFlauto DolceerpatacconeNessuna valutazione finora
- Gem wx400Documento224 pagineGem wx400AvianaNessuna valutazione finora
- Murolo - Mia Martini - Cu'Mme', Spartito Testo e Accordi Per Chitarra - MbutoZone - ItDocumento2 pagineMurolo - Mia Martini - Cu'Mme', Spartito Testo e Accordi Per Chitarra - MbutoZone - ItLorenza MaddalenaNessuna valutazione finora
- Elementi Fondamentali Jazz (Capitolo 1)Documento9 pagineElementi Fondamentali Jazz (Capitolo 1)Roberta PrestigiacomoNessuna valutazione finora
- Estratto Piccola OrchestraDocumento13 pagineEstratto Piccola OrchestraGIANCARLOSCARVANessuna valutazione finora
- 12 21 Guido DeiroDocumento5 pagine12 21 Guido DeiroaliceadslNessuna valutazione finora
- Strumenti Musicali PDFDocumento67 pagineStrumenti Musicali PDFGero CiullaNessuna valutazione finora
- Interprete PDFDocumento37 pagineInterprete PDFGiuseppe CamilleriNessuna valutazione finora
- Elenco Di Strumenti MusicaliDocumento13 pagineElenco Di Strumenti MusicaliCris Tina100% (1)
- L'organo A CanneDocumento10 pagineL'organo A CannepoppcornNessuna valutazione finora
- Ruggeri: Manuale Di Armonia PraticaDocumento22 pagineRuggeri: Manuale Di Armonia PraticaStefano LambarelliNessuna valutazione finora
- Pizzica e Taranta e TarantellaDocumento11 paginePizzica e Taranta e TarantellaLorenzo G. VillaniNessuna valutazione finora
- La Musica EtnicaDocumento29 pagineLa Musica EtnicaSolda Andy Andrea100% (1)
- VurriaDocumento2 pagineVurriavalentinaNessuna valutazione finora
- ER 3069 Spanish PortraitDocumento1 paginaER 3069 Spanish PortraitDocente Alessandra LucchiNessuna valutazione finora
- Guida All'AscoltoDocumento2 pagineGuida All'AscoltoHudson Rabelo100% (1)
- GianniDocumento1 paginaGianniNicola CarnevaleNessuna valutazione finora
- Risult at I 2010Documento8 pagineRisult at I 2010Nóra AntóniaNessuna valutazione finora
- Brahms Sonata 2Documento2 pagineBrahms Sonata 2Fabio CastielloNessuna valutazione finora
- Spanish & Italian LyricsDocumento21 pagineSpanish & Italian LyricsAllen ProvidoNessuna valutazione finora
- Pattern Ritmici 2 BluesDocumento3 paginePattern Ritmici 2 Bluespaolo68audisioNessuna valutazione finora
- Dolcissima Mia Vita Gesualdo Complete ScoreDocumento4 pagineDolcissima Mia Vita Gesualdo Complete ScoreMicheleRussoNessuna valutazione finora
- Accordature Particolari Per ChitarraDocumento2 pagineAccordature Particolari Per ChitarraAntonello CinquegraniNessuna valutazione finora
- Despacito For BandDocumento11 pagineDespacito For BandNóra AntóniaNessuna valutazione finora
- Canzoni NapoletaneDocumento39 pagineCanzoni NapoletaneAnonymous SAuK4CNessuna valutazione finora
- Modo MisolidioDocumento2 pagineModo MisolidioPatrick HopkinsNessuna valutazione finora
- Cazzati - Motets A 1 With VioliniDocumento118 pagineCazzati - Motets A 1 With VioliniG TothNessuna valutazione finora
- 2night Ottobre 2009 - VenetoDocumento37 pagine2night Ottobre 2009 - Veneto2nightNessuna valutazione finora
- Teoria Piano 1 PDFDocumento7 pagineTeoria Piano 1 PDFsaraNessuna valutazione finora
- Milonga Del ConsorcioDocumento2 pagineMilonga Del ConsorcioveroguitarraNessuna valutazione finora
- BlueMoon (Partitura)Documento3 pagineBlueMoon (Partitura)Enrico PiccininiNessuna valutazione finora
- American PatrolDocumento2 pagineAmerican PatrolJavier MiquelNessuna valutazione finora
- Sweet Child O Mine - Violin II PDFDocumento3 pagineSweet Child O Mine - Violin II PDFRogério Violinist100% (1)
- E Penso A Te - BattistiDocumento6 pagineE Penso A Te - BattistiSimone FerrariNessuna valutazione finora
- Mozart e Il PianoforteDocumento12 pagineMozart e Il Pianofortemcain93Nessuna valutazione finora
- AlleriaDocumento1 paginaAlleriaSpartiti Con Basi MusicaliNessuna valutazione finora
- 01 British Poets PDFDocumento8 pagine01 British Poets PDFAdriano BottiniNessuna valutazione finora
- ToscaDocumento48 pagineToscaMi Salvo100% (1)
- Il Trovatore - LibrettoDocumento28 pagineIl Trovatore - LibrettoAndreaNessuna valutazione finora
- Addio Del Passato (Lara Fabian) PDFDocumento2 pagineAddio Del Passato (Lara Fabian) PDFmuic722004Nessuna valutazione finora
- Billie Eilish Lovely With Khalid PDFDocumento3 pagineBillie Eilish Lovely With Khalid PDFS PriceNessuna valutazione finora