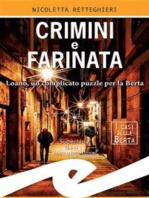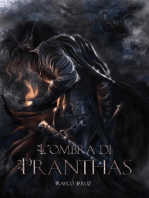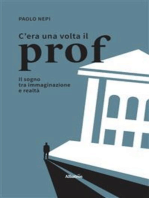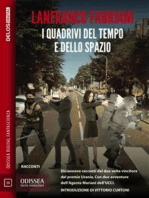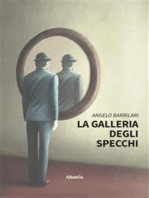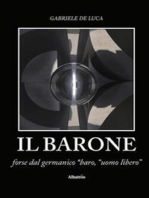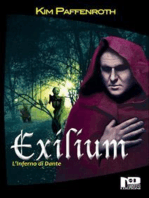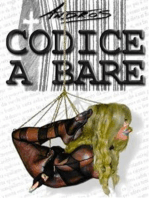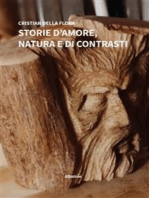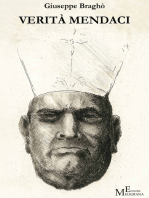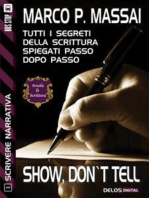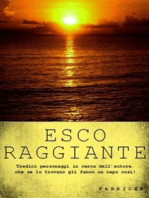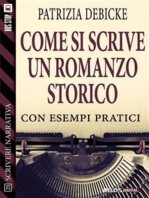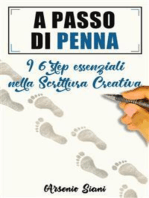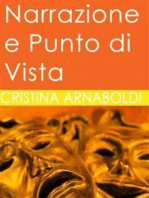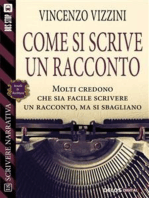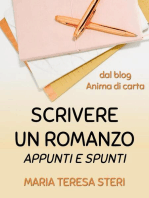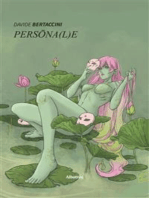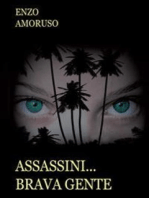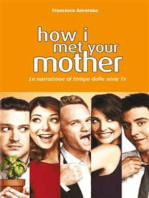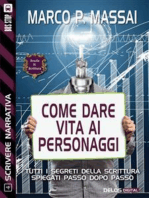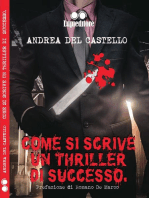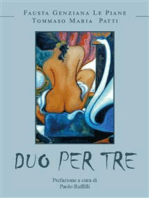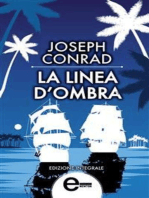Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Lezione 4 - Descrivere Il Mondo Narrativo (Parte 1)
Caricato da
Jenny Del PreteTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Lezione 4 - Descrivere Il Mondo Narrativo (Parte 1)
Caricato da
Jenny Del PreteCopyright:
Formati disponibili
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
1
Questa lezione è incentrata sulle descrizioni del mondo narrativo ed è la
prima di una serie di tre lezioni.
A prescindere da quello che deciderai di scrivere, qualsiasi lettore
necessita di sentirsi legato a un tempo e a uno spazio.
Uno degli errori più frequenti di un esordiente è che la storia galleggia in
uno spazio/tempo mai definito. Una sequela di azioni sospese in un
vuoto cosmico.
È sempre necessario ragionare sulla temporalità e sulla spazialità di
una scena, di un capitolo, dell’intero romanzo.
Ecco perché, con la progettazione narrativa, uno dei primi esercizi da
fare è quello di isolare una porzione di spazio e di tempo, andando a
creare, con l’Idea Prima, un recinto preciso in cui i personaggi si
muoveranno, gli eventi accadranno e le azioni si susseguiranno più o
meno velocemente.
Se non sai cos’è l’Idea Prima ti consiglio di leggere Progettazione su
Misura, il mio corso base di progettazione narrativa.
Se non ci sono, in una buona storia, sufficienti dettagli inerenti il tempo
e lo spazio, il lettore non verrà trasportato nel romanzo o nel racconto,
disprezzando a vario livello quello che hai scritto.
Quali sono i rischi delle descrizioni? Quasi sempre, quando si scrive, il
problema principale sta tutto nel selezionare i dettagli.
Le situazioni pericolose in cui incorrere, se si è scrittori, sono di solito
due.
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
2
Dire troppo: hai lavorato al mondo narrativo della tua storia, alla
scheda dei personaggi e alla trama in modo così viscerale e puntiglioso
che, quando decidi di trasferire tutto quello che sai sulla tua storia in un
impianto narrativo, esageri e metti tutto, senza dare il giusto risalto a
quello che è davvero importante;
Dire poco: hai lavorato al mondo narrativo della tua storia, alla scheda
dei personaggi e alla trama in modo così viscerale e puntiglioso che,
quando decidi di trasferire tutto quello che sai sulla tua storia in un
impianto narrativo, siccome tu sai tutto e conosci ogni più piccolo
dettaglio, non metti nulla di quello che sai del mondo narrativo della tua
storia. Tanto è dentro la tua testa, tu riesci a seguire il filo dei tuoi
pensieri, quindi che importano i lettori?
Come sempre, o quasi, nella vita, le descrizioni sono un elemento dove
selezione e misura sono le tue migliori alleate.
Ecco perché spesso si usa l’occhio esterno di un beta reader o si
sceglie di lavorare con un editor professionista.
La misura e la selezione passano attraverso i dettagli, e sono quelli a
disegnare i contorni di un ambiente, di un personaggio, di un evento.
Quando si scrive si deve pensare ai contorni, e a qualche dettaglio in
più che funga da appiglio per il lettore; ma è quest’ultimo che deve
colmare i vuoti, con la sua fantasia, il suo vissuto e il suo sguardo.
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
3
Tipologie di descrizioni
Ce ne sono una miriade: descrizioni di interni, di esterni, brevi e fugaci
apparizioni, descrizioni legate a un concetto astratto come la paura
(Edgar Allan Poe, Stephen King), impressioni descrittive filtrate dallo
sguardo del personaggio, o da quello del narratore; metafore,
similitudini, con sinestesia o sineddoche…
Tuttavia per alcuni l’unica vera descrizione rimane quella ottocentesca,
quella alla Honoré De Balzac. Non fraintendermi, io lo adoro, ma non
tutti sono pazienti.
Alcuni, se vedono in apertura di paragrafo una lunghissima descrizione,
la saltano a piè pari per arrivare alle sequenze dialogiche e a quelle
narrative. Poi magari alla fine, dopo aver concluso il romanzo, ti
lasciano una bella recensione negativa perché non hanno capito dove e
quando è ambientata la storia.
Qual è quindi la risposta?
Iniziamo con il fare alcune riflessioni legate all’incipit di Papà Goriot,
proprio di Balzac.
La prima stanza emana un odore che non ha nome nel linguaggio, e che
bisognerebbe chiamare odor di pensione: tanfo di rinchiuso, di muffa, di rancido; fa
rabbrividire, è umido all’olfatto, penetra attraverso gli indumenti; ha il sentore di un
locale in cui si sia mangiato; puzza di gabinetto, di cucina, d’ospizio di vecchi. […] E
tuttavia, nonostante questi orrori, se paragonaste la stanza in parola alla contigua sala
da pranzo la trovereste elegante e profumata come il salottino di una dama. La sala,
interamente foderata di pannelli di legno, un tempo era dipinta di un colore che oggi
è divenuto indefinibile e che forma un fondo sul quale il sudiciume ha deposto vari
strati, tracciandovi bizzarre figure.
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
4
Ora, ho fatto volutamente una pausa dalla citazione originale perché
vorrei che ti soffermassi a riflettere sulla funzione di questa descrizione.
Questo è un preludio, una descrizione che prepara l’entrata in scena di
un personaggio.
Il lettore che tipo di personaggio si aspetta? Una donna giovane, nel
pieno della forza e della grazia? O una vecchia laida e decrepita?
Continuiamo…
Questa stanza è in tutto il suo splendore nel momento in cui, verso le sette del
mattino, appare […] la vedova, agghindata nella sua cuffietta di tulle sotto la quale
pende una treccia finta, malamente appuntata. Essa cammina strascicando le
ciabatte grinzose. Il viso vecchiotto, tondo, in mezzo al quale s’erge un naso a becco
di pappagallo, le manine paffute, la persona grassoccia come un topo di chiesa, il
seno troppo colmo e ballonzolante, sono in armonia con quella sala che trasuda
miseria, dove la speculazione si è rincantucciata, e di cui la signora Vauquer respira
l’aria calda e fetida.
Come volevasi dimostrare, ecco puntuale la descrizione della vedova
Vauquer.
In questo caso, assolutamente geniale, l’ambientazione supporta e
giustifica l’entrata in scena del personaggio; il personaggio, con la sua
entrata in scena, giustifica la descrizione dell’ambiente interno in cui
vive e ospita altre persone, come si comprende dall’accenno alla
speculazione, resa “rincantucciata”, quindi viene dato corpo a un
concetto altrimenti astratto.
Questa figura semantica è l’Ecceità. (Per approfondire: trovi un video
dedicato nel mio canale YouTube)
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
5
E se in un'ambientazione tanto laida avesse fatto la sua comparsa una
giovane aitante e bellissima? Sarebbe stato sbagliato?
Ovviamente no, anzi, probabilmente sarebbe stato ancora più
interessante da un punto di vista narrativo, perché avrebbe dato il via
all’equivoco. Come mai una donna così bella vive in un ambiente del
genere?
Ovviamente un dettaglio dissonante come questo serve a far incuriosire
il lettore; la parte di Balzac è molto più coerente e serve solo a
presentare una situazione, il luogo dove si svolgerà e attorno a cui
ruoterà quasi tutta la storia.
Ma come si scrivono nel XXI secolo le descrizioni funzionali alla storia,
con dettagli selezionati?
Vediamo una carrellata di opzioni, come nelle precedenti lezioni.
Descrivere usando i sensi
Una delle domande che mi sono state fatte riguardava l’uso dei cinque
sensi per le descrizioni.
Non sempre le descrizioni devono essere scritte usando tutti i sensi, ma
dei dettagli visivi, uditivi, tattili, etc… contribuiscono a rendere
maggiormente tangibile un luogo, una sensazione, un personaggio, un
concetto estratto.
Ecco un pezzo de Il dominio del fuoco di Sabaa Tahir. Per la precisione
è un fantasy. La scrittrice deve presentare il quartiere delle armi dove la
protagonista femminile del romanzo si reca per la prima volta.
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
6
Il quartiere è un alveare di suoni e di movimenti [METAFORA] più animato, in un
giorno normale, di quanto lo siano molti mercati nei giorni di festa. Le fiamme delle
fucine brillano di un rosso più intenso del sangue; dai magli volano scintille grosse
come la mia testa e dalle spade appena temprate in acqua eruttano, a poca distanza
l’uno dall’altro, pennacchi di vapore. [VISTA] I fabbri urlano ordini mentre gli
apprendisti si agitano a destra e a manca per seguirli. E sopra tutto quanto, centinaia
di mantici che si tendono e pompano, cigolanti come una flotta di navi in mezzo a
una tempesta. [UDITO E SIMILITUDINE]
Come puoi vedere, la descrizione non è lunghissima, e nient’altro verrà
aggiunto sul Quartiere delle Armi.
L’operosità e il movimento continuo di cose e persone è reso con
estrema capacità da una descrizione che stuzzica i nostri sensi e ci fa
ricostruire, angolo dopo angolo, un luogo dove contemporaneamente
occhi e udito, accompagnati dal movimento, sono i sensi più colpiti e
risvegliati.
Sicuramente l’autrice nella sua mente aveva un’immagine molto più
articolata del Quartiere, ma ha scelto, mentre mostrava questa
ragazzina indifesa che entra in una zona che di solito le è preclusa, di
focalizzarsi su dettagli che convergessero sul movimento, la vista e
l’udito.
Se avesse deciso di far toccare un’arma alla protagonista, avrebbe
potuto scegliere il tatto. Ma Laia, la ragazzina, fa parte del popolo dei
Dotti, i pacifisti del regno, e non sa maneggiare le armi. Anche in questa
scelta c’è coerenza, preparazione e progettazione preventiva.
Torniamo per un momento a Amy e Isabelle, il romanzo della Strout che
ho citato anche nelle precedenti lezioni.
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
7
Gli automobilisti di passaggio sull’autostrada, nel sentire quell’odore soffocante di
zolfo, tiravano su i finestrini e si chiedevano come si potesse vivere con quella razza di
fetore che esalava dal fiume e dallo stabilimento.
Questo è un piccolo dettaglio legato all’olfatto che rende però
perfettamente l’idea, visto che è collegato all’azione di proteggere il
proprio naso dal fetore molto aggressivo che raggiunge le narici degli
automobilisti.
Solo transitare vicino a quel luogo ammorba l’olfatto, quindi come sarà
viverci? Come saranno gli abitanti di quel luogo così puzzolente? Come
possono sopportarlo?
Un dettaglio olfattivo e percettivo che obbliga il lettore a porsi delle
domande, anche piccole, sul contesto del mondo narrativo.
Descrivere un interno
Un’altra bella gatta da pelare si presenta quando dobbiamo descrivere i
luoghi dove un personaggio si muove e agisce. Ho già riportato
l’interessante descrizione di un intero quartiere delle armi in poche
righe.
Ora vorrei mostrarti degli esempi altrettanto interessanti.
Il primo esempio è la descrizione della camera della caserma dove
dorme e vive Elias, il protagonista maschile del romanzo Il dominio del
fuoco.
Elias è un Marziale, quindi fa parte del gruppo che è riuscito ad avere la
meglio sui Dotti, i pacifici e che domina il territorio grazie al potere delle
armi.
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
8
La mia camera è un buco freddo e umido con un’entrata bassa e una tenda lacera al
posto della porta. L’interno è largo quanto basta per contenere un giaciglio di corda
e una cassa che funge da tavolino.
Elias ci descrive la sua camera, di solito un rifugio per un ragazzo di
diciassette anni, che invece, per come è descritto, ci sembra
innaturalmente spartano e anche un po’ triste.
Ad un certo punto della storia, per varie motivazioni che non sto ad
approfondire, Elias si ritroverà rinchiuso in una cella. Mettiamo a
confronto la descrizione di questo luogo:
Passano le ore. O forse i giorni. Non ho modo di saperlo. Le campane di Rupenera
non penetrano nelle prigioni sotterranee. Non riesco neanche a sentire i tamburi. I
muri di granito della mia cella senza finestre sono spessi tre palmi, le sbarre di ferro
sono larghe uno. Non ci sono guardie. Non ce n’è bisogno. Cammino avanti e
indietro nella cella, misurandola. Cinque passi in una direzione, sei nell’altra.
Vedi quanto è utile e funzionale questa seconda descrizione?
Suggerisce buio, soffocamento e prigionia.
E lo fa utilizzando l’assenza delle percezioni sensoriali. Il bello di questo
secondo passo è che Elias non ha descritto in un modo molto
lusinghiero la camera in cui vive, rispetto alla cella della prigione.
Tra le righe il lettore trae le sue deduzioni, ancora una volta.
Elias sta vivendo una vita che odia, attimo dopo attimo, obbligato a fare
il soldato e a uccidere il prossimo senza averne la vocazione. Per lui
stare nella camera della caserma o stare in una cella, rappresenta
esattamente la stessa cosa: l’eliminazione, ancora una volta, del suo Io
e della libertà a cui anela.
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
9
Descrivere un luogo esterno
Passiamo ora a un altro esempio di descrizione di luoghi. Torniamo a
L’inganno, di Thomas Cullinan.
Scomparvero nell’oscurità, in mezzo alla foschia che si alzava dal suolo umido, oltre
un fosso con dentro un carro capovolto e un cannone che puntava alla luna.
[ISTANTANEA]
Questo è un pezzo di un flashback che mostra le sorelle Farnsworth
andare alla ricerca del corpo del fratello perito in battaglia a pochi
chilometri dal collegio. Come ho specificato nelle lezioni precedenti, la
narrazione del presente del romanzo rimane invece confinata all’interno
del collegio stesso.
Questa parte è quella che si definisce Istantanea. Facci caso,
assomiglia alla descrizione di una fotografia o di una cartolina,
un’immagine statica che isola in un istante le componenti di un luogo,
fisiche e artificiali.
Subito dopo questo pezzo introduttivo, la descrizione continua.
In quella foschia c’erano cose terribili: uomini in marcia guidati dal generale Jackson
su un cavallo nero, donne piangenti, uccelli mostruosi, pipistrelli e altre creature
d’inferno. Vagavano in silenzio sul campo di battaglia, con il vento che frusciava tra
gli alberi secchi e il nostro vecchio stallone che nitriva e scalpitava nell’aria gelida.
In questo pezzo l’autore riprende un dettaglio della prima fugace
istantanea e decide di esplorare il contenuto di quella foschia in cui le
due donne si immergono, popolata dalle convinzioni errate, dalle
superstizioni e dalle credenze che si propagano sempre
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
10
nel popolo in un momento di paura e terrore com’è la guerra (e quello
attuale che stiamo vivendo, dominato perlopiù dal silenzio, e
dall’assenza di movimento).
Quindi un altro consiglio è quello di iniziare una descrizione in modo
breve, con la tecnica dell’istantanea, e dopo un paio di sequenze
dialogiche, per esempio, ritornare a quella descrizione ampliandola e
rendendola ancora più interessante. Come un farmaco che viene
somministrato a piccole dosi, una goccia dopo l’altra.
Passiamo ora all’incipit di Amy e Isabelle:
Faceva un caldo terribile l’estate che il professor Robertson lasciò la città e per molto
tempo il fiume fu soltanto una cosa piatta stesa lì, al centro della città, come un
serpente marrone morto, con la schiuma giallastra a raccogliersi sulle sponde
Il romanzo della Strout inizia così, spiegando subito al lettore la
collocazione temporale della storia che il narratore si sta accingendo a
narrare.
E per sottolineare l’eccezionalità del caldo, ecco che il fiume rimane
morto per molto tempo
fu soltanto una cosa piatta stesa lì, al centro della città, come un serpente marrone
morto, con la schiuma giallastra a raccogliersi sulle sponde.
segno che l’intera narrazione della storia – come in effetti accade –
durerà quanto l’intera estate in cui il fiume rimane morto. Non a caso il
finale del romanzo, e la chiusura delle questioni in sospeso, viene poi
accolta dai personaggi (e dal lettore) con una formidabile pioggia, che
dura giorni e giorni, cambiando i contorni delle cose.
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
11
Penso sia necessario notare questi dettagli descrittivi in un romanzo,
perché saper gestire in questo modo gli elementi che compongono il
mondo narrativo della storia, fornisce al lettore elementi adeguati per
orientarsi e per immaginare il contesto in cui si collocano.
Torniamo a un altro esempio tratto da Amy e Isabelle.
La casa, piccola e umida, si era rivelata caldissima d’estate e fredda in inverno, ma, per
il resto, adatta alle loro esigenze. Costruita originariamente, all’inizio del secolo,
come piccola stalla per pochi cavalli, era stata in seguito trasformata nell’abitazione di
un custode; poi c’era stato l’incendio: la casa padronale della tenuta dei Crane
era andata distrutta fino alle fondamenta. Non f u mai appurato quali ne
fossero le cause. Probabilmente, l’impianto elettrico difettoso. Ma si
raccontavano storie secondo cui l’onorevole giudice Crane avrebbe avuto
un’amante che una notte gli avrebbe incendiato la casa. Un’altra variante
vedeva il giudice appiccare il f uoco di persona, dopo aver ucciso sua moglie, e
poi allontanarsi in macchina sull’autostrada, il cadavere di lei appoggiato sul
sedile al suo fianco con tanto di cappello in testa. O qualcosa di simile,
comunque.
Non ho messo questo passo nella descrizione degli interni perché a tutti
gli effetti la casa, nel suo interno, qui non viene mostrata. Quello che
l’autrice mostra, invece, con incredibile maestria, è uno dei sette
elementi che compongono un adeguato mondo narrativo: l’Epos, la
memoria storica collettiva (di cui parlo ampiamente in Progettazione su
Misura).
Il mondo narrativo, per essere credibile, deve possedere una memoria
storica collettiva riconosciuta, rispettata e tramandata. L’Epos ha un
grande impatto emotivo sul lettore. La memoria storica di un luogo lo
rende tangibile, reale. Fa comprendere al lettore che vi è tanto altro da
sapere, da approfondire sul folklore, le tradizioni, le convinzioni.
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
12
Ora preparati a leggere una lunga descrizione del mondo narrativo del
romanzo Amy e Isabelle.
Sono abbastanza fissata con la Strout come scrittrice, perché è davvero
evocativa e intelligente nel dosare le informazioni senza ammorbare.
Lungo le strade secondarie di Shirley Falls crescevano margherite e trifoglio rosa.
C’erano anche piselli dolci selvatici, avviluppati tra i lupini e la coda di topo, e
cespugli spinosi di more e lamponi, nonché stapelie dai fiori rossi che si
arrampicavano sui muri di pietra e carote selvatiche nei campi. Ma quell’estate tutte
queste piante avevano un aspetto avvizzito e scolorito, come quello delle erbacce e
dei fiori selvatici che crescono lungo le strade sterrate e vengono coperti da uno
strato di polvere; anche se ora era il tempo a fare questo effetto, quel terribile caldo e
quell’umidità, quell’implacabile cielo bianco che si estendeva ovunque sopra le loro
teste e sembrava deciso, in qualche modo, a nascondere alla vista tutti i normali
colori del mondo. Era giugno, e a giugno il mondo dovrebbe essere verde, solido e
vigoroso, ma stavolta c’era qualcosa che mancava, come se quest’anno (pensò un
giorno Edna Thompson, la moglie dell’allevatore di mucche, mentre stendeva i
panni nel cortile dietro casa) Dio, mettendo il fertilizzante nei vasi sul suo davanzale,
si fosse dimenticato quello del New England; le margherite crescevano alte ma
esilissime, con certe corolle di cui non potevano certo andare fiere; i petali si
staccavano facilmente, appena i bambini li tiravano: «M’ama, non m’ama». La coda
di topo veniva su in fili di un verde pallido, ma poi si ripiegava stanca verso terra,
marrone sulle punte. E i mazzetti di fiori di carota che spuntavano qua e là per i
pascoli assomigliavano a ragnatele grigie, o si notavano appena, confondendosi con il
pallore bianco del cielo. I contadini che avevano lavorato quella terra per molti anni,
che avevano in sé una stoica capacità di sopportare qualunque variazione Madre
Natura causasse nelle stagioni, ora stavano in piedi in mezzo ai campi, a tastare i
fagiolini già avvizziti sulla pianta e a guardare turbati gli acri di piante di granturco
trenta centimetri buoni più basse del normale; perché c’erano campi interi di
foraggio per le vacche che sembrava crescere a stento, ed era questo che più di tutto
disturbava i contadini, il fatto che la naturale spontaneità della crescita era
scomparsa, o pareva quanto meno arrancare. In difficoltà.
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
13
La terra sembrava in difficoltà. Ma dietro queste paure c’erano generazioni di miseria
e sopravvivenza. Ne erano testimoni le antiche pietre tombali sulle rive del fiume che
risalivano al Seicento: madri che avevano perso neonati su neonati, alcuni seppelliti
senza neanche aver ricevuto un nome, anche se molti erano sopravvissuti e si erano
portati dietro per tutta la vita nomi come Fedele, Provato, Paziente. C’erano
famiglie, a Shirley Falls, i cui antenati erano stati scotennati dagli indiani. (La signora
Edna Thompson, ad esempio, aveva una bis-bis-bisnonna, Molly, che era stata rapita
dagli indiani nel 1756 e portata a piedi fino in Canada, dove era stata venduta a un
francese, prima che il fratello arrivasse in suo aiuto). Durante i primi anni di
insediamento, le case e i raccolti erano stati ripetutamente incendiati. Una tale
resistenza (una delle lapidi portava il nome di Resistenza Tibbetts) aveva nutrito per
secoli uomini e donne che ancora oggi avevano tratti da puritani e occhi azzurro
chiaro; non erano degli allarmisti. Eppure, la gente quell’estate era preoccupata, e
quando si sparse la voce che erano stati avvistati degli UFO nel nord dello Stato e che
il governo aveva perfino mandato degli agenti a fare indagini, in città ci fu chi rifiutò
di fare commenti, chi non fece altro che accigliarsi di più e andare avanti col suo
lavoro. A messa, il numero dei fedeli aumentò: senza formulare esattamente il
pensiero, la gente stava pregando per placare Dio. Bastava gettare uno sguardo al
fiume, per avere la prova dell’ostilità del cielo: stava fermo in mezzo alla città come
una cosa morta, con quella putrida schiuma gialla che si raccoglieva sulle sponde,
come un serpente spiaccicato su una strada con le interiora sgocciolanti, sudicio e
infetto sotto un sole incolore. Solo le ninfee sembravano indifferenti. Fiorivano
lungo il fiume come avevano sempre fatto; e salivano a crescere vicino alle case e ai
fienili e lungo i muretti di pietra, con i petali arancione scuro aperti come bocche,
screziati e pieni di forza in confronto a tutto il resto. E così, la gente aspettava.
Questa è una descrizione magistrale scritta con la Tecnica del
Confronto. In breve: Shirley Falls, mondo narrativo di un romanzo
straordinario, di solito è così, ma nell’estate in cui la storia inizia invece
è cosà.
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
14
Geniale, perché permette al lettore di farsi un’idea del luogo e
soprattutto di porre l’accento sull’eccezionalità della situazione che
stanno vivendo abitanti e Natura, intimamente connessi e sgomenti di
fronte a una tale siccità.
Ovvio che l’eccezionalità del momento prepara anche il lettore alla
lettura di una storia altrettanto eccezionale, e unica.
Non vi sarà spazio, nel resto del romanzo, per descrizioni così lunghe.
La Strout ha voluto dare fin dall’inizio al lettore tutti gli elementi per
orientarsi; poi, durante il romanzo, ha scritto delle sequenze descrittive
più brevi, che sono riuscite a centrare il bersaglio, cioè quello di far
richiamare, al lettore, la descrizione iniziale, che rimane statica nel suo
immobilismo provocato dall’eccezionale siccità, fino alla conclusione
della storia.
Esistono poi delle descrizioni di luoghi che non sono destinati ad
evolvere e che non stanno vivendo nessuna eccezionale avventura.
Sono così da un po’ di tempo, e forse sono destinati a rimanere tali per
altrettanto tempo.
Leggiamo insieme questa descrizione, tratta dal romanzo di Dario
Levantino Di niente e di nessuno.
A Brancaccio la strada più bella si chiama viale dei Picciotti. C’è un marciapiede
tutto cacato, sette platani mezzi secchi, i negozi con l’insegna fulminata. Ci abitano i
benestanti: il cassiere del discount, il fruttivendolo con la pensione di invalidità, il
panellaro che vende i panini al liceo classico. Le ragazze del quartiere, quando si
comprano le scarpe nuove o quando si fanno le unghie dalla nigeriana ai domiciliari,
è lì che devono andare a passeggiare. I ragazzi infatti parcheggiano gli scooter sui
marciapiedi, ci si spaparanzano e guardano le passanti esternando apprezzamenti
poco velati.
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
15
Questa descrizione è statica. Non mostra nulla del luogo, non vi è
movimento alcuno.
L’intento è quello di mostrare una parte precisa del quartiere
Brancaccio, dove il protagonista della nostra storia si muove e vive.
Eppure la descrizione viene fatta senza alcun tentativo di abbellire la
realtà, o almeno la realtà secondo gli occhi di Rosario.
Leggiamone un’altra:
Ho preso il treno alla stazione, ho scelto il posto finestrino, ho visto Brancaccio da
una prospettiva diversa. Le pareti delle case a ridosso del doppio binario erano
annerite di CO2. Sui marciapiedi auto posteggiate, la spazzatura seminata come
grano. Una donna stendeva lenzuola lise a poca distanza dal treno; due bambini
giocavano ad aggaddarsi; un palazzo non terminato era diventato un carnaio di cacca
di piccioni e amianto; a un’inferriata qualcuno aveva appeso una frizione di auto; un
mio coetaneo sbraitava i numeri della lotteria del rione; sul balcone sopra la putìa un
vecchio materasso esibiva emorroidi di gommapiuma e poliuretano; in prossimità
del passaggio a livello un impianto stereo faceva vibrare il cofano della Fiat Uno che
lo conteneva; un signore con la canottiera rovistava nella spazzatura; una Lambretta
piena di detersivi legati a un filo procedeva contromano.
Questa seconda descrizione, invece, è del tutto diversa dalla
precedente, più disincantata. Il senso del movimento lo dà il dettaglio
del treno, su cui Rosario sale.
E la diversa prospettiva offre uno spettacolo del tutto desolante del
quartiere. La giusta distanza che Rosario prende attraverso un mezzo di
trasporto, gli permette di notare dei dettagli che non riesce a notare
durante il suo presente e la sua quotidianità di adolescente.
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
16
Nello stesso romanzo vi è un’altra descrizione del quartiere fatta in
movimento, questa volta su un autobus. Eccola:
Sul 224 non c’è un posto libero, ma nel mezzo dell’abitacolo c’è uno slargo dove
posso appoggiarmi a una parete e vedere fuori dal finestrino. Sulle strisce pedonali
una signora con un passeggino aspetta che qualcuno la faccia passare, ma nessuno
rallenta, nemmeno l’autista dell’autobus su cui viaggio. Sul marciapiede del Foro
Italico un simensaro occupa il transito, stipa i pistacchi, ordina i lupini sul bancone.
Cinquecento metri dopo, un pescivendolo, con le dita a molla, spruzza ghiaccio
triturato sul pesce esposto: un cimitero di cadaveri con le bocche spalancate. Dal
tabaccaio un fumatore ha appena comprato le sigarette: esce, butta per terra la
pellicola di plastica, porta in bocca una Marlboro ma non faccio in tempo a vedere in
che modo l’accende.
Eppure in questa descrizione, come potete notare, non vi è spazio per il
degrado, o per il sentimento negativo che predomina nella sequenza
precedente.
Questa è una descrizione di normalità di Brancaccio, perché Rosario
non ha “preso le distanze”, ed è ancora immerso nel suo quartiere.
Lo sguardo è sicuramente meno disincantato e la sua ricostruzione non
parte da una distanza oggettiva che fa cambiare prospettiva ai luoghi e
alle persone che li abitano.
In questa prima parte di tre lezioni dedicate alla descrizione del mondo
narrativo, ho deciso di non mettere degli esempi scritti da Amelia.
Arriveranno nella terza parte.
Ho infatti deciso di dedicare molto spazio a esempi e tecniche per
descrivere i luoghi del romanzo, spesso un elemento di scrittura
narrativa molto debole di troppe storie.
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
17
Nella seconda parte vedremo altre tecniche e soluzioni ingegnose per
collegare e sfruttare il mondo narrativo per mostrare e consolidare la
fabula interpretata della storia; e per descrivere un mondo narrativo
distante dal nostro senza scadere nella banalità.
Ti consiglio di iniziare a sperimentare alcune tecniche viste in questa
lezione e a riflettere sulle descrizioni dei luoghi del tuo romanzo.
Buon lavoro e buon divertimento.
Stefania
CONTINUA A LEGGERE
⇓⇓⇓⇓
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Corso di Scrittura Narrativa Applicata alla Progettazione
18
Ti ringrazio di cuore per aver partecipato a questa
lezione.
Molti me l’hanno chiesto in privato e io ho deciso di
estenderlo a tutti.
Se per un motivo qualsiasi non riesci a seguire le lezioni
nel gruppo Facebook, a fine corso
potrai ricevere IN REGALO l’eBook con TUTTE le
lezioni comodamente nella tua casella e-mail.
Ti anticipo che ci saranno anche due inserti speciali
inediti sui temi della Revisione e della Pubblicazione.
L’eBook in formato .pdf potrà essere consultato in
digitale o stampato in cartaceo.
Lascia la tua e-mail qui ⇒ http://eepurl.com/gV3-9v
Stefania Crepaldi - EditorRomanzi.it
Potrebbero piacerti anche
- STORY DESIGNER. Come creare la struttura di un romanzo che funziona beneDa EverandSTORY DESIGNER. Come creare la struttura di un romanzo che funziona beneNessuna valutazione finora
- Diventare uno scrittore (Tradotto): Psicologia tecniche e consigli per diventare un grande autoreDa EverandDiventare uno scrittore (Tradotto): Psicologia tecniche e consigli per diventare un grande autoreNessuna valutazione finora
- Ovunque vai porti te stesso - Romanzo: Le inquietudini e le ossessioni di un uomo in cerca di espiazione e redenzioneDa EverandOvunque vai porti te stesso - Romanzo: Le inquietudini e le ossessioni di un uomo in cerca di espiazione e redenzioneNessuna valutazione finora
- Lontano Dagli Occhi, Lontano Dal Cuore: Una Guida Al Punto Di Vista Per ScrittoriDa EverandLontano Dagli Occhi, Lontano Dal Cuore: Una Guida Al Punto Di Vista Per ScrittoriNessuna valutazione finora
- Farsi letteratura: Corso di scrittura narrativa e poeticaDa EverandFarsi letteratura: Corso di scrittura narrativa e poeticaNessuna valutazione finora
- Crimini e farinata: Loano, un complicato puzzle per la BertaDa EverandCrimini e farinata: Loano, un complicato puzzle per la BertaNessuna valutazione finora
- Goffaggini erotiche e involuzioni prosaiche: Elementi di stile per novelli scrittori di romanzi eroticiDa EverandGoffaggini erotiche e involuzioni prosaiche: Elementi di stile per novelli scrittori di romanzi eroticiNessuna valutazione finora
- Scrivere narrativa 2 - Il punto di vista: Scrivere narrativa 2Da EverandScrivere narrativa 2 - Il punto di vista: Scrivere narrativa 2Nessuna valutazione finora
- Scrivere narrativa 1 - Show, don't tell: Scrivere narrativa 1Da EverandScrivere narrativa 1 - Show, don't tell: Scrivere narrativa 1Nessuna valutazione finora
- BOBINE: Antologia di racconti brevi a cura di Silvia FraccaroDa EverandBOBINE: Antologia di racconti brevi a cura di Silvia FraccaroNessuna valutazione finora
- A passo di penna: I sei step essenziali nella scrittura creativaDa EverandA passo di penna: I sei step essenziali nella scrittura creativaNessuna valutazione finora
- Com'è facile scrivere difficile. Prontuario di scrittura creativaDa EverandCom'è facile scrivere difficile. Prontuario di scrittura creativaNessuna valutazione finora
- Scrivere una commedia di successo in dieci passiDa EverandScrivere una commedia di successo in dieci passiNessuna valutazione finora
- Lezione 3 - Descrivere e Creare Il - La ProtagonistaDocumento16 pagineLezione 3 - Descrivere e Creare Il - La ProtagonistaJenny Del Prete100% (1)
- Scrivere con stile: Manuale avanzato di scrittura con esempi, esercizi, approfondimentiDa EverandScrivere con stile: Manuale avanzato di scrittura con esempi, esercizi, approfondimentiNessuna valutazione finora
- Le SequenzeDocumento10 pagineLe SequenzeCarla PetcuNessuna valutazione finora
- Lezione Uno PDFDocumento385 pagineLezione Uno PDFrobertoNessuna valutazione finora
- Come Si Analizza Un Testo NarrativoDocumento27 pagineCome Si Analizza Un Testo NarrativoEdvige Forino100% (1)
- How i met your mother: La narrazione al tempo delle serie tvDa EverandHow i met your mother: La narrazione al tempo delle serie tvNessuna valutazione finora
- Scrivere narrativa 4 - I personaggi: Scrivere narrativa 4Da EverandScrivere narrativa 4 - I personaggi: Scrivere narrativa 4Nessuna valutazione finora
- La Segretezza Degli Iniziati H.p.blavatsky PDFDocumento87 pagineLa Segretezza Degli Iniziati H.p.blavatsky PDFJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- La Dottrina Segreta - Vol.5 - AntropogenesiDocumento176 pagineLa Dottrina Segreta - Vol.5 - Antropogenesifederico12801100% (3)
- LA GNOSI H.P.B. E LA DOTTRINA SEGRETA Leonardo Sola PDFDocumento42 pagineLA GNOSI H.P.B. E LA DOTTRINA SEGRETA Leonardo Sola PDFJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- (Ebook - ITA - Esoterismo - Teosofia) - (Helena Petrovna Blavatsky) - La Dottrina Segreta - Vol. 3Documento683 pagine(Ebook - ITA - Esoterismo - Teosofia) - (Helena Petrovna Blavatsky) - La Dottrina Segreta - Vol. 3Egix Di CaroNessuna valutazione finora
- La Dottrina Segreta Vol.2 Antropogenesi H.p.blavatskyDocumento916 pagineLa Dottrina Segreta Vol.2 Antropogenesi H.p.blavatskyEósforo Hedoné100% (1)
- TEOGENESIDocumento80 pagineTEOGENESILuca Del PreteNessuna valutazione finora
- LA CHIAVE DELLA TEOSOFIA Helena P.BlavatskyDocumento144 pagineLA CHIAVE DELLA TEOSOFIA Helena P.BlavatskyJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- H.P. Blavatsky - Dissertazioni Sulla Dottrina SegretaDocumento102 pagineH.P. Blavatsky - Dissertazioni Sulla Dottrina Segretamarvek2118100% (4)
- Derry (Stephen King)Documento3 pagineDerry (Stephen King)Jenny Del PreteNessuna valutazione finora
- I PRECURSORI DI H.P.BLAVATSKY W.EmersonDocumento45 pagineI PRECURSORI DI H.P.BLAVATSKY W.EmersonJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- I LIBRI SEGRETI Di H.P.BLAVATSKY D. e N. ReigleDocumento110 pagineI LIBRI SEGRETI Di H.P.BLAVATSKY D. e N. ReigleJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- I-FENOMENI-DI-H P BLAVATSKY-H S OlcottDocumento2 pagineI-FENOMENI-DI-H P BLAVATSKY-H S OlcottJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- Enoch Dott SegrDocumento10 pagineEnoch Dott Segrthecorfiot2Nessuna valutazione finora
- IMPARARE DA OGNI SINGOLO EVENTO H.P.BlavatskyDocumento6 pagineIMPARARE DA OGNI SINGOLO EVENTO H.P.BlavatskyJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- H P BLAVATSKY-E-LITALIA-P M CalviDocumento4 pagineH P BLAVATSKY-E-LITALIA-P M CalviJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- Laicizzazione Del Diritto e Dello Stato RomanoDocumento2 pagineLaicizzazione Del Diritto e Dello Stato RomanoJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- Che Cos'è La Teosofia Di H.P. BlavatskyDocumento7 pagineChe Cos'è La Teosofia Di H.P. BlavatskyCarmen CopilauNessuna valutazione finora
- It (Romanzo)Documento8 pagineIt (Romanzo)Jenny Del PreteNessuna valutazione finora
- Costantino La Notizia È Il Virus PDFDocumento7 pagineCostantino La Notizia È Il Virus PDFJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- Geografia Dei Luoghi Di Stephen King Derry, Il Maine e PennywiseDocumento3 pagineGeografia Dei Luoghi Di Stephen King Derry, Il Maine e PennywiseJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- It - Tra Film e RomanzoDocumento10 pagineIt - Tra Film e RomanzoJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- Le Rune e La Scienza Sacra - ReloadDocumento123 pagineLe Rune e La Scienza Sacra - ReloadNachtdubist100% (4)
- Bill DenbroughDocumento3 pagineBill DenbroughJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- 29 - Tirare Le Fila La ConclusioneDocumento1 pagina29 - Tirare Le Fila La ConclusioneJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- 27 - Il Piano Di Battaglia Nel III AttoDocumento1 pagina27 - Il Piano Di Battaglia Nel III AttoJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- Lezione 3 - Descrivere e Creare Il - La ProtagonistaDocumento16 pagineLezione 3 - Descrivere e Creare Il - La ProtagonistaJenny Del Prete100% (1)
- Lezione 1 - L'incipitDocumento19 pagineLezione 1 - L'incipitJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- 30Documento1 pagina30Jenny Del PreteNessuna valutazione finora
- 28 - Il ClimaxDocumento2 pagine28 - Il ClimaxJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- Teoriaverifica 01Documento3 pagineTeoriaverifica 01LorenzoNessuna valutazione finora
- Il Destino Di PlatoneDocumento3 pagineIl Destino Di PlatoneKristian Niccolò PaderiNessuna valutazione finora
- Walt Disney, Fantasia 2000 Progetto MusicaDocumento3 pagineWalt Disney, Fantasia 2000 Progetto MusicaAntonio PuzoneNessuna valutazione finora
- (Workshop) Revisione Aria Delle Forcelle Solo Air Di Rock ShoxDocumento11 pagine(Workshop) Revisione Aria Delle Forcelle Solo Air Di Rock ShoxsandrulloNessuna valutazione finora
- Dal Vero by Serao, Matilde, 1865-1927Documento138 pagineDal Vero by Serao, Matilde, 1865-1927Gutenberg.orgNessuna valutazione finora
- Archeologia Di ScavoDocumento12 pagineArcheologia Di ScavoDcHomeMcNessuna valutazione finora
- Problemi Di Fisica TecnicaDocumento38 pagineProblemi Di Fisica Tecnicamatealoredana8015Nessuna valutazione finora
- 01 Libro - Trasformazioni Culturali - Neoclassicismo 1750-1900Documento3 pagine01 Libro - Trasformazioni Culturali - Neoclassicismo 1750-1900JulioCallocchiaNessuna valutazione finora
- Fatti Di SangueDocumento24 pagineFatti Di SangueFederico MastrorilliNessuna valutazione finora
- Classe Prima Le Piante FioriteDocumento2 pagineClasse Prima Le Piante FioritescienzemalmantileNessuna valutazione finora
- Lupo Legendary Fights - 02 - Traversata Infernale PDFDocumento46 pagineLupo Legendary Fights - 02 - Traversata Infernale PDFClaudio PerettiNessuna valutazione finora
- Dati Tattili Animali08Documento5 pagineDati Tattili Animali08n3rinaNessuna valutazione finora
- Never Enough PDFDocumento4 pagineNever Enough PDFYeno PesqueraNessuna valutazione finora
- Game of Thrones - Main Theme - Piano ArrangementDocumento3 pagineGame of Thrones - Main Theme - Piano ArrangementAndrea EdwardsNessuna valutazione finora
- Prove Desame Chit. El. H.R. H.M. Versione 1.2Documento13 pagineProve Desame Chit. El. H.R. H.M. Versione 1.2Jessica PhillipsNessuna valutazione finora
- Rcs S.000.NIE - INF.0030V1T1 Preview PDFDocumento50 pagineRcs S.000.NIE - INF.0030V1T1 Preview PDFAsma SkanderNessuna valutazione finora