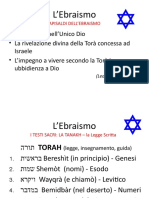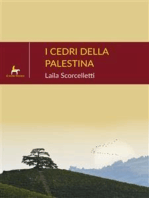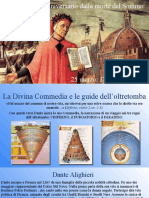Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Paolo-Edoardo Fornaciari PDF
Caricato da
Eliezer PapoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Paolo-Edoardo Fornaciari PDF
Caricato da
Eliezer PapoCopyright:
Formati disponibili
Donne sefardite in un libro ritrovato
Donne Sefardite in un Libro Ritrovato:
Gli ebrei venuti a Livorno, versi di Raffaello Ascoli
computista livornese
Livorno, I.Costa 1886
Quando ho iniziato ad occuparmi della storia e della cultura dei miei concittadini
ebrei, alcuni di loro mi parlarono di un libretto perduto, Gli ebrei venuti a Livorno,
di Raffaello Ascoli. Si pensava fosse la testimonianza pi autentica del mondo del
popolino ebraico livornese che parlava il bagitto, il tipico idioma locale di origine
giudeospagnola.1
Raffaello Ascoli lo aveva fatto stampare... in soli 20 esemplari, nel 1886, dalla
tipografia di Israel Costa, una delle quattro o cinque che nella seconda met
dellOttocento stampavano in ebraico per tutte le qehillot del Mediterraneo.
Venni a conoscenza del testo grazie ad un mio alunno che un giorno disse di
possedere un libro che parlava degli ebrei venuti a Livorno. Sorrisi, scettico: il libretto
era, ed tuttoggi sconosciuto a tutte le bibliografie nazionali ed internazionali.
Persino lIstituto Centrale del Catalogo Unico (ICCU) di Roma non ne conosce
lesistenza.2 Daniele Tabellini, lalunno di cui parlavo, me lo port in visione, ne feci
alcune fotocopie ed ormai da una decina danni esso un libro ritrovato, anche se non
1
2
Lultimo grande cabbalista livornese, Alfredo Sabato Toaff di beata memoria, si doleva di
non averlo mai potuto avere per le mani.
Finch non sar ripubblicato, il libro rimarr una semplice fotocopia che pochi fortunati
hanno avuto in visione, grazie al mio intervento: amici e studiosi come il prof. Renzo
Cabib, di beata memoria, Gabriele Bedarida memoria vivente della Comunit di Livorno
ed il prof. Fabrizio Franceschini dellUniversit di Pisa. Il prof. Ariel Toaff ne cita alcuni
passi in un suo volume: probabilmente vi ha avuto accesso tramite la catena familiare che
ancora lo lega a Livorno.
241
Donne sefardite in un libro ritrovato
ancora noto come dovrebbe meritare. E una miniera di fatti grandi e piccini narrati
in poesia, dal metro vario e talvolta incerto. E quella che altrove si sarebbe chiamata
la memoria del ghetto: uno strumento di formidabile documentazione sulla vita
quotidiana e, soprattutto, sulla mentalit degli Ebrei di Livorno, cio di una qehillah
di recente formazione (appena 4 secoli di storia) ma gi ricca di una costellazione di
riferimenti narrativi testimoni della propria vitalit.
Il volume si apre con la trascrizione, abbastanza fedele se si eccettuano poche
varianti adiafore classificabili senzaltro come errori di stampa, della versione del
1593 delle Lettere patenti di Ferdinando I deMedici (note come Livornine) con cui
il Granduca sceglieva di popolare di una borghesia commerciale ed imprenditoriale la
futura citt di Livorno.3 Il Granduca chiam in citt gli ebrei che erano stanziati lungo
tutto larco del Mediterraneo, e in particolare i marrani, specialmente portoghesi,
garantendo loro, grazie alla sua protezione, la piena libert di culto contro gli attacchi
dellInquisizione.
Il volume diviso in due parti. La prima, intitolata Gli spagnoli, raccoglie
e riporta in poesia notizie varie concernenti gli ebrei di origine iberica (portoghese,
castigliana o catalana), riportando onomastica familiare ed aneddoti dun umorismo
Livorno sino al 1577 era una propaggine di Pisa (Castello e Terra di Livorno si
chiamava, nei documenti ufficiali). In quellanno i Medici decisero di edificarvi il porto e
la citt dintorno, per linterramento oramai irreversibile del Porto Pisano. La prima pietra
fu posta alla presenza del Granduca il 27 aprile del 1577; i lavori si protrassero per quasi un
trentennio, e lerezione a citt avvenne il 4 agosto 1606. In questo quadro amministrativo,
apparvero le Livornine dapprima con un motu proprio di Ferdinando I, che nellottobre
1590 invita a Livorno forestieri non residenti in Toscana manifattori di sartie, calafati,
maestri dascia, legnaiuoli... muratori marangoni scarpellini pescatori marinai fabbri. Sin
dallinizio appaiono le prime forme di privilegio che avrebbero fatto la fortuna di Livorno
(e la cattiva fama dei livornesi): limmunit da delitti commessi fuori del Granducato
(eccetto lomicidio e la lesa maest), la inesigibilit dei debiti lasciati fuori del Granducato,
la moratoria di 5 anni per i debiti contratti nel Granducato al di fuori di Pisa e Terra di
Livorno. Nel 1591 si sarebbero aggiunti altri privilegi importanti, come lesenzione da
ogni forma di corve e lesenzione dal pignoramento delle masserizie per causa debitoria
non eccedente i 500 ducati. Dopo due anni di trattative e negoziati, ebbero forma definitiva
nel 1593 le Lettere Patenti, pi note come Livornine, contenenti condizioni migliori per gli
Ebrei, grazie allattenta regia dellimprenditore ebreo Maggino di Gabriello. Sembravano
concernere Pisa, a cui testualmente si riferivano, ma in realt erano studiate apposta per
lanciare la trasformazione di Livorno da semplice villaggio in citt portuale.
242
Donne sefardite in un libro ritrovato
talvolta surreale. La seconda parte, intitolata Gli altri, narra degli ebrei che non
avevano origine sefardita: gli italkim e gli aschenaziti. Allinterno di questa seconda
parte spicca un elenco degli Ebrei livornesi che hanno partecipato alle varie fasi del
Risorgimento nazionale italiano, a partire dal 1848-1849. Il lavoro si conclude con
due importantissimi elenchi di cognomi di ebrei livornesi, suddivisi in sefarditi e non
sefarditi.
Allinterno del volumetto alcuni passi ricostruiscono la fisionomia dellelemento
femminile ebraico livornese, sefardita ma non solo. Cos, vi si trovano episodi
interessanti relativi a superstizioni:
Bemporad c figliuola a Felice
e la Sraffa al suo sposo sorella.
Mi han pregato con dolce favella
Le susine vogliamo gustar
siamo incinte! Lei sa che non lice
nostre voglie ad alcun trascurar!.
E perch non mi gettin lorzaiolo
due soldi detti lor da buon figliolo
(II parte, canto VIII ottava 19, p. 153)
Lautore allude alla superstizione (non si sa se comune allambiente cristiano) per
cui quando incontravano qualcuno con locchio gonfio, le matrone esclamavano:
ha lorzaiolo perch ha ricusato qualche cosa ad una donna incinta (come chiarisce
lautore stesso, in nota).
Vi sono alcuni esempi di virt muliebri e altri di donne dal comportamento
anticonformista; vi si incontra Laurina Anau che incarna lo stereotipo della donna
soldato, ambientato nelle guerre di indipendenza italiane, verosimilmente nel
quadro della spedizione garibaldina dei Mille, per la quale attestata la partenza di
volontari livornesi da un lido sabbioso (la spiaggia del Calambrone) da dove in barca
raggiunsero una delle due navi, che li attendeva al largo della Meloria:
dalle donnesche gesta un d disciolta
si vede da soldato
col fucile prontissima a far fuoco
contro i Tedeschi. E quando entusiasmato
Cesare laltro figlio and alla guerra
Laurina passo passo ha seguitato
243
Donne sefardite in un libro ritrovato
e al mar, siccome un giuoco,
sinoltra e abbandonare vuol la terra
con lui, ma nella barca non vi loco:
grave pensier sovrasta
allora il suo materno e afflitto core
(II parte, c.V ottave 28-29, p. 120)
Vorrei focalizzare lattenzione su due elementi di rilievo per il nostro discorso,
nellimpossibilit di riportare per intero tutti i passi che ci interessano.
Un primo elemento costituito dalla fisionomia della servit domestica femminile,
che di due distinti tipi. Ascoli ce la presenta dapprima in un passo dedicato ad una
donna che svolge il mestiere di intermediaria tra manodopera e padroni di casa. Di
questa figura di donna e del suo ruolo nulla si sarebbe saputo se Raffaello Ascoli
non le avesse dedicato 52 versi; nulla di lei e del ruolo sociale a cui aveva dedicato
tutta la vita: quello di provvedere di donne di servizio cristiane le case dei ricchi
ebrei di Livorno. Ascoli non lo dice, ma noto che era uso nellaristocrazia ebraica
cittadina impiegare almeno una serva o un servo, cristiani, che potesse accendere
il fuoco e spengere la luce senza infrangere lo abbat. Questuso esponeva ad un
rischio: quello del battesimo, operato dalle serve invitis parentibus, di bambini ebrei
che poi (nonostante la protezione granducale) finivano nella casa dei catecumeni e
spesso addirittura diventavan preti, come accadde sul finire del Seicento al giovinetto
Israel De Meir Leon battezzato Paolo Medici, che divenne un feroce oppositore
dellebraismo, contro il quale stese un volume Riti e costumi degli ebrei4 stillante
veleno.5
Dunque, per assumere servit cristiana si ricorreva ad intermediari. Una di questi
era lebrea Mazzaltov Sitr che esercitava il delicato suo ministero su un canto della via
Per parte mia, ho consultato la seguente edizione: Riti e costumi degli ebrei descritti
e confutati dal dott.Paolo Medici sacerdote e lettor pubblico fiorentino Firenze presso
Gaspero Ricci 1847.
Ma vi erano anche i casi inversi, giacch luso di assumere servit cristiana (prolungatosi
sin nel dopoguerra) ha conosciuto figure fulgide, che aiutarono gli ebrei durante la
persecuzione, come Anna Palagi fedele governante dei Toaff-Bedarida che li salv dalla
deportazione, sottraendoli alle spiate di concittadini felloni ed alla caccia delle autorit
fasciste.
244
Donne sefardite in un libro ritrovato
Serristori, ossia allincrocio in cui il quartiere ebraico si fondeva con quello cristiano.6
Ascoli ci d addirittura i suoi dati anagrafici (nascita 21-1-1783, morte 28-2-1869,
pat.Mos Modigliano, mat.Rosa Tedeschi); interessante anche conoscere i luoghi
(le campagne, o lAppennino) da cui le serve affluivano a Livorno: Lari, Chianni
(in provincia di Pisa) Capannori (in Lucchesia), Campi (probabilmente Bisenzio, tra
Firenze e Prato) e Fiumalbo, sullAppennino pistoiese, oltre a tutta la Garfagnana. Ma
leggiamo cosa ci dice lautore:
Piangete o serve della Garfagnana
e di Fiumalbo voi fulgide stelle
poich il possente che ferisce e sana
che d la vita e la ritoglie, espelle
la generosa vostra protettrice
dal mondo sublunar e le fiammelle
dell almo spirto, nuova Berenice
gi tramandano in cielo i rai lucenti.
Pi di sedici lustri ormai felice
vissuto avea tra la terrena gente
la Mazzaltob Sitr gloria del mondo,
allor che di vecchiaia il mal potente
di un letticiuolo la gett nel fondo:
delle cure per voi dal mal costretta
per sempre ahim 1asciava il grave pondo.
Oh sfortuna per voi! La poveretta
consumata dagli anni ma di spirto viva
si rammentava larte sua diletta,
e alla fida compagna il core apriva.
A Livorno il ghetto non mai esistito; vi stata una zona del centro cittadino abitata
prevalentemente, ma non esclusivamente, da ebrei, soprattutto di bassa estrazione, attorno
alla Sinagoga, lungo via della Tazza (non pi esistente, dopo le distruzioni belliche), via
del Tempio e via di Franco (dal nome di una delle famiglie sefardite pi importanti); ebrei
di estrazione pi elevata hanno abitato in unaltra zona, quella dellodierna via Ernesto
Rossi (talvolta detta addirittura via degli Ebrei). Le famiglie pi ricche abitavano distanti
dal centro, in periferia, generalmente in ville pi o meno sontuose (Villa Attias, Villa
Lazzara, villa Medina, villa Regina, ecc.).
245
Donne sefardite in un libro ritrovato
Potr sul canto di Via Serristori
ancor posar le membra come ambiva?
A miei piedi vedr pi i servitori
pregarmi per impiego, e la donzella
da Lari, o Chianni, o Campi. o Capannori
raccomandarsi per entrare ancella
nelle case cospicue di Livorno ?
La serva fida alla sua vecchierella
rispondeva cos: Verr quel giorno
mia padrona diletta ed adorata,
ben presto vi faran corona intorno
e cuochi, e servi, e ancelle e risanata,
sul seggio avrete regno glorioso
ma in cuor suo della povera malata
gi prevedeva lultimo riposo
e della grave perdita gemeva.
Intanto legra nel dubbio smanioso
se i suoi clienti riveder poteva
di nuovo rammentava i d lontani
allor che il vacillante pi traeva
qua e col per alti e bassi piani.
Vaga lo spirto in quel tempo primiero
e fa agitare le sue scarne mani.
Tentenna la sua mente a tal pensiero
e delirando esclama : Lei beata,
o mia signora, che un gioiello vero
trova in tal donna fida ed onorata;
felice te che padrona s degna
oggi per mezzo mio Dio t ha mandata.
Alfin la fiera lotta in lei simpegna
fra lo spirto vital e il morbo rio;
volge la mente a Lui che lass regna
la nobil vecchia, e rende l alma a Dio.
Luso di impiegare serve cristiane. era compensato da un altro, speculare. Infatti
scopriamo grazie allAscoli che Livorno era luogo di affluenza anche di serve ebree
246
Donne sefardite in un libro ritrovato
aschenazite, il cui ruolo era ovviamente diverso da quello delle cristiane, tant vero
che numerose di loro finivano per trovar marito tra i sefarditi livornesi. Si formavano
vere e proprie carovane di ragazze, che giungevano dal Nordeuropa accompagnate
da un vecchio, detto aliah, letteralmente in ebraico messaggero, in realt una
figura che assommava i ruoli di scorta e conduttore, ma anche sensale; vecchio, per
comportare meno problemi possibile per la virt delle giovani che sciamavano da
Germania e Polonia:
Qual trambusto qual chiasso si sente
sulle vie di Baviera o Sassonia,
perch mai la lontana Polonia
ha coll Austria i villaggi in rumor?
Di Sion la donzella piangente
si separa dai suoi genitor !
Prende la via con sicura speranza
di star pi quieta almeno in lontananza.
Perch ai miseri ebrei che son troppi
non abbonda guadagno e lavoro
e ricercano un qualcho ristoro
alla loro crudel povert,
e han pensato che son vero intoppo
le ragazze di quelle citt.
Si pongono in cammin tra allegre e meste
E aspirano di giunger per le feste.
E sen vanno dirette da un vecchio
quello vispe tedesche ragazze:
vi di tutto, le serie e le pazze,
in questo Esodo strano novel,
se ne van col lor piccolo specchio
che gli rende l immagin fedel,
E vedendosi in quello, ognuna crede
di esser amata, appena la si vede!
247
Donne sefardite in un libro ritrovato
Poich loro ha recato la fama
che a Livorno sul lido toscano
Da color che il danar hanno in mano
Sono accolte con vero piacer,
Solo il loro servigio si brama,
Sia fedele, accurato, sincer !
E per la lor stupenda educazione
acquistaro una gran reputazione !
E col, si soggiunge, ben presto
colla buona condotta morale
quasi tutte com naturale
man di sposo si senton offrir.
Questo voci fan si che, pur mesto,
ogni padre le lasci partir,
ed aspira a sentir lieta novella
che a maritarsi giunse la donzella.
E di fatto le giovani schiere
nelle case trovar di Livorno
cos caro o s lieto il soggiorno
che con poca fatica si ottien,
e serviron lebree con piacere
e i padroni le tennero ben.
Cos si va creando una colonia
dellAustria, di Baviera e di Sassonia.
La donzella che serva rimase,
cameriera o intendente divenne
quasi sempre un marito le venne
giusto premio alla sua fedelt.
Pur taluna, senz esso alle case
invecchiando, ti desta piet!
(II parte c.VIII vv. 1-56. p. 148-149)
248
Donne sefardite in un libro ritrovato
C poi la curiosa vicenda di due sposi promessi per la vita, che pur vivendo assieme
non coronano che platonicamente il loro sogno damore, rimanendo casti sino alla
morte. Al suo interno v tra laltro il riferimento ad un uso proprio dellambiente
sefardita, comune ad altri territori mediterranei, ma non al resto della citt di
Livorno.
Lui, Isacco Silva, porta un regalo di compleanno a lei, la Piangi, che vive nella
sua casa in attesa di sposarlo; si tratta di un regalo simbolico, un ventaglio. Con
quel pretesto Silva la va a trovare sperando di poter fissare finalmente la data del
matrimonio; ma lei, imbronciata per chiss quali motivi, sera gi messa al balcone
a prender aria. La vicenda d luogo ad un curioso giuoco di parole agevolato dalla
polisemia del termine aria in italiano, che vale (tra laltro) sia aria in movimento
che modo di atteggiarsi:
La nascita di lei Silva rammenta
ch il suo primo pensier che tanto adora
e lamore, in quel d, gi non rallenta,
ma gentilmente dalla tasca fuora
trae un ventaglio che si faccia aria
e dice: Cara sposa, questa lora
che devo domandarti: a che tantaria?
E la gentil donzella gli risponde
Aprii il balcone e presi un poco daria
(I parte, canto X vv. 19-91, p. 42-45 )
Lautore in nota (p. 43 nota 2) trascrive anche come tal episodio allepoca veniva
tramandato in giudeo-spagnolo:
Una sera Silva trov imbronciata la sposa e le domanda: A que tiene tanta aria?
ed essa gli rispose in sussiego Me misi o balcon e tom un poco de aria
testimonianza tra laltro del sincretismo linguistico del bagitto (il judeolecto
livornese). In questa citazione si trovano infatti fusi italiano, castigliano e portoghese
(questultima lingua presente con larticolo o). Alla fine, con la storia dellaria,
neanche questa volta il matrimonio vien fissato.
Ma quel che pi interessa la metafora del ventaglio. Alle ragazze sefardite
serviva fisicamente per attenuare la calura estiva; ma simbolicamente per segnalare
la condizione di nubilato, se agitato con alta frequenza. Le donne al contrario
segnalavano di essere coniugate, sventolandolo lentamente. Si tratta di una metafora a
249
Donne sefardite in un libro ritrovato
sfondo sessuale derivato; la giovine usa il ventaglio per sedare il calore del desiderio
che si somma a quello della temperatura; la maritata invece lo sventola lentamente,
giacch ha ormai un marito che calma i suoi ardori, e quindi deve far fronte solo al
clima. un uso attestato ancor recentemente in Sicilia oltre che in Andalusia. Ecco
come narra la vicenda Ascoli:
Oh il belluso di allor che non nasconde
in che stato la donna! Dai suoi moti
che col ventaglio fa, luom non confonde
la donna chha marito, e chi fa voti
ardenti per averlo! Ti fai vento,
o maritata, e lentamente scuoti
le stecche con tranquillo movimento
sul tuo bel seno e pare di sentirti:
Io, marito ce lho! Oh qual contento!
Tu, giovanetta dai bollenti spirti
muovi veloce lo steccato foglio
e ti cuopri e ti scuopri e sembra udirti:
Io lo voglio, il marito, il voglio, il voglio!
E i garzoni dallora tutti onesti
non incorrevano in alcun imbroglio
e i loro omaggi dedicavan presti
alla ragazza che vuole farsi sposa,
che muove il suo ventaglio a tratti lesti.
(I parte, canto X, vv. 49-62, pp. 43-44)
Cos concluderei, sperando di non aver troppo annoiato i miei pochi lettori, che
comunque ringrazio della cortese attenzione.
Paolo Edoardo Fornaciari
Livorno Dubrovnik, giugno-agosto 2008
250
Potrebbero piacerti anche
- Shakespeare William - Il Mercante Di VeneziaDocumento157 pagineShakespeare William - Il Mercante Di Veneziazonoz100% (1)
- The Sibyl of the Apennines - La Sibilla Appenninica: Two texts by Andrea da Barberino and Antoine de La SaleDa EverandThe Sibyl of the Apennines - La Sibilla Appenninica: Two texts by Andrea da Barberino and Antoine de La SaleValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Gli Ebrei Jugoslavi Internati AostaDocumento199 pagineGli Ebrei Jugoslavi Internati AostaEmil Eskenazy Lewinger100% (1)
- Cristo Si È Fermato Ad Eboli Di Carlo Levi (Giovanni Falaschi)Documento28 pagineCristo Si È Fermato Ad Eboli Di Carlo Levi (Giovanni Falaschi)Grodi100% (1)
- SionismoDocumento45 pagineSionismoVikyNessuna valutazione finora
- Benedetto Croce e La 'Sua' NapoliDocumento94 pagineBenedetto Croce e La 'Sua' Napolidavis2aNessuna valutazione finora
- Ebrei Dopo La Shoah. Politica e Cultura Nell'italia Del Secondo Dopoguerra (1945-1973)Documento402 pagineEbrei Dopo La Shoah. Politica e Cultura Nell'italia Del Secondo Dopoguerra (1945-1973)elenamazziniNessuna valutazione finora
- L'Ebraismo Testi Sacri, Halakha e HaggadaDocumento24 pagineL'Ebraismo Testi Sacri, Halakha e HaggadaLuca Broggi100% (1)
- Appunti LETTERATURA INGLESE - GabizonDocumento22 pagineAppunti LETTERATURA INGLESE - GabizonCarlotta Maurizi100% (1)
- Domenico Caruso Uomini Illustri Di CalabriaDocumento151 pagineDomenico Caruso Uomini Illustri Di CalabriamediacalabriaNessuna valutazione finora
- Il Rinascimento Letterario (Appunti)Documento5 pagineIl Rinascimento Letterario (Appunti)• chris18 •Nessuna valutazione finora
- L'Ermafrodito Di Antonio BeccadelliDocumento140 pagineL'Ermafrodito Di Antonio BeccadelliGianfranco ScavuzzoNessuna valutazione finora
- L Ebreo Di Verona CommentoDocumento10 pagineL Ebreo Di Verona CommentoGianandrea de AntonellisNessuna valutazione finora
- Le Lettere Di VeteraniDocumento22 pagineLe Lettere Di VeteraniDan16164Nessuna valutazione finora
- Dante Cap-1Documento10 pagineDante Cap-1cicoNessuna valutazione finora
- Appunti ItalianoDocumento57 pagineAppunti ItalianoAngelica BavettaNessuna valutazione finora
- Cronologia VergaDocumento31 pagineCronologia VergaKarl Heinz StottenbakerNessuna valutazione finora
- La Censura Del Disparate L Entremes deDocumento32 pagineLa Censura Del Disparate L Entremes dealeksinasNessuna valutazione finora
- Et in bona gratia. Un'indagine per il commissario Ludovico AriostoDa EverandEt in bona gratia. Un'indagine per il commissario Ludovico AriostoNessuna valutazione finora
- Narratori Italiano Fino Al 1950Documento418 pagineNarratori Italiano Fino Al 1950Marco BagarellaNessuna valutazione finora
- Il calzare della sposa. Una nuova indagine per il commissario Ludovico AriostoDa EverandIl calzare della sposa. Una nuova indagine per il commissario Ludovico AriostoNessuna valutazione finora
- VirgilioDocumento6 pagineVirgilionicoleroseciccoNessuna valutazione finora
- LetteraturaDocumento13 pagineLetteraturaAlfonso CapuanoNessuna valutazione finora
- C - TesinaDocumento37 pagineC - Tesina155f92656117bdNessuna valutazione finora
- Pen Tamer OneDocumento498 paginePen Tamer Onetoto100% (1)
- Le Tre Guide Di DanteDocumento12 pagineLe Tre Guide Di Danteleila zitouniNessuna valutazione finora
- Marić-1 KolokvijDocumento11 pagineMarić-1 KolokvijAnonymous jt3d09ZNessuna valutazione finora
- Dal Gargano a New York: La difesa delle minoranze in un’intervista a Martin Luther King e altri articoliDa EverandDal Gargano a New York: La difesa delle minoranze in un’intervista a Martin Luther King e altri articoliNessuna valutazione finora
- 13 SQ 23 2022 Leto-1Documento20 pagine13 SQ 23 2022 Leto-1longulucasNessuna valutazione finora
- Letteratura ItalianaDocumento69 pagineLetteratura ItalianaGiulioegabriele CalignanoNessuna valutazione finora
- Annio Il Falsario Di DioDocumento8 pagineAnnio Il Falsario Di DioberixNessuna valutazione finora
- Storia Della Letteratura ItalianaDocumento22 pagineStoria Della Letteratura Italianasharon.gonmarNessuna valutazione finora
- Lindicescarl LINDICE-00301Documento48 pagineLindicescarl LINDICE-00301SlowfingerNessuna valutazione finora
- Storia della letteratura italiana del cav. Abate Girolamo Tiraboschi – Tomo 4. – Parte 2: Dall'anno MCLXXXIII fino all'anno MCCCDa EverandStoria della letteratura italiana del cav. Abate Girolamo Tiraboschi – Tomo 4. – Parte 2: Dall'anno MCLXXXIII fino all'anno MCCCNessuna valutazione finora
- LetteraturaDocumento8 pagineLetteraturaGIOVANNI CANCELLINessuna valutazione finora
- Pjesničke Škole I Velikani Srednjovjekovne Talijanske KnjiževnostiDocumento23 paginePjesničke Škole I Velikani Srednjovjekovne Talijanske KnjiževnostiivanbuljanNessuna valutazione finora
- NARBONE 1857 I Baiuli Nel Regno Normanno Di Sicilia 1130 1194Documento48 pagineNARBONE 1857 I Baiuli Nel Regno Normanno Di Sicilia 1130 1194Greg StaNessuna valutazione finora
- Letteraturaitaliana PDFDocumento53 pagineLetteraturaitaliana PDFnadia cellNessuna valutazione finora
- La Pazzia (1540)Documento64 pagineLa Pazzia (1540)viruta1Nessuna valutazione finora
- L’Opera di Mario Rapisardi: "Il poeta di Lucifero"Da EverandL’Opera di Mario Rapisardi: "Il poeta di Lucifero"Nessuna valutazione finora
- Carabba LucchettaDocumento51 pagineCarabba Lucchettamattia.lattanziNessuna valutazione finora
- Felice barnabei. lettere a giannina milli (1862-1888)Da EverandFelice barnabei. lettere a giannina milli (1862-1888)Nessuna valutazione finora
- La Principessa Belgiojoso (Da memorie mondane inedite o rare e da archivii segreti di Stato)Da EverandLa Principessa Belgiojoso (Da memorie mondane inedite o rare e da archivii segreti di Stato)Nessuna valutazione finora
- Itinerari Ebraici Fra XIX e XX Secolo. Attraverso Brindisi Verso Una Nuova SperanzaDocumento37 pagineItinerari Ebraici Fra XIX e XX Secolo. Attraverso Brindisi Verso Una Nuova SperanzaGiacomoCaritoNessuna valutazione finora
- Una noia splendida. Dizionario letterario di MantovaDa EverandUna noia splendida. Dizionario letterario di MantovaNessuna valutazione finora
- Eleonara D'Arborea Camillo BellieniDocumento58 pagineEleonara D'Arborea Camillo BellieniFrancesco BiancuNessuna valutazione finora
- Piccolomini PDFDocumento151 paginePiccolomini PDFAlexander OlaveNessuna valutazione finora
- Romanticismo - ManzoniDocumento14 pagineRomanticismo - ManzoniTabatha MazzaboNessuna valutazione finora
- 1998 N. 1.16 Rece Storia Della Civiltà Letteraria RussaDocumento16 pagine1998 N. 1.16 Rece Storia Della Civiltà Letteraria RussascaricascaricaNessuna valutazione finora
- Esuli fiumani in Liguria: Storia e Letteratura Atti del Convegno internazionale di studi Genova, 11 ottobre 2022Da EverandEsuli fiumani in Liguria: Storia e Letteratura Atti del Convegno internazionale di studi Genova, 11 ottobre 2022Nessuna valutazione finora
- Studio Biblico Su Giosuè: Perché Dio Dà L'ordine Di Scacciare e Distruggere I Canaaniti?Documento1 paginaStudio Biblico Su Giosuè: Perché Dio Dà L'ordine Di Scacciare e Distruggere I Canaaniti?αναστρεφωNessuna valutazione finora
- SUKKOT - La Festa Ebraica Delle CapanneDocumento3 pagineSUKKOT - La Festa Ebraica Delle CapanneαναστρεφωNessuna valutazione finora
- Shema IsraelDocumento2 pagineShema IsraelGrazia ButtiNessuna valutazione finora
- ChiaMata A SeferDocumento4 pagineChiaMata A SeferStefano ProfeNessuna valutazione finora
- Aiutare Dio Riflessioni Su Vita e Pensiero Di Etty HillesumDocumento15 pagineAiutare Dio Riflessioni Su Vita e Pensiero Di Etty Hillesumdanaka01Nessuna valutazione finora
- Cronologia Della Vita Di GesùDocumento2 pagineCronologia Della Vita Di GesùmeloniscjNessuna valutazione finora
- Calendario Ebraico - Tabella Mesi & FesteDocumento1 paginaCalendario Ebraico - Tabella Mesi & FesteαναστρεφωNessuna valutazione finora